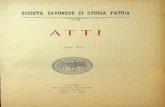La rocca di Breno nella storia: eventi e documenti, in La rocca di Breno tra preistoria e storia,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La rocca di Breno nella storia: eventi e documenti, in La rocca di Breno tra preistoria e storia,...
BrenoLa rocca di
tra preistoria e storia
Quaderni brenesi 1
Un castello postoin luogo eminente,
et molto forte,che altre volte era
una delle principali fortezze che fusse
in questa Valle,et questa terra
si può dirla Metropolidi essa Valle.
Giovanni da Lezze1610
ISBN 978-88-96755-07-5
Euro 10,00
la rocca di breno: tra preistoria e storia 1
Sandro Farisoglio e Simona FerrariniPresentazione
Francesco FedeleLa collina del Castello: il paesaggio e la preistoria
Anna Gattiglia e Maurizio RossiArcheologia storica sulla rocca di Breno
Angelo GiorgiLa rocca di Breno nella storia: eventi e documenti
Simone SignaroliDocumenti e dati storici
Alberto Bianchi e Riccio VangelistiIl Castello e l’abitato di Breno:una ricostruzione toponomastica
Lucia Morandini e Giorgio De MichelisIl recupero architettonico della Roccadai primi anni del Novecento a oggi
Anna Gattiglia, Angelo Giorgi e Maurizio RossiGlossario
5
17
35
51
54
59
68
la rocca di breno: tra preistoria e storia 35
tra età romana e medioevo. I primi otto secoli della nostra èra in Valcamonica sono uno dei periodi meno conosciuti. La collina del castello restituisce solo tracce di frequentazioni nell’età romana; i materiali archeologici ritrovati nel territo-rio di Breno non consentono, certo, di parlare d’insediamen-to, quanto forse di un vicus; il santuario di Minerva in località Spinera, al confine con il territorio di Civitas Camunnorum, ne indica ulteriormente la preponderanza assunta rispetto ai villaggi limitrofi. Poco sappiamo dei secoli dell’alto medio-evo, ma la recente datazione degli scheletri delle due tombe ritrovati negli scavi effettuati dal prof. F. Fedele, tra il 1980 e il 1985, rivela che una comunità inumava i suoi defunti sull’altura nel VI secolo d. C.1, dato che collimerebbe con l’ipotesi già avanzata, riguardo alla possibilità che la collina brenese potesse essere stata sede di uno «stanziamento di tipo arimannico». L’impronta lasciata dalla presenza longobarda (568-774) è testimoniata al di fuori della collina, da più parti della Valle, da reperti archeologici, da dedicazioni, da toponi-mi e da residui lessicali. La Valle Camonica, soggetta a diverse infeudazioni, veniva genericamente nominata per la prima volta in un documento scritto, nel testamento (maggio 774) di Taido, gasindo del re longobardo Desiderio, tra le proprietà che costui lasciava alle basiliche di sant’Alessandro, di santa Maria e dei santi Pietro e Vincenzo e che si estendevano «in suso per Valle Camonense», e nello stesso anno, tra luglio e ago-sto, Carlo Magno, re dei Franchi, ne infeudava alcuni territori ai monaci di Saint Martin de Marmoutier di Tours, che man-tennero il controllo delle terre camune, con la convalida da parte di Ottone II (998), fino al 1050. La prima costruzione d’epoca storica che comparve sullo sperone di roccia che so-
La rocca di Brenonella storia:eventi e documenti
• Angelo Giorgi
1 Si vedano: Fedele et al., “Datazioni radiocarboniche AMS di siti archeologici del Castello di Breno, primo contributo: sito BC3”, in stampa in «Notizie Ar-cheologiche Bergomensi», 18 (2010); L’uomo, le Alpi, la Valcamonica. 20.000 anni al Castello di Breno. Elementi di aggiornamento, in corso di stampa (aggiornamento a Fedele 1988).
36 la rocca di breno: tra preistoria e storia
vrasta Breno fu, probabilmente, la chiesa situata a nord-ovest, tra VI e VII secolo, la cui intitolazione a san Michele arcan-gelo potrebbe essere ricondotta, per via di deduzione, alla cultura longobarda: il più antico documento che fa menzione della dedicazione in terra brenese è più tardo (tra il 1334 e il 1335) e non dà la certezza che si trattasse della costruzione in oggetto, in quanto appare accomunata con Maurizio in un’improbabile «ecclesia sanctorum Micaelis et Maurici de Breno», in un elenco dei benefici apostolici vacanti, la cui rendita era stimata in sette fiorini; solo un documento posteriore, il re-soconto della visita pastorale del vescovo C. Bollani nel 1573, fornisce la certezza nell’individuazione dell’edificio.
Per i secoli dell’età comunale le circostanze portano a ipo-tizzare l’esistenza in Valle di una sorta di comune rustico, do-tato di organi giuridici e amministrativi, la cui sede potrebbe essere forse ravvisata nell’area del castello, soprattutto perché nel collegio formato da tre consoli compariva con regolarità il nome di un brenese. Gli interessi imperiali di Federico I detto Barbarossa per il territorio sono testimoniati, oltre che da alcune discese (1154, 1164 e 1166), anche dalla concessio-ne di alcuni privilegi alla comunità valligiana.
Le accese rivalità tra i guelfi e i ghibellini, che in Valca-monica riguardarono il controllo del territorio, non certo le sorti del papato o dell’impero e neppure l’autonomia da Bre-scia, videro le costruzioni arroccate sul colle di Breno fare da sfondo a contese per le investiture nel corso del secolo XIII: già dall’inizio del secolo vi si riscontra la potente presenza dei feudatari ghibellini Federici; le concessioni del vescovo Berardo Maggi, che continuò a disporre di ben più ampi pos-sedimenti nel resto della Valle, a favore del castello di Breno, sono attestate nel 1277, a beneficio degli Alberzoni e dei loro avversari tenaci i guelfi Ronchi, assieme a numerose altre fa-miglie; il Consiglio generale di Brescia, per porre fine a una lunga contesa con la ribelle Valle Camonica, chiese l’inter-vento pacificatore di Maffeo Visconti, il cui lodo arbitrale del 6 luglio con la conseguente transazione del 17 agosto 1291 fu favorevole solo alla propria causa, stabilendovi che il reggente valligiano, che aveva il compito di organizzare le strutture di governo locali, fosse fedele al duca di Milano e al Comune di Brescia.
La Valle Camonica entrò, nel 1311, nella politica d’inte-resse dell’imperatore Arrigo VII, che, confermando le con-cessioni autonomistiche rilasciate a suo tempo da Federico I
la rocca di breno: tra preistoria e storia 37
Barbarossa, nominava un suo vicario, tra cui anche Cangran-de Della Scala; dal 1325 la comunità valligiana doveva essersi dotata anche di propri statuti. Nel 1337 i Visconti di Milano avevano preso il controllo anche della rocca brenese, che, tra vari passaggi interni al casato, fu tenuta fino all’avvento del-la dominazione veneta: tra gli scarni documenti riguardanti la rocca, si ritrova la testimonianza relativa alla nomina, il 6 gennaio 1374, di Albertolo Marliano che subentrava a Filip-pino Paravesino nella reggenza della Valle e come castellano brenese. Attorno alla metà del XIV secolo, tra gli altri, anche il «Castelus de Breno» pagava tributi al vescovo di Brescia e messer Andreolo di Gerardo Ronchi, scampato a un attentato dei temibili Federici che avevano fatto precipitare nel Lago d’Iseo i loro osteggiatori, trovò la morte ad attenderlo nel suo palazzo posto sull’altura di Breno.
il declino del medioevo e la rinascenza. Negli anni suc-cessivi si videro in Valle e a Breno trasformazioni politiche, sociali ed economiche di grande portata: nel 1397, la pace suggellata dal duca Gian Galeazzo Visconti, al Ponte della Minerva, sanciva una precaria stabilità tra guelfi e ghibellini, oltre che dimostrare l’interesse milanese per la Valle e fare strada alle contese con Brescia e Venezia; si avviava al tramon-to il feudalesimo e iniziava ad affermarsi una nuova economia basata sulla «ferrarezza»; sulla collina l’arroccamento di palazzi civili fu trasformato in roccaforte militare, venne nominato un castellano e un presidio milanese vi fu di stanza, furono effettuate alcune ristrutturazioni e demolizioni di edifici, tra cui il palazzo a fianco della grande torre, forse, in precedenza residenza della potente famiglia di feudatari guelfi Ronchi, per fare posto allo spazioso cortile; in una sorta di insedia-mento polifocale, nel borgo sottostante furono edificate altre case torri, alcune ancora oggi visibili, e anche la primordiale cappella di sant’Antonio (sec. XIV), con accanto probabil-mente anche il «bancum ubi redduntur iura comunitatis Valcamo-nice».
Tra gli scontri e le abili tattiche di consorteria per il con-trollo del potere tra Visconti e Malatesta, agli inizi del XV secolo la rocca brenese era, con evidenza, di particolare in-teresse strategico: forse anche a causa dell’uccisione del con-nestabile, avvenuta nell’ottobre del 1403, il podestà Oddone Spinola, «pro tutela et defensione dicti castri», il 6 marzo 1404 non aveva ritenuto opportuno recarsi al «solitum banchum positum
38 la rocca di breno: tra preistoria e storia
in loco Breni» per comminare la condanna della consorteria Ronchi in occasione delle ruberie commesse a danno dei Federici e aveva chiesto al cancelliere Antonio da Caleppio di registrare l’atto «in cansellaria castri»; durante lo stesso anno fu mandato come podestà e castellano Cressone Crivelli che agì energicamente per sedare le ribellioni; in quegli anni, altri atti risultano emanati dalla fortezza che vide il rafforzamento del-le difese e concessioni di ampi privilegi, fra cui quelli dati da Milano l’11 giugno 1407 e il 27 maggio 1420 che, tra l’altro, ammettevano le spese per il castellano ducale con presidio.
Negli atti di Lorenzo de Vegiis fu Giovanni, di Monza, notaio e cancelliere del podestà e capitano di Valle Camonica, il 13 aprile 1421, «in castrum Breni», fu steso un compromesso tra Bartolomeo di Cemmo fu Girardo, da una parte, e i pro-curatori dei comuni valligiani, dall’altra, con mediazione di Ambrogio Crivelli sindaco di Valle, nella controversia relativa alle richieste avanzate dal detto Bartolomeo, anche in nome del defunto fratello Bochazo di Cemmo, a proposito della cu-stodia del castello, delle spese sostenute per esso e dei danari dati al castellano brenese Amedeo Suardi.
I Visconti, fidando eccessivamente nella potenza della fa-miglia Federici, caddero presto in disgrazia ai camuni che, non vedendo di buon occhio la reintegrazione dell’aristo-crazia ghibellina in Valle, appoggiarono soprattutto i guelfi, tra questi particolarmente i Ronchi di Breno, e l’intervento del capitano di ventura Francesco Bussone, conte di Carma-gnola, che per conto di Venezia fece avanzare le sue truppe dieci miglia sopra Breno. In quel frangente, tra i molti episodi di ribellione anche quello del castellano di Breno che si era impadronito dei beni di alcuni ribelli e si rifiutò di pagare le tasse al duca milanese assieme alla Valle. Più tardi Marin Sa-nudo, diplomatico e memorialista veneziano, poteva scrivere: «Ai 15 di novembre del 1427 i nostri di Bresciana ebbero la Valle di Camonica con alcune fortezze dentro la detta Valle e massime il castello di Bré».
il territorio durante la pax veneta. Il dominio della ca-sata milanese ebbe termine con la pace di Ferrara (18 aprile 1428) che sancì la conclusione del conflitto con la Repubblica di Venezia, riconoscendole la supremazia su tutto il Bresciano, anche se negli anni seguenti la situazione rimase comunque turbolenta a causa di alcuni focolai di resistenza antivenezia-na, segnalati da diverse località camune, fomentati dai ghi-
la rocca di breno: tra preistoria e storia 39
bellini Federici, di cui molti beni furono confiscati, anche a vantaggio dei fedeli a Venezia, come nel caso di tale Giovanni fu Graziolo Griffi di Losine che al tempo della ribellione fu ridotto a riparare con la moglie in castello a Breno.
I conflitti di ordine sociale, tra nobili e vicini, dei secoli precedenti trovarono equilibrio e composizione nel saggio governo veneto che seppe conciliare la ragion di stato con l’autonomia locale: venne insediato come capitano di Valle, con uno stipendio annuo di 900 ducati d’oro, il nobile vene-ziano Giacomo Barbarigo; la Valle, con ducale 1 luglio 1428 del doge di Venezia Francesco Foscari, ottenne la concessione di giurisdizione separata da Brescia, Breno divenne sede del governo valligiano, affidato a un capitano per gli affari civi-li, forse residente nel castello, un vicario per le questioni di giustizia (scelti nell’ambito del collegio cittadino) e ad una serie di consigli generali e speciali, propri statuti e la conferma di alcuni rilevanti privilegi commerciali e da-ziari. I nudi dati archivistici e i freddi reperti archeolo-gici restituiscono un Rinascimento camuno inaspetta-to, attorno al castello, che, grazie alla benefica impronta che il saggio governo veneto seppe esercitare sulle terre separate, divenne il fulcro della vita militare, politica e civile. Luci e ombre si alternano nelle vicende castella-ne: accanto alla vita di palazzo, adeguatamente sfarzosa e benestante, vi era anche la vita produttiva e militare e poi quella dell’amministrazione della giustizia.
Al potere di Venezia e al privilegio dogale tentò di far fronte, senza successo, la calata delle truppe viscontee da Corteno fino a Breno, che mise a dura prova anche il ca-stello, in un assedio durato inizialmente sei mesi e proseguito poi fino all’estate del 1440: molti scontri seguirono per il controllo della rocca che resisteva a oltranza, in cui si distin-sero il capitano di Valle Pietro Contarini, il castellano conte Giovanni Negroboni e Martino Leoni, Lorenzo, Giacomo e Marone Ronchi, il quale aveva chiamato in difesa gente da ogni parte, fin da Pezzaze in Valtrompia e, a proprie spese, ave-va rifornito il castello di «blado, vino, caseo et aliis rebus necessa-riis» a tal punto che un testimone oculare, tale Bartolomeo da Antignano, abitante a Breno, racconta che «gli assedianti ogni giorno ripetevano che avrebbero impiccato tutti i difensori se non si fossero arresi». Un diploma del camerario duca-le Pietro Visconti venne emanato da Corteno il 15 ottobre 1438 (fig. 17), per conferire ampie esenzioni alla Valle, ormai
Fig. 17. Stemma visconteo, particolare dal Privilegio del camerario ducale Pietro Visconti, Corteno 15 ottobre 1438, Raccolta“R. Putelli”,Breno, perg. 609(foto A. Giorgi).
40 la rocca di breno: tra preistoria e storia
irrimediabilmente fuori dal controllo milanese. Non appena anche il castello della città di Brescia si liberò dall’assedio delle truppe milanesi, Venezia, con ducale 22 giugno 1439, le consegnò la soggezione di tutti i luoghi del territorio «ut om-nia membra cum corpore sint unita» e, in seguito, venne stabilito che il capitano valligiano dovesse essere un nobile bresciano, designato con nomina approvata dal consiglio della città. Il castello brenese venne restaurato dai danni subiti negli ultimi anni di guerra e destinato ormai esclusivamente a fortezza e, attorno alla metà del secolo, invece, veniva acquistata una casa, accanto alla chiesa di sant’Antonio, destinata al riadattamento come Palazzo della Ragione.
In un’iniziale situazione di notevole incertezza nell’am-ministrazione, dopo una serie di prove di potere, defezioni e concessioni ai propri sostenitori, fra Venezia e Milano la pace non durò a lungo. Morello Scolari, capitano di ventura di Francesco Sforza, con i suoi cavalieri armati con la stregone-ria delle armi da fuoco e con l’appoggio di alcuni locali, tra il 1453 e il 1454, dopo aver assoggettato la bassa Valle sferrò l’attacco alla fortezza di Breno, trovandovi una resistenza ac-canita da parte dei brenesi, al comando del capitano di Valle, il nobile Pietro Contarini, ma soprattutto da parte del castel-lano Nicolò Rizzi, del cavaliere bresciano Decio Avogadro e degli esponenti delle famiglie Leoni e Ronchi. Cominciò così un nuovo estenuante assedio al castello, che vide la stre-nua resistenza di Pasino Leoni, minacciato da sotto le mura dello smembramento dei corpi del padre Martino, fornitore delle vettovaglie ai resistenti, e del fratello minore, e di tale Giovanni di Scalve, capitano di giustizia e custode delle car-ceri valligiane, che si era adoperato come emissario per la Serenissima e per questo aveva subìto la distruzione della sua casa e aveva visto perpetuati oltraggi ai propri familiari, «cum partibus inferioribus nudis missis per totum exercitum». Il duca di Milano, vista la valorosa resistenza, mandò Sagramoro Viscon-ti, facendo avanzare verso Breno Bartolomeo Colleoni che fece capitolare la rocca tra il 24 e il 28 febbraio 1454.
Il 9 aprile 1454, la pace di Lodi mise fine alle contese tra Repubblica Serenissima e Ducato di Milano per il controllo sulla Valle: il territorio bresciano e camuno passò definitiva-mente sotto il dominio veneto. L’anno seguente, per evita-re eventuali episodi di resistenza, Venezia ordinò e attuò la distruzione di tutti i castelli e rocche esistenti sul territorio valligiano, con l’esclusione di quello di Breno, che venne de-
la rocca di breno: tra preistoria e storia 41
stinato a sede del reggimento locale, oltre che quelli di Cim-bergo e Lozio, tenuti da famiglie schierate con la dominante. Al 19 maggio 1456 risulta un lascito a favore della fabbrica di san Francesco «a Balbarino» effettuato da madonna Bona fu Pasolino Crosotelli di Villanuova di Gavardo, residente tra le mura del castello di Breno, moglie del «magistro» tedesco Girardo fu Alberto de Nortinch «de Alamanea Bassa».
Pasino Leoni, coadiuvato da Giovanni di Braone e Gio-vanni Aliprando, «compiva la pietosa opera di sanare le ferite al venerando maniero dal 12 luglio al 31 ottobre 1457 e dal 3 febbraio al 10 maggio 1458»; il 6 agosto 1467, riceveva per-sino uno stipendio e il glorioso titolo di connestabile. Nicolò Rizzi, che era stato precedentemente riconfermato castellano brenese, presentandosi davanti al capitano nel 1459, pretende-va dalla Comunità di Valle «feno, palia et strame per duj cavalli [...] come sel fusse homo d’arme».
Il 28 settembre del 1468 si decideva, «quia arx Breni Vallis-camonice magnis ponderis est», di eleggere come castellano un nobile veneto che durasse in carica due anni, con lo stipen-dio di 25 ducati al mese e con la proibizione di uscire dalla rocca senza licenza. Con la nomina del nobile Gabriele Bon, 23 agosto 1471, Venezia gli concedeva l’uscita dalla fortezza, non più di una volta a settimana, lasciandovi al suo posto un luogotenente. Nel 1474, Simone Leoni fratello del valoroso Pasino, «volendo comparir in Senato, per conseguire in testa sua la confermatione de Privilegi già concessi à tutta la sua casa, fu accompagnato dal Nobil Signore Marc’Antonio Cal-bo Castellano di Breno». Il castellano veneto Antonio Canal, cui nel 1482 spettavano «page 50, al mese lire 155», come a quello di Pontevico, nel dicembre dello stesso anno ottenne «parecchi guastadori e molto legname su nella fortezza per farvi ristauri e rinforzi». Nel 1488, fattovi castellano il no-bile Nicolò Pizamano, «in quella carica venuto a morte, fu sepellito nella Chiesa de’ Padri Conventuali di San Pietro» in Barberino.
Verso la fine del Quattrocento la Comunità di Valle ac-quistò il fabbricato di fronte alla chiesa di sant’Antonio, vista la vicinanza con il palazzo della Ragione dove il capitano di Valle rendeva giustizia, per collocarvi le prigioni che prima erano nella rocca, la quale, poiché le minacce dell’imperatore contro Venezia erano sempre incombenti e durarono anche nei primi anni del Cinquecento, a seguito della richiesta di rinforzi da parte del capitano di Valle, fu presidiata da «12
42 la rocca di breno: tra preistoria e storia
sciopeti, 6 archibusi, 4 spingarde et do barili de polvere». Come esito della protesta dei deputati valligiani, il 18 ottobre 1498, i rettori bresciani scrivevano a Jacobo Michel, «castel-lano dignissimo», lamentando che «in publica mercantia jn quella rocha che voi seti zudese et executor in fato proprio», ingiungendogli di non intromettersi in tali atti, spettanti al reggente di Valle, e comandandogli, inoltre, di non «lassar usar li compagnie fuora dj quella rocha ma far che istiano ale sue guardie». Inoltre, tra febbraio e giugno 1492, a seguito di am-pio dibattimento con strascichi fino a dicembre, fu ricostruita a spese di Venezia la caserma che era crollata, in cui erano ospitati dieci armigeri che presidiavano la fortezza; il 27 lu-glio del 1496, Andrea Gabriel sollecitava la consegna del le-gname che la comunità gli doveva fornire come castellano; altri lavori di riparazione necessitavano nell’estate del 1497, per i quali si chiedeva l’intervento di Brescia; per riparazioni alle mura della fortificazione, il 27 gennaio 1500, venivano forniti a spese della Serenissima, tramite il capitano bresciano, legnami «de castegna, de pin e de pagera et de larese»; ancora l’11 maggio 1506 il custode castellano Alvise Contarini pre-stava cinque ducati ad Antonio Curti da Borno. La peste, che si diffuse in Valle già dal gennaio del 1504, a metà aprile colpì anche tre ospiti della rocca, costringendo il castellano a porli «extra castrum», con la conseguente grande preoccupazione da parte della Comunità valligiana, che impose, anche in nome dei cittadini brenesi, di non spostare i contagiati, per evitare la possibile diffusione della malattia. In quegli anni di stabilità politica la fortezza bisognosa «assai di riparationi e monition» venne nuovamente ampliata e modificata, su indicazione del castellano e forse anche sotto la guida dell’ingegnere Giaco-
mo da Gavardo.Nel 1508 a seguito della Lega di
Cambrai, Luigi XII di Francia mar-ciò contro Venezia, sconfiggendola ad Agnadello (1509) e divenendo signore di Brescia, di Bergamo e della Valle; il 23 maggio 1509 la roccaforte di Breno cadde in mano agli oppositori di Ve-nezia, discendenti dagli antichi avver-sari federiciani, e il castellano, Matteo Zantani, fortunosamente fuggì aiutato da Vincenzo Ronchi, si insediò inve-ce il castellano francese. I camuni ini-
Fig. 18. Frammento di brocca in ceramica, con profilo di donna, secc. XV-XVI, Museo camuno, Breno(foto A. Giorgi).
la rocca di breno: tra preistoria e storia 43
ziarono una strenua lotta di resistenza all’occupazione francese, e, nel febbraio 1512, la rocca brenese, ancora per ope-ra di Vincenzo Ronchi, forse assieme a Valerio Paitone, venne riconquistata, ma fu per pochi giorni perché, a cau-sa dell’avanzamento dei francesi, costui abbandonò l’impresa permettendone una nuova occupazione, ad opera di Stefano Bastier, comandante di Tirano; a poca distanza di tempo, pare che lo stesso Ronchi, dopo essere stato im-prigionato in castello «acciò pagasse le robbe che furono tolte al castellano», fosse stato liberato con salvacondot-to. Dopo altro allarme per la diffusio-ne della peste nell’alta Valle, Vincenzo Ronchi organizzò un nuovo tentativo di liberare la nostra fortezza, con l’aiuto di mille tra fanti e cavalieri al comando del valtrumplino Giacomino Negroboni: un primo assedio, con «grande scale per mettere a torno al Castello», in cui mo-rirono «tre d’arcobuso», si risolse in una ritirata delle truppe per la promessa di 200 ducati da parte del castellano francese; un nuovo clamoroso assedio, durato cinque giorni, terminò il 13 giugno dello stesso anno con la liberazione dai francesi. Al limite con la leggenda sono le vicende relative: l’intervento delle truppe al comando di Valerio Paitone, che non riusciro-no a catturare il castellano Pietro Zanotti, liberato dal conte Antonio Lodroni; il ricordo del ricco bottino che costui ave-va nascosto, recuperato dai bresciani, e del presidio lasciatovi del mercenario Giacomo Antonio Pochipanni che vendette «tutto per fina le prede del castel et quel che non poté vende-re menò via.» Matteo Zantani, castellano brenese, rimesso al suo posto, con «facoltà di mettervi egli quelli Provisionati, e Guardie, che stimava a proposito per il Servitio Publico, con i soliti salarii, da cavarsi dalle taglie, che la Valle contribuisce alla Serenissima Signoria», si ritirò dal suo incarico il 14 settembre 1512, ma già nell’ottobre, per «non haver salario alcuno né pur esserli sta deputato», il sostituto minacciava d’abbandona-re il suo posto se il senato veneto non avesse provveduto: gli furono corrisposti «diexe ducati d’oro», ribadendo che «stagi serato, secundo solevano far li castellani de esso luogo».
Fig. 19. La torre-porta vista dall’ingresso(foto A. Giorgi).
44 la rocca di breno: tra preistoria e storia
Ben presto subentrarono gli spagnoli, che, già padroni del ducato di Milano, presero il sopravvento fino alla pace di No-yon (1516), quando la Valle Camonica ritornò a Venezia: le vicende che si svolsero attorno alla rocca ci parlano, il 13 settembre 1513, della nuova nomina di Andrea Protino come castellano, con il perentorio comando che «staga in detto ca-stello et tengalo cum quella compagnia che s’è tenuto tanto al tempo de’Veneti che de’Franzosi»; la questione del pagamen-to del castellano si complicò oltremodo, dal momento che il governatore spagnolo, non rispettando i privilegi camuni, so-stenne che dovesse essere stipendiato dalla Comunità di Valle e, al contrario, i valligiani proposero il pagamento da parte della Camera erariale di Brescia.
Dopo la vittoria di Melegnano, il 15 settembre 1515, ve-niva mandato come castellano a Breno con buon presidio il nobile Carlo Emiliani o Miani; per iniziativa di costui, nel dicembre di quell’anno, vennero effettuati altri interventi strutturali al «castrum sive fortilitium», mentre le truppe valligia-ne, sotto la sua responsabilità, respinsero con valore gli assalti dal Mortirolo e dall’Aprica, ricevendone ringraziamento dei provveditori veneti; non si hanno notizie certe di come fu re-spinto l’attacco dei conti Lodroni nel corso del 1516, che, pur devastando l’abitato, forse non causarono problemi alla rocca, probabilmente anche per l’impiego degli «schiopetti» ad ot-tanta colpi che C. Emiliani aveva presentato a Venezia qualche anno prima, anche se nel frattempo si erano asserragliate a Breno le truppe dell’imperatore Massimiliano d’Asburgo.
Con la stabilizzazione politica che era subentrata con il do-minio veneto sulla Valle e a seguito della fedeltà dei valligiani a Venezia, conseguenza di una politica fiscale poco oppressiva e di un certo lassismo amministrativo, a partire dal 1518, la rocca, non più indispensabile per il controllo territoriale, sot-to la reggenza del castellano Carlo Emiliani, veniva privata del presidio di stanza di sei uomini «per esser tutta ruinada»; pare che a causa di «certi segni apparsi in cielo que giorni il Serenissimo Pubblico ritrattò per all’hora l’ordine dell’eva-cuatione della Fortezza di Breno» e che i Rettori bresciani comunicarono al castellano, il 30 dicembre, di rimanere in carica. Proprio il castellano brenese, fratello di Girolamo fon-datore della Congregazione dei chierici regolari di Somasca e santo, che era già stato condannato a Venezia per bestemmie nell’aprile del 1514, scrivendo al funzionario veneto Giorgio Marin il 24 giugno 1518, aveva modo di raccontare una delle
la rocca di breno: tra preistoria e storia 45
pagine più fantasiose della storia camuna, in cui allertava le autorità venete sulla presenza delle streghe in Valcamonica; fu proprio in quella occasione che il rettore di Brescia lo riconfermava come responsabile nella rocca che ormai era privata di guarnigione. Certo è che il fortilizio, nella seconda metà del secolo, risultava «inhabitato»: il capitano di valle e gli altri funzionari avevano trovato sistemazione nel palazzo nel cuore del paese. Neppure la chiesa di san Michele arcangelo «in arce Breni» doveva essere ancora in funzione (fig. 20), se nei decreti della visita pastorale del vescovo Giorgio Celeri, il 31 agosto 1578, viene descritta come «consunta dal tempo».
«un castello posto in luogo eminente, et molto Forte, che altre volte era una delle principali Fortezze che Fusse in Questa valle». Già dal 21 marzo 1583 la Serenissi-ma Repubblica di Venezia aveva perso l’interesse per la rocca, affidandola al Comune di Breno come investitura per una pensione annua e poi «nella visita fattaci il 18 giugno 1586 un governatore veneto ed il Capitano di Brescia si dichiararono contrari ai restauri come ormai inutili». Il 21 marzo 1586 la Comunità di Valle aveva anche valutato la possibilità di ospitare all’interno della struttura i padri cappuccini dell’eri-gendo convento di san Francesco a Mezzarro di Breno, che probabilmente trasferirono gli apparati e gli arredi liturgici della chiesa del castello all’altare di san Miche-le, presente nel loro cenobio. Infine, siccome «la nuova tecnica delle pugne per le nuove armi ed il cessare del bisogno di valersene l’avevano lascia-to in abbandono», il 9 maggio 1598, «acciò non rimanesse inutile quel suolo in paese angusto di sito», dopo due tentativi d’incanto andati deserti a Breno, veniva venduto, «sotto la loggia publica» di Brescia, il terreno entro le mura castellane di piò 1, tavole 59, piedi 10 et onze 6, «posto a mon-te, parte al prato montivo, già detto il Castellaz-zo», assegnato al Comune brenese, rappresentato dal dottor G. B. Leoni, per 620 lire veneziane e il 6 giugno stesso si stendeva l’istrumento di com-pera formale. Il 23 dicembre 1605, il Comune di Breno, a seguito di una controversia con Laura Ronchi, figlia del fu Giovan Antonio Ghiroldo, che riven-dicava la proprietà di un «horticellum [...] intra prima moenia et intra primas duas portas castri», si giunse a una convenzione che
Fig. 20. I resti della chiesa di san Michele inglobati nella cerchia muraria(foto A. Giorgi).
46 la rocca di breno: tra preistoria e storia
pur riconoscendo che «dictum horticellum per communem acqui-situm fuisse ab illustrissimo Dominio Venetiarum simul cum castro», si pagarono 70 lire a madonna Laura, a titolo di indennizzo per gli interventi migliorativi effettuati negli anni precedenti sull’appezzamento nell’antiguardia del castello.
Fig. 21. Resti di affresco scomparso con la Madonna della misericordia con i fedeli, databile alla fine del XV secolo (fotografia dei primi anni del Novecento, di Stefano Vielmi).
«Decadde il palazzotto del castellano, si sfasciarono le ca-serme, crollarono i pontili, le merlature, gli antemurali – su cui a mala pena oggi discernesi traccia degli affreschi agiogra-fici dipinti a protezione – e scomparve quasi del tutto la vaga chiesa romanica [...]. Utilitarismo ne ridusse a vigneti ed orti le piazzette, gli spalti, il gran cortile; smania di villeggiatura lo fece poi coronare di casette moderne». Per molti anni il complesso sistema di mura difensive divenne una cava di pie-tra per la costruzione delle case nel paese e la collina fu uti-lizzata come ideale spazio agricolo per le coltivazioni ortive.Accanto alla testimonianza giuridico-amministrativa, quella economico-sociale stilata dal podestà di Brescia Giovanni da Lezze nel suo Catastico del 1610: «Questo territorio produce biave, vini, et altri frutti massime castagne. Li habitanti molti sono contadini, che attendono all’agricoltura, molti altri sono bottigari, et artisti, et molti altri attendono al Palazzo, et la maggior parte di essi habitanti sono forestieri quivi concorsi per occasione del Reggimento, qual molti anni sono che dà udienza in questa terra, dove tutta la Valle concorre per la Giustitia, non essendovi Reggimento in altra terra. Qui sono da dieci dottori per ordinario con altri tanti nodari, et alcuni procuratori, vi sono anco molte famiglie nobili, fra le quali le principali sono di Federici, che sono sette case, li Griffi che sono due case, poi seguono li Ronchi, che sono da dieci case, li Leoni che sono tre case, li Alberzoni che sono tre case, Cat-
la rocca di breno: tra preistoria e storia 47
tanii una sola casa et vi sono sei molini, et un castello posto in luogo eminente, et molto forte, che altre volte era una delle principali fortezze che fusse in questa Valle, et questa terra si può dir la Metropoli di essa Valle». Nel corso di vent’anni le condizioni del complesso non dovevano certo essere mi-gliorate se, descrivendo lo stato della provincia nel 1643, il consultore Lodovico Baitelli, che aveva avuto l’incarico dalla Repubblica di Venezia di delineare i confini del territorio bresciano, ricordava: «la rocca antica, che vi è, se ben quasi distrutta, doveva esser nelli andati tempi custodia molto forte del passo». La descrizione di padre Gregorio Brunelli, sulla fine del XVII secolo, rimanda invece a una percezione pae-sistica d’insieme: «Et un quarto di miglia più oltre [al ponte di Minerva] si vede pur alla destra dello stesso fiume [Oglio] alzarsi un colle isolato, in cima al quale sta situata la Fortezza di Breno di grosse mura, e diverse ritirate, fiancheggiata da due gran Torri, dette una Gibellina, e l’altra Guelfa».
Nel corso del Settecento la rocca abbandonata divenne sempre di più un’ideale cava di pietre: Gasparo Griffi nel 1712 si procurava un’abbondante scorta di sassi «tolti in Castello di Breno [...] per causa di fabricare nel sito di fare la bugada [il bucato]» nella sua casa sita in Contrada della Fonte: l’11 agosto pagava a Giacomo Taboni e Battista Gazzoli di Breno 18 «brozzi» e nuovamente il 17 agosto altri 16 «brozzi» per un totale di 34 «vetture». Dalla metà del XIX secolo fino alla data di riconoscimento come monumento nazionale (1912), il comune di Breno diede in locazione il manufatto e i terreni racchiusi a privati e anche al Comizio agrario di Breno, per sfruttamento agricolo sistematico, in cambio anche di inter-venti di manutenzione e di riattamento murario. Tra aprile 1918 e gennaio 1919, inoltre, la rocca venne utilizzata come postazione di osservazione e di combattimento antiaereo, at-tività che procurò anche danni murari, sbancamenti e sposta-mento di derrate di pietre.
Fig. 22. Il gran cortile del castello con la torre maggiore, primi anni del Novecento (cartolina).
48 la rocca di breno: tra preistoria e storia
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
archetti g. e turchini a. 2004Visita apostolica e deceti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia, IV. La Valle Camonica, «Brixia Sacra. Memorie Storiche della Diocesi di Brescia», 1 (2004).
bonavoglia diarista (pseudonimo di R. Putelli) 1934“Cronache di Valle e del Lago pel Marzo 1934”, «Illustrazione Camuna e Sebina», 3 (1934), pp. 15-19.
brunelli g. 1698Curiosi trattenimenti continenti ragguagli sacri, e profani de’ popoli camuni, Venezia.
cozzaglio a. 1895Paesaggi di Valcamonica, Brescia.
Codex Diplomaticus Langobardiae, a cura di G. Porro Lambertenghi, “Historiae pa-triae monumenta tomus 13”, Torino, 1873.
Communitatis Valliscamonicae Statuta, Brescia, 1428.
da lezze G.1969-1973Il Catastico bresciano di Giovanni da Lezze (1609-1610), Brescia, voll. I-III (edizione anastatica del ms in BQBS: H.V.1-2).
da soldo C. 1437-1468La cronaca di Cristoforo Da Soldo, a cura di G. Brizzolara, “Rerum Italicarum Scrip-tores. Raccolta degli storici italiani da Cinquecento al Millecinquecento”, Bolo-gna, 1942.
Fedele F. 1988L’uomo, le Alpi, la Valcamonica. 20.000 anni al castello di Breno, Breno.
Fedele F. 2012L’uomo, le Alpi, la Valcamonica 20.000 anni al Castello di Breno. Elementi di aggiorna-mento, in corso di stampa.
Fedele F. et al. 2012“Datazioni radiocarboniche AMS di siti archeologici del Castello di Breno, primo contributo: sito BC3”, «Notizie Archeologiche Bergomensi», 18 (2010), pp. 5-32, in corso di stampa.
guerrini P. 1922“Per la storia dell’organizzazione ecclesiastica della diocesi di Brescia nel Medio-evo. Il Catalogo capitolare delle chiese e dei benefici compilati nell’anno 1410”, «Brixia Sacra», XIII (1922), pp. 3-12; 24-31; 57-69; 90-106.
guerrini P. 1927“Pier Paolo Ormanico. Memorie della famiglia Ronchi di Valle Camonica”, in Le cronache bresciane inedite dei secoli XV-XIX, “Fonti per la storia bresciana III”, Brescia, pp. 327-338.
guerrini P. 1939“Per la storia della nobiltà camuna del Medio Evo. I Ronchi di Breno e i Nobili di Lozio”, «Rivista del Collegio araldico», pp. 433-442, 481-482, 504-513 (ripub-blicato in P. Guerrini, Araldica. Famiglie nobili bresciane, “Pagine sparse I”, Brescia, 1984, pp. 336-356).
lupo M. 1784-1799Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis, Bergamo, voll. 1-2.
la rocca di breno: tra preistoria e storia 49
Margaroli P. 1997Le pergamene Belgioioso della Biblioteca trivulziana di Milano (secoli XI-XVIII). Inven-tario e regesti, Milano, voll. I-II.
Monumenta Germaniae Historica. Die Urkunden der Karolinger. Erster Band. Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Grossen. Diplomata Karolinorum. Tomus I, Pippini, Karlomanni, Karoli Magni Diplomata, a cura di E. Muehlba-cher, con la collaborazione di A.Dopsch, J. Lechner, M. Tangl, Hannover, 1906 (ristampa: 1991).
Odorici F. 1853-1865Storie bresciane dai primi tempi sino all’età nostra, Brescia, voll. 1-11.
Pasero C. 1938“Aspetti dell’ordinamento militare del territorio brescaino durante il dominio ve-neto (sec. XVI)”, «Commentari dell’Ateneo di Brescia» (1938), vol. A, pp. 24-25.
Pasero C. 1939Relazioni di rettori veneti a Brescia durante il secolo XVI, Supplemento ai «Commen-tari dell’Ateneo di Brescia», Toscolano.
Pasero C. 1958Francia Spagna Impero a Brescia. 1509-1516, Supplemento ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia», Brescia.
Pezzotti F. 1978“La Valle Camonica nell’Alto Medioevo”, «Quaderni camuni», 2 (1978), pp. 101-140.
Putelli R. 1907Mezzo secolo di storia della Valle Camonica (1420-1470), estratto dalla «Rivista di scienze storiche», 1907, Pavia.
Putelli R. 1909Le chiese di Valle Camonica: le chiese di Breno, Breno.
Putelli R. 1915Intorno al castello di Breno: storia di Valle Camonica, Lago d’Iseo e vicinanze da Federico Barbarossa a S. Carlo Borromeo, Breno (altre edizioni: Valle Camonica e Lago d’Iseo nella storia, Breno, 1923; una riproduzione anastatica della prima edizione).
Putelli R. 1918“Si pronuncia la condanna, incomincia l’agonia del Castello di Breno (1583-1598)”, «Illustrazione Camuna», 5 (1918), pp. 2-3.
Putelli R. 1920Altre vestigia d’arte in Valle Camonica. Proposte d’aggiunta all’elenco ministeriale, Breno.
Putelli R. 1924Storie bresciane e bergamasche da inediti documenti del R. Archivio di Stato in Venezia, Breno.
Putelli R. 1932“Castelli di Valle Camonica”, «Illustrazione camuna e sebina», 4 (1932), pp. 8-11.
Repertorio diplomatico visconteo: documenti dal 1263 al 1402, a cura della Società storica lombarda, Milano, 1911-1918, tomi 1-2.
Rosa G. 1886Guida al lago d’Iseo ed alle Valli Camonica e di Scalve, Brescia.
50 la rocca di breno: tra preistoria e storia
Rosa G. 1911“L’arte in Valle Camonica”, «Illustrazione Camuna», 8 (1911), pp. 5-6.
Sanudo M. 1847Itinerario di Marin Sanuto per la terraferma veneziana nell’anno MCCCCLXXXIII, a cura di Rawdon Brown, Padova.
Sanudo M. 1879-1902I diarii di Marino Sanuto: 1416-1533 dall’autografo marciano ital.CL VII codd. CD-XIX-CDLXXVII, Venezia, voll. 1-59.
Tarsia S. 1989“Relazione della visita pastorale fatta in Valcamonica (versante sinistro) da Giorgio Celeri dal 20 luglio al 20 settembre 1578”, «Quaderni camuni», 46 (1989), pp. 175-204.
Valetti I. 1976Le comunità di valle in epoca signorile. L’evoluzione della Comunità di Valcamonica duran-te la dominazione viscontea (secc. xiv-xv), Milano.
Zambarbieri T. 1988Castelli e castellani viscontei. Per la storia delle istituzioni e dell’amministrazione ducali nella prima metà del XV secolo, “Studi e testi di storia medievale 18”, Bologna.
RIFERIMENTI DOCUMENTARI
Archivio di Stato, VeneziaBaitelli Ludovico, Confini della città di Brescia con le ragioni d’essa MDCXXXIII: ms Provveditori sopra la camera dei confini, b. 18 (altre copie: Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia: ms It., VII. MCLV, nel cod. misc. 7453, n. 15, cc. 225r-282r; Bi-blioteca Queriniana, Brescia: ms I.VII.11; ms F.III.6.m.3; minuta con indicazione delle fonti: ms F.III.6.m.4; Biblioteca della Fondazione “Ugo Da Como”, Lonato BS: ms 199).
Archivio storico diocesano, BresciaMensa vescovile: reg. 2, anno 1277; reg. 5, 1296-1299, contenente anche designa-menti del 1348; reg. 14, anno 1351 e seguenti.Visite pastorali: reg. 10, c. 186v; reg. 18, c. 126r; reg. VA 1580, 3, c. 662v.
Biblioteca Queriniana, BresciaOrmanico Pier Paolo, Annali notabili di Valcamonica, in Memorie notabili di Valcamo-nica, ms in miscellanea manoscritta con il titolo convenzionale Historia di varie terre bresciane: BQ: ms C.I.10, m. 1, cc. Ir-VIIIv, 1r-137r.Ormanico Pier Paolo, Fragmenta cuiusdam Libri pene confracti cuiusdam Vincentii Run-chi Breni, manuscripti, Petro Paulo Ormanico ab. Ecc.mo Augustino Comite commodatum mense Februarii transcripta ab eodem Ormanico 1635, in Memorie notabili di Valcamonica, ms in miscellanea manoscritta con il titolo convenzionale Historia di varie terre bre-sciane: BQ: ms C.I.10, m. 1, cc. 143r-155v (copia ms in forma italianizzata in BQ: ms Odorici, 40, edito da Guerrini 1927).
Raccolta “R. Putelli”, Palazzo della cultura, Breno BSRegistro mastro compilato da Gasparo Griffi fu Pietro Angelo 1704-1717: reg. 64.Registri delle deliberazioni dei Consigli della Comunità di Valle Camonica: reg. 1, 1492-1501; reg. 2, 1502-1509; reg. 3, 1512-1516; reg. 6, 1586-1588.Rubrica di atti conservati nella Cancelleria della Comunità di Valle tra XV e XVII secolo: reg. 29.
la rocca di breno: tra preistoria e storia 71
La rocca di Breno:tra preistoria e storia«Quaderni brenesi 1»
© 2012 Comune di Breno-Museo Camuno CaMus, Breno (Bs), ItaliaQuesta pubblicazione è protetta dalle norme nazionali e internazionali del copyright: la riproduzione di parti di testo o immagini deve essere formalmente richiesta e formalmente concessa da parte dei singoli autori.
testi di: Alberto Bianchi,Giorgio De Michelis, Francesco Fedele,Anna Gattiglia, Angelo Giorgi,Lucia Morandini, Maurizio Rossi,Simone Signaroli, Riccio Vangelisti.
coordinamento e curatela:Angelo Giorgi e Simone Signaroli.
Le immagini contenute nei singoli contributi sono di proprietà dei rispettivi autori; le immagini della copertina e a pp. 1, 2, 53, 70 sono state gentilmente concesse dallo Studio fotografico Battista Sedani, Breno (Bs);le immagini a p. 4 e p. 58 sono diLucia Morandini.
ISBN 978-88-96755-07-5Edizioni Torre D’Ercolevia L. Sturzo, 13Travagliato (Brescia)www.edizionitorredercole.it
Finito di stamparenel mese di aprile 2012presso la Tipografia ELC,Travagliato (Brescia)Tel. 030 6864932
Questa pubblicazioneè edita con il patrocinio di: