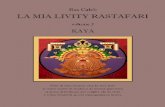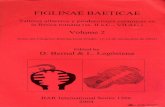La mia pedagogia. Il mio itinerario formativo e di ricerca nell’ambito della Storia...
Transcript of La mia pedagogia. Il mio itinerario formativo e di ricerca nell’ambito della Storia...
Edizion
i ETS
Collana fondata da Leonardo Trisciuzzi e Simonetta Ulivieri
Comitato d’onoreFranco Cambi - Università di FirenzeGiacomo Cives - Università di Roma «La Sapienza»Franco Frabboni - Università di BolognaEliana Frauenfelder - Università di Napoli «Suor Orsola Benincasa»Fanny Gianbalvo - Università di PalermoPaolo Orefice - Università di FirenzeFranca Pinto Minerva - Università di FoggiaVincenzo Sarracino - Università di Napoli «Suor Orsola Benincasa»
Comitato scientifico e refereeRoberto Albarea - Università di UdineCristina Allemann-Ghionda - Università di ColoniaMassimo Baldacci - Università di UrbinoEmy Beseghi - Università di BolognaCarmen Betti - Università di FirenzeGaetano Bonetta - Università «G. d’Annunzio» di ChietiStéphane Bonnery - Università di Parigi 8Antonio Calvani - Università di FirenzeGiovanna Campani - Università di FirenzeMariagrazia Contini - Università di BolognaCarlos Alberto Estêvão Vilar - Università del MinhoPaolo Federighi - Università di FirenzeConsuelo Flecha Garcia - Università di SivigliaAntonella Galanti - Università di PisaSusanna Mantovani - Università di Milano «Bicocca»Alessandro Mariani - Università di FirenzeMarisa Marino - Università di PalermoEkkehard Nuissl von Rein - Università di KaiserslauternSally Power - Università di CardiffFrancesca Pulvirenti - Università di CataniaMaria Grazia Riva - Università di Milano BicoccaDaniela Sarsini - Università di FirenzeNicola Siciliani de Cumis - Università di Roma «La Sapienza»Maura Striano - Università di Napoli «Federico II»Ronald Sultana - Università di MaltaMaria Tomarchio - Università di CataniaGiuseppe Trebisacce - Università della Calabria
Edizion
i ETS
Scienze dell’educazioneCollana di studi, manuali e ricerche
diretta da Simonetta Ulivieri
180.
La Pedagogia, intesa come analisi tanto dei processi educativi, quanto del rela-tivo risultato in termini di capitale umano, sta assumendo un valore emergente ogniqualvolta avviene un mutamento culturale della società. Non è quindi un caso se viene proposta una Collana di Scienze dell’Educazione ad un pub-blico di lettori interessati al settore della formazione (studenti e insegnanti, ma anche genitori ed educatori in senso lato). La Collana si articola in Studi, Ricerche e Manuali. Gli Studi hanno il compito di esporre le riflessioni stori-che, teoriche e sociali sull’educazione e le sue finalità, compiute dai principali esponenti della Pedagogia italiana. Le Ricerche, rivolte agli ambiti: storico, metodologico, sociale, sperimentale, speciale e psicopedagogico, intendono dar conto alla comunità degli studiosi dei risultati di ricerche originali, tenden-ti a rappresentare il vero volto, sul campo, di una Pedagogia scientifica attuale.
I Manuali, infine, si propongono ad uso didattico e intendono fareil punto sullo statuto scientifico dei vari settori disciplinari
che costituiscono il vasto e complesso ambitodelle «Scienze dell’educazione».
Edizion
i ETS
Società Italiana di Pedagogia
La mia PedagogiaAtti della prima Summer School SIPED
a cura diSimonetta Ulivieri,
Lorenzo Cantatore, Francesco Claudio Ugolini
Edizioni ETS
Edizion
i ETS
© Copyright 2015EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]
DistribuzionePDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]
ISBN 978-884674274-2
www.edizioniets.com
Edizion
i ETS
Indice
Parte PrimaSaggi introduttivi
Riflessioni sull’identità del pedagogista. La prima Summer School della siped Simonetta Ulivieri 9Abbiamo bisogno di maestri Lorenzo Cantatore 21“Tu che farai ricerca pedagogica nel 2025” Francesco C. Ugolini 33
Parte SecondaInterventi e saluti dei past presidents siped
Saluto a “La mia Pedagogia”Massimo Baldacci 49Dal presente al futuroMichele Corsi 51La Pedagogia è sguardo sul lontano sull’inattuale sull’utopicoFranco Frabboni 55Il cammino della siped. Dare forza al discorso pedagogicoCosimo Laneve 61
Parte TerzaLa mia Pedagogia in Pedagogia Generale e Sociale
Franca Pinto interprete di una pedagogia dell’hospitalité intellectuelleMaria S. Tomarchio 67
La mia pedagogia: differenza, complessità, ibridazione, utopiaFranca Pinto Minerva 75
Edizion
i ETS
522 La mia Pedagogia
Profilo biografico-antologico di Franca Pinto MinervaA cura di Rosa Gallelli 87
Parte QuartaLa mia Pedagogia in Storia della Pedagogia e Storia dell’Educazione
“La mia Pedagogia” in prospettiva storica. Introduzione al temaGiuseppe Trebisacce 113Maestri e allievi nella ricerca storica: un quadro in cambiamento?Simonetta Polenghi 119L’educazione dei sordomuti: un significativo contributo alla storia della pedagogia specialeMaria Cristina Morandini 125Il mio itinerario formativo e di ricerca nell’ambito della Storia dell’EducazioneRoberto Sani 133Profilo biografico-antologico di Roberto Sani 163
Parte QuintaLa mia Pedagogia in Didattica Generale e Metodologia della Ricerca
L’evoluzione della didattica generale dalla storia all’attualitàGiuseppe Zanniello 177Per un quadro della didattica generale. Muoversi sui confiniRenza Cerri 191Ricerca e identità pedagogica. Una storia di formazioneLoretta Fabbri 201Itinerari di ricerca per un sistema educativo equo ed efficaceGaetano Domenici 211Profilo biografico-antologico di Gaetano Domenici 231Formazione, didattica e nuove tecnologieAntonio Calvani 245Profilo biografico-antologico di Antonio Calvani 261
Parte SestaLa mia Pedagogia in Pedagogia e Didattica Speciale
L’affermarsi della pedagogia speciale. Un panorama storico e attualeLucia De Anna 285
Edizion
i ETS
Indice 523
L’approccio sperimentale in pedagogia e didattica speciale: la ricerca delle evidenze nella prospettiva inclusivaLucio Cottini 295“La mia Pedagogia” nella prospettiva della pedagogia specialeRoberta Caldin 311Educazione e didattica speciale. La mia PedagogiaLuigi d’Alonzo 329Profilo biografico-antologico di Luigi d’AlonzoA cura di Silvia Maggiolini 349
Parte SettimaLa mia Pedagogia in Pedagogia Sperimentale
Pedagogia sperimentale: dai difficili inizi agli sviluppi in corsoLuisa Santelli Beccegato 361Pedagogia sperimentale e professionalità educativeTeresa Grange 371L’evidenza empirica come punto di partenza e punto di arrivo della ricerca in Pedagogia SperimentaleRoberto Trinchero 381Traiettorie tecnologico-comunicative dell’innovazione. Verso la post-pedagogia?Luciano Galliani 391Profilo biografico-antologico di Luciano Galliani 411
Parte OttavaLa mia Pedagogia in Pedagogia Generale e Sociale
La trasversalità dell’educazioneGiuseppe Elia 431Il contributo ampio e complesso dell’opera di Michele Corsi alla pedagogia italianaSusanna Mantovani 437L’opera e la figura di Michele Corsi tra ricerca scientifica e presenze istituzionaliIsabella Loiodice 441La mia Pedagogia. Un itinerario biografico, scientifico e umanoMichele Corsi 447Profilo biografico-antologico di Michele Corsi 471
Edizion
i ETS
524 La mia Pedagogia
Parte NonaInterventi
Quale comunicazione?Laura Clarizia 483L’inter-esse educativo di realismo e costruttivismo. Note per una riflessione pedagogicaEnricomaria Corbi 487Pensare, in grande, lo scacco dell’educativo.Oltre la crisi, l’evoluzioneMaurizio Fabbri 495La didattica come scienza dell’educazioneFloriana Falcinelli 503Pedagogia, utopia, profeziaBruno Rossi 507La Summer School siped e “La mia Pedagogia”. Un contesto di alta formazione per i dottorandi di ricercaFrancesca Dello Preite 511Pedagogia Speciale, “vecchie” e “nuove” categorie di diversità nell’ottica inclusiva.Il contributo del linguaggio teatraleVito Minoia 517
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricercanell’ambito della Storia dell’EducazioneRoberto Sani
Premessa
Sono particolarmente riconoscente alla presidente Simonetta Ulivieri e all’intero Direttivo della Società Italiana di Pedagogia (siped) per l’invito rivoltomi a presentare il mio percorso scientifi-co in questa prima edizione della Summer School destinata ai gio-vani studiosi del nostro settore. È un invito che mi onora.
Sono altresì grato al presidente del Centro Italiano per la Ricer-ca Storico-Educativa (cirse), Giuseppe Trebisacce, e alle colleghe Simonetta Polenghi e Maria Cristina Morandini per i loro compe-tenti e preziosi contributi alla discussione.
Questo invito costituisce per me una sfida assai impegnativa: è tutt’altro che agevole infatti, anche per uno storico quale io so-no, ‘storicizzare’ e rileggere con l’indispensabile distacco critico la propria esperienza di studioso e il proprio percorso di ricerca.
Consapevole di tali difficoltà, mi propongo di ripercorrere in questo intervento il mio itinerario scientifico, inquadrandolo nel più generale scenario accademico e, in particolare, nell’esperien-za della ricerca storico-educativa e scolastica italiana degli ultimi trent’anni; nonché di illustrare i miei principali ambiti di ricerca e gli approdi a cui nel tempo sono pervenuto; in ultimo, di fornire qualche spunto di riflessione sull’attualità che rivesta significato e importanza non solamente per il settore della ricerca storico-educa-tiva e scolastica, ma anche per il più generale ambito delle discipli-ne pedagogiche.
1. Gli studi universitari e la prima formazione alla ricerca
Mi sono iscritto alla Facoltà di Magistero dell’Università di Ro-ma «La Sapienza» nell’autunno del 1977 e ne sono uscito, quattro
Edizion
i ETS
134 La mia Pedagogia
anni dopo, il 14 luglio 1981, con una laurea in Pedagogia conse-guita con il massimo dei voti e la lode discutendo una tesi in Sto-ria Contemporanea con il prof. Pietro Scoppola (correlatore era lo storico del cristianesimo contemporaneo prof. Andrea Riccar-di) sul tema: La Civiltà Cattolica e la politica italiana nel secondo dopoguerra, poi edita, nel 1986, nella prestigiosa collana «Storia Contemporanea» dell’editrice Morcelliana di Brescia diretta da Gabriele De Rosa, con il titolo Da De Gasperi a Fanfani. «La Ci-viltà Cattolica» e il mondo cattolico italiano nel secondo dopoguerra (1945-1962)1.
Nello stesso periodo, ho frequentato diversi corsi dell’Istituto di Scienze Religiose e della Facoltà di Teologia della Pontificia Uni-versità Gregoriana di Roma, primi fra tutti quelli di Storia della Chiesa moderna e contemporanea tenuti all’epoca dal grande sto-rico gesuita padre Giacomo Martina, senza tuttavia conseguire al-cun titolo.
Non è facile descrivere la ‘mitica’ Facoltà di Magistero romana negli anni Settanta e Ottanta del Novecento.
Il ricordo di quella fase storica, dalla quale ci separano solo po-chi decenni, ma che sembra lontanissima per i suoi trascorsi e le peculiari vicissitudini che l’hanno caratterizzata, si concentra ine-vitabilmente – e come potrebbe non essere così? – sulla protesta studentesca e, più in generale, sullo scontro ideologico e politico in atto nel Paese: chi non ricorda il cosiddetto Movimento del ’77, le occupazioni e i cortei, le pratiche violente dell’Autonomia Ope-raia e, nel contempo, l’esperienza dei cosiddetti ‘anni di piombo’ e dell’escalation terroristica culminata con la strage della stazione di Bologna (2 agosto 1980) e con il rapimento di Aldo Moro e l’ucci-sione della scorta (16 marzo 1978) e poi con l’omicidio dello stesso esponente politico democristiano (9 maggio 1978) ad opera delle Brigate Rosse?
In realtà, per un giovane di modesta estrazione sociale prove-niente dall’estrema periferia capitolina che nutriva una grande passione per la ricerca storica e aspirava a crescere culturalmen-te quella stagione offriva anche altro, molto altro. Pur costretta a fronteggiare, al pari delle altre facoltà universitarie della penisola, le gravi carenze organizzative e le crescenti disfunzioni generate
1 Tale lavoro è stato poi ripubblicato, qualche anno fa, in una nuova edizione ag-giornata e accresciuta e con il titolo parzialmente diverso: r. sAni, «La Civiltà Cattolica» e la politica italiana nel secondo dopoguerra (1945-1958), Vita e Pensiero, Milano 2004.
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 135
dalla recente e affrettata trasformazione degli atenei italiani in vere e proprie ‘università di massa’2, la Facoltà di Magistero di Roma – come un articolo apparso sul finire degli anni Settanta nelle pa-gine cittadine de «Il Corriere della Sera» avrebbe autorevolmente confermato – costituiva a tutti gli effetti un’eccellenza per l’eleva-ta qualità dell’offerta formativa erogata, la ricchezza dei servizi e dei supporti culturali forniti agli studenti (biblioteche, laboratori linguistici ecc.), e, soprattutto, l’alto profilo scientifico dei docenti che ne facevano parte in quel periodo.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, è appena il caso di ricor-dare – e mi scuso per le inevitabili omissioni – che la cattedra di Storia della Letteratura Italiana era tenuta da Giorgio Petrocchi, quella di Storia della Filosofia da Armando Rigobello e quella di Sociologia da Franco Ferrarotti; che il comparto storico annovera-va Sofia Gajano Boesch sulla cattedra di Storia Medievale, Massi-mo Petrocchi su quella di Storia Moderna, Giuseppe Talamo sulla cattedra di Storia del Risorgimento e Pietro Scoppola su quella di Storia Contemporanea; il settore pedagogico, infine, vedeva fra gli altri Mauro Laeng sulla cattedra di Pedagogia Generale, Claudio Volpi su quella di Pedagogia Sociale e Fabrizio Ravaglioli titolare della cattedra di Storia della Pedagogia.
Gli anni della formazione universitaria trascorsi nella Facoltà di Magistero di Roma sono stati per me fondamentali per più ragioni. La possibilità di frequentare corsi e seminari nelle diverse discipli-ne con docenti di altissimo livello sempre disponibili al confron-to e, dopo la decisione di chiedere la tesi di laurea al prof. Pietro Scoppola, l’avvio di una stimolante collaborazione con questo bril-lante studioso e con i suoi collaboratori – dal già ricordato Andrea Riccardi, che di lì a poco sarebbe andato a ricoprire la cattedra di Storia contemporanea all’Università di Bari, ad Agostino Gio-vagnoli e a Carlo Felice Casula – hanno contribuito ad allargare notevolmente i miei orizzonti culturali e a confermarmi nella de-cisione di intraprendere la via impegnativa della ricerca scientifica nel settore della storia contemporanea.
Se ripenso al periodo (circa un biennio) di stesura della tesi, e poi agli anni immediatamente successivi al conseguimento della laurea, durante i quali ho avuto la possibilità di insegnare presso le
2 Cfr. u.m. miozzi, Lo sviluppo storico dell’Università italiana, Le Monnier, Firen-ze 1993, pp. 189-411.
Edizion
i ETS
136 La mia Pedagogia
scuole del Pontificio Seminario Minore di Roma e, dunque, di po-ter contare su un reddito stabile capace di consentirmi di condur-re avanti le mie ricerche, trovo spunti ed elementi di un qualche interesse per lumeggiare quelle che – in un’epoca nella quale, nel nostro Paese, non era ancora stato introdotto il Dottorato di ricerca – costituivano le modalità e occasioni più propizie per la crescita e la maturazione dei giovani ricercatori, almeno per quelli che gravi-tavano attorno a Pietro Scoppola e alla sua ‘scuola’.
In primo luogo, le straordinarie lezioni tenute nell’ambito dei corsi ufficiali dallo stesso Scoppola, nelle quali la raffinata erudi-zione, lo stimolante ricorso ad una pluralità di fonti documentarie, l’approccio problematizzante e costantemente preoccupato di for-nire un’interpretazione rigorosa e fondata dei processi storici ana-lizzati si accompagnavano ad uno stile comunicativo immediato e particolarmente efficace, in grado di suscitare, tra i giovani fre-quentanti, unanimi consensi e, sovente, un’istintiva ammirazione.
È pur vero che la collaborazione con il proprio docente di ri-ferimento in vista della stesura della tesi, e poi, dopo il consegui-mento della laurea, per la redazione dei primi lavori di ricerca va naturalmente ben oltre le lezioni cattedratiche, e si sostanzia di di-versi altri momenti e occasioni di confronto e di maturazione.
Dei numerosi colloqui avuti con il prof. Scoppola in quegli anni ricordo ancora – assieme allo stato d’animo di ‘timore’ (reveren-ziale) e di vero e proprio ‘tremore’ che inevitabilmente mi assaliva in queste occasioni – la sollecitazione costante ad allargare i miei orizzonti culturali, a non fermarmi allo studio dei soli libri che po-tevano recare un contributo all’approfondimento degli argomenti della tesi di laurea o alla ricerca che stavo svolgendo, ma a dilatare i miei interessi e ad intraprendere letture sistematiche e organiche, capaci di fornire grandi quadri concettuali e di affinare la capa-cità di analisi e di interpretazione della realtà. Non a caso, tra le ‘letture consigliate’ da Pietro Scoppola figuravano l’opera omnia di don Luigi Sturzo, le opere storiche e gli studi di storiografia di Benedetto Croce, i Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci, per citare solo quelle che affiorano alla memoria, assieme ad una se-rie di ricerche e di contributi più specialistici volti ad approfondire i molteplici aspetti della storiografia politica, culturale e religiosa italiana e francese del Novecento.
Questi colloqui rappresentavano comunque, per chi scrive, anche il momento della valutazione del lavoro svolto. Conservo
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 137
ancora da qualche parte, nel mio archivio personale, i testi datti-loscritti (capitoli della tesi o di libro, articoli per riviste, relazioni o comunicazioni a convegni) sottoposti alla lettura del prof. Scop-pola e contenenti i suoi rilievi e le sue annotazioni critiche. Del-lo Scoppola ‘censore’ dei miei primi contributi di ricerca ricordo an-cora l’estrema precisione delle osservazioni formulate, tese in larga misura a sollecitare un approfondimento della questione, o una in-dispensabile integrazione della bibliografia o della documentazio-ne utilizzate, o, ancora, uno sguardo, un approccio meno banale e scontato a taluni aspetti del tema oggetto della mia indagine.
Debbo confessare che tanta parte del ‘mestiere di storico’ io l’ho appresa da quelle stimolanti osservazioni e da quei rilievi cri-tici di notevole spessore; dalle osservazioni e dai rilievi di Pietro Scoppola e da quelli che, nello stesso periodo, veniva facendo ai miei primi lavori di ricerca l’altra figura centrale nella mia forma-zione di studioso, quella di Andrea Riccardi, alla cui ‘scuola’ ho potuto maturare, tra le tante cose, anche una particolare sensibilità per la dimensione religiosa e spirituale.
Scegliere di fare la tesi di laurea in Storia contemporanea si-gnificava, fra l’altro, applicarsi necessariamente in un lungo e im-pegnativo tirocinio in archivio e in una serie di altre attività volte ad acquisire le indispensabili conoscenze pratiche e gli strumenti fondamentali della ricerca sul campo. Ricordo, a questo riguardo, le esercitazioni svolte presso l’Archivio Centrale dello Stato su di-versi fondi archivistici, tra i quali quelli del ministero dell’Interno relativi alle relazioni dei prefetti sull’ordine pubblico negli anni del secondo dopoguerra; come anche quelle svolte, nello stesso perio-do, presso l’Archivio di Stato di Roma e l’Archivio Segreto Vatica-no su taluni fondi documentari relativi alla vita culturale e religiosa nella Capitale tra Otto e Novecento.
Esercitazioni pratiche, queste, che si sarebbero rivelate di fon-damentale importanza allorché, di lì a poco, mentre ancora atten-devo alla stesura della tesi di laurea, ebbi la possibilità di accedere all’Archivio de «La Civiltà Cattolica» e, più precisamente, di po-ter studiare la straordinaria documentazione inedita della rivista romana della Compagnia di Gesù relativa al secondo dopoguerra. Proprio l’utilizzo di tale ricchissima documentazione d’archivio, alla quale fino a quel momento nessuno studioso aveva ancora avuto accesso, contribuì a far compiere alla mia tesi di laurea un vero e proprio salto di qualità, tale da rendere possibile la sua tra-
Edizion
i ETS
138 La mia Pedagogia
sformazione in una vera e propria monografia, la già ricordata Da De Gasperi a Fanfani. «La Civiltà Cattolica» e il mondo cattolico italiano nel secondo dopoguerra (1945-1962), edita qualche anno più tardi.
Dopo la laurea, mentre attendevo alla revisione della tesi per la sua pubblicazione in volume, sotto la guida di Pietro Scoppola e di Andrea Riccardi ebbi occasione di compiere i primi passi nella ricerca e di farmi conoscere dalla comunità scientifica italiana, par-tecipando con una serie di comunicazioni e di vere e proprie rela-zioni, come usava all’epoca, ad alcuni importanti convegni storici nazionali e internazionali3.
Si collocano in questa stessa fase anche taluni importanti sog-giorni di studio e di ricerca all’estero (Francia, Belgio, Spagna ecc.) e, soprattutto, l’incontro e la collaborazione con studiosi destinati ad esercitare un notevole influsso sulla mia maturazione intellettuale: ricordo, fra gli altri, i francesi Émile Poulat (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) e Jean-Dominique Durand (Université de Lyon 3), lo spagnolo Vicente Faubell Za-pata (Universidad Pontificia de Salamanca) e gli italiani Giacomo Martina (Pontificia Università Gregoriana), Massimo Petrocchi e Gabriele De Rosa (Università di Roma «La Sapienza»), Danilo Ve-neruso (Università degli Studi di Genova) e Francesco Traniello (Università degli Studi di Torino).
Mi piace, in questa sede, ricordare studiosi che si sono fatti, nei miei confronti e nei confronti di tanti giovani ricercatori alle prime armi, autentici ‘maestri’, specialmente in un’epoca come la nostra nella quale, in ambito accademico, il ruolo dei ‘maestri’ e il rapporto maestro-allievo sono riguardati con sospetto e non sola-mente si tende ad assimilare indebitamente la figura del ‘maestro’, del grande studioso capace di far crescere i giovani ricercatori e di creare attorno a sé una vera e propria ‘scuola’, con quella –
3 A titolo puramente esemplificativo, ricordo: r. sAni, Vescovi e mobilitazione cat-tolica nell’età del centrismo, in g. rossini (a cura di), De Gasperi e l’età del centrismo (1947-1953), Editrice Cinque Lune, Roma 1984, pp. 517-531; id., Un laboratorio politico e culturale: «La Civiltà Cattolica», in A. riccArdi (a cura di), Pio XII, Laterza, Roma-Bari 1984, pp. 409-436; id., La Santa Sede e i prigionieri di guerra italiani, in r.h. rAinero (a cura di), I prigionieri militari italiani durante la seconda guerra mondiale. Aspetti e problemi storici, Marzorati, Milano 1985, pp. 201-215; id., Roma cattolica: una idea per un rinnovamento su scala mondiale. La mobilitazione di padre Lombardi, in «Humanitas», XL (1985), n. 1, pp. 59-87; Id., Gli intellettuali italiani e Giovanni XXIII, in «Humani-tas», XLIII (1988), n. 2, pp. 200-230.
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 139
decisamente negativa e priva di ogni autentico afflato culturale e scientifico – del cosiddetto ‘barone’ universitario; ma anche si con-siderano le ‘scuole’ e i cenacoli accademici raccolti attorno ad un ‘maestro’ realtà che attentano alla libertà e all’autonomia dei gio-vani ricercatori, in quanto costituirebbero una forma illegittima di controllo e di limitazione o negazione della libertà di ricerca e dell’accesso alle carriere universitarie.
Sono convinto che debba essere denunciata con forza la vera e propria deriva populista che ispira un simile atteggiamento, nel cui ambito la battaglia in favore della liquidazione o ‘rottamazione’ di una presunta gerontocrazia accademica si nutre di superficiali ge-neralizzazioni e di pericolosi luoghi comuni, primo fra tutti quel-lo in base al quale si dovrebbero affidare i destini dell’università italiana esclusivamente ad una generazione di giovani ricercatori ‘senza padri, né maestri’, tutti pura intuizione e capacità creativa, senza più radici e legami di alcun tipo con le generazioni prece-denti. Questo atteggiamento, fatto proprio in questi ultimi anni dai grandi mezzi di comunicazione di massa e da una parte signifi-cativa della stessa classe politica italiana, ha finito per delegittima-re profondamente l’università nel suo complesso e, nel contempo, ha contribuito ad accreditare un modello di formazione e di reclu-tamento universitario, quello fatto proprio dalla ‘riforma Gelmini’, che sta letteralmente disarticolando la ricerca scientifica e la vita accademica nel nostro Paese.
A differenza di quello che accade nelle cosiddette ‘scienze du-re’, infatti, nell’ambito delle discipline di carattere umanistico, giuridico e sociale il progresso dei saperi non avviene per insight (intuizione), in una logica di tabula rasa, ma per accumulazione e discriminazione delle conoscenze: di qui la necessità di collocare la propria ricerca nel solco di una tradizione consolidata, in un itine-rario già tracciato, di fare nostro ciò che si è fatto in passato e, nel contempo, di misurarsi con la complessità per tracciare, a nostra volta, nuovi solchi e nuovi itinerari.
Ecco perché abbiamo bisogno di maestri. A fronte di tutto que-sto, questo tempo ci appare sempre più caratterizzato dal manife-starsi di una sorta di cesura, ovvero da una vera e propria rottura della continuità negli studi, tra le diverse generazioni di ricercatori, tra vecchi e giovani, tra ‘maestri’ ed ‘allievi’ appunto, con l’inevita-bile rischio di una vera e propria perdita d’identità delle comunità di studiosi che fanno capo ai diversi settori disciplinari.
Edizion
i ETS
140 La mia Pedagogia
2. Gli anni milanesi: un lungo apprendistato come ricercatore e come docente (1988-2000)
In questo paragrafo mi ripropongo di approfondire «gli anni milanesi», ovvero la stagione iniziata nell’aprile del 1988 con il su-peramento del concorso ad un posto da ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 53 (Pedagogia) bandito dalla Facoltà di Magistero dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la quale si sarebbe conclusa dodici anni più tardi, con il definiti-vo abbandono del capoluogo lombardo a seguito della chiamata, nel giugno 2000, a ricoprire la cattedra di Storia della Pedagogia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata.
A distanza di poco più di un triennio dalla nomina a ricercato-re in Cattolica, risultato tra i vincitori del concorso nazionale, nel novembre 1992 avevo lasciato una prima volta Milano per pren-dere servizio, in qualità di professore di seconda fascia di Storia della Scuola, nella Facoltà di Magistero dell’Università degli Stu-di di Genova. Da tale sede, nel novembre 1995, a conclusione del triennio di conferma in ruolo, ero stato nuovamente richiamato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, come profes-sore associato di Storia della Pedagogia presso la Facoltà di Scien-ze della Formazione. Un quinquennio più tardi, nel marzo 2000, conseguivo l’idoneità nella procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia per il settore M-PED 02 (Storia della Pedagogia) bandita dall’Università degli Studi di Lec-ce e, come sopra accennato, nei mesi seguenti ero nominato straor-dinario di Storia della Pedagogia nell’Ateneo maceratese.
Il mio approdo in qualità di ricercatore alla Facoltà di Magiste-ro della Cattolica di Milano, nella seconda metà degli anni Ottan-ta, fu abbastanza casuale. All’origine di tale sviluppo degli eventi debbono essere collocate una serie di ragioni, prima fra tutte la de-cisione di Pietro Scoppola di sospendere provvisoriamente l’inse-gnamento e l’attività accademica per impegnarsi in politica. Dopo aver partecipato in qualità di delegato della cosiddetta «assemblea degli esterni» al Congresso della Democrazia Cristiana del 1982 che avrebbe eletto Ciriaco De Mita segretario nazionale del parti-to, infatti, Pietro Scoppola aveva accolto la candidatura al Senato in un collegio blindato di Roma come indipendente nelle liste DC nelle elezioni per la IX Legislatura (1983-1987).
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 141
Il sempre maggiore coinvolgimento nell’attività politica e parla-mentare di Scoppola, a partire dal 1983, contribuì indubbiamente a rendere più incerta e problematica la mia collaborazione con la cattedra di Storia contemporanea e, più in generale, con l’Istituto di Scienze Storiche dell’Università di Roma, spingendomi a cerca-re nuovi interlocutori e una diversa collocazione accademica. Su questo terreno, mi fu di grande aiuto lo stesso studioso, divenuto ora senatore, il quale si fece sostenitore, assieme ad Andrea Ric-cardi, di un mio diretto coinvolgimento in un progetto di ricerca nazionale, coordinato dal prof. Luciano Pazzaglia dell’Università Cattolica di Milano, sull’operato della Chiesa e dei cattolici italia-ni in ambito educativo e scolastico nell’Italia dell’Otto e del No-vecento; progetto che, all’epoca, era stato appena avviato e che, come testimoniano gli esiti del convegno di studi su Don Lorenzo Milani tra Chiesa, cultura e scuola, svoltosi all’Università Cattolica di Milano il 9 e 10 marzo 1983, aveva mostrato da subito le enormi potenzialità insite nella collaborazione tra gli storici della pedago-gia e della scuola e gli studiosi di storia della Chiesa e del cattolice-simo in età contemporanea4.
L’incontro con Luciano Pazzaglia e l’avvio della collaborazione con il gruppo di storici dell’educazione e della scuola che faceva-no capo al Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica di Milano, tra i quali ricordo in particolare Luciano Caimi e Giorgio Chiosso, maturarono in questo contesto e sfociarono poi, alcuni anni più tardi, dopo il superamento del concorso da ricercatore universitario in Cattolica, nel mio trasferimento in pianta stabile a Milano.
Nel capoluogo lombardo, come membro della «sezione sto-rica» del Dipartimento di Pedagogia della Cattolica sarei stato al contempo testimone e co-protagonista dell’ambizioso progetto di rinnovamento della storiografia educativa e scolastica promosso e coordinato, a partire dai primi anni Ottanta, da Luciano Pazza-glia. Un progetto, deve essere sottolineato, che avrebbe impresso un marchio indelebile alla ricerca storico-pedagogica ed educativa nel nostro Paese e dato corso ad alcune indagini di ampio respiro e d’indiscussa importanza, favorendo altresì l’emergere nel nostro settore di studi di una nuova generazione di ricercatori, maggior-mente attrezzata sotto il profilo metodologico e storiografico.
4 Don Lorenzo Milani tra Chiesa, cultura e scuola, Vita e Pensiero, Milano 1983.
Edizion
i ETS
142 La mia Pedagogia
In generale, Luciano Pazzaglia condivideva con diversi altri stu-diosi dell’epoca la necessità di superare l’impostazione storiografica tradizionale e di andare oltre la vecchia storia del pensiero pedago-gico e delle teorie educative, per dare spazio ad una storia dell’edu-cazione e della scuola considerata nel suo significato più ampio, co-me storia delle dottrine sì, ma anche delle istituzioni, delle pratiche, dei costumi, della mentalità ecc. La sua posizione, tuttavia, non si esauriva nell’istanza di un pur decisivo superamento dell’ormai esangue storiografia pedagogica di matrice gentiliana, ma s’imper-niava su una concezione della storia dell’educazione e della scuola come ambito privilegiato per cogliere e valutare nelle sue reali ca-ratteristiche e dimensioni la più generale evoluzione culturale, civile e religiosa della società italiana degli ultimi due secoli.
Al riguardo, Luciano Pazzaglia riproponeva, adattandola al pe-culiare scenario storico-educativo, la ‘classica’ intuizione di Pie-tro Scoppola, secondo il quale la vicenda del movimento cattoli-co e la stessa esperienza del cattolicesimo politico nell’Italia unita avrebbero dovuto essere studiate non come una storia a sé, ovve-ro secondo una prospettiva meramente autoreferenziale, ma, più correttamente, come parte della più complessiva storia del nostro Paese.
Una storia, e lo studioso della Cattolica di Milano ne era pro-fondamente persuaso, alla quale applicare ricercatori che dispo-nessero di una formazione rigorosamente storica, ma non esclusi-vamente storico-pedagogica, ovvero di un approccio interdiscipli-nare in ambito storico. Non solo le metodologie di ricerca erano in larga misura differenti da quelle proprie della tradizionale storio-grafia pedagogica d’impianto gentiliano, ma anche la documenta-zione e le molteplici fonti archivistiche e a stampa alle quali attin-gere suggerivano la necessità di studiosi dotati di competenze non esclusivamente circoscritte all’ambito pedagogico o filosofico: un problema di non poco conto, se solo si tengono presenti l’atten-zione invero del tutto episodica e marginale assegnata negli anni Ottanta e Novanta agli studi storici nei corsi di laurea in pedagogia (per non parlare di quelli di filosofia, da dove proveniva una par-te rilevante dei ricercatori di ambito pedagogico), e l’impostazio-ne meramente storico-teoretica che caratterizzava, in quello stesso periodo, una parte rilevante delle peraltro allora poco numerose cattedre di Storia della Pedagogia.
Non sorprende a questo riguardo che, ai fini del perseguimen-
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 143
to dell’obiettivo prioritario di approfondire, sulla base di una serie di ricerche organiche e di ampio respiro, il ruolo esercitato dalla Chiesa e dal cattolicesimo nella vicenda educativa e scolastica ita-liana dell’Otto e del Novecento come contributo alla più larga e approfondita comprensione della storia culturale, sociale e civile del nostro Paese, Luciano Pazzaglia abbia dato spazio ad un’esi-genza altrettanto prioritaria, quella di costituire un’equipe, un ce-nacolo di storici dell’età moderna e contemporanea di altissimo profilo, disponibili a lavorare assieme e a fornire il loro autorevole contributo alla ricerca. Basterebbe qui ricordare: Francesco Tra-niello, Pietro Scoppola, Nicola Raponi, Andrea Riccardi, Guido Verucci, Francesco Malgeri, Massimo Marcocchi, Renato Moro, Agostino Giovagnoli, Xenio Toscani, Pierangelo Schiera, Giancar-lo Rocca, Carlo Fantappiè, Antonio Acerbi e diversi altri ancora. Affiancava questi studiosi un gruppo di giovani ricercatori di sto-ria della pedagogia, dell’educazione e della scuola di diversa pro-venienza e di differente formazione culturale e storiografica – ri-cordo, in particolare, oltre al sottoscritto, Giorgio Chiosso, Lucia-no Caimi, Fulvio De Giorgi, Angelo Bianchi, Simonetta Polenghi, Carla Ghizzoni, Hervé A. Cavallera, Angelo Gaudio, Redi Sante Di Pol e Giuseppe Tognon, ai quali successivamente si sarebbero aggiunti Fabio Pruneri, Maurizio Piseri e Filippo Sani – accomu-nati, fra le altre cose, dal desiderio di allargare i propri orizzonti metodologici e storiografici e dall’aspirazione a misurarsi con una grande ricerca di respiro nazionale.
A connotare tale gruppo di studiosi c’era, indubbiamente, la co-mune matrice culturale cattolica, la quale, come si è visto, si riflet-teva nella stessa prioritaria attenzione rivolta a taluni filoni e am-biti di ricerca, primi fra tutti quelli incentrati sul ruolo esercitato dalla Chiesa e dal cattolicesimo in ambito educativo e scolastico.
A Luciano Pazzaglia e al gruppo di ricercatori di storia dell’e-ducazione e della scuola dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-re di Milano si debbono, com’è noto, la fondazione a Brescia, nei primi anni Novanta, dell’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia, forse il primo centro di documentazione e ricerca altamente specializzato del nostro settore sorto in Italia5, e della rivista scien-tifica «Annali di Storia dell’Educazione e delle Istituzioni Scolasti-
5 Cfr. c. ghizzoni, L’archivio per la storia dell’educazione in Italia, in «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», I (1994), pp. 303-305.
Edizion
i ETS
144 La mia Pedagogia
che» (1994), un vero e proprio laboratorio interdisciplinare, desti-nato a costituire, almeno inizialmente, un punto di riferimento e un vero e proprio polo d’attrazione per gli studiosi della peniso-la; nonché la promozione di una serie di importanti convegni di studio destinati ad approfondire il ruolo esercitato dalla Chiesa e dal cattolicesimo italiano in campo educativo e scolastico in epo-ca contemporanea6. Basterebbe qui ricordare il convegno di studi storici sul tema Chiesa e progetto educativo nell’Italia del secondo dopoguerra (1945-1958), svoltosi a Milano dal 6 al 9 maggio 1986; quello dedicato a Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restau-razione e Unificazione, tenutosi a Brescia dal 20 al 23 novembre 1991; il convegno su Cattolici, educazione e trasformazioni socio-culturali in Italia tra Otto e Novecento, svoltosi a Brescia alla fine di maggio del 1996; e, infine, quello incentrato sul tema Chiesa, cultura e educazione in Italia tra le due guerre, tenutosi anch’esso a Brescia nel dicembre 19997.
Ma per riprendere il filo del nostro discorso, c’è da dire che si colloca in questi stessi anni milanesi, e in particolare nel 1983, l’av-vio della stretta collaborazione con Giorgio Chiosso, destinata poi a sfociare in una fraterna amicizia e in un vero e proprio impegno comune per dare vita ad un ambizioso progetto di rinnovamento culturale e storiografico della storia della pedagogia. Un progetto, deve essere sottolineato, che aveva non pochi punti in comune con quello pazzagliano, al quale – non a caso – entrambi avevamo da-
6 Si veda al riguardo l’eccellente analisi di carattere storiografico proposta da F. de giorgi, La storia e i maestri. Storici cattolici italiani e storiografia sociale dell’educazione, La Scuola, Brescia 2005, pp. 172-181.
7 Cfr. Chiesa e progetto educativo nell’Italia del secondo dopoguerra (1945-1958), La Scuola, Brescia 1988; L. pAzzAgLiA (a cura di), Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione, La Scuola, Brescia 1994; L. pAzzAgLiA (a cura di), Catto-lici, educazione e trasformazioni socio-culturali in Italia tra Otto e Novecento, La Scuola, Brescia 1999; L. pAzzAgLiA (a cura di), Chiesa, cultura e educazione in Italia tra le due guerre, La Scuola, Brescia 2003. Si veda anche m. cAttAneo-L. pAzzAgLiA (a cura di), Maestri, educazione popolare e società in «Scuola Italiana Moderna» 1893-1993, La Scuo-la, Brescia 1997, che riproduce gli atti dell’omonimo convegno di studi storici svoltosi a Brescia nel 1993. Su tali convegni e, più in generale, sulle ricerche avviate in questa fase dal gruppo di storici dell’educazione e della scuola della Cattolica di Milano, si vedano: r. sAni, Chiesa e prospettive educative in Italia dopo la Restaurazione: le suggestioni di un convegno, in «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», I (1994), pp. 265-276; c. ghizzoni, Chiesa, educazione e società tra Otto e Novecento, in «Vita e Pensiero», LXXXII (1996), pp. 704-715; eAd., Chiesa, educazione e società tra le due guerre, in «Storia in Lombardia», XX (2000), pp. 139-158.
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 145
to la nostra convinta adesione, ma che traeva ispirazione da una serie di istanze e di convincimenti che giudicavamo di particolare significato e importanza e che, al contrario, sentivamo scarsamente percepiti in seno al gruppo di ricerca milanese.
Ad esempio, eravamo anche noi convinti che occorresse lasciar-ci definitivamente alle spalle la tradizionale storia della pedago-gia di stampo gentiliano, per dare finalmente spazio ad una storia dell’educazione e della scuola considerata nel suo significato più ampio, come storia delle istituzioni, delle pratiche, dei costumi, della mentalità ecc.; eravamo altrettanto convinti, tuttavia, che una tale impresa, per non esaurirsi a breve e non restare in alcun mo-do confinata nell’ambito della dimensione confessionale – il ruolo esercitato dalla Chiesa e dal cattolicesimo in ambito educativo e scolastico – dovesse aprirsi ad obiettivi e orizzonti più larghi, de-stinati cioè a creare le premesse per la promozione di una seria e strutturata organizzazione della ricerca nel settore storico-pedago-gico; organizzazione che in quegli anni, nel nostro paese, risultava essere ancora largamente carente.
Intendo riferirmi alla messa a punto degli strumenti indispen-sabili per un’indagine in grado di andare oltre le sintesi frettolose e superficiali, e di fornire contributi di alto profilo (repertori bi-bliografici, raccolte di fonti, studi prosopografici, ricerche storiche su base locale e di carattere settoriale ecc.); nonché alla promozio-ne di una nuova sensibilità tra gli studiosi del settore, tale per cui sarebbe stato possibile non solamente ampliare e affinare le com-petenze metodologiche e storiografiche di ricercatori che avevano ricevuto una formazione più filosofica e pedagogica che autenti-camente storica, ma anche favorire – contro il tradizionale stile di lavoro individualistico proprio dello studioso di area umanistica italiano – la capacità di lavorare in équipe e il gusto di impegnarsi in ricerche di grande respiro che richiedono la collaborazione di ampie e qualificate reti di specialisti, sulla scia di quanto avveniva ormai da decenni in altri paesi europei, primi fra tutti la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna. Si trattava, peraltro, di sollecitare l’intera comunità degli storici della pedagogia del nostro paese ad allargare i propri orizzonti e a trarre sempre più ispirazione dagli autorevoli modelli della storiografia educativa e scolastica france-se, spagnola e britannica.
Non era estranea al nostro progetto, la consapevolezza che fosse tutt’altro che infondato il vero e proprio j’accuse lanciato al prin-
Edizion
i ETS
146 La mia Pedagogia
cipio degli anni Ottanta, nell’introduzione al suo Scuola, cultura e politica da De Sanctis a Gentile, da uno studioso raffinato e parti-colarmente attento alle vicende della storiografia educativa e scola-stica italiana ed europea come Marino Raicich, il quale aveva trac-ciato un quadro fortemente critico – e a tratti impietoso – dello stato degli studi storico-pedagogici in Italia, sottolineando fra l’al-tro come nel nostro paese mancasse proprio una seria organizza-zione della ricerca in questo settore e come difettassero ancora gli strumenti fondamentali indispensabili per un’indagine storica de-gna di tale nome: «La produzione di storici e pedagogisti intorno ai temi della storia delle istituzioni scolastiche – aveva sottolineato al riguardo lo studioso – è ampia; eppure mi sembra di dover pie-namente consentire con quanto osservato […] intorno alla pover-tà degli studi in Italia sulla storia dell’istituzione scuola. [...] Assai poco abbiamo di valido; né mi pare si debba qui tener conto delle occasionali brevi storie, compendi ad usum delphini, scritte in fret-ta sull’onda del sessantotto8.
Trova spiegazione alla luce di tali presupposti l’avvio di una serie di progetti di ricerca di interesse nazionale, cofinanziati dal miur e coordinati inizialmente dal solo Giorgio Chiosso, e in se-guito da Chiosso e da chi scrive9, i quali hanno reso possibile il recupero e la valorizzazione delle principali fonti per la storia della scuola e dei processi formativi nel nostro paese e l’appron-tamento di nuovi e più sofisticati approcci e strumenti di ricerca. Basterebbe qui far riferimento alla realizzazione dei due repertori dei periodici pedagogici, scolastici e magistrali italiani dell’Otto e
8 Cfr. m. rAicich, Scuola, cultura e politica da De Sanctis a Gentile, Nistri-Lischi, Pisa 1982, pp. 19 e 26.
9 Per quello che riguarda i cosiddetti prin, i Progetti di Ricerca d’Interesse Nazio-nale cofinanziati dal miur, segnaliamo: «Strumenti per apprendere: il libro per la scuola in Italia tra Otto e Novecento», coordinato da G. Chiosso (2000); «Leggere, scrivere e fare di conto: il libro scolastico in Italia tra XX e XXI secolo», coordinato da Giorgio Chiosso (2002); «Editoria scolastica e libri di testo in Italia e in Europa tra Otto e Nove-cento», coordinato da Roberto Sani (2005); «Nuove fonti per la storia dell’educazione e della scuola: materiali per un Dizionario biografico degli educatori, dei pedagogisti e degli scrittori per l’infanzia (1800-2000)», coordinato da Roberto Sani (2008). A questi occorre aggiungere il progetto di ricerca dal titolo «Multiopac del libro scolastico euro-peo», coordinato da Roberto Sani e cofinanziato miur nel 2005, e, infine, il progetto di ricerca internazionale «History on Line», Call for proposal 2007 (EAC/61/2006), Selec-tion year 2007, diretto anch’esso da Roberto Sani e cofinanziato dall’Unione Europea (Nota n. 134051-LLP-1-2007-1-IT-ERASMUS-EVC del 21/07/2007).
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 147
del Novecento10, alla creazione di quelli dedicati all’editoria sco-lastica ed educativa nell’Italia contemporanea11, alla costruzione del database EDISCO sulla manualistica scolastica e i libri di te-sto relativi alle scuole di ogni ordine e grado dati alle stampe nella penisola dal 1800 ad oggi12, nonché alla gran messe di studi e ri-cerche condotti sui diversi aspetti dell’istruzione e dell’educazione scolastica nell’Italia degli ultimi tre secoli13 e, infine, alla recente realizzazione del monumentale Dizionario Biografico dell’Educazio-ne 1800-200014, frutto della collaborazione di oltre un centinaio di ricercatori provenienti da diverse università italiane15, il quale, con i suoi 2345 profili dedicati alle molteplici e variegate figure che tra XIX e XX secolo hanno operato nel mondo della scuola e dell’e-ducazione (pedagogisti, insegnanti, autori di libri di testo, giorna-listi scolastici, fondatori di asili d’infanzia e di opere assistenziali ed educative, scrittori per l’infanzia, educatori speciali dei disabili ecc.)16 costituisce forse il frutto più maturo del rinnovamento sto-
10 g. chiosso (a cura di), I periodici scolastici nell’Italia del secondo Ottocento, La Scuola, Brescia 1992; g. chiosso (a cura di), La stampa pedagogica e scolastica in Italia (1820-1943), La Scuola, Brescia 1997.
11 g. chiosso (dir.), TESEO. Tipografi e editori scolastico-educativi dell’Ottocento, Editrice Bibliografica, Milano 2003; g. chiosso (dir.), TESEO ’900. Editori scolastico-educativi del primo Novecento, Editrice Bibliografica, Milano 2008. Cfr. p. biAnchini, Una fonte per la storia dell’istruzione e dell’editoria in Italia: il libro scolastico, «Contem-poranea», III (2000), 1, pp. 175-182; g. chiosso, Tra artigianato e imprenditorialità. L’editoria per la scuola nel secondo Ottocento, ivi, III (2000), 2, pp. 333-355.
12 Sulla banca dati EDISCO relativa ai libri per la scuola e per l’educazione pub-blicati in Italia dal 1800 ad oggi, si veda F. tArghettA, Verso una banca dati on line in Italia: Edisco, in g. bAndini-p. biAnchini (a cura di), Fare storia in rete. Fonti e modelli di scrittura digitale per la storia dell’educazione, la storia moderna e la storia contempora-nea, Carocci, Roma 2007, pp. 79-90.
13 Si vedano in particolare: g. chiosso (a cura di), Scuola e stampa nel Risorgi-mento. Giornali e riviste per l’educazione prima dell’Unità, Franco Angeli, Milano 1989; g. chiosso (a cura di), Scuola e stampa nell’Italia liberale. Giornali e riviste per l’educa-zione dall’Unità a fine secolo, La Scuola, Brescia 1993; g. chiosso (a cura di), Il libro per la scuola tra Sette e Ottocento, La Scuola, Brescia 2000; P. biAnchini (a cura di), Le origini delle materie. Discipline, programmi e manuali scolastici in Italia, Società Editrice Internazionale, Torino 2010.
14 g. chiosso-r. sAni (dir.), Dizionario Biografico dell’Educazione 1800-2000, Edi-trice Bibliografica, Milano 2013, 2 voll.
15 Avviato a partire dal 2008, il DBE ha coinvolto un folto gruppo di studiosi e di giovani ricercatori provenienti da numerose Università della penisola: Torino, Genova, Milano Cattolica, Verona, Bologna, Macerata, L’Aquila, Roma Tre, Molise, Napoli «Fe-derico II», Napoli «Suor Orsola Benincasa», Lecce, Catania ecc.
16 Cfr. g. chiosso-r. sAni, Conservare la memoria. Per un dizionario biogra-
Edizion
i ETS
148 La mia Pedagogia
riografico che ha contrassegnato il nostro settore negli ultimi de-cenni.
Il lungo sodalizio con Giorgio Chiosso, che a distanza di ol-tre un trentennio ancora prosegue, e continua a produrre frutti nell’ambito del nostro settore di ricerca non solo per noi, ma per diverse generazioni di studiosi italiani, ha collocato fin da princi-pio al centro del nostro operato una serie di impegnativi e ambi-ziosi progetti di rilevanza nazionale e internazionale, facendone il vero e proprio cardine di una modalità per certi versi inedita, al-meno in Italia, di operare nel campo della ricerca storico-pedago-gica ed educativa.
Come si sa, le grandi ricerche richiedono programmazione ri-gorosa, tempi lunghi, impegno personale diretto, acribia filologica, disposizione – anche da parte degli ordinari, non solo dei giova-ni ricercatori! – a rimettersi in gioco, a ricoprire ruoli e funzioni anche di carattere subalterno e di scarsa rilevanza, a colmare le proprie lacune metodologiche e ad acquisire più larghe e appro-fondite competenze; l’accettazione, in genere, di una leadership esterna e di un programma di lavoro dettato da altri. Se ben coor-dinate e dirette, esse costituiscono, a questo riguardo, un’impegna-tiva quanto straordinaria occasione per far crescere culturalmente e rafforzare la coesione di un gruppo di studiosi, costituendo, di fatto, un vero e proprio tirocinio alla ricerca, realizzato attraverso la ricerca stessa e rivolto non solamente ai giovani ricercatori, ma anche agli studiosi più maturi.
Ora, in virtù della competente leadership esercitata in questi lunghi anni da Giorgio Chiosso, le grandi ricerche a cui si è fatto cenno in precedenza, oltre a produrre gli indiscussi risultati scien-tifici sopra richiamati, hanno anche fortemente concorso a realiz-zare quelli che non esiterei a definire dei sensibili e salutari muta-menti nelle abitudini individuali e collettive della comunità degli storici della pedagogia e dell’educazione della penisola. A che cosa mi riferisco? Intendo far riferimento non solamente al già ricorda-to avvio del lavoro in équipe e alla costituzione di un gruppo di ricerca nazionale (all’occorrenza aperto anche ad apporti e a col-laborazioni internazionali) capace di portare a termine indagini di grande respiro e di realizzare progetti a lungo termine, ma anche
fico dell’educazione, in «History of Education & Children’s Literature», IV (2009), 2, pp. 461-464.
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 149
al definitivo superamento del criterio dell’appartenenza ideologica e culturale come principale – e talora unico! – criterio di collabo-razione tra gli studiosi della nostra disciplina; un criterio che, nel nostro settore scientifico-disciplinare, al pari che in altri, aveva do-minato incontrastato il campo nei decenni precedenti, finendo di fatto per marginalizzare la stessa qualità scientifica e le competen-ze specialistiche.
A questo riguardo, l’apertura e l’invito a collaborare alle nostre ricerche rivolto a tutti gli studiosi di buona volontà, a chi lo deside-rava e a chi riteneva di avere adeguate competenze, ha fatto sì che in questi tre decenni si sia prodotta una vera e propria una rete nazionale di studiosi (e di sedi accademiche) che hanno via via im-parato a lavorare assieme e a proporsi obiettivi di ricerca sempre più ambiziosi; una rete nazionale di studiosi la quale, nel corso del tempo, si è stratificata e oggi annovera almeno tre generazioni di ricercatori e di specialisti del settore, dai più vecchi, ormai da tem-po in cattedra, e qualcuno già in pensione, ai più giovani, compresi i dottorandi e gli assegnisti di ricerca.
Al fine di dare concretezza al mio discorso, pur timoroso di in-correre nelle sempre spiacevoli, ma purtroppo assai frequenti di-menticanze, mi limito qui a ricordare, tra i protagonisti di quella rete nazionale di studiosi (e di sedi accademiche) di cui parlavo so-pra, taluni colleghi e amici quali Maria Cristina Morandini e Paolo Bianchini (Torino), Pino Boero e Davide Montino (Genova), Carla Ghizzoni, Simonetta Polenghi, Renata Lollo e Sabrina Fava (Cat-tolica di Milano), Patrizia Zamperlin, Giuseppe Zago e Fabio Tar-ghetta (Padova), Giuseppe Bertagna (Bergamo), Angelo Gaudio (Udine), Franco Bochicchio, Tiziana Pironi e Mirella D’Ascenzo (Bologna), Carmen Betti, Gianfranco Bandini e Stefano Oliviero (Firenze), Giovanni Genovesi e Luciana Bellatalla (Ferrara), Sira Serenella Macchietti e Giuseppe Serafini (Siena-Arezzo), Anna Ascenzi e Raffaele Tumino (Macerata), Gaetano Bonetta (Chieti-Pescara), Furio Pesci (Roma La Sapienza), Francesco Susi, Carme-la Covato, Francesca Borruso e Lorenzo Cantatore (Roma Tre), Franco Trequadrini e Marco Antonio D’Arcangeli (L’Aquila), Al-berto Barausse (Molise), Michela D’Alessio (Potenza), Hervè A. Cavallera (Lecce), Letterio Todaro (Catania) e Salvatore Agresta (Messina).
In conclusione, due progetti e due itinerari di ricerca, quelli animati e coordinati da Luciano Pazzaglia e da Giorgio Chiosso,
Edizion
i ETS
150 La mia Pedagogia
che hanno inciso profondamente sulla mia formazione e sulla mia esperienza di studioso e di ricercatore di storia dell’educazione e della scuola. Due progetti e due itinerari assai differenti, come ho cercato di porre in rilievo nelle pagine precedenti, ma ispirati entrambi da una concezione ambiziosa e di notevole respiro della ricerca storico-educativa, il cui fondamentale apporto al rinnova-mento della storiografia di settore e alla creazione di una nuova ge-nerazione di specialisti è innegabile.
Si è trattato, in entrambi i casi, di progetti aperti al confronto interdisciplinare in ambito storico e al lavoro di équipe, caratteriz-zati da un’attenzione reale, e non fittizia, al dibattito storiografico internazionale, dei quali debbono essere sottolineati il vero e pro-prio primato conferito alle indagini archivistiche e l’analisi rigoro-sa delle fonti.
Due progetti, infine, espressione a tutti gli effetti di una storio-grafia che si potrebbe definire a marcata valenza politica, la qua-le, lungi dall’impedire l’adozione di nuovi approcci o l’utilizzo di particolari fonti documentarie o l’apertura a nuovi filoni di ricerca, punta a salvaguardare la visione del ruolo esercitato dalle istituzio-ni e dai processi educativi nelle diverse società e nelle diverse epo-che, contro le derive del sociologismo e contro la vera e propria ‘perdita di senso’ che caratterizza taluni approcci ascrivibili alla storia sociale e alla storia materiale dell’educazione. Una storiogra-fia nella quale la dimensione politica costituisce il fattore unifican-te delle complesse dinamiche che interessano i processi educativi e scolastici e, nel contempo, rappresenta il principale criterio in-terpretativo dei molteplici processi e dinamismi che caratterizzano la vita della scuola e delle istituzioni e pratiche educative nel loro complesso.
3. L’esperienza maceratese: ripensare la ricerca storico-educativa in un’epoca di transizione (2000-2014)
Come ho già ricordato, dopo essere stato dichiarato idoneo, nel marzo del 2000, nella procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia bandita dall’Università degli Studi di Lecce, nel giugno dello stesso anno sono stato chiamato a ricoprire la cattedra di Storia della Pedagogia presso la Facoltà di
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 151
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata. Artefice della mia chiamata a Macerata era stato l’amico e collega Miche-le Corsi, il quale, trasferitosi sulla cattedra di Pedagogia Generale della neonata Facoltà di Scienze della Formazione, della cui istitu-zione – come, del resto, di quella della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) – egli era stato il principale fautore (in seguito, dopo una serie di vicissitudini, avrebbe eserci-tato in modo esemplare, per ben due mandati, la presidenza di tale Facoltà), aveva ottenuto che la sua antica cattedra presso la Facol-tà di Lettere e Filosofia fosse nuovamente bandita per il settore M-PED 02 (Storia della Pedagogia).
All’instancabile impegno e alla vigorosa progettualità accademi-ca di Michele Corsi, una progettualità nutrita di cultura istituzio-nale e di abilità politica, si debbono non solamente la creazione, nell’Ateneo maceratese, di un primo nucleo di docenti incardina-ti di discipline pedagogiche, ma anche, e soprattutto, la realizza-zione, pressoché dal nulla, di un vero e proprio polo delle scienze della formazione, destinato nell’arco di pochi anni a divenire – sul piano didattico, come su quello della ricerca scientifica – una vera eccellenza non solamente a livello regionale.
Proprio ai fini dell’indispensabile consolidamento e ulteriore potenziamento dei risultati raggiunti fino a quel momento e, più in generale, per rendere possibile il necessario ricambio del gruppo dirigente e un altrettanto indispensabile rilancio dell’Ateneo mace-ratese, di lì a qualche anno, in occasione delle elezioni del nuovo rettore svoltesi nel giugno del 2003, decidemmo con Michele Corsi di presentare la mia candidatura al rettorato. Una scelta, quest’ul-tima, carica di incognite e tutt’altro che scontata nell’esito finale, in quanto la mia era la candidatura di un giovane professore che non aveva ancora concluso lo straordinariato e risiedeva a Macerata da meno di un triennio; candidatura alla quale si contrapponevano quelle, ben più autorevoli, almeno sulla carta, di due presidi di fa-coltà e di altri due ordinari di lungo corso. In realtà, al termine di una ‘campagna elettorale’ decisamente molto impegnativa e coin-volgente, al secondo scrutinio ottenni la maggioranza assoluta dei voti e fui eletto rettore dell’Università degli Studi di Macerata, in-carico al quale fui confermato a larga maggioranza nel 2006 per un secondo mandato, e che conservai fino alla fine di ottobre del 2010.
In questo particolare scenario si collocano le iniziative intra-prese, in stretto raccordo con la collega Anna Ascenzi e, più tar-
Edizion
i ETS
152 La mia Pedagogia
di, anche con l’apporto di un piccolo gruppo di giovani ricercatori chiamati a collaborare da varie parti della penisola (Dorena Ca-roli, Elisabetta Patrizi, Dorena Caroli, Juri Meda, Marta Brunelli, Silvia Assirelli, Luca Montecchi, Luigiaurelio Pomante, Gianluca Gabrielli e Fabiana Loparco), per implementare la ricerca storico-educativa e i relativi insegnamenti all’interno dell’Università di Macerata.
È appena il caso di ricordare che la situazione di vera e propria tabula rasa che aveva caratterizzato fino a quel momento la disci-plina nel piccolo ateneo marchigiano (prima del mio arrivo esiste-va solamente un corso di Storia della Pedagogia nella Facoltà di Lettere e Filosofia, affidato in genere per supplenza o per contrat-to esterno) costituiva, allo stesso tempo, un grave limite, in quan-to l’assenza di ogni tradizione di studi e di esperienze precedenti rendeva necessari una progettualità di ampio respiro e una serie di interventi di vasta portata, ma anche un indubbio vantaggio, per la possibilità di realizzare ex novo un vero e proprio ‘laboratorio didattico e di ricerca’ attorno al quale aggregare, assieme a studiosi d’indiscusso prestigio e di fama internazionale, anche giovani stu-diosi di varia provenienza, dei quali avevo avuto modo di apprez-zare le indubbie qualità scientifiche e la disponibilità a collaborare al progetto.
Nel febbraio del 2004, al termine di una lunga e complessa fase di gestazione, veniva costituito presso l’Ateneo maceratese il Cen-tro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e del-la letteratura per l’infanzia, il cui obiettivo era quello di operare in modo specifico in un ambito della ricerca storico-educativa – quel-lo concernente l’editoria e la pubblicistica per la scuola e la let-teratura per l’infanzia nell’Italia dell’Otto e del Novecento – che, a fronte dell’ampio interesse riscosso a livello internazionale, con riferimento alla realtà italiana risultava all’epoca in larga misura inesplorato.
Diretto a lungo da chi scrive e caratterizzato da un comitato scientifico internazionale del quale fanno parte Alberto Barausse (Università degli Studi del Molise, Italy), Vitaly Bezrogov (Institu-te of Theory and History of Education of Moscow, Russia) Pino Boero (Università degli Studi di Genova, Italy), Giorgio Chiosso (Università degli Studi di Torino, Italy), Alain Choppin (Institut National de Recherche Pédagogique, France) Mariella Colin (Uni-versité de Caen, France), Agustín Escolano Benito (Universidad
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 153
de Valladolid, Spain), Simonetta Polenghi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italy), Bernat Sureda Garcìa (Univer-sitat de les Illes Baleares, Spain) e Fang Weiping (Children’s Cul-ture Institute of Zhejiang Normal University, China), il Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia ha mirato, fin dalle origini, a realizzare i seguenti obiettivi le seguenti finalità: la costituzione di una biblio-teca specializzata che accogliesse la vasta produzione di libri di let-tura per le scuole elementari e di manuali disciplinari per le scuo-le primarie e secondarie editi in Italia nel corso dell’Ottocento e del Novecento, con particolare attenzione alla fase post unitaria; il reperimento, l’inventariazione e la pubblicazione (nella forma di repertori, cataloghi storici, carteggi, edizioni critiche di testi, rac-colte antologiche ecc.) di fonti archivistiche e a stampa relative alla storia delle tipografie e delle case editrici a prevalente vocazione scolastica ed educativa, alla legislazione e alla produzione, circola-zione e fruizione dei libri di testo, alla storia della pubblicistica per l’infanzia e la gioventù, con particolare riferimento alla produzione editoriale italiana dei secoli XIX e XX; la partecipazione a progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea, dal miur e da altri enti e organismi a carattere locale, nazionale e internazionale; l’acco-glienza di giovani studiosi e specialisti del settore da tutto il mon-do per lo svolgimento di indagini e ricerche sui fondi archivistici e librari conservati presso il Centro; la promozione, anche in col-laborazione con altre istituzioni scientifiche e di ricerca nazionali e internazionali di convegni, seminari, giornate di studio, mostre, presentazioni di libri ecc.; l’istituzione, infine, di un dottorato di ricerca sui temi che costituivano l’oggetto del Centro17.
Proprio nell’ambito delle iniziative promosse dal Centro di do-cumentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della lette-ratura per l’infanzia vedeva la luce, a partire dall’anno accademi-
17 Cfr. m. bruneLLi, The «Centre for Documentation and Research in History of Textbook & Children’s Literature» in University of Macerata (Italy), in «History of Edu-cation & Children’s Literature», IV (2009), 2, pp. 441-452. Tra le principali e più fe-conde collaborazioni avviate con altri centri di ricerca stranieri, ricordiamo in particolare quelle instaurate con il Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) de Berlanga de Duero (Soria, Spain), il Children’s Culture Institute of the Zhejiang Normal University (China), il Department of Childood Studies of the Rutgers University (Camden, USA), la Societat d’Història de l'Educaciaò dels Paisos de Llengua Catalana (Barcelona, Spain), l’Institute for Research on the History of Children’s Literature in Iran (Teheran, Iran) e l’Institute of Theory and History of Education of Moscow (Russia).
Edizion
i ETS
154 La mia Pedagogia
co 2004-2005, il Dottorato di ricerca in Storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia, destinato in seguito ad assumere la nuova e più generale denominazione History of Education. Si è trattato del primo ed unico corso di dottorato di ricerca della pe-nisola dedicato in via esclusiva alla formazione di storici dell’edu-cazione e della scuola, presso il quale si è formata, nell’arco di un decennio, una nuova generazione di storici dell’educazione18.
Nel giugno 2006, anche in questo caso al termine di una lun-ga e impegnativa fase di preparazione, ha avviato le sue pubblica-zioni la rivista scientifica internazionale «History of Education & Children’s Literature» (HECL), la quale, indicizzata nelle princi-pali banche dati internazionali – prime fra tutti ISI Web of Scien-ce di Thomson Reuters e Scopus dell’editore Elsevier –, si avvale della consulenza e del supporto scientifico di taluni tra i maggiori studiosi e specialisti del settore a livello internazionale19 e pubblica articoli in lingua inglese, francese, spagnola, tedesca e portoghese, oltre che in lingua italiana.
«History of Education & Children’s Literature» (HECL) è nata dalla volontà di creare una rivista capace di superare le barriere nazionali e di realizzare un programma preciso: stabilire organici collegamenti tra specialisti del settore e gruppi di ricerca operanti nei diversi paesi europei ed extra europei; favorire un proficuo e indispensabile confronto sul piano metodologico e storiografico e un altrettanto significativo approccio interdisciplinare ai temi e al-
18 Tra i giovani studiosi che hanno acquisito il dottorato di ricerca in storia dell’e-ducazione e della letteratura per l’infanzia all’Università degli Studi di Macerata ricordia-mo: Elisabetta Patrizi, Patrizia Morelli, Batsanan Chinzorig, Elisa Mazzella, Michelina D’Alessio, Ilaria Mattioni, Rossella Andreassi, Silvia Assirelli, Davide Boero, Valeria Mi-celi, Valentina Oldano, Fabiola Zurlini, Luca Puglielli, Florindo Palladino, Luigiaurelio Pomante, Luca Montecchi, Esmeralda Hoti Dani, Gianluca Gabrielli, Andrea Marrone, Valeria Viola e Fabiana Loparco.
19 Diretta da chi scrive, «History of Education & Children’s Literature» (HECL) si avvale di un Consiglio Direttivo (Executive Council) del quale fanno parte Pino Boe-ro (Università degli Studi di Genova, Italy), Norberto Bottani (Paris, France), Giorgio Chiosso (Università degli Studi di Torino, Italy), Mariella Colin (Université de Caen, France), Agustín Escolano Benito (Universidad de Valladolid, Spain), Michel Ostenc (Université de Angers, France), Simonetta Polenghi (Università Cattolica del Sacro Cuo-re di Milano, Italy) e Bernat Sureda Garcìa (Universitat de les Illes Baleares, Spain); nonché di un Comitato Scientifico Internazionale (International Scientific Board) che com-prende poco meno di un centinaio di studiosi provenienti da tutto il mondo, e di un Co-mitato di Redazione (Editorial Staff) coordinato da Marta Brunelli, Luigiaurelio Pomante e Dorena Caroli.
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 155
le problematiche oggetto di studio; contribuire alla diffusione dei più significativi risultati delle indagini condotte a livello nazionale e internazionale; dare conto dell’attività di istituzioni e organismi specializzati che, in Europa e in altri continenti, operano nel cam-po della documentazione e della ricerca sul duplice fronte della storia dell’educazione, considerata nella sua accezione più ampia, e della storia della letteratura per l’infanzia.
Più in particolare, l’idea di dare vita ad una rivista scientifica di alto profilo e a marcata vocazione internazionale è scaturita da due precisi convincimenti: il primo – maturato assai prima che in Italia fosse avviato il dibattito sulla valutazione e sulla internazionalizza-zione della ricerca e fosse istituita l’AnVur, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Legge 24 no-vembre 2006, n. 286) – rifletteva la consapevolezza che sul versante delle scienze pedagogiche non disponevamo ancora, in Italia, di un adeguato numero di riviste scientifiche a carattere autenticamen-te internazionale, indicizzate nei principali database internazionali (ISI Web of Science, Scopus ecc.) e, su tale base, in grado di attrar-re i contributi di ricercatori stranieri e di proporsi quali autentici punti di riferimento per la comunità scientifica europea ed extra europea. Il rischio, in tempi di crescente e irreversibile internazio-nalizzazione della ricerca, era – ed è ancora oggi – quello per cui, a lungo andare, nel nostro settore di studi si verifichi una sorta di forzata delocalizzazione dei canali e strumenti di divulgazione dei risultati della ricerca, capace di influenzare in misura rilevante i filoni d’indagine e di condizionare la stessa selezione dei prodot-ti della ricerca. Il secondo convincimento rifletteva – e riflette – il ruolo che il gruppo di ricerca promotore di «History of Education & Children’s Literature» (HECL) si proponeva – e si propone a tutt’oggi – di svolgere nel settore storico-educativo: quello di eser-citare un ruolo di primo piano nel rinnovamento degli studi di set-tore a livello internazionale e costituire un punto di riferimento per gli studiosi europei ed extraeuropei della disciplina.
Nel corso degli anni, grazie alla disponibilità di EUM – Edizio-ni dell’Università di Macerata, la rivista è stata affiancata da un’ap-posita collana editoriale internazionale: la Biblioteca di «History of Education & Children’s Literature» (articolata in tre sezioni: Studi, Strumenti e Repertori bibliografici), la quale accoglie testi in varie lingue e conta, attualmente, oltre una quindicina di opere pub-blicate. Dal 2013, inoltre, il fascicolo di dicembre di «History of
Edizion
i ETS
156 La mia Pedagogia
Education & Children’s Literature» (HECL) è arricchito da una Bibliografia Internazionale (International Bibliography), curata da Dorena Caroli e Luigiaurelio Pomante e realizzata in virtù della collaborazione di una cinquantina di studiosi/corrispondenti da tutto il mondo. Una Bibliografia Internazionale, deve essere segna-lato, compilata attraverso lo spoglio di oltre 400 riviste scientifiche internazionali del settore e dei cataloghi (monografie, miscellanee, proceedings ecc.) di circa 150 editori specializzati di diversi paesi europei ed extraeuropei20.
Nel dicembre 2009, infine, presso il Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infan-zia dell’Università degli Studi di Macerata è stato istituito il Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca», il quale, sotto la direzione di Anna Ascenzi, ha mirato fin dalle origini alla realizzazione di ini-ziative volte a promuovere tra gli alunni delle scuole primarie e secondarie, tra gli studenti universitari dei corsi di laurea in scien-ze dell’educazione e della formazione, tra gli allievi dei corsi post lauream di specializzazione all’insegnamento e tra gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado la conoscenza delle origini e degli sviluppi del sistema formativo e delle istituzioni scolastiche dell’Italia unita, sia attraverso incontri e visite guidate, sia, più in particolare, attraverso specifiche attività didattiche e formative (se-minari, laboratori, master, stage ecc.).
Il Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» di Macerata si è dedicato, inoltre, a costituire una rete nazionale dei musei della scuola, sul modello di quanto è stato fatto con eccellenti risultati in altri paesi (Germania, Regno Unito, Francia e Spagna), nonché a promuovere – in collaborazione con i musei della predetta re-te – una serie di iniziative volte alla realizzazione di veri e propri poli periferici di sistematico censimento, raccolta, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-educativo nazionale, e al-
20 Cfr. r. sAni, History of Education & Children’s Literature (HECL), in «History of Education & Children’s Literature», I (2006), n. 1, pp. 3-7; B. suredA, History of Education & Children’s Literature (HECL), un ambiciós projecte de divulgació científi-ca, in «Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació», 13 (2009), pp. 173-176; R. sAni, «History of Education & Children’s Literature» (HECL), five years on. An on-going assessment, in «History of Education & Children’s Literature», VI (2011), n. 1, pp. 19-36; id., «History of Education & Children›s Literature»: Promezhutochnye itogi, in «Istoriko-Pedagogiceskij Zurnal», 4 (2013), pp. 238-240; id., «History of Education & Children’s Literature» (HECL), in s. uLiVieri-L. perLA (a cura di), Riviste pedagogiche e qualità della ricerca, in «Pedagogia Oggi», VI (2014), n. 2, pp. 81-85.
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 157
lo sviluppo di una maggiore sensibilità del mondo della scuola, e più in generale della società civile, nei confronti dei beni culturali dell’educazione.
Recentemente, oltre agli obiettivi sopra ricordati, il gruppo di studiosi raccolti attorno al Museo si è impegnato nella promozione di una serie di studi e di ricerche sul ruolo dei musei della scuola e dell’educazione e sulla pedagogia del patrimonio storico-educati-vo21, inaugurando, a questo riguardo, un nuovo e stimolante filone d’indagine di rilievo internazionale22.
Più in generale, nel corso di questi anni, il gruppo di ricerca ma-ceratese ha concentrato la sua attenzione su una serie di nuovi filoni d’indagine e su talune tematiche storico-educative a lungo ignora-te o largamente trascurate dalla storiografia tradizionale, quali ad esempio: la storia della manualistica educativa e scolastica e dei libri di testo23 e quella delle discipline scolastiche24, i quaderni di scuo-
21 Cfr. m. bruneLLi, Heritage Interpretation. Un nuovo approccio per l’educazione al patrimonio culturale, EUM, Macerata 2011; m. bruneLLi-e. pAtrizi, School museums as tools to develop the social and civic competencies of European citizens. First research note, in «History of Education & Children’s Literature», VI (2011), n. 2, pp. 507-524; j. medA, La conservazione del patrimonio storico-educativo: il caso italiano, in j. medA-A.m. bAdAneLLi (edd.), La historia de la cultura escolar en Italia y en España: balance y perspectivas. Actas del I Workshop Italo-Español de Historia de la Cultura Escolar (Berlan-ga de Duero, 14-16 de novembre de 2011), EUM, Macerata 2013, pp. 180-193; A. Ascen-zi-e. pAtrizi, I Musei della scuola e dell’educazione e il patrimonio storico-educativo. Una discussione a partire dall’esperienza del Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» dell’Università degli Studi di Macerata, in «History of Education & Children’s Literatu-re», IX (2014), n. 2, pp. 685-714.
22 Si vedano al riguardo i contributi pubblicati da Anna Ascenzi, Marta Brunel-li, Juri Meda ed Elisabetta Patrizi in A.m. bAdAneLLi rubio-m. poVedA sAnz-c. ro-dríguez guerrero (edd.), Pedagogía museística. Práticas, usos didácticos e investigación del patrimonio educativo. Actas de las VI Jornadas Cientificas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo (SEPHE), SEPHE, Madrid 2014.
23 Cfr. A. Ascenzi-r. sAni (a cura di), Il libro per la scuola tra idealismo e fascismo. L’opera della Commissione centrale per l’esame dei libri di testo da Giuseppe Lombardo Radice ad Alessandro Melchiori (1923-1928), Vita e Pensiero, Milano 2005; A. bArAusse (a cura di), Il libro per la scuola dall’Unità al fascismo. La normativa sui libri di testo dalla legge Casati alla riforma Gentile (1861-1922), Alfabetica Edizioni, Macerata 2008, 2 voll.; A. Ascenzi, Il Plutarco delle donne. Repertorio della pubblicistica educativa e scolastica e della letteratura amena destinate al mondo femminile nell’Italia dell’Ottocento, EUM, Macerata 2008; A. Ascenzi-r. sAni (a cura di), Il libro per la scuola nel ventennio fascista. La normativa sui libri di testo dalla riforma Gentile alla fine della seconda guerra mondiale (1923-1945), Alfabetica Edizioni, Macerata 2009.
24 Cfr. A. Ascenzi, Tra educazione etico-civile e costruzione dell’identità nazionale. L’insegnamento della storia nelle scuole italiane dell’Ottocento, Vita e Pensiero, Milano 2004; p. moreLLi, Una cultura classica per la formazione delle élites. L’insegnamento del
Edizion
i ETS
158 La mia Pedagogia
la come fonte per la storia dell’educazione e delle pratiche formati-ve25, il ruolo della scuola e dell’associazionismo giovanile nella pro-mozione dell’identità nazionale e dell’idea di cittadinanza26, la storia dell’educazione speciale e delle istituzioni scolastiche per i sordo-muti27, l’influsso esercitato dalla stampa periodica per l’infanzia nel-la formazione e mobilitazione della gioventù italiana del Novecen-to28, le proposte formative degli istituti religiosi insegnanti29; come
latino nei Ginnasi-Licei postunitari attraverso l’Inchiesta Scialoja sull’istruzione secondaria (1872-1875), EUM, Macerata 2009.
25 Cfr. j. medA-d. montino-r. sAni (edd.), School Exercise Books. A Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th Cen-turies, Edizioni Polistampa, Firenze 2010, 2 voll.
26 Cfr. A. Ascenzi-L. meLosi (a cura di), L’identità italiana ed europea tra Sette e Ottocento, Olschki, Firenze 2008; A. Ascenzi, Metamorfosi della cittadinanza. Studi e ricerche su insegnamento della storia, educazione civile e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento, EUM, Macerata 2009; d. cAroLi, Cittadini e patrioti. Educazione, letteratura per l’infanzia e costruzione dell’identità nazionale nella Russia sovietica, EUM, Macerata 2011; r. sAni, Sub specie educationis. Studi e ricerche su istruzione, istituzioni scolastiche e processi culturali e formativi nell’Italia contemporanea, EUM, Macerata 2011; Ascenzi-r. sAni, «Un’altra scuola… per un altro paese». Ottavio Gigli e l’Associazione nazionale per la fondazione di Asili rurali per l’infanzia tra lotta all’analfabetismo e Nation-building (1866-1873), EUM, Macerata 2014.
27 Si veda al riguardo r. sAni (a cura di), L’educazione dei sordomuti nell’Italia dell’800. Istituzioni, metodi, proposte formative, SEI, Torino 2008.
28 Cfr. j. medA, Stelle e strips. La stampa a fumetti italiana tra americanismo e an-tiamericanismo (1935-1955), EUM, Macerata 2007; Id., È arrivata la bufera. L’infanzia italiana e l’esperienza della guerra totale (1940-1950), EUM, Macerata 2007; A. Ascenzi-m. di FeLice-r. tumino (a cura di), «Santa Giovinezza!». Lettere di Luigi Bertelli e dei suoi corrispondenti (1883-1920), Alfabetica Editrice, Macerata 2008; F. LopArco, I bambini e la guerra. Il «Corriere dei Piccoli» e il primo conflitto mondiale (1915-1918), Nerbini, Firenze 2011; s. AssireLLi, Paradigma Bemporad. Percorsi e linee evolutive dell'illustrazione del libro per l'infanzia in Italia tra Ottocento e Novecento, Nerbini, Fi-renze 2012; j. medA (a cura di), Falce e fumetto. Storia della stampa periodica socialista e comunista per l'infanzia in Italia (1893-1965), Nerbini, Firenze 2013; j. medA, La stampa periodica socialista e comunista per l'infanzia tra età giolittiana e fascismo (1902-1930), Nerbini, Firenze 2013; d. boero, All’ombra del proiettore. Il cinema per ragazzi nell’Ita-lia del dopoguerra, EUM, Macerata 2013.
29 Cfr. r. sAni-p.p. sALAdini, Un ecclesiastico ed educatore nella Modena della Re-staurazione. Severino Fabriani (1792-1849). Biografia e carteggi, Città Nuova Editrice, Roma 2001; r. sAni-p. Arosio, Sulle orme di Vincenzo de’ Paoli. Jeanne-Antide Thouret e le Suore della Carità dalla Francia rivoluzionaria alla Napoli della Restaurazione, Vita e Pensiero, Milano 2001; r. sAni-A. Ascenzi (a cura di), Vita religiosa, carità ed edu-cazione nell’Italia dell’Ottocento. Rosalie Thouret e la fondazione della Provincia mode-nese delle Suore della Carità (1834-1853), Alfabetica Edizioni, Macerata 2007; r. sAni, «Ad Maiorem Dei Gloriam». Istituti religiosi, educazione e scuola nell’Italia moderna e contemporanea, EUM, Macerata 2009.
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 159
anche, con specifico riferimento all’età moderna, la trattatistica edu-cativa e familiare in epoca umanistica e rinascimentale e nell’età del Concilio di Trento30, il ruolo esercitato dalle missioni cattoliche dei secoli XVI-XVIII nel rinnovamento culturale e nella vita della Chie-sa e della società europea31, la storia dell’educazione e delle istitu-zioni scolastiche in Italia dall’umanesimo all’età napoleonica32. Più recentemente, infine, la storia degli asili nido e dell’educazione della prima infanzia33, quella dell’associazionismo magistrale di matrice laica e socialista34, la storia della lotta all’analfabetismo e dello svi-luppo delle scuole rurali35 e quella dell’istruzione superiore e delle università tra Otto e Novecento36.
Conclusioni
Mi sia consentito, al termine di questa rapida ricostruzione, una riflessione di carattere generale concernente non tanto il mio iti-nerario culturale e di ricerca, quanto, piuttosto, il presente, e so-prattutto il futuro, del settore scientifico-disciplinare – M-PED/02
30 Si veda al riguardo e. pAtrizi, La trattatistica educativa tra Rinascimento e Con-troriforma. L’Idea dello scolare di Cesare Crispolti, IEPI, Pisa-Roma 2005; eAd., Silvio Antoniano. Un umanista ed educatore nell’età del Rinnovamento cattolico (1540-1603), EUM, Macerata 2010², 3 voll.; eAd., Del congiungere le gemme de’ gentili con la sapientia de’ cristiani. La biblioteca del card. Silvio Antoniano tra studia humanitatis e cultura eccle-siastica, Olschki, Firenze 2011.
31 Cfr. r. sAni, Unum ovile et unus pastor. La Compagnia di Gesù e l’esperienza missionaria di padre Matteo Ricci in Cina tra reformatio ecclesiae e inculturazione del Vangelo, Armando, Roma 2010; c. giuLiodori-r. sAni (a cura di), Scienza Ragione e Fede. Il genio di P. Matteo Ricci, EUM, Macerata 2012.
32 r. sAni, Storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche nell’Italia moderna, Franco Angeli, Milano 2015.
33 d. cAroLi, Per una storia dell'asilo nido in Europa tra Otto e Novecento, Franco Angeli, Milano 2014.
34 F. LopArco, La Sezione Maestre e Maestri della Camera del Lavoro di Milano. Tra militanza politica e impegno per la lotta all’analfabetismo e per l’istruzione popolare (1893-1917), EUM, Macerata 2015.
35 L. montecchi, La Scuola rurale Faina. Un’esperienza di istruzione popolare e agra-ria nell'Italia rurale del Novecento, EUM, Macerata 2012.
36 L. pomAnte (a cura di), L’Università di Macerata nell’Italia unita (1861-1966). Un secolo di storia dell’ateneo maceratese attraverso le relazioni inaugurali dei rettori e altre fonti archivistiche e a stampa, EUM, Macerata 2012; L. pomAnte, Per una storia delle università minori nell’Italia contemporanea. Il caso dello Studium generale Maceratense tra Otto e Novecento, EUM, Macerata 2013; id., Between history and historiography. Research on contemporary Italian University, EUM, Macerata 2015.
Edizion
i ETS
160 La mia Pedagogia
– (Storia della Pedagogia) – al quale appartengo. Le iniziative con-dotte da chi scrive e dall’equipe di storici dell’educazione dell’A-teneo maceratese si sono realizzate in una fase decisamente critica non solamente per il nostro settore scientifico-disciplinare, ma più in generale per il sistema universitario italiano nel suo complesso. Una fase di estrema confusione e di crisi del sistema, nella quale la massiccia riduzione dei finanziamenti e i tagli lineari apportati ai bilanci delle università hanno fatto da sfondo alla crescente margi-nalizzazione e delegittimazione delle istituzioni accademiche e del-la ricerca scientifica nel nostro paese.
Non sembrano esserci dubbi, al riguardo, sul fatto che la situa-zione nella quale ci troviamo costituisca per tutti noi un’autentica sfida e implichi necessariamente, assieme al superamento dei vec-chi egoismi e delle deleterie logiche autoreferenziali, anche l’assun-zione di nuove consapevolezze e di nuove responsabilità.
Dopo le grandi fratture ideologiche degli anni Ottanta e No-vanta e i pesanti effetti delle contrapposizioni di singoli e gruppi registrate nella stagione più recente, è indispensabile operare per far crescere, all’interno del nostro settore scientifico-disciplinare, il rispetto e la collaborazione tra le diverse sedi universitarie, i vari gruppi di ricercatori, le differenti ‘scuole’ e tradizioni storiografi-che; al contempo, è sempre più necessario affinare la capacità di lavorare assieme e percepire le grandi sfide di questo nostro tempo – il potenziamento e l’internazionalizzazione della ricerca, la for-mazione e il reclutamento dei giovani ricercatori del nostro setto-re, le sfide connesse con la progettazione europea e con il reperi-mento di nuove forme di finanziamento della ricerca ecc. – non già come qualcosa da vivere e da gestire in ordine sparso o, peg-gio ancora, in concorrenza fra di noi, ma come un grande compito comune, una sfida da affrontare e da vincere tutti assieme, nella consapevolezza che solo una comunità scientifica qualificata e coe-sa può aspirare legittimamente ad esercitare un ruolo di rilievo nel sistema universitario e nella realtà culturale del nostro paese.
Su questo versante, deve essere senz’altro sottolineato il ruo-lo estremamente positivo esercitato in questi ultimi anni dal cirse sotto la presidenza dell’amico e collega Giuseppe Trebisac-ce, così come non può essere in alcun modo ignorata, o anche solo sottovalutata, la forte spinta al superamento delle antiche contrap-posizioni ideologiche e politiche e alla promozione di un’autentica collaborazione d’intenti tra le diverse componenti della pedagogia
Edizion
i ETS
Il mio itinerario formativo e di ricerca 161
accademica (pedagogisti, storici, didatti, sperimentalisti ecc.) av-viata in seno alla siped sotto la presidenza di Massimo Baldacci e di Michele Corsi e rilanciata con forza dall’attuale presidente Si-monetta Ulivieri.
Sono convinto che occorra continuare su questa strada e che sia necessario sostenere e dare ulteriore slancio al progetto perseguito dalle mostre società scientifiche. E ciò non solo per noi, ma anche, e soprattutto, per le nuove generazioni di studiosi e, in particolare, per il futuro stesso della nostra disciplina.