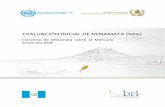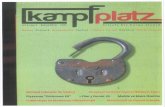LA MIA LIVITY RASTAFARI vol. 2 - KAYA
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LA MIA LIVITY RASTAFARI vol. 2 - KAYA
2
Ras Caleb
LA MIA LIVITY RASTAFARI volume 2
KAYA
PREMESSA
RASTAFARI: L’ETERNA ALLEANZA
Introduzione
Israele: popolo o condizione?
Il ruolo di Cam
Abramo: crocevia mistico
La spiritualità induista e il Messia africano
Un Kaya Club oggi
L’INFLUENZA INDUISTA NELLA GENESI RASTAFARI
Introduzione
Dal Revivalismo a Marcus Garvey
L’Induismo in Giamaica
Induismo e Rastafari
Conclusioni
prodotto da Guido Farella
stampato in proprio - diritti riservati
3
PREMESSA
Negli anni ’80, tornato in Italia dopo un viaggio di sei mesi nelle West Indies
e un successivo lungo soggiorno a Londra, decisi di aprire nella città dove vive-
vo – Torre del Greco – un reggae club, un centro di divulgazione della musica
reggae, e di chiamarlo Kaya, ispirandomi al titolo di un noto disco di B. Mar-
ley. Vi portai alcuni strumenti musicali e un rudimentale apparecchio di regi-
strazione, ne pubblicizzai l’esistenza nel nascente circuito del reggae italiano e
raccolsi le prime adesioni di giovani musicisti, insieme ai quali cominciai a suo-
nare covers e a comporre nuovi brani. Così è iniziata la mia Livity Rastafari.
Il Kaya Club è stato un luogo d’incontro e di studio; ha unito i suoi soci a
partire dal desiderio di apprendere gli stili e i messaggi di questa musica. Ci ha
permesso di sentircene – a nostro modo – protagonisti e di partecipare alla rete
di contatti nel frattempo sorta tra le varie realtà roots italiane. Le nostre infor-
mazioni su Rastafari erano ancora limitate, ma il reggae ci ha istruito grazie al-
la forza carismatica degli artisti che, per suo tramite, si esprimevano come pro-
feti e ministri di un regno altro rispetto a quello babiloniano.
In quel seminterrato ho mosso i primi passi di un cammino, non solo di na-
tura musicale, che mi avrebbe impegnato ancora a lungo. Sono passati più di
trent’anni da quei giorni, I&I continuo a radicarmi in Rastafari e a nutrirmi
della sua linfa. Ho buone ragioni per ritenere che anche il resto della mia vita si
orienterà nella medesima direzione.
Dunque, poco più che ventenne ero partito per Barbados, nelle isole caraibi-
che. Vi ci ero arrivato sulle ali di un viaggio verso il sole e verso una natura più
benigna, verso un’umanità più libera e vera, dalle cui vibrazioni ero stato già in
varie occasioni colpito. A Barbados trovai alloggio presso un centro per l’inse-
gnamento dello yoga, un ostello diverso dai soliti, aperto e diretto da Mr. Tor-
rey Pilgrim, studioso e insegnante del Raja yoga (yoga dei Re), preziosa eredi-
tà che la civilizzazione vedica ha lasciato all’umanità. È a Barbados che scoprii
l’esistenza del reggae e del suo legame con Rastafari. E fu in questo centro che
cominciai a praticare l’Hata yoga, che del Raja yoga è uno dei pilastri. Allora
non lo potevo sapere, ma Rastafari e Yoga sono diventate le gambe grazie alle
quali ancora oggi mi muovo in equilibrio verso la meta a me riservata.
4
Al ritorno da quel viaggio mi resi conto che l’incontro con Rastafari aveva
cambiato il mio posizionamento nella realtà; cominciai a sentire il bisogno di far
emergere ciò che fino ad allora era rimasto silente in fondo alla mia coscienza.
Grazie alla musica reggae, al suo richiamo mistico, agli incontri fatti, alla potenza
della figura di Sua Maestà Haile Selassie e, non ultimo, all’uso mirato della can-
nabis, mi riuscì di aprire il varco attraverso il quale portare luce alla mia spiritua-
lità e a riconoscerne i bisogni.
L’Inghilterra era il posto più vicino dove entrare in contatto con la cultura Ra-
stafari; ci ritornai per altri sei mesi che impiegai studiando musica, approfonden-
do la lettura di libri e pubblicazioni sulla storia africana/etiopica e sulla nascita
del movimento, frequentandone le sedi e partecipando ai loro eventi. Ragionan-
do con i Fratelli cominciai a trovare il mio spazio nella Livity, imparando però
anche la dura lezione del sentirsi esclusi in un ordine di valori spesso articolato
secondo il paradigma della primazia nera.
Con questo bagaglio d’esperienze rientrai definitivamente in Italia, deciso a co-
struirmi le condizioni per realizzare la mia vocazione e metterla al servizio di una
possibile comunità italiana; la mia determinazione a rimanere nella Livity diven-
ne chiara è visibile. Ma il Kaya club non decollò, le adesioni non aumentarono.
Non riuscendo più a far fronte alle spese decisi di lasciare quella sede e di dedi-
carmi allo studio ed al rafforzamento della mia vita interiore. Del lavoro di allora
mi è rimasto un ampio archivio di registrazioni, dal quale sto ancora attingendo
per produrre la maggior parte delle canzoni che oggi diffondo.
Il presente volume rientra nel progetto editoriale LA MIA LIVITY RASTA-
FARI, ne costituisce la seconda parte. Nella prima – VIVA SELASSIE! – ho pro-
posto alcuni miei reasonings su specifici argomenti che hanno connotato la mia
crescita in Rastafari e la traduzione di una porzione per me particolarmente inte-
ressante di un libro che lessi in quegli anni.
Anche questo volume include la traduzione di un saggio che mi ha molto aiu-
tato a delineare con esattezza l’argomento intorno al quale ruotano i vari capitoli;
mi ha fornito riscontri autorevoli a sostegno delle tesi che ho cercato di articolare,
in mancanza dei quali avrei forse peccato di autoreferenzialità. Partendo da uno
specifico aspetto della mia vocazione, mi sono collegato con un elemento presen-
5
te nella storia del movimento non sempre adeguatamente valorizzato e compre-
so: l’influenza della spiritualità indiana. Averne approfondito lo studio, e l’averlo
io stesso vissuto nella mia Livity, mi ha consentito di affrontarlo senza timidezze.
Le mie argomentazioni sono frutto di un processo descrivibile più come una
progressione mistica che come un’organizzazione ragionata di dati. Alla quale ho
fatto ricorso solo quando si è trattato di trasformare la mia esperienza in un lin-
guaggio appropriato alla divulgazione scritta. L’interrogarsi, l’articolare reaso-
nings, il proporli pubblicamente, quando deriva da un genuino desiderio di offri-
re le nostre acquisizioni per il rafforzamento della consapevolezza collettiva, sono
atti di militanza dovuti. Tutti dovremmo sentirci chiamati a valorizzare le speci-
ficità della nostra fede, mettendole a disposizione per il progresso dell’intero mo-
vimento; specialmente chi, in ragione dell’età e dell’esperienza, può influire po-
sitivamente sul potenziale cognitivo delle nuove generazioni.
Sono consapevole che, in alcuni suoi passaggi, questo testo si spinge ben al di
là della semplice testimonianza personale; ma, oltre a offrire uno spaccato sulla
coabitazione di Yoga e Rastafari nella mia Livity, voglio aprire una strada all’in-
contro e alla cooperazione con chi, non sentendosi adepto di un culto impermea-
bile e monolitico, si muove su percorsi affini. Sperando di poter arricchire lo sce-
nario delle comunità Rastafari in Italia con una nuova esperienza aggregativa, gli
rivolgo un particolare invito, quello di lavorare insieme per far evolvere le sensi-
bilità che ci accomunano in un progetto aperto a chiunque desideri avvicinarsi e
coltivare questo specifico campo del nostro overstanding. Come possibili futuri
compagni di strada, auspico di ricevere la vostra giusta attenzione e, nel caso vi
fosse interesse per la proposta, anche disponibilità ad investire risorse ed energie.
Rastafari si manifesta sia nella tradizione delle origini che nelle sue succes-
sive evoluzioni. È una Livity, che, per quanto mi riguarda, significa restare con-
nessi alla parte in fieri della sua storia, riuscendo ad aggiornare in tempo reale la
percezione che ne abbiamo. Se, per un verso, l’eredità lasciata dagli Elders ci con-
segna una naturale sinergia con la cristianità di matrice etiopica, l’odierna gnosi
Rastafari attinge anche da tradizioni culturali e teologiche diverse da quelle giu-
daico/cristiane; in essa la ricerca spirituale si fa più ampia quando si tratta di da-
re risposte alla seguente precisa e fondamentale domanda: riconoscendo la divi-
nità di Haile Selassie Primo a cosa davvero si partecipa?
6
I&I ho da tempo compreso l’impossibilità di ancorarsi a una dottrina Rastafari
definibile una volta per tutte. La mia Livity, prima che all’adesione a uno schema
di culto, mi chiama all’elaborazione, anche inconscia, del flusso d’informazioni e
di conoscenze che continuamente ci scorre dentro e attorno. Pensarsi Rasta viene
prima del professarsi tale; per me significa agire da protagonista di atti creativi, non
da seguace di pratiche imitative. Il concepimento e la realizzazionedel progetto LA
MIA LIVITY RASTAFARI è stata un’ottima occasione per condividerne alcuni.
RASTAFARI: L’ETERNA ALLEANZA
di Ras Caleb
Introduzione
I&I partecipo al movimento spirituale e culturale conosciuto come Rastafa-
ri. In Rastafari si persegue l’unità tra i popoli, a partire da quelli africani. Misti-
camente parlando, in Rastafari si realizza la conoscenza di Jah, l’immanenza divina
nella vita di tutte le cose, mancando la quale l’uomo è destinato all’esilio perpetuo
dall’unità con se stesso e con il creato.
Rastafari non predica una spiritualità metafisica e individuale; chiama tut-
ti indistintamente a diventare protagonisti della salvezza collettiva, ricostruen-
do la nostra sacralità nella storia. Condizione primaria per il raggiungimento di
quest’obiettivo è il radicale espianto de!le strutture che sorreggono la civilizzazio-
ne deviata di Babylon, e la corrispondente affermazione della guida divina nel-
le istituzioni umane.
Rastafari si propone come ispiratore di un governo teocratico mondiale, uni-
co antidoto alla rovina verso la quale gli antagonismi degli attuali sistemi religio-
si/economici/militari ci stanno conducendo. I&I, glorificando l’Imperatore Hai-
le Selassie I, lo additiamo come perfetto esempio di guida divina.
L’adesione a Rastafari, ne sono convinto, si diffonderà sempre più tra chi re-
siste al modello di (in)civiltà imposto dai poteri di Babylon. I suoi paladini lo di-
fendono come il migliore possibile, I&I lo consideriamo un inganno basato sull’i-
pocrisia e sulla negazione della ragionevolezza e della verità; come la cattività in
un mondo dai valori capovolti, dove gli errori non vengono corretti ma diffusi,
per poi avvalersi del fatto che, se tutti sono complici, nessuno può chiamare al-
tri a risponderne.
7
È un destino che accomuna tutti, vittime e carnefici, in un sistema di violen-
za strutturale che mortifica il senso di giustizia e fa deperire i lati migliori di noi,
i più amorevoli, costringendoci purtroppo ad attrezzarci per competere con i ‘ne-
mici’ di turno e per difendere la nostra apparente e illusoria libertà.
In Giamaica i patriarchi Rastafari hanno indicato e percorso una via di riscat-
to. L’hanno fatto con così tanta forza e determinazione da sovvertire la loro sor-
te nello spazio di due generazioni. Da cenciosi reietti sociali a superstars inter-
nazionali; da folli visionari drogati a guide morali e custodi dell’integrità di una
razza alla deriva. La verità che li rese così forti gli si è manifestata nel nome e nel
volto di un dio vivente, nella storia e nella cultura di una teocrazia nobile e anti-
ca. Hanno vinto grazie a un’arma spirituale suprema: Sua Maestà Imperiale Hai-
le Selassie I. La loro testimonianza è impregnata di etiopianismo, ebraismo e cri-
stianità; hanno riletto e, in certi casi, riscritto la Bibbia con la stessa autorevolezza
dei suoi autori originali.
Ma oggi, di fronte all’intero scenario mondiale, come continuare la loro mis-
sione? Possiamo fare affidamento solo sulle varie versioni bibliche e sulla conce-
zione giudaico/cristiana di dio? Decisamente no, a partire dal fatto che l’ebraismo
collegato a queste bibbie, e il cristianesimo che da esso si fa derivare, andrebbero
inclusi più nella categoria della truffa che in quella di spiritualità. Chi se ne defi-
nisce erede, a mio avviso, è guidato dalla malizia.
Israele: popolo o condizione?
Il mio reasoning parte da un assunto: non è corretto riferirsi al giudaismo
come a un’espressione dell’alleanza tra un certo dio e un solo specifico popolo;
quell’alleanza pre-esiste alla differenziazione dei popoli, riguarda l’umanità in-
tera e l’evoluzione della sua storia sacra. Cos’ha determinato questa distorsione?
E, soprattutto, a cosa doveva servire? Provo ad articolare la mia risposta.
La rivelazione del dio di Abramo ha origini più ampie e remote di quelle de-
scritte nelle bibbie lette oggi; scaturisce da un’era di pienezza spirituale la quale,
come acqua che trabocca da una vasca ormai colma, si è separata in tanti rivo-
li gnostici solo apparentemente divergenti, perché destinati proprio a spandersi
e irrigare ogni angolo abitato della terra secondo simboli e linguaggi adeguati. Il
racconto biblico, nella sua odierna parzialità, colloca Abramo nella discendenza
8
di Sem, uno dei figli di Noe, il patriarca per eccellenza, il custode della creazio-
ne nel difficile passaggio in cui la specie umana ne diventa pienamente respon-
sabile. Lo rende protagonista dell’evento fondativo del popolo ebraico, cioè l’as-
segnazione di una terra – Canaan – e l’inizio di un’alleanza con un dio che gli
rivela il suo progetto.
Chi parla (Jahovia/Yahvè, etc.) gli fornisce le prime credenziali attraverso il
proprio nome, che qualcuno traduce come il Colui che è; per I&I corrisponde in-
vece all’Io sono l’Io sono. Le due versioni non sono equivalenti e già introducono
al cuore della questione.
Chi è, cos’è in effetti l’entità che interpella Abramo? Un essere ultraterreno,
come schiere di esegeti si ostinano a sostenere, o il grado supremo della Conoscenza,
come I&I, appunto, lo conosciamo? Se questa risposta ha ragione di esistere, tocca
anche chiedersi di cosa veramente Abramo è diventato capostipite. Secondo gli
stessi esegeti prima citati, una volta raggiunta Canaan comincerebbero le vicen-
de di un popolo su cui si alternano benedizioni e maledizioni, vittorie e sconfit-
te, conquiste e prigionìe. Un popolo sì eletto, ma condannato a un’alleanza in-
compiuta, che solo con Gesu troverà la sua piena realizzazione.
I&I non considero attendibile quest’impostazione della figura di Abramo e
della sua discendenza. L’overstanding che mi guida me ne suggerisce un’altra: la
comparsa di Abramo e l’alleanza di dio con Israele non sono nè eventi databili
storicamente nè gli inizi biologici di un popolo etnicamente o religiosamente se-
parato dal resto dell’umanità. L’archetipo Abramo non va vissuto come persona
ma come un luogo d’incontro da sempre presente sulla mappa della spiritualità.
Il popolo che da lui prende origine è il frutto dell’esperienza esistenziale dell’Al-
leanza, sancita dall’avvento della consapevolezza divina nel piano della fisicità,
a completamento dell’identità dell’uomo e delle ragioni della sua presenza nella
storia dell’universo.
Il ruolo di Cam
Ma perché Canaan, cos’è Canaan?
Canaan discende da Cam, un altro dei figli di Noe. Dalla stirpe camitica sca-
turisce l’albero genealogico della razza nera; la terra di Canaan diventa perciò la
casa africana dei sopravvissuti al diluvio, la dimora più sicura in cui Abramo può
9
generare la sua discendenza. La quale, se volessimo dar credito all’impianto bibli-
co, sarebbe talmente cresciuta in numero e potenza da riuscire a dominare e/o
scacciare gli originali abitanti di quei luoghi.
I&I denuncio anche questa parte del racconto. I&I sostengo che non solo i Ca-
nanei non si sottomisero né se ne andarono dalla loro terra, ma diventarono l’in-
telaiatura sulla quale si sviluppò Israele, fornendogli quel carisma profetico sen-
za il quale nessun altro elemento poteva connotarlo come popolo dell’Alleanza.
Difficile non accorgersi della somiglianza tra tale narrazione e l’odierna pretesa
territoriale del sedicente stato ebraico d’Israele. Sembra il ripetersi di un copione,
come se ciò che accadde allora servisse a legittimare l’odierna sua cieca determi-
nazione a realizzare la propria esistenza alienando terra e libertà di qualcun’altro.
L’estromissione dell’Africa dalla promessa di salvezza riservata a Israele è stata
la principale preoccupazione di chi si è autoproclamato custode e amministratore
delle verità bibliche. A partire dalla storia di Noe, al quale, secondo il loro raccon-
to, tocca l’ingrato compito di maledire proprio quel suo particolare figlio. Ci pre-
sentano un Cam beffardo e irriverente di fronte alla nudità del padre, gabbato però
dai suoi timorati ma furbi fratelli che si avvantaggeranno della sua eterna condan-
na alla schiavitù. Dov’è la gravità del gesto? Perché la nudità di Noe non poteva es-
sere vista, specie se causata da un’ubriacatura, una condizione in cui viene meno il
pudore? Qual’è il danno e chi è il danneggiato?
Il danno, nel mio overstanding, è la presa d’atto del fallimento di quel proget-
to di civilizzazione, del tradimento di un patto grazie al quale a Noe è stata data la
possibilità di sopravvivere al diluvio. È questo ciò che Cam vede. È così che segna
la sua sorte. Se l’inganno parte da qua, occorre demolirne le fondamenta, comin-
ciando col dire che: a) stabilendosi in Canaan, Abramo non delimita un perimetro
di separazione ma stabilisce un presidio aperto di spiritualità, in cui s’incroceranno
direttrici diverse di uno stesso sistema di scambi; b) la discendenza di Israele non
è legata alla consanguineità ma si compie partecipando a una specifica esperienza
del sacro, attraverso la quale creatura e creatore entrano in connessione diretta. È
l’antitesi non negoziabile della visione di chi, invece, colloca la presenza di dio in
una dimensione inaccessibile e immateriale.
Di Abramo si esalta l’obbedienza assoluta, tanto incondizionata da compren-
dere anche il sacrificio del proprio unico figlio Isacco. A cosa serve una simile pro-
10
va se non ad abolire il primato dell’appartenenza ereditaria e a introdurre quella
per condivisione valoriale? Una conquista mentale dunque, un’evoluzione cultu-
rale, non l’apologia del sacrificio elevato a virtù, come una teologia malsana, u-
tile più a depistare che a istruire, vorrebbe farci accettare. Magari per preparare
il terreno all’accettazione di un altra tremenda morte, quella di Gesu in croce, e-
pilogo necessario al loro racconto di un’alleanza che si vuole ormai decaduta. È
questo l’evento che determinerebbe il passaggio di consegne da un Israele semi-
ta macchiatosi di deicidio al cristianesimo Romano civilizzatore e missionario.
Non era facile ribaltare una sentenza di cui molti si sono sentiti esecutori, im-
pegnandosi con zelo, metodicità e religiosa obbedienza. Ma l’odierna epifania
Rastafari svela l’evidenza di un altro Israele, quello che nasce e si salva nella par-
te nera dell’umanità.
In Rastafari si partecipa alla vittoria del dio vivente, rivelatosi nella carne at-
traverso l’unione del re Salomone con la regina Makeda d’Etiopia. La fugace at-
tenzione che le varie bibbie riservano a quell’incontro svela la volontà di smi-
nuirne l’importanza. Ma per I&I è lì che avviene il vero passaggio di consegne.
Nella sua ritrovata collocazione africana il cammino mistico d’Israele continua
a seguire il suo vero percorso, immune dalle manipolazioni affermatesi altrove.
Dai testi sacri etiopici apprendiamo fin nei particolari le vicende collegate a
quell’unione; ma pur dicendo abbastanza su come Menelik e i dignitari di Salomo-
ne risalirono il Nilo per portare in Etiopia l’Arca dell’Alleanza,viene detto ancora
molto poco sul ruolo che l’Africa ha avuto per la futura discendenza di Abramo.
Inoltre, da Menelik a Ezana, primo re etiopico a professarsi cristiano, c’è un
bel tratto di storia. Prima di Ezana – e prima di Menelik – quali altre forme di spi-
ritualità si sono sedimentate in quella parte d’Africa? Mi limito ad osservare che
oggi, nelle cerimonie religiose della Chiesa Ortodossa etiopica, sono presenti l’u-
so liturgico dei tamburi e l’apertura di ombrelli ricamati sui libri sacri, sulle croci,
sugli stessi sacerdoti. Qualcosa di simile a ciò che accade in India durante le pro-
cessioni religiose, quando il passaggio dei Guru viene sempre accompagnato con
un ombrello aperto sulle loro teste e con il suono di canti e tamburi.
Sempre in India vengono venerate due tombe attribuite a Mose e Gesu. C’è
da crederci? Vere o no, il solo fatto di essere citate come tali ne afferma il concet-
11
to. Così come lo afferma un’altra usanza comune alle due religiosità, quella che
per I&I ha preso forma nei dreadlocks dei nostri Elders.
La sua casa etiopica, e gli elementi di cultura indiana che qui si ritrovano, mi
portano a confutare la collocazione semitica d’Israele. L’Israele che riconosco –
e di cui mi sento parte – è sopravvissuto grazie a radici africane e la sua elezio-
ne proviene solo dall’universalità della promessa di salvezza che rappresenta.
Abramo: crocevia mistico
I&I vivo Abramo come un evento sacro della mia Livity, un ponte di salvezza
sopra l’abisso dell’oblìo storico nel quale Babylon vorrebbe gettarmi; è il nesso eti-
mologico, ancor prima che teologico, tra due luoghi della mia geografia spirituale.
Lo vivo come un anello di congiunzione tra la religiosità etiopica, pregna com’è
anche di elementi inerenti all’eredità ebraico/cristiana, tra l’insieme della sua sto-
ria, e la spiritualità di matrice vedica affermatasi in Oriente. In lui, l’antico coinci-
de col presente.
Il nome stesso di Abramo, quasi sovrapponibile a quelli di due manifestazio-
ni del divino fondamentali per l’induismo, Brahman e Brahma, testimonia la ve-
rosimilità della traccia che sto seguendo.
Addentriamoci in esse.
Brahman: “Termine fondamentale della spiritualità indiana, impossibile a tradur-
si senza ricorrere a perifrasi. Il significato più antico indica, probabilmente, una sorta di
forza portante, un fondamento di ogni cosa che, riempiendo l’universo, lo fa vivere e pro-
sperare. È connesso a una radice che sta per ‘crescere, aumentare, ingrassare’ ed al causa-
tivo ‘nutrire, consolidare, fondare’. È come un rafforzamento che, in qualche modo, e gra-
zie al sacrificio, ‘riempie’ gli dèi, facendoli diventare più potenti.
Il valore del termine spazia inoltre dall’àmbito tecnico sacrificale a quello cosmologico,
in cui compare come il pilastro che sostiene l’universo. A rigore, non è possibile dare una
definizione del Brahman che in modo negativo, indicandolo solo come ciò da cui mente e
parola si volgono via senza essere riuscite ad attingerlo. Più precisamente, non è suscettibi-
le di alcuna determinazione concettuale e linguistica.
È, piuttosto, il principio cosciente ed imperituro intimo ad ogni essere. Questo signifi-
ca che il principio fondante del cosmo si rivela identico al principio su cui si basa l’identità
personale, depurata però da ogni riferimento alle caratteristiche contingenti dell’individuo”.
12
Brahma: “Nominativo maschile del termine Brahman, usato per indicare una divinità
di primo piano del Pantheon indù. All’interno della triade, completata da Visnù e Shiva,
rappresenta la funzione dello ‘sprigionamento’ cosmico, presiedendo alla manifestazione
dell’universo. È venerato, insieme alla sua sposa Sarasvati – dea del Sapere – come avo
degli déi e degli uomini. Le scuole di yoga raffigurano l’universo come un uovo che da lui
prende il nome (Brahmanda), del quale il corpo umano costituisce il parallelo microcosmico”
(Enciclopedia dello Yoga - Promolibri).
Crescere/aumentare/consolidare/sacrificio/pilastro che sostiene l’universo/
principio fondante/identità personale/sprigionamento cosmico/avo degli dei e
degli uomini. É facile trovare in questi attributi molte delle funzioni assicurate
da Abramo ai futuri Ebrei. A me danno la certezza di guardare nella giusta di-
rezione. Come veramente agisca tale concomitanza va ulteriormente approfon-
dito; ma solo chi ne teme l’evidenza può fingere d’ignorarla.
Lungo il percorso che mi ha portato a Rastafari trovo un altro indizio signi-
ficativo per sentirmi direttamente artefice – nel mio piccolo – del legame misti-
co di cui sto parlando.
La mia Livity, come ho già raccontato, è cominciata con il Kaya Club. L’a-
dozione di tale nome, col senno del poi, mi appare rivelatrice dell’inconscia i-
spirazione che mi guidò, non fu solo una semplice scelta di stile.
Kaya è un termine noto a chi conosce la musica di Bob Marley. È il titolo di
una canzone che esalta i benefici della cannabis. È, in effetti, uno dei nomi con
cui i Rasta chiamano quella pianta. Il vocabolo Kaya è però presente anche nel
sanscrito, l’antica lingua vedica. In quella lingua indica il ‘corpo’, elemento di
fondamentale importanza nell’insegnamento dello yoga tantrico.
“Il corpo umano è la rappresentazione del cosmo. Questa corrispondenza è evidente non
tanto nell’inesauribile varietà dei corpi materiali, quanto invece nella conformazione del
‘corpo sottile’, una struttura immateriale nella quale sono contenuti, per così dire, i fonda-
menti universali dell’individualità: l’intelletto impersonale, il ‘senso dell’io’, le facoltà sen-
sorie e gli elementi sottili.
Mentre il corpo materiale si dissolve completamente dopo la morte, il ‘corpo sottile’ so-
pravvive indenne… Tra questi due corpi esiste una stretta relazione, garantita soprattutto
dal ‘soffio vitale’, il cui controllo svolge perciò un ruolo essenziale nelle pratiche dello yoga,
13
specie nello yoga tantrico. Del ‘corpo sottile’ fanno parte i chakras, in numero di sette, dei
quali sei sono disposti lungo la colonna vertebrale, misticamente interpretato come l’asse
del Monte Meru, che nella simbologia indù è la montagna che troneggia l’universo. L’ulti-
mo chakra, il supremo, è situato alla sommità del cranio e rappresenta il più alto livello me-
tafisico, meta ultima della meditazione dello yoga” (Enciclopedia dello Yoga – Promolibri).
Considerando quanto più avanti verrà detto sulle influenze induiste nella so-
cietà giamaicana, ritengo scontato che questo termine sia stato adottato dai Ra-
sta anche in virtù della loro esposizione a quella forma di religiosità. Quando lo
scelsi come nome del club non avevo contezza di questa sua altra origine. Solo a-
desso posso dire di capirne veramente l’essenza e di cogliere le indicazioni che a
quel tempo avevo solo inconsapevolmente seguito.
Oggi, sentirmi parte di Rastafari coincide con la responsabilità di abitare un
corpo, di esserne l’anima, quindi di poterlo governare teocraticamente. La prati-
ca yogica mi fornisce gli strumenti per tentare l’impresa, rendendomi nel contem-
po anche re della mia storia.
La spiritualità induista e il Messia africano
1850, Giamaica, Indie Occidentali. I guadagni economici prodotti da quat-
trocento anni di schiavismo cominciano a diminuire. L’Impero Britannico ha
bisogno di trovare altre forme di lavoro a buon mercato.
Le rivolte, gli eventi della guerra civile americana, la fine dell’impunità per chi
organizzava e gestiva la tratta dei Neri, l’insostenibilità morale di una tale impre-
sa mentre cercava di sopravvivere ai moti insurrezionali che stavano insangui-
nando l’Europa, lo inducono a sfruttare la sponda indiana dei suoi domini, dove
recluta decine di migliaia di lavoratori per le sue piantagioni.
In pochi anni, una massa di nuovi abitanti invade le colonie caraibiche britan-
niche, recando con sé una spiritualità antica e strutturata; la tradizione induista
entra in profondo contatto con la negritudine in esilio, portando nuove risorse alla
sua resilienza. L’esempio di autonomia e di dignità che proviene da quella cultura
produce i suoi frutti, sposta il terreno di lotta dalla difesa della libertà fisica alla ri-
costruzione di una storia e un’identità spezzate. É l’inizio dell’epifania Rastafari.
Lo spirito del Brahman/Abramo, come già avvenuto in Canaan, torna a in-
contrarsi con la stirpe camitica e gli fornisce l’antidoto per sottrarsi al più grande
14
crimine mai concepito dall’uomo. Da quel remoto avamposto della diaspora afri-
cana le consente di porre fine a un viaggio epocale: il ritorno a casa d’Israele, il ri-
congiungimento dei suoi figli, mentale e culturale prima ancora che fisico, con la
terra madre da cui sono stati alienati.
Neanche le manipolazioni bibliche sono riuscite a omettere il legame diretto tra
Africa e Mose. Sposato con una etiope, possiamo ragionevolmente supporre che
lo fosse anche lui. Riguardo Gesu, mi limito a considerare le tante madonne nere
venerate nel mondo. Che altro dire? Lascio all’overstanding di ciascuno il compi-
to di trarne le conseguenze.
Dal mio emerge un Gesu diverso da quello proposto fin qui; non più vittima
sacrificale del suo stesso popolo, perché il suo popolo è ben diverso dalla folla ru-
moreggiante che ne decreta la morte. E con lui mi appare anche il vero contenu-
to della sua denuncia, quella sola che poteva renderlo così pericolosamente sedi-
zioso agli occhi dei capi politici e religiosi del suo tempo: Israele non è più qua!
Gesu si rivolgeva a un Israele oramai completamente romanizzato; il suo primo
messaggio, la sua prima esortazione, non può non essere stata che questa, magari
sostenuta proprio dal colore della sua pelle e da quei lunghi dreadlocks che nessu-
na manipolazione iconografica è riuscita ancora a sottrargli.
I&I vivo Gesu, i suoi apostoli, il vangelo che li riguarda come parte di quella
storia ancora non raccontata; ciò che si dice di lui, di loro, è il risultato di una so-
fisticata strategia tendente a spostare la legittimità cristiana verso la Grecia e, da
lì, verso Roma.
Come di Abramo esaltano l’obbedienza, di Gesù magnificano il perdono e del-
la sua morte organizzano il culto. Gesù avrà anche perdonato i suoi aguzzini, ma
non prima di averne smascherato le intenzioni. Via, Verità e Vita dell’identità afri-
cana d’Israele dunque, per liberarla dalla schiavitù che gli impedisce di riconosce-
re il suo vero Messia. Altro che sacrificio della croce!
I Patriarchi giamaicani hanno rotto le catene che imprigionavano questa veri-
tà, diventandone essi stessi testimoni e profeti. Unici al mondo, e con la sola for-
za della loro visione, hanno accusato e giudicato tutti coloro che ancora reclama-
no per sè l’autorità di un Gesu risorto non per restare visibile e governare ma per
tornare in cielo a fianco di un dio metafisico, per non dire metaforico. Tra questi
15
I&I annovero anche la Chiesa Ortodossa Tewaedo d’Etiopia, nonostante il ruo-
lo da essa avuto nell’epifania Rastafari.
Mi chiedo quando, dalla solennità dei suoi conclavi, giungerà la piena accet-
tazione di quest’epifania; e quando vedremo riconosciuta, nel contempo, anche
la congruità storico/profetica che il nostro ruolo avrebbe, se adeguatamente im-
plementato nella sua dottrina. Sarà l’intero scenario giudaico/cristiano ad affran-
carsi dallo stigma di romanità cui Babylon l’ha condannato se la Livity Rastafari
diventerà parte della dottrina ortodossa etiopica.
Per quanto mi riguarda, L’Imperatore Haile Selassie I di quella chiesa è l’amo-
revole Padre, il Figlio più glorioso e lo Spirito ardente, alla presenza del quale o-
gni malignità si consuma.
Il dio che ha modellato Adamo, che affidò a Noe e alla sua discendenza il ri-
popolamento della terra, che ha guidato Abramo, che ha parlato a Mose, che si
è rivelato in Gesu, è tornato a mostrarsi. Dal trono d’Etiopia offre il suo gover-
no al mondo intero. Il Leone di Giuda Haile Selassie I, sovrano cristiano cosi in-
trinsecamente organico alla storia d’Israele, è rimasto indenne dalle falsificazioni.
Un Kaya Club oggi
Rastafari per me non è una minestra riscaldata; riferirsi al passato, se significa
l’adozione di pratiche solo imitative, non mi fa diventare nè più forte nè più cre-
dibile. Nel mio programma di vita il rispetto della tradizione e l’azione innovati-
va devono completarsi per realizzare quello che il presente mi consente di essere.
Poggiarmi sulle fondamenta gettate dai nostri Elders non significa escludere ciò
che domani potrà contribuire all’evoluzione della mia Livity.
L’esperienza mistica, come io la conosco, non è prodotta dalla ripetizione di
determinate pratiche ma scaturisce dall’intima connessione con l’onnipresenza
divina, col suo potere ordinatore di tutti i diversi fenomeni presenti nel tempo e
nello spazio.
Ciò che in Giamaica ha generato il movimento Rastafari non è limitato da
frontiere geografiche o etniche. Il suo incontro con espressioni spirituali diverse
può solo rafforzarne l’universalità. Le acquisizioni che ne derivano dovrebbero
costituire le coordinate del viaggio verso casa che I&I proponiamo all’umanità
intera, a ciascuno secondo il suo posizionamento culturale.
16
In nuce, tutti possediamo la capacità di distillare conoscenza vera dalla miscela
d’informazioni e di esperienze cui una ricerca spirituale libera e aperta introdu-
ce. Serve un metodo di attivazione; il nostro potenziale cognitivo non darà i suoi
frutti se non viene preventivamente sbloccato dai paraocchi che spesso vengono
confusi con l’aderenza alla tradizione e all’ortodossia Rastafari.
Non sono il primo a dirlo: I&I non ha più bisogno di validare la devozione
all’Imperatore Haile Selassie attraverso l’autorevolezza profetica della Bibbia; so-
prattutto se ciò significasse accettare anche la parzialità religiosa e culturale che
oggi accompagna quel libro sacro. Non si tratta tanto di rinnegare l’origine divi-
na di quelle scritture, ma di ricongiungersi, proprio grazie al corretto approccio
con esse, con il luogo dell’antica ed eterna unità spirituale tra gli uomini.
Diffondendo questo reasoning desidero collegarmi a chi, nella Livity Rasta-
fari, sta compiendo un tragitto più lungo e più ampio di quello che la Bibbia ha
permesso ai nostri Elders. La mia percezione è che la presenza Rastafari in Ita-
lia non sarà in grado di esprimere piena maturità e credibilità fino a quando la
nostra capacità organizzativa non si concretizzerà in proposte di Livity al pas-
so coi tempi, in cui l’opzione giudaico/cristiana trovi la sua giusta collocazione
rispetto ad altre opzioni ugualmente inerenti alla nostra missione.
Oggi I&I si muove in uno scenario alquanto confuso, territorio aperto per
chiunque decida di esibire croci e tricolori etiopi, di avvolgersi la testa con tur-
banti, di pronunciare frasi fatte e slogans a suon di musica.
A me interessa invece lavorare per elevare gli standards della testimonianza
Rastafari italiana verso una consapevolezza più evoluta del nostro ruolo nei con-
fronti della società in cui operiamo. Voglio mettere a fuoco e raggiungere tutti
quegli obiettivi necessari per emanciparmi da tutto ciò che appesantisce e degra-
da la mia identità Rastafari, partendo dalla qualità della mia stessa vita.
L’uso che i Rasta fanno della cannabis mi fornisce un esempio molto pregnan-
te per entrare nello specifico di alcune questioni. Quello che viene così grossola-
namente associato alla cultura Rastafari è, a mio parere, assai fuorviante rispet-
to a ciò che oggi I&I dovremmo perseguire. È un quadro più favorevole a chi,
temendo davvero il potere illuminante di un sano approccio all’Erba, si adope-
ra per distorcerne la conoscenza, sia proibendola che promuovendone l’abuso.
17
I&I ho da tempo rimosso quei clichè dalla mia Livity; ne ho guadagnato in
chiarezza e in purezza d’ispirazione. Quello che per molti è ancora indiscutibile,
parte irrinunciabile della visibilità e della libertà Rasta, per me rappresenta un
passato da superare, residuo ormai improduttivo di una pratica non più evolutiva.
Nel primo volume di LA MIA LIVITY RASTAFARI - VIVA SELASSIE!
ho trattato la questione più diffusamente.
Riproporre oggi un Kaya Club per me significherebbe immaginarlo come un
luogo dove prepararsi alla nuova legittimazione a cui I&I vogliamo approdare.
Un luogo dove musica, yoga, cura di sè e delle relazioni, ricerca spirituale, dia-
logo, condivisione e impegno sociale sono la pratica quotidiana. Lo vedrei pro-
tagonista della diffusione Rastafari in Italia presso ceti e ambienti di persone
fino a ieri irraggiungibili. Una decisiva occasione per riuscire a convergere, for-
ti anche delle nostre diversità, nell’unico obiettivo che non ci troverà mai lonta-
ni: l’esaltazione dell’insegnamento e dell’esempio che l’Imperatore Qadamawi
Haile Selassie ha lasciato alla storia.
Per concludere il mio reasoning e per meglio agganciarlo al contributo che
seguirà, non trovo scelta migliore che citare le parole di Sua Maestà, tratte dal
discorso da Lui pronunciato in occasione dell’incontro con il presidente india-
no Sarvapalli Radhakrishna:
“Oggi, come mai nel passato, l’uomo sta attuando quei legami d’unità che attraver-
sano le razze; sta cimentandosi nell’uso di tutte le conoscenze e le saggezze accumulate
durante i secoli, sta superando le secolari barriere che hanno diviso i popoli così a lungo
e sta impegnandosi non solo a beneficio di se stesso e dei suoi immediati vicini, ma per il
benessere dell’umanità intera. È uno sforzo che ben si armonizza con lo spirito dei grandi
mistici delle epoche passate. Nelle tradizioni mistiche delle differenti religioni c’è un’unità
di spirito assai rilevante, una sorta di parentela spirituale che prescinde dalle dottrine da
esse professate. Mentre le differenti religioni, nelle loro forme storiche, ci legano a gruppi
limitati e si oppongono allo sviluppo del senso della lealtà per l’intera comunità mondiale,
i mistici hanno sempre affermato la comunanza d’interessi dell’intera umanità”.
Ecco cosa Vostra Eccellenza c’insegna; l’intera vostra vita è stata dedicata a promuovere
quest’insegnamento, a promuovere quei legami comuni a tutto il genere umano per liberarlo
dalle paure e dalle superstizioni che nascono dall’ignoranza.
18
Quanto più povero sarebbe il pensiero umano se la filosofia di Platone e Socrate, se il
credo cristiano e giudaico non fossero stati armonizzati con la filosofia indù; se lo yoga non
fosse stato aperto ai concetti occidentali, se le religioni dell’occidente non avessero ricevuto
le influenze di quelle orientali, grazie anche al costante lavoro di Vostra Eccellenza.
Addis Abeba, 13 Ottobre 1965
L’INFLUENZA INDUISTA NELLA GENESI RASTAFARI
di Ajai Mansingh e Laxmi Mansingh
Introduzione
L’evoluzione del movimento Rastafari è, probabilmente, il fenomeno socio/
religioso più affascinante e dinamico accaduto da alcuni secoli ad oggi in qualsi-
asi società dell’intero pianeta.
Un’ontogenesi di miti religiosi, di ritualità, di codici sociali, di filosofia e te-
ologia, di ideologia, di espressione artistica figurativa e musicale che, agli albori
di ogni altra grande religione, ha richiesto centinaia d’anni per definirsi e svilup-
parsi, sta compiendosi con ammirabile successo e con una progressione ancora
ininterrotta solo in pochi passaggi generazionali in quel segmento di popolazio-
ne afro/giamaicana che tanto ha già lottato per dare significato e motivazione
spirituale alla propria presenza, altrimenti così fragile e sfuggente, nel cosiddet-
to Nuovo Mondo.
I loro sforzi e le loro acquisizioni non meritano d’essere solo simpaticamente
tollerate; meritano un’analisi mirata e rispettosa, priva cioè di pregiudizi, quindi
predisposta anche all’accettazione.
Rastafari, finora, è stato generalmente considerato più come un movimen-
to di protesta politico/sociale in veste religiosa che come un fenomeno misti-
co/spirituale dalle inevitabili conseguenze anche nel campo sociale e politico.
Da quel che ci risulta, i temi spirituali – secondo noi così centrali al movi-
mento – sono stati relegati solo a un particolare settore di esso, quello che viene
considerato affetto da una ‘sindrome da sfruttamento’ e da un’isteria antisistema.
Con il presente studio, invece, proveremo a evidenziare l’importanza che es-
si hanno avuto nell’intera mappa evolutiva dei concetti, delle opinioni, delle u-
sanze e delle regole di comportamento dei Rastafariani; desideriamo, infatti,
19
fornire risposte ad alcuni fondamentali interrogativi che li collegano a un even-
to ancora non pienamente riconosciuto della storia giamaicana: la massiccia
immigrazione di popolazione indiana e induista cominciata il 10 Maggio 1845.
I suoi autori guardano a Rastafari come a un fenomeno spiritualmente ispi-
rato tendente alla realizzazione del piano divino passando per la realizzazio-
ne di se stessi; ottenibile, quest’ultima, attraverso esperienze prima intuitive e
percettive che solo successivamente diventano razionalizzabili. Il nostro tipo di
approccio, pur ponendosi in termini alquanto diversi rispetto alla tradizione fi-
losofica cristiana – nella quale l’individuo si limita a rispondere alla manifesta-
zione di Dio – non vuole provocare malumori ad alcuno.
Del resto, un’esperienza mistica così caratterizzata può essere compresa e/o
vissuta solo quando ci si riesce ad elevare al di là delle distinzioni terrene basate
su antagonismi razziali, politici, religiosi, ecc. Le confusioni e i fraintendimenti
di cui oggi soffre il movimento Rastafari potrebbero essere state create proprio
dal non riconoscimento delle vere origini delle ispirazioni spirituali dei Breth-
rens, e dalla conseguente razionalizzazione che si è voluta fare della loro espe-
rienza – sia di quella senziente che di quella mistica – all’interno della tradizio-
ne religiosa cristiana e del clima socio/politico giamaicano.
Gli sforzi che tuttora gli studiosi intraprendono per rintracciare le origini del
movimento nelle presunte profezie di Marcus Garvey e nell’incoronazione di Hai-
le Selassie – piuttosto che nelle condizioni culturali ed economiche che da tre se-
coli persistevano nell’isola – hanno, secondo noi, azzoppato la sua potenzialità
religiosa. Non c’è da meravigliarsi, quindi, se esso viene descritto solo come una
setta acefala di millenaristi, priva di una vera centralità tematica; e se, pure dagli
autori di questo studio, esso viene comunque considerato ancora troppo razzial-
mente orientato per generare un richiamo e una proposta veramente universali.
Dal Revivalismo a Marcus Garvey
Nel 1860, ventisei anni dopo l’abolizione della schiavitù e una quindicina di
anni dopo l’arrivo dall’India del primo gruppo d’immigrati, un numero conside-
revole di ex schiavi cominciarono ad asserire, all’interno delle loro pratiche reli-
giose ancora impregnate di africanità, anche la divinità del Cristo; principalmen-
te durante le riunioni in chiesa, nelle quali, insieme al Dio supremo, sia il Cristo e
20
sia gli antenati venivano adorati nel caratteristico stile della Kumina (riti di pos-
sessione ad opera di spiriti ancestrali). Ma questo aggancio con la tradizione cri-
stiana di matrice europea doveva essere già stato sufficientemente significativo
fin dal 1816, se le autorità coloniali sentirono il bisogno di condurre una “Inda-
gine conoscitiva sullo stato della religiosità tra gli schiavi e la ricerca dei mezzi più idonei
per diffondere tra loro la luce della vera cristianità”.
Stranamente, la pressione religiosa che i cristiani europei esercitarono su di
essi già in epoca precedente all’emancipazione non fu molto osteggiata, nean-
che da quegli schiavi che in seguito, quando si trattò di distruggere per sempre
lo schiavismo, si dimostrarono invece sufficientemente consapevoli e decisi. Pro-
babilmente ciò che spinse masse di schiavi alla rivolta fu più il desiderio di mi-
gliorare la loro posizione all’interno di quel sistema che la volontà di cambiarlo.
La presenza di cinquemila immigrati induisti di estrazione assai popolare, con
uno spiccato e peculiare senso d’identità etnico/culturale e completamente indi-
pendenti dalle manovre religiose dei Bianchi e dei loro preti, può aver ispirato o,
in qualche modo, catalizzato il movimento religioso, successivamente chiamato
Revivalismo, sopra descritto? Dopo tutto, l’evoluzione spirituale, nella sua com-
ponente emozionale, viene generalmente innescata da una momentanea esposi-
zione a un pensiero forte, a una vera e propria visione ispiratrice.
Quindici anni di manifesta indipendenza culturale dai padroni bianchi nel-
la vita delle piantagioni è, senza dubbio, un periodo abbastanza lungo per deter-
minare una qualche influenza sulle menti, tanto intelligenti quanto indagatrici,
dei mistici giamaicani; privi, com’essi erano, d’una qualsiasi memoria razziale
di quelle conquiste sociali che invece gli Europei, gl’Indiani e, addirittura, i Ci-
nesi residenti in Giamaica dimostravano di avere.
Agl’inizi di questo secolo, il senso dell’identità religiosa e la fiduciosa certez-
za culturale degli Indiani non passarono certamente inosservate a Marcus Gar-
vey; così come non poterono essere ignorate nemmeno dai Giamaicani che si
stabilirono in Gran Bretagna negli anni ’70. Ma la concettualizzazione, la com-
prensione e la reale accettazione di un dio comunque altro da se stessi è stato un
problema che, lungo l’intero corso della storia umana, tutte le società, per quan-
to diverse tra loro, hanno dovuto affrontare.
21
In Africa, ad esempio, la Chiesa Ortodossa Etiopica (fondata nel 330 d.C.)
preferì separarsi dall’Ortodossia orientale piuttosto che condividerne la posizio-
ne sullo status del Cristo. Quest’ultima credeva in un Cristo sia divino che uma-
no, mentre gli Etiopi gli riconoscevano solo la natura divina. Sempre in Africa,
ma molti secoli dopo, i missionari europei dovettero cominciare a usare raffigu-
razioni africanizzate dei personaggi divini per rafforzare il loro impatto sugli A-
fricani da convertire.
Anche Marcus Garvey ha, in un certo modo, adottato lo stesso criterio dei
missionari europei quando, rivolgendosi agli Afro/giamaicani, dava connotati a-
fricani ai personaggi biblici enfatizzando che, pur non avendo dio alcun colore, la
natura umana è portata a osservare ogni cosa come se guardasse attraverso una
sua specifica lente: “… Così come i Bianchi hanno visto il loro Dio usando lenti bian-
che, noi abbiamo appena iniziato a vedere il nostro Dio attraverso le nostre lenti; e, benché
in ritardo, da ora in avanti Lo adoreremo da Etiopici”.
L’Africa, spiegava Garvey, è stata lo scenario in cui si sono svolti gli eventi
biblici, perciò i popoli citati in essa devono essere stati necessariamente di colo-
re. Dunque quei Neri che s’interrogavano su quale veramente fosse il colore di-
vino saranno stati certamente convinti dal Cristo africano suggerito da Garvey.
Non lo furono però quei mistici giamaicani animati da una consapevolezza afri-
cana ancora più forte, i quali, spinti dalle proprie urgenze spirituali, dalle condi-
zioni sociali in cui si trovavano e dagl’influssi che ne ricevevano (verosimilmente
anche dagli Indù), continuarono il loro cammino di ricerca verso la realizzazio-
ne di un dio non dipendente da altre culture religiose, soprattutto da quelle di de-
rivazione europea.
Marcus Garvey nacque e crebbe nel periodo in cui l’immigrazione di mano-
dopera indiana raggiunse il suo massimo. Ma ancora niente è stato scritto sulle
influenze che proprio gl’Indiani potrebbero aver esercitato sul pensiero dell’e-
roe nazionale giamaicano. Un primo elemento che testimonia il favore di cui la
cultura indù godeva presso i coniugi Garvey ci viene fornito dalla stessa moglie
quando, commentando le loro pratiche religiose quotidiane, racconta che: “Abi-
tualmente le preghiere consistevano in invocazioni, a volte sommesse a volte a voce ben al-
ta, per la realizzazione di qualcosa che si desiderava. Alcuni di noi adottavano lo stile me-
22
ditativo degli orientali, altri si appellavano alla forza dello Spirito per superare gli ostacoli
e per essere guidati in ogni loro azione”.
Cos’altro poi se non l’interesse di Marcus Garvey per gli Indo/giamaicani e
per gli avvenimenti indiani può averlo spinto a cominciare una corrispondenza
con il Mahatma Gandhi? Così come dev’essere stato il senso di beatitudine e-
spresso dai visi degl’Indiani ogni qualvolta essi parlavano della loro casa e dei lo-
ro dei incarnati a ispirare Garvey quando diffondeva i suoi appelli riferendosi al
dio d’Etiopia. Magari la sua intenzione era proprio quella di proporre, all’inter-
no del contesto biblico, una meta di devozione e pellegrinaggio in Africa, capace
quindi di attrarre i cristiani di razza nera con la stessa intensità con cui gl’immi-
grati indiani mostravano di venire attratti dai propri luoghi santi.
Durante l’intero periodo migratorio indiano il tema del Ritorno in India ricor-
reva assai spesso. Anche in seguito continuò a essere motivo di dibattito, tanto
da ispirare una grande marcia svoltasi a Kingston nel 1948. Nonostante la mag-
gioranza degl’Indiani immigrati sia poi rimasta in Giamaica, nessuno di loro a-
veva abbandonato la speranza di ritornare nella propria madre patria; ma più il
tempo passava e più il ricordo di casa si idealizzava, facendo così crescere e radi-
care sempre più profondamente la nostalgia e l’attaccamento per essa. Stati d’a-
nimo, questi, che venivano poi trasmessi e condivisi con i compagni di lavoro,
nelle piantagioni e altrove. Tutto ciò non può non avere avuto un certo effetto
anche sui sentimenti e sulle emozioni dei Neri giamaicani.
Diventa dunque importante notare il fatto che, mentre dopo il 1930 nessun
Nero giamaicano sembrò veramente interessato a tornare in Africa grazie al pro-
getto di fondazione della Liberia, molti di loro cominciarono effettivamente ad
agognare un ‘Ritorno in Etiopia’, ma in un modo assai più simile a quello che si
riscontrava tra gl’Indiani.
Nel Pantheon Rasta, Marcus Garvey è generalmente considerato l’ispiratore
del movimento Rastafari, secondo solo ad Haile Selassie. Ma egli, pur essendo
vissuto altri dieci anni dopo l’incoronazione dell’Imperatore – e la sua divinizza-
zione ad opera dei Rasta – è rimasto completamente silenzioso su quella che do-
veva essere la manifestazione evidente delle sue profezie. Del resto, pur ammet-
tendo che Garvey davvero fece delle predizioni sull’incoronazione di un re nero,
23
esse non scaturirono da qualche potere profetico, mistico o divino; erano solo il
frutto di una normale conoscenza degli eventi mondiali.
Alla morte di Menelik, re d’Abissinia, gli era succeduto Lij Yasu, il quale
venne quasi subito deposto. Fu la figlia di Menelik, Zauditu, ad ereditare il tro-
no, ma era Ras Tafari ad adempiere alle funzioni di Reggente; era lui che, alla
morte della Regina, avrebbe regnato. E, dal momento che i sovrani d’Abissinia
si erano sempre mostrati interessati alla Diaspora africana – ed anche all’attività
dell’U.N.I.A. (Universal Negro Improvement Association) – dai loro successori
ci si aspettava un’uguale attenzione.
Bisogna anche interrogarsi sul fatto che, mentre i Rastafariani hanno elevato
Marcus Garvey al rango di profeta, la signora Garvey si è mantenuta sempre to-
talmente indifferente al loro movimento, quasi come per dissociare i Garvey da
esso. In un suo scritto del 1974, Garvey and the Garveyism, ella descrive suo ma-
rito come “un sionista negro” che ha dato nuovo impulso alla religione dei bei
tempi andati, insegnando a visualizzare Cristo – il Salvatore di tutto il genere u-
mano – come un uomo di pelle scura.
La forte fede cristiana di Marcus Garvey non viene evidenziata solo dai suoi
concetti africanizzati del Cristo e della Bibbia. Nel 1922 egli fece concreti tenta-
tivi per dichiarare ufficialmente cristiana l’intera UNIA, dovendo però recede-
re dall’idea per non alienarsi l’appoggio dei musulmani che già aderivano all’or-
ganizzazione.
L’Induismo in Giamaica
Il programma d’immigrazione a contratto condusse in Giamaica, tra il 1845
e il 1917, più di trentacinquemila lavoratori indiani; con essi introdusse nell’iso-
la un intero nuovo sistema di credenze religiose e di rituali, di filosofia, di sche-
mi socio/culturali e di nuovi mestieri che ebbero un impatto sottile, ma significa-
tivo e indelebile, sulla vita e sulla mentalità delle masse giamaicane.
Non appena misero piede nell’isola, gl’Indiani diventarono un polo d’attra-
zione e di curiosità, un motivo d’affetto e d’attenzione per la popolazione rura-
le. Gli si dava il benvenuto, gli ex schiavi li accoglievano con cortesia e ospitali-
tà, offrendogli cibo e bevande. I compagni nelle piantagioni li trattavano subito
con amicizia e quando i datori di lavoro non riuscirono più a garantirgli né il sa-
24
lario promesso né una regolare assunzione e nemmeno il costo del viaggio di ri-
torno, un gran numero di questi indiani, provati e malnutriti, invasero le strade
di quasi tutte le città dell’isola.
Il fenomeno generava continui episodi di cronaca, puntualmente riportati dal-
la stampa, e divenne argomento di molti dibattiti parlamentari. Gli ambienti le-
gati alla chiesa, già contrari alla politica immigratoria, trovavano sempre nuovi
motivi per biasimare i ‘paganismi’ e le ‘insanità’ degl’Indiani, guardandosi bene
però dall’organizzare una qualsivoglia opera di assistenza.
Tra le masse nere, invece, la condizione degl’Indiani provocò più simpatia e
curiosità che indifferenza o insensibilità. Inavvertitamente la presenza degli In-
dù, e l’unicità della loro cultura, divenne nota in tutta la Giamaica.
È induista colui che riconosce la trinità divina costituita da Brahma (il creato-
re), da Vishnu (il conservatore) e da Shiva (il distruttore/ricostruttore). Questi tre
aspetti della Trimurti sono considerati forme diverse della stessa Suprema Divi-
nità e dovrebbero governare le nostre vite sia nei pensieri che nelle azioni.
I concetti fondamentali che ne derivano sono: l’autorità di Brahman, l’Assoluto,
l’Essere Supremo, il Dio degli dei, la sorgente dell’energia e della vita universale;
la divinità dell’Atman (l’anima individuale della creatura) in quanto parte del Para-
matman (l’anima suprema del Creatore) e la loro riunificazione, obiettivo ultimo
di ogni anima incarnata indipendentemente dal numero di rinascite necessario; il
Dharma o la vita retta, fedele cioè alla legge interiore, come cammino di elevazio-
ne spirituale; il Karma, cioè la catena che lega ogni azione alle sue conseguenze.
In quanto parte – o figlio – di un’Anima Suprema, l’induista contribuisce a
realizzare il piano divino cominciando a realizzare se stesso, mantenendo la sua
propria divinità di creatura sempre in armonia con la Divinità Creatrice. Le in-
tuizioni e le percezioni che egli vive vengono accuratamente razionalizzate, per-
ché è dalla razionalità che deve svilupparsi la spiritualità. Il piano spirituale va
però mantenuto ben al di sopra di quello razionale che, a sua volta, deve elevarsi
dal piano senziente. Le vie per realizzare il divino sono: la devozione, la medita-
zione e la ricerca della conoscenza.
Mitologicamente parlando, i poteri di ogni polo della Trimurti risiedono nel-
le loro consorti. Tra esse c’è la consorte di Shiva, che può però manifestarsi in u-
25
na vasta gamma di deità femminili: dalla più bonaria e materna Sati, alla più ter-
rificante Kali.
Riconoscendo il bisogno che ogni persona ha di realizzarsi in Dio parten-
do dalla propria storia, tradizione ed esperienza, l’Induismo non impone mai le
sue vedute né i suoi concetti, preferendo piuttosto accogliere al suo interno quel-
li degli altri, rendendoli così accettabili e condivisibili. È forse proprio grazie a
questa attitudine di fondo che i sacerdoti indù si guadagnarono il rispetto degli
Afro/giamaicani, particolarmente nei sobborghi ad alto mescolamento etnico
come West Kingston.
Sui posti di lavoro o nelle occasioni di socialità la filosofia indù, la sua mito-
logia, specialmente quella riguardante la dea Kali, e le pratiche rituali – inclusa
quella dell’uso della ganja (cannabis) come medicamento ed euforizzante – ve-
nivano soventemente discusse. I mistici afro/giamaicani erano soprattutto affa-
scinati dallo status che l’induismo dà alle sue varie divinità, dall’effetto che es-
so provocava nei devoti. Ad esempio, la dea nera Kali, terribile espressione della
madre terra, nella mitologia indiana è considerata la forma più potente di ener-
gia divina; grazie al suo potere di distruggere il male, viene invocata per solleva-
re gli animi dai sentimenti di afflizione, di disperazione e di bisogno.
In Giamaica le Kali-puja diventarono occasioni speciali di riunione per i fe-
deli, i loro parenti e una cerchia ristretta di amici. Inizialmente ai rituali e alle
preghiere cerimoniali potevano partecipare solo i devoti indù, ma c’era sempre
qualche Afro/giamaicano che, seppur da lontano, tendeva a sbirciare e a origlia-
re su quanto accadeva. Durante il rito veniva sacrificato un montone, si recitava-
no i mantra e si fumava ganja, per poi celebrare con canti e danze tra continue
invocazioni alla dea.
La segretezza di queste speciali occasioni si erose sempre di più, fino ad an-
nullarsi del tutto dal 1915 in poi, quando un gran numero d’Indiani si trasferiro-
no a Kingston e in altri centri, entrando perciò in più stretto contatto con gli A-
fro/giamaicani.
Si sa che la ganja veniva usata per scopi medicinali e commerciali dai popo-
li che abitavano la valle dell’Indo fin dal 3000 ac. Dall’India la pianta si è diffu-
sa in altre parti del mondo e la droga che se ne ricava è conosciuta con vari no-
mi (marijuana, kif, charas, ecc.).
26
Sono sicuramente stati gl’immigrati indiani a introdurre la pianta in Giamaica,
probabilmente durante la prima fase dell’immigrazione (1845 – 1848), conside-
rando il fatto che la maggior parte di quegl’immigrati provenivano da una regione
dove l’uso rituale della cannabis, associato alle Kali-puja, è tuttora molto diffuso.
La pianta venne liberamente coltivata nei terreni delle piantagioni destina-
ti all’approvvigionamento agricolo, fino a quando l’uso smodato che i braccian-
ti afro/giamaicani cominciarono a farne aprì la strada, nel 1913, alle leggi che
la proibirono.
Anche l’usanza dei locks – chiamati jata dagl’Indiani – è stata, e continua ad
essere, una tradizione molto diffusa tra i mistici e i santi dell’India. I Jatavi, ov-
vero gli uomini con i locks, non erano perciò così insoliti tra gl’immigrati indiani
presenti in Giamaica, perché in ogni comunità indiana dell’isola alcuni dei suoi
membri diventavano locksman per motivi religiosi.
Uno studio compiuto presso la Biblioteca Nazionale su fotografie e dipinti an-
tecedenti il 1930 non ha fornito alcuna prova della presenza di locksman afro/
giamaicani. È stata però trovata una foto risalente al 1910 che ritrae un gruppo di
Indiani in una piantagione, e tra essi si nota anche un Jatavi con dei lunghi locks.
Tra gli Indù si sono codificate attenzioni speciali verso le donne mestruate;
esse sono esenti dalle mansioni domestiche. In quei giorni, anche per ragioni sa-
nitarie, non frequentano né le cucine né i templi. Questa tradizione è stata mol-
to rispettata dagli Indo/giamaicani fino al 1950, particolarmente nella zona di
West Kingston dove, come già detto, s’erano stabiliti numerosissimi induisti e
molti dei loro sacerdoti.
I Veda e la Gita sono i più antichi libri sacri in cui, per progredire nella vi-
ta spirituale, viene raccomandata la dieta vegetariana. In Giamaica, i sacerdo-
ti e tutti i più ortodossi devoti indù si attenevano a questa prescrizione, men-
tre la maggioranza degl’Indiani si asteneva, comunque, dalla carne di maiale
e di mucca.
Dando il giusto valore all’insieme dei sopracitati fattori, si può agevolmente
comprendere come la costante esposizione alle kali-puja rituali degli Indù, ai lo-
ro racconti storici e mitologici, al loro tradizionale uso della ganja e alle altre lo-
ro manifestazioni culturali, possa aver acceso quella curiosità intellettuale, spi-
27
rituale e psicologica così unica nei Neri giamaicani. Essi dovettero trovare non
poche similarità tra la propria sensibilità mistica e l’approccio intuitivo e percet-
tivo che gli induisti mostravano di avere con il continuo svelarsi dei misteri divi-
ni. E quando gli Indiani lasciarono le piantagioni per riversarsi nelle città, la lo-
ro religione e la loro cultura gli divenne ancora più familiare.
Le navi degl’immigrati indiani, inoltre, facevano scalo anche in Africa e im-
barcavano un buon numero di passeggeri africani. Durante il lungo viaggio es-
si diventavano così ben informati sull’Induismo che, una volta giunti a destina-
zione, dovettero contribuire non poco a rendere la cultura indiana più popolare
tra gli Afro/giamaicani.
Induismo e Rastafari
Così come i Cristiani introdussero il concetto di un Essere Supremo – e del suo
figlio Gesu – nel sincretismo religioso sviluppatosi in Giamaica, agli Indù può
essere attribuita l’introduzione di due nuovi concetti nella spiritualità afro-orien-
tata presente nell’isola: quello di una divinità africana di natura simile alle dei-
tà indiane, e quello di un regnante con poteri sia divini che temporali; concetto,
quest’ultimo, che ha caratterizzato in maniera unica il formarsi della gerarchia
spirituale induista. È in esso che, secondo noi, trovò successivamente posto la fi-
gura di Haile Selassie; a conferma del fatto che nessun altro gruppo di Giamai-
cani è stato cosi influenzato dalla filosofia e dalle tradizioni indù come lo furo-
no i Rastafariani.
Quando nel 1918 Joseph Hibbert – co-fondatore, insieme a Leonard Howell,
del movimento Rastafari – cominciò a sentir parlare delle deità incarnate india-
ne, volle saperne di più. Dopo aver letto libri e averne discusso con amici, con-
cepì egli stesso l’idea di un’incarnazione divina africana. Si convinse che “…O-
gni nazione ha il suo dio; così come ce l’hanno i Bianchi e gl’Indiani, anche gli Africani
ne hanno uno, solamente che noi ancora non lo conosciamo”. La sua ricerca di una di-
vinità africana prendeva dunque il via, e con essa l’intero processo che porterà
alla nascita del movimento.
Secondo noi, dunque, le origini di Rastafari trovano la loro ovvia collocazio-
ne in quella mistica scoperta di dio e della sua umana manifestazione che poté
essere raggiunta anche grazie al percorso – sia meditativo che senziente – forni-
28
to dagli Indù. Naturalmente sono stati tutti i diversi stimoli presenti nel contesto
giamaicano di allora a innescare il processo, ma esso si diresse e si modellò assai
conformemente all’esempio devozionale che proveniva dall’Induismo, pur man-
tenendosi sempre entro quei confini forniti dal concetto e dalla visione del dio in-
carnato – e della sua esistenza nel tempo e nello spazio – che i singoli suoi prota-
gonisti hanno saputo, ed ancora oggi sanno, esprimere e realizzare.
La nicchia spirituale che, anche grazie al contributo degli Indo/giamaicani,
si era aperta nel pensiero e nella filosofia dei fondatori del movimento Rastafa-
ri trovò il suo inquilino nel 1930 quando, da un quotidiano locale, essi appresero
la notizia dell’incoronazione a Imperatore di Ras Tafari Makonnen il quale, ol-
tre al nome di Haile Selassie I (Potenza della Trinità), aveva anche assunto i tito-
li di Re dei Re, Signore dei Signori, Leone Conquistatore della Tribù di Giuda.
Per Howell, Hibbert e i loro accoliti gli anni della ricerca si erano dunque con-
clusi; come le deità indiane, anche Haile Selassie era nato re, e come loro non po-
teva non essere che divino, visto che anche i suoi titoli lo affermavano. Howell,
Hibbert e gli altri, però, non si sforzarono più di tanto per capire che quei tito-
li gli provenivano da un governo scelto da lui stesso e che, nonostante la Chie-
sa Ortodossa Etiopica formalmente gli riconoscesse il legame con il re Salomo-
ne e con la regina di Saba, né essa né tantomeno il resto del mondo erano pronti
a controfirmarli.
Fin dai suoi esordi in Rastafari si sono sovrapposte due diverse posizioni sull’e-
satto status divino di Selassie: quello che lo vede come divinità incarnata e quel-
lo che lo considera la reincarnazione di Gesu. Ambedue, secondo noi, riflettono
una profonda influenza induista.
Coloro che più conoscevano l’Induismo e si muovevano con un approccio
più autonomo (Howell e i suoi), guardavano a Selassie come la manifestazione
stessa di dio; questa è la posizione che rifiuta di far coincidere l’essenza divina di
Selassie con quella di qualsiasi altra entità messianica, men che meno con il Cri-
sto degli Europei. In questo i seguaci di Howell si dimostrano filosoficamente,
ritualisticamente e normativamente più induisti dei seguaci di Hibbert i quali,
basandosi maggiormente sulla Bibbia, considerano Haile Selassie come la rein-
carnazione di Gesu Cristo.
29
Ma, indipendentemente dal fatto che l’anima di Haile Selassie si sia già ma-
nifestata o no, la sua esistenza è stata comunque concepita passando attraverso il
concetto della (re)incarnazione; il suo ruolo in Rastafari è perciò comparabile a
quello delle deità incarnate (Rama, Krishna o Buddha) dell’Induismo.
Il suo status e l’origine divina che i suoi devoti gli riconoscono non possono
essere, neanche remotamente, collegate alle cose teorizzate e predicate da Gar-
vey, così come si distaccano da ciò che predicano Giudaismo, Islam e Cristianità.
La fase d’incubazione del movimento Rastafari durò tre anni (1930/33) e av-
venne a West Kingston, il quartier generale degli Induisti.
Hibbert e i suoi seguaci, provenendo dal Garveyismo e conoscendo solo la
Bibbia come Sacra Scrittura, cominciarono a collocare in essa il concetto del
‘Cristo rinato’, studiandone accuratamente i passaggi da cui trarre la conferma
– a volte anche in maniera assai vaga – della loro ipotesi.
I seguaci di Howell, invece, continuavano ad affermare il supremo ruolo di-
vino di Haile Selassie, ricercando però anche una forma di religione, uno stile
di vita più affine alla storia e al credo religioso induista. Hibbert arrivò a scon-
trarsi con Howell sull’argomento e lo attaccò, sostenendo che il suo era solo un
tentativo per arrivare a dichiararsi profeta.
Vero è che Howell cambiò il suo nome in Gyangun Guru Maharaj (il Vir-
tuoso, il destinato alla Conoscenza). Molto probabilmente – dando credito alle
accuse di Hibbert – egli voleva costruire un’organizzazione, un movimento re-
ligioso simile a quello dei Musulmani Neri operante negli Stati Uniti. Il fonda-
tore di quel movimento, infatti, aveva ritenuto necessario affermarla la sua pro-
feticità, affiancandola addirittura a quella di Maometto. Del resto, la presenza
in loco di una figura guida con un’aura di divinità ha sempre favorito l’adozio-
ne e la nuova interpretazione di filosofie e di pratiche già esistenti.
La comunità di Pinnacle, fondata e guidata da Howell secondo il modello
degli ashram induisti, ha fortemente influenzato i primi decenni del movimen-
to, diventando più volte scenario di violente incursioni poliziesche. Ma la filoso-
fia Rasta, nei suoi codici e nelle sue tradizioni, ha continuato anche dopo a im-
pregnarsi di varie usanze e concetti provenienti dall’Induismo. In anni recenti, la
loro adozione può essere stata ulteriormente incoraggiata dall’emergere – sem-
30
pre negli Stati Uniti – di vari movimenti ispirati alla misticità orientale, non ul-
timo quello Hippies.
Sicuramente è stato Howell a sancire tra i Rasta il continuo uso della ganja per
invocare gli spiriti interiori, affermando tra l’altro che: “…Il centro della religiosità
Rasta è quella dimensione rivoluzionaria che si apre in seguito all’impatto della Santa Erba”.
Anche l’usanza dei locks entrò a far parte delle tradizioni Rasta durante gli
anni di Pinnacle, più esattamente nella sua seconda fase, diffondendosi ancora
di più tra il 1960 e il 1970 allorquando, oltre al significato mistico, acquistò una
valenza antisistema. Secondo una certa ipotesi, essa si affermò in seguito alla dif-
fusione di alcune foto di guerrieri etiopici.
Tuttavia, il fatto che i locksman già esistevano in Giamaica ancor prima degli
anni ’30 – e che venivano definiti col termine hindi Jatavi – aggiunto alla conside-
razione che il Ritorno in Africa non ha fatto parte fin dall’inizio delle tematiche
Rastafariane ma si è aggiunto ad esse solo successivamente, suggeriscono un’o-
rigine tutta giamaicana di questa usanza, proveniente cioè dagli ambienti dei la-
voratori immigrati indiani e dalle immagini religiose e mitologiche abitualmen-
te esposte nelle loro case.
La stessa provenienza potrebbe avere l’invocazione che i Rasta rivolgono a
dio con la frase Jah Rastafari! Verosimilmente essa deriva dall’espressione indù
Jai Bhagwan o Jai Ram. C’è una grossa somiglianza fonetica tra Jah e Jai, e l’u-
so che ne fanno i Rasta è decisamente affine a quello praticato dagli Indù; in o-
gni caso, assolutamente non paragonabile a ciò che avviene nella Cristianità o
nel Revivalismo.
Anche la vita familiare dei Rasta – e i ruoli religiosi che in essa si esprimo-
no – si è sviluppata in linea con le tradizioni indo/giamaicane. Lo status dell’uo-
mo e della donna nelle coppie indiane è più complesso di quello che appare agli
occidentali; in esse, così come il marito è considerato divino, la moglie è la di-
vinità. Ma, nonostante ciò, le mogli non presiedono mai le puja o le attività del
tempio; socialmente parlando, esse si pongono sempre in seconda posizione ri-
spetto ai loro mariti. In maniera molto simile, la donna Rasta è vista come la re-
gina, ma non le viene dato alcun ruolo nelle gerarchie religiose o sociali, diver-
samente dalle chiese sorte durante il Revivalismo, dove le donne ministro erano
molto più comuni.
31
Il vegetarismo è parte delle tradizioni induiste tanto quanto la filosofia del kar-
ma e della reincarnazione; risulta dunque difficile credere che sia entrato nelle a-
bitudini dei Rasta indipendentemente dalle influenze indù, specialmente consi-
derando la sua quasi completa assenza dalle tradizioni di qualsiasi società non
orientale.
Analogamente, è solo agli Indù che i Rasta possono essere collegati quando
alla donna mestruata viene richiesto di astenersi dalle faccende domestiche e dal-
le riunioni religiose.
Conclusioni
Basandoci sulle prove che abbiamo fin qui fornito, per noi Rastafari è la rispo-
sta mistica a quell’urgenza spirituale che, dall’interiorità, chiama alla realizzazio-
ne di dio attraverso la realizzazione di se stessi nel tempo e nello spazio. La sua
nascita e il suo sviluppo sono certamente di matrice giamaicana, ma sono stati i-
spirati da stimoli di natura socio/culturale presenti nell’isola già da molti decen-
ni prima dell’effettivo emergere del movimento.
È dagli anni settanta in poi che Rastafari cominciò veramente ad espandersi
tra la Diaspora africana, ma non tutti vi aderirono per realizzare la propria ricerca
mistica. Alcuni lo fecero solo per esprimere visivamente un’identità etnica, altri fu-
rono attratti dall’uso della ganja, altri ancora per semplice opportunismo politico.
Noi non vediamo correlazioni tra la filosofia, l’insegnamento e l’esempio of-
ferto da Garvey e i concetti basilari, le opinioni, le ritualità e i codici di comporta-
mento Rastafari; al contrario, esse ci sembrano due strade completamente diverse:
l’una incastonata nelle tradizioni euro/cristiane, l’altra nell’induismo popolare
praticato dagl’Indiani emigrati in Giamaica.
Le cosiddette profezie di Garvey hanno solo un valore di mito, non essendo
mai state in alcun modo documentate nè, dagli stessi Garvey, confermate. Il lo-
ro silenzio sul movimento non può essere ignorato, liquidato o male interpretato.
Tuttavia Garvey potrebbe aver fornito ai fondatori del movimento Rastafari la
fiducia necessaria per consentirgli di procedere lungo la propria autonoma strada.
Va anche ricordato che tutti gli sforzi fatti dai seguaci di Howell per promuo-
vere il culto di Haile Selassie tra i garveyiti di New York sono completamente fal-
liti; i Neri americani, ovviamente, non avevano alcuna cognizione di cosa fosse
32
l’Induismo, nè avevano alcuna ‘nicchia devozionale’ disponibile nella loro pre-
disposizione spirituale. La ‘consapevolezza nera’ risvegliata in loro dagl’insegna-
menti di Garvey non poteva essere sufficiente per permettergli di concepire una
nuova religione o di accettare nuove divinità.
Per i Rasta è stato altrettanto ovvio respingere il concetto del ‘Cristo nero’
proposto da Garvey e creare una nuova figura divina la cui origine ed esistenza
fosse per loro tanto esclusiva quanto Rama, Krishna e Buddha lo sono per l’In-
dia e per l’Asia intera.
Rastafari non può neanche essere considerato una variante del Revivalismo,
perché i due movimenti differiscono l’uno dall’altro in modo molto significati-
vo. Nel Revivalismo non c’è mai stato spazio per Haile Selassie, per la ganja, la
reincarnazione, ecc.. Pur essendoci in esso un grande imput di africanità, solo la
divinità di Gesù Cristo viene riconosciuta e adorata. C’è, è vero, qualche simila-
rità con i Rasta nella pratica di evocare le energie spirituali interiori, ma i modi
e gli scopi non coincidono.
I concetti basilari, i comportamenti e le ritualità Rastafari sono invece mol-
to più affini all’Induismo praticato in Giamaica fin dal 1845, essendone – a pa-
rer nostro – una derivazione.
La reincarnazione, la divinità dell’anima, la legge del Karma, la realizzazio-
ne divina attraverso la realizzazione personale sono, a ben vedere, i pilastri por-
tanti anche della filosofia Rasta.
Altri suoi aspetti come il vegetarismo, l’uso cerimoniale della ganja, la prati-
ca dei locks, l’invocazione Jah Rastafari, le limitazioni richieste alle donne me-
struate, la generale assenza delle donne dalle gerarchie religiose, sono tutti già
presenti nella tradizione induista giamaicana.
E c’è di più: in ambito Rastafariano è stato pure approfondito e discusso l’u-
so dei chakras yogici per scopi meditativi.
Sono stati gli Indù, dimostrandosi cosi indipendenti dai Bianchi giamaicani e
condividendo – dalla base – le condizioni di vita dei Neri, ad innescare l’imma-
ginazione mistica degli Afro/giamaicani. Probabilmente, l’elemento di sintonia
più grande tra i due gruppi è stato proprio l’approccio intuitivo e percettivo alle
energie spirituali necessarie per la realizzazione divina.
33
Inoltre, la scarsa presenza di donne indiane durante i primi anni dell’immigra-
zione, causò quell’irreversibile integrazione biologica che ha sicuramente gioca-
to un ruolo significativo nella propagazione del pensiero e della cultura induista.
Rastafari, insomma, è un’interessante combinazione tra Oriente e Occidente;
i suoi concetti fondamentali, le ritualità e i comportamenti derivano dall’Indui-
smo, ma esso cerca legittimazione collegandosi storicamente con la Cristianità.
Il forte fondamento biblico dei Rasta, pertanto, non è il riflesso dell’influenza
ricevuta da Garvey, ma è un tentativo di trovare le proprie radici religiose in A-
frica. La loro dipendenza dalla storia cristiana non ci appare motivata tanto da
ragioni spirituali, ma più dalla volontà di fondare stabilmente, tramite Haile Se-
lassie, la loro reclamata antica discendenza.
Il movimento oggi (1980) è di fronte a un bivio: o si rivitalizza in modo dina-
mico e programmato o, gradualmente, svanirà. Se il suo obiettivo era quello di
convincere i Brethrens che le loro radici sono altrettanto profonde e paragona-
bili a quelle degli Europei, potrebbe non avere più molta strada da percorrere,
perché la maggioranza dei suoi intellettuali ha, secondo noi, sprecato i preziosi
anni ’60 e ’70 per riscrivere la Bibbia e reinterpretare i suoi versetti piuttosto che
investire le proprie energie nello sviluppo di una filosofia universale in grado di
attirare la presente generazione.
L’eccessiva fede riposta nell’Antico e nel Nuovo Testamento può averlo per-
ciò privato del suo originale e indipendente richiamo religioso invece che averne
rafforzato – nel tempo – la credibilità.
Traduzione e adattamento di Guido Farella