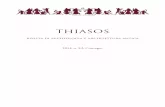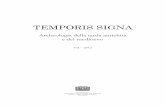La meloterapia come strumento taumaturgico del culto di Asclepio, in Atti del Convegno "Asclepio e...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of La meloterapia come strumento taumaturgico del culto di Asclepio, in Atti del Convegno "Asclepio e...
73
La meloterapia come strumento taumaturgiconel culto di Asclepio
Valentina Calì
Con il presente contributo ci siamo proposti di esaminare le fonti lettera-rie, epigrafiche e archeologiche al fine di verificare l’eventuale utilizzo a scopo terapeutico della poesia lirica ovvero del mšloj – secondo la definizione pla-tonica1 di canto costituito da tre elementi: parole, armonia e ritmo (tÒ mšloj ™k triîn ™stin sugke…menon, lÒgou te kaˆ ¡rmon…aj kaˆ ∙uqmoà) e cioè da parole accompagnate dal suono di strumenti musicali – e quindi l’even-tuale esistenza della meloterapia come prassi curativa consolidata nel culto di Asclepio in età greca e romana.
Com’è noto il culto di Asclepio era un culto iatromantico, sviluppatosi in Grecia a partire dalla seconda metà del V secolo a.C. e diffuso in tutto il ba-cino del Mediterraneo sino ai primi secoli dell’era cristiana, attraverso il quale il devoto otteneva i rimedi necessari al recupero e al mantenimento della pro-pria salute o, in alcuni casi, anche la guarigione istantanea.2 L’attività terapeuti-ca rientrava nell’ambito delle attività cultuali che si svolgevano negli Asklepieia proprio come in un vero ospedale, con tutto ciò che questo comportava, sia in termini di personale addetto, sia in termini di spazi per l’accoglienza. Per-tanto i trattamenti curativi facevano parte dell’itinerario cultuale che vedeva il momento culminante nel rituale dell’incubazione, durante il quale il paziente riceveva in sogno il dio e otteneva al risveglio la prescrizione di una cura o la guarigione miracolosa. Il percorso cultuale comprendeva una serie di rituali, preliminari o successivi all’incubazione, che si traducevano in attività terapeu-tiche e che al tempo stesso erano utili per agevolare il contatto diretto con la divinità. Spesso tali rimedi curativi coincidevano con quelli prescritti dalla medicina empirica contemporanea3 ma nel culto divenivano uno strumento taumaturgico ancora più efficace.
1 Plato, Rep. 398d. 2 Per gli aspetti storico-religiosi riguardanti la complessa e problematica questione dell’ori-
gine del culto di Asclepio in Grecia vedi Edelstein-Edelstein 1945, II, 65 ss. e Sfameni Ga-sparro 2002, 205 e ss., in particolare nota 10 con bibliografia precedente.
3 Dalle testimonianze in nostro possesso, costituite in particolar modo dalle liste delle
Asclepio.indd 73 30/09/2008 15.10.59
74 Valentina Calì
Gli studi storico-religiosi e archeologici hanno permesso di ricostruire un quadro abbastanza preciso delle attività terapeutiche praticate negli Asklepieia ed hanno focalizzato la loro attenzione sulle prescrizioni di esercizi fisici, di-giuni o rimedi a base di erbe evidenziando anche l’impiego di cure specifiche come l’idroterapia, che prevedeva l’uso di acqua corrente sulle parti malate o anche l’assunzione di acqua salutare, pratiche ininterrottamente attestate nel culto del dio dall’età greca a quella romana imperiale.4
Per quanto riguarda invece la meloterapia, sino ad oggi mancano studi specifici sul suo utilizzo nel culto di Asclepio, anche se a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso si sono notevolmente sviluppati gli studi sull’im-portanza e il ruolo della musica nella cultura, nella società e nella religione greca e romana e sulle relazioni con particolare riferimento ad alcune divi-nità come Apollo, Diosiso e Cibele, e si è costituito un filone di studi sulla psicomusicologia e musicoterapia antica.5 È infatti noto che i benèfici effetti della musica sulla psiche umana erano ben conosciuti nell’antica Grecia e che, anzi, la medicina tradizionale vi attribuiva il potere di curare molte e diverse malattie, non solo di tipo psichico ma anche fisico. A questo proposito è già stato rilevato, grazie in particolar modo alla lettura delle opere di Platone e di Teofrasto e degli scritti del Corpus Ippocraticum, che non soltanto la specula-
iamata o sanactiones rinvenute negli Asklepieia e dalle fonti letterarie si deduce che i rimedi e le cure adottate dai sacerdoti nel tempio erano pressappoco gli stessi di quelli consigliati dalla medicina laica, dove un ruolo importante giocava l’utilizzo di sostanze naturali, erbe e medi-camenti di comprovata riuscita e di antica tradizione. Per la relazione tra il culto di Asclepio e la medicina ippocratica vedi Temkin 1991, 79-85 e Kee 1982, 134-136.
4 L’acqua rivestiva un ruolo essenziale all’interno dei santuari, non solo per gli aspetti pra-tici della vita quotidiana, ma per le sue molteplici funzioni. Innanzitutto l’acqua svolgeva una funzione purificatrice, essenziale prima di accedere all’incubatio; quindi, una funzione idro-mantica, necessaria all’esplicazione delle pratiche oracolari ben attestate anche nei santuari di Apollo; infine quella predominante, ovvero la funzione terapeutica, utile ed indispensabile strumento di guarigione. Ricordiamo, inoltre, la rilevanza fondamentale che l’acqua rivestiva nel mondo antico e il fatto che essa fu sempre connotata da una profonda ambivalenza insita nella sua stessa natura, sfuggevole e variabile poiché priva di una forma, caratterizzata soprat-tutto da forti opposizioni: caldo-freddo, quiete-movimento, fonte di vita-portatrice di morte. Cfr. gli studi approfonditi sull’utilizzo terapeutico dell’acqua nella Grecia antica di Argoud 1986, Id. 1987, Collin-Bouffier 1992, ed i contributi del convegno di Parigi del 1994 “L’eau, la santé et la maladie”. Sull’uso dell’acqua nei santuari medicali vedi Croon 1967, 225-246 e Ginouvès 1994, 237-243 ed in particolare sul ruolo dell’acqua nella medicina ippocratica si vedano gli studi di Jouanna 1990, 25-40 e Villard 1994, 41-60.
5 Tra gli studi più recenti si segnala Barker 2005.
Asclepio.indd 74 30/09/2008 15.10.59
La meloterapia come strumento taumaturgico nel culto di Asclepio 75
zione filosofica ma anche la medicina scientifica riteneva la musica in grado di riequilibrare stati psichici e fisici alterati e di curare i disturbi provocati dal disagio interiore – come stati di agitazione, di paura o terrore, placare stati d’ira, infondere coraggio- o anche alleggerire la fatica del lavoro6 e persino di guarire l’epilessia e la sciatica,7 soprattutto quando lo strumento veniva suonato secondo la pratica della kataleusis, in direzione del paziente o me-glio sulla parte dolorante. È stato inoltre significativamente sottolineato che Platone paragona l’attività del musicista a quella del medico e il concetto di salute a quello di armonia musicale, e che negli scritti del Corpus Ippocraticum8 il linguaggio musicale è usato frequentemente per esporre questioni di carattere medico.
Ma in particolar modo la speculazione filosofica e la medicina scientifica greca attribuivano una più intensa efficacia curativa alla poesia lirica di carat-tere sacro, secondo il ben noto concetto aristotelico di catarsi,9 cioè capace di produrre effetti terapeutici e risanatori10 e comunque uno stato di benessere fisico. Senza contare che l’inno dedicato alla divinità ed eseguito durante le cerimonie religiose assumeva anche un importante valore cultuale poiché di-veniva proprio uno strumento catartico in grado di mettere in comunicazione il fedele con il mondo divino.
Sull’utilizzo della meloterapia nel culto di Asclepio l’esegesi delle fonti letterarie, epigrafiche e archeologiche ha dato esiti positivi, riconoscendone l’impiego per alleviare sofferenze fisiche e psichiche. Indubbiamente, il potere taumaturgico delle esecuzioni poetico-musicali ben si esplicava in un santua-rio dove il benessere dell’individuo era il principale obiettivo e dove l’incontro diretto con la divinità era ricercato anche mediante un colloquio che nella forza energetica liberata dal canto trovava una efficace espressione.
Coloro che si recavano nei santuari di Asclepio vi trovavano una serie di
6 Teofrasto frr. Nn. 555, 552°-b F . 7 Teofrasto Fr. 726°-c F.8 Corpus Hippocraticum, De Victu I, 8, 2.9 Aristotele, Politica, 7, 1341b 32 - 1342a 16. 10 Aristotele, Poetica, 6, 1449b 24-28; XIII, 2; XIV, 1-2. Aristotele si esprime con queste
parole: «…la musica non va praticata per un unico tipo di beneficio che da essa può derivare, ma per usi molteplici, poiché può servire per l’educazione, per procurare la catarsi (...) e in terzo luogo per il riposo, per risollevare l’animo e per la sospensione dalle fatiche…». Lo stesso Ippocrate parla di una catarsi medicamentosa (Gén. des Animaux 738 a 27) in grado di ristabilire la salute. Inoltre, sulle proprietà terapeutiche della catarsi tragica si veda Pigeaud 1987, 162 ss.
Asclepio.indd 75 30/09/2008 15.10.59
76 Valentina Calì
edifici predisposti per le cure immersi in uno scenario certamente alquanto suggestivo, arricchito dalla presenza della rigogliosa vegetazione del boschet-to sacro,11 dove musiche e canti permeavano lo spazio sacro in ogni momen-to della giornata, creando un’atmosfera accogliente e rilassante. Colui che si rivolgeva ad Asclepio per ottenere la guarigione dalle proprie sofferenze, diveniva partecipe di un’esperienza taumaturgica in cui melodie e canti confe-rivano una particolare enfasi al rituale che si stava praticando e agevolavano il contatto tra la divinità e il fedele e di conseguenza la guarigione miracolosa.
Le numerose epigrafi che venivano donate dai devoti negli Asklepieia, testi-moniano che durante lo svolgimento del culto del dio vi erano alcuni momen-ti ben precisi, connessi in particolar modo al rituale del sacrificio, nei quali l’intonazione degli inni o peana rispondeva spesso ad un preciso ordine dello stesso Asclepio e dunque faceva parte delle prescrizioni terapeutiche che i fedeli ricevevano per bocca della divinità al fine di ottenere la guarigione.
I testi di molti inni o peana sono riportati nelle iscrizioni che venivano pubblicamente esposte nei santuari, all’interno del tempio o in prossimità di esso, dove potevano essere viste da tutti i pellegrini. Insieme agli ex-voto anato-mici l’epigrafe costituiva un’offerta consueta al dio per segnalarne la benevola attenzione in un momento di sofferenza o, più frequentemente, per il ringra-ziamento di una guarigione ottenuta; nella maggior parte dei casi si trattava di stele marmoree nelle quali erano descritti gli episodi di guarigione.12
11 Il sacro boschetto costituiva una componente caratteristica dei maggiori Asklepieia, così come è noto dalle fonti letterarie ed epigrafiche. Una iscrizione dall’Asklepieion di Atene (IG II2, 4960, 28-29) riporta la notizia di lavori eseguiti da Telemaco nel 413-412 a.C. relativi alla piantagione di verde sacro nel santuario e testimonia l’importanza che il boschetto rivestiva nell’ambito dell’area sacra. Esso costituiva infatti il luogo ideale per l’incontro tra l’uomo e il dio e dunque il teatro di feste, sacrifici, offerte votive ed altre cerimonie peculiari e rivestiva al tempo stesso un’importanza paesaggistica non indifferente, costituendo anche un riparo naturale dal sole e dalla calura durante il giorno per i numerosi pellegrini che affluivano bi-sognosi delle cure di Asclepio. In generale, sui boschi sacri e l’atmosfera religiosa di essi nei santuari dell’Asia Minore vedi Graf 1993, 23-29.
12 Le più note sono certamente le quattro lunghe stele con gli iamata provenienti dal santuario di Epidauro, datate nella seconda metà del IV sec. a.C., che raccontano ben set-tanta episodi di guarigione e forniscono utili informazioni, sulle malattie sofferte, sul ceto di provenienza dei malati, sulle prescrizioni assegnate dal dio e sulle modalità di guarigione. La deposizione delle stele con iscritte le guarigioni era un atto spontaneo con il quale i devoti ringraziavano il dio per le richieste esaudite e costituiva pertanto un monumento tangibile dei miracoli compiuti nel santuario. Diversamente che alle origini del culto, in età romana la registrazione degli episodi taumaturgici aventi luogo negli Asklepieia finì nel rientrare nell’am-
Asclepio.indd 76 30/09/2008 15.10.59
La meloterapia come strumento taumaturgico nel culto di Asclepio 77
Nei casi in cui invece l’iscrizione riportava un canto dedicato alla divinità, il dono esprimeva la volontà di istaurare un rapporto ancora più profondo tra dio e devoto, nel quale all’atto di cari$ che la divinità concedeva o che era sollecitata a concedere corrispondeva l’offerta di un canto carist»rio$, ter-mine con cui è definita la benevolenza del dio in due iscrizioni di età romana imperiale dedicate da un certo medico Nicomede.13
Gli inni o peana dedicati al dio costituivano, in parole semplici, vere e proprie preghiere la cui esecuzione o ascolto diveniva uno strumento tauma-turgico efficace –anche per il significato magico-religioso che l’intonazione musicale possiede – per lenire alcune affezioni, in particolar modo quelle legate a problemi nervosi o psicosomatici. Questo tipo di terapia, ovviamen-te, si traduceva nella duplice forma attiva e/o passiva, a seconda del ruolo di diretto protagonista del canto o di semplice ascoltatore che al devoto veniva assegnato.
E nella meloterapia impiegata nel culto di Asclepio rientrano anche gli spettacoli teatrali dove il testo poetico e i cori accompagnati dalla musica e dalle danze avevano un ruolo di rilievo e svolgevano funzione curativa secon-do il ben noto meccanismo aristotelico della catarsi.14 Non a caso, infatti, il teatro costituiva una componente architettonica peculiare dei maggiori Askle-pieia del mondo greco come ad Atene, Epidauro, Corinto, Pergamo, solo per citare i più importanti. L’esistenza di un legame tra gli spettacoli teatrali e il
bito delle prescrizioni impartite direttamente dalla bocca del dio in apertura o chiusura delle iscrizioni, circostanza frequentemente attestata ad Epidauro e a Lebena.
13 IG XIV, 967a e IG XIV, 967b, dedicate dal medico Nicomede.14 Vedi sopra, nota 10.
Asclepio.indd 77 30/09/2008 15.11.00
78 Valentina Calì
culto di Asclepio è anche confermata dai grandi sacrifici che i poeti e gli attori facevano in onore del dio ad Atene, il giorno prima delle Grandi Dionisie, cioè il giorno in cui essi apparivano per la prima volta in pubblico.15
Che gli inni venissero eseguiti mediante l’accompagnamento di strumen-ti musicali è testimoniato dal fatto che alcuni strumenti musicali si trovano citati nelle liste degli inventari dei beni di proprietà degli Asklepieia, insieme agli altri arredi sacri necessari per lo svolgimento dei rituali, come l’aulos e la lyra in una iscrizione della seconda metà del IV secolo a.C. dal santuario di Epidauro.16 Kymbala bronzei17 con iscrizione recante la dedica da un certo Mikylos ad Asclepio, databili all’inizio del V sec. a.C., sono stati rinvenuti in tale santuario nel cosiddetto Edificio E. La loro provenienza topografica in tale edificio è oltremodo significativa perché esso è stato interpretato il luogo dove si svolgeva nel V secolo a.C. il rituale dell’incubazione. Inoltre, il rinve-nimento di kymbala bronzei con iscrizione dedicatoria ad Asclepio assume un considerevole valore storico-religioso anche per le virtù apotropaiche e catartiche attribuite al bronzo nell’antichità.
15 Aeschines, Orationes, III, 66-67: … Dhmosqšnej. . . gr£fei y»fisma, toÝj kairoÝj
tÁj pÒlewj ØfaipoÚmenoj, ™kklhs…an poie‹n toÝj prut£neij tÍ ÑgdÒhi ƒstamšnou toà
™lafhboliînoj mhnÒj, Ót' Ãn tù 'Asklhpiù ¹ qus…a kaˆ Ð proagèn, ™n tÍ ƒer´ ¹mšrai,
Ö prÒteron oÙdeˆj mšmnhtai gegonÒj. .. 16 IG II/III2 1533.17 Museo Nazionale di Atene, 10870; IG IV 1202.
Asclepio.indd 78 30/09/2008 15.11.00
La meloterapia come strumento taumaturgico nel culto di Asclepio 79
SEG 30.390 (III sec. d.C.)
'Asklhpi ]on £e…somenÖj kalep¦j noÚsouj ¢palšxetai ] ¢nqrèpoisin
sÝn Paiîni ¥nakti 'ApÒllw ]ni klutotÒxwi ] wj dš s' ¢e…sw ™pista ]mšnwj katalšxai
'Asklhp ]ioà ¢gla¦ tškna ]j Ümnoj ¢oidÁj ]ton dš soi Ãt[or ] oÚneka p[ ] me [
E ancora dall’Asklepieion di Epidauro proviene un documento di eccezio-nale importanza: si tratta di una iscrizione18 scoperta nel 1977 che conserva notazioni musicali e che costituisce pertanto l’attestazione più antica di uno dei rarissimi esemplari che restituiscono la melodia insieme alle parole. La dedica ad Asclepio è una integrazione19 ma è assai verosimile considerato il luogo di rinvenimento dell’epigrafe. Il testo è in esametri ed epigraficamente risale al III secolo d.C., ma secondo l’editore potrebbe essere riferibile al III secolo a.C. poiché trova impiegato il genere musicale cromatico tipico dell’età ellenistica e ormai “fuori moda” in età imperiale. L’epigrafe è un documento eccezionale perché sopra il primo rigo sono segnate anche notazioni musica-li: due gruppi di note separate da una pausa resa graficamente da un leimma. L’analisi dei simboli ritmici permette di ipotizzare che si tratta di una melodia composta per essere ripetuta nello stesso modo per ciascun verso. In realtà una struttura melodica ripetitiva è altresì ipotizzabile per la maggior parte degli inni conservati, poiché si nota il ripetersi di invocazioni ad Asclepio, spesso indicato l’epiteto Paian, come una sorta di refrain.
I testi degli inni spesso forniscono anche informazioni sulle loro stesse modalità di esecuzione e attestano che i canti erano intonati dai devoti su or-dine dello stesso dio o talvolta da cori di fanciulli per i quali è verosimile ipo-tizzare la presenza stabile nei santuari. Da queste testimonianze emerge come in età greca vi sia un preciso momento del rituale in cui veniva dedicato un canto al dio della medicina, e come questa prassi sia consolidata e collegata al
18 SEG 30.390; DAGM 19.19 West 1986, 39-46.
Asclepio.indd 79 30/09/2008 15.11.00
80 Valentina Calì
momento del sacrificio rituale che certamente era uno dei momenti più sug-gestivi ed importanti del culto. Al tempo stesso è anche possibile ipotizzare con una certa verosimiglianza la presenza di cori di fanciulli che stabilmente risiedevano nell’Asklepieion; alla loro voce si affiancava volta per volta quella dei pellegrini che si univano nei canti leggendo i testi direttamente dalle epi-grafi esposte nei santuari.
Nel caso in cui il canto è intonato direttamente dal devoto, abbiamo detta-gliate informazioni da una epigrafe rinvenuta ad Eritrea nella Ionia,20 databile tra il 380 e il 360 a.C., che conserva il testo di una lex sacra in cui sono enun-ciate una serie di prescrizioni rituali tra cui anche il momento in cui deve es-sere cantato il peana ed il testo del peana stesso. Si dice espressamente che in occasione delle festività religiose quando la città compie sacrifici per Asclepio le offerte devono essere fatte in un primo momento nel nome di tutta la co-munità e non di un singolo individuo; successivamente poi, si può procedere ad effettuare sacrifici secondo le prescrizioni indicate: si dice che dopo avere dormito nel tempio di Asclepio si deve fare un sacrificio al dio e poi ritornare nuovamente a compiere un sacrificio per Apollo e quando si offre la porzione sacra della vittima sacrificata si deve intonare per tre volte il peana.
La presenza del coro di fanciulli nella liturgia di Asclepio è attestata anche da una iscrizione da Epidauro21 (IG IV2, 40), del 400 ca. a.C. dove è descritta
20 Inscriptio Erythraea - Wilamowitz 1909, 40-41.21 IG IV2, 40 (ca. 400 a.C.): toˆ ƒ | [aro]mn£mone$ f[e]rÒsqo: t | [oà de]utšro to‹$ ¢oido‹
| [$ dÒnto, t]Õ d' ¤teron | to[‹]$| [frouro‹$ dÒnto kaˆ t™n] | [dosq…dia].. .
Asclepio.indd 80 30/09/2008 15.11.00
La meloterapia come strumento taumaturgico nel culto di Asclepio 81
la scena di un sacrificio di animali e l’offerta di vegetali sull’altare di Apollo: l’iscrizione è significativa perché menziona coloro che prendevano parte al rituale e che gerarchicamente dovevano dividersi le varie parti delle vittime sacrificali e tra questi sono citati i membri del coro.
La menzione di kouroi interpretabili come membri del coro si trova anche in un’altra iscrizione dal sito di Eritrea,22 che conserva il testo di un inno molto famoso nell’antichità che costituisce una vera e propria lex sacra in cui è riportato un breve elenco della genealogia di Asclepio e la richiesta al dio di guardare con occhi benevoli la città e concedervi prosperità. Dell’iscrizione sono conservate altre tre copie rinvenute in diverse località del bacino del Mediterraneo e riferibili a differenti periodi cronologici.23
Paean Erythraeus in Asklepium (380-360 a.C.)
In una iscrizione dall’Asklepieion di Atene24 (IG II2, 4473) che riporta il testo di un inno composto da Macedonio, un poeta del I secolo a.C., il coro è composto da giovani ateniesi che invocano Asclepio come Paian affinché li protegga dalle malattie; nel testo si dice che costoro che cantano con inni
22 Anonymus, Pean Erythraeus in Asklepium (Edelstein 1945, T. 592).23 Il peana Eritreo è databile tra il 380 e il 360 a.C.; quello di Ptolemaide in Egitto nel 97
a.C.; quello di Atene (IG II2, 4509), nel I-III d.C.; quello di Dium in Macedonia alla fine del II d.C.
24 IG II2, 4473 (Peana di Mecedonio - ca. I secolo d.C.): ... 'Asklhpiš, s¾n de d…dou sof…
an Ømnoàntaj ™j a„[ei q]£llein ™n biotÍ...
Asclepio.indd 81 30/09/2008 15.11.01
82 Valentina Calì
degni di lode (¥me[mp]toj Ûmnoj) la sapienza del dio ricevono in cambio di prosperare insieme alla diletta Igea.
IG II2, 4510 (Peana di Sofocle - età imperiale)
Purtroppo assai mutilo è il testo di un inno conservatosi in una epigra-fe di età imperiale dall’Asklepieion di Atene. Si tratta del cosiddetto peana di Sofocle25 che doveva essere molto famoso nell’antichità anche perché la sua composizione era attribuita al poeta tragico del V secolo a.C. che era noto-riamente devoto al dio della medicina.26 Nell’inno viene descritto il momento culminante di una cerimonia in cui si intona davanti all’altare di Asclepio un inno accompagnato dai flauti sàrix; inoltre nella parte finale mutila dell’iscri-
25 IG II2, n. 4510. Cfr. Oliver 1936, 112.26 Celebri sono le ultime parole di Socrate, alla fine del Fedone di Platone, con cui il filo-
sofo prima di morire chiede ai suoi allievi di offrire ad Asclepio un galletto. Platone, Phaedo, 118 A: .... eŒpen, Ö d¾ teleuta‹on ™fqšgxato: ’W Kr…twn, œfh, tù 'Asklhpiù Ñfe…lomen
¢lektruÒna: ¢ll¦ ¢pÒdote kaˆ m¾ ¢mel»shte. «Egli [Socrate] disse, ed erano le sue ultime parole, Critone, disse, offrite un fallo ad Asclepio. Ma pagatelo e non dimenticatelo».
Asclepio.indd 82 30/09/2008 15.11.01
La meloterapia come strumento taumaturgico nel culto di Asclepio 83
zione si conservano le lettere lur, probabilmente integrabili con lura. Una fonte ascrivibile allo stesso periodo dell’iscrizione, Filostrato Junior nelle Ima-gines (13), ci informa che il dio stesso aveva ordinato a Sofocle di scrivere il peana, come una vera e propria prescrizione, utilizzando il verbo pareggu£w (ordinare).
Le testimonianze epigrafiche sin ora presentate hanno evidenziato l’esi-stenza di un rituale abbastanza tradizionale che rimase praticamente immu-tato dall’età greca a quella romana. E che in epoca romana imperiale la me-loterapia continuava ad essere impiegata con successo. Per questo periodo le iscrizioni che ci forniscono informazioni sono meno numerose ma in com-penso possediamo una fonte esauriente e preziosa. Si tratta degli Hieroi logoi di Elio Aristide, opera in cui il Retore traccia una storia della propria malattia descrivendo le terapie che lo portarono alla guarigione presso il santuario di Pergamo.27
La lettura di questo resoconto autobiografico – che è stato efficacemente definito dagli studiosi «la prima e unica autobiografia religiosa che il mondo pagano ci abbia lasciato» o anche «autobiografia onirica»28 – fornisce una serie di notizie dettagliate sui rimedi curativi utilizzati nell’Asklepieion di Per-gamo e testimonia ancora nel II secolo d.C. l’esistenza di una lunga tradizione medicale ormai consolidata con l’impiego ininterrotto dei medesimi metodi terapeutici dall’età greca a quella romana. Nell’opera di Aristide si fa anche riferimento a procedimenti terapeutici fondati sull’esercizio della parola an-che senza l’accompagnamento della musica, ad una sorta di logoterapia che veniva praticata nei portici del santuario e che aveva fatto dell’Asklepieion di Pergamo la sede di un cenacolo di intellettuali, filosofi, medici, poeti e retori che desideravano recuperare le proprie capacità fisiche ed intellettuali.29
Anche la medicina scientifica di epoca romana, così come quella greca, apprezzava l’impiego di simili terapie “alternative” come riferisce Galeno,30 il celebre medico di Pergamo contemporaneo di Elio Aristide, che riporta che ad alcuni soggetti ammalati Asclepio ordinava una sorta di esercizi psichici consistenti nel «comporre odi, mimi comici e carmi vari» oltre agli esercizi fisici
27 Com’è noto, gli Hieroi logoi corrispondono alle orazioni XLVII-LII della numerazione tradizionale. Sulla personalità di Elio Aristide nel contesto storico-religioso della sua epoca si veda il lavoro di Sfameni Gasparro 2002, che raccoglie anche la bibliografia precedente.
28 Rispettivamente Dodds 1965, 40 e Nicosia 1988, 173-189.29 Si veda l’analisi ben documentata di Nicosia 1984, 9-53.30 De Sanitate Tuenda, I, 8, 19-21.
Asclepio.indd 83 30/09/2008 15.11.01
84 Valentina Calì
come «la caccia, l’equitazione e la pratica delle armi», al fine di placare e regolare le passioni e riequilibrare gli umori corporei.
In più di un’occasione Aristide sottolinea come egli sperimentò su se stes-so la forza guaritrice dei canti, della musica e dell’esercizio della parola:31
Aristide, Oratio 50, 30-31:32
kai; dh; kai; ojdovntaç ajlgw'n pote e[tucon kai; ou[te dia'rai to; çtovma oi|ovç t∆ h\n, ajporiva/ te eijcovmhn deinh'/: oJ de; proçtavttei tw'n lovgwn tina; ajnagnw'nai tw'n pepoihmevnwn moi toi'ç fivloiç ejpaggeivlanta çunouçivan. ei\con de; tovt∆ ejn cerçi; to;n trivton tw'n eijç aujto;n lovgwn: tou'ton ajnevgnwn dia; tevlouç, kai; pri;n a{panta dielqei'n, th'ç ojduvnhç ajpallavgmhn. ejnh'ge dev me kai; pro;ç th;n tw'n melw'n poivhçin. ajrch; me;n ou\n tiç ejgevneto ejn ÔRwvmh/ ejx ∆Apovllwnoç. h\lqe gavr moi ejnuvpnion fravzon tovn te Paia'na wJç devon poih'çai tw'/ qew'/ kai; a{ma th;n ajrch;n aujtou', kai; ei\cen ou{tw pwç, Formivggwn a[nakta Paia'na klhivçw. hjpovrhça me;n dh; o{ ti crhvçomai, dia; to; mhvpw provçqen ejmautou' pei'ran ejçchkevnai peri; tau'ta: ajll∆ ejdovkoun pantelw'ç e[cein ajdunavtwç, o{mwç d∆ ejneceivrhça kai; th'ç ajrch'ç oi|on ejpi; bavqraç ejcovmenoç ejpevrana to; a\/çma ejn duoi'n çtrofai'n, kai; trivthn, oi\mai, tina; ejphvgagon, h}n kalou'çin oiJ grammatikoiv moi dokei'n ejpw/dovn. kai; a[rti te ajpeivrgaçto to; a\/çma kai; proçaggevllei moiv tiç eJorth;n ∆Apovllwnoç ei\nai, ∆Apollwvnia, ejn h|/ th;n iJppodromivan ÔRwmai'oi poiou'çi tw'/ qew'/.
31 Si riporta in nota la traduzione italiana di Nicosia 1984.32 «E un giorno appunto che avevo il mal di denti, e non ero in grado neppure di aprir
bocca, e mi trovavo in tremende difficoltà, mi ordinò di convocare una riunione di miei amici, e di recitare loro uno dei discorsi a lui dedicati: io lessi fino in fondo, e prima ancora di averne completato la lettura mi ritrovai liberato dal dolore. Mi indusse anche a comporre poesie. In verità una prima prova l’avevo fatta a Roma per ispirazione di Apollo. In sogno infatti mi era apparso dicendomi che dovevo comporre un peana in onore del dio, e me ne aveva pure suggerito l’inizio, che suonava più o meno così Celebrerò Peana, signore delle ce-tre. Non sapevo che fare, perché non avevo ancora alcune esperienza in materia, e veramente l’impresa mi appariva impossibile. Ciò nondimeno mi misi all’opera e tenendomi fermo a quel primo verso come ad un appiglio, riuscii a completare un carme in due strofe, cui ne aggiunsi pure una terza, quella che i grammatici chiamano, mi pare, epodo. Avevo appena ul-timato la composizione, quando qualcuno mi annunziò che erano in corso i giochi apollinari, la festa durante la quale i Romani organizzano le corse di cavalli in onore del dio».
Asclepio.indd 84 30/09/2008 15.11.01
La meloterapia come strumento taumaturgico nel culto di Asclepio 85
Aristide, Oratio 50, 17:33
e[fhn ou\n ejgw; mh; e[cein o{ ti crhvçomai, proçtetavcqai gavr moi i[ça kai; pevteçqai, melevthn lovgwn ajnapnei'n ouj dunamevnw/, kai; tauvthn ejntauqoi': levgwn aujtw'/ th;n çtoa;n kai; to; o[nar dihgou'mai. kai; o}ç ajkouvçaç, tiv ou\n, e[fh, poihvçeiç, kai; pw'ç e[ceiç… tiv d∆ a[llo ge, e[fhn, h] a{per dunato;n, tau'ta poihvçw, periballovmenoç qoijmavtion, çta;ç ouJtwçi;, to; provblhma ajpoçhmhvnaç aujto;ç pro;ç ejmauto;n, kai; mivkr∆ a[tta uJparxavmenoç ei\t∆ ajpallavxomai, kai; ou{twç ajfwçivwtaiv moi… mhdamw'ç, e[fh, mh; ou{twç. ajll∆ ejmev t∆ ajkroath;n e[ceiç toutoni; kai; ajgwvniçai pavçh/ proqumiva/: dunavmewç de; melhvçei tw'/ qew'/.
Aristide, Oratio 50, 38:34
oJ çwth;r ∆Açklhpio;ç kai; tou't∆ ejpevtaxen hJmi'n, diatrivbein ejn a[/çmaçi kai; mevleçi, kai; dh; kai; paivzein te kai; trevfein pai'daç. o{ça me;n dh; kai; a[lla th'ç çumboulh'ç tauvthç ajpelauvçamen eijç eujqumivan kai; to; ajntarkei'n ajpevranton a]n ei[h levgein, ta; d∆ a[/çmata h\/don oiJ pai'deç, kai; oJpovte h] pnivgeçqai çumbaivnoi, tou' trachvlou taqevntoç ejxaivfnhç h] tou' çtomavcou kataçtavntoç eijç ajporivaç, h[ tiç a[llh gevnoito a[poroç proçbolh;, parw;n a]n Qeovdotoç oJ ijatro;ç kai; memnhmevnoç tw'n ejnupnivwn ejkevleue tou;ç pai'daç a[/dein tw'n melw'n, kai; metaxu; aj/dovntwn lavqra tiç ejgivgneto rJa/çtwvnh, e[çti d∆ o{te kai; pantelw'ç ajphv/ei pa'n to; lupou'n.
33 «Gli dissi dunque che mi trovavo in grande difficoltà, perché era come se mi fosse stato ordinato di volare: una esercitazione oratoria, per giunta qui - cioè nel portico - ad uno come me, incapace persino di respirare! Gli raccontai il sogno, e quello dopo aver ascoltato: Che pensi dunque di fare e come ti senti? Chiese. Ed io: Cos’altro posso fare, se non ciò che è possibile? Mi aggiusto il mantello, così come mi trovo, il tema me lo propongo io stesso, e prendendo le mosse da una breve introduzione, vedrò di sbrigarmi; e così avrò compiuto la volontà divina. Ma nient’affatto, disse quello. Non così! Ci sono qua io come ascoltatore, declama dunque con tutto lo slancio di cui sei capace, e vedrai che la forza si curerà il dio di dartela».
34 «Il salvatore Asclepio mi ordinò, fra le altre cose, di dedicarmi all’attività poetica e cano-ra, e in particolare, di svagarmi istruendo un coro di fanciulli. Quali benefiche conseguenze ebbe questo consiglio, sul mio morale, tra l’altro, e sulla mia resistenza, sarebbe troppo lungo a dirsi. Cantavano dunque i fanciulli; e tutte le volte che mi accadeva di sentirmi mancare il respiro per una improvvisa tensione al collo, o per gravi disturbi allo stomaco, o di subire un qualsiasi altro insostenibile attacco, il medico Teodoto, che era lì presente, e memore dei sogni, ordinava ai fanciulli di intonare uno dei miei canti; e mentre essi cantavano, avvertivo un senso latente di sollievo, talvolta addirittura la scomparsa totale di ogni sofferenza».
Asclepio.indd 85 30/09/2008 15.11.01
86 Valentina Calì
Aristide, Oratio 47, 30:35
ajlouçiva hJmerw'n e{x. deutevra/ ejdovkoun ejn tw'/ iJerw'/ ei\nai tou' ∆Açklhpiou' o[rqrion eujqu;ç ejx oJdou' poqe;n h{kwn, kai; caivrein wJç tacevwç ajnewv/gnuto. ejdovkoun de; kai; tou;ç pai'daç a[/dein to; ajrcai'on a\/çma, ou| hJ ajrchv ejçti Diva to;n pavntwn u{paton klhv/zw
Aristide, Oratio 49, 4:36
kai; tou'to me;n ou{twç. ejdovkoun de; kai; dia; th'ç ∆Alexandreivaç diexiw;n didaçkalei'a paivdwn oJra'n: oiJ d∆ ajnegivgnwçkovn te kai; h\/don ta; e[ph tavde, uJphcou'nteç wJç h{diçton. Pollou;ç d∆ ejk qanavtoio ejruvçato derkomevnoio.ajçtrafeveççi puvlh/çin ejp∆ aujth'/çin bebaw'taç ∆Ai?dew..tau'ta d∆ ejçti; tw'n hJmetevrwn ejpw'n, a} prw'ta çcedo;n.ejpoihvçamen tw'/ qew'/. qaumavzein ou\n o{pwç h[dh diapefoithkovta eijç th;n Ai[gupton ei[h kai; caivrein uJperfuw'ç, o{te.dh; tugcavnoimi kateilhfw;ç aj/dovmena tajmautou'.
Aristide, Oratio 50, 42-45:37
ejdovkei ga;r a[/dein ejmo;n paia'na ejn w|/ tauvthn th;n provçrhçin ei\nai, ∆Ih; paia;n ”Hrakleç ∆Açklhpiev. kai; ou{tw dh; to;n paia'na ajpevdwka ajmfotevroiç toi'ç qeoi'ç koinovn. Kai; toivnun kai; corou;ç e[çthça dhmoçiva/ devka tou;ç çuvmpantaç, tou;ç me;n paivdwn, tou;ç de; ajndrw'n. kai; çunevbh ti toiou'ton. hJnivka to;n prw'ton h[mellon ajnavxein coro;n, h\n ejn tw'/ new'/ ÔRoufi'noç, ou| mikrw'/ provçqen ejmnhvçqhn.37ijdw;n ou\n aujto;n, eijç kalo;n h{keiç, e[fhn, eij
35 «Mi pareva poi che i fanciulli cantassero l’antico inno che comincia con le parole “Glo-ria a Zeus, il sommo fra tutti…».
36 «Questo dunque era il sogno. Poi mi sembrava anche di attraversare la città di Ales-sandria, e di vedere una scuola di bambini, i quali recitavano e cantavano con intonazione dolcissima questi versi: Molti egli ne salvò da morte certa ormai giunti alle inflessibili porte di Ade. È questa una delle mie poesie, fra le prime da me composte in onore del dio, ed ero perciò sorpreso che essa fosse già arrivata in Egitto, e felice nel constatare che i miei carmi venivano cantati».
37 «Gli sembrava di cantare un peana da me composto, contenente l’invocazione: “Evviva Peana, Eracle Asclepio”. E così offrii un peana in comune ad entrambe le divinità. Orga-nizzai inoltre delle esecuzioni corali pubbliche, dieci in tutto, sia di fanciulli che di adulti. E quando mi apprestavo ad effettuare la prima, successe questo. Nel tempio era presente quel Rufino che ho menzionato poco fa. Vedendolo Dunque gli dissi: Capiti proprio al momento giusto, se hai, beninteso, un po’ di tempo libero: sto per fare eseguire un coro in onore del dio, ed è chiaro che tu mi farai il favore di essere presente all’audizione. Ma non c’è affatto bi-
Asclepio.indd 86 30/09/2008 15.11.01
La meloterapia come strumento taumaturgico nel culto di Asclepio 87
a[ra kai; çcolhv çoi: mevllw ga;r çthvçein coro;n tw'/ qew'/, kai; dh'lon dh; o{ti ajkroavçei hJmetevran cavrin. ajll∆ oujde;n, e[fh, dei' kalei'çqaiv me uJpo; çou', ajlla; kai; prokevklhmai uJpo; tou' qeou': tekmaivrou de;, e[fh, kai; th;n w{ran, ouj gavr pw provteron thnikavde ajphvnthça, ajlla; polu; u{çteron eijwvqein foita'n. ajlla; kevklhmaiv ge, e[fh, kai; touvtwn e{neka kai; eijç th;n ajgaqh;n tuvchn, kaiv çoi çumpareçthvxomen hJmei'ç, auJto;n dh; levgwn kai; to;n Çhda'ton, o}ç h\n hJmi'n çumfoithth;ç ejn tw'/ tovte. kai; tou'to me;n peri; th;n prwvthn proçagwgh;n tou' corou' çunevbh. pavlin de; ejpi; tw'/ dekavtw/ teleçqevnti ejgw; me;n e{n ti tw'n aj/çmavtwn e[tucon pareikw;ç, dia; to; pantelw'ç aujtoçcedivwç te kai; ejk tou' rJav/çtou pepoih'çqai kai; o{çon aujtov façin, e[peiq∆ h|ken o[nar ajpaitou'n kai; tou'to, kai; ajpevdomen. peranqevntwn de; touvtwn ejdovkei crh'nai ajnaqei'nai trivpoda ajrgurou'n, a{ma me;n tw'/ qew'/ cariçthvrion, a{ma de; mnhmei'on tw'n corw'n ou}ç ejçthvçamen. kai; ejmoi; me;n pareçkeuvaçto ejlegei'on toiondi; Poihth;ç ajevqlwn te brabeu;ç aujtovç te corhgo;ç, çoi; tovd∆ e[qhken a[nax mnh'ma coroçtaçivhç.
Aristide, Oratio 50, 50:38
prw'ton me;n w[fqh to; e{doç trei'ç kefala;ç e[con kai; puri; lampovmenon kuvklw/, plh;n tw'n kefalw'n: e[peiq∆ oiJ qerapeutai; proçeiçthvkeimen, w{çper o{tan oJ paia;n a[/dhtai:
sogno del tuo invito, rispose quello, perché sono già stato invitato dal dio, come puoi arguire anche dall’ora mattutina: così presto non mi sono mai presentato, ma ho l’abitudine di venire al santuario assai più tardi. E poiché sono stato invitato per questo motivo, e per buona sorte, ti assisteremo noi, disse, riferendosi oltre che a se stesso, anche a Sedato, mio compagno di soggiorno in quel periodo. Questo accadde durante la prima esibizione del coro. Di nuovo, dopo la decima esecuzione, poiché avevo trascurato uno dei canti, composto in maniera as-solutamente improvvisata e cursoria, come cosa, diciamo così, privata, un sogno intervenne a richiedermi anche quello, ed io lo offrii. A conclusione dell’impresa pensai di dover offrire un tripode d’argento, come atto di ringraziamento al dio e al tempo stesso ricordo dei cori istituiti. Avevo approntato il seguente distico elegiaco: Un poeta che fu ad un tempo giudice e corego ti dedicò questo tripode, o signore, a ricordo dei cori istituiti…».
38 «Dapprima la statua del dio mi apparve in forma tricefala, tutta circonfusa di fuoco tranne le teste; quindi noi devoti ci disponevamo vicino ad essa, come quando si esegue il peana, ed io tra i primi».
Asclepio.indd 87 30/09/2008 15.11.01
88 Valentina Calì
Aristide, Oratio 48, 30:39
touvtw/ givgnetai th'ç aujth'ç nukto;ç o[yiç ojneivratoç h{per kajmoi;, mikra;.dev pwç parhvllatten. ejdovkei oJ me;n Filavdelfoç, toçau'ta.ga;r ou\n e[cw diamnhmoneu'çai, ejn tw'/ qeavtrw/ tw'/ iJerw'/.plh'qoç ajnqrwvpwn ei\nai leuceimonouvntwn kai; çunelhluqov twn kata; to;n qeo;n, ejn d∆ aujtoi'ç eJçtw'ta ejme; dhmhgorei'n.te kai; uJmnei'n to;n qeo;n, a[lla te dh; levgonta pantoi'a.kai; wJç paratrevyeiev mou ta;ç moivraç pollach' me;n kai; a[llh/, e[nagcoç de; o{te kai; ajyivnqion proçeurw;n proçtavxeie.piei'n o[xei dieimevnon, wJç mh; duçceravnaimi.
Volendo trarre alcune brevi considerazioni conclusive su quanto è stato detto, possiamo affermare che tutte queste testimonianze contribuiscono alla definizione di un quadro storico-religioso assai complesso nel quale l’espe-rienza musicale aveva un ruolo di rilievo accanto alle altre attività terapeu-tiche esercitate negli Asklepieia. In tali santuari, affollati da un gran numero di pellegrini bisognosi di cure, ogni aspetto dell’itinerario cultuale costituiva un momento peculiare per il raggiungimento dell’obbiettivo finale, ovvero la guarigione. Pertanto le diverse attività che componevano il rituale divenivano strumento terapeutico e taumaturgico di prim’ordine, nelle quali il paziente era protagonista e accettava in maniera incondizionata le prescrizioni da parte del dio. La musica, intesa nel senso che i greci attribuivano al termine, com-prendeva l’intero mondo del suono e cioè suono e ritmo, suono e movimento e al tempo stesso costituiva una cura per il corpo e lo spirito.
La diffusione di copie di inni documentata negli Asklepieia di diverse lo-calità del bacino del Mediterraneo riflette la volontà di uniformare il culto del dio nelle sue diverse “succursali”, circostanza che si verifica anche dalla comparazione degli ex-voto anatomici e nel ripetersi di schemi topografico-architettonici con caratteristiche analoghe in ambiti geografici distanti e diffe-renti. L’ambito di competenza del dio, proprio per il fatto di interessare una particolare e delicata sfera dell’esperienza umana dell’individuo, il manteni-mento della salute e la guarigione dalle malattie, presumeva che i pellegrini che si recavano negli Asklepieia, motivati dalle medesime aspettative, vi tro-vassero in ciascuno di essi le medesime risposte che si traducevano nei rimedi
39 «Costui (il neocoro) sognò dunque - questo è tutto ciò che riesco a ricordare - che nel sacro teatro si era raccolta per rendere onore al dio una gran folla di persone vestite di bianco, e che in piedi in mezzo a loro io tenevo concione, e inneggiavo al dio, dicendo, tra le molte altre cose, che in vari modi e circostanze egli aveva stornato da me il destino…».
Asclepio.indd 88 30/09/2008 15.11.01
La meloterapia come strumento taumaturgico nel culto di Asclepio 89
curativi più efficaci per il recupero della propria salute fisica e psichica. Ciò, indubbiamente, comportò lo sviluppo di una lunga e ben consolidata tradi-zione medico-religiosa che, per la sua eccezionale durata nel corso dei secoli, rappresenta un unicum nel panorama religioso greco-romano.
Bibliografia
Argoud 1986
Argoud 1987
Barker 2005Collin-Bouffier 1992
Croon 1967
Dodds 1965
Edelstein - Edelstein 1945
Ginouvès 1994
Graf 1993
Jouanna 1990Kee 1982
L’eau, la santé et la maladie
Nicosia 1984Nicosia 1988
Argoud G., L’utilisation médicale de l’eau en Grèce et le plan des sanc-tuaires d’Asclépios, in Archéologie et médecine, VIIe Rencontres Inter-nationales d’Archéologie et d’Historie d’Antibes, 23-25 octobre 1986, 1987, 531-536.Argoud G., Le problème de l’eau dans la Grèce antique, in Aa.Vv., L’eau et les hommes en Méditerranée, 1987.Barker A., Psicomusicologia nella Grecia antica, Napoli 2005.Collin-Bouffier S., L’eau en Sicile grecque : réalités et mythes, Univer-sité de Nanterre 1992.Croon J.H., Hot, Springs and Healing gods, in Mnemosyne 20, 1967, 225-246.Dodds E.R., Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia. Aspetti dell’espe-rienza religiosa da Marco Aurelio a Costantino, Firenze 1970 (ed. originale: Pagan and Christian in an Age of Anxiety, Cambridge 1965).Edelstein E.J. - Edelstein L., Asclepius. A Collection and Interpreta-tion of the Testimonies, voll. 1-2, Baltimore 1945 (rist. New York 1965; The Johns Hopkins University Press 1998).Ginouvès R., L’eau dans les sanctuaires médicaux, in Aa.Vv., L’eau, la santé et la maladie dans le monde grec, Actes du Colloque de Paris, 25-27 novembre 1992, in BCH suppl. XXVIII, Paris 1994., 237-243.Graf F., Bois sacrés et oracles en Asie Mineure, Aa.Vv., Le bois sa-crés, Actes du Colloque International du Centre Jean Berard e de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (V section), Naples 23-25 Novembre 1989, Collection du Centre Jean Berard, 10, Napoli, 1993, 23-29.Jouanna J., Hippocrate. De l’ancienne medicine, Paris 1990.Kee H.C., Self-Definition in the Asclepius Cult, in Meyer F. - Sand-ers P. (edd.), Jewish and Cristian Self-Definition, 3, London 1982, 118-136.Aa.Vv., L’eau, la santé et la maladie dans le monde grec, Actes du Col-loque de Paris, 25-27 novembre 1992, in BCH suppl. XXVIII, Paris 1994.S. Nicosia, Elio Aristide. Discorsi sacri, Milano 1984.Nicosia S., L’autobiografia di Elio Aristide, in Guidorizzi G. (a cura di), Il sogno in Grecia, Bari 1988, 173-189.
Asclepio.indd 89 30/09/2008 15.11.01
90 Valentina Calì
Oliver 1936
Pigeaud 1987
Sfameni Gasparro 2002
Temkin 1991
Villard 1994
West 1986
Wilamowitz 1909:
Oliver J.H., The Sarapion Monument and the Pean of Sophocles, Hes-peria 5, 1936, 91-122.Pigeaud J., Folie et cures de la folie chez le médecins de l’antiquité gréco-romaine, Paris 1987.Sfameni Gasparro G., Elio Aristide e Asclepio, un retore e il suo dio: salute del corpo e direzione spirituale, in Ead., Oracoli, Profeti, Sibille. Rivelazione e salvezza nel mondo antico, Roma 2002, 205 e ss.Temkin O., Hippocrates in a World of Pagans and Christians, Balti-more and London 1991.Villard L., Le bain dans la médecine hippocratique, in Aa.Vv. 1994b, 42-60.West M.L., The singing of hexameters: evidence from Epidauros, ZPE 63, 1986, 39-46.Wilamowitz U. von, Nordionische Steine, Berlin 1909.
Asclepio.indd 90 30/09/2008 15.11.01