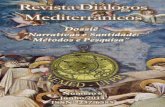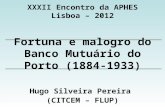II Foro di Ravenna nei primi - cento anni dell'unità d'Italia
La fortuna del tema dell'idra nei primi anni del pontificato chigiano
-
Upload
unitusdistu -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La fortuna del tema dell'idra nei primi anni del pontificato chigiano
545
et un ange qui descend du ciel avec une clef àla main, et qui tient une hydre enchainée»4.
L’opera è ancora correttamente segnalatada Lione Pascoli, come «in una stanza, ove farsi suole il concistoro, un quadro grande col-l’angelo, che schiaccia l’idra», ma già non com-pare più nella dettagliata descrizione dei palaz-zi vaticani di Agostino Taja, redatta nel 1750,dove la sala del Concistoro risulta parata diarazzi fiamminghi5.
Il possibile disegno di presentazione, indi-viduato in un foglio presso l’Art Institute diChicago, rappresenta il soggetto descritto neidettagli dal signor di Seignelay6 (Fig. 1). Lafigura predominante è quella dell’immensaidra in primo piano, tenuta in catene dall’an-gelo che ha già reciso una delle teste.
Come indica l’edizione padovana del 1618dell’Iconologia del Ripa, l’idra è uno degli attri-buti della Religione finta7, e la capacità delmostro mitologico di rigenerarsi al taglio delleteste indica, con facile trasposizione allegorica,le difficoltà incontrate dalla Chiesa di Romanell’estirpare le sempre nascenti eresie. È statoosservato come Cortona, al di là del “concet-to” suggerito dal papa, abbia potuto, per lafigura dell’idra, essere influenzato da Rubens,ossia dal dipinto, della serie medicea con laRiconciliazione, dove, tuttavia, il mostro è con-fuso nell’impasto dei colori con lo sfondo8.Ma va anche ricordato che, a sua volta, il pit-tore di Anversa aveva eseguito una copia del-l’incisione di Antonio Tempesta con Apollo ePitone, che potrebbe essere l’antecedente diret-to dell’idra cortonesca, per il modello delleteste, e per la lunga, grossa coda attorta in spi-
La fortuna del tema dell’idra nei primi anni del pontificato chigiano (1655-1662)
La fortuna del tema dell’idra nei primi anni del pontificato chigiano (1655-1662)Daniela Gallavotti Cavallero
Numerose testimonianze documentanole prime vicende della grande pala rea-lizzata da Pietro da Cortona raffigu-
rante «l’Arcangelo Gabriello in atto di custodedella S.ta Sede, che tenesse da una parte sottole braccia il regno et le chiavi, calpestasse dra-goni e serpenti; et si vedesse apparire in Para-diso la SS.ma Trinità». Nel giugno del 1655 ildipinto era già stato commissionato al pittoreda papa Alessandro VII, secondo un «concet-to proprio della S.ta S., la quale pero desideradi vederlo colorito quanto p.ma»1. Sei mesidopo, il 10 gennaio 1656, scrivendo al cardina-le Carlo de’ Medici per riferirgli del concisto-ro tenutosi la mattina, il nobile Lelio Allisegnalava come si fosse «ben visto in quellastanza un bellissimo e grande quadro di Pietroda Cortona, alto da 20 palmi, con l’AngeloCustode della Chiesa discaccia il mostro del-l’Epocalisse [sic], sopra vi è la città d’oro, e piùin alto la gloria con il Padre Eterno, attornoun cornicione intagliato et indorato»2.
Seguiva, il 3 luglio dello stesso anno, ilpagamento di cinquecento scudi, al «cavalierPietro Berettini da Cortona per prezzo di duequadri per servitio di N.S.»3.
Nel 1671 il dipinto venne visto nella collo-cazione originaria dal marchese di Seignelay,figlio del ministro Colbert, in viaggio a Romaper controllare lo stato dei lavori del monu-mento equestre berniniano a Luigi XIV: «Delà [la sala Clementina], je suis entré dans lachambre où mangent le jeudi saint les douzepauvres auxquels le pape lave les pieds. Il y asur la cheminée un grand tableau de Pierre deCortone; c’est une Gloire avec un Dieu le Père
546 Daniela Gallavotti Cavallero
Fig. 1 - Pietro da Cortona, La Trinità e un angelo che scende dal cielo tenendo un’idra incatenata, 1655, disegno, Chicago,Art Institute.
547La fortuna del tema dell’idra nei primi anni del pontificato chigiano (1655-1662)
Fig. 4 - Ciro Ferri, La Fede e la Chiesa di Roma mostrano l’immagine di Alessandro VII all’idra dell’eresia, ca. 1658, disegnopreparatorio, Roma, collezione Apolloni (da Fagiolo 2001).
Fig. 2 - Antonio Tempesta, Apollo uccide Pitone, 1600-1606, incisione.
Fig. 3 - Pietro da Cortona, Ciro Ferri, Giuseppe Testana,La Fede e la Chiesa di Roma mostrano l’immagine di Alessan-dro VII all’idra dell’eresia, 1658, incisione.
re9 (Fig. 2). Tipologia cui Tempesta fa ricorsoogni volta che deve rappresentare un drago10.
Papa Alessandro VII era salito al soglio il 7aprile 1655. Durante il pontificato Pamphilj,come segretario di stato Fabio Chigi si era tro-vato ad affrontare la questione luterana nelleterre dell’Impero11. Il monumentale dipinto,realizzato da Pietro da Cortona nei mesiimmediatamente successivi, sembra da porsiin relazione con l’impegno subito profuso dalChigi, una volta papa, contro il giansenismo,senza soluzione di continuità con le azioni diInnocenzo X, la cui ultima condanna dellecinque proposizioni era contenuta in un Bre-ve emanato il 29 settembre 1654. Per ribadireil testo del Breve, il 16 ottobre 1656 sarebbeuscita la Bolla Ad sanctam beati Petri sedem12.
Nel disegno di Chicago l’idra ha cinquegrandi teste, che possono simbolicamente rap-presentare le cinque proposizioni di Gianse-
548
nio, mentre una testa di dimensioni molto piùpiccole è posta in secondo piano, e un’altra giàspiccata è a terra, così da rispettare il numerodi sette, canonico per il mostro mitologico.Tuttavia le teste sono coronate, e potrebberoanche alludere, oltre che ai principi tedeschi,al luterano Gustavo Adolfo, re di Svezia,anche se già defunto, e ai difficili rapporti delChigi con il re di Francia all’indomani dell’e-lezione papale, il cui risultato non aveva avutoil gradimento del governo di Parigi13. Un ruo-lo di primo piano è riservato nel disegno aisimboli del papato – triregno e chiavi decussa-te – con evidente significato di tramite fra laTrinità e l’azione dell’arcangelo, che stringe asua volta in una mano una grande chiave.
Il mostro policefalo come rappresentazio-ne versatile dei nemici della chiesa di Romariappare nel frontespizio della tesi presentata il4 giugno 1658 da Carlo Saraceni14 (Figg. 3, 4).
Daniela Gallavotti Cavallero
Fig. 5 - François Spierre, La Trinità e l’angelo in atto di cac-ciare l’idra, disegno preparatorio per il frontespizio delMissale Romanum, 1662, collezione privata (da Graf 1998).
Fig. 6 - François Spierre, La Trinità e l’angelo in atto di cac-ciare l’idra, frontespizio del Missale Romanum, 1662.
Probabilmente non si tratta di una tesi univer-sitaria, ma del foglio di tesi di un avvocato elet-to al Collegio concistoriale15. La ripresa deltema del dipinto cortonesco nella sala delConcistoro, coniugata con la celebrazione dipapa Chigi, assume allora il significato di pie-na adesione alla politica papale in materia didottrina. L’incisione di Giuseppe Testana, suinvenzione di Pietro da Cortona e disegno diCiro Ferri, esprime un’allegoria complessa,per la quale è stata accennata più d’una inter-pretazione16. Sedute su una nuvola, le figuredella Fede con la croce e della Chiesa di Romacon il triregno e il modellino di Santa Mariadella Pace mostrano all’idra il medaglione conl’effigie di Alessandro VII, mentre due angio-letti scendono dal cielo con lo stemma chigia-no sormontato dai simboli del papato e unnastro con l’iscrizione ACCEDITE ET ILLU-MINAMINI17. L’esortazione è rivolta all’idra,furiosa e cieca per le bende che le serrano gliocchi, tanto da autoaddentarsi, ad eccezionedi una testa a cui una figura femminile – forsela Religione, meno probabilmente la Vergine,nonostante sia elettivamente connessa conl’immagine del serpente – ha liberato la vista.L’immagine di papa Chigi, su cui il mostro fis-sa lo sguardo quasi ipnotizzato, ha il potere diplacarne l’ira e renderlo mansueto. Se anchein questo caso le teste dell’idra stanno a signi-ficare altrettante situazioni di conflitto, insu-bordinazione o disobbedienza alla chiesa diRoma, da un lato la volontà pacificatrice delpontefice è resa esplicita dalla presenza deltemplum pacis, dall’altra la testa ammansita,che non riesce a distogliere lo sguardo dalritratto papale, sembra l’allegoria di un casodi ritorno nell’alveo del cattolicesimo roma-no, come quello che la regina Cristina diSvezia aveva compiuto nel dicembre del1654, seguito dal trasferimento a Roma unanno dopo. Conversione che il papa avevasalutato come una grande vittoria, poichéinteressava la figlia del ricordato re GustavoAdolfo. Il taccuino di provenienza Odescal-chi di cui fa parte il disegno preparatorio per
549
l’incisione è attestato come originariamenteproveniente dalle collezioni della stessa Cri-stina di Svezia18.
Per la terza volta in pochi anni l’idra ricom-pare in un disegno di François Spierre, trat-to dal prototipo cortonesco per la grandepala della sala del Concistoro, e propedeu-tico all’incisione per il frontespizio del Mis-sale Romanum edito nel 166219 (Figg. 5, 6).Spierre introduce alcune varianti, come lenumerose figure angeliche intorno alla Tri-nità. Per la necessità di inserire il riquadrocon il titolo e relative iscrizioni nel fronte-spizio a stampa la più significativa è la cesu-ra che il riquadro interpone tra gli emblemipapali, su cui non è più presente la direttailluminazione dello Spirito Santo, e l’idra,della quale sono di nuovo pienamente visi-bili solo cinque teste. Le corone dell’origi-nale sono accennate ma non più riconosci-
La fortuna del tema dell’idra nei primi anni del pontificato chigiano (1655-1662)
Fig. 7 - Niccolò Billy, La Trinità e l’angelo in atto di caccia-re l’idra, incisione dal frontespizio del Missale Romanum.
bili come tali. In luogo della spada infuoca-ta l’arcangelo stringe nella destra una saettae sotto il mostro si apre un lago di fuoco. Lapresenza così insistita del fuoco nelle manidell’angelo e sotto le zampe del mostrorichiama il modo in cui sant’Ambrogio ave-va descritto l’Idra in quanto allegoria dell’e-resia: «Haeresis enim velut quaedam hydrafabularum, vulneribus suis crevit; et dumsaepe reciditur, pullulavit igni debita incen-dioque peritura»20.
Mancando riferimenti cronologici docu-mentari sulla fase progettuale del Missale,un’indicazione ante quem è stata individuata al
550
1660, anno di morte dell’incisore Jean Baron,autore di cinque tavole incise21.
A divulgare e incrementare la fortuna delmostro policefalo contribuì anche la pedisse-qua ripresa del frontespizio nell’incisione diNiccolò Billy, con la sola variante di aver elimi-nato l’iscrizione relativa al Missale e riempito ilvuoto con l’angelo sulla porta della Gerusa-lemme celeste (Fig. 7). All’invenzione cortone-sca mediata dall’incisione farà riferimentoanni dopo il Baciccio, nel disegno per il nonrealizzato affresco dell’Immacolata, e nellenumerose altre occasioni grafiche in cui hariproposto la grande idra22.
Daniela Gallavotti Cavallero
Note1 Il soggetto e la successiva indicazione sull’invenzio-
ne papale del tema sono contenuti in una lettera del 26giugno 1655, inviata dal cardinale Giovan Carlo de’Medici al fratello Ferdinando II (pubblicata in E. Fuma-galli, Le “ambiguità” di Pietro da Cortona e la prima attivitàdi Ciro Ferri, “Paragone”, XLVIII, serie III (1997), 567, pp.34-82, in part. 48 e 79.
2 Pubblicato in Fumagalli, Le “ambiguità” cit., pp. 48e 90.
3 Il pagamento è pubblicato da L. Ozzola, L’arte allacorte di Alessandro VII, “Archivio della Società Romana diStoria Patria”, XXXI (1908), pp. 5-91, in part. 58, comeproveniente dai Libri d’entrata e d’uscita della Depositeriagenerale della rev.a Camera Apostolica presso l’Archivio diStato di Roma, senza indicazione della segnatura. Corto-na era già stato insignito del cavalierato, nel marzo dellostesso anno (ibid., p. 58).
4 L’Italie en 1671. Relation d’un voyage du Marquis de Sei-gnelay, suivie des lettres inédites [1671], ed. a cura di P. Cle-ment, Paris 1867, pp. 150-151. Il dipinto è segnalatoanche da F. Titi, Nuovo studio di pittura, scoltura, ed archi-tettura, Roma 1721, ed. comparata a cura di B. Contardie S. Romano, Firenze 1987, I, p. 235: «l’altro quadrogrande con l’Angelo che scaccia l’Idra, è bel lavoro di Pie-tro da Cortona».
5 L. Pascoli, Vite de’ pittori, scultori ed architetti moderni[1730-1736], a cura di A. Marabottini, Perugia 1992, p.50. Nel commento di Alessandro Marabottini alla Vitadi Pietro da Cortona è indicata una sintetica tracciabibliografica per le vicende del dipinto (ibid., p. 71), cuiva aggiunto A. Taja, Descrizione del Palazzo Apostolico Vati-cano, Roma 1750, p. 496.
Per la collocazione nell’aula vaticana, e non nellasala del Concistoro, e per alcune difformità nei contenu-ti, non sembrerebbero riferirsi al dipinto in questione i
versi encomiastici contenuti nel Musarum plausus Alexan-dro VII Pontefice Maximo Renunciato, Typis Vitalis Mascar-di MDCLVI, segnalati in M. Fagiolo dell’Arco, Pietro daCortona e i ‘cortoneschi’. Gimignani, Romanelli, Baldi, il Bor-gognone, Ferri, Milano 2001, pp. 69 e 77: «In tabulam pic-tam à Petro Berettino affixam iussu ALEXANDRI SEP-TIMI PONT. MAX.»: «Sub Vaticanae celsis laquearibusaulae/ Artis Apellae nobile fulget opus./ Apparet mediosupremum numen Olympo,/ Quod movet aeternoduncta supercilio,/ Illius imperio dux aliger arcta cate-nis/ Cogit ad infernos horrida monstra lacus,/ Lustrati-sque refert felicia saecula terris».
6 Matita, inchiostro grigio, acquerello grigio rialzatoa biacca, mm 450 x 355. La vicenda collezionistica deldisegno e la bibliografia ad annum sono in Great Drawingsfrom The Art Institute of Chicago: The Harold Joachim Years1958-1983, catalogo della mostra a cura di M. Tedeschi,Chicago, 24 luglio-30 settembre 1985, Chicago 1985,pp. 34-35, cat. 6 (ill).
7 C. Ripa, Iconologia, Padova 1618, ad vocem.8 D. Graf, Disegni di Pietro da Cortona e della scuola per
il Missale Romanum del 1662, in Pietro da Cortona, a curadi Ch. L. Frommel e S. Schütze, Atti del convegno,Roma-Firenze, 12-15 novembre 1997, Milano 1998, pp.201-214, in part. 205. Il quadro, del 1622-1625, è a Pari-gi, Museo del Louvre.
9 L’incisione di Tempesta fa parte della serie delleMetamorfosi, datata 1606. Numerose altre incisioni illu-strano il mito di Apollo che uccide il serpente Pitone.Idre iconograficamente prossime a quella di AntonioTempesta sono in J. W. Baur, Apollo e Pitone (incisa nel1639 per le Metamorfosi di Ovidio, stampate a Vienna nel1641) e nel disegno di Bernardo Buontalenti, su model-lo di Agostino Carracci, per una rappresentazione teatra-le del tema (Londra, Victoria & Albert Museum).
10 Ad esempio nel foglio che illustra l’episodio di Cad-mo e il drago nelle citate Metamorfosi di Ovidio, tavola 23).
11 L. von Pastor, Storia dei Papi, Roma 1932, XIV, 1,pp. 411-412.
12 Bolla di papa Alessandro VII contro i giansenisti,il 16 ottobre 1656, in Bullarium Romanum, Augustae Tau-rinorum 1869, XVI, II, pp. 245-247.
13 Von Pastor, Storia dei papi cit., pp. 366-367.14 Il frontespizio completo è in BAV, Stampe Barb.
X.1.28; misure dell’incisione mm 184 x 240. 15 Il foglio non è presente fra le tesi di studenti con
frontespizio su disegno di Pietro da Cortona elencate incalce a L. Rice, Pietro da Cortona and the Roman Baroque The-sis Print, in Pietro da Cortona cit., pp. 189-200, in part. 200.
16 H. Ost, Studien zu Pietro da Cortonas Umbau von S. Maria della Pace, “Römisches Jahrbuch für Kunst-geschichte”, XIII (1971), pp. 231-285, in part. 272-274,fig. 48, la indica come allegoria della pace, rappresentan-do il mostro la guerra; D. Gallavotti Cavallero, “Une pen-sée sublime”: Lo stemma del cardinale Pietro Ottoboni senior,invenzione del Bernini incisa da Giuseppe Testana, in Berninie la pittura, a cura di D. Gallavotti Cavallero, Roma2003, pp. 107-118, in part. 111-112, fig. 7, come l’apoteo-si di Alessandro VII di fronte all’eresia; J. M. Merz, Pietroda Cortona and Roman baroque Architecture, New Haven2008, pp. 179-180, come allegoria della conversionedegli infedeli; A. Antinori, La magnificenza e l’utile. Proget-to urbano e monarchia papale nella Roma del Seicento, Roma2008, pp. 101-102, fig. 40, come «l’allegoria del pontifi-cato di Alessandro VII che rivolge ai protestanti ancorain grado di scorgere la Verità l’invito a riavvicinarsi allaChiesa di Roma e tornare nella luce della fede cattolica».
17 Salmi, XXXIII, 6.Un possibile disegno preparatorio per l’incisione,
con l’attribuzione a Pietro da Cortona, è nel taccuinoOdescalchi all’Istituto Nazionale per la Grafica, conte-nente disegni di Pietro da Cortona e Ciro Ferri, discus-so in S. Prosperi Valenti Rodinò, scheda 10, in Pietro daCortona e il disegno, catalogo della mostra a cura di S. Pro-speri Valenti Rodinò, Roma, 30 ottobre 1997-10 feb-braio 1998, Milano 1997, p. 181, con bibliografia prece-dente. Il disegno preparatorio di Ciro Ferri è passato in
551
asta presso Sotheby’s, Londra, 18 aprile 1994, lotto 18. Èlo stesso pubblicato da M. Fagiolo dell’Arco, Pietro daCortona e i ‘cortoneschi’ cit., pp. 76, 80, n. 33 e fig. 124come appartenente alla collezione Apolloni (matitanera, pennello e biacca su carta preparata con inchiostrobruno, mm 200 x 253; scheda in “A soggetto romano”.Disegni di artisti italiani e stranieri a Roma, Apolloni, Roma1994, n. 3.
18 Il Taccuino è estensivamente discusso in Pietro daCortona e il disegno cit., pp. 17-37.
19 Missale Romanum ex decreto Sacrosanti Concilii Tri-dentini restitutum Pij V. iussu editum. Clementis VIII, et urba-ni Papae VIII auctoritate recognitum. Additis etiam MissisSanctorum ab Innocentio X et Alexandro VII. Pont. Max. ordi-natis, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apo-stolicae, M.DC.LXII. Il frontespizio è iscritto «EquesPetrus Berrettinus Corton. Pinx. – Fr. Spierre del. EtSculp.». Un esemplare del Missale (Roma, coll. privata) èstato esposto in L’Ariccia del Bernini, catalogo dellamostra a cura di M. Fagiolo Dell’Arco e F. Petrucci, Palaz-zo Chigi in Ariccia, 10 ottobre-31 dicembre 1998, Roma1998, pp. 168-171. Il disegno preparatorio dello Spierreè in collezione privata.
20 Sant’Ambrogio, De fide, 1,46.21 Graf, Disegni di Pietro da Cortona cit., pp. 203-205.22 Il disegno è a Genova, Galleria di palazzo Rosso,
Gabinetto dei Disegni, inv. 2494. Una scheda dettaglia-ta, con bibliografia precedente, è stata redatta da D.Graf, in Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio. 1639-1709,catalogo della mostra a cura di M. Fagiolo dell’Arco, D.Graf e F. Petrucci, Ariccia, 11 dicembre 1999-12 marzo2000, Milano 1999, pp. 302-303. Un foglio a Düsseldorf[Kunstmuseum Düsseldorf, Sammlung der Kunstakade-mie inv. KA (FP) 1914r] è uno studio per la sola idra; unaltro foglio, copia da Baciccio [Kunstmuseum Düssel-dorf, Sammlung der Kunstakademie inv. KA (FP) 11129]presenta il tema dell’Immacolata sotto forma di pala (p.303). L’idra è, infine, riproposta nel disegno per l’anti-porta del componimento intitolato La Santa Genuindaovero l’Innocenza difesa dall’Inganno (p. 304).
La fortuna del tema dell’idra nei primi anni del pontificato chigiano (1655-1662)