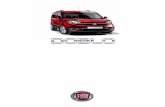La FIAT e Torino (in Santangelo-Vanolo)
Transcript of La FIAT e Torino (in Santangelo-Vanolo)
BIBLIOTECA DI TESTI E STUDI / 594
GEOGRAFIA
Serie EU-POLIS/3
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 3
I lettori che desideranoinformazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editricepossono rivolgersi direttamente a:
Carocci editore
via Sardegna 50,00187 Roma,
telefono 06 /42 81 84 17,fax 06 /42 74 79 31
Visitateci sul nostro sito Internet:http://www.carocci.it
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 4
Di capitale importanza
Immagini e trasformazioni urbane di Torino
A cura di Marco Santangelo e Alberto Vanolo
Carocci editore
C
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 5
1a edizione, luglio 2010© copyright 2010 by
Carocci editore S.p.A., Roma
Realizzazione editoriale: Fregi e Majuscole, Torino
Finito di stampare nel luglio 2010dalla Litografia Varo (Pisa)
ISBN 978-88-430-5303-2
Riproduzione vietata ai sensi di legge(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)
Senza regolare autorizzazione,è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,compresa la fotocopia, anche per uso interno
o didattico.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 6
Introduzionedi Marco Santangelo e Alberto Vanolo
1. Descrivere Torinodi Marco Santangelo
1.1. Quale città descrivere1.2. Una descrizione ignorante1.3. Da sopra1.4. In mezzo1.5. Da sotto1.6. Una descrizione complessa
Bibliografia
2. Torino e la costruzione di immagini urbanedi Alberto Vanolo
2.1. La città fordista: alcune note su un dibattito mai esaurito2.2. L’immagine della città: miti, mode e fantasie2.3. Torino come Detroit?2.4. Nuove immagini per la città2.5. Ipotesi conclusive
Bibliografia
3. La FIAT e Torino: lavoro, relazioni industriali e immagi-ni della città operaiadi Paolo Giaccaria
3.1. Torino oltre la one-company town3.2. Verso il fordismo (lento pede)
7
11
19
19202227313335
37
374043475254
57
5761
Indice
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 7
I N D I C E
8
3.3. La transizione postfordista (adagio lento)3.4. Conclusioni: l’importanza delle relazioni istituzionali
Bibliografia
4. Da capitale a nodo di reti globalidi Giuseppe Dematteis e Alessia Toldo
4.1. Introduzione: centralità territoriale e centralità di rete4.2. Da capitale politica a città industriale: le risorse del conte-
sto storico e geografico4.3. Torino capitale dell’automobile: scale e articolazioni
territoriali4.4. Torino capitale delle relazioni industriali e delle imprese
sociali4.5. Torino capitale delle Alpi4.6. Le molteplici “Torino capitale”4.7. Conclusioni: Torino dalla centralità territoriale alla
centralità di reteBibliografia
5. Vent’anni di networking urbano: la città e il lato soft delprocesso di internazionalizzazionedi Piero Bonavero e Cristiana Rossignolo
5.1. Introduzione5.2. Torino tra classifiche, immagini e scenari: una vocazione
di cerniera5.3. Torino e il saper fare networking
5.3.1. Torino e le reti di città / 5.3.2. Due casi esemplari:Eurocities e Quartiers en crise
5.4. ConclusioniBibliografia
6. La città del sociale: dalle immagini come retoriche allenon rappresentazioni come pratichedi Francesca Governa e Michele Lancione
6.1. Introduzione: problemi come immagini e immagini comepotere
666972
75
75
77
80
858789
9398
101
101
102107
114117
119
119
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 8
I N D I C E
9
6.2. Fra crescita industriale e deindustrializzazione: immagini,retoriche e mezze verità
6.3. Torino on the move6.3.1. Immagini sociali di una Torino al 2011 / 6.3.2. Leimmagini nascoste dalla nebulosa
6.4. Conclusioni: come cambia la genesi e la forza delle imma-giniBibliografia
7. La nuova questione abitativa: disagio, politiche e terri-torio urbanodi Alberta de Luca e Michele Lancione
7.1. Introduzione7.2. La questione abitativa nella Torino fordista
7.2.1. Il disagio abitativo nella Torino industriale / 7.2.2.Le politiche di prima generazione: dal Testo Unico del1938 alla conclusione del Piano decennale di edilizia resi-denziale pubblica del 1978
7.3. La nuova questione abitativa7.3.1. Crescita e complessificazione del disagio / 7.3.2. Lageografia del disagio abitativo odierno / 7.3.3. Le politicheabitative di seconda generazione: dalla seconda metàdegli anni Novanta a oggi
7.4. ConclusioniBibliografia
8. Torino e le sue periferie: immagini e politiche per la rige-nerazione della città (1993-2009)di Francesca Governa e Cristiana Rossignolo
8.1. Introduzione8.2. Periferie e rigenerazione urbana nelle politiche della città
8.2.1. Sindaci e miti: i nuovi sindaci di Torino / 8.2.2.Nuove centralità e aree dismesse: il Piano regolatoregenerale del 1995 / 8.2.3. Un progetto speciale per le peri-ferie della città / 8.2.4. La svolta competitiva delle politi-che urbane torinesi
8.3. Riflessioni conclusiveBibliografia
123127
133136
139
139140
146
157161
165
165167
177179
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 9
Introduzione1
di Marco Santangelo e Alberto Vanolo
Un problema rilevante delle città europee contemporanee – importante agliocchi di molti politici, amministratori ed esperti – è la ricerca di un ruolo, eperciò di un posizionamento (politico, economico, culturale), della città nelloscenario della globalizzazione. In questo quadro, due fondamentali strumen-ti di conoscenza e di controllo sembrano orientare le strategie urbane: da unlato la misurazione del proprio valore in rapporto ad altre realtà, secondoparametri e metodologie adottate ormai a livello internazionale (classifica-zioni, esercizi di benchmarking ecc.); dall’altro la rilevazione, tramite l’ado-zione di punti di vista ben precisi (ad es., nel contesto europeo, la strategia diLisbona e Göteborg), delle principali opportunità di competizione dellacittà stessa nel contesto regionale, nazionale e globale. Si tratta di due stru-menti molto simili nell’approccio (prevalentemente liberista) e negli intenti(dimostrare quanto e perché si vale) che si differenziano soprattutto per unpiù o meno marcato uso della comparazione con città simbolo o esemplaridella tipologia urbana che si intende emulare: esempi ricorrenti sono Bilbaoper la cultura, Amsterdam per la creatività, Monaco per la direzionalitàeconomica, le città scandinave per il connubio fra società della conoscenza ewelfare state.
Tuttavia, occorre notare come l’impulso conoscitivo alla base del proces-so comparativo sia generalmente il risultato di logiche solo in parte esplici-tate e messe in discussione; più sovente, le premesse metodologiche, teorichee politiche (nella forma dell’“inconscio politico” di Jameson, 1981) alla basedell’analisi tendono a inquadrare i problemi in una maniera spesso conven-zionale, tesa a suggerire essa stessa soluzioni più o meno consolidate (Bucket al., 2005, parlano a questo proposito di new conventional wisdom). Adesempio, una prima logica intende la globalizzazione come una spinta a unaforma estrema di competizione urbana, da cui dipenderebbe la ricerca dicompetitività come fine ultimo dell’azione intrapresa: una politica urbana ètanto più utile ed efficace quanto in grado di aumentare il livello di competi-
11
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 11
tività della città, misurato e valutato ad esempio attraverso parametri econo-mici quali la capacità di attirare investimenti. Viene spesso implicitamente oesplicitamente applicata una prospettiva di autovalutazione ricorsiva e auto-sufficiente: tornando all’esempio precedente, analizzare la carenza dicompetitività nei termini di una presunta debolezza sul fronte degli investi-menti non può che suggerire (pre)determinate linee di azione e processi diripensamento delle strategie di trasformazione della città sempre entro i limi-ti della crescita economica (che, a sua volta, è regolata da meccanismi chepossono avere poco o niente a che vedere con la dimensione concreta e fisi-ca della città).
Infine, ne deriva una sorta di organizzazione logica delle azioni e deiprocessi in atto nelle città nella forma di insiemi definiti di strategie di trasfor-mazione: è il fatto stesso di considerare le azioni come categorie unitarie (poli-tiche di competitività, politiche di riqualificazione, processi di elaborazionedi un piano strategico) a dare senso a ciò che si fa, con il pericolo di prescin-dere dalla coerenza delle azioni tra loro e del loro rapporto con il contestourbano. Il discorso sulla competitività diventa così un “meccanismo di disci-plinamento” quasi normativo, ossia un modo di organizzare il discorso sullosviluppo urbano che contiene e riproduce dall’interno determinate visionidella città, e in questo senso riproduce specifiche strutture di potere: le stra-tegie di sviluppo urbano sono spesso costruite come scelte “tecniche” primaancora che politiche, solitamente a vantaggio di ristrette élite economicheurbane.
Da un punto di vista metodologico, simili logiche riproducono quindiuna visione riduttiva delle argomentazioni che ispirano, poiché assumono unaprospettiva specifica (di mercato) da cui osservare la realtà, in modo da inter-pretare e spiegare la città in maniera coerente con il punto di vista adottato. Inaltre parole, esistono molti fatti sociali e ambientali che semplicemente nonpossono essere spiegati (né tanto meno governati) con le logiche dell’econo-mia e della competitività, ma che imprimono importanti direzioni nellosviluppo di una città.
Simili critiche valgono certamente anche per l’analisi geografica, ovveroil punto di vista dei contributi di questo volume, tanto più che la geografia, perla sua natura di scienza connettiva, si è essa stessa declinata settorialmente ingeografia economica, sociale, politica ecc. Esistono però logiche propria-mente geografiche che possono stimolare un dibattito differente sullo statodella città. Si tratta di logiche relative al rapporto che il territorio, inteso comespazio geografico, ha con differenti spazi di connessione, interazione, eserci-zio delle funzioni e del potere.
L’idea di indagare la dimensione fisica della città, considerata comedimensione complessa che vede un’interazione reciproca tra spazio e società
D I C A P I T A L E I M P O R T A N Z A
12
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 12
I N T R O D U Z I O N E
13
nel tempo, diventa costitutiva di una visione non semplificata della realtà percui, banalmente, un processo conoscitivo volto a riconoscere le caratteristichecompetitive di una città – posto che ci interessi sapere solo questo – prevedeun’analisi territoriale che riconsidera e verifica saperi che vengono general-mente intesi come dati e immutabili nel lungo e nel medio periodo (ad es. lecaratteristiche geomorfologiche, le logiche insediative, le caratteristichemicroclimatiche ecc.). Allo stesso modo, l’approccio geografico non può limi-tarsi alla ricognizione delle condizioni che caratterizzano un territorio e lodifferenziano da un altro, ma necessariamente mette in relazione questo terri-torio con altri e con altre scale. Un simile approccio mette quindi in discus-sione le logiche conoscitive citate in precedenza perché non si propone difornire soluzioni, non fornisce risposte note in partenza, non assume un obiet-tivo di fondo (ad es. diventare “competitivi come Londra”).
Una simile prospettiva di decostruzione non rappresenta certo una novitàmetodologica in seno alle scienze sociali: per chi si è dilettato con il “vecchio”dibattito sul postmodernismo, affermare che non esistano più grandi teorie emetanarrative non costituirà certamente sorpresa. Per chi invece è menoavvezzo a queste espressioni altisonanti, basti considerare come, nel dibatti-to sulla filosofia della scienza, molto inchiostro è stato speso negli ultimidecenni per criticare ogni interpretazione dei fenomeni sociali eccessiva-mente lineare, semplicistica e universale. In altre parole, in una società semprepiù complessa (o “liquida”, per usare la celebre espressione di Bauman,2000), dove i confini fra classi sociali, generi, etnie, religioni, culture (e percerti versi anche fra spazi geografici) divengono di fatto sempre più sfumati edifficili da inquadrare, ogni teoria generale comincia a mostrare il fianco.Tanto per citare un esempio, è veramente arduo immaginare nelle città occi-dentali una rigida contrapposizione fra le tradizionali categorie dei “borghe-si” e dei “proletari”: le differenze nella ricchezza esistono, forse più di prima,ma la teoria sociale che tradizionalmente le spiegava pare oggi vacillare nelformulare spiegazioni2.
Gli studi urbani non fanno eccezione. Tradizionalmente, la geografia el’urbanistica hanno presentato veri e propri “modelli” astratti, spesso basatisull’osservazione di poche realtà (Chicago in primis, vera e propria culladegli studi urbani all’inizio del secolo scorso), in grado di suggerire idee di“certezza” nell’interpretare le trasformazioni delle nostre città. Così, fino auna manciata di decenni fa, sarebbe stato plausibile analizzare Torino para-gonandola a un organismo che si espande o si contrae nello spazio, o ipotiz-zare centri concentrici legati a differenti andamenti del mercato immobiliare3,o ancora immaginare la capitale subalpina in qualche punto di una ipoteticaevoluzione da città industriale, a città fordista, a città postfordista. Ma, con lacrisi del fordismo (a Torino si pensi al momento simbolico della marcia dei
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 13
40.000, nel 1980), oltre a problemi ben più seri di natura sociale ed economi-ca, cominciano a diventare palesi i problemi di natura interpretativa: che cos’èuna città postfordista? Quali differenti traiettorie evolutive può intraprende-re una città fortemente legata all’industria, elemento urbano oggi spessoconsiderato implicitamente “vecchio”, spesso in favore di nuove parole chia-ve – e insieme opache – di portata globale come “cultura”, “servizi”, “turi-smo”, “creatività”?
La risposta, in senso scientifico, non esiste, poiché il mondo della geogra-fia è troppo vario per essere ricondotto a semplici modelli o ipotesi applica-bili ovunque. La traiettoria evolutiva di Glasgow potrà essere molto differen-te da quella di Genova o di Stoccarda, in quanto non vi è nulla di “spontaneo”o di “naturale” nello sviluppo della città: si tratta di processi sociali costruitidalle persone, dagli abitanti, dalle élite politiche, dalle lobby industriali,dalle ideologie dominanti, e dal modo in cui queste forze dialogano fra loronegoziando il “diritto alla città”4.
Alla luce di queste considerazioni generali, la scelta di una metodologiae di un percorso di ricerca per condurre un’indagine sulle trasformazioni inatto a Torino rappresenta un nodo di difficile soluzione. La nostra scelta,tutt’altro che originale5, è di provare a sfidare alcune “narrazioni consolida-te” che riguardano Torino. Come ha magistralmente discusso Rob Shields(1991), la costruzione e l’organizzazione del sapere geografico passano spessoattraverso la costruzione di slogan e stereotipi: dinanzi all’impossibilità diuna conoscenza esaustiva dei fenomeni e al contempo alla necessità di orga-nizzare in qualche maniera una “mappa del mondo”, le città tendono a ridur-si a poche affermazioni o immagini stereotipate, sia nel caso della visionedella città da parte degli abitanti, sia soprattutto da parte di soggetti esterni.Nel caso di Torino, è intuitivo come gran parte delle narrazioni legate aquesto luogo si articolino a partire dai temi della città industriale: nell’ultimosecolo, Torino è stata innanzitutto agli occhi di molti la “capitale” italianadell’automobile, con tutte le conseguenze positive e negative che ne deriva-no, e i recenti accordi fra FIAT e Chrysler non hanno fatto che ribadire lacentralità di questo volto di Torino agli occhi del mondo (e degli stessiabitanti). Ma esistono molte altre immagini comuni della città, legate ai piùdisparati temi, come il calcio (la città della Juventus), la spiritualità cristiana(un certo numero di santi, la Sindone), la tradizione marxista (Gramsci, lelotte operaie), la città della sinistra liberale di Gobetti e Bobbio, la città olim-pica. Come tutte le storie, queste narrazioni su Torino non sono mai comple-tamente vere, né completamente false: sono discorsi costruiti da persone,destinati a una certa audience, che incorporano semplificazioni e stereotipi.Per un tifoso del Chelsea, Torino è la città della Juventus, mentre per unpellegrino in visita alla Sindone la narrazione dominante sarà necessaria-
D I C A P I T A L E I M P O R T A N Z A
14
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 14
I N T R O D U Z I O N E
15
mente diversa. Sarebbe impossibile trovare una singola narrazione che costi-tuisca uno specchio neutrale della città: i discorsi stessi, con il loro linguag-gio, con la scelta di cosa includere e cosa escludere, con l’“inconscio politi-co” di chi scrive, creano e producono una loro realtà.
Nella prospettiva di questo libro, si è scelto quindi di sfidare alcune delletradizionali immagini di Torino, non tanto per valutare quanto siano “vere”,quanto per discutere, semmai, come si siano evolute dinanzi alle dinamichedella città degli ultimi anni, come siano state interpretate dal dibattito scien-tifico, quali conseguenze portino con sé nello scenario della globalizzazionecon i suoi cambiamenti strutturali non solo nel mercato, ma nella società enella quotidianità. Naturalmente, la scelta di queste “storie”, ossia la ridu-zione di un complesso insieme urbano a otto capitoli, è necessariamentepassata attraverso una selezione di cosa includere e cosa escludere, di qualiargomenti affrontare e di quali lasciare sullo sfondo. Inoltre, queste analisinon pretendono in alcun modo l’universalità di questo caso studio: Torinonon è necessariamente il “modello” della città postfordista cui altri centripotranno tendere, poiché proporre una simile linea di ragionamento presup-porrebbe dare per scontato che Torino sia riducibile alla semplice etichettadi “città postfordista”. Il percorso che si sviluppa nei capitoli seguenti ripor-ta a una questione fondamentale per la (le) città, ovvero quali logiche defini-scano o debbano definire le proprie dinamiche di sviluppo. Quali sono infat-ti le scelte di fondo per una rielaborazione delle strategie di trasformazionedella città che siano coerenti con il senso del luogo? Si tratta di logiche, e discelte, che non si possono nascondere né rinviare a lungo, pena l’adesione,peraltro confusa, a modelli ormai largamente confutati di competizioneurbana.
Inoltre, reputiamo l’esperienza di Torino interessante perché molte dellenarrazioni analizzate possono offrire punti di contatto, analogie e utili compa-razioni con altre città che condividono, anche se parzialmente, alcuni tratti.L’esercizio intrapreso è stato quello di provare a ragionare su una città percapire come leggere una realtà specifica in relazione a un contesto molto piùampio, senza peraltro ridurre la città alle sue dipendenze dal contesto stesso:Torino è una città inserita nelle dinamiche di sviluppo europee e mondiali,oltre che regionali e nazionali, ma non può essere considerata solo in relazio-ne al suo ruolo in questi contesti, poiché ha specificità proprie che medianocon le dinamiche citate per definire un modello di sviluppo “locale”. L’anali-si effettuata è, quindi, organizzata per “segmenti” operativi e tematici (i capi-toli) non esaustivi della realtà torinese. A partire dalle specificità del luogo, eriprendendo una tradizione di studi di caso, si ha però l’ambizione di raccon-tare e descrivere un luogo per arricchire un panorama più ampio di ricerche,riflessioni e argomentazioni.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 15
IIll vvoolluummee èè ddiivviissoo iinn ttrree ppaarrttii,, ooggnnuunnaa ddaa iinntteennddeerrssii ccoommee uuttiillee aallllaa rriifflleess--ssiioonnee ssuullllee nnaarrrraattiivvee ttoorriinneessii ccoommuunnii aa cchhii hhaa ssttuuddiiaattoo oo vviissssuuttoo qquueessttaa cciittttàà..
Nella pprriimmaa ppaarrttee si guarda alle trasformazioni della città industriale,ovvero a come è cambiata, se così è, l’anima più tradizionalmente fordistadella città. Il CAP. 1 affronta il problema di definire quale città descrivere se sivuole raccontare Torino. Le difficoltà principali in questa operazione nonsono tanto quelle di narrare i cambiamenti della città fordista, quanto di rico-noscere un oggetto urbano torinese sufficientemente specifico da consentir-ne una descrizione. Nel CAP. 2 ci si interroga circa l’immagine di Torino comecittà prima fordista e poi postfordista, introducendo il lettore ai limiti diquesta distinzione dicotomica; nel CAP. 3 si discute il legame concreto conl’impresa centrale di Torino, la FIAT, e la forza del rapporto tra queste duerealtà.
La sseeccoonnddaa ppaarrttee si occupa del rapporto di Torino con il suo passato dicapitale e prova a interrogarsi sul senso di primacy che il ruolo di capitale(politica, ma non solo) porta: nel CAP. 4 si ragiona quindi non solo sul ruolodella città come capitale dell’Unità d’Italia fino al 1863, ma anche del suo ruolodi capitale dell’automobile, della televisione italiana, del marketing e di deci-ne di altri primati più o meno noti ai torinesi stessi. Il ruolo di capitale deveinoltre essere considerato anche nella sua accezione più moderna e reale,ovvero di centro egemone di un territorio più o meno vasto, più o meno isti-tuzionalizzato, più o meno condiviso con altri centri. In questo senso, il CAP. 5si interroga sul rapporto che si è instaurato nel tempo tra Torino e altre città,rapporto reticolare che non sembra però poter fare a meno dello spazio,della materialità e delle caratteristiche del territorio del quale Torino è anco-ra, in qualche modo, capitale.
La terza parte del volume affronta un’altra immagine fortemente conso-lidata: l’immaginario della Torino sociale, della città dei santi, dei preti operai,dei sistemi organizzati di assistenza (e resistenza) che si pone alla base delterzo settore e negli interstizi e lacune del sistema del welfare. Si tratta di unaquestione teorica che si apre a una moltitudine di prospettive: infatti, se ilCAP. 6 rilegge questo tema come rapporto tra marginalità e coesione nella cittàcontemporanea, i CAPP. 7 e 8 affrontano due temi – le politiche abitative e iprocessi di rigenerazione urbana – che riconfigurano l’immagine della cittàsociale a partire dall’azione dell’attore pubblico. La Torino sociale quindi nonè solo la città nella quale l’operare di uomini e associazioni definisce unrapporto particolare tra disagio e opportunità, tra bisogno e cura, ma è anche– e ancora una volta – la città laboratorio nella quale l’attore pubblicopromuove politiche urbane con un forte contenuto sociale.
#da recuperare#
D I C A P I T A L E I M P O R T A N Z A
16
#no
n e
ssen
do
pro
pri
amen
te d
ivis
o in
3 p
arti
,sa
reb
be
meg
lio in
dic
are
qu
ali c
apit
oli
trat
tan
od
eter
min
ati a
rgo
men
ti#
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 16
I N T R O D U Z I O N E
17
Note
1.@Nel 2005 EU-POLIS (centro di studi del Dipartimento Interateneo Territorio del Politec-nico e dell’Università di Torino) e SiTI (Istituto superiore sui sistemi territoriali per l’innova-zione) hanno siglato una convenzione triennale finalizzata alla realizzazione di un’attività diricerca sui temi della competitività e della coesione dei sistemi territoriali di Torino e delPiemonte, svoltasi negli anni successivi sotto la direzione di Giuseppe Dematteis e Carlo Salo-ne. La convenzione, cofinanziata dalla Compagnia di San Paolo, è stata promossa perapprofondire la conoscenza della situazione torinese e piemontese rispetto ai trend in atto nelcontinente europeo.
2.@Nel caso dell’esempio qui illustrato, i modelli di stampo marxista sono stati quindiriproposti in nuove formulazioni, come nel celebre lavoro di Hardt e Negri (2000) dove ilconcetto di proletariato è sostituito dall’idea, assai più postmoderna, di “moltitudine”.
3.@Il riferimento è a due celebri filoni di studi urbani: la metafora della città come organi-smo e il modello a centri concentrici elaborato da Burgess, Park e McKenzie negli anni Venti.
4.@Riguardo all’idea di un diritto (spesso poco discusso) “alla città”, ossia alla negoziazio-ne delle forme e delle pratiche del costruire e vivere l’urbano, si veda, oltre al testo fondamen-tale di Lefebvre (1968), il più recente Harvey (2008).
5.@Per citare due illustrissimi precedenti, si tratta sostanzialmente dell’approccio propo-sto da Soja (2000) e da Bridge, Watson (2003).
Bibliografia
BAUMAN Z. (2000), Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge (trad. it. Modernitàliquida, Laterza, Roma-Bari 2002).
BRIDGE G., WATSON S. (2003), City Differences, in G. Bridge, S. Watson (eds.), ACompanion to the City, Blackwell, London, pp. 251-60.
BUCK N., GORDON I., HARDING A., TUROK I. (eds.) (2005), Changing Cities. RethinkingUrban Competitiveness, Cohesion and Governance, Palgrave Macmillian,Basingstoke.
HARDT M., NEGRI A. (2000), Empire, Harvard University Press, London (trad. it.Impero, Rizzoli, Milano 2002).
HARVEY D. (2008), The Right to the City, in “New Left Review”, 53, September-Octo-ber, pp. 23-40.
JAMESON F. (1981), The Political Unconscious: Narrative as a Socially Simbolic Act,Cornell University Press, Ithaca (NY).
LEFEBVRE H. (1968), Le droit à la ville, Anthropos, Paris.SHIELDS R. (1991), Places on the Margin. Alternative Geographies of Modernity, Rout-
ledge, London.SOJA E. W. (2000), Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, Blackwell,
Oxford (trad. it. Dopo la metropoli. Per una critica della geografia urbana eregionale, Patron, Bologna 2007).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 17
1Descrivere Torino
di Marco Santangelo
1.1Quale città descrivere
Descrivere una città, Torino, Toronto o Taipei, può essere un esercizio moltostimolante e interessante, soprattutto perché la descrizione può essere fatta intanti modi quanti sono gli obiettivi che ci prefiggiamo. È possibile descrivereper far capire come è fatta la città, scrivere di alcuni fenomeni specifici,raccontare gli sviluppi degli ultimi trent’anni o immaginare i prossimi trenta.In ogni caso è possibile dare per scontato che, se si parla di una città, questasia almeno in parte corrispondente a un modello idealtipico: se si tratta diuna città europea avrà un centro storico, dei quartieri periferici, un’areametropolitana estesa, forse delle città satelliti, un patrimonio monumentale eartistico di un certo pregio, delle aree verdi e così via. Questa città avrà uncerto tipo di popolazione (sempre più anziana e con un numero crescente diimmigrati), un certo tipo di economia (ad es. genericamente postfordista ocreativa), un certo tipo di approccio allo sviluppo (ad es. orientato alla compe-tizione tra città o alla cooperazione in ambito comunitario; cfr. CAP. 5).
Se si tiene conto delle diverse condizioni presenti nelle città è quindipossibile pensare di descriverle e di fare un lavoro sufficientemente approfon-dito. A maggior ragione, se si volessero affrontare aspetti specifici – econo-mici, sociali, politici, ambientali ecc. – si potrebbe pensare di fare una descri-zione per quanto possibile precisa, puntuale e completa.
C’è però un problema oggettivo che, se sottovalutato, rende molto piùcomplicata e difficile l’operazione di racconto di una città: esiste infatti unproblema di individuazione dei limiti della città, ovvero di cosa sta dentro ecosa sta fuori dalla descrizione.
Se ci si occupa di Torino e si pensa di descriverla tenendo conto dei suoiconfini – se non altro per provare poi a fare un elenco di ciò che avvienedentro quei confini ed eventualmente decidere cosa raccontare e cosa no – cisi ritrova con diverse opzioni, tutte discutibili: considerare solo la città corri-spondente al Comune di Torino (operazione oramai impossibile, pena lasottovalutazione di troppi fenomeni); considerare l’area metropolitana
19
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 19
20
M A R C O S A N T A N G E L O
(operazione ancora impossibile, perché non esiste una definizione condivisadi quale sia l’area metropolitana torinese); considerare l’urbanizzato compat-to e diffuso, ovvero l’estensione fisica dell’edificato anche quando diventameno denso (però fino a che punto?).
Inoltre, ognuna delle possibilità sopra ipotizzate comporterebbe unapproccio specifico alla descrizione, con esiti differenti man mano che da unascala definita da un limite amministrativo ci si avvicina a una scala metropoli-tana diffusa. Alcuni fenomeni possono ad esempio essere misurati alla scalacomunale, ed è ovviamente possibile sommare i dati di tutti i comuni che siritiene di considerare per avere un quadro completo di un fenomeno o di unadinamica. Se vengono però a mancare i limiti della città, come posso anchesolo immaginare di sapere quanti abitanti considerare? Quale dimensionefisica? Quali caratteristiche socioeconomiche?
A rendere le cose un po’ più facili basterebbe ammettere che una cittàcontemporanea si trova sempre nella condizione di avere un urbanizzato inparte compatto e denso e in parte diffuso e sparso, di non avere limiti precisie spesso di non avere confini amministrativi che ricalchino almeno in partequesta sua forma. Torino è certamente in queste condizioni. In queste condi-zioni, però, che tipo di descrizione utilizzare? Come raccontare al meglio ilfenomeno urbano torinese?
1.2Una descrizione ignorante
In questo capitolo si propone una maniera possibile di descrivere una città,ovvero di farlo a partire dall’osservazione soggettiva – da parte dell’autore –di quanto avviene. Si tratta di una scelta soggettiva che sacrifica possibiliapprofondimenti a favore della possibilità di intuire un’immagine di sintesi diquesta città senza confini, e che non fa riferimento esplicito a teorie, metodi efiloni di ricerca noti.
È una descrizione quindi “ignorante”, nella quale l’ignorato è voluta-mente tale, perché è tesa a descrivere, raccontare, una città attraverso l’osser-vazione personale di quanto è successo e succede nella città stessa. Non ci saràquindi un approccio attento alle dinamiche sociali per questa descrizione, néun approccio legato ai processi di rigenerazione di parti del territorio. Non sicomincerà a descrivere il territorio periurbano per distinguerlo da quellocompatto, né si racconteranno le possibili trasformazioni per immaginare ildestino della città e dei suoi abitanti. Non si concentrerà l’attenzione su quan-to le dinamiche economiche abbiano mutato e rimutato vaste parti del terri-torio, e neanche si muoverà dalle percezioni di gruppi o di singoli per defini-re un nuovo contesto locale di azione e reazione.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 20
La descrizione ignorante sarà solo una descrizione, da parte dell’autore,di quanto gli è possibile capire della città osservandone alcuni aspetti, alcunifenomeni e alcune parti, senza pretese di esaustività che sguardi attenti emeglio focalizzati potrebbero aspettarsi. Una descrizione di elementi mate-riali, così come si presentano davanti agli occhi, e di elementi immateriali, cosìcome percepiti dall’autore in base a ciò che si è letto, si è sentito e si è osser-vato in precedenza. È una descrizione che pretende di essere ignorante,perché fondata comunque su un osservatore che ha una formazione, delleidee e delle esperienze (e che ha, tra i suoi riferimenti, la figura del flaneur);una descrizione che, per quanto possibile, cerca in parte di essere informe eopaca per poter dare poi modo ad altri di rifinire, sbozzare e intuire.
Quale è il senso di questa operazione? Per rispondere a questa domandaoccorre ricordare che questo capitolo riguarda Torino, la città e il suo terri-torio, ma che in qualche modo, come in tutto il libro del resto, Torino può edeve essere intesa come archetipo, o stereotipo, di una città italiana o europeadi dimensioni e caratteristiche vagamente simili. Una città che ha una lungastoria alle spalle e che negli ultimi due secoli ha corso per adeguarsi alla velo-cità dei mutamenti delle società, dell’economia, della tecnologia, della scien-za e della storia stessa. Una città che è stata studiata, analizzata, interpretata eche ha tratto grande giovamento da questo interesse ma che oggi, in un perio-do di rinnovato mutamento della velocità delle trasformazioni sopra citate,sembra essere in difficoltà perché le diverse analisi sembrano non avere piùun “terreno” comune di riflessione, di scambio, di fertilizzazione. Nei capitolidi questo volume si affrontano infatti le trasformazioni della città da molte-plici, e specifici, punti di vista, ma proprio per scelta dei diversi autori non siha un approccio unitario alla descrizione. Non si può raccontare una città, ilsuo cambiamento, scrivendo tutto insieme e nello stesso tempo, a meno che– forse – non si tenti un approccio ignorante che eviti appositamente didenunciare riferimenti specifici e di esplicitare i propri punti di vista e dipartenza e scelga invece di cominciare da una descrizione sregolata di quan-to si può e si sa osservare1.
Rimane da affrontare il problema del modo con il quale sviluppare unadescrizione ignorante. Il modo dipende molto dall’oggetto della descrizionestessa, non può darsi un modo generale cui far discendere un modo partico-lare. Torino ha delle caratteristiche peculiari, pur nella sua ordinaria appar-tenenza all’insieme delle città medio-grandi (o medio-piccole) europee, equeste caratteristiche informano la possibilità di una sua descrizione, perquanto ignorante. È una città di fondazione romana, e quindi dovrebbe porsiil problema di individuare il suo castro originario, il suo cardo e il suo decu-mano, le eventuali eredità della centuriazione romana nel parcellare agrario enelle trame viarie e così via. È anche una città che sonnecchia per molti seco-
21
1 . D E S C R I V E R E T O R I N O
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 21
22
M A R C O S A N T A N G E L O
li e si risveglia capitale di un ducato e poi regno, che si espande per volontà emodello regio praticamente fino al tardo Ottocento. È infine la città che vienedi necessità travolta dall’industrializzazione pre e postbellica e che solo moltodi recente ha ricominciato a riscoprire le tracce tutt’altro che residuali delsuo passato. Anche se forse oggi fa un po’ di fatica a capire cosa essere per iprossimi decenni. In questo si traccia un percorso molto simile, come si dice-va sopra, a quello di molte altre città europee.
La descrizione di Torino in questo capitolo ha però bisogno di slegarsida queste modalità, non perché non valide, ma perché il senso di un’ulterioredescrizione della città è nel tentativo di raccontare un insieme senza peròperdere la sua specifica unitarietà e le complicazioni che essa comporta: lacittà delle periferie è contigua e a volte sovrapposta a quella del centro; la cittàdell’industria e quella delle produzioni tipiche comunque convivono; la cittàdelle strategie di sviluppo e quella delle trasformazioni sociali silenti o nonregistrate sono la stessa cosa, sono lo stesso luogo. Eppure, per trovare unfilo conduttore in quello che potrebbe rivelarsi solo come un elenco dielementi con l’unico comune denominatore costituito dalla compresenzageografica, si è scelto di tripartire lo sguardo, di scegliere tre punti di vistaper osservare la città. I tre punti di vista, per facilitare il lavoro al descrittoreignorante, sono punti di vista fisici, materiali: si descriverà Torino guardan-dola da sopra, dal cielo, un po’ dallo spazio e un po’ a volo di uccello; la siosserverà poi da “in mezzo”, dalle sue strade, dai suoi corsi e dalle sue vie; lasi guarderà e in parte immaginerà infine da sotto, dalle sue viscere passate,presenti e future.
1.3Da sopra
Vista da sopra, ad esempio attraverso Google Earth, Torino è una città chepresenta subito due caratteristiche evidenti – la sua posizione geografica e lasua forma – che possono essere descritte in maniera più esaustiva.
In primo luogo, Google Earth non ci farà vedere i confini amministrativi,per cui vedremo un’area edificata posta grossomodo al centro di un emiciclodi vette innevate. Si potrebbe anche dire che Torino si trovi in un cul-de-sacgeografico, al fondo di una pianura, delimitata da due catene montuose, chesi trova a sua volta al fondo di un braccio poco profondo del Mar Mediterra-neo. Sarebbe una posizione poco felice, o meno felice di altre, se il cul-de-sacnon distasse pochi chilometri, nel suo punto più stretto, da un altro mare delMediterraneo (il Tirreno) pur non godendo di molti dei privilegi di una taleposizione, perché l’Arco alpino proprio in Piemonte è mediamente più alto easpro e l’Appennino, in questa sua prima parte, riesce a comportarsi da muro
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 22
di recinzione. Torino si trova quindi al centro di questa splendida (nelle bellegiornate) conca alpino-appenninica, apparentemente isolata se si guarda allasua posizione nel contesto italiano, a un passo dalla Francia e in posizionemediamente centrale se si guarda al contesto europeo. A movimentare questaconca sono le colline (di Torino, del Monferrato, delle Langhe, del Roero) cherompono la monotonia del paesaggio della pianura e serrano ancora di più ilterritorio piemontese tra le montagne, le colline e la pianura piatta che guar-da a est. Torino, fra l’altro, sorge sull’unica strettoia che ci sia nella PianuraPadana, poiché si trova su un’ampia deiezione di sedimenti alluvionali chedalle montagne arriva fino alle colline, serrando di fatto il passaggio da sud anord della Pianura Padana.
Che cosa può dirci questa particolare conformazione del territoriopiemontese? Che cosa può dirci la posizione di Torino al centro di questoterritorio?
In primo luogo, la posizione di Torino al centro di un cul-de-sac sembre-rebbe a prima vista non invidiabile, soprattutto se consideriamo un approc-cio italo-centrico al problema (cfr. CAP. 4). Torino condividerebbe con Paler-mo, Cagliari e Trieste, ad esempio, il problema di essere periferica rispetto aun ipotetico centro del paese. Con Trieste condividerebbe anche il problemadi essere marginale perché vicina ai confini2. Se però consideriamo l’Europanel suo insieme (e tralasciamo l’ipotesi che Torino possa essere marginalerispetto al bacino mediterraneo), Torino (come Trieste) non solo non è peri-ferica perché vicinissima al core geografico, economico e politico europeo, manon è assolutamente marginale perché necessaria al collegamento tra il Norditaliano e il resto d’Europa, ben più di quanto il dibattito sul collegamento adalta velocità con Lione possa dimostrare. In questo dibattito spinoso, come inaltri però, è abbastanza evidente come le scelte della città (in senso ampio,quindi anche le scelte condizionate da altri attori che la rappresentano a gran-de scala, come la Provincia o la Regione) non siano guidate dalla consapevo-lezza di un ruolo pienamente europeo in termini di riorganizzazione dellospazio comunitario. Le scelte relative all’alta velocità possono infatti risulta-re in realizzazioni che minimizzino l’impatto e le conseguenze del passaggiodi una simile infrastruttura o valorizzino al massimo questa opportunità perrafforzare i propri legami transalpini (valgono naturalmente anche l’opzionezero, di non esecuzione dell’opera, o l’opzione catastrofica – da molti paven-tata – di assoluta inutilità), ma sembra mancare l’inserimento di questo temaall’interno di un più ampio ripensamento delle forme future dell’organizza-zione territoriale.
Questo esempio è utile per osservare proprio come la posizione geografi-ca della città sia talvolta poco presa in considerazione per immaginarne il futu-ro o per descriverne le potenziali trasformazioni. Non sembra infatti possibi-
23
1 . D E S C R I V E R E T O R I N O
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 23
24
M A R C O S A N T A N G E L O
le immaginare un futuro di Torino, in un contesto alquanto consolidato comequello comunitario, se non come quello di una città esplicitamente rivolta aovest e a nord, non per fuggire dall’Italia, ma per consolidare rapporti tran-sfrontalieri per poi ripensarli come rapporti macroregionali.
Due suggestioni dal dibattito politico e scientifico attuale si intersecanocon quanto osservato finora: da un lato la proposta di rafforzare un asse Tori-no-Milano (noto come MITO e relativo, per il momento, soprattutto a colla-borazioni in campo culturale) per creare una sorta di massa critica economi-co-politica a livello continentale e globale, dall’altro i numerosi contributi aldibattito scientifico di studiosi del policentrismo, inteso come modalità digoverno di una Europa urbanizzata senza gerarchie urbane particolarmenteevidenti (cfr. CAP. 4). Se ci limitiamo a continuare a osservare il territoriopiemontese dall’alto, sempre grazie alle possibilità date da internet, e magariallarghiamo lo sguardo alle vicine Rhone-Alpes e Lombardia, possiamoimmediatamente notare due elementi: la dimensione dell’area urbana mila-nese e inevitabilmente la presenza costante delle vette innevate tra Torino eLione. In un certo senso da un lato (est) è evidente la facilità con la quale ilprogetto MITO sia prevedibile, ma è altrettanto evidente come il rapporto diforza – in termini economici, finanziari e anche demografici – tra le due cittàsia favorevole a un ruolo più forte di Milano3. Se si guarda a ovest, ma anchea nord (Ginevra) o a sud (Genova) è invece la complessità dell’eventualestrategia policentrica a saltare agli occhi, perché le Alpi sono un ostacolooggettivo a una piena trasformazione del territorio in esame in una macrore-gione europea a tutti gli effetti. Questa difficoltà oggettiva, che è utile arappresentare anche altre difficoltà (politiche, amministrative, normative,infrastrutturali ecc.) non nasconde però il fascino di questo disegno che nonha solo l’obiettivo di creare massa critica per poter competere, ma intendecreare un nuovo territorio europeo, un nuovo spazio comune all’interno di uncontinente che a fatica si ridisegna.
Per fare il punto, alla scala continentale il territorio torinese e piemonte-se può vedersi come parte di un nuovo spazio macroregionale, oppure comecerniera tra un versante e l’altro delle Alpi, o ancora come parte di un sistemapolicentrico nord-italiano centrato su Milano.
Se ci si sofferma ancora su alcune caratteristiche geografico-fisiche allascala regionale e macroregionale è possibile aggiungere altre considerazioniutili a comprendere un contesto ampio come quello torinese e piemontese piùin generale. La conformazione abbastanza chiusa del territorio regionale,circondato su tre lati da montagne e sul quarto in parte collinare e in partepianeggiante, ha aggravato un problema comune a tutte le città che hanno unpassato e un presente legato all’industria: uno dei problemi principali che l’in-tera Pianura Padana si trova ad affrontare negli ultimi anni riguarda infatti il
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 24
livello elevato di inquinamento atmosferico. Data la portata del fenomeno,non si può pensare che una città da sola possa incidere con le sue scelte sulmiglioramento delle condizioni di qualità dell’aria. È però vero che, inmancanza di un quadro organico di interventi a scala interregionale e nazio-nale, le città possono avviare iniziative pilota e immaginare politiche utili asperimentare soluzioni efficaci. La gravità del problema è, per il momento,ancora poco evidente ma se si considerano anche le pesanti eredità del passa-to industriale in termini di contaminazione dei suoli e delle falde acquifere eil tasso crescente di edificazione del suolo in una situazione abbastanzacompromessa, diventa difficile relegare un dibattito su questi temi ad arenepolitiche o accademiche minoritarie. Questo tema, come gli altri superficial-mente trattati in questo capitolo, non viene affrontato in maniera approfon-dita, ma a un osservatore sufficientemente attento non può sfuggire comemolti dei piani di sviluppo del territorio, ai diversi livelli, facciano semplice-mente riferimento ai problemi di degrado delle condizioni del contestogeografico-fisico e non ne considerino l’enorme portata progettuale4. Il fatto,ad esempio, che le condizioni di inquinamento dell’aria, dell’acqua e dei suolisiano da ritenersi non più come straordinarie ma come elementi stabili, intempi medio-lunghi, del paesaggio urbano torinese metropolitano ci porte-rebbe non a ipotizzare strategie settoriali di contenimento o di riduzione deldanno, ma a programmare uno sviluppo territoriale nel quale siano integral-mente comprese anche tali criticità.
A questo punto è possibile avvicinarsi un po’ alla città e provare a mette-re in relazione l’area urbana con i confini amministrativi. L’operazione risul-ta apparentemente complessa, perché non sembrano esserci relazioni alcunetra i confini comunali e l’estensione dell’edificato, anche se ci si sposta e siprendono in considerazione i confini dei comuni limitrofi. Questa osserva-zione rende evidente un altro problema di Torino: esiste una città reale chenon coincide con il territorio comunale. La città amministrata e quella che sipotrebbe rilevare anche solo a volo di uccello sono due cose diverse, eppureogni tentativo per avvicinarsi alla realtà è più o meno fallito a Torino cosìcome nelle altre città italiane. Esistono alcune eccezioni che non riguardanoperò luoghi, ma attività o servizi che in quei luoghi avvengono (ad es. la crea-zione di agenzie metropolitane dei trasporti, aziende municipalizzate diproduzione ed erogazione di energia elettrica ecc.). Ci sono quindi casi neiquali aspetti concreti della vita urbana riescono a farsi percepire e a riorga-nizzarsi al livello più appropriato per una loro corretta funzionalità. Al di là diquesti esempi, se si osserva il continuum urbanizzato dell’agglomerazionetorinese si può notare come attorno al centro storico e alle sue espansioni piùcompatte, ormai storiche anch’esse, si siano (auto)organizzati bracci protesiora verso nord (Ivrea e il Canavese), verso nord-est (il Chivassese), verso ovest
25
1 . D E S C R I V E R E T O R I N O
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 25
(la Val Susa), verso sud-ovest (il Pinerolese), verso sud-est (Moncalieri e ilversante pedecollinare fino al Pianalto di Poirino) e due parziali eccezioni aest e sud dovute alla presenza di vaste aree che possiamo definire in gran partelibere. Si ha quindi un’espansione dell’edificato di Torino, e di molti suoicomuni più o meno contigui, che è continuo per la presenza di edifici resi-denziali, produttivi o commerciali e dell’infrastrutturazione necessaria acollegarli, ma che lascia anche molti ampi spazi residuali che solo in partetestimoniano usi precedenti, come nel caso delle aree agricole intercluse. Nonsi tratta infatti solo di ampie porzioni di terreno coltivato che si trovano dadecenni a contatto con fabbriche o abitazioni, spesso con precari “corridoiecologici” che permettono agli addetti di spostarsi da un campo all’altro. Sitratta anche di aree agricole abbandonate, di edifici produttivi dismessi diepoca preindustriale o di più recente abbandono per delocalizzazioneproduttiva, di aree residuali da lottizzazioni di epoche diverse, di antichipossedimenti reali che, come nel caso del Parco di Stupinigi a sud di Torinoo del Parco della Mandria a nord-ovest, solo con un processo di riqualifica-zione possono assumere un ruolo attivo nel ridisegnare il territorio urbano.Si tratta, ancora, di aree che sono sfuggite a una lottizzazione massiccia e chepossono adesso costituire parte del mai realizzato anello verde intorno allacittà – come nel caso dell’area detta BORSETTO (Borgaro, Settimo, Torino), anord del comune di Torino –. E ancora si potrebbero citare le sponde protet-te dei quattro corsi d’acqua principali che attraversano il territorio torinese eper ultimo l’area libera a est del comune principale che è costituita dalla Colli-na di Torino. Quest’area è in realtà solo in parte libera, in primo luogo perchéin alcune zone è molto edificata e alcuni dei comuni principali dell’areametropolitana sono collinari in tutto (Chieri) o in parte (San Mauro), insecondo luogo perché la collina è sempre stata per Torino sia area di villeg-giatura che di produzione agricola.
Se si considera quindi il continuum urbanizzato, quello torinese si presen-ta come un territorio di urbanizzazione diffusa con addensamenti lungo alcu-ni assi di collegamento principali. Basta però considerare la commistione di usidel suolo in aree contigue per allargare la definizione di urbanizzazione diffu-sa a un territorio molto più ampio: in questo senso è possibile considerarecome area urbanizzata praticamente tutta l’area pianeggiante e in parte colli-nare per un raggio di 30-35 chilometri intorno a Torino. Il restante territorio èa sua volta possibile considerarlo come frangia periurbana, ancora meno densama certo non esclusivamente rurale, direttamente collegata a sua volta ad altrearee urbanizzate subito a sud (nel Cuneese) e a nord-est (Vercellese, Novare-se, Varesotto e infine Milanese). Di nuovo a far da limite, questa volta all’ur-banizzazione del territorio, sono le Alpi da un lato e la collina dall’altro.
Riconsideriamo la visione a volo d’uccello, oppure osserviamo la città da
M A R C O S A N T A N G E L O
26
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 26
1 . D E S C R I V E R E T O R I N O
27
qualche altura della collina: con lo sguardo si abbraccia tutto il Piemonte,tranne un po’ di territorio collinare alle nostre spalle. Se escludiamo le areemontane più impervie, tutto ciò che osserviamo è antropizzato e urbanizzatoin qualche modo. O con una diffusione continua dell’insediamento urbano, ocon una frammentazione degli usi del suolo dovuta agli effetti della disper-sione urbana, o attraverso la diffusione di stili di vita urbani anche in ambitirurali o naturali.
Sul territorio ci sono ovviamente segni, più che segnali, che ci indicanoconnessioni possibili in questo insieme disordinato di oggetti e fenomeni eche una descrizione superficiale può cogliere. Le centralità storiche di questourbanizzato diffuso, i tessuti densi dei borghi rurali, le grandi cascine, i gran-di impianti produttivi storici, costituiscono caratteristiche utili, insieme allearee agricole sopravvissute, alle aree a parco, alla collina e alle aree fluvialiper pensare al territorio torinese non più e non solo in termini di comuni oarea metropolitana ma di un territorio del quale si deve ripensare la logicaorganizzativa non solo a partire dalle sue componenti maggiormente attive eredditizie (aree produttive, commerciali e residenziali).
1.4In mezzo
L’osservazione di una città e dell’uso che delle sue parti si fa ci porta ad abbas-sare ulteriormente il nostro punto di vista e a scegliere di stare in mezzo allacittà stessa, a muoversi lungo le sue strade. A questo livello infatti è possibilefare delle osservazioni in relazione ad alcune idee consolidate di città e dellacittà di Torino, in particolare: l’esistenza e il ruolo dei suoi limiti, le caratteri-stiche delle aree di frangia periurbana, la densità del centro storico contrap-posta a quella delle periferie, la specificità o al contrario l’anonimato delleperiferie, la presenza di elementi sorprendenti che ci appaiono per casi fortui-ti. Alcune di queste idee vengono rafforzate dall’osservazione, altre vengonomesse ancora una volta in discussione.
Dall’alto abbiamo constatato come sia complicato definire dei limiti all’e-spansione urbana. Se ci portiamo a livello strada possiamo verificare comequesto esercizio non sia più semplice, anzi. Quali sono i limiti di una città?Come posso percepire il passaggio dal comune di Torino a quello di Monca-lieri? E se mi porto al limite anche di quest’ultimo come posso dire che quelgruppo di case che vedo un po’ discoste non siano anche esse segno di urba-nità, sfuggito per caso al di là di una linea immaginaria? Semplicemente, alivello strada non ho modo di poter stabilire i limiti della città, anche perchéper gran parte della superficie della Pianura Padana non ci sono spazi per iquali lo sguardo umano possa perdersi senza incontrare un manufatto che
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 27
possa rimandare alla vita cittadina (una fabbrica, un esercizio commerciale,delle villette ecc.)5. Dovrei spostarmi quindi ai limiti dell’urbanizzato, perpoter capire qualcosa dei limiti della città, abbandonando l’idea che sia possi-bile seguirne i confini amministrativi. Andrei quindi alla ricerca delle aree difrangia periurbana, così come sono talvolta definite, ovvero quelle areetalmente al margine della diffusione urbana da non essere nemmeno opachequanto le aree di periurbanizzazione stesse. Tali aree di frangia sono ancoradegli spazi dove elementi più chiaramente riconoscibili come urbani simischiano a elementi meno chiaramente identificabili come rurali. Aree nellequali un lotto di palazzine di tre piani a uso residenziale confina con duepiccole fabbriche, una strada con alcune attività commerciali, un terrenoincolto con un piccolo bosco e un accampamento abusivo. Si potrebbetradurre sbrigativamente l’espressione “aree di frangia” con “disordine” o,con uno sforzo di immaginazione, con “aree con qualche forma di auto-orga-nizzazione”. Non se ne avrebbe però giovamento dal punto di vista dell’os-servazione, perché non si presenterebbe in generale davanti ai nostri occhi unesempio classificabile di organizzazione degli usi del suolo. Per di più, presen-tandosi questo problema nei lembi estremi delle aree urbanizzate o all’inter-sezione di aree amministrative diverse, si tende a sottovalutarne l’importanzae a ritardarne ogni tentativo di risoluzione, con il rischio di trovarsi a doverintervenire in situazioni che hanno oramai raggiunto una sorta di equilibrioprecario e consolidato modi di uso e stili di vita che possono entrare in conflit-to con ogni tentativo di programmazione e pianificazione.
Se ci si astraesse dalla necessità di immaginare una città come un organi-smo controllato e/o controllabile in ogni sua parte, si potrebbe anche ritene-re che forme autonome di organizzazione non solo siano possibili, ma sianoanche salutari e ammissibili. Che frammenti resistenti abbiano il compito disperimentare e innovare forme nuove di coesistenza urbana. Si potrebbeaddirittura pensare che il continuum urbanizzato, e tutto il resto che conti-nuum non è ma che è urbanizzato, debba essere inteso come una forma deltutto nuova e inevitabile dell’organizzazione umana sul territorio e che, cometale, il problema non stia nella sua regolazione, ma nella comprensione delfenomeno. Ci si dovrebbe concentrare quindi non tanto sulla forma di rego-lazione dell’espansione urbana di Torino e della sua area metropolitana,compreso anche il problema mai risolto dei limiti dell’area metropolitana nelsuo insieme, ma sulla conoscenza di questa nuova forma di organizzazioneterritoriale, sparsa, diffusa che è altro da quanto abbiamo conosciuto e chenon potremo mai conoscere finché non la considereremo nel suo insieme,come una forma di città o un paesaggio urbano, e non solo per parti di città edi campagna che coesistono.
Potrebbe, e forse dovrebbe, essere questa la strada da percorrere. Una
M A R C O S A N T A N G E L O
28
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 28
1 . D E S C R I V E R E T O R I N O
29
strada, tra l’altro, che necessita di sguardi di geografi perché in gran parte sitratta di una terra incognita nella quale concetti e idee utilizzati a lungo vannoridiscussi e messi alla prova.
Un’idea abbastanza consolidata, ad esempio, è quella che ci permette diassociare ai centri storici, e a maggior ragione quelli delle grandi città, unadensità materiale (di popolazione, di edifici e di infrastrutture) e immateriale(di funzioni, di dinamiche sociali ed economiche, di aspetti culturali ecc.)tale da potersi distinguere dalle periferie genericamente intese. Le periferie,all’opposto, andrebbero intese come luoghi dell’anonimato, del sonno o delsonnolento, quasi della vita di paese in città ma senza le qualità di tale vita,solo con i suoi difetti. Una città come Torino permette però di mettere subi-to in discussione tale idea di periferie, perché una certa storia del movimentooperaio e delle forme di organizzazione del periodo fordista sono tipiche delleperiferie della città, non del suo centro storico per altro all’epoca poco consi-derato.
Torino stessa quindi non può essere letta come una città con determina-te dinamiche in centro e altre in periferia, dove il centro è più denso della peri-feria, perché per certi versi è stato, ed è, il contrario (cfr. CAP. 8). Parte delcentro storico è stata oggetto di un imponente processo di riqualificazione el’intero centro è stato in qualche modo riammesso nell’immaginario colletti-vo come patrimonio culturale e ambientale comune6, ma i processi piùcomplessi e interessanti di rigenerazione e di ridiscussione delle identità deiluoghi sono avvenuti nelle periferie della città e ancora lì in parte avvengono(a questo proposito, cfr. CAP. 8). Mentre però tutto ciò avveniva, nei venti annipassati, in tutto il resto dell’area metropolitana si erano promossi alcuniprocessi simili, di rigenerazione e riqualificazione, ma non si è mai posto ilproblema di dare una dimensione sovracomunale alle strategie di interventoe alle prospettive di evoluzione. In un contesto urbanizzato come quellosommariamente descritto nelle pagine precedenti, l’intervento di rigenera-zione in una parte della periferia della città di Torino avrebbe forse senso – inprospettiva e a lungo termine – se fosse presente un’idea metropolitana digoverno delle trasformazioni urbane (che non si riferisca solo alle scelte loca-lizzative di grandi aree commerciali, alla posizione di centri di interscambio edi termovalorizzatori). Considerando la dimensione metropolitana o addirit-tura regionale dell’urbanizzazione, l’attenzione dovrebbe essere postaproprio su quelle aree indefinibili, di frangia, di margine, che sembrerebberoauto-organizzarsi per mancanza di alternative, che si rendono “periferia” inassenza di centralità, che si fanno intersezioni e interclusioni laddove al poli-centrismo a scala urbana come idea di riorganizzazione (un’idea dell’ammi-nistrazione comunale di Torino di metà degli anni Novanta) non è seguitaalcuna ipotesi operativa. Anche in questo caso, Torino, intesa come grande
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 29
area urbanizzata torinese, ha una struttura reale policentrica, mentre solo inparte è capace di pensare a una città policentrica concreta della quale non siriesce a individuare il perimetro, la forma amministrativa e in ultima analisi ilsenso.
Stare a livello della strada ci permette anche di fare altre scoperte, oltre aquelle relative alla difficoltà di interpretare la città che abbiamo di fronte. Taliscoperte hanno un duplice valore, perché se da un lato ci mostrano fenomeniinaspettati che contribuiscono a mettere in discussione delle immagini di cittàconsolidate, dall’altro ci forniscono già delle coordinate utili per riconosceree ipotizzare il cambiamento. In ogni città queste scoperte sono possibili, ed èinteressante provare a raccontarne qualcuna scegliendo magari tra quelle piùpiccole e apparentemente insignificanti. Tali scoperte, o sorprese, possonoinfatti essere di dimensione, caratteristiche e significato diversi (sono scoper-te, d’altra parte, sia l’idea che le aree industriali dismesse possano essere utiliz-zate per insediare nuove funzioni urbane, sia l’idea che i centri sociali, la cuifunzione più evidente è di dare spazio alla manifestazione del dissenso, possa-no anche rappresentare centri di formazione, di servizio e di integrazionesociale per le parti della città nelle quali sono localizzati). Il ruolo necessarioche queste scoperte hanno, però, è legato alla loro capacità di mostrarediscontinuità laddove la città e la rappresentazione che della città abbiamoprevedrebbero un racconto lineare.
In una città come Torino è facile che alcune di queste sorprese si trovinoin parti della città delle quali ci pare di aver immaginato tutto, come ad esem-pio nel suo versante più accidentato e nascosto, tra le pieghe della collina. Èinfatti nella precollina a ridosso di piazza Vittorio Veneto, in pieno centrostorico, che si trova un elemento rurale per eccellenza, un vigneto, che è statoripiantato a testimonianza di uno degli usi antichi della collina. Se gli orti sonoormai una nota consueta dei paesaggi urbani, una condizione della cittàcontemporanea, e le modalità più innovative del rapporto urbano/rurale sonoda ricercarsi nelle forme di guerrilla gardening o di urban farming che si posso-no intravedere nei cortili dei quartieri del centro7, un vigneto in piena attivitàosservabile stando comodamente seduti in un dehor di una delle maggioripiazze del centro è spiazzante. In qualche modo, rende la città borgo ruralee, per alcuni, la vendemmia una possibile attività creativa e di gioco.
Altro segnale da interpretare lo si può trovare a pochissima distanza,sempre in collina. Dal centro di Torino è infatti possibile raggiungere in pochiminuti l’inizio di diversi sentieri che si perdono per i versanti e che permetto-no di camminare in boschi più o meno secolari (anche questi interrotti ognitanto da case, qualche campo, strade). In questo caso l’ambiente naturale è apiù stretto contatto con la città storica di quanto non lo siano vaste parti dellasua area urbanizzata estesa. Un altro esempio di questo rapporto tra natura-
M A R C O S A N T A N G E L O
30
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 30
1 . D E S C R I V E R E T O R I N O
31
lità e urbanità è dato dal fiume Po, che ha carattere torrentizio, irregolare eselvaggio fino a Moncalieri, ovvero fino alla porta sud di questa ipotetica-mente definita area metropolitana torinese. Solo da Moncalieri in poi, conun sistema di chiuse, il torrente diventa fiume e le sponde diventano parco.
Le sorprese, osservando la città dalle sue strade, sono quindi possibili,molteplici e necessarie perché al di là della possibile aneddotica ci permetto-no di considerare l’imprevedibilità di ogni rappresentazione.
1.5Da sotto
Che si possa descrivere una città guardandola da sotto può essere considera-to normale in alcuni casi: Londra è per molti esattamente corrispondente allamappa della sua metropolitana; Parigi ha una letteratura che si ispira ai suoisotterranei; Napoli ha un suo alter ego sotterraneo che troppo spesso sidimentica. Questa possibile descrizione è meno evidente per Torino che, aeccezione di alcuni casi (le gallerie sotterranee militari, gli infernot, le ghiac-ciaie, le bealere e i rifugi antiaerei), non ha una sua vera e propria dimensionesotterranea.
Le gallerie, tra le più famose e visitabili quelle di Pietro Micca, sono quan-to rimane dei cunicoli adibiti al trasporto di materiali e messaggi, alla fuga o alposizionamento di esplosivi che erano stati scavati intorno alla cinquecente-sca cittadella fortificata della città. Naturalmente si narra di gallerie in partecrollate che collegavano punti distantissimi tra loro, come il Palazzo Reale alCastello di Rivoli, ma della cui esistenza non ci sono testimonianze o proveconcrete. Le stesse gallerie di Pietro Micca sarebbero ancora oggetto di discus-sione se non fosse per la passione di pochi speleologi urbani che, per il gustodi scoprire una nuova dimensione di esplorazione della città, hanno fattodelle spedizioni nelle viscere della cittadella. Antichi anch’essi, ma nati per altriscopi, sono gli infernot, ovvero le profonde cantine degli edifici storici chepotevano contenere per esempio vini o prigionieri. Vaste e meno numerose leghiacciaie, strutture sotterranee imponenti nelle cui sale veniva conservato ilghiaccio tutto l’anno. Nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, infine, venne-ro scavati numerosi rifugi antiaerei di quartiere, alcuni dei quali ancora visita-bili. Fin qui ciò che si può sapere e in qualche caso osservare direttamente.
Esistono anche delle reti di servizio sotterranee, ovviamente, che in qual-che caso sono state utilizzate come vie di fuga (come nel caso dei tunnel fogna-ri che collegano Porta Nuova al Valentino), così come esiste un reticolo dicorsi d’acqua naturali e artificiali che solcavano le campagne torinesi – lebealere – e che sono state man mano interrate all’avanzare dell’edificato. Tori-no non ha però mai conosciuto un vero e proprio sviluppo sotterraneo fino a
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 31
quando non si sono visti, nel giro di pochi anni, i lavori per la creazione delpassante ferroviario, della prima linea di metropolitana e del sistema diparcheggi sotterranei nelle aree centrali della città.
Il passante ferroviario di per sé sarebbe una grande opera ingegneristicadi scavo per posare a una certa profondità le principali vie ferrate che attra-versano Torino. A questo valore in sé si aggiungono certamente il valoresimbolico della ricucitura delle parti ovest ed est della città, fino a pochi annifa separate da un fossato, e il valore economico delle operazioni effettuate suenormi aree ora utilizzabili nelle zone centrali e semicentrali della città. Ilpassante ha però un altro valore simbolico e pratico che non può essere piena-mente colto fino alla fine dei lavori, perché attorno al passante si riorganizze-ranno le principali vie d’accesso alla città e quindi nuove aree di espansioneper attività terziarie, servizi e residenze. Si tratta, nel suo insieme, di uncambiamento strutturale epocale per la città e forse solo la traduzione ingle-se del nome dato all’operazione dà una giusta proporzione al processo incorso: il nome italiano “Spina” (associato a dei numeri che identificano idiversi lotti dell’operazione) si traduce come “Backbone”, ovvero spinadorsale. In questi anni, quindi, si lavora sulla spina dorsale della città. Opera-zione non da poco.
Un’operazione apparentemente di ricucitura più minuta è quella relativaalla creazione della prima linea della metropolitana sotterranea, inaugurata inparte in occasione dei XX Giochi olimpici invernali del 2006 e destinataanch’essa a cambiare il volto della città, perché il cambiamento radicale deitempi di attraversamento da ovest a sud porta a ripensare alla geografiafunzionale della città stessa. In più, i torinesi cominceranno a sovrapporre allaloro idea di città una città simile a quella della mappa della metropolitana, perquanto ancora si tratti di una mappa estremamente semplificata: per andareda Porta Susa al Lingotto non dovrò spostarmi da nord a sud in un certolasso variabile di tempo e di costo, ma dovrò fare dieci fermate in quindiciminuti circa al costo di 1 euro.
I parcheggi sotterranei, infine, ultimo esempio di espansione verso ilbasso della città e forse l’esempio meno chiaro di quale visione strategica ci siadietro la scelta di favorire l’ingresso delle automobili fino al cuore della città.
Gli esempi recenti citati: il passante, la metro, i parcheggi sotterranei,sono un chiaro sintomo della scoperta tardiva ma necessaria della quartadimensione di sviluppo per la città; dopo le espansioni in lungo e in largo e imai troppo ben digeriti tentativi di espandersi verso l’alto con i grattacieli,ecco che si esplorano le grandi possibilità di dotare Torino di un nuovo piano– fisico – di sviluppo. Anche in questo caso, come si è detto, gli effetti nonsaranno immediati sulla percezione della città da parte degli abitanti, ma sitratterà sicuramente di una rivoluzione geografica di grande importanza.
M A R C O S A N T A N G E L O
32
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 32
1 . D E S C R I V E R E T O R I N O
33
1.6Una descrizione complessa
La descrizione ignorante della quale si è scritto all’inizio di questo capitolo èstata, si può infine affermare, un diversivo. Si è detto che avrebbe permesso didescrivere alcuni aspetti della realtà torinese cercando di non tenere troppoconto di riferimenti analitici e teorici specifici e senza, per altro, approfon-dirne nessuno.
La vaghezza di questo tipo di descrizione ha permesso, però, di scrivere diTorino e di alcune sue specificità e, nello stesso tempo e con un certo grado diastrazione, di ragionare su di essa e di fornire spunti per riflettere su una cittàmedia, europea, generica. La possibilità quindi di estendere il risultato di taliriflessioni anche ad altre realtà urbane e l’accettazione della difficoltà di descri-vere tutto (e bene) ha portato a delle scelte: di punti di vista, di cosa racconta-re in maniera aneddotica, di quanto allargare o restringere lo sguardo.
La scelta di descrivere la città dall’alto, cogliendo quindi soprattutto lasua natura di oggetto geografico, le sue coordinate spaziali, la sua articolazio-ne su un territorio vasto, ha permesso di richiamare alcuni processi che hannomodificato, o lo faranno nei prossimi anni, in maniera radicale il rapportodella città con il territorio. La riconfigurazione dello spazio europeo, che siprospetta anche attraverso l’infrastrutturazione ferroviaria a scala continen-tale, pone di fronte a scenari molto diversi: una macroregione transalpina emediterranea; un persistere dell’immagine delle Alpi come spazio ibrido edelle metropoli alpine come passaggi o cerniere tra un versante e l’altro; unrafforzarsi di sistemi policentrici a scala nazionale nel Nord-Ovest italiano.Questi scenari, e altri ancora, non sono solo possibilità verso cui orientarsi perimmaginare lo sviluppo del territorio, sono anche prefigurazioni di forme diorganizzazione dello spazio che da un lato dipendono da “invarianti” fisico-geografiche anche di grande scala, dall’altro sono in stretta relazione conforme di urbanizzazione consolidata, modi di uso e stili di vita la cui variabi-lità è ipotizzabile in tempi medio-lunghi.
A queste considerazioni si aggiungono anche elementi critici, costituitiad esempio dallo stato di degrado della qualità dell’aria, dell’acqua e deisuoli, che non possono più essere considerati come vincoli alla progettazionedello sviluppo del territorio quanto, piuttosto, elementi attivi della progetta-zione stessa. Se così fosse non si porrebbe, probabilmente, il problema dicome disporre delle aree libere lasciate nei centri urbani dalle delocalizza-zioni delle industrie, ma ancora prima il problema di come utilizzare areecon suoli inquinati, come e dove smaltire i rifiuti (ovvero i suoli stessi), comeintervenire per bonificare le falde acquifere avvelenate di un territoriopostindustriale.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 33
Dal punto di vista “in mezzo” sono divenuti evidenti altri due problemi:la questione dei limiti e dell’irriconoscibilità dei confini della città e la diffici-le formalizzazione, se necessaria, di modelli di espansione urbana.
La scarsa valenza conoscitiva dei limiti amministrativi della città, dalpunto di vista dell’osservazione delle dinamiche e dei modelli di crescita urba-na, non solo non ci permette di raccontare la città in alternativa a un territo-rio esterno, ma anche di poter definire dei confini entro i quali i fenomeniche osservo possono essere considerati come urbani.
La diffusione delle modalità urbane di intendere il rapporto con il terri-torio (ad es. per quanto riguarda la percezione di spazi definiti per determi-nate attività, la mobilità privata su distanze considerevoli e la diffusione diinformazioni in tempo reale) non permette quindi di definire dei modelli didiffusione dell’edificato urbanizzato: dalla città storica e compatta si passa aun edificato sempre più diffuso e misto che non ha soluzioni reali di conti-nuità. Nel caso di Torino si devono, infatti, considerare le zone di media e altamontagna come limite estremo dell’urbanizzazione diffusa piemontese (piùche esclusivamente torinese) e occorre decidere di considerare alcune areecome “non urbanizzate”, perché a prevalente uso agricolo ad esempio, perindividuare alcune pause nel processo di urbanizzazione.
Nei paragrafi precedenti venivano però rilevati anche alcuni aspetti che,pur non rappresentando delle soluzioni ai problemi individuati, sono da rite-nersi come elementi positivi per una migliore comprensione di quanto cicirconda. Questi elementi di sorpresa, che si sono individuati come “discon-tinuità”, sono stati scelti arbitrariamente tra molti possibili ma ci permettonodi vedere come l’immagine di sintesi della città contemporanea sia fatta dielementi apparentemente inconciliabili che invece convivono. Si tratta diuna caratteristica fondante delle città e del carattere di urbanità che peròtende a perdersi nella lettura del fenomeno urbano come fatto unitario.
Tali elementi sono sorprendenti perché ci mostrano usi fuori dalla normadi parti della città, perché riguardano fenomeni che non sappiamo bene inter-pretare ma che si sviluppano al di fuori di schemi ufficiali, perché anche nelcaso di elementi che nascono da progettualità ufficiali, come i piani di svilup-po sotterraneo della città, sono destinati a cambiare il modo con il quale icittadini percepiscono lo spazio urbano.
Discontinuità fisica, nel caso della diffusione urbana, e narrativa, nelcaso di storie relative a elementi inattesi che sono presenti in questo processodiffusivo, caratterizzano la descrizione della città e contribuiscono a render-la complessa. Queste discontinuità, insite sia nel racconto che nella rappre-sentazione della città, diventano quindi elementi utili per comprendere appie-no il fenomeno urbano che ci circonda e per immaginarne le trasformazioni.Ci permettono di mettere in discussione idee consolidate di città per potere,
M A R C O S A N T A N G E L O
34
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 34
1 . D E S C R I V E R E T O R I N O
35
eventualmente, ripensare alla città così come è davanti ai nostri occhi esempre meno come la trasposizione di un modello ideale nella realtà.
Note
1.@A questo punto è giusto fare riferimento a due autori che hanno influenzato questa scel-ta, perché di ispirazioni teoriche e metodologiche ce ne sono molte, più o meno evidenti, maquesta descrizione ignorante deve molto – anche se l’ignoranza è naturalmente solo dell’auto-re – alle riflessioni di Giuseppe Dematteis e di Arturo Lanzani.
2.@Geograficamente, sempre con un approccio italo-centrico, anche Milano sarebbe peri-ferica perché posta a poche decine di chilometri dal confine, ma in questo caso entrerebbero ingioco immediatamente caratteristiche quantitative e qualitative (relative al peso economico,finanziario e culturale che Milano ha nel contesto italiano) tali da rendere quasi ininfluente ilpeso della posizione geografica.
3.@In questo caso si sceglie esplicitamente di considerare solo la dimensione fisica –l’estensione dell’urbanizzato – delle due città per valutarne in prima battuta i rapporti di forza.Si tratta di un’operazione di banalizzazione evidente, ma è anche vero che la grandezza di unagglomerato urbano, in un contesto europeo occidentale, è abbastanza legata ad altre caratte-ristiche, ad esempio di dimensione demografica o di forza economica, tali da permettere questasemplificazione.
4.@Il riferimento alle condizioni di degrado del territorio cui ci si riferisce è sommario eintuitivo e non tiene conto delle condizioni naturali di possibile degrado, come ad esempio ilrischio geologico o quello idrogeologico, entrambi rilevanti in una regione che per il 55% delsuo territorio è montana. Tuttavia questi aspetti non sono di secondaria importanza e a ricor-darcelo sono eventi come l’alluvione del 2001 che, tra gli altri effetti, rese Torino una penisolaisolata dal resto d’Italia per 24 ore.
5.@Nel caso di Torino si segnalano due volumi che ci confermano la difficoltà di definire ilimiti della città. Il primo, I confini di Torino, è di Dario Voltolini (2003) e racconta le aree dellacittà poste ai suoi confini amministrativi. Il secondo, In fondo alle vie di Torino. La città e leAlpi, di Giorgio Faraggiana (2005), mostra come le Alpi facciano da sfondo alla maggior partedelle vie di Torino e, in qualche modo, definiscano il limite della città.
6.@Negli anni Novanta infatti una parte consistente del vecchio centro storico degradato,il cosiddetto “Quadrilatero romano” fu oggetto di massicci investimenti da parte di soggettiprivati che hanno portato a un ampio processo di gentrification e di recupero urbano. Nellostesso tempo anche altre parti del centro storico, soprattutto le zone auliche, venivano recupe-rate e riqualificate dando così il via a un processo di riappropriazione del patrimonio culturalee monumentale cittadino da parte dei torinesi stessi.
7.@Ad esempio a San Salvario è attiva un’associazione di urban farming che organizza veri epropri blitz per la costruzione di orti e giardini urbani (cfr. http://progettorizomi.wordpress.com).
Bibliografia
FARAGGIANA G. (2005), In fondo alle vie di Torino. La città e le Alpi, Editris 2000,Torino.
VOLTOLINI D. (2003), I confini di Torino, Quiritta, Roma.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 35
37
2Torino e la costruzione di immagini urbane
di Alberto Vanolo
Torino rappresenta, nell’immaginario comune, l’archetipo della città fordistaitaliana. Si tratta di un’eredità per molti versi oggi scomoda: al di là delladifficile questione di quanto sia o non sia ancora una one-company town (cfr.CAP. 3), la città si muove ormai da tempo verso la promozione e riproduzionedi un differente immaginario. Obiettivo di questo capitolo è l’analisi delleimmagini torinesi di città fordista e postfordista. A questo scopo, il primoparagrafo ricostruisce alcuni nodi del dibattito sulla città fordista, mentre ilsecondo, anch’esso di taglio teorico, affronta il tema della natura delle imma-gini urbane. I CAPP. 3 e 4 si concentreranno invece sul caso torinese e sulle sueimmagini vecchie e nuove.
2.1La città fordista: alcune note su un dibattito mai esaurito
La sensazione di vivere un periodo storico caratterizzato da straordinarimutamenti è oggi alquanto diffusa: è quasi banale descrivere come “radicali”le trasformazioni apportate dalle nuove tecnologie, dall’ascesa di Cina e Indianello scenario economico globale, dalla globalizzazione. Si tratta di muta-menti ancora in atto, difficili da etichettare, come testimonia il fatto che alcu-ni concetti si siano caricati di significati così ampi da risultare vaghi e indeter-minati: è il caso dell’espressione globalizzazione, utilizzata sia con riferimentoall’espansione dell’impresa multinazionale negli anni Ottanta, sia alle nuovis-sime trasformazioni socioeconomiche relative all’ascesa dei colossi asiatici(avvenuta decenni dopo), sia ancora alle trasformazioni delle pratiche socioe-conomiche legate a internet e alle nuove tecnologie della comunicazione.
Qualcosa di analogo è accaduto all’incirca due o tre decenni fa con riferi-mento al dibattito sulla crisi del fordismo e sulle successive trasformazionidell’economia e della cultura urbana, etichettate con la generica espressione“postfordismo”. Gli anni Settanta e Ottanta sono stati generalmente vissutidagli studiosi come un periodo di profondo mutamento nella struttura e orga-nizzazione dell’economia e della società occidentale (Amin, 1994), un crocevia
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 37
segnato da forze (tecnologiche, di mercato, sociali e istituzionali) molto diffe-renti da quelle che avevano dominato lo scenario negli anni successivi allaSeconda guerra mondiale. Questa sensazione di un’incipiente trasformazioneepocale, o di una transizione verso una nuova fase del capitalismo, è stataaccompagnata dalla nascita di un certo numero di espressioni accademichequali “postfordismo”, “postindustriale” e “postmoderno”. Si tratta di terminiche si riferiscono a dibattiti paralleli, guidati da prospettive teoriche e discipli-nari sovrapposte, come quelle della scuola regolazionista nella politica econo-mica, delle analisi neoschumpeteriane nello sviluppo dei paradigmi tecnolo-gici, della prospettiva della specializzazione (e accumulazione) flessibile, odell’ipotesi dell’avvento di un nuovo capitalismo “disorganizzato”. Si tratta diun corpo di teorie piuttosto variegato e probabilmente ben noto a chi si occu-pa di discipline vicine all’economia; per i profani, basti considerare come ungran numero di approcci teorici si siano occupati, in particolare durante glianni Ottanta, dell’analisi delle profonde trasformazioni legate all’imminentecrisi dell’economia e della società (o, per usare espressioni accademiche, delregime di accumulazione e modo di regolazione) fordista.
Gli studi urbani non hanno fatto eccezione. Il fordismo, in particolare, hasegnato profondamente i caratteri dello sviluppo delle città: l’imposizione diun modo di accumulazione intensivo legato a tecniche di produzione taylori-ste, la forte capitalizzazione dell’economia, la diffusione di un modello stan-dardizzato di consumo di massa, la rapida rottura degli stili di vita tradizio-nali, la generalizzazione delle condizioni di lavoro e la diffusione di stili socialiomogenei hanno profondamente plasmato la città occidentale (Esser, Hirsch,1989), in particolare in alcune realtà fortemente legate alla grande industriacome Torino. La struttura regionale è stata regolata e dominata dalla localiz-zazione industriale (ad es. automobilistica), con un drastico crollo del pesodelle attività agricole e una parziale industrializzazione del settore primario.La città fordista è stata quindi caratterizzata da vistosi processi di agglomera-zione, dalla standardizzazione dell’ambiente costruito, dalla nuclearizzazionedella famiglia, da processi di disintegrazione sociale, ad esempio nel casodell’erosione dei tradizionali milieu socioeconomici (gli ambienti dei lavora-tori). La vasta imposizione della mobilità privata (automobili) ha accompa-gnato una forte differenziazione dello spazio funzionale, caratterizzandofenomeni di suburbanizzazione, la formazione di città-satellite, periferie, lospopolamento di determinate aree, la morte di produzioni e attività econo-miche di nicchia. La vita nella famiglia nucleare, il lavoro standardizzato, latelevisione e l’automobile sono diventati simboli alla base di un certo model-lo di vita e strutturazione dello spazio urbano. Si tratta di processi per moltiversi problematici: si pensi ai conflitti legati alle trasformazioni degli spaziresidenziali periferici in aree dormitorio (cfr. CAP. 8).
A L B E R T O V A N O L O
38
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 38
2. T O R I N O E L A C O S T R U Z I O N E D I I M M A G I N I U R B A N E
39
La crisi dell’economia fordista, della grande impresa verticalmente inte-grata, della società dei consumi di massa, può essere letta dal nostro punto divista come una crisi della città fordista (Lever, 2001). Il declino di quel para-digma economico ha determinato la riduzione della centralità delle economiedi scala e quindi di strutture geografiche caratterizzate da grandi impiantiindustriali situati all’interno di città di grandi dimensioni (con la formazionedei cosiddetti “vuoti industriali”), spesso accompagnandosi alla crescita dellepiccole e medie imprese, che richiedono meno addetti e maggiore flessibilità(con la conseguente frammentazione del mercato del lavoro), nonché allacontrazione del settore industriale in favore dei servizi (Scott, 1988). Si trattadi fenomeni che hanno avuto rilevanti conseguenze anche con riferimentoall’esperienza sociale del capitalismo. A questo proposito, David Harvey(1989) ha posto in evidenza alcune tendenze.
La prima si riferirebbe alla centralità della produzione di capitale simbo-lico. Oggi più che mai i beni che consumiamo contengono una quantitàcrescente di simboli, prima ancora che di qualità materiali: acquistandoun’automobile di una certa marca, ad esempio, acquistiamo anche (e soprat-tutto) una certa concezione della moda e del proprio status sociale. Si tratta diconsiderazioni centrali per la vita urbana, da un lato poiché culla di culture,mode e significati (Zukin, 1995), dall’altro lato perché anche l’ambientecostruito è vissuto come un’esperienza consumistica: risiedere in una certaarea della città o visitare uno spazio urbano nella veste di turista sono dueesempi di codici di distinzione sociale e di consumo di esperienze urbane(Harvey, 1987).
In secondo luogo si segnala la progressiva spettacolarizzazione dell’espe-rienza urbana. Si tratta ad esempio della proliferazione (e del supporto daparte delle politiche urbane) di strutture materiali e di eventi che promuovo-no esperienze di shopping o di divertimento di massa, come nel caso di centricommerciali (Le Gru e 8 Gallery, per citare due noti esempi torinesi), quar-tieri “etnici” (San Salvario come luogo di locali alla moda per il divertimentonotturno), musei e spazi culturali pubblicizzati come merci di consumo. Inaltre parole, si tratta di trasformare parti delle città in arene di spettacolo econsumo (l’intera città, nel caso di un evento come le Olimpiadi), da un latosegnando un divario sociale fra chi può e chi non può prendere parte a unsimile spettacolo, e dall’altro lato spostando il fulcro delle politiche urbanedal supporto alla produzione e ai servizi sociali ad attività maggiormenteimprenditoriali, come appunto la promozione dell’immagine della città, l’or-ganizzazione di eventi, la ricerca di politiche attive coinvolgenti attori privatie semi-pubblici (Mayer, 1994).
Il dibattito sul postfordismo negli anni Ottanta e Novanta ha conosciutouna popolarità accademica eccezionale, aprendo infinite discussioni sui possi-
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 39
bili scenari che questa fase di crisi e incertezza, intesa comunemente cometransitoria, avrebbe aperto per il futuro. In altre parole, molto si è scrittosulla crisi del fordismo e sulle ipotetiche forme della città postfordista, ma ècurioso notare come nonostante questo dibattito si sia affievolito, non si siamai giunti a una conclusione ragionevolmente condivisa. Se da un lato è bennoto cosa si intenda per “città fordista”, dall’altro lato non è altrettanto chia-ro cosa sia una “città postfordista”, al di là dell’ovvia constatazione che essanon sia più esclusivamente fordista: ad esempio, alcuni autori hanno discus-so come il suffisso “post” non significhi necessariamente “non” fordista(Amin, 1994). Probabilmente, il periodo di trasformazione dell’economiaapertosi negli anni Settanta è andato molto al di là della crisi del paradigmafordista, sovrapponendosi ad altri fenomeni socioeconomici, geografici, poli-tici, tecnologici ancora difficili da inquadrare in categorie concettuali nette.Tuttavia, il postfordismo si lega a importanti trasformazioni dell’immaginariourbano, ossia al modo in cui intendiamo e percepiamo la città.
2.2L’immagine della città: miti, mode e fantasie
Le rapide trasformazioni dello scenario economico legate alla crisi del fordi-smo e, in tempi più recenti, alla ipermobilità del capitale e agli effetti piùattuali della globalizzazione aprono nuove sfide e opportunità per le città.L’aumento dei flussi globali di capitale, turisti, informazioni, merci e spetta-coli ha aperto l’arena competitiva delle città, muovendo le politiche urbaneverso differenti forme di imprenditorialità (Mayer, 1994). Una convinzionecomune presso gli attori politici si riferisce all’idea che le città debbano posi-zionarsi nello scenario globale attraverso operazioni di marketing (o branding)urbano, ossia proporre immagini attrattive per richiamare capitali e investi-menti, per finanziare il proprio sviluppo e favorire la localizzazione e il radi-camento dei soggetti economici.
In generale, l’espressione “immagine della città” si riferisce metaforica-mente all’idea generale (all’immaginario) che circonda un luogo, e si colleganon solo a elementi visivi, ma anche ai simboli incarnati negli elementi mate-riali (strade, monumenti, edifici) e in quelli immateriali, come le abitudini,routine, istituzioni e organizzazione che regolano la vita degli abitanti, idiscorsi relativi alla città, gli stereotipi relativi agli abitanti, le descrizioni daguide turistiche, film, slogan, campagne di marketing urbano (Vanolo,2008a). La costruzione simbolica dell’immagine urbana è solitamente distin-ta in due dimensioni: quella interna, relativa a simboli percepiti e riprodottida abitanti e city users, e quella esterna, riferita a percezioni e rappresentazio-ni della città di (e per) persone e organizzazioni più o meno estranee alla vita
A L B E R T O V A N O L O
40
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 40
2. T O R I N O E L A C O S T R U Z I O N E D I I M M A G I N I U R B A N E
41
locale. Queste immagini esterne sono spesso vaghe, astratte e semplicistiche:è ad esempio comune associare idee positive o negative a luoghi inesplorati opoco familiari. Tuttavia, nella nostra prospettiva si tratta di elementi impor-tanti poiché permettono di formulare generalizzazioni, aspettative, nonché diguidare le nostre azioni (Shields, 1991), come le scelte di turisti e investitori.Si tratta della ragione alla base dell’interesse nel branding urbano (Kavaratzis,Ashworth, 2005), inteso come la costruzione di immagini positive e affasci-nanti come strumento per attrarre flussi globali di turismo e investimenti. Lapratica del marketing dei luoghi è ben lungi dall’essere innocente, per presen-tare invece un elevato contenuto politico: si tratta di creare autorappresenta-zioni egemoniche ottimistiche e positive, nascondendo dall’immagine tuttociò che appare sfavorevole e problematico (Rossi, Vanolo, 2010). Si pensi aquanto può essere violento il cartello pubblicitario “Torino città della tecno-logia”, attualmente posto a un ingresso della città, per un disoccupato vitti-ma della chiusura dello stabilimento Motorola.
Un nodo teorico di particolare importanza nel rapporto fra immagineurbana e paradigmi economici è stato presentato da Short e Kim (1998): la crisidella città fordista ha introdotto un punto di rottura nella rappresentazioneurbana, come testimoniato dal fatto che vecchie immagini sono allontanate erifiutate. Per dirla sinteticamente, la città fordista non solo non è oggi econo-micamente funzionale e tende a connotare situazioni di crisi, ma si lega anchea simbolismi di decadenza, fallimento e negatività in genere: la “ciminierafumante” non può figurare su nessuna immagine pubblicitaria. Le città devo-no produrre altre immagini, che possiamo generalmente etichettare “postfor-diste”. Quali siano queste immagini è un problema decisamente complesso,che implica problematiche di riconoscibilità, credibilità, identità di un luogo.Si tratta di costruire narrazioni selettive (Sandercock, 2003) mirate a gestirequale impressione e comprensione della città avranno potenziali investitori,visitatori o abitanti. Certamente, non si tratta di costruire narrative immagi-narie: si tratta di articolare e rappresentare immagini che devono avere unacerta base nell’identità e nei dibattiti locali. Immagini palesemente false (ades. Torino città del sole) sono destinate a una bassa credibilità. Si tratta di temiche aprono importanti questioni politiche e sociali, se si considera che leimmagini possono operare come un vocabolario per la legittimazione dispecifiche politiche urbane.
Inoltre, individuare immagini attrattive, sostenibili e distintive è uncompito difficile, soprattutto considerando la variabilità di mode e stereotipi.Ad esempio, durante gli anni Novanta era opinione diffusa che i flussi globa-li fossero diretti verso i luoghi caratterizzati da un’immagine di alta tecnolo-gia: gli esempi di information cities sono innumerevoli, come nel caso diBarcellona (telematic city), Amsterdam (information city), Manchester (wired
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 41
city), una moda esasperata e stereotipata che ha spinto molte città a inseguireaprioristicamente un certo immaginario di vocazione all’alta tecnologia comepanacea per la risoluzione di qualsiasi problema urbano e come opposizioneal declino industriale caratteristico della crisi fordista. Immagini tecnologichesono state celebrate ovunque, anche in assenza di una significativa vocazio-ne, tanto che alcuni autori hanno ironizzato su queste high-tech fantasies(Massey, Quintas, Wield, 1992) o technodreams (Dobers, 2003). Si tratta di unrischio già evidenziato da David Harvey (1989): la scomparsa del messaggioin una folla di immagini urbane pressoché identiche.
Oggi, l’enfasi sull’alta tecnologia si è per certi versi ridotta, aprendo lastrada a immaginari di successo: quello della città verde ed ecologicamentesostenibile, della città globale e cosmopolita, della città culturale e creativa. Sitratta di un panorama molto ampio, a testimonianza dell’esplosione delleidentità individuali e collettive che contraddistingue la vita postmoderna(Featherstone, 1991). Una sintetica analisi della letteratura (Vanolo, 2008b),permette tuttavia di individuare alcuni elementi che paiono nutrire la retori-ca della promozione urbana nelle città del mondo occidentale. In altre paro-le, le operazioni di branding passerebbero attraverso la celebrazione di alcu-ni stereotipi ed elementi dell’immaginario urbano postfordista:– l’idea di vitalità sociale, ad esempio si pensi, nelle immagini pubblicitarie,all’abbondanza di rappresentazioni di aggregazione sociale, di persone che siincontrano e chiacchierano, che creano facilmente legami deboli, ossia cheentrano facilmente nel giro, conoscendo amici (Florida, 2002; Storper, Vena-bles, 2004);– la celebrazione della vita notturna, sia nel caso di lussuosi ristoranti, siadi luoghi attrattivi per persone giovani e alla moda (il cosiddetto playscape:Chatterton, Hollands, 2002);– la presenza di una vivace scena artistica e culturale, con riferimento sia alleforme alte che a quelle più popolari (Zukin, 1995);– la disponibilità di spazi pubblici (o spazi privati percepiti come pubblici,come nel caso di un centro commerciale), inclusi spazi verdi, parchi per ilrelax e lo sport, fiumi e waterfronts in generale (Cybriwsky, 1999);– la presenza di architetture di elevato valore simbolico, veri e propri land-marks, e in particolare costruzioni appariscenti firmate da prestigiosi architetti dirilievo internazionale e architetture postmoderne in genere (Temelova, 2007); – la rappresentazione della varietà, della tolleranza e della differenza, conparticolare attenzione a multietnicità, multiculturalismo, molteplicità degliorientamenti sessuali, integrazione (Florida, 2002; Landry, 2006);– la disponibilità di opportunità di educazione e formazione di alto livello,sia per i più giovani che per i professionisti, elemento comunemente ritenutoessenziale per la competitività urbana (Stead, 2003);
A L B E R T O V A N O L O
42
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 42
2. T O R I N O E L A C O S T R U Z I O N E D I I M M A G I N I U R B A N E
43
– la proliferazione di eventi e megaeventi (Hall, 1992; Hiller, 2000). Questiultimi, come concerti, esibizioni sportive e culturali, hanno il potere ipnoticodi attrarre e concentrare, nello stesso istante e luogo, l’attenzione di milioni dipersone da tutto il mondo per ammirare lo spettacolo urbano. Questo note-vole potere comunicativo è spesso utilizzato per diffondere idee di trasfor-mazione, rigenerazione e successo urbano, e non solo per l’audience esterno:gli eventi culturali possono aggiungere vita alle strade, restituendo un rinno-vato orgoglio ai cittadini (Richards, Wilson, 2004).
L’interrogativo iniziale del capitolo può quindi a questo punto esseremeglio formulato: nel caso di Torino, quanti di questi ingredienti sono staticelebrati negli ultimi anni nel tentativo di ricostruire un immaginario urbanopostfordista?
2.3Torino come Detroit?
La potenza comunicativa di riferimenti funzionali e slogan di sintesi è eviden-te a qualsiasi torinese che, viaggiando per il mondo, si sia trovato nella situa-zione di parlare della propria città. Quali referenti geografici possono farsvanire l’espressione di perplessità suscitata dal nome della città in un ipote-tico interlocutore statunitense o asiatico? Potrà apparire un luogo comune,ma è innegabile che le parole “FIAT” e “Juventus” entreranno rapidamentenella discussione, risvegliando associazioni di idee nell’uditore. D’altro canto,si pensi al caso della città di Nagoya in Giappone: pur trattandosi di una cittàeconomicamente diversificata e ricca di elementi urbani degni di interesse,per qualsiasi profano nel mondo si tratterà semplicemente della città dellaToyota; persino per un torinese, probabilmente ignaro del fatto che il capo-luogo piemontese è gemellato con la città nipponica.
L’immagine di Torino come capitale italiana dell’automobile è tantobanale quanto inamovibile, presente e totalizzante. Si tratta, come vedremo,di un’immagine che è certamente mutata nel tempo, ma che rimane il princi-pale referente funzionale nella geografia della città ormai da un secolo, daquando l’esposizione universale celebrò la “modernità industriale” della capi-tale subalpina. Non è un caso che vari autori, nel passato, abbiano compara-to il profilo della città con quello di Detroit (cfr. Amari, 1980; Città di Torino,1982; Castagnoli, 1998), e se per molti versi Torino non è più una città fordi-sta, rimane comunque una città industriale, in cui manifattura e produzionesono centrali nella vita sociale ed economica (Shaw, 2001): l’impiego nel setto-re secondario è stato, nel 2006, del 34,9%, la quota più elevata fra le provincemetropolitane italiane, una cifra praticamente identica a quella di dieci anniprima (36,4% nel 1996: L’Eau Vive, Comitato Giorgio Rota, 2007).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 43
Nondimeno, i principali stereotipi riguardanti gli abitanti, eventi storici(il movimento operaio, gli scritti di Gramsci), le specializzazioni economiche,i paesaggi urbani legano l’immagine di Torino all’industria. Ad esempio, èopinione diffusa che lo sviluppo della FIAT a Torino sia strettamente collega-to al suo ambiente sociale, radicato nell’organizzazione gerarchica e militaredel regno Savoia. La cultura industriale torinese, legata al lavoro di massa, haspesso celebrato l’autodisciplina e l’orgoglio del lavoratore specializzato.Ancora, secondo Revelli (1989), l’intero sviluppo fisico della città è statofunzionale alla centralità dell’industria automobilistica, «forma spaziale tipi-ca di una società locale fordista» (Lanzani, 1996, p. 194). Del resto, basti pensa-re come tradizionalmente, nel cinema italiano, Torino abbia rappresentato ilset ideale di situazioni di disagio, emarginazione sociale, degenerazione poli-tica, alienazione e assenza di prospettive psicologiche e sociali: per fare alcu-ni esempi, Torino nera (Lizzani, 1972), Torino violenta (Ausino, 1977), Laragazza di via Millelire (Serra, 1980), Vite di ballatoio (Segre, 1984), Portami via(Tavarelli, 1994), La seconda volta (Calopresti, 1994), Tutti giù per terra (Ferra-rio, 1997), Preferisco il rumore del mare (Calopresti, 1999).
Nodo del discorso, nella nostra prospettiva, non è la decostruzione diquesta immagine; piuttosto, è interessante discutere come la società e gli atto-ri locali abbiano recepito e affrontato la crisi di rappresentazione nel corsodegli ultimi decenni, nel difficile e lento tentativo di sostituire un immagina-rio postfordista a quello fordista. Una simile rilettura delle politiche urbanenon deve necessariamente andare molto indietro nel tempo, in quanto lapromozione dell’immagine è un fenomeno relativamente nuovo per la città.Durante gli anni Ottanta e i primi anni Novanta, in particolare, l’amministra-zione municipale non sembra interessarsi alla questione, mentre emergono iprimi importanti dibattiti promossi da rilevati attori e istituzioni culturali loca-li: Fondazione Giovanni Agnelli, IRES Piemonte, Compagnia di San Paolo.Vale la pena citare almeno quattro visioni geografiche fortemente discusse inquegli anni: MITO, ossia l’integrazione funzionale con Milano; GEMITO, ideaanaloga con l’inclusione di Genova; la Pianura meccatronica, intesa comeregione di expertise meccanica ed elettronica, e non solo automobilistica;Torino technocity, riferita all’idea di città delle tecnologie dell’informazione ecomunicazione, come in molte altre città degli anni Novanta1. Due importan-ti elementi relativi a queste immagini meritano attenzione.
Primo, occorre sottolineare la natura informale di questi dibattiti: inquanto sviluppati volontariamente da attori culturali, mancano di qualsiasilegittimazione da parte degli abitanti, ponendo il problema dell’autorizza-zione dell’immagine discusso da Short e Kim (1999). Ma, allo stesso tempo,sottolineano come già allora fosse urgente la questione di una politica di bran-ding e visioning per la città.
A L B E R T O V A N O L O
44
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 44
2. T O R I N O E L A C O S T R U Z I O N E D I I M M A G I N I U R B A N E
45
In secondo luogo, questi tentativi condividono un denominatore comu-ne: il tentativo di promuovere qualcosa di differente dalla FIAT. Durante glianni Ottanta, queste immagini (MITO, GEMITO, Pianura meccatronica) enfa-tizzano altre vocazioni manifatturiere per la città, mentre durante gli anniNovanta, e in particolare dopo la difficile crisi industriale del 1996, un massic-cio rifiuto di identità industriali comincia ad aggirarsi per la città. Si tratta diuna dinamica non nuova: basti pensare come i sentimenti popolari rispetto allavoro in FIAT siano progressivamente mutati di generazione in generazione:se negli anni Cinquanta era vissuto come prestigioso, il panorama era decisa-mente cambiato negli anni Ottanta e Novanta2 (Bocca, 2002). È in questoquadro che, in sintonia con altre città industriali in crisi, cominciano a diffon-dersi idee salvifiche di “alta tecnologia”, intesa come parola chiave dellatrasformazione, del rinnovamento, della rimodernizzazione (Vanolo, 2006).Alcuni esempi, certamente di valenza aneddotica, possono testimoniarequesta considerazione. Si pensi alla fortissima celebrazione, in quegli anni,dell’esperienza imprenditoriale di Vitaminic, pionieristica attività di venditasu internet di brani musicali, o alla celebrazione della decisione da parte diMotorola di localizzare un centro di ricerca e sviluppo a Torino: nella FIG. 2.1,il logo dell’impresa svetta alto sopra la città, resa riconoscibile dallo skylinedel suo principale simbolo, la Mole Antonelliana, mentre il testo sottostanteè piuttosto significativo riguardo alla percezione che le ICT rappresentino la
FIGURA 2.1Campagna pubblicitaria della Motorola a Torino
Fonte: http://www.itp-agency.org/stampa/pdf/risultati.pdf (ultimo accesso agosto 2008).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 45
speranza per fuggire all’eredità industriale della città. E ironicamente ilsimbolo della Motorola appare straordinariamente simile al cono di luce diBatman sopra la grigia, industriale, Gotham City; parallelamente, nellabrochure Torino. Una città da scoprire, ci si affrettava a dichiarare a carattericubitali: “Una città impegnata a convertire vecchie aree industriali trasfor-mandole in nuovi servizi per l’intera città”. Sono anni di marcata negazionedel volto industriale della città.
Tuttavia, l’urgenza di promuovere l’immagine della città diventa eviden-te alla fine degli anni Novanta, e in particolare dopo la forte crisi FIAT del 1996,accompagnandosi all’istituzionalizzazione di varie iniziative:– nel 1997 nasce l’agenzia regionale ITP (Investimenti Torino e Piemonte)con l’obiettivo di attrarre investimenti e incentivare la localizzazione di attoriesterni. Nel 2006 la sua attività è stata pesantemente riorganizzata attraversola fusione con l’IMA (Istituto regionale di marketing agroalimentare) e rino-minata Piemonte Agency for Investments, Export and Tourism;– sempre nel 1997 nascono le tre agenzie locali per il turismo (ATL 1, 2 e 3),consorzi pubblico-privati specializzati nella promozione di differenti parti delterritorio della Provincia. Dal 2006, le tre agenzie sono state fuse in TurismoTorino e Provincia;– parallelamente sorgono differenti organizzazioni specializzate in diversicampi tematici, e in particolare Torino Convention Bureau (nato nel 2000 conla finalità di attrarre e organizzare fiere ed esposizioni) e Torino FilmCommission (nata nel 2000 per attrarre set cinematografici fornendo variservizi).
Ma soprattutto il primo Piano strategico della città (Associazione TorinoInternazionale, 2000), approvato dopo due anni di lavoro, segna un fonda-mentale passo nella definizione di politiche di branding. Il piano, elaboratodall’omonima associazione (che includeva originariamente 60 partner – oggi120 – fra cui i sindaci dell’area metropolitana, università, fondazioni cultura-li, imprese private) si incentrava intorno a tre finalità (Pinson, 2000): in primoluogo, come testimoniato dal suo nome, di promuovere l’internazionalizza-zione, ma anche di sviluppare una visione comune per il futuro e di veicolar-la attraverso operazioni concrete (molte delle quali finanziate con FFoonnddii ssttrruutt--ttuurraallii oobbiieettttiivvoo 22 ##ssiicc??##). Una simile operazione ha aperto un ampio dibattitosulle modalità di integrazione della città nel contesto globale dopo un secolodi FIAT, durante il quale i caratteri fisici, sociali ed economici della città sonostati guidati dalle strategie e dai tassi di crescita della grande impresa (Danse-ro, Rota, 2006). E in quel momento di crisi FIAT, dinanzi alla concreta possi-bilità che alcune funzioni fossero rilocalizzate, la necessità di promuovere erappresentare diversificazioni e riconversioni economiche divenne il cuoredell’agenda politica urbana.
A L B E R T O V A N O L O
46
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 46
2. T O R I N O E L A C O S T R U Z I O N E D I I M M A G I N I U R B A N E
47
2.4Nuove immagini per la città
Nel 2006, con la seconda edizione del Piano strategico della città, gli interro-gativi circa le possibili nuove direzioni di sviluppo della città trovano formal-mente una risposta univoca. Si afferma chiaramente che l’obiettivo di fondosi riferisce alla realizzazione di una “società della conoscenza” (AssociazioneTorino Internazionale, 2006), e l’evento delle Olimpiadi invernali ha rappre-sentato una formidabile opportunità per promuovere una massiccia politicadi costruzione di immagini. Più nel dettaglio, la città ha predisposto unospecifico piano di comunicazione, gestito da un ufficio ad hoc chiamato Servi-zio di comunicazione centrale, con lo scopo di dar forma a una nuova “iden-tità visiva” per la città e rinnovare i materiali di marketing (Martina, 2006).Anche se materiali promozionali sono prodotti anche da altre istituzionicome la Regione Piemonte, il Servizio di comunicazione centrale rappresen-ta oggi il cuore dell’attività promozionale, istituzionalizzando completa-mente il processo di produzione di immagine, precedentemente piuttostoinformale e disperso fra vari attori locali. Il suo lavoro consiste nel produrremateriali di marketing, sia direttamente che per mezzo di agenzie pubblici-tarie esterne, e di promuoverne la circolazione nei media nazionali e interna-zionali. La città di Torino fornisce le principali linee guida attraverso il pianodi comunicazione, ma il Servizio centrale è ampiamente autonomo nellapropria attività.
Il tentativo di costruzione di una politica di branding è evidente ad esem-pio nell’esplicita scelta di riferirsi alla città, nei materiali internazionali, comeTorino, e non Turin, a prescindere dalla lingua (Owen, 2006) e di associarlofrequentemente a slogan come il celebre “Always on the move” (proposto daArmando Testa) per enfatizzare come qualcosa stia cambiando. Questomessaggio (e, dal 2006, “Passion lives here” e “Torino sempre più bella”,collocando esplicita enfasi su retoriche affettivo-sentimentali) è stato ampia-mente promosso attraverso molti media, oltre a 7.000 pannelli e poster e 3.000bandiere disseminate per la città.
Riguardo ai contenuti di queste operazioni di rimodellamento dell’im-magine urbana, una disamina dei principali materiali promozionali e dellepolitiche cittadine più recenti può facilmente rendere conto della centralitàdei temi della città postfordista, richiamati nel secondo paragrafo, nei discor-si relativi alla capitale piemontese. Più nel dettaglio, dal punto di vista deimateriali di marketing, sono stati qui considerati prodotti diffusi fra il 2006 eil 2008, incluse 20 brochure, il DVD promozionale Passion lives here, il CD foto-grafico fornito alle agenzie stampa straniere per la realizzazione di servizi sulcapoluogo piemontese, siti web ufficiali3.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 47
Innanzitutto, la celebrazione di immagini di vitalità sociale è ampiamen-te diffusa (FIG. 2.2). Nei materiali promozionali, ad esempio, abbondanoslogan del calibro di “A thousand opportunities for seeing friends, gettingtogether, dancing, staying out late” o “La gente anima i locali, le vinerie, iristoranti e i club che propongono musica jazz dal vivo o un dj set di tenden-za”. Questa immagine di vitalità urbana si è tuttavia accompagnata a sensi-bili processi di frammentazione e riorganizzazione dello spazio. Certamentealcune aree della città (essenzialmente Quadrilatero romano, Murazzi e SanSalvario) hanno vissuto intensi processi di riqualificazione (nonché gentrifi-cation) e si rivelano oggi dense di locali e club affollati. Non solo: anche se sitratta di fenomeni difficili da quantificare, alcune aree alla moda come iMurazzi hanno assunto negli ultimi anni (grazie in particolare alla popolaritàdella musica dei Subsonica) un importante ruolo nel playscape e nell’imma-ginario del divertimento delle generazioni più giovani a livello nazionale. Sitratta certamente di un fenomeno nuovo, poiché l’immaginario urbano diTorino si è tradizionalmente collocato in una direzione opposta: addirittu-ra, questo è implicitamente ammesso negli stessi materiali promozionaliladdove si afferma, nel sito Turismo Torino, «con le recenti Olimpiadi inver-nali Torino ha detto al mondo – che la pensava timida, seria e rigorosa – cheinvece ama divertirsi e far divertire i suoi ospiti»4. Si noti tuttavia come, nel
A L B E R T O V A N O L O
48
FIGURA 2.2Il playscape dei Murazzi
Fonte: Brochure Passion lives here (Città di Torino, 2007).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 48
2. T O R I N O E L A C O S T R U Z I O N E D I I M M A G I N I U R B A N E
49
caso delle periferie torinesi e in generale delle aree prima citate, la cittàabbia sperimentato un’ulteriore riduzione della vitalità notturna; da unpunto di vista sociale, le periferie sono spesso più deserte di un tempo, inquanto processi di concentrazione spaziale hanno portato a un accentuarsidegli squilibri fra aree centrali e periferiche nella vita giovanile notturna(Crivello, 2009).
La promozione del lato artistico e culturale della città ha parallelamentesperimentato uno sviluppo eccezionale (al riguardo, si vedano i dati pubbli-cati da L’Eau Vive, Comitato Giorgio Rota, 2008). Ad esempio, Torino vantauna vasta gamma di musei, circa quaranta, spesso localizzati nell’area centra-le (si ipotizza la realizzazione di un distretto museale centrale), molti deiquali di recente costituzione o espansione (Museo del cinema, Museo egizio).Ancora, la scena teatrale, l’arte contemporanea e la musica classica trovano aTorino situazioni di primo piano a livello nazionale. Tuttavia, anche in questocaso occorre introdurre alcune puntualizzazioni. Nel dibattito scientifico,ormai da decenni la distinzione fra cultura alta e bassa è oggetto di critiche,poiché sempre più oggetti di uso quotidiano, musica e arte si mescolano conelementi della cultura pop, folk o kitch, dando vita a processi di ibridazionetipici del postmoderno (Lash, Urry, 1994). Tuttavia, è intuitivo come vi sia unadifferenza profonda (in termini di status sociale, contenuti e audience) fraforme culturali tendenzialmente di nicchia, come la danza classica, e formedecisamente più popolari o consumistiche, come la fiera del cioccolato.Probabilmente un simile divario è particolarmente vivo a Torino e ricondu-cibile, nell’ipotesi che discuterò più avanti, a un’eredità culturale fordista. Inaltre parole, esiste una scena culturale alta, particolarmente sviluppata, affian-cata da un certo numero di eventi e manifestazioni che, pur celebrati comeculturali, sembrano perlopiù classificabili come operazioni imprenditoriali.Si pensi al caso di manifestazioni come Salone del gusto, Cioccolatò e Torinocapitale del libro. Certamente, da un punto di vista sociologico, cioccolato e(soprattutto) libro possono rappresentare prodotti con un elevato contenutodi conoscenza, ingegno e creatività, ma in una prospettiva di politica urbanapare forse ragionevole considerare simili esempi come operazioni di suppor-to alle produzioni locali che implicano la mercificazione e spettacolarizzazio-ne della cultura, intesa come trasformazione e incorporazione di contenuticulturali in prodotti di facile consumo (tradizioni e culture locali “vendute”assieme a cioccolato, vino, libri, biglietti di eventi) con la promozione dellacittà come effetto secondario. Si tratta di operazioni condotte con moltaprofessionalità e credibilità, celebrando ad esempio le tradizioni locali, laqualità, la creatività, il rispetto dell’ambiente, anche se evidentemente laconnessione fra cioccolato e creatività non è così intuitiva e immediata. Dalpunto di vista delle politiche urbane si tratta di operazioni di co-branding,
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 49
ossia costruzione di simboli e connessioni fra localizzazione geografica,prodotto e cultura (Kavaratzis, Ashworth, 2005). Anche questa particolareenfasi nella promozione della città attraverso la celebrazione di merci e formedi consumo riflette una certa attitudine culturale fordista (o postfordista, inte-sa come un’eredità e una reazione alla prospettiva fordista).
La celebrazione di spazi urbani e landmarks è anch’essa largamentepresente nel nuovo volto di Torino. Come discusso precedentemtente, lacostruzione di edifici firmati da architetti dello star system mondiale è gene-ralmente riconosciuta come un elemento per migliorare l’immagine di unacittà e l’attrazione di turisti e classe creativa, anche se ormai gli edifici di FrankGehry abbondano in giro per il pianeta, e molto difficilmente potranno assu-mere nuovamente il ruolo propulsivo sperimentato nel caso del Guggenheimdi Bilbao (Evans, 2003; Peck, 2005). Torino non è esente da questo orienta-mento, e negli ultimi anni sono sorte opere che portano la firma di ArataIsokazi, Renzo Piano, Gae Aulenti, Massimiliano Fuksas, alcune delle qualispesso di mero valore simbolico (alcuni edifici sono oggi pressoché inutiliz-zati: L’Eau Vive, Comitato Giorgio Rota, 2007). Il potere di simili trasforma-zioni simboliche è però importante: si pensi al caso del Lingotto, storico stabi-limento manifatturiero-fordista della FIAT, trasformato e celebrato a tempiodel consumo postfordista (centro commerciale, cinema, auditorium, centrofitness ecc.) grazie alle ristrutturazioni progettate da Renzo Piano (FIG. 2.3).Non a caso, alla voce “Torino contemporanea” nel sito promozionale Torinoplus compare proprio l’immagine della Bolla, sommità del luogo fordista(rappresentato tra l’altro come landmark negativo in film come Mafioso diLattuada, 1962 e Un colpo all’italiana di Collinson, 1969) convertito al post-moderno (celebrato e riadattato in film legati al pubblico giovane come SantaMaradona di Ponti, 2001)5. E, ancora, la città sperimenta oggi la contrapposi-zione fra sostenitori e detrattori del progetto di costruzione di un imponentegrattacielo che modificherà il tradizionale skyline urbano.
Merita un discorso differente la rappresentazione della varietà, della diffe-renza, del multiculturalismo: in questo caso raramente appare un’associazioneintrinseca con i temi della cultura. Nelle brochure e nei siti internet, occasio-nalmente sono rappresentate immagini e simboli di multietnicità e multicul-turalismo, ma solitamente in un contesto di benessere e giustizia sociale, rife-rendosi a situazioni di convivenza pacifica. Il tema del multiculturalismosembra quindi associarsi alle questioni del welfare e dell’integrazione sociale,e poco sembra aver a che fare con la cultura e la celebrazione della diversità.Al limite, la retorica della varietà culturale può sovrapporsi ai temi economici,ad esempio con slogan come “il valore della differenza”, riferito all’importan-za dell’imprenditorialità straniera. Anche in questo caso, la retorica torinesesembra allontanarsi da quella tipicamente postfordista (ad es., in merito al lega-
A L B E R T O V A N O L O
50
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 50
2. T O R I N O E L A C O S T R U Z I O N E D I I M M A G I N I U R B A N E
51
me fra multiculturalismo e creatività, cfr. Landry, Bianchini, 1995) per appari-re più prossima a quella tipicamente fordista, incentrata sulla gestione e valo-rizzazione dei fenomeni migratori. Nell’intero sito vetrina Torino plus, adesempio, non vi è praticamente nessun riferimento a questo tema, e la colora-tissima Porta Palazzo (vistosa zona di immigrazione extracomunitaria) è essen-zialmente celebrata come luogo del tradizionale mercato delle pulci6. Natu-ralmente, non mancano eccezioni ed esempi di forme di eventi e consumolegati all’altromondismo: per citarne due, la rassegna Terramadre, incentratasui temi del cibo e alimentazione, e quella musicale Gong.
In generale tuttavia la “dimensione umana” (Florida, 2002) della cittàpostfordista, intesa come il potenziale creativo degli abitanti, è raramenteconsiderata, e comunque in secondo piano rispetto ai temi degli spazi fisici,della produzione e del consumo. Fatta eccezione per gli aspetti più economi-ci e vicini ai temi della produzione (come nel caso del design), non vi è adesempio una particolare celebrazione di Torino come città in cui artisti ostudiosi possono trovare spazio di espressione (al di là del fatto che questosia vero o meno). Ad esempio, nei materiali promozionali della città, Univer-sità e Politecnico occupano poco spazio come elementi creativi o culturalidella città; più sovente, essi sono posti al centro di discorsi finalizzati a discu-
FIGURA 2.3Il Lingotto come simbolo postindustriale
Fonte: brochure Always on the move (Città di Torino, 2006).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 51
tere i nuovi spazi fisici della città (ad es. l’espansione del Politecnico) o laproduzione di alta tecnologia per le imprese. Si tratta tuttavia di un quadromutevole, perché proprio negli ultimi mesi il Politecnico ha progressivamen-te posto enfasi sui programmi di internazionalizzazione e sull’attrazione distudenti stranieri, una politica particolarmente esplicita nelle immagini dellebrochure o del sito internet dell’istituzione.
Infine, per quanto riguarda il tema degli eventi, la città si è rivelata parti-colarmente attenta. Al di là dell’ovvio riferimento alle Olimpiadi invernali del2006, Torino negli ultimi anni sembra pervasa dalla frenesia di presentaremomenti di straordinario interesse per un vasto audience internazionale. Ècosì scattata una frenetica rincorsa all’evento che, se da un lato ha permessol’attrazione di manifestazioni di indubbio rilievo (Universiadi, Congressomondiale degli architetti), dall’altro lato ha peccato di esagerazione quandoeventi di palese rilievo marginale (dal punto di vista della vastità del potenzialeaudience) sono stati celebrati in maniera forse eccessiva (ad es. campionati discacchi, campionati di scherma; cfr. a questo proposito L’Eau Vive, Comita-to Giorgio Rota, 2007).
2.5Ipotesi conclusive
È naturalmente impossibile affermare scientificamente se una città si presentio meno postfordista: le percezioni, in particolare con riferimento a un oggettocomplesso come uno spazio urbano, saranno molteplici, così come innumere-voli saranno i possibili punti di vista, le prospettive, le dimensioni del cambia-mento. Torino, negli anni, ha certamente sperimentato la transizione da unimmaginario urbano a qualcos’altro, fortemente differente, che possiamo gene-ricamente etichettare come postfordista. A prima vista, nel caso di Torinotutti gli elementi caratterizzanti la retorica dei discorsi riguardanti la cittàpostfordista sono stati oggetto di trasformazioni spaziali, rappresentazioni enarrazioni. Si tratta della celebrazione della città come luogo di arte e cultura,di interazione sociale, di eventi, di consumo, di architetture di prestigio, disimboli dell’economia postfordista. Tuttavia, il lungo discorso intrapreso nellepagine precedenti era teso a evidenziare come, nelle tracce di queste rappre-sentazioni, siano ancora ben visibili alcuni tratti di un’eredità culturale fordi-sta. In questo senso, Torino non è certamente una città non Fordista: ne èpiuttosto un’evoluzione, che incorpora elementi di continuità e discontinuità.Rimane una città industriale, e l’accordo FIAT-Chrysler del 2009 ha certamen-te restituito molta fiducia al volto manifatturiero della città, riportandola peral-tro a un immaginario di importanza mondiale nelle reti dell’industria automo-bilistica. Ma, a un livello più sottile, si può comunque notare come molte delle
A L B E R T O V A N O L O
52
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 52
2. T O R I N O E L A C O S T R U Z I O N E D I I M M A G I N I U R B A N E
53
immagini proposte nelle politiche e nei materiali di marketing abbiano sempreposto particolare enfasi sul tema, caro al Fordismo, della produzione. Questotraspare ad esempio con riferimento al tema della creatività: a differenza dellaretorica che permea altre città e altri discorsi urbani, non pare qui emergereun particolare interesse per il potenziale innovativo legato all’attirare talenti,artisti, culture differenti. L’enfasi pare piuttosto incentrata sul fornire adegua-te forme di consumo culturale, da cui il discusso divario fra offerte “intellet-tuali” (musica classica) e offerte decisamente più popolari (prodotti del gusto,libri). In generale, mentre nei discorsi di Florida e dei teorici della “città crea-tiva” (che rappresenta peraltro uno dei dodici assi di intervento del Secondopiano strategico della città) si pone enfasi sulla necessità di attrarre la classecreativa come veicolo di innovazione, nel caso torinese la classe pare suscitareinteresse come potenziale nicchia di mercato, in grado di assimilare passiva-mente la produzione, in questo caso l’offerta culturale locale.
Dal punto di vista delle politiche urbane, una simile riflessione non impli-ca nessuna particolare critica o valutazione di merito: semplicemente, Tori-no sta sviluppando una sua peculiare nuova immagine, attraverso specificidiscorsi e retoriche, i cui esisti sono ancora difficili da prevedere. D’altrocanto, imprevedibili sono i modi di costruzione dell’immaginario collettivo diuna città. Si tratta solamente di un aneddoto, ma mi sono recentementesorpreso nel veder associata Torino all’immagine di città solare e mediterra-nea. Mi è accaduto a Helsinki chiacchierando con un non-addetto ai lavori: inFinlandia, Torino è una popolare marca di pasta7, da cui l’idea di città del Sud.Il potere dell’immaginario FIAT qui è stato scalzato dal potere degli spaghetti,perlomeno fra gli scaffali dei supermercati.
Note
1.@Riguardo a queste immagini si veda Fondazione Giovanni Agnelli (1984); Rolfo (1993);IRES Piemonte (1994) e il saggio di De Rossi e Durbiano (2006).
2.@Nel 1984 i Negazione, gruppo musicale di culto della scena torinese, cantavano «Nellestrade, nelle piazze, nei palazzi, i bambini, madri a casa, operai, tanti soldi, una casa, un lavo-ro, tutti pazzi, tutti pazzi, tutti pazzi. Non è questa la mia vita, tutto questo non fa per me».
3.@Cfr. i siti http://www.torinoplus.it; http://www.turismotorino.org; http://www.torino-piemonte.it (ultimo accesso marzo 2008).
4.@Cfr. il sito http://www.turismotorino.org (ultimo accesso marzo 2008).5.@Un altro esempio cinematografico potrebbe riferirsi alle diverse rappresentazioni dei
Murazzi in un film fordista come Quelli della calibro 38 di Dallamano, 1976, e in uno postfordi-sta come Tandem di Pellegrini, 2000.
6.@Si noti tra l’altro il valore simbolico del mercato delle pulci, inteso essenzialmente comeluogo di nostalgia postmoderna (Crewe, Gregson, Brooks, 2003).
7.@Cfr. il sito http://www.torino.fi (ultimo accesso agosto 2008).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 53
Bibliografia
AMARI G. (1980), Torino come Detroit: capitale dell’automobile, 1895-1940, Cappelli,Bologna.
AMIN A. (1994), Postfordism: Models, Fantasies and Phantoms of Transition, in Id. (ed.),Postfordism. A Reader, Blackwell, Oxford, pp. 1-39.
ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE (2000), Il piano strategico della città, Asso-ciazione Torino Internazionale, Torino, http://www.torino-internazionale.org(ultimo accesso marzo 2010).
ID. (2006), Secondo piano strategico dell’area metropolitana di Torino, Torino,http://www.torino-internazionale.org.(ultimo accesso marzo 2010).
BOCCA G. (2002), FIAT. Quando per i torinesi era la mamma-padrona, in “La Repubbli-ca”, 10 ottobre, http://www.larepubblica.it (ultimo accesso agosto 2008).
CASTAGNOLI A. (1998), Da Detroit a Lione: trasformazione economica e governo locale aTorino (1970-1990), FrancoAngeli, Milano.
CHATTERTON P., HOLLANDS R. (2002), Theorising Urban Playscapes: Producing, Regu-lating and Consuming Youthful Nightlife City Spaces, in “Urban Studies”, 39, 1,pp. 95-116.
CITTÀ DI TORINO (a cura di) (1982), Torino-Detroit: due città a confronto, Città di Tori-no, Torino.
CREWE L., GREGSON N., BROOKS K. (2003), Alternative Retail Spaces, in A. Leyshon, R. Lee,C. C. Williams (eds.), Alternative Economic Spaces, Sage, London, pp. 74-106.
CRIVELLO S. (2009), Torino di notte: politiche urbane, consumo e dinamiche spaziali nelplayscape della città, in “Archivio di Studi Urbani e Regionali”, 95, pp. 112-35.
CYBRIWSKY R. (1999), Changing Patterns of Urban Public Space. Observations andAssessments from the Tokyo and New York Metropolitan Areas, in “Cities”, 16, 4,pp. 223-31.
DANSERO E., ROTA F. S. (2006), Torino: la città, la fabbrica, il paesaggio industriale. Unalettura alla luce dei recenti processi di trasformazione urbana, in E. Dansero,A. Vanolo, Geografie dei paesaggi industriali in Italia. Riflessioni e casi studio aconfronto, FrancoAngeli, Milano, pp. 245-67.
DE ROSSI A., DURBIANO G. (2006), Torino 1980-2011. Le trasformazioni e le sue immagi-ni, Allemandi, Torino.
DOBERS P. (2003), Image of Stockholm as an IT City: Emerging Urban Entrepreneurship,in C. D. Hjorth (ed.), New Movements in Entrepreneurship, Edward Elgar,pp. 200-17.
ESSER J., HIRSCH J. (1989), The Crisis of Fordism and the Dimensions of a “Postfordist”Regional and Urban Structure, in “International Journal of Urban and RegionalResearch”, 13, 3, pp. 417-36.
EVANS G. (2003), Hard-branding the Cultural City. From Prado to Prada, in “Interna-tional Journal of Urban and Regional Research”, 27, 2, pp. 417-40.
FEATHERSTONE M. (1991), Consumer Culture and Postmodernism, Sage, London.FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI (1984), Tecnocity, Fondazione Giovanni Agnelli,
Torino.
A L B E R T O V A N O L O
54
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 54
2. T O R I N O E L A C O S T R U Z I O N E D I I M M A G I N I U R B A N E
55
FLORIDA R. (2002), The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work,Leisure, Community, and Everyday Life, Basic Books, New York.
ID. (2003), Cities and the Creative Class, in “City & Community”, 2, 1, pp. 3-19.HALL C. M. (1992), Hallmark Tourist Events: Impacts, Management and Planning,
Belhaven, London.HARVEY D. (1987), Flexible Accumulation through Urbanization: Reflections on “Post-
modernism” in the American City, in “Antipode”, 19, 3, pp. 260-86.ID. (1989), The Condition of Postmodernity, Blackwell, Oxford.HILLER H. (2000), Mega-events, Urban Boosterism and Growth Strategies: An Analysis
of the Objectives and Legitimations of the Cape Town 2004 Olympic Bid, in “Inter-national Journal of Urban and Regional Research”, 24, 2, pp. 439-58.
IRES PIEMONTE (1994), Reti. Telecomunicazioni in Piemonte, Rosenberg & Sellier, Torino.KAVARATZIS M., ASHWORTH G. J. (2005), City Branding: An Effective Assertion of Iden-
tity or a Transitory Marketing Trick?, in “Tijdschrift voor Economische en SocialeGeografie”, 96, 5, pp. 506-14.
LANDRY C. (2006), The Art of City Making, Earthscan, London.LANDRY C., BIANCHINI F. (1995), The Creative City, Demos, London.LANZANI A. (1996), Tra analisi sociale e indagine morfologica, in A. Clementi, G.
Dematteis, P. C. Palermo (a cura di), Le forme del territorio italiano, Laterza,Roma-Bari, pp. 186-206.
LASH S., URRY J. (1994), Economies of Signs & Space, Sage, London.L’EAU VIVE, COMITATO GIORGIO ROTA (2007), Senza rete. Ottavo rapporto annuale su
Torino, Guerini e Associati, Milano.ID. (2008), Solista e solitaria 2008. Nono rapporto annuale su Torino, Guerini e Asso-
ciati, Milano.LEVER W. F. (2001), The Postfordist City, in R. Paddison (ed.), Handbook of Urban Stud-
ies, Sage, London, pp. 273-83.MARTINA A. (2006), Comunicare la città, Paravia, Torino.MASSEY D., QUINTAS P., WIELD D. (1992), High Tech Fantasies. Science Parks in Society,
Science and Space, Routledge, London.MAYER M. (1994), Post-fordist City Politics, in A. Amin (ed.), Postfordism. A Reader,
Blackwell, Oxford, pp. 316-37.OWEN J. (2006), From ‘Turin’ to ‘Torino’: Olympics Put New Name on the Map, in
“National Geographic News”, http://news.nationalgeographic.com (ultimoaccesso giugno 2010).
PECK J. (2005), Struggling with the Creative Class, in “International Journal of Urbanand Regional Research”, 29, 4, pp. 740-70.
PINSON G. (2002), Political Government and Governance: Strategic Planning and theReshaping of Political Capacity in Turin, in “International Journal of Urban andRegional Research”, 26, 23, pp. 477-93.
RICHARDS G., WILSON J. (2004), The Impact of Cultural Events on City Image: Rotter-dam, Cultural Capital of Europe 2001, in “Urban Studies”, 41, 10, pp. 1931-51.
ROLFO S. (1993), The Italian Machine Tool Industry, CERIS, Torino.ROSSI U., VANOLO A. (2010), Geografia politica urbana. Una prospettiva critica, Laterza,
Roma-Bari.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 55
REVELLI M. (1989), Lavorare in FIAT, Garzanti, Milano.SANDERCOCK L. (2003), Cosmopolis II. Mongrel Cities for the 21st Century, Continuum,
London.SCOTT A. J. (1988), New Industrial Spaces, Pion, London.SHAW D. V. (2001), The Post-industrial City, in R. Paddison (ed.), Handbook of Urban
Studies, Sage, London, pp. 284-95.SHIELDS R. (1991), Places on the Margin. Alternative Geographies of Modernity, Rout-
ledge, London.SHORT J. R., KIM Y.-H. (1998), Urban Crisis/Urban Representations: Selling the City in
Difficult Times, in T. Hall, P. Hubbard (eds.), The Entrepreneurial City. Geogra-phies of Politics, Regime and Representation, John Wiley & Sons, Chichester,pp. 55-75.
IDD. (1999), Globalization and the City, Pearson, Harlow.STEAD D. (2003), Is Urban Living Becoming more Attractive?, in “Local Environment”,
8, 5, pp. 559-65.STORPER M., VENABLES A. J. (2004), Buzz: Face-to-Face Contact and the Urban Economy,
in “Journal of Economic Geography”, 4, 4, pp. 351-70.TEMELOVA J. (2007), Flagship Developments and the Physical Upgrading of the Post-
socialist Inner City: the Golden Angel Project in Prague, in “Geografiska AnnalerB”, 89, 2, pp. 169-81.
VANOLO A.(2006), Le differenti immagini della base economica urbana: vocazioneindustriale e alta tecnologia a Helsinki e Torino, in P. Terna e G. Russo (a curadi), Produrre a Torino, Otto, Torino, pp. 165-95.
ID. (2008a), Internationalization in the Helsinki Metropolitan Area: Images, Discours-es and Metaphors, in “European Planning Studies”, 16, 2, pp. 229-52.
ID. (2008b), The Image of the Creative City: Some Reflections on Urban Branding inTurin, in “Cities”, 25, 6, pp. 370-82.
ZUKIN S. (1995), The Cultures of Cities, Blackwell, Oxford.
A L B E R T O V A N O L O
56
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 56
57
3La FIAT e Torino: lavoro, relazioni
industriali e immagini della città operaiadi Paolo Giaccaria
3.1Torino oltre la oonnee--ccoommppaannyy ttoowwnn
La rappresentazione di Torino come città fordista è ben nota in letteratura sindagli anni Cinquanta, ed è divenuta negli ultimi due decenni una sorta di“convitato di pietra” con cui tanto gli analisti dell’economia locale quanto gliamministratori e i professionisti delle politiche di sviluppo hanno dovuto farenecessariamente i conti. Indubbiamente, nel caso di Torino, l’organizzazio-ne ford-taylorista dell’accumulazione e la sua regolazione sociale si sonointegrate come in un caso da manuale. Per quanto riguarda l’organizzazionedella produzione, si è assistito alla costruzione di grandi stabilimenti integra-ti (il Lingotto, Mirafiori, la Lancia di Chivasso), alla realizzazione di automo-bili di gran successo per il mercato di massa, alla creazione di un indotto dipiccole imprese altamente dipendenti dalla FIAT, operanti come “repartiesterni”. Dal lato della regolazione sociale, sono stati gli anni dell’immigra-zione dall’Italia meridionale e orientale, dell’edilizia residenziale pubblica,dei quartieri dormitorio, delle lotte e delle occupazioni operaie, dei conflittifra tute blu e colletti bianchi, della collaborazione fra l’amministrazione citta-dina e la direzione della FIAT.
Questo processo di crescita, che ha portato l’area metropolitana a inclu-dere oltre 1.800.000 abitanti nel 1971, è rallentato nel corso degli anni Ottantarovesciandosi in una profonda crisi dell’identità manifatturiera torinese. Siapre così il secondo periodo nella storia della manifattura torinese, in cui allecertezze si sostituisce l’ansia, allo sviluppo la recessione, alla prosperità ladisoccupazione. Anzitutto, questa crisi deve essere pensata con riferimentoalla profonda trasformazione delle dinamiche competitive del settore chespiega come l’immagine tradizionale one-company town di Torino si sia alme-no in parte modificata. Nell’adattarsi alle mutate regole della produzione edella competizione infatti la FIAT non poteva che cambiare profondamentel’intera struttura manifatturiera e territoriale torinese che era stata plasmatasulla sua organizzazione e sulle sue esigenze.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 57
Sotto questa luce, possiamo identificare almeno tre radicali cambiamen-ti nel rapporto fra Torino e il suo passato fordista (Conti, Giaccaria, 2001;Giaccaria, 2010). Anzitutto, la produzione è stata delocalizzata sempre piùnell’Italia meridionale, così che dell’antico ciclo produttivo verticalmenteintegrato sono rimaste nel Torinese solamente le lavorazioni a più alto valoreaggiunto, per ciò che riguarda tanto i componenti quanto l’assemblaggio deimodelli più prestigiosi. In secondo luogo, sono mutati radicalmente i rappor-ti fra FIAT e il suo indotto. Negli anni Ottanta e Novanta si è assistito a unaradicale selezione dei primi fornitori. Di conseguenza, si è verificata unadrastica riduzione del loro numero, parzialmente compensata da una maggio-re responsabilizzazione dei primi fornitori superstiti, in termini di partecipa-zione all’innovazione e alla progettazione dei componenti. Il terzo punto dirottura riguarda il ruolo crescente del design e della progettazione. I cambia-menti sopraggiunti nel settore autoveicolistico hanno reso necessaria unasempre maggiore integrazione fra ricerca, innovazione, design, progettazionee produzione. In particolare, il design e la progettazione svolgono il ruolo ditrait d’union fra innovazione e produzione. Da questo punto di vista, la situa-zione di Torino è quanto mai peculiare. Nell’area metropolitana torineseinfatti si trova una delle più alte concentrazioni mondiali di designer e proget-tisti. Soprattutto, a Torino sono presenti studi e imprese indipendenti che nonappartengono a FIAT, sebbene vi siano legati da lunghe consuetudini. Si trat-ta dei nomi storici del design automobilistico, come Pininfarina, Bertone,Giugiaro, Idea e altri.
Dal punto di vista dell’immaginario evocato dal binomio FIAT-Torino, lacrisi del settore automobilistico ha fatto sì che la metafora della città dell’au-to sia divenuta inadeguata per descrivere le trasformazioni della manifatturatorinese. Così, la ricerca di nuove soluzioni e nuove politiche per il rilanciodella competitività del capoluogo subalpino ha condotto all’elaborazione diimmagini nuove sin dagli anni Novanta (Bagnasco, 1986, 1990; Tendenze, 1991;IRES, 1994; Bruzzone, 1993; Fondazione Giovanni Agnelli, 1995) culminandoprima nel progetto di Torino Internazionale (Associazione Torino Interna-zionale, 2000, 2006), volto a riposizionare Torino nelle gerarchie urbane euro-pee, e successivamente nella messa a punto di un sistema articolato di piat-taforme tecnologiche che dovrebbero restituire un’immagine più complessadella tradizione manifatturiera torinese e piemontese.
Con un’interpretazione forse superficiale delle trasformazioni del capi-talismo contemporaneo, alcuni hanno prospettato un’immagine decisamen-te postindustriale della manifattura torinese ed è stata auspicata la recisionedei rapporti con questa forte tradizione, in favore di un’improbabile terzia-rizzazione dell’economia locale e specializzazione in “servizi avanzati”, inparticolare nel campo della information and communication technology.
P A O L O G I A C C A R I A
58
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 58
3 . L A F I A T E T O R I N O
59
In altri casi la vocazione manifatturiera dell’area torinese è stata riconosciuta,volgendo però l’attenzione a settori non più legati alla veicolistica, in partico-lare nell’aerospazio e nel settore dei beni strumentali. Negli ultimi anni, ilcatalogo delle proposte è stato quanto mai variegato. L’immagine più inte-ressante è quella della Pianura meccatronica, affermatasi negli anni Ottantain seguito alla scoperta di una concentrazione di produttori di beni strumen-tali senza confronto in Europa (Rolfo, 1993). In tempi più recenti, è statocaldeggiato lo sviluppo di settori ad alta tecnologia come condizione essen-ziale per l’ammodernamento della struttura manifatturiera torinese: si pensiall’ambizioso progetto del “polo delle telecomunicazioni” (IRES, 1994) o allanascita, nell’Eporediese, di un distretto tecnologico specializzato nelle biotec-nologie. Un altro tentativo di confrontarsi con la transizione dal fordismoverso una nuova organizzazione della produzione è rappresentato dalle rifles-sioni su un ipotetico distretto tecnologico dell’automobile (Enrietti, 1999).Queste visioni assumono l’idea che la specializzazione automobilistica defi-nisca tuttora l’identità manifatturiera torinese e che ci si trovi di fronte a unaprofonda riorganizzazione della produzione e delle relazioni, tanto fra impre-se quanto all’interno delle imprese. Per molti aspetti, questa immagine ècoerente con il quadro descritto dalle teorie del postfordismo. La FIAT infattiviene descritta come un’impresa a rete, dotata di una prospettiva e di strate-gie globali ma anche di una mente e di un cuore locali, profondamente radi-cati nel torinese. In questa prospettiva l’attenzione viene concentrata sul fattoche le decisioni – in particolare per quanto riguarda i rapporti di fornitura –sono tuttora accentrate a Torino. È enfatizzata, in secondo luogo, l’autonomiae la capacità innovativa di numerosi suoi fornitori, alcuni dei quali sono dive-nuti imprese leader nella produzione di certi componenti. In questa maniera,si invalidano due presupposti dell’organizzazione fordista: la prevalenza dirapporti gerarchici tra la FIAT e i suoi fornitori e la dipendenza dell’interaeconomia metropolitana dalle decisioni dell’impresa dominante. La disconti-nuità con l’organizzazione fordista è ulteriormente accentuata dall’attenzio-ne dedicata ai rapporti collaborativi fra piccole e medie imprese. Secondo gliesegeti del distretto dell’auto, insieme ai centri di ricerca locali, alla FIAT e aiprimi fornitori, queste PMI formano una rete fra le cui maglie si sviluppanoinnovazioni che rendono il distretto competitivo sul mercato mondiale. Inquesta prospettiva si è mosso, ad esempio, il progetto From Concept to Car,promosso dal 2003 dalla Camera di commercio torinese e finalizzato a costi-tuire un portfolio di fornitori specializzati che possa essere promosso inter-nazionalmente attraverso iniziative volte a penetrare la filiera ormai globaliz-zata della veicolistica. Sicuramente la metafora del distretto dell’auto nelle suediverse declinazioni ha catalizzato l’attenzione degli studiosi producendoun’ampia letteratura di indubbio interesse (Bianchi, Enrietti, Lanzetti, 2001;
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 59
Whitford, Enrietti, 2005). Tuttavia, l’enfasi posta in questa letteratura sull’in-cessante modificarsi delle relazioni tra la FIAT e i suoi fornitori rischia di ridur-re l’attenzione ad altri elementi che hanno giocato un ruolo fondamentale neldefinire storicamente l’immagine di Torino come città fordista per antono-masia. Si pensi alle relazioni con la pubblica amministrazione e in particolarecon la forza lavoro, due momenti essenziali nella definizione tanto del mododi regolazione quanto del regime di accumulazione propri di Torino. Perquesta ragione, la nostra lettura del rapporto tra FIAT e Torino non si incen-trerà tanto sulle relazioni tra la multinazionale torinese e l’indotto locale difornitori – per quanto ne riconosciamo l’importanza assoluta (Giaccaria, 1999,2010) – quanto piuttosto sulle relazioni tra organizzazione e mercato del lavo-ro. In fin dei conti, il ford-taylorismo è prima di tutto un modo di organizza-re la forza lavoro, così come la presenza di una forte e dinamica tradizioneoperaia costituisce un elemento imprescindibile dell’immagine di Torinocome città operaia. Per quanto riguarda l’organizzazione del discorso,manterremo la tradizionale ripartizione in due periodi, il primo dei quali vadalla fondazione della FIAT al volgere del XX secolo sino alla crisi degli anniSettanta e il secondo dalla fine degli anni Settanta, primi anni Ottanta, sino aigiorni nostri. Sebbene questa ripartizione corrisponda grossomodo allacontrapposizione tra fordismo e postfordismo, la nostra ipotesi di ricerca èche questa dicotomia non renda giustizia della complessità delle dinamicheche intercorrono tra organizzazione del lavoro e mercato del lavoro. In parti-colare la nostra prima ipotesi è che la territorializzazione fordista del rappor-to FIAT-Torino abbia raggiunto il proprio zenit e il proprio nadir in due speci-fici decenni, gli anni Sessanta e gli anni Novanta. La seconda ipotesi,strettamente correlata alla prima, è che in entrambi i periodi sia stato all’ope-ra una sorta di ritardo cognitivo tra il momento in cui le innovazioni organiz-zative venivano introdotte e quello in cui divenivano pienamente manifeste.In particolare, il nostro punto è che, sebbene l’organizzazione ford-tayloristadel lavoro sia stata introdotta in teoria sin dai primi decenni del XX secolo, lasua realizzazione effettiva debba essere posticipata agli anni Sessanta. Analo-gamente, molti dei processi di deterritorializzazione che sono associati all’e-poca postfordista e che diventano chiari solamente negli anni Novanta, comel’automazione e l’organizzazione flessibile del lavoro, datano agli anni Settan-ta, riducendo di fatto l’epoca fordista a circa due decenni.
Nel fare questo, cercheremo di mostrare come il ruolo dell’organizzazio-ne del lavoro e della presenza di un mercato del lavoro specializzato vadanoben oltre i luoghi comuni imposti dall’immaginario della one-company town,con la sua ipersemplificazione delle relazioni tra capitale e lavoro caratteristi-che del ford-taylorismo. Come vedremo, la rigida separazione tra lavoratorinon qualificati, operai specializzati, tecnici e impiegati non sembra in grado
P A O L O G I A C C A R I A
60
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 60
3 . L A F I A T E T O R I N O
61
di dare conto di come l’organizzazione del lavoro interagisca con il mercatodel lavoro e con la produzione dell’immagine della città operaia. In partico-lare due aspetti di questo processo sono particolarmente rilevanti: la relazio-ne tra organizzazione della produzione e processi di apprendimento e ilrapporto tra questi e le relazioni industriali e sindacali. Sebbene questi dueambiti possano essere separati dal punto di vista teorico, il legame tra le duedinamiche è in realtà forte e indivisibile, dal momento che la FIAT ha tradizio-nalmente perseguito i propri obiettivi di crescita attraverso strategie combi-nate che mescolano senza soluzione di continuità organizzazione del lavoro edella produzione.
3.2Verso il fordismo (lleennttoo ppeeddee)
Un’analisi che intenda chiarire il ruolo dell’organizzazione e del mercato dellavoro nel produrre e definire l’immaginario fordista torinese non può nonprendere le mosse dal contesto, e dalle competenze, da cui l’industria auto-mobilistica torinese ha mosso i suoi primi passi. Già prima della fine del XIX
secolo, le industrie elettriche e meccaniche avevano largamente affiancato esostituito il tessile – in particolare la lavorazione del cotone e della seta – comeprincipali motori della crescita economica del Piemonte, attraendo capitalilocali sempre maggiori, alla ricerca di nuovi e più profittevoli mercati. Perquanto attiene direttamente il mercato del lavoro, l’area torinese già possede-va una classe di lavoratori metalmeccanici altamente qualificati che affondavale proprie radici nella presenza degli arsenali sabaudi e nella manifattura dibiciclette e carrozze. Inoltre dalla metà del XIX secolo, Torino ospitava un grannumero di scuole tecniche specializzate che erano necessarie per la formazio-ne di una classe di manager intermedi e di operai specializzati di cui potevanobeneficiare i nuovi settori dell’economia regionale: esattamente le risorsegiuste al momento giusto (Rugafiori, 1999, p. 179). Si tratta di un nucleo diconoscenze e di competenze che si è riprodotto in circa 150 anni di storia indu-striale di Torino e del Piemonte, attraverso un processo territorialmente radi-cato di apprendimento e una continua fecondazione reciproca di conoscenzacodificata, rappresentata dalle scuole di ingegneria presenti nell’area, e diconoscenza tacita, incarnata in una classe di operai specializzati i cui epigoniancora affollano gli atelier dei grandi designer e carrozzieri torinesi. A partireda questa tradizione, incessantemente riprodotta nel tempo attraverso unasequela di specializzazioni e di trasformazioni, la nostra analisi si incentreràsulle relazioni tra la FIAT e queste competenze, incarnate appunto nella forzalavoro e nel mercato del lavoro, cercando di evidenziarne l’ambiguità di questerelazioni, al tempo stesso di dipendenza e di antagonismo.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 61
Sebbene la presenza torinese della FIAT sarà per sempre associata con l’in-troduzione in Italia e in Europa del ford-taylorismo, la sua adozione dei prin-cipi dell’organizzazione scientifica del lavoro è stata in realtà meno diretta diquanto si possa ipotizzare e certamente meno pervasiva. Sebbene la storiaufficiale enfatizzi il ruolo dei viaggi compiuti da Giovanni Agnelli senior aDetroit nel 1906 e nel 1911 e la sua ammirazione per il Modello T della Ford –un’ammirazione che ispirerà il lancio della FIAT Zero, un’autovettura checostava solamente 7.000 lire, meno della metà delle vetture di fascia media deisuoi concorrenti italiani – non mancano le evidenze storiche che riducono laportata della fascinazione fordista del fondatore della FIAT. Ad esempio,Volpato (2004) argomenta che, nel caso della FIAT, non si può parlare real-mente di produzione di massa prima degli anni Trenta: la prima auto indiriz-zata a un mercato più ampio, la 508 Balilla, risale al 1932 e la prima vera autoeconomica che portava il marchio FIAT fa la sua comparsa solamente nel 1936(la 500 soprannominata Topolino per la sua somiglianza a Mickey Mouse).Soprattutto, il tentativo di costruire un mercato di massa per l’auto non corri-sponde necessariamente all’applicazione dei principi dell’organizzazionescientifica del lavoro in fase di produzione. Nello stabilimento del Lingotto –nell’immaginario collettivo uno dei totem dell’architettura industriale fordi-sta – la produzione della Topolino era organizzata in dipartimenti con l’as-semblaggio organizzato su tre linee parallele, rispettivamente dedicate aimotori, agli chassis e alle carrozzerie. In particolare, la macchina aveva unavera e propria struttura su cui i componenti, il motore e la carrozzeria veniva-no montati in sequenza da gruppi di lavoratori. Queste équipe sono una carat-teristica tipica di un’organizzazione del lavoro che si fonda ancora su compe-tenze di tipo artigianale, in contrapposizione alle stazioni di lavoroindividuale che caratterizzano le linee di assemblaggio nella produzione dimassa. Ogni équipe era composta da operai con un’ampia gerarchia dicompetenze: il caposquadra, coadiuvato da operai altamente qualificati e, aseguire, da operai semispecializzati, non qualificati e apprendisti. Questecategorie di lavoratori erano soggette alle regole proprie delle corporazioniartigiane. Per passare da un grado a quello successivo, l’aspirante era obbli-gato a produrre una prova evidente delle sue capacità (il “capolavoro”), giudi-cata dai componenti più vecchi ed esperti della squadra, una prova di abilitàche in FIAT era ancora comune negli anni Settanta (Volpato, 2004, p. 41).Questa tesi circa la resilienza di forme di organizzazione prefordiste è corro-borata dai dati disponibili circa la produttività media dei lavoratori, che rima-ne stabile attorno alle due vetture per anno per quasi quarant’anni, sino allametà degli anni Cinquanta. Solo a quel punto la produttività incomincia acrescere esponenzialmente grazie all’applicazione dei principi dell’organiz-zazione scientifica del lavoro, raggiungendo e successivamente superando la
P A O L O G I A C C A R I A
62
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 62
3 . L A F I A T E T O R I N O
63
soglia dei sette veicoli per lavoratore nel 1960. In altri termini, non sarebbetroppo eccentrico sostenere che per la prima metà della storia industrialedella FIAT la produzione è rimasta saldamente ancorata alle sue origini arti-giane e che le competenze e i valori (il gusto e l’orgoglio per il “lavoro benfatto”) che erano tradizionalmente radicati nella forza lavoro torinese hannogiocato un ruolo centrale nella crescita della multinazionale.
La prima importante rottura con questa tradizione avviene negli anniSessanta, quando la standardizzazione crescente nella produzione, sino adallora limitata alla fase di assemblaggio, iniziò a interessare le fasi di produ-zione delle singole parti. Le macchine utensili in questo periodo vengonoriprogettate per eseguire una singola lavorazione su un singolo componentecon un solo utensile. In questa maniera, le competenze richieste al singolooperatore – un tempo in grado di compiere differenti processi con numerosistrumenti – si riducono costantemente, abbattendo le sue possibilità di avan-zamento professionale e di mobilità sociale all’interno della fabbrica. Mentrein precedenza il gruppo di lavoro appariva come un organismo dalle moltefacce che compendiava differenti competenze e qualifiche, ora l’organizza-zione del lavoro si fonda su una dicotomia ferocemente polarizzata. Da unlato, andava producendosi una legione di operai non qualificati, spesso immi-grati da altre regioni, con un bagaglio tecnico scarso o inesistente, impiegatiin un numero limitato di operazioni routinarie. Dall’altro lato, rimanevano icapisquadra, non più nelle condizioni di apportare le loro competenze alprocesso produttivo, ma semplicemente ridotti ad aggiornare statistiche sullaproduttività del loro gruppo di lavoro. In questa maniera, viene formandosila miscela esplosiva che caratterizzerà le relazioni non solo tra lavoro e capi-tale ma anche tra lavoratori a partire dagli anni Settanta: violenti contrasti tralavoratori non qualificati e capisquadra; progressiva erosione del saper farediffuso in fabbrica; crescente insoddisfazione per la qualità del proprio lavo-ro non solo tra gli operai generici ma anche all’interno dell’aristocrazia deilavoratori specializzati.
Ai fini della nostra analisi, ci sono due elementi che dobbiamo prenderein considerazione per comprendere questo processo di erosione dei rapportitra organizzazione del lavoro e mercato del lavoro. Il primo elemento consi-ste nel fatto le relazioni sindacali sono state sistematicamente utilizzate, sin dalprimo decennio del XX secolo, per contenere e ridurre le aspirazioni dei lavo-ratori più qualificati. Sino agli anni Settanta, quando i gruppi di lavoro vengo-no definitivamente aboliti, le relazioni di potere e di gerarchia sono la veraposta in gioco, più che il livello dei salari o le condizioni di lavoro: i conflitti siincentrano prima di tutto sulla decisione di chi detiene realmente l’autoritàall’interno della fabbrica. Gli operai specializzati, molti dei quali proveniva-no da settori a piccola scala di produzione come la fabbricazione di carrozze
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 63
e di biciclette, caratterizzata da un livello elevato di abilità artigianali, oppo-sero una fiera resistenza all’introduzione dei principi dell’organizzazionescientifica della produzione. Emblematica di questa resistenza è senza dubbiola difesa dei contratti a cottimo – che permettevano ai lavoratori di lavorarecon i propri tempi e ritmi ed essere pagati non sulla base del tempo lavoratoma secondo la quantità prodotta – che ha caratterizzato la maggior parte deiconflitti tra capitale e lavoro per i primi quarant’anni del XX secolo. Negli anniVenti, il tentativo di ridurre l’incidenza del cottimo e di introdurre riformetayloristiche – nella fattispecie il sistema Bedaux – generò numerosi conflitticon la forza lavoro più qualificata e come conseguenza il metodo Bedauxvenne abolito nel 1934. Come risultato il lavoro a cottimo ammontava al 90-95% del salario nel 1936. Sostanzialmente, la posta in gioco non erano riven-dicazioni salariali ma una combinazione di coscienza di classe e di consape-volezza delle proprie competenze tecniche, combinazione rafforzata dal fattoche il lavoro manteneva un vantaggio relativo sul capitale, dati i limiti allameccanizzazione e la resistenza di metodi organizzativi che erano più vicini aquelli delle botteghe artigiane che non alla fabbrica ford-taylorista angloa-mericana. Questo processo ha spinto la parte più qualificata della forza lavo-ro in cima al movimento operaio, portando a un periodo di turbolenze e discioperi che culminò nell’occupazione degli stabilimenti FIAT nel 1920.
La reazione delle gerarchie della FIAT è stata così orientata a sciogliere lasaldatura tra élite operaie e movimenti rivoluzionari attraverso una duplicestrategia, apparentemente contraddittoria: introducendo gradualmentenuovi metodi di formazione e al tempo stesso aumentando la percentuale dilavoratori non qualificati. Per quanto riguarda il primo punto, nel 1922 FIAT
fonda il proprio centro di formazione, la Scuola Allievi FIAT, la cui ammissio-ne era ristretta ai figli dei lavoratori e ai loro più stretti parenti. Dall’altrolato, parallelamente alla crescita della produzione la FIAT ha iniziato ad attin-gere a un diverso mercato del lavoro: i nuovi assunti non erano più operaispecializzati, provenienti dalle botteghe artigianali torinesi, ma masse di lavo-ratori con un’educazione tecnica nulla o scarsa, provenienti prima dallecampagne piemontesi e successivamente dal resto d’Italia; il processo culmi-nerà con l’assunzione di massa di 15.000 lavoratori nel 1978 (Bonazzi, 1998).
Sebbene queste due misure appaiano in contraddizione tra di loro, illoro effetto combinato è stato quello di ridurre l’incidenza e l’importanza dellavoro qualificato all’interno della FIAT. La Scuola Allievi FIAT infatti avevacome obiettivo quello di addestrare una nuova classe fidelizzata di specialistie di supervisori, imbevuti di cultura ford-taylorista, che potessero rimpiazza-re i capisquadra appartenenti alle élite metalmeccaniche, mentre il flusso dilavoratori non qualificati, almeno nel breve periodo, doveva annacquare lacoesione della forza lavoro, isolandone le componenti maggiormente sinda-
P A O L O G I A C C A R I A
64
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 64
3 . L A F I A T E T O R I N O
65
calizzate e rivoluzionarie. Sebbene queste assunzioni avvenissero in periodi diespansione della produzione, venivano accompagnate da un elevato turnover,espellendo i lavoratori maggiormente politicizzati e rendendo la forza lavoropiù malleabile. Va in ogni caso tenuto presente che questo processo ha impie-gato oltre trent’anni prima di essere effettivo e pervasivo, e che le équipe dilavoro mantennero alcune caratteristiche della propria organizzazione prefor-dista sino agli anni Cinquanta.
Un secondo aspetto, rilevante ai fini della nostra analisi, della spaccaturaprofonda che andava creandosi tra capitale e lavoro qualificato riguarda ildestino di quelle competenze progressivamente marginalizzate che, come èovvio aspettarsi, non evaporarono nell’aria ma diedero forma a importantiprocessi di riorganizzazione, i cui effetti durano ancora oggi e che sarannodiscussi nelle conclusioni. Dalla fondazione della FIAT sino agli anni Cinquan-ta, i lavoratori qualificati percepivano l’assunzione in FIAT come il corona-mento di un processo di emancipazione che iniziava in piccole botteghemetalmeccaniche o presso altri produttori di automobili. Questa percezionedi privilegio andava oltre la garanzia di un’occupazione stabile, di salari piùelevati o di possibilità di carriera: prima di tutto, l’assunzione in FIAT venivainterpretata come un riconoscimento delle proprie competenze e dellapropria eccellenza artigiana, come testimonia la già citata ritualità del capo-lavoro che regolava il passaggio di categoria. Lentamente ma inesorabilmen-te, la diffusione dell’organizzazione scientifica del lavoro, stravolgendo l’usodel tempo e dei modi di relazione all’interno della fabbrica, l’isolamento deilavoratori più politicizzati, il disagio innanzi alle masse di lavoratori non quali-ficati provenienti da contesti rurali (Fofi, 1964; Negri, 1982) e la trasformazio-ne dei capisquadra in redattori di tabelle e statistiche – quando non in control-lori e delatori – causarono una crescente insoddisfazione nel rapporto tra glioperai specializzati e la vita in fabbrica.
Questo mutato atteggiamento si tradusse in un esodo dei lavoratorimaggiormente qualificati verso altri settori della galassia metalmeccanica tori-nese, in particolare verso i primi produttori di componenti che stavanocrescendo in seguito alla prima ondata di deverticalizzazione e di esternaliz-zazione, verso produttori di macchine utensili e verso imprese specializzatenel design, nella progettazione e nella prototipizzazione. In un certo sensopossiamo dire che queste competenze entrano a partire dagli anni Cinquantain un cono d’ombra: da un lato, hanno giocato un ruolo fondamentale nelgarantire flessibilità ante litteram all’indotto che, per garantire il rispetto dellecondizioni imposte dal cliente monopsonista dovevano attingere a questoserbatoio di forza lavoro plurispecializzata e orgogliosa del proprio saper fare;dall’altro lato queste competenze sono state marginalizzate dal cuore del siste-ma FIAT, diluite quando non espulse, sommerse dall’inurbamento di masse
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 65
di lavoratori non qualificati che dovevano divenire i protagonisti tanto delboom economico-demografico degli anni Cinquanta e Sessanta quanto delleproteste incandescenti degli anni Settanta e Ottanta. Questo non significaovviamente che la FIAT fosse divenuta, in termini di competenze, un gusciovuoto e che tutte le sue competenze tecniche siano state drenate altrove. Ènondimeno indubitabile che la nuova classe di tecnici ford-tayloristici prodot-ta internamente in sostituzione delle vecchie maestranze sarà inquadrata,almeno sino alla metà degli anni Ottanta, in una gerarchia scarsamente flessi-bile, ingessata in canoni di interazione rigidamente codificati che contrasta-vano con quanto già in quegli anni veniva sperimentato nella fabbriche tede-sche e giapponesi. Come vedremo, per contro, ciò che sopravviverà di questecompetenze specializzate sarà destinato a occupare una nuova centralità apartire dagli anni Ottanta, quando la crescente consapevolezza dell’allenta-mento dei legami che radicavano la FIAT al territorio torinese spingerà lediverse forze sociali della città (amministratori, associazioni di categoria,sindacati ecc.) a cercare soluzioni all’imminente deterritorializzazione e delo-calizzazione dell’industria automobilistica.
3.3La transizione postfordista (adagio lento)
La crisi petrolifera degli anni Settanta ha introdotto nell’architettura dellaveicolistica torinese imperniata sulla domanda della FIAT – sia di lavoro sia dicomponenti – una serie di trasformazione che si paleseranno appieno neglianni Ottanta e soprattutto negli anni Novanta. In particolare, nell’economiadel nostro ragionamento, le relazioni tra capitale e lavoro cambiano drastica-mente sia per quanto riguarda l’organizzazione della produzione sia per ciòche concerne le relazioni sindacali. In quest’ambito, una data si erge comevero e proprio spartiacque: il 14 ottobre 1980 (Castronovo, 2005, pp. 693-8).Quel giorno i supervisori e i capisquadra della FIAT organizzarono una mani-festazione, passata alla storia come “marcia dei quarantamila” in favore deldiritto a lavorare, nella speranza di porre termine allo stillicidio di scioperi edi picchettaggi che avevano quasi paralizzato la produzione per 35 giorni. Lamanifestazione superò le aspettative e si risolse in un fiume silenzioso di capi-squadra, quadri manageriali, impiegati e semplici cittadini che si riversò perle strade attorno allo stabilimento di Mirafiori. Al di là delle dispute sul nume-ro dei partecipanti e degli effetti che la marcia ebbe sulle negoziazioni tra FIAT
e sindacati, il vero significato della protesta era politico e destinato a mutareradicalmente l’immagine di Torino come città operaia. La posta in gioco eral’insoddisfazione non tanto dei cosiddetti colletti bianchi, dei quadri impie-gatizi, quanto piuttosto quella dei capisquadra e dei supervisori, ovvero di ciò
P A O L O G I A C C A R I A
66
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 66
3 . L A F I A T E T O R I N O
67
che rimaneva della tradizione degli operai specializzati che era stata margina-lizzata a partire dagli anni Cinquanta, intrappolata tra l’incudine dell’orga-nizzazione scientifica della produzione e il martello del lavoro delle masse dioperai non qualificati. Come osserva Castronovo (ivi, p. 694), i supervisorivenivano a trovarsi in una situazione conflittuale: da un lato dovevano garan-tire alla proprietà e al management il rispetto dei tempi e della produttivitàprevista; dall’altro aumentavano minacce e violenze da parte dei loro sotto-posti, sino a culminare in veri e propri atti di terrorismo negli anni Settanta.
Paradossalmente, potremmo spingerci a sostenere che il vero obiettivodella marcia dei quarantamila non era tanto influenzare le relazioni sindacaliquanto le pratiche organizzative all’interno degli stabilimenti. Sebbene laprotesta abbia avuto un impatto profondo su entrambe le questioni, le cosenon presero la direzione immaginata dagli organizzatori. Indubbiamente neimesi successivi la conflittualità negli stabilimenti si ridusse, ma il vero moto-re fu l’innovazione tecnologica e l’automazione, non certo un ritorno allepratiche artigianali e al culto del lavoro ben fatto. È interessante osservarecome l’automazione venga introdotta ancora in piena epopea fordista: dopoche l’organizzazione ford-taylorista aveva impiegato oltre quarant’anni pertrovare la sua piena applicazione, già all’inizio degli anni Settanta, diciottorobot di saldatura Unimate venivano introdotti nelle linee di Mirafiori, segui-ti dal sistema Digitron nel 1974 e da quello Robogate negli stabilimenti diRivalta e Cassino nel 1978. Sebbene questi primi esperimenti abbiano avutoluogo nell’area torinese, non dobbiamo dimenticare che quasi tutti i succes-sivi cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e della produzione avverran-no lontano dalla casa madre, marginalizzando il ruolo degli stabilimenti edelle maestranze torinesi e contribuendo sostanzialmente alla deterritorializ-zazione di FIAT dal suo contesto originario. La conversione di FIAT all’auto-mazione e alla produzione flessibile si realizzò solamente con il progettodella Highly Automated Factory (HAF), un progetto che divenne realtà non aMirafiori o a Rivalta ma a Termoli nel 1983 e a Cassino nel 1987.
Indubbiamente, queste innovazioni riducevano lo stress e la fatica asso-ciati con molte delle funzioni di produzione, introducendo migliorie ergono-miche e spostando un’elevata percentuale di forza lavoro dalle noiose e ripe-titive routine manuali verso funzioni di controllo e manutenzione. Indefinitiva, nondimeno, l’esito reale non fu uno smantellamento ma piuttostoun rafforzamento delle contraddizioni dell’organizzazione scientifica dellavoro (Volpato, 2004, p. 263).
Il bisogno di superare le contraddizioni inerenti all’organizzazione tecno-centrica della produzione e di ristabilire l’equilibrio tra le sue dimensioni,tecniche da un lato e sociali dall’altro, ha indotto il management FIAT a intro-durre la nozione di Fabbrica integrata, rappresentata come la fine dell’espe-
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 67
rienza ford-taylorista e l’avvio di un nuovo approccio italiano al just-in-time eal toyotismo. L’aspetto della Fabbrica integrata che ci interessa in questa sedeè la nozione di Unità tecnologica elementare (UTE) ovvero l’unità organizza-tiva fondamentale che gestisce un sistema tecnologico elementare e che ponein essere prevenzione, compensazioni della varianza, auto-controllo e miglio-ramenti continui per conseguire gli obiettivi di qualità, produttività e servi-zio (Volpato, 2004, p. 270).
La UTE, in particolare, ha introdotto nuove figure professionali con ilcompito di supervisionare il lavoro degli operai meno qualificati: il supervi-sore UTE, il Conduttore di processi integrati (CPI) e l’Operatore di processiintegrati (OPI). La prima figura introdotta combina i compiti precedente-mente assegnati al caposquadra con ulteriori responsabilità in materia dicosti, qualità e servizio. Soprattutto, la riforma poneva l’accento sulla dimen-sione proattiva piuttosto che su quella reattiva o adattiva del lavoro di super-visione, spostando l’attenzione dall’applicazione meccanica di regole e routi-ne decise ai livelli gerarchici superiori allo sviluppo di proceduremultifunzione che consentivano al supervisore un buon grado di discrezio-nalità e di capacità decisionale autonoma. Dal canto loro il CPI e l’OPI assu-mevano la responsabilità di insegnare ai membri del gruppo meno qualificatila maniera giusta di fare le cose e quindi di garantire che gli obiettivi di qualitàvenissero raggiunti. Sebbene con qualche limitazione, anche a queste duefigure intermedie erano concessi spazi di discrezionalità nell’adempiere ailoro compiti.
Al di là della questione se l’introduzione dell’UTE abbia realizzato le aspet-tative sociali e organizzative o se abbia semplicemente contribuito a conse-guire maggiori risultati in termini di produttività ed efficienza, quello che ciinteressa sottolineare è che questa prassi organizzativa può essere interpreta-ta, nell’orizzonte del nostro discorso, come un ritorno alla cultura del lavoroben fatto su cui si fondava il sistema dell’automotive torinese nei suoi primidecenni di vita e che era stato deliberatamente e accanitamente smantellato innome dell’ideale, e dell’ideologia, dell’organizzazione scientifica del lavoro.Tuttavia, il punto centrale è un altro: l’introduzione della Fabbrica integrata,a differenza delle riforme precedenti, non è stata preceduta da alcun tipo disperimentazione condotta negli storici stabilimenti dell’area torinese cheperdevano così il proprio status di laboratori dell’innovazione non solo tecno-logica ma anche organizzativa del sistema FIAT. Va osservato infatti che la scel-ta della localizzazione dove sviluppare il modello della Fabbrica integrata harichiesto un processo decisionale complesso che escludeva a priori l’area tori-nese. Sebbene sia comprensibile che la natura radicale dell’innovazionerichiedesse un investimento di tipo greenfield, la scelta di aree periferichesenza una tradizione manifatturiera significativa appare indicativa del modo
P A O L O G I A C C A R I A
68
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 68
3 . L A F I A T E T O R I N O
69
con cui il top management della FIAT percepiva il ruolo di Torino e della suaforza lavoro. Il fatto che, proprio nel momento in cui si trattava di applicare iprincipi ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo oorrggaanniizzzzaazziioonnaallee aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee ddeellllaa pprroodduu--zziioonnee, venisse esclusa l’area dove maggiormente si concentravano le compe-tenze in campo veicolistico e meccanico è indicativo di come l’applicazionecapillare del ford-taylorismo avesse ridisegnato l’intero scenario cognitivotorinese. Questa tesi appare confermata dal lavoro di Bonazzi (1998) chemostra come le UTE, nello stabilimento torinese di Mirafiori, abbiano dovutodedicare più tempo ad adattare i modi di produzione alla nuova tecnologiache a migliorare la produttività. Bonazzi conclude a questo proposito che siera creata una biforcazione tra le UTE che riuscivano maggiormente a realiz-zare le aspettative della Fabbrica integrata e i loro parenti poveri, le UTE tori-nesi che erano ancora alle prese con il lascito del fordismo. Un’ulterioreevidenza di questa biforcazione è evidente nella decisione di costituire aMelfi, accanto alla Fabbrica integrata, un centro di ricerca e un centro diformazione al fine di diffondere tra i nuovi assunti i principi della specializza-zione flessibile. Con la fondazione del centro di formazione di Melfi, all’iniziodegli anni Novanta, si chiude idealmente un cerchio aperto settant’anni primacon l’apertura della Scuola Allievi FIAT di Torino. Idealmente le due espe-rienze creano una sorta di cortocircuito centrale nell’ottica del nostro ragio-namento: paradossalmente il centro di Melfi si propone di diffondere nell’or-ganizzazione del lavoro principi di autonomia e di discrezionalità decisionaleche erano patrimonio comune della classe operaia torinese sino agli anniCinquanta e che proprio la Scuola Allievi torinese aveva contribuito a margi-nalizzare per favorire la lenta affermazione dell’organizzazione scientificadella produzione di matrice ford-taylorista.
3.4Conclusioni: l’importanza delle relazioni istituzionali
Nel trarre alcune conclusioni a partire dal ragionamento svolto in questo capi-tolo, ci sembra opportuno tornare sulla costruzione – e successiva crisi e supe-ramento – dell’immagine di Torino come one-company town e città operaiae, in particolare, sul ruolo giocato dalle amministrazioni pubbliche nel quadrodelle più ampie relazioni tra capitale e lavoro. Infatti, ci sembra legittimosostenere che proprio i rapporti tra FIAT e amministrazioni locali siano statistoricamente l’ambito in cui i canoni tradizionali del fordismo sono statiapplicati più direttamente ed esplicitamente nel Torinese. Quanto meno apartire dal dopoguerra, la pubblica amministrazione torinese e piemontese hasvolto un ruolo keynesiano fondamentale nel reggere il modo di regolazionefordista, sostenendo la crescita della FIAT e facendo propria, dal punto di vista
#sic
?#
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 69
politico, l’immagine di città dell’auto e di città operaia. Il quartiere operaiodelle Vallette – che prende il proprio nome proprio da Vittorio Valletta, diret-tore generale, successivamente amministratore delegato e presidente dellaFIAT lungo un arco di quasi quarant’anni, uno dei principali promotori dellarivoluzione fordista – è sicuramente un luogo emblematico di questa saldatu-ra tra la dimensione simbolica (legittimazione del regime di accumulazionefordista) e quella funzionale (fornitura di servizi, infrastrutture, abitazioniecc.) dei rapporti tra FIAT e pubblica amministrazione.
Con gli anni Ottanta, come abbiamo avuto modo di osservare, le cosecambiano radicalmente: la posta in gioco non è più supportare localmente ilregime di accumulazione di FIAT e offrire forme di regolazione sociale mapiuttosto attutire gli effetti della strategia di exit della multinazionale e porrerimedio ai suoi effetti più macroscopici, non solamente socioeconomici,come i licenziamenti e la disoccupazione, ma anche urbani e culturali, comeil proliferare di vuoti industriali effetto dei processi di delocalizzazione e dellacrisi dell’indotto meccatronico. Si trattava, in altri termini, di definire un’im-magine che rispondesse a una nuova progettualità di territorializzazione deirapporti tra città e industria. Semplificando forse eccessivamente il dibatti-to, possiamo identificare due ipotesi di lavoro principali, la prima incentratasu un’accelerazione della transizione postfordista e terziaria dell’economiatorinese, la seconda invece maggiormente legata ai saper fare della tradizio-ne meccatronica radicata nell’area metropolitana. È interessante notare comequeste due progettualità abbiano trovato il loro ancoraggio territoriale in dueluoghi simbolo dell’epopea fordista della città: gli stabilimenti del Lingottoe di Mirafiori. Sin dalla prima metà degli anni Ottanta, tanto la FIAT quantogli attori pubblici locali iniziano a interrogarsi circa il futuro della fabbricasimbolo del fordismo italiano ed europeo, in funzione dal 1930 al 1982. Unaserie di progressivi restauri e riqualificazioni sotto la direzione di RenzoPiano porta alla definizione, a partire dagli anni Novanta, di un utilizzo esclu-sivamente terziario, che comprende un portfolio caratteristico di funzionipostindustriali: centri commerciali, strutture ricettive, una galleria d’arte, unpolo fieristico e uffici di società di consulenza e intermediazione. A partire dal2005, una seconda ondata di conversione funzionale riguardante il rapportocon il proprio passato fordista ha investito la città, incentrandosi questavolta su Mirafiori, lo storico stabilimento torinese della FIAT, la cui impor-tanza strategica andava progressivamente riducendosi, anche in virtù delledifficoltà di adeguamento alle trasformazioni imposte dalla riorganizzazionedel lavoro, come evidenziato nel paragrafo precedente. Inaugurato nel 1939,Mirafiori rappresenta una sorta di città nella città, con i suoi due milioni dimetri quadri di superficie (circa quattro volte la superficie del centro storico),20 chilometri di linee ferroviarie, 11 chilometri di strade sotterranee. La sua
P A O L O G I A C C A R I A
70
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 70
3 . L A F I A T E T O R I N O
71
progressiva sottoutilizzazione ha posto con urgenza la questione del riutiliz-zo, aprendo un dibattito che è tuttora in corso. Ci sembra tuttavia legittimoaffermare che nel caso di Mirafiori la filosofia progettuale è stata radical-mente differente rispetto a quella seguita per il Lingotto. Complice il fatto,non secondario, che Mirafiori è uno stabilmente tuttora in uso, la stradapercorsa dalle pubbliche amministrazioni locali (in primis Comune e Regio-ne) è stata quella di un riuso industriale dell’area, favorendo la rilocalizza-zione in Mirafiori di imprese dell’automotive operanti nella componentisticae soprattutto nel design e progettazione. In questa direzione si muove lascelta di localizzarvi il Centro del design, in collaborazione con il Politecnico,ma anche la scelta di FIAT di stabilirvi a fine 2008 la sede della rinata Abarth,il marchio storico di proprietà FIAT che firmava gli allestimenti sportivi deimodelli di serie. Sempre in quest’ottica già dieci anni prima si era registrata lacollaborazione tra FIAT e Politecnico di Torino per la creazione – cento annidopo la fondazione della casa automobilistica torinese – del corso di laurea inIngegneria dell’autoveicolo che ha sede, simbolicamente, nell’ex repartoverniciatura del Lingotto. Analogamente, come discusso, il progetto FromConcept to Car si propone di mettere in contatto componentisti e fornitori delfu indotto FIAT con reti sovralocali di buyer, usando proprio la tradizione dieccellenza della meccatronica torinese come marchio di promozione dellaproduzione veicolistica.
Tutti questi casi ci parlano di una profonda trasformazione nel modo incui Torino rappresenta e utilizza il proprio rapporto con il passato fordista eoperaista della città: significativamente questo ripensamento, dopo un primomomento di rigetto quasi inconscio della propria tradizione manifatturiera ela conseguente ubriacatura di turismo e nuove tecnologie, sta negli ultimi annivalorizzando proprio quelle competenze che erano state marginalizzate neglianni della costruzione della città-fabbrica fordista e spinte ai confini dellacatena del valore. In questa prospettiva, la stessa enfasi che circonda l’imma-gine del distretto dell’auto assume uno specifico significato, dal momento chel’evocazione della distrettualità fa esplicito riferimento a un contesto prefor-dista, in cui competenze artigianali radicate nel territorio e nel tessuto produt-tivo si integrano con istituzioni sociali, culturali e politiche che vanno benoltre il modo di regolazione keynesiano. Resta da comprendere se non siatroppo tardi per evocare il golem dell’operaio specializzato, padrone deipropri mezzi, fiero del lavoro ben fatto, se non si tratti semplicemente di un’a-stuta strategia di city marketing in cui resta la griffe e scompare la produzione.Il lancio scenografico della nuova FIAT 500, con la sua spettacolarizzazionedella storia sociale ed economica di Torino e dell’Italia e la concomitantedelocalizzazione delle produzione negli stabilimenti polacchi della FIAT, nonsembra lasciare spazio a incauti ottimismi.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 71
Bibliografia
ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE (2000), Il piano strategico della città, Asso-ciazione Torino Internazionale, Torino.
ID. (2006), Secondo piano strategico dell’area metropolitana di Torino, Torino,http://www.torino-internazionale.org.
BAGNASCO A. (1986), Torino. Un profilo sociologico, Einaudi, Torino.ID. (1990), La città dopo Ford. Il caso di Torino, Bollati Boringhieri, Torino.BIANCHI R., ENRIETTI A., LANZETTI R. (2001), The Technological Car District in Pied-
mont: Definitions, Dynamic, Policy, in “International Journal of AutomotiveTechnology and Management”, 1, 4, pp. 397-415.
BONAZZI G. (1998), Between Shock Absorbtion and Continuous Improvement: Supervi-sors and Technicians in a FIAT Integrated Factory, in “Work, Employment andSociety”, 2, pp. 219-43.
BRUZZONE E. (a cura di) (1993), Torino: una città incompleta, FrancoAngeli, Milano.CASTRONOVO V. (2005), FIAT. Una storia del capitalismo italiano, Rizzoli, Milano.CONTI S., GIACCARIA P. (2001), Local Development and Competitiveness, Kluwer Acad-
emic Publishers, Dordrecht.ENRIETTI A. (1987), Il processo di selezione nella componentistica auto piemontese, IRES,
Torino.ID. (1999), La dinamica innovativa nel distretto tecnologico dell’auto in Piemonte, in
“Quaderni di ricerca del Dipartimento di Economia Cognetti de Martiis”, 1, Torino.FOFI G. (1964), L’immigrazione meridionale a Torino, Feltrinelli, Milano.FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI (a cura di) (1995), Catalogo dei progetti per Torino,
Convegno Nuova progettualità a Torino La città fisica, la città culturale, Torino28-29 maggio.
GIACCARIA P. (1999), Competitività e sviluppo locale. Produrre valore a Torino, Fran-coAngeli, Milano.
ID. (2010), Ripensare l’automotive e la meccatronica torinesi, in P. Giaccaria, V.Demetrio, VVeerrssoo uunn’’iimmmmaaggiinnee ddii ssiinntteessii ddeell ssiisstteemmaa mmaanniiffaattttuurriieerroo ppiieemmoonntteessee##vveerriiffiiccaarree ttiittoolloo##, Carocci, Roma ##vveerriiffiiccaarree uusscciittaa##.
IRES PIEMONTE (a cura di) (1994), Reti. Telecomunicazioni in Piemonte, Rosenberg &Sellier, Torino.
NEGRI N. (1982), La città difficile, FrancoAngeli, Milano.ROLFO S. (1993), The Italian Machine Tool Industry, CERIS, Torino.RUGAFIORI P. (1999), Alle origini della FIAT. Imprese e imprenditori in Piemonte (1870-
1900), in C. Annibaldi, G. Berta (a cura di), Grande impresa e sviluppo industriale,il Mulino, Bologna.
TENDENZE (1991), Torino tra crisi e sviluppo, Numero monografico sull’economiatorinese, CGIL, CISL, UIL, Unione Industriale, Camera di commercio, Torino.
VANOLO A. (2008), The Image of the Creative City: Some Reflections on Urban Brand-ing in Turin, in “Cities”, 25, 6, pp. 370-82.
VOLPATO G. (2004), FIAT Auto. Crisi e riorganizzazioni strategiche di un’impresa simbo-lo, ISEDI, Torino.
P A O L O G I A C C A R I A
72
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 72
3 . L A F I A T E T O R I N O
73
WHITFORD J., ENRIETTI A. (2005), Surviving the Fall of a King. The Regional InstitutionalImplications of Crisis at FIAT Auto, in “International Journal of Urban and Region-al Research”, 29, 4, pp. 771-95.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 73
75
4Da capitale a nodo di reti globali
di Giuseppe Dematteis e Alessia Toldo1
Torino, amico mio, è una scoperta capitale.@@
Friedrich Nietzsche, Ecce Homo@
4.1Introduzione: centralità territoriale e centralità di rete
Se per città capitale intendiamo un centro che ospita le funzioni di controllodi un territorio (politico-militari, economiche, ideologico-culturali) tutte lecittà, come già avvertiva Cattaneo (1858), sono in qualche misura delle capita-li. Ma una città è capitale in senso stretto solo se esercita queste centralità tutteinsieme e in modo esclusivo, su un territorio di cui ha il pieno controllo.Questo almeno è quello che si pensava fino a una trentina di anni fa ed è quel-lo che accadde a Torino tra il XVI e il XIX secolo, quando la città fu la capitaledi un territorio che raggiunse una rilevanza nazionale nel Risorgimento, primadi perdere il primato politico e ridursi al ruolo di semplice capoluogo ammi-nistrativo provinciale.
Vista in questa luce, quella di Torino potrebbe apparire come la storia diun declino. Tuttavia, va ricordato che nel contempo l’internazionalizzazionedell’economia e poi la globalizzazione provvedevano a ridurre la capacità dicontrollo territoriale delle città, capitali politiche comprese, tanto che oggi sipuò dire che non esistano più città capitali in senso pieno. Per mantenereuna posizione di rilievo nello spazio globalizzato delle reti e dei flussi, le prin-cipali città sono diventate nodi di queste reti, cioè sedi di imprese e di istitu-zioni con una capacità di comando e di controllo, pur sempre inserite in unagerarchia transcalare, ma diversa: non più territoriale, ma di rete.
Negli ultimi decenni il destino delle città si è giocato sulla capacità dioperare questa sostituzione tra la vecchia centralità territoriale e la nuovacentralità di rete. In certi casi ciò ha comportato una rottura netta col passa-to, in altri si è trattato di un processo evolutivo che ha utilizzato l’eredità stori-ca e ha conservato le vecchie forme di centralità territoriale, anche se menoestese ed esclusive, ma funzionali a quelle di rete. Questo è il caso di Torino,qui esaminato in termini di transizione dalle vecchie alle nuove forme dicentralità.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 75
Come molte espressioni del passato che hanno perso il loro significatoletterale, anche il termine “capitale” è sopravvissuto come immagine metafo-rica per indicare le città che occupano un rango particolarmente elevato inqualche settore. Così Torino viene sovente indicata come capitale dell’auto,del cinema, del gusto, del libro, del design, del barocco ecc. Una simile reto-rica comporta il rischio di una banalizzazione dell’attributo e del suo signifi-cato, fino a renderlo un’espressione piuttosto superficiale, buona al più comeslogan nel marketing urbano volto ad accrescere (talvolta in modo poco criti-co e lontano dalle reali possibilità) la visibilità di una città. Ma se ci si limita aquesto, si rischia di orientare lo sviluppo della città in una direzione pococoerente sia con le trasformazioni in atto al suo interno, sia con quelle operan-ti in un contesto più vasto, almeno europeo. Dunque, per quanto in questasede venga spesso utilizzata, questa metafora non deve essere presa alla lette-ra e il suo significato va riferito alla realtà che essa vuole evocare, cioè allacapacità di comando che un territorio limitato (una città e il suo intorno), inquanto nodo di una rete globale, riesce ad avere sugli altri nodi e quindi anchesu altri territori, in altre parti del mondo.
In quest’ottica quindi l’obiettivo del capitolo non è tanto verificare (e nelcaso ridimensionare) le velleità di Torino capitale, ma piuttosto quello dioffrire una descrizione interpretativa e propositiva. L’esame di alcune dimen-sioni in cui si ritiene che Torino abbia esercitato, o eserciti tuttora, una centra-lità sovraregionale sarà infatti condotto attraverso l’individuazione dei prin-cipali spazi, materiali e immateriali, entro cui e con cui si svolgono relazioni dicontrollo territoriale e di protagonismo in alcune reti di diversa ampiezza. Lalettura di questi spazi e di queste connessioni consentirà di riflettere sull’arti-colazione, alle diverse scale geografiche, delle funzioni della città e sul suoposizionamento nello scenario internazionale, con uno sguardo attento acogliere i rapporti tra passato, presente e futuro.
Inoltre la tendenza dello spazio europeo a strutturarsi in aggregazionipolicentriche macroregionali (si pensi al Randstad olandese, alla regione delReno-Rhur, al Diamante fiammingo ecc.) rende evidente la necessità, perTorino come per qualsiasi sistema urbano europeo, di articolare le propriestrategie di sviluppo con riferimento a un duplice contesto geografico. Da unlato la città continua a rafforzare la sua posizione nello scenario internaziona-le, forte della sua posizione di capoluogo regionale e di nodo di specifichereti transnazionali, dall’altro non può trascurare le sinergie e complementa-rietà di rete a scala macroregionale, ottenibili sfruttando la prossimità e lacomunanza di interessi territoriali con altri centri. Stiamo infatti assistendoalla progressiva affermazione di nuove configurazioni territoriali che assu-mono un ruolo sempre più importante come orizzonte di riferimento per losviluppo del sistema torinese.
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
76
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 76
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
77
In quest’ottica, in cui la centralità strategica non è più quella territoriale,cioè esercitata dalle città capitali in senso stretto, ma quella di rete, occorrefare riferimento a cooperazioni decisamente multiscalari e integrate, oriz-zontalmente e verticalmente, consentendo alla città di raggiungere quellamassa critica e quell’insieme di funzioni che permettono un posizionamentovantaggioso nello scenario internazionale, senza incorrere negli svantaggi diuna concorrenza diretta e nelle diseconomie di agglomerazione di cui soffro-no, non a caso, molte delle città capitali del mondo.
Per questa ragione Torino ha avviato, da qualche anno, diverse relazionicooperative – istituzionali e non, più o meno formalizzate – che contribui-scono alla creazione di nuovi spazi materiali e immateriali, in cui la centra-lità torinese si delinea sempre più in relazione alle complementarietà e allespecializzazioni funzionali delle reti multiscalari che li attraversano e li strut-turano.
Il passaggio di Torino a centralità di rete viene analizzato, in questo capi-tolo, a partire dalla rinascita urbana (tra la fine dell’Ottocento e l’inizio delsecolo successivo) come città industriale (PAR. 4.2) e capitale dell’automobile(PAR. 4.3) per poi proseguire con la trattazione di alcune realtà nelle quali ilnodo torinese ha esercitato (o esercita tuttora) un ruolo tale da giustificare lostatus di capitale, sebbene non in senso stretto: capitale delle relazioni indu-striali e delle imprese sociali (PAR. 4.4), delle Alpi (PAR. 4.5), del cinema, delgusto e dell’editoria (PAR. 4.6). La transizione a centralità di rete, con le conse-guenze che ne derivano, viene presa in esame nelle conclusioni a partire dafatti più recenti e dilatata a dimensioni di area vasta, cioè quelle reti di retiche costituiscono oggi il fondamento dello sviluppo policentrico, il modelloterritoriale fortemente promosso dall’Unione Europea negli ultimi dieci anni.
4.2Da capitale politica a città industriale:
le risorse del contesto storico e geografico
Quando, nel 1865, Torino perde le sue funzioni di capitale del Regno d’Ita-lia non solo deve fronteggiare la crisi economica conseguente al trasferi-mento della corte, degli uffici ministeriali, delle banche e delle società diaffari, ma soprattutto deve adattarsi al nuovo spazio generato dall’unifica-zione della Penisola. La città viene infatti privata sia della sua centralità poli-tico-economica, sia della centralità geografica di cui godeva nel Regno diSardegna.
Come osserva Gabert (1964) il valore della collocazione geografica tori-nese varia molto in relazione allo spazio di riferimento considerato. A metàdel secolo scorso (e a maggior ragione all’epoca dell’unificazione nazionale)
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 77
la posizione di Torino come cerniera fra il Mediterraneo e l’Europa conti-nentale (cui oggi assegniamo un’accezione fortemente strategica) non si eraancora pienamente realizzata e l’ostacolo dell’emiciclo alpino, per quantostoricamente permeabile, costituiva un problema per lo sviluppo economicodella città. Alla scala regionale, dopo il trasferimento della capitale, la cittàconferma la sua centralità territoriale entro i confini odierni del Piemonte edella Valle d’Aosta, anche se verso est e sud-est il suo controllo funzionale èeroso dal dinamismo di Milano, favorita da una posizione geografica assai piùcentrale, ed è limitato dalla crescente autonomia di Genova come porto ecentro industriale.
Se passiamo alla scala nazionale questa relativa centralità territorialediventa invece una evidente perifericità, in quanto si esercita in una regioneche l’unità della Penisola ha reso geograficamente periferica. Ma la situazio-ne pare capovolgersi se, su una carta politica della seconda metà del XIX seco-lo, si osserva come Torino e Milano siano le due grandi città italiane più vici-ne al cuore pulsante dell’Europa. Mentre su una carta fisica si vedrebbe inveceche la prossimità all’Europa nord-occidentale è ostacolata dalla formidabilebarriera dell’Arco alpino, superato allora dal mezzo moderno (la ferrovia)solo attraverso i trafori del Frejus (realizzato dal 1857 al 1870), del San Gottar-do (1872-82) e del Sempione (1889-1905). Ma solo il primo mette capo a Tori-no, mentre gli altri due convergono su Milano.
Se ci limitiamo a queste osservazioni cartografiche, la storia e la geografiasembravano dunque condannare Torino a un ruolo periferico, poco più cheprovinciale. Ma non fu così, perché nel corso di quasi tre secoli la storia avevasedimentato nella città un’ingente dotazione di capitale fisso, demografico,sociale, cognitivo e istituzionale. Senza trascurare il consistente patrimonio direlazioni di livello nazionale e internazionale, che sarà messo a frutto, e poten-ziato, nelle grandi esposizioni del 1902 e del 1911 (precedute dalle Esposizionigenerali italiane del 1884 e del 1898). I lasciti di una grande storia offrivanoquindi un insieme di precondizioni positive per rinnovare radicalmente labase economica della città, per modificarne la struttura e persino, in parte,l’identità (Castronovo, 1987; Gabert, 1964).
Quanto alla geografia, saranno proprio quelle Alpi che paiono chiuderegli orizzonti torinesi a fornire l’energia idroelettrica richiesta per il decolloindustriale di una città che non ha «ni fer, ni houille», come scrivevaBonnefon-Craponne nell’Italie au Travail (1916), poco dopo che il torineseGalileo Ferraris inventasse il modo di trasportare l’abbondante energia elet-trica prodotta nelle valli (FIG. 4.1).
Storia e geografia offrirono così alcune importanti condizioni per quelrapido e massiccio sviluppo industriale – esempio di “fenomeno emergente”
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
78
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 78
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
79
FIGURA 4.1I principali centri di produzione idroelettrica in Piemonte a metà del XX secolo
Fonte: Gabert (1964, p. 31).
#Ver
ifica
re i
nom
i del
la m
appa
, in
par
ticol
are:
Val
pelli
no, T
icin
o, F
eltr
inel
li, F
erre
ria,
Isol
iaz.
Gra
zie#
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 79
unico in Italia per le sue dimensioni e raro anche altrove – che ha portato Tori-no nel giro di pochi decenni ad affermarsi ancora una volta sulla scenamondiale2.
È interessante notare che anche negli ultimi trent’anni saranno nuova-mente sia l’eredità storica (le dotazioni culturali e soprattutto il capitale cogni-tivo accumulato in un secolo di sviluppo industriale moderno) sia le Alpi (itrafori autostradali e le Olimpiadi invernali) le principali risorse endogene acui la città farà ricorso per superare le crisi strutturali.
4.3Torino capitale dell’automobile: scale e articolazioni territoriali
È probabile che alla firma dell’atto costitutivo della Fabbrica italiana auto-mobili Torino, nel 1899, nessuno dei presenti immaginasse quanto profonda-mente e a lungo le sorti della FIAT si sarebbero intrecciate a quelle di Torino (epiù in generale a quelle dell’intero paese) strutturandone e organizzandone ilterritorio e la società, trasformandola da capitale nazionale decaduta in unadelle capitali regionali della modernizzazione europea.
L’integrazione di Torino con la sua industria principale alla quale ha, perpiù di mezzo secolo, delegato le sue principali relazioni esterne, ha fatto sì chela città esercitasse una certa centralità soprattutto in quegli spazi, materiali eimmateriali costruiti proprio dalla FIAT. D’altro canto, questa simbiosi con lacittà è stata un punto di forza e un valore aggiunto decisivo per lo sviluppodell’industria stessa. La FIAT ha potuto infatti godere dei vantaggi offerti daistituzioni pubbliche collaborative, da un ambiente sociale pragmatico, intri-so di cultura politecnica e dotato di un prezioso patrimonio di competenze eprofessionalità, al centro di un territorio ricco di forza lavoro disponibile.Tuttavia, come sostiene Castronovo (1999), queste circostanze non sarebbe-ro state sufficienti a creare un rapporto così saldo fra impresa e città, se leproiezioni espansive della FIAT non avessero contribuito a rinverdire le aspi-razioni di Torino e della sua classe dirigente a riconquistare in qualche modola centralità perduta con lo spostamento della capitale.
Cosa abbia rappresentato tutto ciò per la società, l’economia e l’urbani-stica della città è noto e ampiamente dibattuto3. In questo paragrafo ci limite-remo a esaminare il mutato rapporto di Torino con gli spazi geografici, appar-tenenti alle diverse scale, coinvolti nella sua ascesa a capitale dell’automobile.
La vocazione della FIAT a una forte internazionalizzazione, destinata acoinvolgere la città, è evidente fin dai suoi esordi nel mercato. A pochi annidalla sua fondazione, nel 1903, venivano avviate le prime esportazioni negliStati Uniti e, in breve tempo, fu chiara l’intenzione di perseguire una strate-
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
80
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 80
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
81
gia di respiro sempre più ampio, che si attuerà in una fitta rete estera di produ-zione (diretta e su licenza), vendita, investimenti e joint venture. Relazioni elegami di varia natura che la FIAT intrecciò con i circuiti economici, politici efinanziari di molti paesi: in primo luogo europei (con la Francia e la Spagnain particolare), ma anche americani, dell’Unione Sovietica (fin alla realizza-zione dello stabilimento di Vaz, a Togliattigrad) e dell’Est Europa (si pensiagli accordi con la Polonia), del Sud America (soprattutto con il Brasile e l’Ar-gentina) e, in tempi più recenti, con l’espansione nei mercati asiatici dell’In-dia (FIGG. 4.2 e 4.3).
Tuttavia se, specie a partire dalla seconda metà del secolo scorso, lacentralità dell’industria automobilistica torinese si afferma a livello interna-zionale, i fattori che l’hanno resa possibile hanno operato, come già nellaprima metà del secolo, su una scala ben inferiore.Consideriamo la forza lavoro: circa il 44% degli immigrati che giungono a
FIGURA 4.2Stabilimenti FIAT Group Automobiles (FGA) nel mondo, anno di inizio delle attivitàe numero di addetti
Fonte: nostra elaborazione su dati Ufficio stampa FIAT.
#in
seri
re a
nn
i di F
ran
cia
e R
uss
ia,
un
ità
di S
erb
ia e
Ru
ssia
#
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 81
Torino fra il 1946 e il 1960 provengono ancora dal Piemonte (TAB. 4.1) seguitodal Nord-Est (circa 13%) e dal Centro e Mezzogiorno (circa 30%) (Gabert,1964).
TABELLA 4.1Movimenti migratori a Torino nel periodo 1946-60 (valori percentuali)
Origine degli arrivi Destinazione delle partenze Territori a Torino da Torino
Comuni limitrofi 10,0 15,0Resto del Piemonte 33,8 34,3Resto del Nord-Ovest 6,4 13,1Nord-Est 13,2 9,7Centro 6,5 7,4Mezzogiorno 24,0 17,4Stranieri 4,0 8,2Altri 1,1 2,1
Fonte: nostra rielaborazione da Gabert (1964, p. 249).
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
82
FIGURA 4.3Addetti FIAT nel mondo (2008)
Fonte: nostra elaborazione su dati del Bilancio consolidato e d’esercizio al 31 dicembre 2008 (http://www.fiat-group.com).
#La
fig
ura
no
n è
ch
iara
:la
cif
ra n
el c
erch
io s
op
ra l’
Eu
rop
a a
cosa
co
rris
po
nd
e? Il
to
tale
del
le c
om
po
nen
eti è
cir
ca 1
06.0
00 (
> d
el g
rup
po
fia
t),i
n o
gn
i cas
o la
cif
ra d
ell’E
uro
pa
dov
reb
be
con
ten
ere
anch
e le
alt
re e
qu
i è in
feri
ore
alla
so
mm
a#
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 82
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
83
In questo periodo le migrazioni interne alla regione hanno una natura pretta-mente urbana e industriale: i flussi sono orientati verso le città, con una nettaprevalenza di Torino (+ 300.000 abitanti tra i censimenti 1951-61 e altri 40.000circa nelle cinture in formazione). Questa forte polarizzazione ha anche pesan-ti riflessi sull’organizzazione territoriale della regione. Essa contribuisce adaggravare il dualismo città-campagna: le aree più colpite dallo spopolamentoe dall’abbandono sono quelle agricole del Piemonte meridionale, prima fratutte la provincia di Cuneo, che nello stesso periodo perde 47.000 residenti,seguita da quella di Asti e Alessandria (Fofi, 1964). Inoltre crea forti squilibritra il centro metropolitano in ascesa e le altre città (IRES Piemonte, 1966, 1967),riducendo la loro capacità di “controllo” territoriale.
Occorrerà attendere gli anni Ottanta per cogliere i primi segnali di unriequilibrio, dovuto non tanto alle velleità pianificatorie, quanto all’avventodella fase postfordista e dei conseguenti processi di delocalizzazione e di accu-mulazione flessibile, destinati a rivitalizzare, anche in Piemonte, i sistemiurbani minori. Ciò capita dopo che la FIAT, all’inizio degli anni Settanta è arri-vata a occupare nei suoi stabilimenti del torinese intorno ai 125.000 addetti,di cui 40.000 nel solo stabilimento di Mirafiori. Il tutto con un effetto molti-plicatore sull’indotto e sulle attività rivolte al mercato locale che porterà lapopolazione di Torino a raggiungere nel 1973 il suo massimo storico di circa1.200.000 abitanti nel comune centrale e 1.800.000 con le sue cinture metro-politane. Oggi la FIAT occupa nel Torinese circa 33.0004 persone, mentre Tori-no oscilla intorno ai 900.0005 abitanti. La popolazione dell’area metropolita-na, che i processi di periurbanizzazione hanno dilatato ben oltre la secondacintura, è ancora cresciuta, fino ai 2.160.000 abitanti censiti nel 2001 (CRESME,2007, p. 14).
Il ridimensionamento dell’occupazione e della produzione dell’indu-stria automobilistica a Torino era però iniziato già sul finire degli anniSessanta, quando la FIAT aveva cominciato a delocalizzare i suoi impianti ascala nazionale. Sarà soprattutto tra la fine degli anni Sessanta e i primiSettanta che la polarizzazione torinese si farà sentire su scala nazionale. L’af-flusso dalle aree economicamente depresse del Sud Italia raggiunge propor-zioni molto elevate, arrivando a caratterizzare Torino come la terza cittàmeridionale d’Italia (Castronovo, 1999). In tal modo la capitale dell’auto-mobile svolge un ruolo preminente negli assetti territoriali che la Penisolava progressivamente assumendo in seguito alle forti migrazioni interne dallecampagne alle città, dalle montagne alle pianure, dal Sud al Nord (Sommel-la, Viganoni, 1997).
A questa azione indiretta si aggiungerà una partecipazione della FIAT
esplicitamente orientata alla strutturazione dello spazio produttivo meridio-nale. L’avvio di una massiccia politica di industrializzazione – che contem-
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 83
plava investimenti industriali non solo nei settori di base, ma anche in quelloautomobilistico, petrolifero e petrolchimico – costituiscono lo sfondo delsalto di scala dell’intervento FIAT nel Sud Italia, e dei conseguenti cambia-menti nelle logiche e nelle strategie aziendali. Fino alla fine degli anni Sessan-ta, la localizzazione degli impianti automobilistici si era infatti mantenutanell’area torinese, secondo un modello fordista classico, basato sulle econo-mie di scala negli stabilimenti e sulle economie di agglomerazione nel territo-rio. Lo stesso avveniva per quasi tutti i settori produttivi compresi nel trian-golo industriale, con le massime concentrazioni nei tre grandi vertici diTorino, Milano e Genova. Non a caso, negli anni Settanta, il governatore dellaBanca d’Italia, Guido Carli, commentando le scelte dell’amministratore dele-gato della FIAT, Vittorio Valletta, e della sua dirigenza affermava: «Quelli delsuo stato maggiore non sapevano neanche dove fosse il Sud. La geografiadell’Italia, per loro, andava solo fino a Milano e a Genova» (Castronovo, 1999,p. 1034).
Tuttavia, in linea con quello che avveniva in molti paesi industrializzati, ladebolezza intrinseca di questo modello non tardò a manifestarsi. Sul finiredegli anni Sessanta l’ingovernabilità della forza lavoro locale, su cui si scari-cavano le diseconomie derivanti dall’eccesso di concentrazione e dalla rapi-da crescita urbana, favorì (non senza contrasti all’interno dei vertici azienda-li) scelte rilocalizzative pilotate dai cospicui incentivi pubblici che l’interventostraordinario per il Mezzogiorno metteva a disposizione attraverso la nuovafase di contrattazione programmata. Così, le sorti di un numero cospicuo disistemi urbani meridionali (Sulmona, Cassino, Termoli, Bari, Termini Imere-se, Lecce, Brindisi e Vasto) finirono per dipendere in varia misura dalle deci-sioni dei quartieri generali torinesi, a cui si dovevano adattare le amministra-zioni pubbliche nazionali e locali.
In tal modo questo legame diretto con il Nord si traduce soprattutto inrelazioni di controllo e dipendenza del Sud: i nuovi stabilimenti sono di ridot-te dimensioni e quasi sempre isolati dai contesti e dalle economie locali; laproduzione è completamente organizzata, gestita e controllata dalla sede tori-nese. La stessa dirigenza, i macchinari, i materiali industriali e persino i forni-tori dei nuovi impianti e delle successive produzioni provengono dal Setten-trione, realizzando un modello di industrializzazione che genera assai pocosviluppo o, come dirà Trigiglia (1992), sviluppo senza autonomia, caratteriz-zato da scarse ricadute sullo sviluppo regionale.
Anche la seconda incursione, all’inizio degli anni Novanta, di Torino edella FIAT nel Meridione avviene rispondendo alle medesime logiche: da unlato, un’ulteriore incremento della produzione (e della sua qualità) graziealla costruzione di nuovi grandi impianti integrati, nei quali riproporre ilmodello produttivo postfordista della Toyota (cfr. CAP. 3). Dall’altro, gli
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
84
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 84
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
85
ingenti contributi statali6 di cui poté avvantaggiarsi la FIAT per la costruzio-ne, all’inizio degli anni Novanta, del primo stabilimento integrato italiano eche orientarono la scelta localizzativa sulla Basilicata, facendo di Melfi un’ap-pendice industriale torinese.
Oggi, l’intero gruppo FIAT conta nel mondo più di 198.000 addetti,concentrati soprattutto nelle sedi europee e del Sud America; di questi, quasi120.000 si riferiscono a FIAT Group Automobiles, localizzati per quasi unterzo in Italia.
4.4Torino capitale delle relazioni industriali e delle imprese sociali
Come centro della grande industria e come destinazione privilegiata deimassicci flussi di immigrazione, Torino è fin dal XIX secolo teatro degli squi-libri e dei conflitti tipici di una società in rapida trasformazione. Allo stessotempo però proprio in ragione di una radicata cultura operaia e intellettualedi matrice socialista, si è andata sviluppando una forte tradizione mutualisti-ca, cooperativa e sindacale, che ha fatto di Torino la punta avanzata delle rela-zioni industriali: una città in cui la dialettica capitale-lavoro impronta di sél’intera società. Basti pensare alla forza delle ottocentesche società operaie dimutuo soccorso, alla nascita della prima Camera del lavoro (1891), della FIOM
(1901) e alla Lega industriale (1906), da cui deriverà la Confindustria, anch’es-sa fondata a Torino nel 1911. Questo ruolo nazionale di Torino si rafforzeràancora tra le due guerre e nel primo Dopoguerra, per avere la sua ultima fiam-mata nell’autunno caldo del 1969 ed essere poi teatro della grande sconfittasindacale del 1980, con la marcia dei quarantamila.
A partire dall’epoca giolittiana Torino assume così un ruolo di capita-le sia del movimento operaio, sia dell’intellettualità progressista (Spriano,1958). Addirittura punto di incontro, sia pure dialettico, tra pensiero comu-nista e liberale: tra l’“Ordine Nuovo” di Gramsci e “La Rivoluzione Libe-rale” di Gobetti. Con Luigi Einaudi che nel primo vedrà «il più dottoquotidiano dei partiti rossi» e nel secondo il settimanale in cui «i pochigiovani innamorati del liberalismo fanno le loro prime armi, e per dispera-zione dell’ambiente sordo in cui vivono, sono ridotti a fare all’amore con icomunisti dell’Ordine nuovo» (Bobbio, 1977, p. 1). Da questi amori pocoortodossi deriverà tra l’altro il movimento politico Giustizia e libertà capa-ce di contrapporsi efficacemente al fascismo e di esercitare, assieme alpartito comunista, la leadership del movimento di Liberazione, dettandopoi molti dei principi scritti nella Costituzione repubblicana. Come scriveNorberto Bobbio: «Dopo essere stata la capitale del moto unitario eradiventata la prima città industriale italiana, e proprio per questo, nel primo
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 85
Dopoguerra, del più agguerrito e battagliero movimento operaio, una cittàdunque che era destinata a diventar la sede di una cultura più politica epoliticizzata» (ivi, p. 4).
Questa atmosfera impregnata di ideali di giustizia sociale, emancipazionedelle classi popolari e progressismo produrrà anche un’influente cultura lette-raria (da De Amicis a Levi e Pavese), storiografica (da De Sanctis a Salvato-relli), scientifico-filosofica (dai primi darwinisti italiani a Lombroso, al mate-matico Peano, ai tre Nobel per la medicina: Luria nel 1969, Dulbecco nel 1975e Levi Montalcini nel 1986) che si imporrà anch’essa a livello nazionale e inter-nazionale. Questa tradizione sarà rinvigorita dal ruolo, anch’esso di primopiano in Italia, che Torino svolgerà nella Resistenza, fino a raggiungere unmassimo tra gli anni Cinquanta e Settanta, quasi un mito, incarnato nel grup-po della casa editrice Einaudi.
Le dinamiche della Torino industriale e operaia hanno anche avuto, findal primo Ottocento, importanti attori di matrice religiosa cattolica, capacidi creare grandi imprese sociali, alcune oggi multinazionali. La loro caratte-ristica originaria è la capacità di rispondere a problemi sociali sottraendosiallo stretto legame che la casa Savoia manteneva con le istituzioni ecclesiasti-che tradizionali le quali, con le loro opere caritatevoli, i loro simboli e prati-che devozionali, come la Sindone, potevano essere viste come un instrumen-tum regni. I centri di queste nuove imprese sono invece i santuari popolari(Maria Ausiliatrice per i Salesiani e la Consolata per le Missioni omonime) oi quartieri più poveri come Valdocco. Qui, in uno spazio residuale dellebasse di Dora, poco fuori da Porta Palazzo, il prete torinese Giuseppe Bene-detto Cottolengo inaugurava nel 1832 la Piccola casa della divina provviden-za. La finalità è quella di accogliere malati poveri, affetti da gravi malforma-zioni e malattie croniche, privi di assistenza. Nel 1835 la sua fama è tale dameritargli il premio internazionale Montyon e Franklin per i benefattoridell’umanità. Nel 1842, alla morte del fondatore, la Piccola casa ospitava già1.300 persone e le sue 200 suore operavano in 25 altri centri urbani dellaregione. Oggi esistono 270 Piccole case in Italia e una decina nel restomondo. Un testo che spiega bene le radici profonde di questo successo,anche al di là della sua utilità sociale è La giornata di uno scrutatore di ItaloCalvino (1963).
Nel 1859 Don Bosco fonda la Pia società di San Francesco di Sales, che sioccupa di ragazzi abbandonati e bisognosi, avviandoli al lavoro. È l’iniziodella Congregazione salesiana, oggi l’ordine ecclesiastico più influente in senoalla chiesa cattolica, presente in 130 paesi, con 1.207 scuole, 1.587 oratori, 1.212parrocchie, oltre a numerose missioni. L’Istituto dei missionari della Conso-lata, fondato da Giuseppe Allamano nel 1901, è a oggi fortemente radicatosoprattutto in Africa e nel Sud America.
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
86
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 86
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
87
Oppure si pensi al più recente Gruppo Abele, nato a Torino alla fine deglianni Sessanta per volontà di Luigi Ciotti, e che dal 1970 ha avviato progetti dicooperazione internazionale con l’Asia (in particolare con il Vietnam), l’Afri-ca (Costa d’Avorio, Burkina Faso, Mali, Senegal e Marocco) e il Sudamerica(Guatemala e Messico). E ancora l’azione svolta dal SERMIG, che mira soprat-tutto alla creazione in loco di comunità attive, coinvolgendo la popolazionelocale nei progetti. La FIG. 4.4 illustra l’estensione di questa rete, con i princi-pali degli oltre 2.000 interventi avviati in 88 nazioni, dei quali più di 100 realiz-zati in paesi in guerra.
4.5Torino capitale delle Alpi
Torino divide con altre città, come Grenoble, Ginevra, Trento e Innsbruck,l’appellativo di capitale delle Alpi che si riferisce, ovviamente, sempre soltan-to a una parte delle Alpi. Nel caso Torinese all’arco occidentale che, tra lafine del XVI e la metà del XIX secolo, prima della cessione della Savoia e diNizza, fu per la maggior parte sotto il controllo politico della capitalepiemontese. Tale controllo riguardava principalmente il traffico dei valichi,
FIGURA 4.4I progetti del SERMIG nel mondo
Fonte: http://www.sermig.org.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 87
le risorse idriche, forestali e minerarie. Queste ultime spiegano anche comeTorino fosse nel XIX secolo all’avanguardia in Europa per gli studi sullageologia e l’orogenesi alpina. Lo stesso si può dire per quanto riguardal’idraulica delle turbine e poi, all’inizio del Novecento, per le tecnologieidroelettriche che, come s’è visto, furono un fattore decisivo del decolloindustriale della città.
A Torino fu fondato, nel 1863, il Club alpino italiano, che ebbe a lungo lasua sede centrale nella città e oggi ancora vi mantiene la biblioteca e il museonazionale. Alla fine dell’Ottocento, furono torinesi alcuni degli iniziatoridello sport che prese poi il nome di sci alpino e, non a caso, la prima grandestazione sciistica moderna delle Alpi, quella di Sestriere, fu pensata e realiz-zata dalla famiglia Agnelli tra il 1932 e il 1939 (Bartaletti, 2004, p. 175). A essaseguirà quella di Cervinia nel 1937, a opera di Lora Totino, record allora sia diquota che di dislivello.
Durante tutto il secolo scorso il rapporto tra Torino e le Alpi si caratte-rizza per un duplice flusso incrociato: quello della popolazione alpina che, inseguito al venir meno dell’economia locale tradizionale, cerca lavoro in cittàe quello dei torinesi che, con lo sviluppo del turismo e degli sport alpini, rico-lonizzano la montagna con le seconde case. Questo dello sport e del loisir è ilmodo con cui l’immagine più recente di Torino capitale delle Alpi si èprogressivamente consolidata fino a raggiungere la sua massima espressionecon il grande evento dei XX Giochi olimpici invernali del 2006: 9 siti olimpi-ci (Torino, Pinerolo, Cesana-San Sicario, Pragelato, Sauze d’Oulx, TorrePellice, Sestriere, Claviere, Bardonecchia), 985.000 presenze (fra impianti,Medals Plaza e notti bianche), 716.684 biglietti venduti (Bondonio, Dansero,Mela, 2007) e investimenti complessivi pari a 3.435 milioni di euro (L’EauVive, Comitato Giorgio Rota, 2007).
Alla crescente dipendenza del territorio alpino dalla metropoli ha datoun forte impulso anche l’accelerazione della mobilità che si è registrata negliultimi decenni. La mobilità transfrontaliera delle merci è all’origine dellastagione dei grandi trafori autostradali del Monte Bianco (1957-65), del GranSan Bernardo (1958-64) e del Frejus (inaugurato nel 1980), che per essereconnessi con l’avampaese metropolitano hanno dovuto attrezzare gli assivallivi, trasformandoli in corridoi infrastrutturali. Ciò ha permesso un rapidoaccesso alle parti più interne, con indubbi vantaggi per il turismo, mentre lebasse valli più a contatto con la metropoli hanno accentuato il loro caratteredi periferie-dormitorio. Questo intensificarsi dell’integrazione alpina sottoforma di una crescente dipendenza dalla città ha prodotto anche crisi dirigetto, come quella degli abitanti della Val Susa di fronte al progetto dellanuova linea ferroviaria ad alta velocità/capacità da Lione a Torino. In realtàil conflitto, tuttora irrisolto, che si trascina dall’accordo italo-francese del
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
88
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 88
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
89
2001, non oppone soltanto Torino (né tutta Torino) a una controparte alpina,ma anche e soprattutto i governi nazionali e i grandi padroni delle reti (comela Lyon Turin Ferroviaire, LTF) che si sono illusi di sostituire con un malac-corto decisionismo quello che nel resto dell’Europa si risolve con il dialogo ela negoziazione.
Già in sede di programmazione dei Giochi olimpici7 Torino ha svoltouna riflessione sul suo ruolo di città delle Alpi, sul significato che esso puòavere e sulle responsabilità che comporta. Oggi si va facendo strada l’ideache i territori alpini non debbano più essere semplici appendici dell’avam-paese urbanizzato e che quindi la città debba entrare nelle Alpi non solo conl’espansione dell’agglomerato metropolitano e non solo trasformando lospazio alpino in campo di vacanza e di svago per la popolazione urbana, maanche favorendo la localizzazione nelle Alpi di alcune delle attività e delleistituzioni che oggi hanno sede nelle grandi città e che potrebbero collocarsimeglio in ambiente alpino, in quanto si legano alle caratteristiche specifichedi esso. Ad esempio, ricerche e progettazione su temi come le energie alter-native, paesaggio, tecnologie edilizie, impiantistiche, agricole, forestali emanifatturiere appropriate all’ambiente montano; produzioni e attivitàformative connesse, mostre e manifestazioni ecc. Tutto ciò in linea con l’ideache le Alpi possano oggi proporsi come un grande laboratorio a scala euro-pea, dove si sperimentano nuovi modi e nuove tecniche di sviluppo sosteni-bile (cfr. Camanni, 2002; Bätzing, 2005).
4.6Le molteplici “Torino capitale”
Ci sono altri settori, oltre a quelli sin qui ricordati, in cui Torino ha raggiun-to posizioni di eccellenza in ambito sovraregionale, tendenzialmente inter-nazionale: è il caso, ad esempio, di Torino capitale del cinema e del gusto.Inoltre, di recente, l’appellativo di “capitale” è stato riferito a eventi perlo-più annuali, che promuovono determinate realtà e contemporaneamenteaccrescono la visibilità della città che li ospita, lungo tutta la durata dellamanifestazione, come Torino capitale mondiale del libro (con Roma, da apri-le 2006 ad aprile 2007) e di Torino World Design Capital nel 20088. Tuttiquesti casi rivelano bene lo sforzo della città di affrancarsi dal suo passatoindustrial-fordista, attraverso processi virtuosi di ripensamento e trasforma-zione dell’immagine e dell’economia urbana, che passano anche attraversoqueste forme di marketing territoriale (cfr. CAP. 2). Tuttavia, non si tratta solodi emanciparsi dall’idea, a lungo radicata nell’immaginario collettivo, digrigio polo industriale, quanto soprattutto di rendere la città concretamentepiù attrattiva e competitiva (e quindi meglio posizionata nello scenario inter-
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 89
nazionale) diversificando la produzione, cercando nuovi settori in cui conso-lidare la proprie competenze, agganciandosi alle reti globali con il ruolo, lamassa critica e l’immagine di un centro di eccellenza.
Nell’introduzione al suo capitolo sul cinema a Torino, Gigi Caorsi (1980)descrive l’esperienza cinematografica nella città subalpina come una meteo-ra tanto brillante quanto fugace, pietra angolare di quell’ideale muro delpianto ai piedi del quale tanti torinesi amano raccogliersi per lamentare i tortipatiti dalla città (ad es. la perdita del primato radiofonico, e più di recente,del Salone dell’automobile9 e di molti grandi quartieri generali del poterefinanziario).
Il caso del cinema esemplifica bene la capacità della Torino postfordistadi reinventarsi, recuperando e reinterpretando certi elementi sopiti delle suepassate esperienze e vocazioni. L’immagine della città come culla del cinemaè ampiamente documentata e condivisa (Rondolino, 1980; Crivello, 2009). ATorino nasce infatti l’industria cinematografica italiana con l’apertura, dal1907, dei primi studi e delle maggiori case di produzione (Ambrosio, Italafilm, Aquila e gli studi Fert); negli anni successivi vengono prodotti i primifilm a soggetto, i grandi kolossal e le prime rubriche di critica. L’industriacinematografica subalpina dimostra, rispetto agli altri centri italiani, unanettissima superiorità quantitativa e, a giudicare dal favore con cui venivanoaccolti i suoi film dal mercato nazionale, anche qualitativa. Nonostantequesto, il ruolo di capitale produttiva del cinema si esaurisce nel giro di pochidecenni e termina, nel 1937, con l’inaugurazione a Roma degli studi di Cine-città.
Tuttavia, proprio il patrimonio di competenze e capacità tecniche alta-mente specializzate che hanno fatto della città un’eccellenza nella produzio-ne cinematografica rappresentano la tradizione su cui fa leva, e che sostiene,la moderna vocazione torinese al cinema e, più in generale, all’immagine ealla multimedialità. Si tratta di una ritrovata centralità, che si manifesta conuna duplice modalità: culturale, in primo luogo, sia con il rilancio del Museonazionale del cinema e il suo trasferimento, dal 2002, nella suggestiva sededella Mole Antonelliana, sia con l’istituzione, a partire dagli anni Ottanta, didiversi festival, fra cui il più noto Torino film festival, che si inserisce a pienodiritto nel circuito delle manifestazione d’essai come quelle di Berlino,Toronto e San Sebastian. A questa prima dimensione se ne affianca unaseconda, più tecnica, con una rinnovata capacità produttiva del territorio chesi manifesta, ad esempio, con la nascita della Film Commission, grazie allaquale Torino, con 35 film, è stata nell’anno scorso il principale set cinemato-grafico italiano. A questo si aggiunge la recente inaugurazione del Cinepor-to, con la riapertura nel 2002 degli Studi Fert sotto la nuova denominazionedi Virtual Reality Multimedia Park (specializzato nella postproduzione) e
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
90
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 90
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
91
ancora, l’istituzione del corso di laurea in Ingegneria del cinema del Politec-nico di Torino.
L’immagine di Torino come capitale mondiale del gusto si è costruita suuna tradizione enogastronomia fortemente radicata nel territorio regionale,che si serve del capoluogo come vetrina della sua visibilità internazionale.Dal 1996 la città è sede dell’annuale Salone internazionale del gusto10, a cuinel 2004 si è affiancata Terra madre, manifestazione che favorisce l’incontrofra produttori e operatori della filiera agroalimentare di tutto il mondo.Dietro queste realizzazioni c’è la straordinaria crescita di Slow Food. L’asso-ciazione, fondata nel 1986 nella vicina Bra, assume carattere internazionaledal 1989, con la sottoscrizione, a Parigi, del suo manifesto da parte di delega-ti provenienti da quindici paesi. La sua articolazione territoriale ha centro aBra – dove è stata fondata anche la prima Università di Scienze gastronomi-che, con sede congiunta a Pollenzo e Colorno, in collaborazione con laRegione Piemonte e la Regione Emilia Romagna – e si dispiega a livello inter-nazionale con una rete di sedi locali che contano oltre 80.000 associati: più di400 condotte in Italia e oltre 1.000 convivium in 130 paesi. Alla creazione direlazioni internazionali contribuiscono anche i progetti dei presìdi, in soste-gno delle piccole produzioni eccellenti che rischiano di scomparire11. La retedei presìdi all’estero coinvolge oltre quaranta paesi, di cui oltre la metà inAfrica, Stati Uniti e Canada, Sud America, Medio Oriente e Asia. L’obietti-vo è di tutelare e promuovere la biodiversità, valorizzando i territori e recu-perando le competenze e il saper fare tradizionale.
All’immagine di Torino capitale del gusto concorrono anche altre inizia-tive sia a livello locale, come alle manifestazioni legate al cioccolato e allatradizione dei grandi marchi torinesi, o alla recente Eataly, un marchio cheriunisce un gruppo di piccole aziende enogastromiche proponendo unavasta gamma di eccellenze della produzione artigianale nazionale a prezzicontenuti, ora presente anche in altre città come Bologna, Milano, Asti, Pine-rolo, Torino e, a livello internazionale, Tokyo.
Infine, sul capoluogo si riflettono le principali eccellenze regionali, comequella delle colline meridionali (Langhe, Roero, Astigiano e Monferrato) oracandidate a patrimonio dell’umanità UNESCO.
Il titolo “Torino capitale mondiale del libro con Roma” è stato conferitodall’UNESCO alle due città per l’anno 2006-07 in ragione del ruolo di primopiano che hanno tradizionalmente ricoperto nella storia della letteratura edell’editoria e, più in generale, nell’impegno alla promozione del libro e dellalettura come occasione di crescita civile, sociale e culturale. A Torino, inparticolare, si riconosce il merito di aver dato i natali a grandi scrittori.Sempre a Torino, editori come Einaudi, UTET e Bollati Boringhieri hannoscritto la storia della letteratura italiana e internazionale12. E ancora, la città
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 91
ospita, dal 1988, l’annuale Salone internazionale del libro, la più importantemanifestazione italiana del settore (seconda in Europa solo alla Buchmesse diFrancoforte ma prima, negli ultimi tre anni, per il numero dei partecipanti).Per lungo tempo la collocazione torinese del Salone è stata contestata (tantoche molti torinesi hanno temuto di dover aggiungere un altro mattone almuro del pianto dei torti ingiustamente subiti) a vantaggio di Milano, sia perla presenza di molte case editrici, ma soprattutto per la migliore accessibilità,in particolare a scala internazionale, del capoluogo lombardo. Tuttavia, daalcuni anni queste tensioni sembrano cessate e il Salone ha rafforzato la suaposizione internazionale con l’affiancamento, dal 2004, della manifestazioneLingua madre, che costituisce il luogo di incontro privilegiato soprattuttoper gli scrittori di cultura extraeuropea (in particolare asiatici, africani e lati-noamericani).
La nomina di “Prima capitale mondiale del design” venne invece confe-rita a Torino dall’International Council of Societies of Industrial Design nel2005. Alla città si riconosce il ruolo centrale esercitato a livello internaziona-le in ragione delle numerose eccellenze presenti nel campo del design: centridi ricerca, centri stile, laboratori di modelleria e prototipistica in numerosisettori (primi fra tutti l’automotive, l’aerospace e i trasporti in generale, maanche la cinematografia, l’ICT, l’oreficeria e la gioielleria, il tessile, l’enoga-stronomia, la domotica e il design per la casa). Si tratta di un valore aggiuntoper la città che deriva direttamente dal suo ruolo di capoluogo di una regio-ne caratterizzata da una forte tradizione industriale, da storiche e peculiaricompetenze tecniche, accademiche e professionali, che hanno saputo evol-vere a fronte delle numerose crisi dovute alla transizione verso la produzionee l’economia postfordista.
Ci sono anche altri campi in cui Torino, pur non godendo dell’appellati-vo retorico di “capitale”, primeggia o almeno eccelle a livello nazionale esovente anche internazionale. In questo senso, la città occupa una posizionedi eccellenza in Europa nell’industria aerospaziale, nella meccatronica e nelleapplicazioni dell’ICT, per quanto riguarda gli investimenti privati e per laformazione universitaria offerta. Ancora, va sottolineata l’importanza delpatrimonio museale, sebbene valorizzato solo in parte e privo di una vera epropria rete di connessione (L’Eau Vive, Comitato Giorgio Rota, 2008), o diiniziative come Settembre musica (recentemente estesa anche alla città diMilano). Infine, si ricorda la presenza di numerose sedi di Organizzazioniinternazionali, come l’United Nations Educational, Scientific and CulturalOrganization (UNESCO), l’International Training Center of the InternationalLabour Organization (ITCILO), lo United Nations Interregional Crime andJustice Research Institute (UNICRI), lo European Training Foundation (ETF),lo United Nations System Staff College (UNSSC).
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
92
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 92
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
93
4.7Conclusioni:
Torino dalla centralità territoriale alla centralità di rete
Dall’esame delle eccellenze torinesi si possono ricavare alcune indicazionigenerali, utili per riflettere sulle future traiettorie evolutive della città. Colpisceanzitutto l’incapacità di Torino di mantenere alcune delle posizioni principaliche aveva raggiunto nell’arco degli ultimi 150 anni, a partire da quando haceduto il suo ruolo di capitale politica nazionale. Così il ruolo di guida dell’U-nità nazionale, molte cose sono nate a Torino per poi trovare altrove una sedemigliore (Caorsi, 1980): il cinema, la radio, la moda, la grande editoria, laleadership del movimento sindacale, quella culturale nel campo delle scienzeumane e sociali13, il big business dell’energia elettrica, quello bancario e assicu-rativo, il salone dell’auto e altro ancora.
La lista è troppo lunga perché il fenomeno sia del tutto casuale. Tra l’al-tro la sua ricorrenza ha generato una tendenza al vittimismo, con reazioniche oscillano tra la ribellione e il piagnisteo che sembra quasi essere diventa-to un carattere distintivo della torinesità. È vero che, specie per quanto riguar-da gli aspetti più propriamente socioculturali, molte città hanno avuto nellostesso periodo degli alti e dei bassi. Si pensi ad esempio a Napoli, Firenze,Barcellona, Vienna ecc. Ma nel caso di Torino occorre anche tener presentecome certi fattori strutturali locali abbiano interagito con le dinamiche gene-rali del periodo considerato.
I fattori strutturali sono anzitutto quelli della posizione relativamenteperiferica e della conseguente difficoltà di competere con centralità geografi-che più forti, come quella milanese, o con nodalità elevate come quella bolo-gnese. Inoltre, parzialmente correlato a questo aspetto, ha rivestito un ruolomolto importante il fattore “massa”. Non si può infatti trascurare come l’areametropolitana di Torino conti, per popolazione, occupati, imprese, PIL ecc.,meno della metà di Milano, circa la metà di Roma (CRESME, 2007, pp. XI-XII) esia anche nettamente inferiore ad altre metropoli europee relativamente peri-feriche, come Barcellona, Lione, Manchester, Liverpool e Stoccolma (Confé-rence des Régions Péripheriques Maritimes d’Europe, 2002). Altro fattorestrutturale, piuttosto intangibile ma non meno importante, è la path depen-dence di Torino da un cammino di sviluppo prevalentemente industriale e laconseguente atmosfera del suo milieu urbano, che ha canalizzato lungo certelinee evolutive le attitudini e la cultura di buona parte dei suoi abitanti, assi-milando le loro virtù, come ha osservato Arnaldo Bagnasco, più a quelle diVulcano che non a quelle di Mercurio.
Certo, l’evoluzione di Torino, come quella di ogni sistema complesso,non è soggetta a leggi puramente deterministiche: a dimostrarlo bastereb-
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 93
be la straordinaria e imprevedibile emergenza dell’industria automobilisti-ca all’inizio del secolo scorso. Tuttavia, essa non è neppure libera da vinco-li strutturali rappresentati sia dalla posizione della città nella geografiadella rete delle città e della mobilità europea, sia dalle opportunità e dailimiti derivanti dal suo cammino pregresso. Ciò significa che, se nessuno èin grado di dettare leggi predittive o prescrittive relative al futuro di questacome di ogni altra città, esistono però delle invarianti delimitative, cherestringono il campo degli sviluppi più probabili a quelli che i vincoli sopraindicati suggeriscono essere più adatti alla situazione e alla struttura dellacittà, in relazione alla dinamiche generali in atto. Quest’ultima precisazio-ne è fondamentale, in quanto, come già è avvenuto nel passato, il futuro diTorino deriva da un processo di interazione del sistema locale con i sistemidi livello territoriale superiore, sotto la spinta di driving forces che operanoa livello globale. Ad esempio, dal momento che queste tendenze vannoverso la progressiva concentrazione e centralizzazione dei grandi gruppifinanziari, non possiamo ragionevolmente attenderci che questo processofavorisca la localizzazione torinese che, come si è visto, è meno attrattiva acausa della sua posizione meno nodale e della sua massa relativamenteridotta.
Perciò, il fatto che Torino negli ultimi anni abbia perso la sede centraledi alcune grandi banche come San Paolo e CRT o di grandi società di assicura-zione come SAI e Toro, va vista come una prevedibile conseguenza di questoprocesso di centralizzazione e della sua selettività geografica basata su vinco-li strutturali. Invece di recriminare occorre dunque trarre da questi episodi lamorale che nessuna città, e Torino ancor meno di altre, è oggi capace di ognitipo di sviluppo e che quindi le centralità urbane si definiscono e si modifica-no sempre più in relazione al posizionamento possibile di ogni città comenodi in strutture di rete a diversi livelli. Questo non significa che lo sviluppodi Torino sia bloccato da limiti strutturali e neppure che la città debba rasse-gnarsi a occupare un posto di terza o quarta fila nella gerarchia urbana euro-pea. Questo modo di pensare risente infatti di una visione superata dellacentralità urbana: superata perché risale a un’epoca in cui si pensava (anchese poi la realtà era già allora più varia e complessa) che ogni città potesse svol-gere tutte le attività e le funzioni proprie del rango che essa occupava in unagerarchia essenzialmente territoriale, cioè con riferimento alla dimensionedella sua area di influenza. La competizione tra città dipendeva quindi dallapossibilità di estendere la propria influenza istituzionale o di mercato a piùvasti territori, in modo da salire di livello nella gerarchia urbana e guadagna-re così funzioni di grado più elevato.
Oggi sappiamo che questa visione territoriale della centralità urbana è ingran parte superata, ma fatichiamo a trovare gli occhiali giusti per vedere le
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
94
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 94
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
95
nuove realtà. Dal momento che oggi le centralità derivano da specializzazio-ni settoriali e da complementarietà funzionali nella divisione del lavoro all’in-terno di reti di diverso livello, la gerarchia da considerare è quella delle reti piùche dei territori. Ad esempio, con l’operazione Chrysler la FIAT ha acquisitonel suo settore una centralità di rete di livello globale e, se la sua direzionecontinuerà a essere legata al contesto torinese, la città sarà anch’essa, in questosettore, un nodo di massimo livello in una rete globale di peso rilevante nell’e-conomia mondiale.
Il fatto che Torino abbia perso centralità nella rete nazionale ed europeadel settore bancario è un effetto limitativo dello stesso processo di specializ-zazione che invece rafforza la sua posizione industriale. Inoltre non significauna sua estromissione dal settore finanziario, ma solo il ridimensionamento diuna funzione in cui la città conserva comunque ancora un buon grado dicentralità, ad esempio come sede delle fondazioni bancarie.
Se si perde centralità in certe reti, se ne può guadagnare in altre. Ad esem-pio, grazie agli investimenti connessi con le Olimpiadi invernali, alle loro rica-dute di immagine e alle politiche attuate nell’ultimo decennio, Torino si ècollocata a un livello gerarchico superiore nella rete del turismo culturale.Occorre accettare che, a differenza di quelle territoriali, dotate di un’inerziasecolare, le centralità di rete sono in continuo movimento: nell’arco di pochidecenni esse possono salire e scendere di livello gerarchico. Ovviamente ciònon avviene a caso, ma dipende molto da come gli attori pubblici e privatisanno interfacciarsi a processi tendenzialmente globali, tenendo presenti lepotenzialità e i limiti strutturali del contesto urbano. Le centralità di reterichiedono un’attenzione e un impegno continuo. Inoltre tenuto presente checiò che in una visione campanilistica può sembrare una perdita, può diventa-re un guadagno se invece di considerare il sistema torinese in maniera isolata,lo interpretiamo come componente attiva di una rete macroregionale costrui-ta secondo il principio di cooperare per competere.
È il caso, ad esempio, del Nord-Ovest italiano, dove la maggior forza deri-vante dalle recenti fusioni bancarie, corrisponde a un riposizionamento ditutta questa rete nella gerarchia europea e mondiale, in cui l’accresciutacentralità di Milano si traduce in un guadagno per l’intero sistema, che sidistribuisce in varia misura tra le sue componenti.
Nel caso di Torino, è opportuno declinare lo spazio a geometria variabi-le delle relazioni urbane quantomeno alla scala del Nord-Ovest e del Norditaliano, così come dell’Euroregione transfrontaliera Alpi-Mediterraneo. Nelprimo caso la città è già impegnata su diversi fronti, con azioni di coopera-zione e networking di varia natura: dalla Fondazione delle province delNord-Ovest ai progetti integrati per la logistica (si pensi alla Fondazionesistema logistica dell’Arco alessandrino, SLALA, e al masterplan per il Piemon-
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 95
te e la Liguria), all’Alta scuola politecnica fra l’ateneo torinese e quello mila-nese ecc.
Considerando la netta superiorità in termini di massa critica del capo-luogo lombardo è infatti auspicabile che Torino (ma anche Genova) perseguauna politica sempre più mirata alla specializzazione e all’eccellenza dellefunzioni e della loro messa in rete. Se quello che si vuole evitare è l’oscura-mento del nodo torinese dovuto alla prossimità geografica di Milano e all’a-simmetria gerarchica dei due capoluoghi (L’Eau Vive, Comitato GiorgioRota, 2008) è necessario puntare soprattutto sull’eccellenza proprio in queisettori caratterizzati da un importante capitale di competenze e professiona-lità specifiche e fortemente consolidate sul territorio: l’automotive, l’aerospa-ce e i trasporti in generale, ma anche la cinematografia, l’ICT, l’enogastrono-mia, il turismo e la cultura ecc.
Alla scala dell’intera area padana vanno invece declinate quelle questio-ni settentrionali (o del Nord, come suggerisce Bagnasco14) che necessitano –per cogliere opportunità o limitare criticità – di un orizzonte di riferimentopiù vasto: si pensi, ad esempio, alla partita del corridoio V Lisbona-Kiev, allaquestione aeroportuale, al bacino fluviale del Po (con la Consulta delleprovince rivierasche). La geometria variabile delle reti di cooperazionedovrebbe comunque estendersi anche oltre i confini nazionali, ad esempioattraverso l’Euroregione Alpi-Mediterraneo (in ragione di una storica coope-razione transfrontaliera con il Rhône Alpes e il Provence-Alpes-Côted’Azur), fino a comprendere un’area ben più vasta, coerentemente alle indi-cazioni comunitarie espresse nello Schema di sviluppo dello spazio europeo(SSSE)15.
La scelta di perseguire politiche e azioni di networking attivo fra i centridi queste reti di reti non va dunque interpretata come l’indebolimento delruolo autonomo della metropoli torinese, ma piuttosto come il riconoscimen-to di quanto opportunità e rischi generati da un territorio sempre più connes-so e infrastrutturato a livello globale, vadano affrontati anche (e in alcuni casisoprattutto) su una scala più estesa di quella urbana.
Note
1. Il capitolo è frutto di una riflessione comune. Si possono attribuire i PARR. 4.1, 4.2, 4.3 e4.4 ad Alessia Toldo e i PARR. 4.5, 4.6 e 4.7 a Giuseppe Dematteis.
2.@Si tratta di un processo, scrive Gabert (1964), tutt’altro che prevedibile se si considerala penuria di quei fattori storicamente centrali per lo sviluppo delle città industriali. Saràproprio la particolare posizione geografica della città, così prossima ai rilievi alpini, a compen-sare la povertà di materie prime del sottosuolo piemontese, attraverso lo sfruttamento massic-cio della risorsa idrica (la meno costosa d’Italia) per la produzione di energia idroelettrica.
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
96
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 96
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
97
Il rapido sviluppo di questo comparto, che vede convogliare sul nodo torinese tutte le lineedella Società idrica piemontese e dell’Azienda elettrica municipale (cfr. FIG. 4.1) mette a dispo-sizione delle industrie del capoluogo una grande quantità di energia a basso prezzo, che verràsfruttata in primo luogo proprio dalla nascente industria automobilistica.
3.@Fra i principali contributi cfr.: Bagnasco (1986, 1990); Berta (2008); Castronovo (1987);Comoli Mandracci (1983); Fofi (1964); Gabert (1964); Garelli (1998); Governa, Rossignolo,Saccomani (2008); Levi, Maida (2002); Mazza, Olmo (1991); Revelli (1989).
4.@Considerando tutti gli addetti FIAT, non solo quelli impiegati in FIAT Group Automo-biles (dati forniti da Ufficio stampa FIAT).
[email protected] a fine dicembre 2008 (ISTAT).6.@Ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, Disciplina organica dell’intervento straordinario
nel Mezzogiorno.7.@Cfr. il volumetto Torino, città delle Alpi, curato da Rinaldo Bontempi, con contributi
di Enrico Camanni, Daniele Jalla e Roberto Gambino, edito nel 2006 dal Comitato per l’orga-nizzazione dei XX Giochi olimpici invernali.
8.@E ancora alla prevista Torino capitale dei giovani e capitale della scienza nel 2010. 9.@Il primo Salone dell’automobile di Torino (e di Italia) viene fatto coincidere con la
manifestazione espositiva Mostra di automobili del 1900, da allora si susseguirono ben 68edizioni, fino all’aprile del 2000.
10.@La prima edizione sperimentale del Salone del gusto ha luogo a Torino nel 1996, nel2000 vengono presentati i presìdi italiani, nel 2002 quelli internazionali e si affianca la terzaedizione del premio Slow Food da cui, due anni dopo, nasce Terra madre.
11.@I presìdi coinvolgono direttamente i produttori, offrono l’assistenza per migliorare laqualità dei prodotti, facilitano scambi fra paesi diversi e cercano nuovi sbocchi di mercato(locali e internazionali).
12.@Più recentemente, sono nate piccole case editrici altamente specializzate: è il caso diBlu per quanto concerne la narrativa di viaggio e la montagna, Codice per la saggistica scienti-fica e infine Instar per la narrativa.
13.@Il già citato saggio di Norberto Bobbio sulla cultura a Torino dal 1920 al 1950 si chiudecon un capitolo significativamente intitolato Fine di un mito, anche se in realtà grazie a perso-naggi come lo stesso Bobbio, Antonicelli, Mila, Firpo, Abbagnano, Payerson e altri, Torino èstata ancora per vari anni il teatro di uno splendido tramonto.
14.@Nella relazione Il Nord come Regione Globale, presentata alla Conferenza Regioniglobali e fondazioni bancarie: priorità e prospettive (Alba 31 gennaio 2009), Arnaldo Bagnascosuggerisce come la questione settentrionale, opposta a quella storica meridionale, sia da inten-dere in un’ottica relativa e riproponga il tema del dualismo Nord-Sud, delle redistribuzionidelle risorse ecc. Al contrario, la questione del Nord è intesa in termini assoluti, riguarda temie problemi di questo specifico territorio, che esisterebbero anche se il resto del paese, Sudcompreso, non ci fosse.
15.@Senza prevedere nuove competenze comunitarie in materia di assetto territoriale, loSSSE costituisce un quadro di orientamento politico finalizzato a migliorare la cooperazione trale politiche comunitarie settoriali che hanno un impatto significativo sul territorio. Lo SSSE defi-nisce infatti obiettivi politici e principi generali per uno sviluppo territoriale sostenibile edequilibrato dello spazio europeo. Si tratta di un documento di natura intergovernativa a carat-tere indicativo e non vincolante. Conformemente al principio di sussidiarietà, la sua applica-zione avviene al livello di intervento più appropriato e a discrezione dei diversi protagonistinell’ambito dello sviluppo territoriale.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 97
Bibliografia
AA.VV. (1980), Torino città viva. Da capitale a metropoli 1880-1980, Centro Studi Piemon-tesi, Torino.
BAGNASCO A. (1986), Torino. Un profilo sociologico, Einaudi, Torino.ID. (a cura di) (1990), La città dopo Ford. Il caso di Torino, Bollati Boringhieri, Torino.BARTALETTI F. (2004), Geografia e cultura delle Alpi, FrancoAngeli, Milano.BÄTZING W. (2005), Le Alpi, Bollati Boringhieri, Torino.BERTA G. (2008), Nord. Dal triangolo industriale alla macroregione padana, Mondadori,
Milano. BOBBIO L., GUALA C. (2002), Olimpiadi e grandi eventi, Carocci, Roma.BOBBIO N. (1977), Trent’anni di storia della cultura a Torino (1920-1950), Fondazione
CRT, Torino.BONDONIO P., DANSERO E., GUALA C., MELA A., SCAMUZZI S. (a cura di) (2007), A giochi
fatti, Carocci, Roma.BONDONIO P., DANSERO E., MELA A. (a cura di) (2006), Olimpiadi, oltre il 2006, Caroc-
ci, Roma.BONNEFON-CRAPONNE L. (1916), L’Italie au travail, Pierre Roger et Cie, Paris.BONTEMPI R. (a cura di) (2006), Torino, città delle Alpi, Comitato per l’organizzazione
dei XX Giochi olimpici invernali, Torino.CAMANNI E. (2002), La nuova vita delle Alpi, Bollati Boringhieri, Torino.CAORSI G. (1980), Il cinema, in AA.VV., Torino città viva. Da capitale a metropoli 1880-
1980, Centro Studi Piemontesi, Torino.CASTRONOVO V. (1987), Torino, Laterza, Roma-Bari. ID. (1999), FIAT 1899-1999. Un secolo di storia italiana, Rizzoli, Milano. CATTANEO C. (1858), La città considerata come principio ideale delle isotrie italiane, in
D. Castelnuovo Frigessi (a cura di), Opere scelte, Einaudi, Torino 1972, vol. IV, p. 82.COMOLI MANDRACCI V. (a cura di) (1983), Le città nella storia d’Italia. Torino, Laterza,
Roma-Bari.CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE (2002), Etude sur la
construction d’un modèle de developpement polycentrique et équilibré pour le terri-toire européen, CRPM, Rennes.
CRESME (2007), Le città italiane negli anni 2000. Passato recente e scenari di cambia-mento, Rapporto di ricerca, volume I, parte I, CRESME, Roma, pp. XI-XII.
CRIVELLO S. (2009), Fare cinema a Torino: lavoro, radicamento e relazioni sociali, osser-vatorio sullo sviluppo locale, in “Sviluppo Locale”, 31, pp. 69-90.
FOFI G. (1964), L’immigrazione meridionale a Torino, Feltrinelli, Milano.GABERT P. (1964), Turin. Ville industrielle, Presses Universitaires de France, Paris. GARELLI M. (1998), Centralità e periferie nell’area torinese, in Associazione Torino
Internazionale, I dati fondamentali. Informazioni sintetiche di base per la costru-zione del Piano, Torino, http://images.torino-internazionale.org/f/Editoria/I_/I_dati_fondamentali.pdf.
GOVERNA F., ROSSIGNOLO C., SACCOMANI S. (2008), Le molte periferie della città post-industriale, in L. Fregolent (a cura di), Periferia e periferie, Aracne, Roma,pp. 438-75.
G I U S E P P E D E M A T T E I S / A L E S S I A T O L D O
98
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 98
4. D A C A P I T A L E A N O D O D I R E T I G L O B A L I
99
GINSBORG P. (1989), Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988,Einaudi, Torino.
IRES PIEMONTE (1966), Linee per l’organizzazione del territorio della Regione, Torino.ID. (1967), Rapporto dell’Ires per il Piano di Sviluppo del Piemonte, IRES, Torino.L’EAU VIVE, COMITATO GIORGIO ROTA (2007), Senza rete. Ottavo rapporto annuale su
Torino, Guerini e Associati, Milano.IDD. (2008), Solista e solitaria. Nono rapporto annuale su Torino, Guerini e Associati,
Milano.LEVI F., MAIDA B. (2002), La città e lo sviluppo. Crescita e disordine a Torino 1945-1970,
FrancoAngeli, Milano.MAZZA L., OLMO C. (a cura di) (1991), Architettura e urbanistica a Torino, 1945-1990, Alle-
mandi, Torino.REVELLI M. (1989), Lavorare in FIAT, Garzanti, Milano.RONDOLINO G. (1980), Torino come Hollywood: capitale del cinema italiano, 1896-1915,
Cappelli, Bologna.TRIGIGLIA C. (1992), Sviluppo senza autonomia, il Mulino, Bologna. SOMMELLA R., VIGANONI L. (1997), Dinamiche demografiche e assetti territoriali, in
P. Coppola (a cura di), Geografia politica delle regioni italiane, Einaudi, Torino,pp. 146-232.
SPRIANO P. (1958), Storia di Torino operaia e socialista. Da De Amicis a Gramsci, Einau-di, Torino.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 99
101
5Vent’anni di networking urbano: la città e il lato soft del processo
di internazionalizzazionedi Piero Bonavero e Cristiana Rossignolo##11##
5.1Introduzione
Negli ultimi decenni profondi mutamenti nella geografia dell’economiamondiale hanno rimesso in gioco antichi equilibri e modificato logiche di cresci-ta e di sviluppo consolidate nel tempo. In particolare, i fenomeni legati allamondializzazione dell’economia e all’integrazione europea hanno esposto consempre maggiore intensità le aree urbane del paese alla concorrenza interna-zionale, facendo emergere una crescente competizione fra i territori per attrar-re e concentrare le funzioni di eccellenza ma, allo stesso tempo, offrendo allecittà l’opportunità di essere nodi di reti strategiche, reti di flussi invisibili (finan-za, informazione, servizi, innovazione ecc.; Dematteis, Bonavero, 1997).
Fino ad alcuni anni fa, lo sviluppo di molte città europee dipendeva daorganizzazioni a rete sovralocali e tendenzialmente globali (istituzioni finan-ziarie, imprese transnazionali, reti di ricerca ecc.), secondo un modello dinetworking passivo, che poco si “ancorava” ai contesti locali, alimentandoinvece la frammentazione sociale e territoriale. Da qualche anno invece alcu-ne città hanno intrapreso politiche e azioni di networking attivo. Queste città,come sistemi di governo locale, si sono cioè organizzate in reti urbane di diver-so livello per costruire alleanze, per imparare lavorando in comune, per scam-biare informazioni, per avere vantaggi dalle economie di scala, per sviluppa-re mercati comuni e complementarietà.
Partendo da una delle tre immagini che compongono la visione strategi-ca di Torino1 – Torino metropoli europea – ci siamo chiesti se la città in questianni sia andata effettivamente in questa direzione e attraverso quali percorsi.Fino a che punto la città abbia saputo, pur mantenendo gli ancoraggi ai conte-sti locali, aprirsi agli scambi internazionali, fare politica estera, sfruttare leOlimpiadi invernali del 2006, dotandosi di progetti di respiro internazionale,attraendo nuove energie e nuovi capitali, rafforzando la sua presenza nelle retiinternazionali esistenti, dotandosi di mezzi e infrastrutture adeguate a questoscopo. Come abbia giocato la carta dei suoi vantaggi competitivi per affer-marsi sulla scena europea e mondiale.
#In
dic
are
le a
ttri
buzi
on
i dei
par
agra
fi in
no
ta g
razi
e#
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 101
Non c’è dubbio nell’affermare che la vocazione al networking del terri-torio torinese e piemontese trova le sue origini in una sua collocazione geogra-ficamente strategica come naturale cerniera tra l’Europa e una sua periferia,il Mediterraneo, ma anche in una serie di politiche e di azioni portate avanti inquesti ultimi anni coerentemente con le strategie comunitarie in materia diriassetto e di riequilibrio del territorio europeo.
Torino e i suoi territori appaiono caratterizzati da una buona capacità,rispetto a molte altre città italiane, di “fare rete”. Infatti, i processi di coope-razione che hanno coinvolto il capoluogo e la regione rappresentano unpercorso volontario e consolidato nel tempo, direttamente relazionato allepolitiche e alle strategie dell’Unione Europea per il riequilibrio del territoriocomunitario affermatesi dalla fine degli anni Ottanta.
In quest’ottica, questo capitolo ha lo scopo di presentare alcuni elementidi riflessione per l’analisi del sistema urbano torinese sulla scena europea einternazionale, come caso particolarmente rappresentativo di dinamichecooperative di diverse tipologie.
Nell’ampio e complesso panorama che la questione dell’internazionaliz-zazione di Torino offre, il capitolo si propone in particolare di riflettere su untema molto specifico. In un quadro di progressiva internazionalizzazione, e inparticolare di apertura verso l’Europa, che cosa ha significato per Torino esse-re in rete con il resto del mondo?
Il contributo si articola in due parti. Nel PAR. 5.2, ripercorrendo le classi-fiche delle città europee e le immagini di sintesi della geografia urbana euro-pea sviluppate sin da fine anni Ottanta, si metterà in evidenza come in questivent’anni la posizione di Torino sulla scena europea non sia complessiva-mente cambiata, anzi come nell’ultimo decennio siano molti i segnali cheportano a riflettere sulle potenzialità crescenti della città come nodo di rete esull’importanza delle strategie da adottare in questa direzione. Il PAR. 5.3 inve-ce si concentra sulle attività di networking attivo condotte in questi ultimivent’anni, attraverso una sorta di bilancio delle esperienze condotte. In parti-colare, dopo una ricognizione dell’ampia e articolata attività di Torino nelcampo delle reti di cooperazione internazionale, si è focalizzata l’attenzionesu due casi esemplari che consentono di illustrare in modo efficace il ruolodella partecipazione alle reti per i processi di elaborazione e apprendimentonelle politiche di sviluppo urbano.
5.2Torino tra classifiche, immagini e scenari: una vocazione di cerniera
Anche se Torino è stata legata per molto tempo all’immagine della one-company town, interpretazioni recenti hanno attribuito alla città un ruolo disecond city, di “città globale minore” (Sassen, 2008).
P I E R O B O N A V E R O / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
102
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 102
5 . V E N T’A N N I D I N E T W O R K I N G U R B A N O
103
A conferma di ciò, in una ricerca della rete ESPON (2006) nella classificazionedelle 76 Metropolitan European Growth Areas (MEGA)2 che possono rappre-sentare in futuro un “contrappeso” al Pentagono3, Torino viene annoveratafra le MEGA forti insieme ad altre sette aree urbane: Atene, Dublino, Helsinki,Oslo (città capitali), Ginevra, Göteborg, Manchester (FIG. 5.1). Si tratta di città
FIGURA 5.1Le Metropolitan European Growth Areas (MEGA)
Fonte: ESPON (2006, p. 29).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 103
relativamente popolose, in crescita, con buone capacità competitive e un’ele-vata dotazione in termini di capitale umano. Nonostante alcune carenze4 leMEGA forti rivestono un ruolo molto importante all’interno del territorioeuropeo, assimilabile a quello di relais per la costruzione di un sistema urba-no comunitario policentrico ed equilibrato.
Negli studi comparativi sulle città europee svolti negli ultimi vent’anni, inparticolare in quelli più recenti, Torino emerge come una metropoli europeache gode di una posizione geografica particolarmente strategica. Infatti, laprossimità al cuore europeo, ma anche la vicinanza al Mediterraneo, consoli-dano per la città una vocazione di gateway (Rossignolo, 2010).
Già nel noto studio del gruppo Reclus-Datar (Brunet, 1989), la città eravista come potenzialmente in grado di occupare un ruolo importante sullascena internazionale soprattutto grazie alla posizione strategica tra ladorsale centrale europea e il nuovo asse di sviluppo dell’Arco latino-medi-terraneo.
È interessante notare come gli studi Competitive Alternatives svolti daKPMG negli ultimi anni (2002, 2004, 2006) abbiano dato particolarmente risal-to alla posizione strategica di Torino – a 100 km dal confine francese, a 140km da Milano –, ma anche alle sue dotazioni infrastrutturali di area più vasta:un aeroporto continentale (Caselle), un aeroporto intercontinentale (Malpen-sa a 150 km) e un porto internazionale (Genova a 150 km)5.
Ma una riprova delle potenzialità di Torino viene anche dallo studio chela Conferenza delle Regioni periferiche marittime europee (CRPM) ha pubbli-cato nel 2002, come proposta di applicazione concreta del policentrismoeuropeo, enunciato nello Schema di sviluppo dello spazio europeo (UE, Comi-tato di sviluppo spaziale, 1999). Lo studio, pur rimanendo entro i limiti di unesperimento ipotetico, permette di verificare il posizionamento e il ruolo dimolte città, tra cui Torino, in una prospettiva di sviluppo policentrico euro-peo. Va anzitutto rilevato che la massa dell’area metropolitana torinese (intermini demografici ed economici) le assicura l’ingresso in una delle cinquearee di integrazione globale. Nel confronto analitico il sistema regionalepiemontese si presenta forte in termini di connettività, soprattutto grazie allasua posizione a contatto con il Pentagono (a cui appartiene Milano). Presen-ta invece condizioni medie per quanto riguarda la competitività e le dinami-che di sviluppo in atto. Sulla competitività è superato da Helsinki, Stoccol-ma, Copenaghen-Malmö, Bordeaux, Lione-Grenoble, Pais Vasco, Madrid,Barcellona e Roma. Lo studio si conclude con due scenari. In entrambi ilsistema metropolitano torinese presenta delle prospettive positive. In parti-colare, nello scenario volontarista (FIG. 5.2), risultato di politiche nazionali edeuropee rivolte a rafforzare il policentrismo, Torino farebbe anzitutto siste-ma con Milano e Genova e, a scala macroregionale, verrebbe a occupare una
P I E R O B O N A V E R O / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
104
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 104
5 . V E N T’A N N I D I N E T W O R K I N G U R B A N O
105
posizione centrale in una grande zona di integrazione dell’economia europeache va da Montpellier a Trieste (e che, fra l’altro, coincide con la sezionemediana del cosiddetto Corridoio 5).
FIGURA 5.2Il modello policentrico “volontaristico”
Fonte: Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (2002, p. 179).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 105
Recentemente gli scenari spaziali al 2030 per il territorio europeo (ESPON,2007a, 2007b)6 hanno tratteggiato alcune prospettive per Torino che vannoda una posizione più marginale, ancora legata al Pentagono, ma senza lo sboc-co strategico del Mediterraneo (scenario competitive-oriented) a una prospet-
P I E R O B O N A V E R O / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
106
FIGURA 5.3Lo scenario proattivo al 2030
Fonte: ESPON (2007b, p. 60).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 106
5 . V E N T’A N N I D I N E T W O R K I N G U R B A N O
107
tiva decisamente orientata verso uno sviluppo coeso e policentrico (scenariocohesion-oriented), dove Torino assumerebbe centralità sia rispetto al coreche alle nuove aree di sviluppo territoriale del Mediterraneo, secondo unaprospettiva che sembra riproporre (almeno in parte) l’immagine dell’Arcolatino già indicata negli studi RECLUS-DATAR (Brunet, 1989) e recentementeconsolidata dall’azione dell’iniziativa comunitaria Interreg (a cui si accenneràpiù avanti). In particolare, lo scenario proattivo (FIG. 5.3) rappresenta l’evo-luzione auspicata secondo le linee guida della politica spaziale europea: siosserva come Torino si caratterizzi come “città snodo” in una posizione dicerniera tra Europa continentale e Mediterraneo.
Nel contesto mondiale, come appare evidente dagli studi prima citati, èdeterminante la capacità di fare sistema non solo con la realtà regionale(Dematteis, Rossignolo, 2004), ma con la più vasta area dell’Italia settentrio-nale, che rappresenta nel suo insieme un territorio dotato, da un lato, di unamassa critica rilevante, dall’altro di una dotazione funzionale ampia e varie-gata, in grado di colmare le lacune evidenziate da Torino in alcuni ambiti.
In questo quadro, le iniziative di networking urbano attivo sono andateassumendo un’importanza crescente, sia in generale sia nel caso specifico diTorino, e possono rappresentare, insieme ad altre, un importante strumento pervalorizzare le potenzialità del capoluogo piemontese nel contesto europeo emondiale citate sopra. A illustrare le esperienze di Torino in questo campo,approssimativamente negli ultimi vent’anni, è dedicato il paragrafo che segue.
5.3Torino e il saper fare networking
Nell’ampio e articolato quadro delle politiche di sviluppo di Torino, l’inter-nazionalizzazione costituisce da tempo un obiettivo strategico per la città.Come già anticipato in precedenza, il primo Piano strategico di Torino del1999 evidenziava la vocazione europea del capoluogo piemontese, vocazioneche il secondo Piano strategico del 2006 rafforzava riproponendola trasver-salmente in molte direzioni e obiettivi: dall’internazionalizzazione del sistemauniversitario a quella del tessuto produttivo locale, dalla valorizzazione dellacultura come strumento di attrattività e internazionalizzazione alla promo-zione dell’immagine del territorio e all’attrazione di grandi eventi (Associa-zione Torino Internazionale, 2006).
Le Olimpiadi invernali del 2006 hanno indubbiamente rappresentato perTorino un punto di svolta e di accelerazione per le trasformazioni fisiche dellacittà attraverso una vasta serie di interventi infrastrutturali e di riqualificazio-ne urbana, ma anche per la promozione della città, per la visibilità del suoterritorio, gli investimenti nella cultura e nel turismo.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 107
In particolare, le Olimpiadi hanno inaugurato, e probabilmente facilita-to, una stagione di grandi eventi che hanno portato all’affermazione di un“modello Torino”, un modello di città che ha costruito in anni recenti il suosviluppo e la sua immagine attraverso l’attrazione e l’organizzazione di even-ti di portata internazionale: da ricordare, ancora nel 2006, Torino capitalemondiale del libro con Roma, le Olimpiadi degli scacchi, i Mondiali di scher-ma, nel 2007 le XXIII Universiadi invernali, nel 2008 il World Design Capital,il Congresso mondiale degli architetti, il Salone internazionale del gusto eTerra madre, nel 2010 l’ostensione della Sindone e l’Euroscience OpenForum (ESOF), nel 2011 i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Si tratta di un modello di city marketing che trova dei precedenti in Euro-pa, ad esempio nelle politiche promosse a partire dai primi anni Ottanta daGlasgow attraverso strategie di rigenerazione urbana a lungo termine chehanno fatto leva su eventi culturali culminati nel 1990 con la designazione dicapitale europea della cultura, ma sono stati scanditi nel tempo da iniziative eappuntamenti periodici con la finalità di modificare l’immagine della cittànonché attrarre flussi di turisti e di investimenti (Gómez, 1998; García, 2005).Si tratta peraltro di un modello che per certi versi ha esasperato la logica delgrande evento al punto tale da indirizzare tutti gli sforzi verso alcune azionidi pura immagine, trascurando invece quegli interventi più decisivi per latrasformazione strutturale dell’economia e della società urbana.
Torino forse potrebbe imparare qualcosa da questa e altre esperienze,valorizzando gli aspetti positivi del modello in questione in una logica ditrasformazione strutturale e di sviluppo di lungo periodo della città. Ripen-sando alle politiche e alle strategie condotte negli ultimi anni nel capoluogopiemontese, riteniamo che in realtà qualcosa sia già stato fatto: in particolare,la vocazione internazionale della città non si è infatti costruita solo su unastagione fortunata di grandi eventi di livello nazionale e internazionale, mapiuttosto Torino è riuscita a cogliere gli effetti positivi degli stessi attraversoun saper fare relazioni internazionali maturato negli anni, un saper farenetworking.
Torino può in effetti vantare rispetto a molte città italiane ed europee unprimato, per intensità e risultati ottenuti, nel campo del fare networking. Unprimo livello può essere individuato nel fatto che il capoluogo piemontese,come molte altre città, porta avanti da diversi anni relazioni stabili con nume-rose altre realtà urbane attraverso le formule dei gemellaggi e degli accordibilaterali: sebbene queste forme non rappresentino certamente la modalità piùcompleta e articolata del fare rete, crediamo comunque opportuno ricordarliin quanto ne costituiscono una non trascurabile forma embrionale e, nel casospecifico di Torino, presentano storicamente una rilevanza significativa.
Per quanto riguarda i primi, Torino è gemellata con 16 città europee ed
P I E R O B O N A V E R O / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
108
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 108
5 . V E N T’A N N I D I N E T W O R K I N G U R B A N O
109
extraeuropee. In Europa, con Chambéry e Glasgow, cui si aggiunge il gemel-laggio plurimo con una città di ciascuno degli altri paesi fondatori della CEE:Colonia (Germania), Esch sur Alzette (Lussemburgo), Liegi (Belgio), Lille(Francia) e Rotterdam (Paesi Bassi); negli altri continenti con Campo Grande(Brasile), Cordoba (Argentina), Detroit e Salt Lake City (USA), Nagoya (Giap-pone), Quetzaltenango (Guatemala), Shenyang (Cina), Haifa e Gaza City(Israele e Territori palestinesi). Fra le attività portate avanti nell’ambito deigemellaggi vi sono non soltanto azioni formali quali scambi di delegazioni einiziative analoghe, ma anche collaborazioni concrete su progetti comuni:fra queste ultime, oltre a quelle portate avanti soprattutto nell’ambito delleattività culturali e delle politiche urbane nel quadro dei due gemellaggi “stori-ci” (quello con Chambéry del 1957 e quello “plurimo” del 1958, che hannorecentemente festeggiato i rispettivi cinquantenari), vi sono scambi di espe-rienze nel campo della riconversione industriale e rigenerazione urbana conGlasgow, nonché progetti di cooperazione allo sviluppo con le città di CampoGrande e Quetzaltenango e iniziative per la promozione della pace e dellaconvivenza con quelle di Haifa e Gaza City. Anche con le altre città sonostate avviate attività di collaborazione in campo economico, culturale, scien-tifico e della formazione (per un quadro completo delle iniziative messe inatto nell’ambito dei gemellaggi si vedano i vari Rapporti annuali sulle attivitàinternazionali della città di Torino).
Anche gli accordi bilaterali coinvolgono sia città europee che extraeuro-pee: in totale sono 8, e interessano le città di Bacau (Romania), Barcellona eLione (accordo trilaterale), Cannes (Francia), Ekaterinburg (Russia), Zlin(Repubblica Ceca), Vancouver (Canada), Harbin e Shenzhen (Cina). Fra gliaccordi più significativi si trova quello triangolare con Barcellona e Lione,motori trainanti delle rispettive regioni di appartenenza e città facenti parte,come Torino, della macroregione transnazionale del cosiddetto “Arco lati-no”7: nel quadro di questo accordo sono stati avviati numerosi progettinell’ambito della cooperazione economica e scientifica fra le tre città. Gli altriaccordi riguardano una pluralità di temi, fra i quali si trovano in particolarequelli della cooperazione nel campo della cultura e delle politiche urbane.L’accordo con la città di Bacau nasce invece dalla presenza a Torino di nume-rosi immigrati provenienti da quella città, e quello con Vancouver dal“passaggio di testimone” relativo all’organizzazione delle Olimpiadi inver-nali (per una descrizione più dettagliata delle azioni intraprese nell’ambitodegli accordi si rinvia anche in questo caso ai Rapporti annuali sulle attivitàinternazionali della città di Torino).
Oltre al tema dei gemellaggi e degli accordi vanno poi sottolineate leiniziative di “cooperazione di prossimità” della città di Torino e del Piemon-te, in particolare nel contesto dello spazio alpino: si tratta in particolare di
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 109
azioni che hanno avuto il loro sviluppo essenzialmente nel corso degli anniOttanta e Novanta, come quella del “Diamante alpino” (la cooperazionetriangolare Torino-Lione-Ginevra) e quella della Communauté de Travail desAlpes Occidentales (COTRAO), che riuniva le regioni italiane del Piemonte,della Liguria e della Valle d’Aosta, le regioni francesi del Rhône-Alpes e dellaProvence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), i cantoni svizzeri del Vaud, del Vallesee di Ginevra (Buran, Ferlaino, 1993). Più di recente, va ricordata la Conferen-za della Alpi franco-italiane (CAFI), che promuove la cooperazione fra i dipar-timenti francesi delle Alpes Maritimes, Alpes de Haute Provence, HautesAlpes, Isère, Savoie e Haute Savoie, le province italiane di Imperia, Cuneo eTorino, e la Regione autonoma Valle d’Aosta8, e dal 2006 l’Euroregione Alpi-Mediterraneo9. CAFI coincide, con l’esclusione del dipartimento dell’Isère,con il territorio dell’Alcotra, il programma di cooperazione transfrontalieraattivato nell’ambito dell’Obiettivo 3A della programmazione delle politiche dicoesione nel periodo 2007-1310 (prosecuzione delle precedenti iniziativecomunitarie Interreg I, II e III). Tutte queste iniziative mettono in evidenza ilrapporto privilegiato, mai completamente espresso ma potenzialmentesuscettibile di significativi sviluppi, del capoluogo piemontese con la città diLione, sebbene vada sottolineato come quest’ultima non risulti compresa nelterritorio interessato dal citato programma ALCOTRA attualmente il corso.
5.3.1. Torino e le reti di città
Uno specifico argomento di interesse è poi quello che riguarda la partecipa-zione di Torino alle reti internazionali di città. Attualmente il capoluogopiemontese partecipa a una pluralità di reti urbane e di associazioni di carat-tere internazionale, permettendo alla città di sviluppare e migliorare neglianni una serie di contatti e di collaborazioni che spesso hanno portato allacondivisione di esperienze locali e di scambio delle cosiddette “buone prati-che” nella politica urbana.
Le reti di cooperazione internazionale a cui partecipa la città di Torino sipossono suddividere in alcune tipologie principali:– reti di carattere generale: Eurocities, Rete delle città strategiche, Metro-polis e UCLG (United Cities and Local Governments);– reti culturali: Associazione delle città sedi di esposizioni internazionali,Associazione europea dei festival, Associazione europea Vie di Mozart,BJCEM-Associazione internazionale per la biennale dei giovani artisti dell’Eu-ropa e del Mediterraneo, Emporion-Associazione europea dei mercati, Lessommets du tourisme, LUCI (Lighting Urban Community International Asso-ciation), Pépinières européennes pour jeunes artistes, Ruta europea delmodernisme;
P I E R O B O N A V E R O / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
110
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 110
5 . V E N T’A N N I D I N E T W O R K I N G U R B A N O
111
– reti a tema sociale: Città sane, ESN-European Social Network, FESU-Forumeuropeo per la sicurezza urbana, Quartiers en crise-ERAN (European Regene-ration Area Network), European Union Agency for Fundamental Rights-FRA;– reti su educazione e giovani: AICE-Associazione internazionale delle cittàeducative, EFCF-Federazione europea delle city farm, ERYICA-EuropeanYouth Information and Counselling Agency, EYO-European Youth Obser-vatory, Platform-Network for European Youth Activities, Xarxa;– reti a tema ambientale: ICLEI-International Council for Local Environ-mental Initiatives;– altre reti di cooperazione internazionale: 100 città per 100 progetti Italia-Brasile, Eurogaza, Rete europea degli enti locali per la pace in Medio Orien-te, Osservatorio internazionale di democrazia partecipativa.
Fra queste numerose iniziative, quelle che hanno inciso in misura piùsignificativa sulla storia della cooperazione interurbana di Torino sono Euro-cities e Quartiers en crise-ERAN, di cui si parlerà diffusamente nel paragrafoseguente; anche fra le altre, alcune ricoprono peraltro un ruolo di una certarilevanza per la cooperazione del capoluogo piemontese. Ad esempio, la reteBJCEM, di natura culturale, coinvolge città appartenenti a 24 paesi euromedi-terranei e si occupa della promozione della Biennale dei giovani artistidell’Europa e del Mediterraneo, la cui ultima edizione ha avuto luogo nelsettembre 2009 a Skopje; la città di Torino, in qualità di socio fondatoredell’associazione, costituitasi a Sarajevo nel 2001, ne detiene oggi la presiden-za per il secondo mandato. Un’altra rete in cui il capoluogo piemontese svol-ge un ruolo attivo è quella denominata Emporion, che associa Torino conBarcellona, Lione e Budapest per la promozione e la riscoperta del valoreeconomico, sociale e culturale dei mercati cittadini nelle realtà urbane coin-volte. Inoltre, Torino fa parte dal 2004 della rete Città sane, promossa dall’Or-ganizzazione mondiale della sanità con l’obiettivo di diffondere la culturadella salute in tutte le politiche urbane orientando le scelte delle amministra-zioni locali. Infine, va ricordata la rete Xarxa, che riunisce 23 città europee (tracui, ancora una volta, Barcellona e Lione), con l’obiettivo di promuovere lacollaborazione fra i centri di formazione professionale e le aziende per miglio-rare la qualità della formazione attraverso metodologie innovative11.
5.3.2. Due casi esemplari: Eurocities e Quartiers en crise
Come si è accennato, le reti di cooperazione internazionale che hanno stori-camente svolto un ruolo maggiormente significativo per l’esperienza dellacittà di Torino sono Eurocities e Quartiers en crise che, nate da un’iniziativaautonoma di cooperazione tra differenti città europee verso la fine degli anniOttanta, e avendo in seguito ricevuto un cofinanziamento dalla Commissio-
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 111
ne europea, sono tra le poche ad aver mantenuto e sviluppato i propri intentie la propria organizzazione, riuscendo così a sopravvivere al termine dell’e-rogazione dei fondi comunitari.
Il cofinanziamento della Commissione europea attraverso un programmapilota denominato RECITE (Regioni e città d’Europa)12 attivato all’internodell’ex art. 10 del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) rappresenta perqueste due reti un elemento che risulterà caratterizzante e discriminante intutto il loro percorso di sviluppo. Infatti, la Commissione europea attraversoquesto progetto, ma anche attraverso le Iniziative comunitarie Interreg13 eUrban14 e i Progetti pilota urbani15, intraprende proprio in quegli anni undialogo diretto con gli enti locali (Rossignolo, 1998a, 1998b). Si tratta di unastrategia fortemente innovativa che afferma in concreto il principio di sussi-diarietà come elemento cardine della crescita dell’UE, riconoscendo compe-tenze e ruoli alle città senza l’intermediazione dei livelli nazionali.
In questo quadro, Torino si pone in una posizione di particolare rilievo,diremmo quasi di prima della classe, almeno per quello che riguarda la realtàitaliana. Infatti, la città sembra agire in grande sintonia con le strategie comu-nitarie, riconoscendo nel networking attivo, e in particolare in queste due reti,i valori dello scambio con altre città (e con la UE), del confronto concreto suproblemi rilevanti (quali ad esempio lo sviluppo economico e la rigenerazio-ne urbana), della creazione di economie di scala, ma anche dimostrando dipoter e saper lavorare in autonomia rispetto ai livelli di governo di scala supe-riore (Regione e Stato) (Avedano, 2004).
Altro elemento innovativo di queste reti è il fatto che esse rappresentanonon solo uno strumento per lo scambio di esperienze, informazioni, metodi epratiche, ma anche un mezzo per diffondere una cultura, un modello disviluppo che vede le autorità locali (transfrontaliere, transnazionali, interre-gionali) chiamate a confrontarsi e a “progettare” su problematiche comuni(dall’ambiente alle infrastrutture, dalle questioni sociali alle forme di aiuto peri paesi dell’Est europeo) attraverso metodologie e programmi di lavoro condi-visi (Avedano, Rossignolo, 2008).
Il filo conduttore dell’esperienza torinese nelle due reti in questione è l’in-teresse e il coinvolgimento sulle tematiche relative alle politiche urbane e inparticolare alle questioni della rigenerazione urbana. Se Eurocities si confi-gura come una rete di carattere più generale (affrontando le questioni urba-ne sotto diversi aspetti: sociali, economici, culturali, ambientali e ammini-strativi), Quartiers en crise pone più attenzione alle politiche sociali e allarigenerazione urbana.
Eurocities nasce nel 1986 in seguito a un accordo tra Barcellona, Birmin-gham, Francoforte, Lione, Milano e Rotterdam per sviluppare sinergie, econo-mie di scala, scambiare esperienze. La rete è successivamente cresciuta16 e si è
P I E R O B O N A V E R O / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
112
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 112
5 . V E N T’A N N I D I N E T W O R K I N G U R B A N O
113
caratterizzata all’esterno come una piattaforma per dare voce alle città, ai loroproblemi specifici, alle loro necessità, all’interno delle istituzioni comunitarieper risolvere problemi comuni esercitando pressioni sulla Commissione euro-pea. Si tratta molto spesso di vere e proprie azioni di lobbying politica perdare spazio alle città, elemento molto importante in questa ultima fase in cuila Commissione sembra essere tornata sui suoi passi, attribuendo una nuovacentralità al ruolo svolto dagli Stati nazionali come mediatori fra realtà locali eistituzioni comunitarie (Atkinson, Rossignolo, 2010).
Torino entra a far parte di Eurocities nel 1992. Da subito partecipa attiva-mente al gruppo di lavoro Economic Development and Urban RegenerationCommitee (EDURC) e in una seconda fase al forum Economic Developmentdove la città ha presentato il lavoro sulla rigenerazione urbana svolto negliultimi anni dal Progetto speciale periferie (PSP) del Comune di Torino (cfr.nota 19). Inoltre la città è stata attiva, e in alcuni casi lo è ancora, all’interno dialcuni gruppi di lavoro tra i quali Euro-med, European NeighbourhoodPolicy, Cohesion Policy, International Accessibility, Urban Research, UrbanRegeneration, oltre che in alcuni progetti specifici. Torino si è quindi impe-gnata in questi anni su fronti decisamente variegati, spaziando da temimaggiormente legati alle problematiche fisiche della città (avvicinandosi allarigenerazione urbana e alla mobilità) sino a ricerche nell’ambito della coope-razione con altre realtà urbane nazionali e internazionali.
Quartiers en crise17 nasce nel 1989 con la partecipazione di dieci città euro-pee con l’intento di scambiare esperienze e metodologie su politiche urbanee problemi di esclusione sociale, promuovendo la riqualificazione urbana diquartieri degradati e la partecipazione di residenti, tecnici e politici a questiprocessi di rivitalizzazione, vedendo in un approccio pluralistico il metodopiù adatto per contrastare i problemi legati al degrado fisico e sociale di alcu-ne aree urbane (Jacquier, 1991). Da subito la rete si pone nei confronti delletematiche urbane in una prospettiva decisamente vicina alle realtà che studia,attenta ai risvolti pratici delle tematiche che affronta, con una particolareattenzione verso lo scambio di esperienze in materia di rigenerazione urbanae di politiche sociali riferite a specifici casi, portati di volta in volta dalle cittàpartecipanti (Avedano, 2004).
Torino è una delle città fondatrici e ha rivestito da sempre un ruolo digrande importanza, presiedendo la rete nel periodo 1993-97, organizzandonele assemblee generali del 1994 e del 2005, partecipando come membro delcomitato esecutivo dal 1998 al 2005 e tornandone alla presidenza nel 2006.Torino, nell’ambito delle tematiche affrontate, ha portato come casi studioin un primo tempo un’area nord della città (Lucento-Vallette-Madonna diCampagna) scelta per il bando Urban I (non ammesso poi a finanziamento) epoi l’esperienza del Progetto The Gate, a Porta Palazzo. La città ha dunque
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 113
operato con uno sguardo particolarmente attento alle politiche sociali utiliall’interno dei processi di rigenerazione urbana dei quartieri in crisi. Traqueste politiche troviamo temi decisamente consolidati per la realtà torinese,come l’integrazione delle minoranze etniche, affiancati da altri meno affron-tati nel contesto delle altre reti di città, come quelli legati alla parità tra i sessinel lavoro e nei processi decisionali.
Ma c’è di più. Torino ha utilizzato queste due reti anche per portare avan-ti vere e proprie politiche urbane. Se infatti da un lato la città ha sfruttatoQuartiers en crise per scambiare buone pratiche e confrontarsi con altre realtàurbane sulle diverse esperienze, dall’altro ha soprattutto fatto propria quellametodologia – l’approccio integrato – che ha fatto scuola in questi ultimivent’anni in Italia e in Europa nel campo delle azioni di rigenerazione urbana.Ciò è avvenuto non solo applicando quella metodologia nei programmi speci-fici che lo richiedevano (dal Progetto pilota urbano, PPU, di Porta Palazzoall’Urban II di Mirafiori Nord18), ma rielaborandola in un progetto più ampioe articolato, il Progetto speciale periferie19, per la rigenerazione delle periferietorinesi. Il PSP nasce nella seconda metà degli anni Novanta per volontà delsindaco, Valentino Castellani, e dell’assessore al Decentramento, EleonoraArtesio. In particolare, «fin dalla sua istituzione, il PSP si propone di affronta-re la rigenerazione urbana delle periferie torinesi attraverso la messa in atto diprogetti innovativi e sperimentali, basati sull’integrazione (fra settori, istitu-zioni, attori e politiche) e sulla partecipazione diretta dei cittadini alle trasfor-mazioni» (cfr. CAP. 8).
Se l’esperienza di Quartiers en crise ha dunque permesso di costruireuna nuova consapevolezza sui temi delle periferie attraverso l’attuazione diuna vera e propria politica urbana, d’altro canto l’esperienza di Eurocities hain parallelo permesso l’accesso all’Europa, migliorato la visibilità della cittàalla scala comunitaria e facilitato l’accesso a iniziative specifiche. Congiuntu-ra positiva che si può leggere nelle numerose iniziative ed eventi legati all’Eu-ropa, dal Progetto pilota urbano di Porta Palazzo, all’Urban II, dalle presi-denze delle reti Quartiers en crise ed Eurocities, ai numerosi convegni eincontri di respiro europeo. Torino ha di fatto saputo sfruttare efficacemen-te Eurocities per mantenersi in stretto contatto con le istituzioni comunitariee svolgere attività di lobbying per queste iniziative.
5.4Conclusioni
Alcune considerazioni conclusive sono d’obbligo per rispondere all’interro-gativo iniziale relativo ai significati dello stare in rete per Torino.
In primo luogo, la riflessione su questi vent’anni nelle reti di città ha
P I E R O B O N A V E R O / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
114
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 114
5 . V E N T’A N N I D I N E T W O R K I N G U R B A N O
115
consentito di riconoscere che la partecipazione non è sempre stata la stessaper intensità dell’azione e risultati conseguiti, ma ha attraversato fasi alterne,riconducibili a momenti diversi del governo della città: a una fase sicuramen-te propulsiva dell’inizio degli anni Novanta20 ha fatto seguito un periodo diampia progettualità tra fine anni Novanta e inizio del decennio successivo, perarrivare infine a una fase (quella attuale) più problematica e in parte svuotatadi contenuti. Ciò non è tuttavia da imputare per intero a una debolezza intrin-seca della città, ma a due specifiche circostanze concomitanti. Da un lato,una fase che sta connotando l’ultimo decennio, che vede la città investirenell’internazionalizzazione soprattutto attraverso l’organizzazione di grandieventi. Dall’altro, un riorientamento delle strategie di azione comunitarie.Infatti, negli anni Novanta, queste ultime avevano privilegiato un rapportodiretto delle istituzioni europee con le città, riconosciute come interlocutoriappropriati, al tempo stesso oggetto e soggetto delle politiche urbane. Neldecennio 2000-10 invece, e in particolar modo nella sua seconda metà, con lanuova programmazione dei Fondi strutturali 2007-13, si è assistito a un recu-pero di centralità del ruolo degli Stati nazionali come mediatori fra gli entilocali e le istituzioni comunitarie.
Nonostante le problematiche emerse recentemente, appare tuttaviaindubbio il valore delle esperienze cui si è fatto riferimento, che hannomostrato come la città negli ultimi vent’anni abbia percorso con successouna via all’internazionalizzazione solo apparentemente secondaria rispetto adaltre modalità più consolidate. Essere in rete ha infatti significato per Torinopraticare una strada più soft verso l’internazionalizzazione. Quello del capo-luogo piemontese rappresenta un caso esemplare di reciprocità fra Europa ecittà, che ha sperimentato nuove forme di incontro, di interazione, di proget-tazione congiunta, attingendo al patrimonio di idee ed esperienze sviluppatein altri contesti urbani con significative ricadute sulle politiche locali.
Note
1.@Il Piano strategico del 1999 proponeva una visione di Torino al 2010 che si basava su treimmagini principali: Torino metropoli europea; Torino ingegnosa, città del fare e del saper fare;Torino che sa scegliere, l’intelligenza del futuro e la qualità della vita. Nel documento leggiamo:«Torino metropoli europea è dunque il primo punto di una possibile visione per il futuro», chevede la città «collaborare e competere con le altre grandi città della nuova Europa, come capi-tale di una macroregione alpina» (Associazione Torino Internazionale, 2000, p. 21).
2.@Le 76 MEGA sono state classificate in 5 classi secondo 4 gruppi di indicatori: la massa(popolazione e PIL); la competitività (PIL pro capite, centri di comando di imprese europeetop); la connettività (trasporto aereo, accessibilità); la conoscenza (livello di istruzione, perso-nale impiegato in R&S).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 115
3.@Il Pentagono europeo è il nucleo centrale del territorio continentale, con funzionieconomiche globali e di alta qualità, delimitato dalle metropoli di Londra, Parigi, Milano,Monaco e Amburgo (UE, Comitato di sviluppo spaziale, 1999).
4.@Queste aree presentano evidenti debolezze in almeno una delle variabili considerate,sovente in relazione alla massa critica (e in particolare al peso demografico) o ancora all’acces-sibilità.
5.@Per maggiori informazioni cfr. i siti http://www.kpmg.com; http://www.competitivealternatives.com.
6.@Gli studi condotti della rete ESPON, in particolare i progetti Territorial Futures. SpatialScenarios for the Europe (ESPON, 2007a) e Scenarios on the Territorial Future of Europe (ESPON,2007b), hanno prodotto visioni fra loro alternative che provano a tratteggiare l’evoluzione delterritorio comunitario al 2030, utilizzando le tendenze evolutive (demografiche, sociali, econo-miche, ambientali) a partire da tre differenti approcci: uno tendenziale, uno teso all’incremen-to della competitività e uno espressamente orientato da politiche e pratiche di coesione (permaggiori informazioni cfr. il sito http://www.espon.eu).
7.@L’Arco latino è la fascia che comprende le regioni spagnole, francesi e italiane che siaffacciano sul Mediterraneo occidentale.
8.@Cfr. in proposito il sito http://www.cafiweb.eu/it.9.@Per maggiori informazioni cfr. il sito http://www.euroregion-alpes-mediterranee.eu.10.@Cfr. il sito http://www.interreg-alcotra.org/.11.@Per una sintesi relativa a tutte le reti si rinvia ai già citati Rapporti annuali sulle attività
internazionali della Città di Torino (http://www.comune.torino.it/relint), e in particolare aquello del 2009.
12.@Il programma RECITE, complementare agli altri progetti di cooperazione finanziatidalla Commissione europea nell’ambito del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR),ha promosso la cooperazione interregionale e interurbana. Le proposte sono scaturite sia daorganizzazioni internazionali in rappresentanza di città e regioni, che direttamente da gruppi diautorità locali, a testimonianza di una forte necessità di sviluppare una solida politica di valo-rizzazione delle collettività locali (Commissione europea, DG XVI, 1996a, 1996b, 1996c).
13.@L’Iniziativa comunitaria Interreg, lanciata nel 1990 e finanziata con il FESR, oggi vive lasua quarta fase. Lo scopo di questo strumento è la riduzione dell’effetto confine tra i paesi e leregioni dell’Unione, attraverso la promozione della coesione e lo sviluppo integrato delle zonetransfrontaliere. A questo fine, Interreg finanzia progetti di cooperazione transfrontaliera, tran-snazionale e interregionale, coinvolgendo soggetti pubblici e privati che operano nel territoriodell’Unione e negli Stati limitrofi (per maggiori informazioni cfr. il sito http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm).
14.@Altra iniziativa comunitaria sempre sotto il FESR, è stata Urban (1994-99, 2000-06). Essaha promosso strategie innovative per la rivitalizzazione economica e sociale di aree urbane incrisi in circa 200 città (per maggiori informazioni cfr. il sito http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/index_en.htm).
15.@I Progetti pilota urbani (PPU) vennero finanziati anch’essi sotto l’ex art.10 del FESR indue fasi (1989-93 e 1996-99) per sperimentare nuove idee per una migliore gestione a livello loca-le e sviluppare nuovi strumenti e un approccio più integrato ai problemi urbani.
16.@Oggi la rete conta più di 130 membri e si articola secondo sette tematiche: cooperazio-ne, cultura, economia, ambiente, società della conoscenza, mobilità, affari sociali (per maggio-ri informazioni cfr. il sito http://www.eurocities.org).
17.@Venne promossa nel 1989 dalla Délégation interministérielle à la Ville (Francia), conun cofinanziamento della Comunità europea, della Caisse des Dèpots et Consignations, e dalle
P I E R O B O N A V E R O / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
116
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 116
5 . V E N T’A N N I D I N E T W O R K I N G U R B A N O
117
dieci città fondatrici interessate da problemi comuni di declino urbano (disoccupazione,condizioni abitative disagiate, criminalità, droga, servizi inadeguati) (per maggiori informazio-ni cfr. il sito http://www.qec-eran.org/).
18.@Il PPU di Porta Palazzo 1994-99 fu attivato nell’ambito dei fondi comunitari per miglio-rare le condizioni di vita e di lavoro del quartiere di Porta Palazzo (per maggiori informazionicfr. il sito http://www.comune.torino.it/portapalazzo/). L’Urban II di Mirafiori nord (2000-06)è il programma di rigenerazione urbana promosso dall’Unione Europea per lo sviluppo e laqualità della vita e dell’ambiente nel quartiere Mirafiori Nord (per maggiori informazioni cfr.il sito http://www.comune.torino.it/urban2/).
19.@Il PSP è stato istituito nel 1997 per occuparsi di politiche di rigenerazione urbana, percontrastare il degrado fisico e sociale delle periferie (cfr. CAP. 8).
20.@Questo ruolo è esemplificato ad esempio dal fatto che Torino si colloca fra le cittàfondatrici della rete Quartiers en crise e ne assume subito la presidenza.
Bibliografia
ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE (2000), Il piano strategico della città, Asso-ciazione Torino Internazionale, Torino.
ID. (2006), Secondo piano strategico dell’area metropolitana di Torino, Torino,http://www.torino-internazionale.org.
ATKINSON R., ROSSIGNOLO C. (2010), Cities and the “Soft Side” of Europeanization: TheRole of Urban Networks, in A. Hamedinger, A. Wolffhardt (eds.), The Euro-peanization of Cities, Techne Press, Amsterdam.
AVEDANO L. (2004), Le politiche europee di rigenerazione urbana: la partecipazione diTorino nella rete Quartiers en crise, Tesi di laurea, Università degli studi di Tori-no, Torino.
AVEDANO L., ROSSIGNOLO C. (2008), 20 Years of Urban Networks: Assessment andLearning Processes, paper presented at the XI EURA Conference Learning cities ina knowledge based society, Milan October 9-11.
BRUNET R. (éd.) (1989), Les villes européennes, La Documentation Française, Paris.BURAN P., FERLAINO F. (1993), La macro-regione delle Alpi occidentali: complementari-
età, differenze e prospettive, in “Attività di Osservatorio”, 31, IRES Piemonte,Torino.
CITTÀ DI TORINO (2009), Rapporto annuale sulle attività internazionali della città, anni2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, http://www.comune.torino.it/relint/rapporto.
COMMISSIONE EUROPEA, DG XVI (1996a), Interregional Cooperation Projects, Thirdinterim report on article 10, Bruxelles.
ID. (1996b), L’expérience RECITE, in “Cahier”, 10.ID. (1996c), RECITE II, Dossier informativo, Bruxelles.CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE (2002), Study on the
Construction of a Polycentric and Balanced Development Model for the EuropeanTerritory, CRPM, http://www.crpm.org.
DEMATTEIS G., BONAVERO P. (a cura di) (1997), Il sistema urbano italiano nello spaziounificato europeo, il Mulino, Bologna.
DEMATTEIS G., ROSSIGNOLO, C. (2004), Il Piemonte nello spazio europeo, Irescenari 1,IRES Piemonte, Torino.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 117
ESPON (2006), Atlas. Mapping the Structure of the European Territory,http://www.espon.eu.
ID. (2007a), Territorial Futures. Spatial Scenarios for the Europe, http://www.espon.eu.ID. (2007b), Scenarios on the Territorial Future of Europe, http://www.espon.eu.GARCÍA B. (2005), Deconstructing the City of Culture: The Long-term Cultural Legacies
of Glasgow 1990, in “Urban Studies”, 42, 5-6, pp. 841-68.GÓMEZ M. V. (1998), Reflective Images: The Case of Urban Regeneration in Glasgow
and Bilbao, in “International Journal of Urban and Regional Research”, 22, 1,pp. 106-21.
JACQUIER C. (1991), Voyage dans dix quartiers européens en crise, Delegation intermi-nisterielle à la Ville, Paris.
ROSSIGNOLO C. (1998a), Le reti di cooperazione nell’Unione Europea: il programmaRecite, in P. Bonavero, E. Dansero (a cura di), L’Europa delle regioni e delle reti,UTET, Torino, pp. 273-81.
ID. (1998b), La politica dell’Unione Europea per la cooperazione transfrontaliera, inBonavero, Dansero, pp. 117-25.
ID. (2010), Torino in Europa tra interpretazioni consolidate e scenari futuri, in C. Cabo-di, C. Rossignolo, F. S. Rota, Torino e i suoi territori. Scenari competitivi e coesiviin Europa, Carocci, Roma, pp. 15-26.
SASSEN S. (2008), Parziali ricostruzioni e dinamismo globale, in “D di Repubblica delleDonne”, 6 settembre 2008, n. 613, p. 61.
UE, COMITATO DI SVILUPPO SPAZIALE (1999), Schema di sviluppo dello spazio europeo.Verso uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile dell’Unione Europea,Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Bruxelles-Luxem-bourg.
P I E R O B O N A V E R O / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
118
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 118
119
6La città del sociale:
dalle immagini come retoriche alle non rappresentazioni come pratiche
di Francesca Governa e Michele Lancione1
6.1Introduzione: problemi come immagini e immagini come potere
Torino è una città complicata, probabilmente come tutte, senz’altro nonmeno di altre. Prototipo della one-company town, è anche la città dei Giochiolimpici invernali del 2006, la città always on the move, come dice lo sloganconiato dall’amministrazione comunale per descrivere (e comunicare) icambiamenti in atto. Torino è anche la città dei santi sociali ottocenteschi epiù di recente della sinistra cristiana e del movimentismo cattolico che arrivaal Gruppo Abele di don Ciotti e al SERMIG di Ernesto Olivero; è la città delmovimento sindacale nei primi decenni del secolo scorso e delle prime occu-pazioni delle fabbriche, di Gramsci e Gobetti, della Resistenza e della cultu-ra operaia (cfr. CAP. 4). Quanti e quali di queste esperienze, che scavano nellasocietà torinese, hanno saputo farsi immagini della città? E di quali immaginistiamo parlando?
Non si tratta unicamente delle immagini del marketing urbano, rivolte allacostruzione e alla vendita di un prodotto, in cui il fatto che il prodotto sia la cittào il territorio fa poca o nessuna differenza (cfr. CAP. 2). Le relazioni fra immagi-ne e città non si esauriscono qui: le immagini di un territorio, di una città deri-vano da complessi meccanismi relazionali, emergono anche indipendente-mente dalla volontà del governo urbano, con modalità ed esiti spesso inattesi,non programmati e magari neppure voluti. Le immagini «attraversano, incon-trando molte resistenze, lo spazio che separa le pratiche discorsive dagli esiticoncreti delle azioni di modificazione della città, del territorio e della societàcostruendo relazioni tra ciò che con qualche semplificazione indichiamo comeil reale e le parole che utilizziamo per dirlo» (Secchi, 2000, p. 11)2. Le immaginidi una città non sono quindi esclusivamente rappresentazioni sintetiche ingrado di condensare intorno a sé iniziative e interessi, e di conseguenza ancheun progetto di azione sulla realtà, ma si configurano anche come ipotesi di inter-pretazione di questa stessa realtà (Dematteis, 1995). Produzione di immagini eproduzione di città non sono quindi processi disgiunti, separati e separabili:
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 119
entrambi concorrono alla formazione, informazione e creazione di un fenome-no sociospaziale, ridefinendo la città e la sua autorappresentazione. Ma il giocodelle immagini è ambivalente: può fare apparire quello che ancora non c’è, puònascondere possibili tracce di una diversa città, può “raccontare” una realtàautonoma, totalmente sganciata dalla città cui si riferisce e con cui fare i conti.Attraverso le immagini, quindi, la città sogna sé stessa (Amin, Thrift, 2002), siproiettano e si costruiscono delle narrazioni sulla e della città (Rose, 2007) cheesprimono e solidificano relazioni di potere (Painter, 1995). Le immagini siconfigurano quindi come linguaggi di governmentality (Elden, 2007), dovecon questo termine si intendono quelle pratiche e quelle tecniche – potenzial-mente espresse da ogni elemento che agisce, senza distinzione tra uomo omacchina (cfr. Latour, 2005), nella città (Huxley, 2007; Wood, 2007; Davis,2008) – capaci di “governare” una società o un suo particolare aspetto. Leimmagini sono qui intese, in altre parole, come strumenti (veri e propri linguag-gi) della governmentality, ovvero del governo prodotto dagli eterogenei poteripresenti in ambito urbano.
Con una schematizzazione, possiamo indicare tre modi diversi di inten-dere l’immagine della città:– schema di orientamento per l’azione;– mezzo per costruire il consenso e la condivisione (sul progetto di trasfor-mazione o sulla città);– autoriflessione della città su sé stessa. Questi tre modi non sono disgiun-ti o separati, ma si intersecano, si mischiano, si nutrono l’uno dell’altro. Ogniimmagine inoltre prima di configurarsi come tale, prima di emergere e affer-marsi nella ridda delle idee e delle voci che animano una città (Amin, Thrift,2002), passa attraverso diverse fasi (FIG. 6.1).
Le rappresentazioni delle città, o di tematiche particolari legate a esse,non sono il frutto esclusivo dell’azione di alcuni elementi piuttosto che altri.L’amministrazione, le forze economiche locali, i movimenti sociali, gli effettidi territorializzazioni passate, l’azione di processi dirompenti e imprevisti (sipensi al terremoto dell’Aquila e all’immagine della città emersa dopo la cata-strofe) sono tutti elementi che, attraverso processi organizzati o imprevisti eimprevedibili, esprimono, più o meno intenzionalmente, esigenze e progetti.Non tutti gli elementi superano questo passaggio: alcuni elementi (ad es. Enella FIG. 6.1) non riescono ad articolare le proprie intenzionalità in un’im-magine, che quindi si blocca, non emerge. Questo processo può avvenire inmaniera più o meno cosciente e consapevole, ma poco importa. Quel che èrilevante è il passo successivo, in cui diverse immagini della città si scontranol’una con l’altra per affermarsi, esprimendo le proprie istanze, le proprieesigenze, i propri interessi. Il processo di emersione, e quindi l’interazionefra le diverse immagini di una città, può essere cooperativo o conflittuale. In
F R A N C E S C A G O V E R N A / M I C H E L E L A N C I O N E
120
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 120
6. L A C I T T À D E L S O C I A L E
121
ogni caso, è relazionale e può quindi essere interpretato come un gioco dipotere, in cui le forze in campo lottano, mettendo in gioco le proprie risorse(economiche, culturali ecc.), per portare le proprie istanze al livello successi-vo, quello della “nebulosa” (cfr. FIG. 6.1). È qui che l’immagine diviene visi-bile (ad es. nel dibattito pubblico), benché non si sia ancora imposta sulle altrené sia riuscita a proiettare significativamente i propri effetti verso l’esterno,attraverso quelli che possono essere considerati dei veri e propri diagrammidi potere (Crampton, Elden, 2007). Lo stadio della nebulosa di immagini, inogni caso, non è necessariamente l’anticamera per quello successivo. Anzi:tale stadio, per tutta una serie di immagini, rimane spesso l’unico raggiungi-bile. Ciononostante all’interno della nebulosa possono emergere diverseconfigurazioni di potere tra le diverse immagini, per cui una può assumereun peso relativo significativamente più importante delle altre. Da questa fasesi può passare poi, in certi casi, alla proiezione dell’immagine vincente siaverso l’esterno, sia per riflesso verso l’interno. La città è così letta, rappresen-
FIGURA 6.1Esemplificazione dell’emissione di un’immagine sulle altre
Fonte: nostra elaborazione.
Proiezionedell’immagine verso l’esterno
Legenda
Attori in grado di produrre immagini, rappresentazioni delle proprie istanze
Attore non in grado di produrre immagini, rappresentazioni delle proprie istanze
Intensità delle diverse immagini prodotte dagli attori in competizione/cooperazione tra loro
Nebulosa rappresentante le immagini che emergono all’attenzione pubblica, da cui scaturirà/anno quella/e con rilevanza anche estrema
Nebulosa delle immagini che emergono
Zona di emersione (conflitto, cooperazione)
Zona di formazione (organizzazione, progettazione, imprevisto)
Proiezione dell’im
magine verso l’interno
A B E
C D
A B C D
E
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 121
tata e condizionata in quel particolare modo, fino a che un’altra immagine nonsostituisce la precedente, attraverso lo stesso meccanismo. Le immagini, infat-ti, sono mutuamente esclusive: un’immagine non ne ammette altre, sullostesso tema o temi simili. In qualsiasi modo la concepiamo, l’immagine è unarappresentazione esclusiva della realtà e, come tale, non ammette interferen-ze nel suo campo di azione.
Se questo può essere considerato, almeno a grandi linee, il meccanismorelazionale di potere attraverso cui questa o quella immagine si forma, emer-ge ed eventualmente si proietta verso l’interno e l’esterno, rimane da sottoli-neare un aspetto chiave: le immagini non sono neutre. Ed è per questo in defi-nitiva che diventano rilevanti per il territorio3. Sono almeno tre gli effettiprincipali di un’immagine sul territorio. In primo luogo, l’immagine vincen-te sminuirà le altre in termini politici e il peso relativo delle istanze rappre-sentate dalle altre immagini, inevitabilmente, diminuirà. In secondo luogo,l’immagine vincente, soprattutto se in termini assoluti, godrà di una posizio-ne dalla quale potrà controllare e sfruttare al meglio il proprio perpetuarsinel tempo, dilatando la propria influenza e rallentando l’emergere di altreimmagini. In terzo luogo, il protrarsi di tale situazione può comportare l’in-sorgere di conflittualità e tensioni destinate a esplodere. La rilevanza delleimmagini per il territorio è quindi prima di tutto politica: investe un insiemedi elementi (quali il conflitto, la capacità di organizzazione, la rappresentan-za ecc.) che sono alla base del governo del territorio. Ma è anche tecnica,poiché chiama in causa i saperi e le conoscenze necessari alla costruzione,affermazione e pertinenza delle immagini. La rappresentazione del territorioe il territorio non possono quindi essere slegati, né viaggiare su due binaridistinti e (come spesso accade) neppure paralleli: semplicemente perché laprima è indissolubilmente legata al secondo.
All’interno di questo quadro, questo capitolo si concentra sulle immagi-ni di Torino relative al “settore sociale”: dalla povertà al lavoro, dal welfarealla marginalità. In particolare, cercheremo di capire quali sono le questionisociali che hanno portato alla definizione di immagini in grado di imporsicome rappresentazioni collettive della città e quali no; quali sono gli attori egli interessi in grado di inserire le proprie istanze, via immagine, nell’agendadelle politiche, rappresentando alcuni problemi ed escludendone altri. Quel-lo che ci interessa è quindi il processo attraverso il quale certe immagini emer-gono e si impongono, altre riescono a emergere, ma non trovano adeguataesposizione, altre ancora infine non emergono o non riescono ad articolarsicome problemi collettivi. Le immagini sono quindi concepite come descri-zioni e rappresentazioni di un disagio, di una realtà sociale che questo o quel-l’attore, questa o quella contingenza, portano o meno a emergere dalla nebu-losa dei temi e dei problemi della città e a radicarsi, per un periodo più o meno
F R A N C E S C A G O V E R N A / M I C H E L E L A N C I O N E
122
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 122
6. L A C I T T À D E L S O C I A L E
123
lungo, nel dibattito pubblico e nella costruzione delle politiche urbane. Sitratta in altre parole di analizzare cosa riesce a emergere e, nel senso ampio deltermine, a trovare rappresentanza, a farsi pubblico all’interno dell’arena urba-na e oltre, e cosa no.
L’ipotesi sottesa al capitolo è la seguente. La rappresentazione semplicedei problemi sociali della città nel periodo fordista ha permesso una defini-zione sostanzialmente condivisa dei problemi collettivi, anche a ragione delruolo centrale esercitatato da alcuni attori rilevanti nella costruzione deglistessi (pochi problemi, pochi attori, pochi mediatori). Tale rapresentazioneha, del resto, portato all’esclusione di alcune questioni, che appaiono peròriemergere, in forme e modalità diverse, nelle dinamiche attuali della Torinopostindustriale, in cui alle immagini patinate delle strategie di marketingurbano, si affiancano le aree grigie di un disagio frammentato e nascosto epertanto ancora più insidioso.
6.2Fra crescita industriale e deindustrializzazione:
immagini, retoriche e mezze verità
Nella seconda metà dell’Ottocento, con lo spostamento della capitale a Firen-ze nel 1865, la perdita del primato politico-amministrativo e delle struttureeconomiche e sociali che avevano costituito il centro della vita cittadina, e lafondazione della FIAT nel 1899 iniziano a delinearsi, a Torino, i caratteri (o ilsogno) della città industriale (Gabert, 1964; AA.VV., 1994). Questo processo siconsolida nel corso del Novecento, definendo un modello di sviluppo indu-striale e urbano, la città fordista, che trova il suo pieno compimento negli anniSessanta e Settanta del secolo scorso. L’intero percorso è stato costellato da (esi è nutrito di) immagini ben precise della città, come quella della one-company town, che hanno letteralmente coperto le altre e che in alcuni casihanno fatto credere, e fanno credere ancora oggi, che null’altro si muovesse(e cercasse di emergere) dietro la scena.
Durante la Prima guerra mondiale Torino assume un’immagine partico-lare e unica nel contesto italiano. La vitalità della nuova borghesia imprendi-toriale rese infatti possibile la valorizzazione del consolidato patrimonio diconoscenze tecniche e produttive dell’industria militare sabauda per far fron-te alle commesse di materiale bellico. Torino diviene così la capitale italianadell’industria e del lavoro4. Un’immagine precisa, che connota a lungo la città,e che non è stata senz’altro neutra rispetto ai processi di crescita dell’insedia-mento urbano o alle dinamiche sociali. Se infatti, da un lato, l’immagine dellaTorino città-industria emerge in questo periodo quasi naturalmente dalmilieu urbano, dall’altro lato essa è stata utilizzata per costruire e legittimare
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 123
interventi che hanno portato a trascurare ogni altra possibile immagine dellacittà. Due esempi più di altri sembrano fotografare al meglio questa dicoto-mia tra la complessità del reale e la schematicità della rappresentazione.
Nel periodo di innesco della città industriale, è attivo a Torino un nume-ro sempre crescente di organizzazioni sociali (sindacati, società di mutuosoccorso, organizzazioni operaie) che cercano di rappresentare parti di societàtorinese, offrendo un’immagine diversa del prorompente sviluppo industria-le (mancanza di diritti sul lavoro, soprusi ecc.). Tali rappresentazioni altre,benché presenti e attive, non si affermano nella nebulosa delle immagini delperiodo, in cui risultano vincenti immagini più attratte dalla necessità di noninterrompere l’efficienza produttiva della macchina torinese. Un secondoesempio, simile al precedente si colloca a ridosso della Prima guerra mondia-le e riguarda gli scioperi operai del 1917 che rimasero quasi completamentesconosciuti nel resto del paese (Spriano, 1980). Nell’agosto del 1917 dilagò unaviolenta sommossa contro l’aumento dei prezzi, per il pane e la pace, cui seguìuna durissima repressione da parte della polizia e dell’esercito. Ancora unavolta, volente o nolente, la città appare incapace di andare oltre alle proprieindustrie (un meccanismo simile, pur con le dovute differenze legate soprat-tutto alla resistenza culturale torinese, si ebbe anche durante l’ascesa delregime fascista).
Il problema non è chiaramente la Torino industriale in sé, che fa riferi-mento a caratteristiche specifiche del contesto socioeconomico locale, quan-to l’immagine esclusiva di quella Torino a partire dalla quale si sono giustifi-cati alcuni interventi (le repressioni, in nome prima del lavoro e poi dellaretorica fascista) e non se ne sono fatti altri. Torino era ormai definita, classi-ficata, immaginata in un certo modo: una dicotomia tra la realtà territoriale ela sua immagine che porta la seconda ad agire in maniera strumentale e selet-tiva sulla prima, con un meccanismo di potere diffuso che si ripropone, indefinitiva, in tutta la storia della città.
Nel secondo dopoguerra, Torino si avvia a diventare una città di un milio-ne di abitanti, anche grazie agli intensi flussi migratori che si attivano verso lacittà. In 20 anni la popolazione raddoppia, con una progressione di circa50.000 abitanti in più l’anno. Negli anni Cinquanta, l’incremento della popo-lazione torinese fu davvero sorprendente: «Quando nel 1958 potevamo crede-re che si fosse raggiunto il massimo dell’assorbimento, gli arrivi non hannofatto che crescere tanto che dai 51.925 del 1957 sono passati ai 64.745 del 1960»(Gabert, 1964, p. 245). In questa fase, Torino proietta l’immagine di “città dellavoro” o, meglio, di “città in cerca di braccia operaie”, con tutti gli effettiche questo comporta.
Lo stretto legame fra industrializzazione e urbanizzazione segna la vitasociale ed economica della città: Torino diventa il prototipo della città fordi-
F R A N C E S C A G O V E R N A / M I C H E L E L A N C I O N E
124
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 124
6. L A C I T T À D E L S O C I A L E
125
sta, la città industriale per eccellenza, la one-company town italiana (Bagnasco,1986, 1988), con caratteristiche per tanti versi atipiche nel panorama naziona-le e più simili a quelle delle grandi conurbazioni industriali del centro e delNord Europa. L’aumento della popolazione che si determina in questo perio-do è segnato da notevoli squilibri, con l’instaurarsi di una netta divisione frala fascia, ristretta, della borghesia industriale e la grande massa degli operai.Questa è chiaramente una schematizzazione. Tuttavia, la stratificazione socia-le della città è stata a lungo semplice, caratterizzata da «una netta dicotomiaborghesia/proletariato, con poche cose nel mezzo» (Bagnasco, 1986, p. 41)5.
Tra l’immagine di Torino proiettata verso l’esterno (città che offre lavo-ro) e le sue conseguenze all’interno si annidano almeno tre dicotomie. Inquesto caso, a differenza della precedente narrazione sulla Torino pre-Ford,l’immagine “vincente” non è direttamente utilizzata dal potere locale o nazio-nale per indebolire altre forme di rappresentazione, ma l’effetto è lo stesso. Ilpotere discorsivo, e per certi versi persuasivo, delle immagini si diffonde infat-ti relazionalmente a ogni livello.
Una prima dicotomia è fra la “Torino città del lavoro” e chi quel lavoroconcretamente lo svolge, ovvero la grande massa degli immigrati che popolala città in quegli anni. Questa popolazione aveva, ovviamente, delle esigenzepressanti, prima fra tutte la casa, che solo parzialmente riuscirono a definirsicome problema collettivo. Banalmente: a Torino, come del resto in tuttaItalia, fu assente una vera e propria politica della casa, soprattutto nel primoperiodo di espansione, se non per mano, ancora una volta, della FIAT, checoncentrò però la costruzione di case intorno ai propri stabilimenti (perse-guendo, quindi, un preciso schema-immagine di sviluppo urbano). Forare lacappa rappresentata dall’immagini di Torino città del lavoro non era affattosemplice. Al centro dell’agenda politica, sociale ed economica dell’epocac’era una sola questione: la produzione. Ogni altra rappresentazione di desi-derio, necessità o disagio difficilmente riusciva a uscire allo scoperto e a esse-re presa adeguatamente in considerazione. Un altro processo simile è quellolegato alla rappresentazione delle istanze sociali di quella fascia di popolazio-ne che con il lavoro operaio c’entrava poco o nulla. Un esempio è quello,comune a tutta l’epoca fordista, delle esigenze della terza età o dei bambini:anziani e bambini sono completamente, culturalmente, assenti dal dibattitodel tempo in parte anche per il loro difficile inquadramento negli schemi,concettuali e immaginifici, del fordismo urbano.
Nel corso degli anni Settanta, i presupposti economici su cui si basava laconcentrazione industriale entrano in crisi. La crisi della città industrialefordista si accompagna a una crisi che investe non solo i centri produttivi, mala città nel suo complesso, in un periodo particolare della storia italiana. L’im-magine della città in crisi è esemplificata dalla contestazione, dal terrorismo,
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 125
dalle lotte nei quartieri, fino alla marcia dei quarantamila del 14 ottobre 1980(una rappresentazione ad arte dato, banalmente, che 40.000 non erano), chesegna un punto di rottura nella storia delle lotte sindacali in Italia. Cambianoper sempre, in questo contesto, i rapporti tra lavoratori, sindacati e grandeimpresa. E non solo: cambiano anche i meccanismi di rappresentazione dellacittà che passano da quelli impositivi, in mano a pochi, del pre-Ford (regi efascisti), a quelli industriali ed escludenti della città-fabbrica, a quelli ancorpiù frammentati, diffusi ma non per questo più democratici, della cittàpostfordista.
Il superamento del fordismo e l’avvio della transizione verso il postfordi-smo è segnato, non solo a Torino, da rilevanti ambiguità (Amin, 1994; Lebor-gne, Lipietz, 2002). Come scriveva anni fa Bagnasco (1990), sappiamo chesiamo “dopo Ford”, ma non sappiamo con chiarezza che cosa questo signifi-chi e comporti, se non l’affannosa ricerca da un lato di un modello di svilup-po urbano in grado di sostituire, o almeno completare, la tradizionale specia-lizzazione industriale, dall’altro lato di strumenti di rappresentazione (e dipotere) adatti alla nuova era. Era in cui, con una notevole differenza rispettoal passato, la città deve imparare a rappresentarsi non solo per sé stessa, maanche in rapporto al contesto globale.
Il passaggio verso la contemporaneità non è però immediato. Benché nonsia più evidentemente la one-company town dell’era fordista, Torino per alme-no due decenni continua a essere interpretata e interpretabile come città indu-striale. La netta prevalenza dell’organizzazione sul mercato spiegherebbe ilpermanere di molti caratteri della società locale: «Un’organizzazione econo-mica ancora troppo uniforme, una struttura sociale che va differenziandosisenza che ancora si siano delineati con nettezza nuovi attori ben strutturati,ma anche un sistema politico troppo fragile e troppo poco emancipato dallasocietà civile» (Bagnasco, 1986, p. 72). I caratteri strutturali dell’ambienteeconomico torinese, dopo un periodo di crisi e di conseguente ristrutturazio-ne, risultano così confermati, se non addirittura rafforzati; il modello econo-mico e socioculturale di riferimento, pur in una fase di ridefinizione, si conso-lida. Prende così peso un’interpretazione secondo la quale, a Torino, «laristrutturazione sia avvenuta nella più completa continuità» (Antonelli, 1990,p. 92), mantenendo anche quella dicotomia tra immagine unificata e unifi-cante ed eterogeneità del contesto locale di cui si è detto fino a ora.
Oggi Torino non è più quella città semplice, caratterizzata da un’orga-nizzazione sociospaziale facilmente individuabile, che si è costruita nel perio-do fordista. La città è molteplice, plurima, frammentata (Governa, Rossigno-lo, Saccomani, 2008). Ma siamo proprio sicuri che non lo sia sempre stata eche la rappresentazione dicotomica del periodo fordista, benché non privadi solide basi empiriche, non fosse comunque una rappresentazione sempli-
F R A N C E S C A G O V E R N A / M I C H E L E L A N C I O N E
126
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 126
6. L A C I T T À D E L S O C I A L E
127
ficata della città che ha finito per farsi immagine e quindi realtà? In altre paro-le, siamo proprio sicuri che la città fordista fosse più semplice, più chiara nellesue contrapposizione e nei suoi conflitti, più certa nelle sue differenze o taleimmagine-rappresentazione non nasconda in realtà una profondità di orga-nizzazioni sociospaziali sovrapposte che non riuscivamo a vedere prima eche oggi tendiamo a dimenticare?
6.3Torino oonn tthhee mmoovvee
Tra i processi di deindustrializzazione e la Torino di oggi vi sono alcunipassaggi chiave che se, da un lato, si sono giocati sulla mera morfologia urba-na, dall’altro lato hanno coinvolto a pieno anche la “morfologia sociale” dellacittà. Negli ultimi anni sembra essersi verificato, in altre parole, un vero eproprio processo di territorializzazione che ha cambiato le geografie e leimmagini della città (Governa, 1997; Dematteis, Governa, 2005). Dalla primatrasformazione del Lingotto (Pace, 2008) al veloce susseguirsi di idee e proget-ti per la costruzione della nuova città che hanno attraversato gli anni Novan-ta (De Rossi, Durbiano, 2006), Torino si è affacciata al nuovo millennio comeprima città italiana ad avere un piano strategico, come emblema del cambia-mento fordismo/postfordismo e con due megaeventi, l’uno in saccoccia (leOlimpiadi) e l’altro in preparazione (il centocinquantenario dell’Unità d’Ita-lia) (De Rossi, 2008).
Questa visione rosea delle cose è però solo parziale. Se è vero che Torinoha cambiato volto e immagine, è anche vero che questo progetto per la cittànon ha visto la partecipazione di (e non è stato concepito per) tutti i suoiabitanti. Non ci si riferisce, qui, agli inevitabili limiti della cosiddetta parteci-pazione al progetto locale (Cammelli, 2005; Donolo, 2005), quanto al fattoche l’immagine della nuova Torino è un prodotto particolare che, se puòdirci alcune cose sul capoluogo piemontese, ne tralascia altrettante. Questo èevidente anche nella letteratura, per immagini, sulle trasformazioni di Tori-no degli ultimi venti anni, dove ogni sorta di Spina, Passante e Parco sonopresi in considerazione (Bassignana, De Magistris, 2008), ma dove ben pocoo nulla si dice intorno a chi effettivamente usa (e quindi in un’ottica geografi-ca relazionale concretamente attiva) quelle trasformazioni (Whatmore, 2002).Nella nebulosa delle immagini della Torino postfordista, alcuni elementi dispicco ne oscurano altri.
Per cogliere a pieno questa affermazione in relazione alle immagini socia-li della città, è necessario compiere almeno due movimenti. Per prima cosa sipresenteranno le principali immagini della Torino “sociale” che emergonodalle politiche, dalla stampa e dalle iniziative in atto nella città. In secondo
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 127
luogo si procederà a evidenziare come queste rappresentazioni risultinoparziali e fuorvianti, considerando in particolare alcune immagini che nonsono emerse e che rimangono così all’ombra delle prime, in un contesto, quel-lo postfordista, in cui la molteplicità di immagini proposte, emerse e non, èindubbiamente maggiore rispetto al passato.
6.3.1. Immagini sociali di una Torino al 2011
Per cogliere le immagini della Torino sociale che accompagneranno la cittàverso il prossimo grande evento, il centocinquantenario dell’Unità d’Italia,partiamo dalle politiche messe in atto dalla città e in particolare dalle manife-stazioni mediatiche di tali politiche (come e quanto le stesse sono presentateall’esterno), senza tralasciare ovviamente anche le immagini che sono riuscitea emergere dalla società civile.
Le politiche sociali su cui il Comune di Torino ha investito molto negliultimi anni sono essenzialmente legate a quattro categorie:– le periferie e la rigenerazione urbana;– l’invecchiamento della popolazione e i servizi per gli anziani;– i flussi migratori;– le questioni di genere o più in generale quelle legate alla “cultura civica”.
Sono aspetti che riguardano sia Torino sia altre città italiane, su cui l’im-magine delle metropoli del nostro paese viene costruita quotidianamente, perpoi essere riflessa verso l’esterno come una bandiera (o una cartina tornaso-le). Basti pensare che, nell’annuale classifica sulla qualità della vita nelle cittàitaliane, promossa ogni anno da Italia Oggi, sono proprio questi i parametriche rivestono un ruolo fondamentale (Italia Oggi, 2008).
A partire dalla metà degli anni Novanta, Torino ha messo in atto una seriedi politiche di rigenerazione urbana su quelle parti di città che, da un lato, hannomaggiormente risentito del declino industriale e, dall’altro lato, abbisognavanodi interventi importanti volti a colmare i vuoti, infrastrutturali e di servizi, eredi-tati dal passato. Interventi come quelli coordinati dal Progetto speciale periferie(cfr. CAP. 8), si sono basati su «un inedito e per molti versi originale modello dilavoro intersettoriale e di cooperazione territoriale» (De Rossi, Durbiano, 2006,p. 84), attivando vere e proprie esperienze di sviluppo locale partecipato (Cittàdi Torino, 2003). Al di là dei limiti, o dei singoli pregi, degli interventi, quel che èimportante notare è l’immagine che emerge dagli stessi: quella di una Torinocoraggiosa, capace di innovare e di mettersi in gioco nel complesso campo dellarigenerazione urbana, diventando così un modello, almeno nel contesto italiano(Governa, Saccomani, 2004).
La seconda immagine è quella di una Torino attenta alla terza età. Le poli-tiche, i programmi e i progetti, anche di associazioni private, intorno agli
F R A N C E S C A G O V E R N A / M I C H E L E L A N C I O N E
128
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 128
6. L A C I T T À D E L S O C I A L E
129
anziani sono molteplici, così come molto ampia è la pubblicistica a riguardo.Uno dei settori del Comune, il Giovani, genitori e anziani (GGA), raccoglietutte le informazioni sui progetti in atto in Città, di tipo ludico e socioassi-stenziale (come i presìdi per gli anziani sparsi per tutta la Provincia – Città diTorino, 2008 – e i servizi di assistenza domiciliare offerti dal Comune)6. Tori-no quindi con i suoi 214.000 ultrasessantacinquenni residenti (al marzo 2008,con un incremento di 20.000 unità rispetto ai dati del censimento 20017),propone di sé un’immagine di città attenta sia alla cura sia allo svago della suapopolazione in terza età.
La terza immagine è connessa ai flussi migratori. Negli ultimi quindicianni, Torino è stata al centro di una vera e profonda trasformazione: in ordi-ne di arrivo, peruviani, marocchini, polacchi, rumeni, cinesi, hanno popolatosempre più alcuni quartieri della città. L’incremento di popolazione stranie-ra, per lo più extracomunitaria, è stato notevole: al 2008, risultano residentiin città 63.238 extracomunitari e 52.571 comunitari, con un incremento percen-tuale rispetto al 2007 dell’11,6% e un tasso sulla popolazione totale del 12,7%(Città di Torino – Settore statistica, Prefettura di Torino, 2008). La città hacercato di costruire un’immagine di sé come centro capace di accogliere, e dipromuovere, le differenze. Anche qui, come nel caso precedente, abbonda-no iniziative culturali e pubblicistica (anche di tipo “letterario” e non mera-mente commerciale, cfr. Vietti, 2008). Si passa dalle attività del Centro inter-culturale del Comune alle mostre destinate a promuovere la multiculturalitàpresenti ciclicamente in città8, a veri e propri progetti di inserimento socialefinanziati dalla UE e dalla città stessa (come quelli promossi nel quartiere diPorta Palazzo dall’agenzia di sviluppo The Gate). L’immagine della Torino“multietnica” si è creata, quindi, dall’incrocio di questi flussi migratori e diqueste iniziative promosse dalla città9, anche grazie a una notevole partecipa-zione della cosiddetta società civile che, soprattutto attraverso iniziativedell’associazionismo e del terzo settore (SERMIG, Cottolengo, Servizio migran-ti Caritas, Drop-in e Servizio accoglienza del Gruppo Abele, Alma mater ealtri), ha contribuito a proiettare un’immagine di Torino città dell’integra-zione, attenta ai temi del multiculturalismo e della multietnicità10.
È possibile riscontrare infine una quarta immagine della Torino socialeodierna, ed è quella legata alle questioni di cultura civica, quali quelle di gene-re, religione o discriminazione su base etnica. In questo campo Torino, oltrea supportare numerosi eventi culturali che contribuiscono a diffondere suscala nazionale un’immagine responsabile della città, organizza per iniziativadell’amministrazione comunale anche vere e proprie campagne di sensibiliz-zazione (non ultima quella avviata in collaborazione con l’ente Pubblicitàprogresso, relativa alle discriminazioni sulle donne in ambito familiare, che hacoinvolto anche numerose associazioni locali)11.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 129
Nel complesso, il set di immagini della Torino sociale è variegato, ma conver-gente (FIG. 6.2): Torino coraggiosa, che innova, che si prende cura dei proprianziani, che integra le molte etnie presenti, che promuove il rispetto di unacultura civica e rifiuta ogni discriminazione. Se queste sono le immagini dellaTorino sociale postfordista, per quanto esse siano politicamente corrette eaccattivanti, sorge un dubbio: c’è ancora qualcosa sotto la nebulosa o il discor-so può considerarsi esaurito?
F R A N C E S C A G O V E R N A / M I C H E L E L A N C I O N E
130
FIGURA 6.2Il variegato set di immagini messo in campo dalla città
A B
C D
Fonti: A. Slogan del Progetto speciale periferie (http://www.circololaquilone.org); B. Iniziative per gli anziani(http://www.comune.torino.it/servizisociali); C. Amare le differenze, installazione permanente a Porta Palazzo(http://www.comune.torino.it); D. Pubblicità progresso finanziata dal Comune (http://www.pubblicitaprogres-so.org).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 130
6. L A C I T T À D E L S O C I A L E
131
6.3.2. Le immagini nascoste dalla nebulosa
Il discorso non può considerarsi esaurito. Le questioni sociali che cercano dipromuovere la propria immagine, ovvero la propria rappresentazione dellarealtà, e che in qualche modo si annidano al di sotto o ai lati delle immaginipresentate in precedenza, sono infatti molte e variegate. Basti citarne due,emblematiche per il loro rapporto “conflittuale” con le precedenti: la prima,come immagine nascosta; la seconda, come immagine creata dagli effetti dellagovernmentality dell’immagine vincente.
Partiamo dalla questione dell’invecchiamento della popolazione. Torino,come si è detto, ha costruito e proiettato una particolare immagine in relazio-ne a questa tematica. Ma l’immagine della Torino attenta alla terza età nonesaurisce affatto la questione, che appare meno certa, chiara, netta di quantosi possa immaginare guardando all’immagine rassicurante di una città cheinvecchia accompagnando dignitosamente i singoli in tale inevitabile proces-so. Se guardiamo, ad esempio, la situazione degli anziani residenti nelle casepopolari del Comune, emerge una realtà fatta di istanze inascoltate, di biso-gni negati, di assenza di servizi adeguati. A ciò si aggiunga la sconsolata situa-zione delle politiche per gli anziani secondo quanto descritto da alcune asso-ciazioni (ad es. Città di Torino, Cooperativa Educamondo, 2007): un sistemafortemente segnato sia dalla mancanza di coordinamento tra le diverse inizia-tive proposte, sia dall’assenza di integrazione tra le politiche sociali messe inatto dal Comune. L’immagine della “cura” quindi sembra spesso fermarsiall’assistenza sanitaria e ludica, mentre appare assolutamente carente l’inte-grazione effettiva con altri aspetti (quali quello del reddito o quello della casa,cfr. CAP. 7).
Un valido esempio di conflitto tra immagine proposta e immagini latentiemerge invece considerando il rapporto tra l’immagine di Torino moderna eolimpica e gli effetti collaterali di questa rappresentazione sul territorio urba-no. Un esempio su tutti è lo spaccio e il consumo di droga in alcune aree speci-fiche della città12. Nell’ottobre del 2006, la stampa locale ha dato ampia eco aifatti di cronaca connessi allo spaccio di stupefacenti nell’area del cosiddetto“Tossic Park”, ovvero il Parco Stura, posto nella periferia nord della città neipressi dell’imbocco dell’autostrada per Milano. In questa zona, a partire dalfebbraio 2006, si è registrata un’elevatissima concentrazione di spacciatori,tanto che, per alcuni mesi, l’area è stata considerata la più grande piazza dispaccio di tutto il Nord Italia. Tale concentrazione è stata determinata, pereffetto domino, collaterale e ovviamente non voluto, dalle strategie messe inatto per “ripulire” le aree centrali della città durante le Olimpiadi invernali.Nel periodo olimpico, le consuete aree di spaccio torinesi (via Nizza, i Muraz-zi del Po, Porta Palazzo) sono state militarizzate, sottoposte a intensi e conti-
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 131
nui controlli, impedendo di fatto il commercio di stupefacenti. La Torinodella droga non poteva essere assolutamente accettata accanto alla Torinoolimpica. Gran parte dello spaccio di droga è stato così spostato, di fatto, dallearee centrali alla zona dell Parco Stura, che presentava un ulteriore vantaggiolocalizzativo. La vicinanza con l’autostrada si è infatti rivelata un atout strate-gico, in quanto ha aumentato l’accessibilità al mercato degli stupefacenti,permettendo anche l’ampiamento delle dimensioni dello stesso. Nel comples-so, quindi, un’azione del Comune, attuata durante l’evento Torino 2006 efunzionale all’immagine di Torino città olimpica, ha concorso a creare unaquestione sociale prima e la relativa rappresentazione poi (da Parco Stura aTossik Park) in un’altra area della città. Il conflitto, anche sociale, conse-guente a questa operazione si è reso particolarmente evidente nel momento incui i cittadini di Barriera di Milano, il quartiere adiacente al parco, hannoiniziato a organizzarsi in ronde per proteggere il quartiere e per cambiare l’im-magine negativa che andava sedimentandosi.
Se le immagini della Torino sociale presentate nel PAR. 6.3.1 sono perfet-tamente coerenti sia con l’idea di una Torino internazionale e multietnica(centri culturali, manifestazioni, iniziative ecc.) sia con una Torino anziana,ma capace di essere innovativa nell’affrontare il problema della terza età, visono però tutta una serie di questioni sociali, dalla povertà sempre più diffu-sa alle situazioni di più grave disagio, che non rientrano con la stessa facilitàsotto l’immagine di una Torino internazionale, aperta, innovativa, solidale. Visono, per così dire, dei vuoti, dei veri e propri coni d’ombra nascosti nella (ea volti creati dalla) nebulosa delle immagini presenti in città.
Ciò non vuole affatto essere a sostegno dell’ipotesi che nulla sia cambia-to, che Torino non sia effettivamente in movimento né che alcune politicheintraprese negli ultimi anni non abbiano portato a risultati concreti. Il Pianodei servizi sociali del Comune (Città di Torino, 2003) è molto articolato, toccamolteplici realtà, fornisce un’immagine complessa ed eterogenea della Tori-no sociale (così come il Piano regolatore ssoocciiaallee ##??## della città13). Ma per pren-dere sul serio le possibilità costruttive e prospettiche delle immagini, è neces-sario ridiscutere e reinterpretare sia le immagini sedimentatesi negli anni, siaquelle che non sono mai riuscite a emergere. Se è vero che ciò che si vede èinfluenzato da ciò in cui crediamo (Berger, 1972), le immagini e le descrizionidella Torino sociale odierna devono essere ridiscusse in un quadro ampio,esteso anche a quelle marginalità presenti oggi nella rete allargata degli spazidella città (Massey, 2004). Le immagini con cui la città si presenta contano (siaper chi le vede, sia per chi attraverso le stesse è visto, cfr. Rose, 2007), e devo-no quindi essere rilette alla luce della complessità geografica della cittàpostfordista, aperta a flussi, sfide e problemi prima inimmaginabili (Amin,Thrift, 2004). Questo vale naturalmente per Torino e per tutte le altre città
F R A N C E S C A G O V E R N A / M I C H E L E L A N C I O N E
132
#co
me
dir
eg
ener
ale?
#
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 132
6. L A C I T T À D E L S O C I A L E
133
italiane in cui simili ridefinizioni sembrano essere l’unico mezzo plausibile perattuare politiche urbane realmente inclusive o, per dirla altrimenti, concreta-mente on the move.
6.4Conclusioni: come cambia la genesi e la forza delle immagini
Descrivere il rapporto tra territori e immagini come una nebulosa, che si formaattraverso il potere di chi è in ballo, e che diffonde il suo potere oltre i confini delterritorio stesso, pone la necessità di affrontare la questione delle immagini dellecittà alla luce della complessità geografica delle città stesse. Per analizzare imeccanismi di questa nebulosa e per tentare di governarli, si rende in altre paro-le necessario l’utilizzo di un’ottica capace di cogliere il movimento e di rappre-sentare puntualmente i giochi di forza tra le immagini messe in campo.
L’ottica attraverso la quale si leggono le immagini territoriali, sia neldibattito pubblico sia attraverso il marketing che le ripropone, è infatti senzadubbio puntuale e ha come risultato, in genere, di proporre immagini mono-litiche ed esclusive: “Torino città industriale”, “Torino attore collettivo” ecc.Una simile lettura non restituisce però pienamente l’eterogeneità non solodegli elementi che compongono il territorio (cfr. CAP. 1), ma anche dei poteria cui questi elementi sono sottoposti e che a loro volta emanano. Né tanto-meno è capace di cogliere quel flash of the unexpected (il cambiamento) (Law,Mol, 1994 ) che caratterizza senza ombra di dubbio la creazione dello spaziosociale nelle città. La costruzione e la lettura delle immagini urbane risultaquindi spesso statica, rivolta a individuare ciò che emerge e non ciò che rima-ne sotto. Soprattutto, le immagini così prodotte (volontariamente e non),riprodotte e lette giustificano automaticamente la rappresentazione stessa(che diviene una sorta di mantra, o di verità assoluta) e, allo stesso tempo, neassumono l’ineludibilità. Le immagini risultano così non solo possibili, maaddirittura inevitabili. Questa lettura delle immagini non permette però dicogliere adeguatamente tutte le discrasie e dicotomie che si creano tra imma-gine e realtà e che hanno un’elevata carica di responsabilità politica e sociale.
Le immagini, per volontà dei singoli, delle organizzazioni o per imprevi-sto, si formano. Ma qualcosa può forse essere detto e fatto in relazione allaloro produzione e alla loro gestione. Per rispondere, almeno parzialmente,alla necessità di dotarsi di strumenti utili a governare tali limiti, è necessarioun cambio di ottica, che rimandi in particolare a una visione dinamica delleimmagini e del loro processo di emersione/non emersione. In questa prospet-tiva, la comprensione delle immagini urbane può forse essere condotta utiliz-zando la metafora del caleidoscopio, uno strumento che da un lato produce edall’altro permette di leggere delle immagini. Il caleidoscopio permette così
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 133
di evocare i meccanismi della nebuolosa in cui si formano le immagini urba-ne: gli elementi nel caleidoscopio si muovono, proiettano immagini checoncorrono a formare un’immagine di insieme che è inevitabilmente impre-cisa, multiforme e soprattutto non semplicemente rappresentabile.
Leggere la realtà delle immagini attraverso la metafora del caleidoscopiopermette di comprendere che, data l’eterogeneità e la frammentazione delleimmagini, delle rappresentazioni, delle istanze che popolano l’universo urba-no, questo insieme rifugge l’inevitabilità della rappresentazione perché perdefinizione non è in grado di chiarire, fissare e proiettare un’unica verità.Leggere le immagini che la città produce attraverso la metafora del caleido-scopio porta ineludibilmente a rigettare di per sé il concetto di rappresenta-zione. Alla base di questa metafora vi è quindi l’accettazione dell’impossibi-lità di rappresentare univocamente i processi sociali, sia per la lorocomplessità, sia per il semplice fatto che tutti, chi più chi meno, siamo “radi-cati” dentro quegli stessi procesi (come Thrift, con la sua non-representatio-nal theory sostiene da anni, cfr. Thrift, 2000, 2008).
Dovremmo quindi rifiutare completamente le rappresentazioni? È questala via di uscita dall’impasse in cui siamo caduti? Certamente no, e questo peralmeno due motivi. In primo luogo, perché le immagini, e le rappresentazio-ni, sono spesso inevitabili (non volute, non cercate); in secondo luogo, perchéesse sembrano essere divenute sempre più un motore della presunta compe-tizione tra città nell’economia globale (e quindi ci si deve fare i conti).
Si può però ipotizzare un diverso modo di agire, soprattutto per chi leimmagini le costruisce e le promuove consciamente. Una diversa etica dell’u-tilizzo delle immagini urbane. In questo senso una politica responsabile devesostenere il territorio non promuovendone immagini stereotipate e costruite atavolino, ma analizzando le pratiche del territorio e successivamente promuo-vendo l’emersione, lo sviluppo delle rappresentazioni o anche la loro conclu-sione. Quello che deve essere incentivato non è lo sviluppo di immagini di persé, quanto lo sviluppo dei canali sociali attraverso cui le pratiche che costrui-scono il territorio possano emergere e certamente anche confliggere, per poisedimentarsi. Si tratta in altre parole di sostenere pratiche volte non allarappresentazione tout court, ma l’esatto contrario: pratiche – applicando l’ideadi Thrift non solo concettualmente, ma alle concrete dinamiche di processo –di non rappresentazione, in cui l’obiettivo non è produrre immagini chiare edefinitite, ma caleidoscopi in cui gli elementi possano effettivamente entrare ingioco tra loro e costituire rappresentazioni in movimento.
Concludendo, con non più che una suggestione, le “non rappresentazio-ni”, in questo senso possono essere intese come pratiche di partecipazione,coinvolgimento, ascolto, volte a due scopi principali: favorire l’emersione diimmagini che non riescono a emergere o che non riescono neppure ad artico-
F R A N C E S C A G O V E R N A / M I C H E L E L A N C I O N E
134
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 134
6. L A C I T T À D E L S O C I A L E
135
larsi e studiare gli effetti che le immagini che emergeranno potrebberoprodurre sulla città attraverso il loro ineludibile potere discorsivo. Schemati-camente, invochiamo la necessità di:– rendere conto della molteplicità urbana (l’eterogeneità dei suoi attori,delle loro istanze, dei loro poteri);– affermare l’impossibilità di ridurre tale molteplicità a delle rappresenta-zioni statiche (immagini che si impongono sulle altre), cosa che sostiene impli-citamente, con la sua non-representational theory, anche Thrift;– che è quindi necessario procedere non a rappresentazioni, ma a pratichedi non-rappresentazione, cioè a pratiche volte a rendere evidenti complessitàe molteplicità del rapporto tra attori/istanze/rappresentazioni, promuoven-do discorsi inclusivi e in divenire, indipendenti dal risultato che si raggiungerà.
In questa sede non è possibile approfondire ulteriormente tale sugge-stione, dato che si è preferito concentrarsi sull’analisi del processo di emer-sione e formazione delle immagini più che sull’analisi delle dinamiche di pote-re che effettivamente permettono a questa o quella immagine di divenirepredominante – e politicamente rilevante – rispetto alle altre (un aspettocentrale su cui concentreremo i nostri sforzi futuri). Ciononostante è possi-bile sostenere fin da ora la necessità di interrompere i meccanismi per cuialcune istanze si impongono, al di fuori di un vero e proprio processo dialet-tico, su tutte le altre. Si tratterebbe, in altre parole, di gestire il processo dicreazione delle immagini, partendo dal presupposto che prima della rappre-sentazione la Città dovrebbe porsi il problema della non rappresentazione:ovvero dei sistemi, dei meccanismi e dei poteri che rendono possibile da unlato e impediscono dall’altro la rappresentazione delle molteplici istanzedell’odierno mondo urbano. L’idea di fondo è quindi l’impossibilità concet-tuale e fattuale – per la sua banalità – di rendere i territori urbani attraversoqualsivoglia slogan. Ciò non significa, in ultima analisi, sostenere che esista-no immagini “buone” e altre meno opportune. Tutt’altro: si tratta semplice-mente di rendersi conto che la rappresentazione è di per sé riduttiva, esclusi-va, produttrice di limiti (attraverso il suo potere discorsivo) e in apertocontrasto con la molteplicità della città contemporanea. Essa va quindicombattuta, lavorando maggiormente sulle dinamiche di processo e sulle sueopportunità e costrizioni, indipendentemente dai risultati (buoni per gli uni emeno per gli altri) che proprio da tale processo emergeranno.
Note
1.@Il capitolo è frutto di una riflessione comune. Si possono attribuire i PARR. 6.1 e 6.4 aentrambi gli autori; il PAR. 6.2 a Francesca Governa e il PAR. 6.3 a Michele Lancione.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 135
2.@Secchi (2000) in realtà parla di “figure”, intendendo con questo termine, a un livelloastratto, qualcosa che ha «un ruolo costruttivo, di organizzazione del nostro pensiero» e, «all’e-stremo opposto e a un livello apparentemente meno astratto, forme di città» (ivi, p. 10).
3.@Se il diagramma di potere è una forza che «definisce e progetta una certa verità dellacittà, una verità che sottende un insieme di tentativi di rendere l’esistenza urbana allo stessotempo più e meno simile a quello che si intende con “città”» (Osborne, Rose, 1999, p. 5) e ilpotere stesso è una forza che non è controllata da questo o da quello, ma semmai dalla qualesiamo tutti «investiti, marchiati, forzati dal compiere azioni, dal performare eventi, dall’emet-tere segni» (Foucault, 1991, p. 25, trad. nostra); la rappresentazione, con i significati che espri-me, non può, per definizione, essere neutra.
4.@È forse vero quindi che Torino non riesce ad autorappresentarsi che come capitale«non importa se di un regno o di un settore industriale oppure del mondo del lavoro»(Deaglio, 1991, p. 471). L’idea “Torino capitale” ha raggiunto, in anni recenti, un livello paros-sistico: nel corso degli ultimi anni Torino è stata, per citare a caso, capitale del libro, del cine-ma, dell’albero, del design ecc. (cfr. CAP. 4).
5.@Tale dicotomia è comunque mediata da quel fenomeno che Gallino (1990) chiama“riproduzione della struttura latente” e che denota, a Torino, il permanere di alcuni tratti difondo di una comune ideologia del lavoro: la tradizione del pensiero gramsciano basato sull’e-saltazione della competenza e della professionalità dell’operaio di mestiere o il riprodursi della«cultura laburista, […] [del] doverismo che nasce dal lavoro e sul lavoro si riproietta, […][dello] sfondo industriale della cultura» (ivi, p. 359).
6.@Cfr. il sito http://www.comune.torino.it/gga/ (ultimo accesso febbraio 2009).7.@Elaborazione dati dal sito internet dell’Ufficio Statistico del Comune di Torino
(http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/).8.@Cfr. il sito http://www.comune.torino.it/intercultura/s1.asp?p1=SERVIZI&p2=
Mostre%20e%20kit%20didattici&temp=_home (ultimo accesso febbraio 2009).9.@È interessante notare inoltre che proprio di un’immagine si tratta in quanto il Centro
interculturale ricade, nel sito internet del Comune, sotto il canale Arte e cultura (cfr. http://www.comune.torino.it/intercultura/lh.asp?p1=HOME&p2=Pagina%20iniziale&temp=_home).
10.@A questo proposito basti ricordare che Torino è da anni la sede di numerosi eventiorganizzati da e per stranieri proprio dall’associazionismo locale: si veda il sito internet di Tori-no intercultura http://www.comune.torino.it/intercultura.
11.@Cfr. http://www.pubblicitaprogresso.org/campagnap.aspx?id=475 (ultimo accessofebbraio 2009).
12.@La ricostruzione è stata effettuata consultando diverse fonti, tra le quali articoli dellacronaca locale (ultimo accesso febbraio 2009): La Stampa (http://www.lastampa.it/redazio-ne/cmsSezioni/torino/200610articoli/11522girata.asp); La Repubblica (http://newscontrol.repubblica.it/tag/tossic+park); ACMOS (http://www.acmos.net/modules.php?name=News&file=article&sid=445); Diritti globali (http://www.dirittiglobali.it/articolo.php?id_news=3882).
13.@Cfr. il sito internet http://www.torino-internazionale.org/IT/Page/t07/view_html?idp=3275 (ultimo accesso febbraio 2009).
Bibliografia
AA.VV. (1994), Il sogno della città industriale. Torino fra 800 e 900, Fabbri, Milano.AMIN A. (ed.) (1994), Postfordism: A Reader, Blackwell, Oxford.
F R A N C E S C A G O V E R N A / M I C H E L E L A N C I O N E
136
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 136
6. L A C I T T À D E L S O C I A L E
137
AMIN A., THRIFT N. (2002), Cities, Re-imaging the Urban, Polity, Cambridge.IDD. (2004), The “Emancipatory” City?, in L. Lees (ed.), The Emancipatory City?
Paradoxes and Possibilities, Sage, London.ANTONELLI C. (1990), L’economia fra mercato e organizzazione, in Bagnasco (1990),
pp. 92-107.BAGNASCO A. (1986), Torino. Un profilo sociologico, Einaudi, Torino.ID. (1988), Torino: la città e la fabbrica, in “Spazio e Società”, 42, pp. 84-7.ID. (a cura di) (1990), La città dopo Ford. Il caso di Torino, Bollati Boringhieri, Torino.BASSIGNANA P. L., DE MAGISTRIS A. (2008), La nuova Torino. Com’era, com’è, Alleman-
di, Torino.BERGER J. (1972), Ways of Seeing, Penguins, London.CAMMELLI M. (2005), Considerazioni minime in tema di arene deliberative, in “Stato e
Mercato”, 73, pp. 89-96.CITTÀ DI TORINO (2003), Periferie. Il cuore della città. 100 buone pratiche, sei anni di svilup-
po locale partecipato nelle periferie di Torino (1998-2003), Progetto periferie Città diTorino, Torino.
ID. (2008), Scheda dei presìdi – Rubrica dei presìdi per gli anziani, Torino.CITTÀ DI TORINO – SETTORE STATISTICA, PREFETTURA DI TORINO (2008), Osservatorio
interistituzionale sugli stranieri in Provincia di Torino. Rapporto 2008, Torino.CITTÀ DI TORINO, COOPERATIVA EDUCAMONDO (2007), Le famiglie degli anziani a Tori-
no: ricerca sulla qualità della vita nell’ambito delle nuove povertà, CooperativaEducamondo, Torino.
CRAMPTON J. W., ELDEN S. (eds.) (2007), Space, Knowledge and Power. Foucault andGeography, Ashgate, Aldershot.
DAVIS B. (2008), The City as Theater of Protest: West Berlin and West Germany, 1962-1983, in G. Prakash, M. K. Kruse (eds.), The Spaces of the Modern City, PrincetonUniversity Press, Princeton.
DEAGLIO M. (1991), Torino e il Piemonte: un declino arrestabile?, in L. Mazza,A. Pichierri, Le trasformazioni territoriali in Piemonte, in “Atti e Rassegna Tecni-ca della Società degli Ingegneri e Architetti in Torino”, 9-10, pp. 435-80.
DEMATTEIS G. (1995), Immagine e identità urbana: metafore spaziali e agire sociale, in“Critica della Razionalità Urbanistica”, 3, pp. 88-93.
DEMATTEIS G., GOVERNA F. (a cura di) (2005), Territorialità, sviluppo locale, sostenibi-lità: il modello SLoT, FrancoAngeli, Milano.
DE ROSSI A. (2008), TO-morrow, in A. Bagnasco, C. Olmo (a cura di), Torino 011.Biografia di una città, Mondadori Electa, Milano.
DE ROSSI A., DURBIANO G. (2006), Torino 1980-2011. La trasformazione e le sue immagi-ni, Allemandi & C., Torino.
DONOLO C. (2005), Dalle politiche pubbliche alle pratiche sociali nella produzione dibeni pubblici? Osservazioni su una nuova generazione di policies, in “Stato eMercato”, 73, pp. 33-65.
ELDEN S. (2007), Rethinking Governmentality, in “Political Geography”, 26, 1, pp. 29-33.FOUCAULT M. (1991), Discipline and Punish. The Birth of the Prison, Penguins, London.GABERT P. (1964), Turin. Ville industrielle, Presses Universitaires de France, Paris.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 137
GALLINO L. (1990), Policy making in condizioni avverse, in Bagnasco (1990), pp. 68-91.GOVERNA F. (1997), Il milieu urbano. L’identità territoriale nei processi di sviluppo,
FrancoAngeli, Milano.GOVERNA F., ROSSIGNOLO C., SACCOMANI S. (2008), Torino. Le molte periferie della città
post-industriale, in L. Fregolent (a cura di), Periferia e Periferie, Aracne, Roma.GOVERNA F., SACCOMANI S. (2004), From Urban Renewal to Local Development. New
Conceptions and Governance Practices in the Italian Peripheries, in “Planningtheory and Practice”, 5, 3, pp. 327-48.
HUXLEY M. (2007), Geographies of Governmentality, in J. W. Crampton, S. Elden(eds.), Space, Knowledge and Power. Foucault and Geography, Ashgate, Alder-shot.
ITALIA OGGI (2008), Rapporto sulla qualità delle vita nelle città italiane, Classeditori,Milano.
LATOUR B. (2005), Reassembling the Social, Oxford University Press, Oxford.LAW J., MOL A. (1994), Regions, Networks and Fluids: Anaemia and Social Topology, in
“Social Studies of Science”, 24, pp. 641-71.LEBORGNE D., LIPIETZ A. (2002), L’après-fordisme et son espace, in “Géographie,
Économie et Société”, 4, pp. 489-513.MASSEY D. (2004), Geographies of Responsibility, in “Geographiska Annaler”, 86B, 1,
pp. 5-18.OSBORNE T., ROSE N. (1999), Governing Cities, in “Environment and Planning D”, 17,
pp. 737-70.PACE S. (2008), Architettura e società a Torino negli anni Ottanta e Novanta, in
A. Bagnasco, C. Olmo (a cura di), Torino 011. Biografia di una città, MondadoriElecta, Milano.
PAINTER J. (1995), Politics, Geography and “Political Geography”, Arnold, London.ROSE G. (2007), Visual Methodologies, Sage, London.SECCHI B. (2000), Prima lezione di urbanistica, Laterza, Roma-Bari.SPRIANO G. (1980), Storia di Torino operaia e socialista, Einaudi, Torino.THRIFT N. (2000), Afterwords, in “Environment and Planning D”, 18, 2, pp. 213-55.ID. (2008), Non-Representational Theory. Space, Politics, Affect, Routledge, London.VIETTI F. (a cura di) (2008), Torino è casa nostra, Mangrovie, Napoli.WHATMORE S. (2002), Hybrid Geographies. Natures Cultures Spaces, Sage, London.WOOD D. M. (2007), Beyond the Panopticon? Foucault and Surveillance Studies, in
J. W. Crampton, S. Elden (eds.), Space, Knowledge and Power. Foucault andGeography, Ashgate, Aldershot.
F R A N C E S C A G O V E R N A / M I C H E L E L A N C I O N E
138
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 138
139
7La nuova questione abitativa:
disagio, politiche e territorio urbanodi Alberta de Luca e Michele Lancione1
7.1Introduzione
La questione abitativa è una delle prospettive più significative dalle qualiosservare e analizzare le dinamiche che oggi sottopongono le città a continuetrasformazioni (Mayer, 1994; Le Galès, 2006). I fenomeni di segmentazione ediseguaglianze che interessano le città (Sassen, 2000) si rendono particolar-mente evidenti nei processi di esclusione abitativa che coinvolgono personemai colpite prima d’ora da un simile disagio.
La questione abitativa, indagata su scala urbana, è però un campo dianalisi ancora piuttosto inesplorato, dal momento che la maggior parte deicontributi si concentra alla scala nazionale o macroregionale, fornendo anali-si di contesto o descrivendo il ruolo dei diversi attori (Priemus, Dieleman,2002; Doherty, 2004; Doiling, 2006). Le esperienze urbane, quando presenti,si riferiscono ai noti casi del Centro-Nord Europa, mentre un’attenzioneancora modesta è riservata all’Europa del Sud, salvo rarissime eccezioni(Allen, 2006).
Lo sguardo su Torino assume per questo motivo particolare interesse,sebbene rappresenti una delle possibili esperienze nell’ampio e variegatocontesto del Sud Europa. Esso declina infatti al suo interno dinamiche disviluppo – presenti e passate – estremamente diverse nonché domande erisposte abitative differenti.
Prima di fotografare le immagini attuali della questione abitativa, è peròopportuno fare un passo indietro e ricalcare i tratti salienti del passato,rispetto ai quali si misura il cambiamento degli ultimi anni. Il primo passag-gio delinea il disagio abitativo della Torino fordista e le politiche cosiddettedi “prima generazione”. Il secondo consiste nella rappresentazione dei nuovitermini della questione abitativa a partire dal caso torinese: alla descrizionedel disagio e della sua localizzazione segue la rassegna sulle politiche cosid-dette di “seconda generazione”. Nel passaggio conclusivo, da un lato si riflet-te sulle trasformazioni che la città ha conosciuto sotto la spinta di una
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 139
domanda abitativa sempre più consistente e complessa e degli interventirealizzati per farvi fronte, dall’altro su alcuni caratteri della “nuova questio-ne abitativa” che svolgono una funzione rilevante nei processi di trasforma-zione delle città.
7.2La questione abitativa nella Torino fordista
7.2.1. Il disagio abitativo nella Torino industriale
I problemi abitativi della Torino fordista vengono da lontano. Il punto dipartenza può essere fissato nel primo inurbamento seguito alla crisi dell’agri-coltura negli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia – che mise adura prova la tenuta del sistema dei borghi ottocenteschi come Borgo Dora –o nei primi venti anni del Novecento con la relativa rapida espansione delsistema FIAT2. In quegli anni la popolazione, in rapida crescita, si installaprevalentemente all’esterno della cinta daziaria. In questa frontiera tra città ecampagna, dove sia i costi di costruzione sia quelli della vita sono meno eleva-ti, la popolazione aumenta nel periodo 1881-1911 del 117,3% (Angeli, Castro-villi, Seminara, 1998).
Il punto di svolta è da riscontrarsi in piena epoca fascista, con l’aperturadello stabilimento FIAT-Mirafiori (1939) nella zona sud del perimetro urbano.Da quel momento il flusso migratorio verso la città, sia dalle campagne circo-stanti sia dal Veneto e dal Meridione d’Italia, continua ad aumentare (Levi,1999), con un passaggio tra il 1950 e il 1965 da 3.000 a 40.000 residenti nella solazona di Mirafiori3.
Tra il luglio 1956 e il giugno 1957 (ma il trend si ripete nel corso dell’interodecennio e fino alla metà degli anni Sessanta), il flusso dei “nuovi arrivati” ènotevole. La nuova popolazione si concentra al centro, al Nord e a Sud-Ovestdella città: i meridionali si addensano al Nord e al Centro mentre a ovest e asud – dove un numero considerevole di abitazioni è costituito dagli alloggidelle grandi società metallurgiche che danno impiego a una manodoperaqualificata – si insediano prevalentemente piemontesi e, in generale, italianidel Nord (FIG. 7.1).
In mancanza di precisi interventi pubblici che, come si vedrà, comince-ranno con il Programma INA-Casa, Torino si trova impreparata ad affrontareil problema casa strettamente interconnesso con la rapida espansione dellaFIAT e del suo indotto.
In questo contesto sono tre gli aspetti localizzativi più rilevanti del disa-gio abitativo di quegli anni, ognuno relativo alle modalità attraverso le quali imigranti cercano di colmare l’assenza di una precisa politica abitativa.
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
140
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 140
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
141
In primis, la diffusione di sistemazioni di fortuna ai margini della città e nelleimmediate vicinanze dei maggiori centri produttivi. La figura dell’immigrato“baraccato”, privo dell’accesso ad acqua corrente, riscaldamento ed elettri-cità, entra nell’immaginario collettivo torinese e non. Meridionali, veneti-istriani e piemontesi trovano riparo nelle baracche in corso Polonia, al Marti-netto, sul lungo Dora Colletta, a Nichelino, in viale Michelotti, alle Basse diStura, lungo il Sangone, alla Pellerina, in corso XI febbraio, in via Lavagna, viaZini e sulla collina di Superga.
In secondo luogo viene a crearsi un disagio prodotto dall’unica rispostapubblica fornita in quegli anni, ovvero la concentrazione di ex baraccati e
FIGURA 7.1I nuovi arrivati a Torino nel 19574
Fonte: Gabert (1964).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 141
nullatenenti prevalentemente in edifici pubblici preesistenti: l’ex cartiera dicorso Regio Parco 139, in cui vivevano più di 150 famiglie su quattro piani conquattro latrine per piano, in condizioni igieniche e ambientali facilmenteimmaginabili (Angeli, Castrovilli, Seminara, 1998); le numerose “casermette”di proprietà dell’Ente comunale di assistenza e l’asilo notturno di via Ormea119 dove erano ospitati lavoratori meridionali, profughi e sfrattati in condi-zioni di vita ancora molto precarie.
In terzo luogo il disagio che, come accade frequentemente dopo un perio-do di baraccamento, trova risposta in sistemazioni di fortuna perlopiù rica-vate nelle soffitte delle case situate nei vecchi borghi ottocenteschi. Qui, inparticolare, oltre ai soliti problemi di sovraffollamento, si creano i maggioriconflitti con i natii torinesi (i famosi cartelli “non si affitta ai meridionali”ben fotografavano questa realtà).
Fatta eccezione che per quest’ultima tipologia, la geografia localizzativadi tali insediamenti residenziali ricalca per lo più la distribuzione dell’espan-sione FIAT in città (De Magistris, 1999). Baracche, sistemazioni di fortuna erisposta pubblica (minima) al disagio si concentrano, in altre parole, a ridos-so dei più grandi complessi industriali dell’epoca: Mirafiori a sud e le zonedell’indotto (come la Michelin) a nord, andando a occupare tutti gli spazi libe-ri e portando praticamente alla saturazione il territorio comunale (Governa,Rossignolo, Saccomani, 2008).
7.2.2. Le politiche di prima generazione: dal Testo Unico del 1938 alla conclusione
del Piano decennale di edilizia residenziale pubblica del 19785
Oltre alle sistemazioni di fortuna appena descritte, estemporanee e provviso-rie, si articola in questi anni, mediante il Programma INA-Casa, l’interventodello Stato che si forgia su un approccio meramente quantitativo, ovveropuntando esclusivamente alla produzione di alloggi.
Ciò accade nella maggior parte dei paesi industrializzati, dove la situa-zione si articola però in modo a volte anche molto differente; al di là deglielementi di differenziazione, nel periodo che va dagli anni Cinquanta allafine degli anni Settanta, ovunque in Europa occidentale cresce il numero diabitazioni fino a superare il numero delle famiglie, aumenta vertiginosamen-te il titolo di proprietà e migliora la qualità complessiva delle abitazioni.
Torino riflette queste tendenze e sul versante dell’affitto elabora politicheche si basano sull’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata a canonesociale – mediante fondi statali – per consentire alle famiglie recentementeinurbate di lavorare in città. Quasi tutti gli alloggi di edilizia residenzialepubblica (ERP) della città sono sorti in questi anni6.
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
142
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 142
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
143
La peculiarità di Torino sta nel fatto che a realizzare questo interventonon sono unicamente l’Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) e l’Istitutoautonomo case popolari: un ruolo fondamentale lo svolge, ancora una volta,la FIAT. Se fino al 1949 la sua strategia residenziale si era caratterizzata per laframmentarietà e la limitatezza delle proposte, soprattutto rispetto alle altreiniziative in campo sociale (in particolare per l’assistenza sociale e la forma-zione), tra il 1949 e il 1952 la FIAT realizza con l’INA 2.000 alloggi (prevalente-mente a Torino e, in maniera più limitata, ad Avigliana, Chieri, Moncalieri eCollegno)7. Successivamente, dal 1955 al 1957 realizza autonomamente il Pianocase FIAT per 2.500 alloggi i cui criteri di assegnazione rivelano un forte pater-nalismo aziendale, basti pensare che i contratti di locazione decadevano nelcaso di fine contratto8. In particolare, possono essere evidenziati due grandiinsediamenti al Sud della città, uno (circa 1.000 alloggi) vicino agli stabilimentiMirafiori e Lingotto, l’altro (circa 750 alloggi) in corso Giamone e quello anord, nei pressi di corso Grosseto (circa 850 alloggi) (nella FIG. 7.2 indicatirispettivamente con i numeri 1, 3 e 2).
Sorgono numerosi complessi edilizi, ubicati spesso vicino agli stabili-menti: Lingotto, con fondi INA ma realizzato direttamente dalla FIAT, Sospel-lo, Lucento, Falchera e Racconigi ospitano per lo più piemontesi, torinesi,veneti, molti profughi giuliani e in misura minore meridionali; alle Vallette, siconcentra invece la popolazione proveniente dal Sud Italia. La città pubblicasi sviluppa, in questo modo, nelle campagne metropolitane, con la costruzio-ne di grandi quartieri monoceto (forza lavoro immigrata), monofunzione(quartieri dormitorio privi, in genere, di urbanizzazioni secondarie) e di scar-sa qualità, fatta eccezione per le Vallette, primo quartiere progettato con crite-ri residenziali diversi dai soliti quartieri-dormitorio.
Agli inizi degli anni Sessanta, riprendono gli interventi a livello comuna-le: nel 1962 l’Ente comunale assistenziale crea un centro per immigrati, picco-lo villaggio di 600 appartamenti che diventa presto un ghetto provvisorio maobbligato; con il piano Torino-Case, il Comune costruisce altri 816 alloggi.Tuttavia, la consistenza di questi interventi è piuttosto marginale, conside-rando che tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta siregistra il picco massimo di crescita della città e il numero di richieste di allog-gi si aggira intorno alle 15.000 unità.
Un intervento più decisivo avviene solo alla fine degli anni Settanta quan-do sono varati, a livello nazionale e mediante la legge 457/1978, il Piano decen-nale per l’edilizia e il Programma straordinario per i Comuni a elevata tensio-ne abitativa.
Nel frattempo, il disagio abitativo sin qui tratteggiato inizia a declinare, inparte riflettendo il declino industriale degli anni successivi (quando la cittàsmette di attirare popolazione) e in parte trasformandosi. Il disagio abitativo,
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 143
come si vedrà successivamente, assume connotati meno legati alla questioneabitativa in senso stretto (possedere un tetto dove dormire) e più vicini all’a-bitare così come inteso da Tosi (1994), ovvero come condizione sociale di cui
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
144
FIGURA 7.2I complessi residenziali realizzati dalla FIAT
Fonte: nostra elaborazione da Gabert (1964).
#il n
umer
o 11
èvi
cino
al 4
?#
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 144
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
145
il “tetto” è solo una delle componenti, insieme ai servizi, la qualità dell’urba-nizzato e la socialità.
Per il Piano decennale e il Programma sperimentale, i finanziamenti chela Regione Piemonte ottiene sono indirizzati sia all’edilizia sovvenzionatache a quella agevolata e impiegati per la manutenzione straordinaria.Complessivamente vengono costruiti 12.400 alloggi dall’Istituto autonomocase popolari e dai Comuni e 21.300 alloggi da imprese e cooperative.
La localizzazione di questi interventi prosegue la tendenza avviata prece-dentemente a espandersi al di là dei confini comunali. A causa della satura-zione delle aree interne al proprio perimetro infatti la città dà risposta alladomanda abitativa nei comuni limitrofi. Se si prende in considerazione l’areametropolitana – nella delimitazione proposta nel 1972 dalla Regione ecomprendente i ventitré Comuni attorno a Torino e i ventinove Comuniconfinanti – si può notare che le nuove costruzioni si realizzano soprattuttonella prima corona (più del 60% degli interventi); in piccola parte è interes-sata anche la seconda cintura (circa il 16%) mentre a Torino si localizza soloil 23% degli interventi. Essa ospita invece più del 60% delle operazioni direcupero di edilizia residenziale pubblica realizzati nell’area metropolitana(Corrado, Giaimo, 2007).
I risultati del Piano decennale in Piemonte sono contraddittori (IRES
Piemonte, 1991): l’aumento dell’incidenza pubblica sullo stock esistente alle-via per molti versi il problema della casa, ma la costruzione dei nuovi alloggiavviene senza una programmazione territoriale e urbanistica.
La seconda fase di incremento dello stock residenziale è molto piùcontenuta di quella avvenuta negli anni Ottanta (lo Stato, come si vedràsuccessivamente, si ritira progressivamente dal settore, riducendo in manie-ra radicale la spesa per la casa). Viene ancora confermata la tendenza a inve-stire nella prima cintura dei Comuni attorno a Torino, dove si localizza circail 60% degli investimenti; un dato significativo è quello relativo alla secon-da cintura che cresce e arriva quasi al livello di Torino (rispettivamente 18%e 20% del totale degli investimenti), nonostante il fatto che verso la metàdegli anni Novanta il Piano regolatore generale (PRG) abbia destinato alcu-ne aree di proprietà pubblica a edilizia residenziale popolare (Corrado,Giaimo, 2007).
Gli interventi di recupero, in questa fase, sono decisamente pochi, sia aTorino che nella prima cintura. Negli ultimi anni infatti questi complessi resi-denziali hanno avuto bisogno di massicci interventi di ristrutturazione. Ciò èaccaduto in realtà nella maggior parte delle città italiane (si pensi ai noti casi delCorviale a Roma, dello ZEN a Palermo, delle Vele a Scampia). A Torino questotipo di interventi si è inserito in un progetto più ampio di riqualificazione erigenerazione di interi quartieri, il Progetto speciale periferie (cfr. CAP. 8).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 145
7.3La nuova questione abitativa
7.3.1. Crescita e complessificazione del disagio
Il passaggio dal fordismo al postfordismo produce profondi cambiamenti aTorino, dal punto di vista sociale, politico e spaziale (Mela, 1997; Mela, Davi-co, Conforti, 2000; Conforti, Mela, 2006; Governa, Rossignolo, Saccomani,2008).
Parallelamente cambia anche il disagio che si nasconde fra le sue case (deLuca, Governa, Lancione, 2007), dove si riscontra una situazione sostanzial-mente nuova e comune alla maggior parte delle città italiane: essa si caratte-rizza per i costi abitativi crescenti, per l’estensione della fascia di popolazio-ne in sofferenza e per l’affacciarsi di nuove figure sulla scena del disagio (Tosi,2004).
Per indagare questa nuova configurazione del disagio abitativo – caratte-rizzato appunto dalla crescita e dalla complessificazione della categoria dipersone che lo esprimono – è necessario dotarsi di quella che Pile (1999) chia-ma un’immaginazione geografica allargata, utile a non ridurre la questioneurbana, e quindi quella abitativa, solo ad alcuni aspetti o categorie (Amin,Graham, 1997; Amin, Thrift, 2005; Robinson, 2006). Operando una catego-rizzazione necessariamente macroscopica per motivi di sinteticità, possonoessere individuate tre classi di persone colpite oggi da disagio abitativo: laprima, invisibile e spesso dimenticata nei discorsi sulla casa, si riferisce a colo-ro che soffrono il disagio abitativo prevalentemente nell’irregolarità o nell’a-busività (essenzialmente immigrati, regolari e non). La seconda, manifesta,prende in considerazione coloro che presentano richiesta per alloggi di Edili-zia residenziale pubblica (ERP) (anziani, immigrati e cittadini italiani chedispongono di un reddito, seppur minimo). La terza, infine, è una categoriaanch’essa parzialmente invisibile che va però sempre più emergendo, quelladi coloro con un reddito superiore ai minimi per l’ERP ma non sufficiente peraccedere al mercato privato.
Nella prima categoria del nuovo disagio abitativo rientrano almeno duegruppi di soggetti. Da una parte coloro che per legge non possono faredomanda né di casa popolare né per i vari fondi alla locazione in quanto irre-golari. Tra di essi vi sono essenzialmente extracomunitari, lavoratori a tempopieno o stagionali che spesso si trovano in situazioni di abusivismo e/o emer-genza abitativa. Per questi soggetti il problema primo non è quello della casa,in quanto la loro condizione di irregolarità è il principale limite che si pone,in questa categoria sono però compresi tutti quei soggetti che, pur essendoregolari, non riescono, per incapacità perlopiù sociali e culturali a entrare a
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
146
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 146
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
147
conoscenza dei (e accedere ai) servizi abitativi offerti dalla città. Tra questi sipossono annoverare immigrati regolari, senzatetto, tossicodipendenti e“nomadi”9 comunitari, per cui il problema della casa si allaccia a doppio filocon questioni prettamente sociali.
Prendere in considerazione questa categoria nell’affrontare la questionecasa a Torino e in Italia non è banale, né da un punto di vista empirico né daquello politico (Tosi, 1980). In primo luogo, vi sono i numeri a confermarlo:basti sottolineare che il centro di accoglienza SERMIG, uno dei più grandi delcapoluogo piemontese, ospita nelle sue diverse sedi una media di 1.840 perso-ne per notte10, senza contare che a Torino sono presenti almeno altri quindi-ci dormitori di cui nove comunali. I nomadi che risiedono sul territorio tori-nese, inoltre, si trovano a vivere in campi dalle condizioni precarie e spesso,al di là dell’operato del Comune (Lancione, 2008), abusive, con tutti i rischisanitari e le problematiche abitative che ciò comporta. In secondo luogo talequestione abitativa è nuova anche per l’affacciarsi di questa categoria di irre-golari/abusivi sulla scena, che va presa quindi in considerazione. Se in altreparole si intende l’abitare come un insieme di elementi, che vanno al di là delmero tetto, la condizione di questi individui è anche abitativa e come taleanche le politiche abitative debbono affrontarla.
La seconda categoria colpita dal disagio è quella per certi versi più classi-ca. Si tratta di coloro che hanno presentato domanda per ottenere un allog-gio ERP. A Torino, come in altre città italiane, se questa categoria è la più clas-sica nelle forme lo è certamente meno nella sostanza.
In primo luogo c’è da registrare un aumento delle domande presentate: aTorino tra il 2001 e il 2007 vi è stato un notevole aumento non solo delledomande accettate (+20%; Città di Torino, 2008a), ma anche di quelle a cuiè stato attribuito il punteggio di massimo disagio abitativo, definito urgente(FIG. 7.3).
In secondo luogo, cambia la composizione di coloro che fanno richiestadi alloggio. In particolare a Torino aumentano le domande di soggetti cheappartengono a particolari categorie, come disabili e anziani e, fra di essi,aumentano nello specifico individui che dichiarano un disagio abitativo moltoelevato (>10 punti – i punti vengono assegnati sulla base del disagio dimo-strato con opportuna documentazione all’atto della domanda). Questa, inogni caso, pare essere una caratteristica in parte peculiare del capoluogopiemontese, data la sua consistente popolazione ultrasessantacinquenne. AMilano, ad esempio, l’ultimo bando pubblicato dal Comune ha visto un note-vole incremento non delle assegnazioni ad anziani ma a cittadini stranieri11,tanto da spingere alcuni partiti a prese di posizione specifiche contro questoaumento12.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 147
La terza categoria di disagio è infine quella in cui rientrano tutti coloro chesoffrono del problema casa ma che per limiti di reddito non possono rientra-re nell’edilizia pubblica, dovendo quindi rivolgersi al mercato privato dellalocazione o della proprietà. Fa parte di questa categoria un numero conside-revole di persone che non erano state mai colpite in passato da questa condi-zione. Non quindi le fasce più deboli della popolazione, che tradizionalmen-te hanno costituito il target delle politiche di assistenza abitativa, ma i giovaniesclusi dal credito perché precari, gli anziani (sempre più numerosi), i lavora-tori e gli studenti fuori sede, i nuclei familiari monoparentali (Tosi, 2004).
Alcune indicazioni sulle cause economico-finanziarie di una tale esten-sione dell’area di sofferenza possono essere individuate. Come sottolineaCaudo (Caudo, 2005; Caudo, Sebastanelli, 2008), paiono essere tre i motoridi questo nuovo disagio: il basso costo del denaro, la liberalizzazione deicanoni di affitto e la patrimonializzazione dei redditi. Brevemente, il mecca-nismo pare essere stato il seguente. In primo luogo, è in atto un ciclo positi-vo del mercato immobiliare che dal 1997, escluso il 2001, continua fino a oggi
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
148
FIGURA 7.3Confronto tra i bandi per l’assegnazione di ERP a Torino negli anni 2001, 2004 e2007
Fonte: nostra elaborazione da Città di Torino (2008a).
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Bando 2001
Bando 2004
Bando 2007
da 0 a 3 da 7 a 9da 4 a 6 oltre 10
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 148
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
149
(questo in media, fatta salva ovviamente la crisi del 2009 in cui il prezzo dellecase è sceso, tornando poi a risalire). I valori immobiliari sono cresciuti ecrescono, in particolare, per due ragioni: da un lato per il basso costo deldenaro, per cui le famiglie sono incentivate all’accensione di mutui per l’ac-quisto della casa; dall’altro per l’abolizione dell’equo canone che, facendoaumentare i costi di locazione, ha di conseguenza contribuito all’aumento delvalore della redditività del patrimonio immobiliare. In secondo luogo, inquesto meccanismo si inseriscono le nuove società immobiliari nate pergestire i beni immobiliari delle imprese. Finanziate dalle banche, questeimmobiliari hanno maturato grandi profitti dalla continua compravendita diimmobili contribuendo, con questi passaggi, all’aumento esponenziale delloro valore, alla costruzione, secondo l’efficace espressione di Caudo, di veree proprie “case di carta”, immesse nel mercato finanziario per produrreredditività e sostenere il sistema economico delle banche e delle imprese. Intutto questo a rimetterci sono quei soggetti che hanno visto aumentare note-volmente il costo della locazione, o che hanno preso in prestito denaro il cuibasso costo era solo un’illusione. Ecco quindi, in questo meccanismo, emer-gere la terza categoria della nuova questione abitativa: caratterizzata dasoggetti, come si è detto, che potenzialmente non dovrebbero essere toccatidalla questione ma che, probabilmente a causa di quanto appena esposto, ladebbono affrontare.
7.3.2. La geografia del disagio abitativo odierno
La complessificazione della questione casa si esprime anche nella diversifica-zione dei luoghi in cui si manifestano forme di tensione abitativa. Prendendoin considerazione le categorie proposte per l’articolazione del disagio (irre-golari e abusivi, richiedenti alloggi di ERP e i nuovi soggetti colpiti da disa-gio), si può vedere come esse traccino una geografia del problema casa diver-sa da quella dell’epoca fordista. In particolare si possono rilevare anche quitre categorie (tre geografie) delle forme territoriali della questione abitativa aTorino: il sovraffollamento, le occupazioni abusive e i campi nomadi; i quar-tieri a elevata concentrazione di ERP; gli spazi accessibili e inaccostabili dellalocazione.
Porta Palazzo, San Salvario e zona nord: sovraffollamento, occupazioni abusive e campi nomadi
Della categoria degli irregolari e abusivi sembra opportuno sottolineare inparticolare due questioni spaziali: la presenza di sovraffollamento e di occu-pazioni abusive e quella di campi nomadi (autorizzati e non)13.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 149
Il sovraffollamento e le occupazioni abusive a Torino rappresentano unproblema ancora limitato rispetto ad altre città italiane. A Milano, ad esem-pio, per far fronte al fenomeno – più di 5.000 alloggi occupati abusivamente– è stata creata un’apposita sottocommissione consigliare14. La questione peròesiste ed è prevalentemente concentrata nelle aree di prima immigrazione, lestesse analizzate in precedenza nel disagio fordista, le cosiddette “porte” dellacittà (Governa, Rossignolo, Saccomani, 2008). Queste aree sono prevalente-mente quelle di Porta Palazzo (circoscrizione 7 e 6) e San Salvario (circoscri-zione 1 e 8, intorno alla stazione di Porta Nuova). Nella prima, in particolare,si riscontra un’elevata concentrazione di popolazione immigrata che spessovive in condizioni di forte precarietà abitativa e sovraffollamento, come sotto-lineano alcuni studi effettuati da The Gate (l’agenzia di sviluppo del Comu-ne nell’area)15. La cronaca locale riporta, inoltre, sempre più spesso episodidi alloggi fatiscenti e senza riscaldamento affittati a stranieri, spesso clande-stini, anche in veri e propri sottoscala16. I quartieri interessati da questi feno-meni vedono, tra l’altro, l’arrivo costante di nuovi flussi migratori (comel’ondata di popolazione cinese a Porta Palazzo nel 2008) che fa pensare a unpersistere e un rinnovarsi della questione abitativa irregolare anche nel lungoperiodo.
In relazione alla presenza dei campi nomadi regolari e irregolari presentiin città, cui si affiancano altre forme di insediamento a opera di soggetti immi-grati negli ultimi anni, bisogna premettere che essi pongono, come si è giàdetto, anche la questione dell’abitare. Vi sono essenzialmente due aspetti daevidenziare. Il primo riguarda la localizzazione dei campi autorizzati dalComune che si concentrano prevalentemente al Nord della città in aree didegrado – come quella di Basse di Stura – che nei prossimi anni sarannosoggette a profonde trasformazioni (per cui si pone un problema sul futurodi questi campi)17. Il secondo punto riguarda la localizzazione dei campiabusivi. Su circa 3.000 nomadi presenti in città (IRES Piemonte, 2005) il Comu-ne ne dichiara solo 466 residenti nelle piazzole di sosta autorizzate (Città diTorino, 2007a). Circa l’85% occupa quindi aree in modo abusivo, spesso nellevicinanze di campi autorizzati, riproponendo quindi la questione precedentein relazione al futuro di questi insediamenti (Lancione, 2008).
Gli aspetti qui tratteggiati – che si riferiscono a problemi, tra l’altro, diffu-si in tutto il paese (Coop-ASAL, 2001) – sembrano ripresentare alcune formedel disagio fordista (il sovraffollamento in zone centrali della città, o il “barac-camento” nei vuoti urbani, cfr. FIG. 7.4) ma pongono anche questioni di ordi-ne differente. Se per i baraccati FIAT la politica della casa di prima generazio-ne poteva essere una risposta adeguata, oggi l’intervento dovrebbe essere ditipo integrato: da un lato per la casa, dall’altro per l’effettiva integrazionesocioeconomica. Un problema quindi molto più complesso (sociale, econo-
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
150
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 150
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
151
mico, politico ecc.) che coinvolge a pieno una definizione delle prospettivedi sviluppo dell’intera società torinese.
I quartieri a elevata concentrazione di edilizia residenziale pubblica (ERP)
Data l’eterogeneità dei soggetti e delle problematiche che caratterizzano l’am-pia categoria di coloro che rientrano nei programmi di edilizia residenzialepubblica, si è deciso di concentrarsi sulla condizione di una particolare fasciadi soggetti, quella degli anziani. Tale scelta è stata fatta perché all’aumentoconsiderevole registrato a Torino delle domande per ERP presentate da ultra-sessantacinquenni e classificate con più di dieci punti, si va ad aggiungere l’al-larme lanciato dall’ultimo dossier Caritas (2008) sulla povertà, che affermache tra il 2005 e il 2006 l’incidenza di povertà relativa (percentuale di poverisul totale dei residenti, così come concepito dall’ISTAT18) in persone sole di 65anni e più è passata da un valore di 5,8% a un valore di 8,2%, con particolareriferimento alle regioni del Nord.
FIGURA 7.4Baracche di immigrati romeni a Torino, Lungo Stura Lazio (2008)
Fonte: fotografia di Michele Lancione (il cartello riporta la scritta: “È venuto il giorno di nostro Signore ilSalvatore”).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 151
L’aspetto di tipo territoriale-distributivo che è interessante sottolineareè quello relativo alla quota di popolazione anziana residente nelle aree diERP in città (Mela, 1997; Conforti, Mela, 2006; de Luca, Governa, Lancione,2007). La popolazione anziana cioè si concentra nelle aree in cui è maggio-re la presenza di ERP, come ad esempio Barriera di Milano, Falchera, Mira-fiori Nord, Madonna di Campagna19. Ciò è importante da rilevare, da unpunto di vista del disagio abitativo, in quanto spesso tali aree – costruiteprincipalmente per gli operai della Torino fordista – mancano dei piùelementari servizi per la popolazione di terza età. Questo problema nonriguarda solo Torino, ma si pone anche per altre città italiane, in cui la fortepresenza di anziani in quartieri privi di servizi è ormai un vero e proprioallarme sociale20.
Affittare a Torino: gli spazi accessibili e quelli inaccostabili
La localizzazione della terza categoria di soggetti, cioè dalle persone che siinterfacciano con le nuove forme di disagio abitativo, non è impresa facile. Inparte per la mancanza di dati attendibili e in parte per l’estrema diffusione etrasversalità che questo tipo di disagio può avere. Esso, come si è visto inprecedenza, sfugge alle statistiche convenzionali e non mostra evidenzespaziali e territoriali tali da poter essere prese direttamente in considerazione.Per superare questi ostacoli si è operata, quindi, un’astrazione, volta a misu-rare gli effetti territoriali che tale disagio potrà riservare in futuro per la cittàdi Torino.
La domanda alla base dell’astrazione è: quali sono le effettive possibilitàdi locazione, sul territorio comunale di Torino, per una giovane coppia? Perrispondere si sono messi a confronto i canoni medi di affitto per un apparta-mento formato da due locali più cucina (trilocale21) nelle diverse circoscrizio-ni torinesi (Città di Torino, 2008b), con i redditi a disposizione di tre ipoteti-che giovani coppie (A, B e C). A, con un reddito pari a +40% della soglia dipovertà ISTAT (1.381 euro); B, con un reddito pari a +80% di tale soglia (1.776euro); C, con un reddito pari a +100% di tale soglia (1.974 euro)22.
Per decidere quanta parte del reddito potesse essere impiegata per l’one-re della locazione, si è fissato il tetto massimo del 30% (pari a quello stabilitodalla legge per le rate del mutuo). Ne è derivato, quindi, che A potrà pagareun affitto massimo di 414 euro, B di 533 euro e C di 592 euro. Quali sono learee della città in cui tali coppie potranno permettersi di vivere? E quali leprossime possibili geografie dell’insediamento a Torino per questi gruppi dicoppie?
La geografia del nuovo disagio abitativo – esemplificativa e parziale –che emerge a Torino da questa astrazione è riportata nella FIG. 7.5.
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
152
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 152
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
153
Attuando questa simulazione emergono almeno tre dati interessanti:– con un reddito maggiore del 40% della soglia di povertà ISTAT, e quindiun reddito sufficiente per essere classificato come “sicuramente non povero”,la coppia A non sarebbe in grado di prendere in locazione, in media, alcunappartamento a Torino. In questo caso emerge quindi una geografia dell’e-sclusione abitativa;
FIGURA 7.5Una possibile configurazione territoriale del disagio abitativo relativo all’accessoalla locazione
Fonte: per i dati sui canoni medi di locazione, Città di Torino (2008b); per i dati sulla soglia di povertà relativa,ISTAT (2008).
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 153
– con un reddito maggiore dell’80% la coppia B potrebbe trovare casaesclusivamente in due precise circoscrizioni, la 5 e la 10. In questo caso emer-ge quindi, una chiara marginalizzazione di alcune fasce di reddito;– nessuna delle tre coppie esaminate potrebbe infine alloggiare nelle circo-scrizioni 1, 8 e 4 (le prime due, in particolare, sono quelle a pregio urbanisticoe architettonico più elevato della città).
Al di là dei limiti evidenti di tale analisi esemplificativa (l’indagine suicanoni medi di affitto ha riguardato solo il comune di Torino e inoltre le circo-scrizioni, al loro interno, hanno valori di locazione anche molto diversi traloro), ciò che emerge è un aspetto ancora poco studiato della nuova questio-ne abitativa. In particolare rimangono aperti due quesiti: quali saranno lefuture configurazioni territoriali della locazione a Torino? E quali sarannoinfine le strategie (abitative e di spostamento) messe in atto da coloro che,visto il loro reddito, la città non riesce più a ospitare?
7.3.3. Le politiche abitative di seconda generazione: dalla seconda metà degli anni Novanta a oggi
Negli anni più recenti la questione abitativa entra nuovamente nell’agendapolitica nazionale. Per rispondere all’inadeguatezza delle politiche abitativedi prima generazione, concentrate sull’assegnazione di alloggi realizzati inte-ramente con risorse pubbliche, vengono introdotte delle novità sostanzialiche l’Italia, in realtà, recepisce con notevole ritardo rispetto agli altri paesieuropei per i quali si è parlato di una “rivoluzione abitativa” già negli anniSettanta (Tosi, 1994).
Nate a partire dalla fine degli anni Novanta, le politiche di seconda gene-razione si oppongono al mass housing (le cosiddette “politiche abitative dimassa”) e tentano di dare una risposta al mutato e problematico fenomenoabitativo, caratterizzandosi per la maggiore integrazione con l’ambito socia-le. Esse intendono eliminare le inefficienze di un controllo accentrato e di unagestione totalmente pubblica del problema, orientare al mercato le politicheper renderle finanziariamente più sostenibili, realizzare una mediazione trainteressi pubblici, mercato della casa, e interessi dei privati bisognosi, concen-trare l’attenzione sulle emergenti fasce sociali a rischio con politiche ad hoc,attuare politiche di sostegno all’affitto al di fuori del limitato numero di allog-gi ERP disponibili, realizzare il passaggio di competenze dallo Stato alle Regio-ne e ai Comuni.
Il processo di decentramento va avanti tra profonde incertezze e scarsitàdi risorse (vanno a esaurirsi i fondi nazionali ex GESCAL – l’Istituto che gesti-va la costruzione delle case dei lavoratori, poi INA-Casa – e quelli delle regio-ni). Inoltre, con la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta comin-
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
154
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 154
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
155
cia a essere dismesso il patrimonio pubblico: ne deriva una situazionecomplessa dal punto di vista della gestione amministrativa, aggravata dalpunto di vista del disagio e dell’esclusione in quanto negli stabili rimastipubblici peggiora la stigmatizzazione di coloro che vi abitano. La legge17 febbraio 1992, n. 172, cerca di introdurre criteri di efficienza ed efficacianelle politiche abitative mediante il passaggio degli Istituti autonomi di casepopolari a enti di natura economica (le Agenzie territoriali per la casa) e lafissazione di norme per l’introduzione di piani integrati nell’ambito dei qualii Comuni acquisiscono un ruolo di primo piano.
Nonostante queste novità si registra a livello nazionale una forte stasi. Lostallo che caratterizza le politiche abitative nel paese si rispecchia anche nellarealtà torinese dove dal 1980 al 1995 non viene indetto neanche un bando perl’assegnazione di alloggi ERP.
Rispetto alle altre grandi città italiane, Torino presenta caratteristichepeculiari: cresce negli ultimi anni, in particolare dal 2003, il numero delle fami-glie in locazione, trend contrario rispetto alla media nazionale. Dal latodell’offerta c’è da registrare la destinazione a edilizia residenziale pubblica diuna parte degli interventi realizzati per le Olimpiadi del 2006 (551 alloggi) ma,soprattutto, si sono rese disponibili nuove aree (le cosiddette Zone urbane ditrasformazione) che il PRG vigente destina a nuove costruzioni. Rispetto aglianni precedenti quindi si presume che la nuova produzione di alloggi saràdecisamente più determinante rispetto agli interventi di recupero.
Come si comporta la città di fronte al rischio di frammentazione territo-riale derivante dalla crescita e diversificazione del disagio? Gli interventiprogrammati e in alcuni casi avviati dal Comune di Torino per dare rispostaalla nuova, crescente e diversificata domanda cambiano notevolmente. Lepolitiche intervengono in modo indiretto privilegiando il sostegno alla perso-na e lasciando che il mercato e gli attori non necessariamente pubblici offra-no le soluzioni che l’edilizia sociale non è più in grado di dare.
La risposta della città alla domanda abitativa è elaborata prevalentemen-te all’interno dei confini comunali e si basa sulla riqualificazione di immobiliesistenti. In questo senso è in linea con l’opera di riqualificazione del tessutourbano centrale prevista dal PRG approvato nel 1995. Le politiche messe incampo a Torino si iscrivono in quattro filoni principali: l’edilizia residenzialepubblica, il sostegno all’affitto, i programmi sperimentali e l’housing sociale(Città di Torino, 2007b, 2008b).
Per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica, è stato messo a puntoun piano di vendita degli alloggi siti in altre municipalità e di acquisto all’in-terno dei propri confini comunali: la città è infatti proprietaria di 2.903 allog-gi situati in altri comuni delle vicinanze. A partire dal 2002 l’assegnazioneavviene da parte delle municipalità in cui sono localizzati gli alloggi e non da
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 155
parte dell’ente proprietario: ciò comporta per la città di Torino gravosi costidi gestione, manutenzione e alti oneri fiscali, senza la possibilità di usufruiredi tali immobili per far fronte all’emergenza abitativa23. Contemporanea-mente, il Comune intende procedere con l’acquisto – nel mercato privato –di alloggi da destinare a ERP in diverse aree della città. Per il biennio 2007-08è stato previsto l’acquisto di 648 unità immobiliari (di queste, 445 fanno partedegli ex villaggi olimpici); per quello 2009-10 di 391 unità immobiliari e 2 inte-ri stabili; nella maggior parte dei casi si tratta di alloggi siti nelle aree più peri-feriche della città.
L’incremento del patrimonio ERP è affidato anche ad altre iniziative comela concessione di aree in diritto di superficie all’Agenzia territoriale per lacasa, interventi comunali di nuova costruzione ecc.
Nel campo dell’affitto, è stato stimato che il 10% circa delle famiglie inlocazione ha un’incidenza sul reddito tale da essere esposte a rischio d’ina-dempienza e, quindi, di sfratto (Città di Torino, 2008c). Il Comune, per farfronte a questa situazione, prevede una misura di sostegno al reddito checonsente alle famiglie di permanere nel mercato privato della locazione.Dall’anno 2000 al 2008 sono stati emessi otto bandi, con l’erogazionecomplessiva di 80 milioni di euro.
Un’altra misura di sostegno all’affitto, particolarmente innovativa e simi-le a realtà diffuse soprattutto nell’Europa centrale, è l’ufficio LOCARE (Loca-zioni convenzionate, assistite, residenziali) che opera dal 2000 come una verae propria immobiliare pubblica. Esso favorisce l’incontro tra la domanda el’offerta mediante specifici incentivi e garanzie a favore dei proprietari econtributi a favore degli inquilini. Attraverso un fondo di garanzia, LOCARE
fornisce anche assicurazioni contro il rischio di morosità del conduttore. Sinoa oggi, ha promosso la sottoscrizione di 2.000 contratti di locazione e negliultimi anni l’attività è cresciuta notevolmente tanto che nell’ultimo bienniosono stati stipulati oltre 400 contratti di locazione all’anno. Nell’ambito delPiano casa regionale 2007-12 è stata prevista l’evoluzione di LOCARE a scalametropolitana e dieci comuni hanno aderito al progetto.
Infine, sempre nell’ambito del sostegno all’affitto, sono previsti dei cano-ni assistiti per le famiglie che rischiano lo sfratto per morosità. Il contributoprevisto sarà pari a un massimo del 25% del canone di locazione annuo.
Nel campo dei programmi sperimentali, il Comune intende destinarealcuni complessi immobiliari alla realizzazione di alloggi ERP per gli anziani.Tali condomini solidali saranno integrati con servizi medici, luoghi di aggre-gazione comuni e spazi ricreativi. I primi condomini dovrebbero essererealizzati in piazza della Repubblica (28 alloggi per anziani e un alloggio diservizio destinato al volontariato), corso Principe Eugenio (29 alloggi desti-nati agli anziani in un immobile di proprietà dell’IPAB Buon Pastore), via
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
156
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 156
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
157
Porri (6 alloggi per anziani); in via Gessi (nella quale nel corso del 2008 sonostati assegnati degli alloggi – 18 alloggi per anziani e 12 alloggi a madri solecon figli minori).
Un’altra iniziativa sperimentale è quella del portierato sociale per l’ac-compagnamento e il sostegno ai residenti che vivono particolari forme di disa-gio. Il primo esperimento si è avuto in un isolato di via San Massimo, ora sipensa di replicare questa esperienza nei Villaggi olimpici di Spina 3.
Un ultimo gruppo di politiche messe a punto dall’amministrazione comu-nale attiene alla categoria dell’housing sociale che configura Torino comeuna delle città italiane più innovative24. Questo insieme di interventi è indi-rizzato soprattutto ai giovani25. Un’iniziativa di notevole interesse è quella perla quale il Comune, per sostenere i giovani nell’accesso al mercato dellacompravendita, se ne fa garante presso la banca. Qualora l’acquirente nonsia più in grado di sostenere l’onere del mutuo, il Comune vi subentra e diven-ta titolare dell’alloggio garantendo al giovane di potervi rimanere corrispon-dendo in canone sociale rapportato al reddito. L’acquirente può in ognimomento riscattare la proprietà, previo rimborso al Comune dei ratei versatidallo stesso.
Altre esperienze che rientrano in questa categoria di politiche sono leCase giovani destinate a giovani e single, abitazioni in grado di far coesiste-re l’autonomia privata con spazi comuni; infine, gli alberghi sociali, struttu-re gestite dal privato con attese di remunerazione non speculative, costi diaffitto contenuti e calcolati in base al reddito degli utenti. Tali alberghiconsentono al Comune di soddisfare la domanda emergenziale di personeche per ragioni di carattere sociale, economico, familiare, professionalevivono fasi di transizione o di momentanea difficoltà (separati, madri solecon figli a carico, ex carcerati, lavoratori fuori sede, studenti ecc.). Si ipotiz-za, come possibile localizzazione, una struttura dotata di duecento camerecon angolo cottura e ampi spazi comuni, di proprietà di Poste S.p.A., sita invia Ivrea. Un’altra possibilità è costituita da un immobile sito in piazza dellaRepubblica, per il quale è stata sottoscritta la convenzione per la concessio-ne in comodato e avviata la selezione dei progettisti delle opere architetto-niche.
7.4Conclusioni
L’evoluzione della questione abitativa a Torino consente da un lato di coglie-re le trasformazioni avvenute in forza della domanda abitativa e delle rispo-ste improntate e dall’altro di mettere in evidenza alcuni caratteri della questio-ne casa comuni alle altre città europee.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 157
Tenendo presente i due aspetti presi in considerazione – il disagio abita-tivo e le sue implicazioni territoriali – possono essere rimarcati due aspetti. Ilprimo deriva dall’osservazione della tipologia di disagi che la città ha decisodi affrontare. Con la nuova questione abitativa, la domanda di casa, aumen-ta ma soprattutto si diversifica. Emergono nuove categorie, quali gli immi-grati o gli anziani, che pongono questioni abitative complesse che per essereaffrontate richiedono strumenti capaci di intendere l’abitare nel sensoampio, sociale, del termine (Tosi, 1994). Se da un lato, dall’analisi delle poli-tiche di prima generazione è emerso che il disagio abitativo fordista è stato, aitempi, in qualche modo arginato (seppur nelle aree periferiche o esterne allacittà senza prevedere, nella maggior parte dei casi, servizi e connessioniadeguate), dall’altro, le politiche odierne pur nella loro complessità nonsembrano prendere in considerazione lo spettro completo dei problemi postidal nuovo disagio.
Il disagio meno acuto, che la città sceglie di trattare, è quello di giovani eanziani. I primi, a cui è precluso l’affitto in molte aree della città, sono desti-natari di un considerevole numero di iniziative di housing sociale che la cittàmette in campo per favorire soprattutto il loro accesso nel mercato privatodelle abitazioni. Alla domanda degli anziani, concentrati nei vecchi quartieridi edilizia residenziale pubblica spesso inadatti alle loro mutate esigenze divita, la città fa fronte con alcuni programmi sperimentali imperniati sull’inte-grazione della funzione residenziale con servizi dedicati. Sono entrambi inter-venti che pongono la politica abitativa di Torino sulla scia di quella di moltealtre città europee e che sembrano essere un buon punto di riferimento per lecittà italiane. Nonostante ciò, numerosi altri problemi rimangono da affron-tare: il disagio da sovraffollamento o abusivismo che si concentra nelle areecentrali (San Salvario e Porta Palazzo) o marginali (l’area a nord e le spondedei fiumi), la questione posta dagli anziani che vivono nelle case popolari oche sono costretti ad abbandonare i loro alloggi per l’aumento dei canoni,quella delle categorie che entrano sulla scena del disagio per via delle specu-lazioni immobiliari.
La tendenza a selezionare il tipo di disagio cui indirizzare gli interventi equindi a non prendere in considerazione quello più grave, è uno degli aspettidi quella che è stata definita la neo liberal housing policy – basata sulla priva-tizzazione, la deregulation e il progressivo ritiro dell’attore statale – che si staconsolidando nella maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale e negliorientamenti proposti dalla stessa Unione Europea (Clapham, 2006; de Luca,Governa, Lancione, 2009). La frammentazione sociale che ne deriva spinge achiedersi se è possibile elaborare un’alternativa a questo tipo di approccio alproblema casa (Clapham, 2006). La stessa esperienza torinese dimostra, inquesta primissima fase di attuazione, che le politiche più efficaci sono quelle
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
158
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 158
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
159
in cui il soggetto pubblico non rinuncia al ruolo di pilotage, come nel caso incui il Comune si fa garante presso le banche per favorire l’accesso alla casa daparte dei giovani.
Il secondo aspetto da rimarcare deriva dall’osservazione delle implica-zioni territoriali della questione casa. Mentre fino ai primi anni Novanta larisposta al disagio abitativo è avvenuta nelle aree più marginali della città (igrandi insediamenti residenziali nei comuni della prima corona attorno aTorino), a partire dalla seconda metà degli anni Novanta la risposta si artico-la prevalentemente all’interno della città e ciò non solo perché il disagio si insi-nua in maniera più diffusa nella città ma anche perché gli interventi si fannopiù puntuali (ad es. i condomini per anziani in piazza della Repubblica, corsoPrincipe Eugenio, via Porri e via Gessi; il portierato sociale in via San Massi-mo; l’albergo sociale in via Ivrea). Sembra che la tendenza sia quella di unapolitica per la casa “per progetti” che rispondano alle esigenze operative. Ilrischio è quello di eludere il problema della casa (Tosi, 2004), ovvero delegit-timare gli approcci settoriali, tanto nelle politiche quanto negli interventi, chesono invece necessari soprattutto relativamente a quei contesti territoriali,come l’Europa del Sud, caratterizzati da uno stock immobiliare molto caren-te. L’attivazione di progetti è una modalità per molti versi efficace, il succes-so delle esperienze che stanno avendo luogo a Torino lo dimostra, purchéelaborate all’interno di un programma più ampio che prenda in considera-zione l’insieme non solo delle politiche per la casa ma anche di quelle per lacittà.
Note
1.@Il capitolo è frutto di una riflessione comune. Si possono attribuire i PARR. 7.1 e 7.4,nonché tutte le immagini, le carte e le tabelle inserite nel testo, a entrambi gli autori; i PARR.7.2.2 e 7.3.3 ad Alberta de Luca e i PARR. 7.2.1, 7.3.1 e 7.3.2 a Michele Lancione.
2.@Per l’inquadramento di Torino in epoca fordista si è fatto riferimento al noto lavoro diGabert (1964).
3.@Cfr. Progetto Love Artom, http://www.loveartom.it/edificio_storia.html (ultimo acces-so febbraio 2009).
4.@Attraverso i cerchi è indicato il numero globale dei nuovi arrivi per zone statistiche.RRiissppeettttoo aallll’’oorriiggiinnaallee –– cchhee mmiissuurraavvaa 11 mmmm22 ppeerr 4455 nnuuoovvii aarrrriivvii –– qquueessttaa vveerrssiioonnee èè lleeggggeerrmmeenntteerriiddoottttaa.. AAllll’’iinntteerrnnoo ddeeii cceerrcchhii,, èè iinnddiiccaattaa llaa ppoorrzziioonnee ddeeii mmeerriiddiioonnaallii..
5.@Rientrano in questa categoria le politiche che vanno dal primo intervento organico nelsettore, il Testo Unico del 1938, alla conclusione del Piano decennale di edilizia residenzialeattivato con la legge 5 agosto 1978, n. 457. Segue un periodo di transizione che perdura fino aiprimi anni Novanta (quando verranno realizzare le politiche di seconda generazione) caratte-rizzato da una stasi marcata, dall’assenza di finanziamenti, dal mutamento del contesto socioe-conomico e, come si vedrà, dalla complessificazione del problema abitativo.
#Poc
o ch
iaro
, pe
rché
ade
s-so
qua
l è la
pro
porz
ione
?R
idot
ta o
ingr
andi
ta?#
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 159
6.@Dei 19.000 alloggi oggi esistenti, il 68% è stato infatti costruito prima del 1981, il 18%tra il 1981 e il 1990 e solo il 14% dopo il 1990.
7.@L’unico intervento realizzato prima del 1949 fu il villaggio Agnelli a Villar Perosa.8.@Tra i criteri di assegnazione vi erano sia lo stato di necessità del richiedente che l’anzia-
nità di servizio, cui si aggiungevano anche criteri di ordine disciplinare.9.@Viene utilizzato il virgolettato intorno alla parola “nomadi” in quanto le popolazioni
rom, sinti e camminanti presenti sul territorio italiano sono perlopiù stanziali, a meno di «even-ti derivanti da conflitti con la popolazione locale o con altri rom o sinti non li spingano aspostarsi» (Città di Torino, 2007a, p. 1).
10.@Cfr. il sito internet del SERMIG, http://www.sermig.org/ (ultimo accesso novembre2008).
11.@Cfr. il sito internet per l’Edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano,http://www.comune.milano.it/ (ultimo accesso febbraio 2009).
12.@La Lega nord, ad esempio, ha presentato una mozione per limitare il bando per le casepopolari solo ai residenti da almeno venti anni a Milano (http://www.globalproject.info/art-10890.html, ultimo accesso febbraio 2009).
13.@È importante ricordare preliminarmente che i soggetti interessati da queste problema-tiche non sono esclusivamente irregolari (ovvero senza permesso di soggiorno) ma, in granparte, come nel caso dei campi nomadi o degli insediamenti abusivi, sono o cittadini italiani atutti gli effetti (ad es. i sinti) o cittadini comunitari (ad es. i rumeni) o persone con diritto d’asi-lo politico (ad es. i rifugiati del Darfur presenti in città).
14.@Cfr. il sito internet http://www.comune.milano.it (ultimo accesso febbraio 2009).15.@In particolare si veda la ricerca di The Gate sull’ambiente costruito di Porta Palazzo,
con le relative carte della densità abitativa (http://www.comune.torino.it/portapalazzo/ambienti/costruito/stock_abitativo/dati/affollamento.pdf, ultimo accesso novembre 2008).
16.@Un esempio è riportato da “La Stampa” del 26 novembre 2008, dove si documental’intervento dei carabinieri nella zona di Porta Palazzo volto a scoprire proprio questi tipi dialloggi assolutamente precari e abusivi (http://www.lastampa.it/Torino/cmsSezioni/crona-ca/200811articoli/8845girata.asp, ultimo accesso novembre 2008).
17.@Per l’area di Basse di Stura, in particolare, il PRG di Torino prevede la riconversione inun polmone verde, con aree di rigenerazione urbana. Tuttavia, al momento sono ancora alvaglio i numerosi progetti di trasformazione.
18.@La soglia di povertà relativa secondo l’ISTAT è calcolata sulla base della spesa familiarerilevata dall’indagine annuale sui consumi (sempre ISTAT), condotta su un campione di circa 28mila famiglie, estratte casualmente dalle liste anagrafiche in modo da rappresentare il totaledelle famiglie residenti in Italia. Nel rapporto sulla povertà relativa in Italia nel 2008, diffusonel 2009, l’ISTAT ha considerato che la soglia di povertà per una famiglia di due componenti èrappresentata dalla spesa media mensile per persona, che nel 2008 è risultata pari a 999,67 euro(+1,4% rispetto alla linea del 2007). Le famiglie composte da due persone che hanno una spesamedia mensile pari o inferiore a tale valore vengono quindi classificate come relativamentepovere.
19.@Più precisamente, le circoscrizioni caratterizzate dalla marcata presenza di popolazio-ne anziana e di ERP sono la 6 (Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertola, Falchera, Rebau-dengo e Villaretto), la 5 (Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento e Vallette) e la 2(Santa Rita e Mirafiori Nord).
20.@A Genova recentemente è stato denunciato dalla stampa locale il caso di anzianicostretti a rimanere chiusi in casa in quanto le vecchie case popolari in cui vivono sono privedi ascensore (http://www.liftonweb.it/news_ascensori.asp?INWS=374, ultimo accessofebbraio 2009).
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
160
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 160
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
161
21.@Si è scelto di svolgere tale simulazione con un trilocale, piuttosto ad esempio di bilocalio mansarde, perché la simulazione è stata fatta su una giovane coppia che, presumibilmente,vorrà una stanza per sè, una per il figlio venturo, più l’ambiente cucina.
22.@Il modello non è che un’astrazione dal momento che non è stata calcolata la consi-stenza di queste classi (ovvero quante persone si trovano in questa condizione). Questo eserci-zio mette in evidenza le difficoltà della maggior parte delle famiglie residenti che, sebbene“sicuramente non povere” (come si è detto in una nota precedente, l’ISTAT classifica come talile famiglie che superano del solo 20% la soglia di povertà, ISTAT, 2008), riescono a soddisfareraramente il proprio bisogno abitativo in città.
23.@Il piano di vendita si articola in due bienni, 2007-08 e 2009-10; i proventi ammontanocirca a 31.920.000 euro (Città di Torino, 2006, 2008c).
24.@Sullo stato dell’housing sociale in Europa cfr. de Luca, Governa, Lancione (2009).25.@Possono accedere a questa iniziativa i giovani con meno di 35 anni e un reddito fami-
liare non superiore a quello previsto per gli acquisti di edilizia agevolata (nel 2008 tale soglia siaggirava intorno ai 37.000 euro). Rientrano nella categoria di housing sociale anche le iniziati-ve della Regione Piemonte che afferiscono al Programma 10.000 alloggi entro il 2012 (RReeggiioonneePPiieemmoonnttee,, 22000066 ##iinnsseerriirree iinn bbiilliiooggrraaffiiaa##). Circa 300 alloggi saranno resi disponibili mediantefinanziamenti che coprono al massimo il 65% dei costi di costruzione. Gli alloggi saranno desti-nati permanentemente alla locazione a canoni mediamente non superiori ai 250 euro mensili, afavore di soggetti con redditi di non oltre il 30% superiori ai limiti per l’accesso agli ERP.
Bibliografia
ALLEN J. (2006), Welfare Regimes, Welfare Systems and Housing in Southern Europe,in “European Journal of Housing Policy”, 6, 3, pp. 251-77.
AMIN A., GRAHAM S. (1997), The Ordinary City, in “Transaction of the Institute ofBritish Geographers”, 22, pp. 411-29.
AMIN A., THRIFT N. (2005), Citizens of the World, in “Harvard International Review”,27, 3, pp. 14-7.
ANGELI L., CASTROVILLI A., SEMINARA C. (1998), Corso Taranto: 30 anni di vita, speranzeprogetti, Officine della Memoria, Torino.
CARITAS (2008), Settimo Rapporto Caritas/Migrantes sull’immigrazione, IDOS, Roma.CAUDO G. (2005), Case di carta: la “nuova” questione abitativa, in “L’Unità”, 24 e 27
dicembre, Roma.CAUDO G., SEBASTANELLI S. (2008), Dalla casa all’abitare, in F. Garofalo (a cura di),
L’Italia cerca casa. Mostra internazionale dell’architettura della Biennale diVenezia, Mondadori Electa, Milano, pp. 40-7.
CITTÀ DI TORINO (2006), Piano casa 2007-2008, Torino.ID. (2007a), Relazione su rom, sinti e nomadi per l’Osservatorio interistituzionale,
Torino.ID. (2007b), Terzo rapporto dell’osservatorio sulla condizione abitativa, anno 2006, Torino.ID. (2008a), Bando generale n. 5/2007 per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata. Caratteristiche e dimensioni della domandaabitativa, Torino.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 161
ID. (2008b), Quarto rapporto dell’osservatorio sulla condizione abitativa, anno 2007,Torino.
ID. (2008c), Piano casa 2009-2010, Torino.CLAPHAM D. (2006), Housing Policy and the Discourse of Globalization, in “European
Journal of Housing Policy”, 6, 1, pp. 55-76.CONFORTI L., MELA A. (2006), La configurazione sociale dei diversi ambiti spaziali della
città di Torino e i processi di mobilità residenziale, IRES, Torino.COOP-ASAL (2001), Affittasi a tutti?, Roma, http:/www.cestim.org/ilmondoincasamia
(ultimo accesso febbraio 2009).CORRADO F., GIAIMO C. (2007), Città e territorio metropolitano contemporaneo. Rappor-
to da Torino, FrancoAngeli, Milano.DE LUCA A., GOVERNA F., LANCIONE M. (2007), Il problema della casa come problema di
giustizia sociale, Rapporto di ricerca EUPOLIS-SiTi, Torino.IDD. (2009), Politiche della casa in europa. Differenze nazionali e tendenze unificanti
dell’housing sociale in europa, in “Rivista Geografica Italiana”, 116, 3, pp. 349-78.DE MAGISTRIS A. (1999), L’urbanistica della grande trasformazione (1945-1980), in
N. Tranfaglia (a cura di), Storia di Torino. Gli anni della Repubblica, Einaudi,Torino.
DOHERTY J. (2004), European Housing Policies: Bringing the State Back in?, in “Euro-pean Journal of Housing Policy”, 4, 3, pp. 253-60.
DOILING J. (2006), A European Housing Policy?, in “European Journal of HousingPolicy”, 6, 3, pp. 335-49.
GABERT P. (1964), Turin. Ville industrielle, Presses Universitaires de France, Paris.GOVERNA F., ROSSIGNOLO C., SACCOMANI S. (2008), Torino. Le molte periferie della città
post-industriale, in L. Fregolent (a cura di), Periferia e periferie, Aracne, Roma,pp. 438-75.
IRES PIEMONTE (1991), L’attuazione del piano decennale per l’edilizia residenziale inPiemonte: analisi di una politica pubblica, Torino.
IRES PIEMONTE (2005), Rom e Sinti in Piemonte, Torino.ISTAT (2008), La povertà relativa in Italia nel 2007, ISTAT, Roma.LANCIONE M. (2008), I nomadi tra problemi e ambiguità: il caso di Torino, in G. Demat-
teis (a cura di), L’Italia delle città: tra malessere e trasfigurazione, Società Geografi-ca Italiana, Roma, pp. 127-8.
LE GALÈS P. (2006), Le città europee. Società urbane, globalizzazione, governo locale, ilMulino, Bologna.
LEVI F. (1999), L’immigrazione, in N. Tranfaglia (a cura di), Storia di Torino. Gli annidella Repubblica, Einaudi, Torino, pp. 157-87.
MAYER M. (1994), Post Fordist City Policy, in A. Amin (ed.), Post Fordism: A Reader,Blackwell, London, pp. 316-37.
MELA A. (1997), La configurazione sociale dei diversi ambiti spaziali della città di Torino,IRES, Torino.
MELA A., DAVICO L., CONFORTI L. (2000), La città, una e molte. Torino e le sue dimen-sioni spaziali, Liguori, Napoli.
PILE S. (1999), What is a City?, in D. Massey, J. Allen, S. Pile (eds.), City Worlds, Rout-ledge, London, pp. 4-19.
A L B E R T A D E L U C A / M I C H E L E L A N C I O N E
162
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 162
7. L A N U O V A Q U E S T I O N E A B I T A T I V A
163
PRIEMUS H., DIELEMAN F. (2002), Social Housing Policy in the European Union: Past,Present and Perspectives, in “Urban Studies”, 39, 2, pp. 191-200.
RREEGGIIOONNEE PPIIEEMMOONNTTEE ((22000066)),, ##iinnsseerriirree##ROBINSON J. (2006), Ordinary Cities, Routledge, London.SASSEN S. (2000), Cities in a World Economy, Pine Forge, Thousand Oaks (CA). TOSI A. (1980) (a cura di), Ideologie della casa, FrancoAngeli, Milano.ID. (1994), Abitanti. Le nuove strategie dell’azione abitativa, il Mulino, Bologna.ID. (2004), Case, quartieri, abitanti, politiche, CLUP, Milano.ID. (2007), Povertà e domanda sociale di casa: la nuova questione abitativa e le categorie
delle politiche, in “Rivista delle Politiche Sociali”, 3, pp. 61-78.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 163
165
8Torino e le sue periferie:
immagini e politiche per la rigenerazionedella città (1993-2009)
di Francesca Governa e Cristiana Rossignolo
8.1Introduzione
Il termine periferia rimanda a luoghi molto diversi tra loro sia per le differen-ti caratteristiche che presentano le molte parti di città che possono esserequalificate come periferiche, sia in relazione al modo in cui definiamo cosa èe cosa non è periferia (Dematteis, 1998; Governa, Saccomani, 2002, 2004).Elementi di perifericità si ritrovano anche in aree che dal punto di vista fisicoperiferiche non sono o non sono più (Bellicini, Ingersoll, 2001; Fregolent,2008): la città pubblica (Di Biagi, 2006), le aree della speculazione e dell’abu-sivismo, le periferie esterne alla città e quelle interne. La periferia inoltre nonè più solo identificabile e interpretabile in senso negativo. Come testimonia,forse un po’ come scommessa, un’ormai ampia letteratura internazionale suiquartieri difficili (cfr. Murie, Musterd, 2004; Blanc, Beaumont, 2005; Robin-son, 2005; Middleton, Murie, Groves, 2005), la periferia urbana non è solomancanza, ma può essere letta e interpretata come sovrapposizione e interse-zione di fenomeni diversi: anomia, degrado ed esclusione si associano allapresenza di relazioni sociali dense, di uno specifico capitale sociale, di riferi-menti identitari localmente radicati. Periferia diviene allora l’insieme di queiluoghi in cui, accanto al degrado, sono presenti sperimentazioni e cambia-menti nell’abitare, negli stili di vita, nei rapporti sociali, nelle pratiche dicostruzione e di uso degli spazi (Paba, 1998).
Torino non fa eccezione: le descrizioni della periferia torinese hannospesso sottolineato, come dato iniziale, la sua molteplicità, spesso anche la suaframmentazione (Garelli, 1998; Mela, Davico, Conforti, 2000; Governa, Rossi-gnolo, Saccomani, 2008). Tali descrizioni hanno permesso di identificare unapluralità di luoghi periferici e una pluralità di pratiche per la loro rigenera-zione. A Torino del resto è stato realizzato il Progetto speciale periferie, un’e-sperienza spesso indicata, a livello nazionale, come buona pratica di rigene-razione urbana (Città di Torino, 2003). Tale esperienza ha definito unastrategia complessiva per l’intervento nelle periferie urbane, contribuendo
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 165
anche a modificare l’immagine consolidata di una periferia come semplicelontananza dal centro. Torino dunque come esempio di una molteplicità diperiferie e di una politica di rigenerazione urbana innovativa, costruita suun’immagine diversa e più complessa delle periferie della città che contem-poraneamente aiuta a ridefinire.
L’esperienza torinese nel campo della rigenerazione urbana che si avvianella seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso è parte di quell’am-pio insieme di progetti e iniziative che hanno cambiato il volto della città:piano regolatore, piano strategico, Olimpiadi, riuso dei vuoti industriali,metropolitana, per non citare che i principali. L’insieme di questi progetti, didiversa origine e natura, è stato ben documentato da una mostra che si è svol-ta nel 2008, in occasione del Congresso mondiale degli architetti ##aaggggiiuunnggee--rree ccoorrrreezziioonnee??##, nella straordinaria cornice del vuoto industriale delle Offi-cine grandi riparazioni. La mostra, intitolata Torino 011. Biografia di una cittàe curata da Carlo Olmo e Arnaldo Bagnasco, ha offerto un ampio catalogoragionato delle trasformazioni della città, individuando le principali direttri-ci per il futuro e le sfide con cui confrontarsi. Come nelle intenzioni dei cura-tori (Bagnasco, Olmo, 2008), la mostra ha permesso alla città di conoscere séstessa, le sue dinamiche di sviluppo e le possibili evoluzioni future, così comedi definire i temi di un dibattito pubblico allargato del quale spesso si lamen-tano, a Torino ma non solo, le manchevolezze (Bianchetti, 2008a). Una sortadi sogno della città su sé stessa, come invitano ad esempio a fare Amin eThrift (2005). Un sogno che deve confrontarsi, come mette bene in evidenzail saggio di Bagnasco (2008) contenuto nel volumetto di accompagnamentodella mostra, con tre questioni chiave: sviluppo economico, coesione sociale,libertà democratica. Tre questioni che non si escludono a vicenda, ma che lecittà (in questo caso, Torino) devono imparare a tenere insieme. Riuscire,come scrive Bagnasco (2008, p. 17) citando Dahrendorf, a «quadrare ilcerchio», e quindi a combinare in maniera accettabile le tre dimensioni indi-cate, è un problema difficile, ma imprescindibile poiché «una o due ottenu-te a scapito delle altre, o dell’altra, non è una combinazione accettabile eforse alla lunga neppure possibile».
All’interno di questo quadro, il capitolo intende descrivere le periferietorinesi attraverso la ricostruzione delle politiche di rigenerazione urbana chehanno interessato e stanno interessando la città. Guardando alle politiche dirigenerazione urbana nelle periferie torinesi proveremo quindi a capire se aTorino la quadratura del cerchio che si va profilando appaia accettabile, seessa stia definendo un’immagine della città in grado di combinare competiti-vità, coesione e libertà democratica e se, e quanto, tale immagine si ritrovianche nelle politiche della città per le sue periferie.
F R A N C E S C A G O V E R N A / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
166
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 166
8. T O R I N O E L E S U E P E R I F E R I E
167
8.2Periferie e rigenerazione urbana nelle politiche della città
8.2.1. Sindaci e miti: i nuovi sindaci di Torino
Nel 1993, in un periodo di intensa crisi del sistema politico e istituzionale italia-no, e collegata a numerosi altri provvedimenti legislativi e di modifica istitu-zionale (Vandelli, 2000; Cammelli, 2007), è approvata la legge 25 marzo 1993,n. 81, sull’elezione diretta dei sindaci (e dei presidenti di Provincia). È unalegge importante che, modificando radicalmente il meccanismo elettorale alivello locale, prima basato sul dominio assoluto dei partiti, attribuisce aisindaci il massimo grado di legittimazione popolare, irrobustendone il ruoloe aumentando la responsabilità personale. Non a caso, il libro che Vandelli(1997) dedica alla nuova legge elettorale è intitolato Sindaci e miti. La leggesuscita molte attese: i nuovi sindaci, espressione diretta della volontà popola-re, sono visti come punti di riferimento di un’Italia che vuole cambiare,lasciandosi alle spalle la profonda crisi che ha agitato il sistema politico italia-no all’inizio degli anni Novanta, e riuscendo finalmente ad attuare il mito dellabuona amministrazione. È all’interno delle grandi attese suscitate dalla leggesull’elezione diretta del sindaco, delle difficoltà che incontrano i nuovi sinda-ci alle prese con le fatiche dell’amministrazione locale (Vandelli richiamanon a caso il mito di Sisifo) e delle successive delusioni per l’operato di alcu-ni, che devono essere inserite le politiche urbane delle città italiane degli ulti-mi venti anni. Le nuove modalità di elezione dei sindaci, e la più generalemodifica dell’architettura istituzionale, si riverberano infatti in un cambia-mento del governo della città, sia dal punto di vista degli attori coinvolti, siada quello delle politiche messe in atto dalle diverse amministrazioni.
Torino è una delle città italiane che per prima, con Milano e Roma, hasperimentato il nuovo meccanismo elettorale. Il primo sindaco eletto con lalegge 81/1993 è Valentino Castellani, professore del Politecnico prestato allapolitica che svolgerà due mandati come primo cittadino (1993-97, 1997-2001)per poi divenire presidente del TOROC (Torino Organising Committee), ovve-ro l’ente organizzatore dei XX Giochi olimpici invernali che si sono svolti afebbraio 2006. Durante il primo mandato, Castellani guida una giunta dicentro-sinistra (Partito democratico della sinistra, Verdi e Alleanza per Tori-no), considerata per tanti versi l’anticipazione in chiave torinese dell’espe-rienza dell’Ulivo, ma chiara espressione della società locale per il coinvolgi-mento di intellettuali, esponenti del mondo imprenditoriale e delle professioni.Come è stato osservato (Barbera, Pacetti, 2009, p. 55), la giunta è compostada una «ristretta élite intellettuale e professionale, illuminata, rigorosa e prag-matica aperta al confronto, in cui i partiti hanno un peso modesto». Nel
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 167
secondo mandato elettorale, gli equilibri si spostano, sia dal punto di vistadei partiti che sostengono il sindaco (Castellani si allea, al secondo turno, conRifondazione comunista, che avrà poi due assessorati), sia da quello del ritor-no dei partiti al centro della vita politica locale (come accade, del resto, inmolte altre città italiane, cfr. Vandelli, 1997).
Il successore di Castellani, alla fine dei due mandati previsti dalla legge, èSergio Chiamparino (anche se il candidato del centro-sinistra alle elezionidel 2001 doveva essere Domenico Carpanini, già vicesindaco di Castellani, chemuore improvvisamente durante la campagna elettorale). Anche Chiampari-no è eletto sindaco di Torino per due volte consecutive (nel 2001 e nel 2006)alla guida di una giunta di centro-sinistra. È un politico, come si dice, diprofessione, la cui personale storia politica attraversa direttamente e attiva-mente (componente della segreteria del PCI e della CGIL torinese, segretariodel PDS di Torino e del Piemonte, deputato) tutte le travagliate vicende dellatrasformazione della sinistra italiana dal PCI all’attuale PD.
Le recenti ricerche sulle élite torinesi e sui processi di governance urbanache caratterizzano la città (cfr. Bobbio, Dente, Spada, 2005; Scamuzzi, 2005;Belligni, Ravazzi, Salerno, 2008; Barbera, Pacetti, 2009) sottolineano tutte, purcon diversa enfasi e attenzione, una modificazione del reticolo degli attori chegoverna la città, sempre più caratterizzato dall’intreccio fra mondo politico,quello dell’industria, dell’edilizia, della ricerca e della finanza, con un ruolonon marginale delle fondazioni bancarie e della Camera di commercio. Un reti-colo complesso, denso ed equilibrato, che vede la partecipazione di una plura-lità di attori secondo le forme consuete della governance urbana. Al suo inter-no, il governo locale mantiene, e anzi rafforza, il proprio ruolo, grazie a unasalda leadership politica che, pur facendo molte cose, tende a produrre forticircolarità nei processi decisionali senza vere opposizioni (Bobbio, 2009).
Al di là delle differenze biografiche, i due sindaci di Torino eletti con lalegge 81/1993, e le giunte da loro guidate, cioè gli attori chiave della governan-ce urbana, appaiono portatori di idee di città diverse anche se non alternativee, per quanto a noi interessa maggiormente, di diverse idee di periferia edella rigenerazione urbana. Queste differenze possono essere individuate apartire dall’analisi delle politiche per le periferie torinesi attuate nel corsodegli anni e durante i diversi mandati elettorali.
8.2.2. Nuove centralità e aree dismesse: il Piano regolatore generale del 1995
Castellani, nel 1993, eredita una città in una situazione difficile, sia dal puntodi vista politico (la città viene da un anno di gestione da parte di un commis-sario governativo), sia da quello socioeconomico (la transizione della one-company town italiana appare tutt’altro che indolore). Con la riforma eletto-
F R A N C E S C A G O V E R N A / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
168
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 168
8. T O R I N O E L E S U E P E R I F E R I E
169
rale, i nuovi poteri del sindaco e le attese che suscitano sia il nuovo meccani-smo elettorale sia soprattutto la svolta verso la società civile della politica loca-le, permisero al sindaco e alla sua giunta di operare con strumenti in largamisura innovativi e con un notevole consenso.
Durante il primo mandato di Castellani sono varate numerose iniziative:il nuovo Piano regolatore generale (PRG) (1995), alcune grandi opere (come laSpina e la metropolitana), investimenti e iniziative per promuovere la compe-titività urbana a livello nazionale e internazionale. Un insieme di interventiche si intrecciano in maniera spesso contraddittoria con la rigenerazione delleperiferie. È questo un tema che, come vedremo, assume un ruolo importantenelle politiche urbane torinesi, benché segua un binario per tanti versi paral-lelo rispetto a quello seguito dalle “grandi questioni urbanistiche” che guida-no la trasformazione della città. Esemplare in questo senso è la vicenda delnuovo PRG, adottato dal Consiglio comunale nel 1993, dopo un lungo e fati-coso iter di formazione, e approvato definitivamente dalla Regione nel 1995.
Il nuovo PRG di Torino (elaborato dalla Gregotti associati) rappresenta ilrinnovo e il rilancio edilizio della città: come fa notare, un po’ entusiastica-mente, uno studio della Camera di commercio, il Piano sembra in grado dirimediare «alle delusioni dell’urbanistica per progetti degli anni Ottanta, chedi fatto aveva determinato lo stallo dei processi di trasformazione della città»(De Santis, Russo, 1997, p. 132). Ma esso mostra anche, a un esame più critico,numerosi limiti tecnici (Saccomani, 2001).
Secondo De Rossi e Durbiano (2006), che hanno dedicato uno studioalla trasformazione di Torino e alle sue immagini nel periodo 1980-2011, l’im-magine guida del nuovo PRG è il ritorno al centro. Un’immagine che si preci-sa attraverso la definizione di tre nuove centralità: «La Spina centrale, chelega lungo il Passante ferroviario le diverse aree industriali dismesse; corsoMarche, un progetto di cui si parla da tempo e che viene per molti reinven-tato dal Piano; il Progetto Po, asse di amenities lungo le sponde fluviali» (DeRossi, Durbiano, 2006, pp. 37-8). Non stupisce quindi che l’attenzione delnuovo PRG sia tutta rivolta alle nuove centralità e, in particolare, all’asse dellaSpina, mentre le aree periferiche della città, o comunque quelle non compre-se nel nuovo asse direttore dello sviluppo urbano, siano lasciate sullo sfon-do. Questa disattenzione programmatica è, in realtà, un paradosso. Moltedelle aree di trasformazione previste dal PRG, e in particolare gli ambiti 3 e 4della Spina, ricadono nelle aree in cui sono presenti insediamenti produttivie stabilimenti industriali costruiti fra la fine del XIX secolo e i primi decennidel XX secolo, con forti concentrazioni soprattutto nella zona a nord delfiume Dora, cioè nella prima periferia industriale. In particolare, Spina 3,cioè l’area delle Ferriere e della Michelin, l’ambito di trasformazione urbanapiù grande (più di un milione di metri quadrati), concentra buona parte
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 169
dell’attuale sviluppo edilizio della città: 4.000 alloggi, di cui circa il 60%destinato al libero mercato e circa il 40% all’edilizia convenzionata o agevo-lata; un polo terziario-produttivo innovativo (con il riuso dello stabilimentodella Savigliano); un grande parco e una nuova stazione, mentre sono giàrealizzati un grande centro commerciale (e altri due si trovano poco lontano,uno a nord e l’altro a est), organizzato attorno a una nuova piazza, con annes-sa multisala cinematografica e parcheggio, e un parco scientifico-tecnologi-co. L’esito di tale trasformazione è descritto in questo modo da CristinaBianchetti (2008b, p. 47):
Torri e isole residenziali hanno sostituito le officine per la lavorazione dei metalli edella gomma rendendo visibile l’esternalizzazione dei processi di ristrutturazionedell’impresa a mezzo del mercato immobiliare e dei suoi attori. Gli spazi di prossi-mità sono annullati entro un disegno poco articolato, nel quale spicca la presenza digrandi centri commerciali. Lo spazio affidato all’automobile dichiara le difficoltà dimuoversi altrimenti. Un grande prato in procinto di trasformarsi in un parco di 45ettari è il cuore dell’intera operazione: un luogo notevole che a dispetto delle buoneintenzioni e dei cospicui finanziamenti non riesce a costruire alcun legame con altriimportanti spazi urbani.
Spina 3 è così trattata come un grande playground, un terreno di gioco sepa-rato dalla città, in cui si gioca con gli indici, le destinazioni di uso, la distribu-zione e l’organizzazione degli spazi (Bianchetti, Todros, 2009).
Benché il nuovo Piano incida profondamente su alcune aree sensibilidella città, cioè sulle aree industriali dismesse localizzate nelle barriereoperaie di fine Ottocento e inizio Novecento e allineate lungo la linea ferro-viaria ora in via di interramento, la loro “sensibilità” (o possibile perifericità)non è tematizzata. Le barriere operaie torinesi, e in particolare Barriera diMilano nella zona nord della città, hanno mantenuto, sino a tempi moltorecenti e nonostante gli intensi processi di deindustrializzazione e di crisiproduttiva, una netta caratterizzazione operaia; presentano alti tassi didisoccupazione, ampie quote di popolazione con basse qualifiche professio-nali e scolarità limitata; sono soggette a profonde modificazione come «esitodello scivolare fuori da sé stesse di San Salvario e Porta Palazzo» (Bianchet-ti, 2009, p. 12) e, cioè, del progressivo spostamento di ampie quote di popo-lazione straniera dalle aree di prima accoglienza di Porta Palazzo e SanSalvario, fisicamente più centrali, alla ricerca di abitazioni meno degradate,di una maggiore stabilità nel tessuto urbano e sociale, di una maggiore inte-grazione, di servizi ecc. (Governa, Rossignolo, Saccomani, 2008). In sostan-za, il PRG di Gregotti-Cagnardi non affronta direttamente il problema delcome intervenire, sia dal punto di vista dei contenuti sia da quello procedu-
F R A N C E S C A G O V E R N A / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
170
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 170
8. T O R I N O E L E S U E P E R I F E R I E
171
rale, all’interno di aree che presentano alcune caratteristiche delle nuoveperiferie urbane né esprime modalità specifiche ed esplicite per la rigenera-zione della città1. Gli interventi previsti nel Piano sono semplicemente ilprodotto di opportunità di trasformazione che derivano dalla presenza divuoti industriali da riempire. Inoltre, come spiega Pace (2008, p. 44), inquesta operazione:
il mercato fondiario e immobiliare non sta a guardare, anzi tenta di condizionare lescelte agendo soprattutto su quel campionario di vuoti urbani che vanno prima boni-ficati e poi riempiti. […] L’industria dismette e possibilmente bonifica a sue spese,l’amministrazione municipale ripaga l’indispensabile e dispendioso servizio in termi-ne di moltiplicazione delle rendite, i promotori immobiliari trovano convenienteoperare avendo a disposizione quantità senz’altro generose.
8.2.3. Un progetto speciale per le periferie della città
Nonostante questa disattenzione dello strumento cardine della pianificazio-ne locale, la questione delle periferie e delle politiche per le periferie assumeun’importanza crescente nell’agenda politica torinese degli anni Novanta,con l’avvio della stagione dei Programmi urbani complessi e l’istituzione, nel1997, del Progetto speciale periferie, per iniziativa del Comune di Torino incollaborazione con le circoscrizioni, l’Agenzia territoriale per la casa e il priva-to sociale.
Dopo la sua elezione a sindaco, Castellani diviene presidente della reteurbana comunitaria Quartiers en crise, una rete cofinanziata dall’UnioneEuropea all’interno dell’ex art. 10 del Fondo europeo di sviluppo regionale(RECITE) allo scopo di mettere le città a confronto attraverso la cooperazionedei soggetti locali per promuovere e diffondere il cosiddetto “approcciointegrato” ai problemi e alle opportunità di intervento delle periferie urbane(cfr. CAP. 5). Negli stessi anni, la Città di Torino predispone un progetto perun’area periferica a nord della città nell’ambito dell’Iniziativa comunitariaUrban (non ammessa poi ai finanziamenti)2. I principi delle politiche urbanecomunitarie, e in particolare il cosiddetto “metodo Urban”, influenzanofortemente l’approccio seguito dall’amministrazione comunale e regionalenella definizione dei programmi per intervenire nelle periferie della città.Approccio area-based, integrazione, intersettorialità e partecipazione diven-gono quindi i cardini attorno cui si costruiscono le esperienze torinesi dirigenerazione urbana (Saccomani, 2004; Cavallo Perin, 2009; Governa, Rossi-gnolo, Saccomani, 2008).
Il tentativo di modificare le politiche urbane per i quartieri difficili dalletradizionali modalità di riqualificazione fisica a progetti integrati di rigenera-
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 171
zione urbana trova il suo momento più articolato e innovativo nel 1997, conl’istituzione del Progetto speciale periferie. Il PSP è stato fortemente volutodall’allora assessore al Decentramento e all’integrazione urbana, EleonoraArtesio (uno dei due assessori di Rifondazione comunista della seconda giun-ta Castellani). Fin dalla sua istituzione, il PSP si propone di affrontare la rige-nerazione urbana delle periferie torinesi attraverso progetti innovativi e speri-mentali, basati sull’integrazione (fra settori, istituzioni, attori e politiche) esulla partecipazione diretta dei cittadini alle trasformazioni.
Il PSP si pone una molteplicità di obiettivi: migliorare la qualità ambien-tale e urbana delle periferie, creare opportunità di sviluppo economico esociale dei quartieri attraverso la valorizzazione delle risorse locali, favorirela crescita del senso di appartenenza ad aree della città dove si è costretti avivere (Jacquier, 2002), qualificate spesso come prive di identità, problema-tiche, difficili. Ponendosi questi obiettivi, il PSP ha sviluppato alcuni elemen-ti qualificanti nelle proprie azioni, che possono essere riassunti in tre aspet-ti principali (Artesio, 2002; Governa, Rossignolo, Saccomani, 2008).Il primo aspetto riguarda il modo di interpretare le periferie e il ruolo cheesse svolgono nelle dinamiche urbane, basato su un’ipotesi di città policen-trica, composta da molte realtà, ciascuna dotata di identità, specificità,risorse umane, economiche e culturali, spesso sottoutilizzate, diverse traloro ma complementari, potenzialmente collegate e collegabili da una retedi scambi tendenzialmente non gerarchici, che costituiscono la vera ricchez-za del sistema urbano. In questa prospettiva, in secondo luogo, la margina-lità o il disagio di un quartiere non dipende unicamente dai servizi di cui èdotato o dalla posizione geografica eccentrica, ma dalle relazioni che intes-se nel contesto urbano: creare coesione sociale valorizzando le risorse endo-gene dei singoli luoghi diviene quindi il fattore essenziale per un rilanciodelle periferie della città e del sistema urbano nel suo complesso. La valo-rizzazione delle risorse locali infine si fonda sulla predisposizione di unospecifico approccio operativo in cui svolgono un ruolo centrale modalità diintervento intersettoriale e integrato all’interno della pubblica amministrazio-ne, forme di partenariato pubblico/privato per la definizione delle azioni disviluppo economico e produttivo, pratiche partecipative diffuse rivolte alcoinvolgimento della popolazione, al riconoscimento e alla valorizzazionedella conoscenza del proprio quartiere da parte degli abitanti, alla diffusionedi sedi di concertazione e di incontro fra cittadini e fra cittadini e pubblicaamministrazione.
Elemento conduttore degli interventi attuati dal PSP non è certo la perife-ricità geografica dei quartieri oggetto di intervento, dal momento che alcunisono localizzati in aree centrali come Porta Palazzo o San Salvario. Qualifi-cante è piuttosto l’attenzione ai luoghi in cui è maggiore e più evidente il
F R A N C E S C A G O V E R N A / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
172
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 172
8. T O R I N O E L E S U E P E R I F E R I E
173
disagio sociale, come mostra una ricerca svolta per il PSP dall’IRES nel 2000(IRES, 2000). Proprio il tentativo di intervenire nella aree di maggiore criticitàha portato il PSP a introdurre specifiche modalità di attuazione e, in partico-lare, il Piano di accompagnamento sociale (PAS), ossia un piano strutturato eorganico per la partecipazione degli abitanti alla definizione delle scelte ealla attuazione dei progetti.
Al di là dei molti elementi che qualificano il PSP, c’è un dato di fondo checonnota in termini particolarmente interessanti il progetto, tanto da farneun’esperienza più volte citata nel panorama italiano, in verità non esaltante,delle politiche per le periferie. Per chiarire questo dato, partiamo dallo sloganscelto nel 2003 dal Progetto periferie della Città di Torino per presentare gliesiti dei suoi interventi: “Periferie, il cuore della città”. Ed è proprio qui cherisiede il dato di fondo dell’esperienza del PSP: quello cioè di aver dato pienalegittimità al tema delle periferie, l’averle considerate uno dei centri della cittàe uno dei fulcri della politica urbana torinese in un’azione di sperimentazio-ne che non si limita a mettere in atto singoli interventi, ma li collega ai luoghiin una rete estesa su tutta la città e che intende l’azione nelle periferie comeattività continua di sperimentazione e ricerca. La periferia diviene così plura-le, non assunta ma costruita, da individuare quartiere per quartiere, via pervia, quasi casa per casa, andando alla ricerca dei problemi, ma anche dellepotenzialità di intervento.
Dal 1997, il PSP ha di fatto gestito, utilizzando finanziamenti regionali,nazionali ed europei, tutte le iniziative di riqualificazione e rigenerazioneurbana presenti a Torino: tre Programmi di recupero urbano, quattroContratti di quartiere, un Urban II, un Progetto pilota urbano, tre Program-mi integrati di sviluppo locale e altre azioni locali di rigenerazione urbana edi sviluppo locale partecipato. Accanto a queste iniziative attuate attraversostrumenti formalizzati sono anche stati realizzati tutta una serie di iniziative(dal Laboratorio città sostenibile delle bambine e dei bambini promosso daiServizi educativi nel 1999 al concorso Centopiazze bandito nel 2001) che,nell’insieme, testimonia la grande attenzione al tema delle periferie e l’effer-vescenza di progetti e iniziative del periodo.
8.2.4. La svolta competitiva delle politiche urbane torinesi
Accanto alle iniziative specifiche sulle periferie, la fine degli anni Novanta èsegnata da due momenti importanti per la città. Castellani promuove un’a-zione di governance urbana del tutto innovativa nel panorama italiano, magià sperimentata altrove, il Piano strategico, e nel giugno del 1999 Torinovince la candidatura per ospitare le Olimpiadi invernali del 2006. Entrambi imomenti non hanno un riferimento diretto ed esplicito con il tema delle peri-
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 173
ferie, benché le intersezioni fra strategia di sviluppo urbano, il Programmaolimpico, cioè l’insieme dei progetti per preparare la città a ospitare i XX
Giochi olimpici, e le periferie della città siano numerose. In effetti, il Piano strategico di Torino, promosso dal sindaco nonostante
alcune diffidenze da parte del Consiglio comunale (Spaziante, 2008) e firma-to nel 2000, si pone l’obiettivo di costruire una visione condivisa per lo svilup-po urbano, stimolando l’elaborazione di processi di marketing urbano perfavorire la competitività internazionale della città. Nel Piano, la questionedelle periferie è richiamata solo indirettamente, con riferimento al migliora-mento della qualità e alle azioni di rigenerazione urbana attuate dal PSP. Nonmolto diversi sono i contenuti del Secondo piano strategico, elaborato fra il2004 e il 2006 sotto la guida del nuovo sindaco Chiamparino. Anche in questocaso, il tema delle periferie è trattato con riferimento a principi generali (laqualità sociale e dell’abitare), senza un riferimento specifico ai luoghi e allaqualità urbana degli interventi (una vaghezza, del resto, che secondo alcuneletture critiche caratterizza entrambi i Piani strategici di Torino, cfr. Palermo,2009)3.
Il Programma olimpico, dal suo canto, ha un impatto sulla città straordi-nario. Basti solo ricordare le quantità in gioco: «Le Olimpiadi permettono allacittà di investire 7,5 miliardi di euro in opere pubbliche, che non sono solo le65 opere olimpiche, ma anche i più di mille interventi, nel solo comune diTorino, sulle infrastrutture viabilistiche; 4,5 milioni di metri quadri di solaioutile di nuovi edifici negli ultimi dieci anni, di cui il 70% di edilizia residen-ziale» (De Rossi, Durbiano, 2006, p. 93). Molti di questi metri quadri di solaiosono concentrati in alcune parti della città, lungo il passante ferroviario el’asse della Spina centrale: 342 alloggi trasformati in alloggi di edilizia sovven-zionata nella parte nord e 204 alloggi convertiti in alloggi di edilizia socialenella parte sud. Attraverso il Programma olimpico si attua quindi uno straor-dinario cambiamento fisico, sociale e funzionale di parti della città: periferiae centro, esclusione sociale e rilancio turistico, coesione e marketing, dein-dustrializzazione e sviluppo della ricerca, dei servizi alle imprese, della finan-za, della cultura, vuoti industriali e trasformazioni olimpiche. L’esclusionesociale e la perdita di coesione che caratterizzano alcune parti della città sicombinano con il dispiegarsi di strategie competitive che mirano a posizio-nare Torino nello scenario internazionale, a promuovere il turismo, a rilan-ciare l’immagine urbana.
Dopo due giunte Castellani, nel 2001 Sergio Chiamparino diviene sinda-co di Torino. Dal punto di vista dell’agenda di governo, pur nel mutato pano-rama in cui si muove l’azione politica, l’amministrazione Chiamparino simuove in totale continuità con le azioni avviate da Castellani: metropolitana,Spina, viabilità e Olimpiadi. Una marcata discontinuità si può invece leggere
F R A N C E S C A G O V E R N A / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
174
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 174
8. T O R I N O E L E S U E P E R I F E R I E
175
nel ritorno all’interno della giunta dei «professionisti della politica» (Barbe-ra, Pacetti, 2009, p. 57), in una maggiore visibilità pubblica dell’operato dellagiunta (anche grazie alla straordinaria ribalta mediatica offerta dai Giochiolimpici invernali del 2006), in un progressivo spostamento verso politicheurbane rivolte alla competitività.
Un indizio, forse marginale, del cambiamento di prospettiva che si avviacon il cambiamento della leadership politica della città, è la vicenda del PSP.Nel 2001, si avvia una prima riorganizzazione del Progetto, che cambianome. Diventa infatti Settore periferie, una struttura permanente dell’ammi-nistrazione comunale il cui assessore di riferimento è dapprima il vicesinda-co, Marco Calgaro, e dal 2003 l’assessore alle Politiche per la casa e allosviluppo delle periferie, Roberto Tricarico. Pur nel tentativo di continuarel’esperienza del PSP, nel passaggio da un’esperienza pilota a struttura stabiledell’amministrazione, l’iniziativa sulle periferie sembra perdere la spintainiziale. Questo affievolimento è da attribuire, almeno in parte, al fatto che ilPSP nasce come un’avventura pubblica in un «particolare clima caratterizza-to da una serie di contingenze politiche e programmatiche, dipendendomolto da finanziamenti straordinari dal futuro incerto e da personalità fortiche oggi non vi partecipano più» (Fioretti, 2009, p. 2). Ma è anche vero chela strategia sulle periferie sembra aver progressivamente perso quella forzasperimentale e innovativa che la caratterizzava all’inizio, con il progressivoaffievolirsi di quelle logiche che intendevano ricomporre le diverse azionilocali in una visione policentrica del territorio urbano, investendo più sulwelfare e l’inclusione sociale che sulla trasformazione fisica. Inizialmente,inoltre, l’origine dei finanziamenti e i requisiti per ottenerli avevano portatoil PSP a privilegiare di fatto i luoghi di maggiore disagio e le situazioni parti-colarmente problematiche. Il progressivo esaurirsi delle risorse finanziarie,più o meno straordinarie, per la rigenerazione urbana (Governa, Rossigno-lo, Saccomani, 2008) ha invece spinto progressivamente il Settore periferie aintervenire nelle periferie normali, soggette a forti processi di trasformazio-ne, a perdita di funzioni, caratterizzate da forme di povertà e vulnerabilitàmeno estreme e da situazioni di più o meno difficile convivenza multietnica.In queste aree, apparentemente più semplici, l’azione pubblica sembra avertrovato maggiori ostacoli: paradossalmente, ma forse non troppo, gli inter-venti sono diventati più difficili laddove le situazioni sono meno estreme, iltessuto urbano più ordinario, il veicolo della riqualificazione fisica menoincisivo (e peraltro quasi sempre privo di risorse specifiche), l’esigenza divalorizzare le risorse locali, presumibilmente più ricche in una situazionemeno polarizzata e meno estrema, più pregnante, l’intersettorialità dell’azio-ne pubblica ancor più imprescindibile.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 175
Nel 2006, dopo le nuove elezioni che riconfermano Sergio Chiamparinoa larga maggioranza e il cambiamento della giunta comunale, il Settore peri-ferie cambia ulteriormente ed è sostituito dal Settore rigenerazione urbana(SRU). Come assessore di riferimento è indicata, in “quota sindaco”, IldaCurti, che aveva precedentemente gestito l’esperienza del Progetto pilotaurbano di Porta Palazzo. È ovviamente pretestuoso ragionare unicamentesul cambiamento dei nomi. Tuttavia, la strategia dell’SRU non appare del tuttodelineata, se non dal progressivo superamento degli elementi qualificantil’esperienza del PSP. Scrive Luigi Bobbio (2009, p. 150):
La rincorsa dell’eccellenza e delle trasformazioni immobiliari mette in secondo pianoi problemi sociali. In una città, in qualche misura ancora industriale, in cui sonocresciute le diseguaglianze (e anche i ghetti), il rogo della ThyssenKrupp ha apertouno squarcio su una realtà che la città non conosceva più. Ed è sorprendente comesia stato progressivamente depotenziato quel Progetto speciale periferie […] cheaveva cominciato a intervenire sui (molti) quartieri degradati della città, in modoinnovativo con l’attivo coinvolgimento dei residenti.
Cosa è capitato e perché? Non è facile rispondere a queste domande. Èunicamente possibile avanzare alcune ipotesi. Le ragioni del cambiamentosembrano essere tre:– la progressiva diminuzione dei fondi per la rigenerazione urbana;– lo spostamento dell’agenda pubblica locale verso i temi della competiti-vità urbana;– le innegabili debolezze dell’esperienza del PSP.
Queste ultime, nonostante l’interesse delle iniziative, e più in generaledella “filosofia” di fondo del PSP, rimandano in particolare a cinque difficoltàche “esplodono” nelle pratiche e nel consolidamento delle esperienze(Governa, Rossignolo, Saccomani, 2009). La prima difficoltà è quella dell’in-tegrazione, con la prevalenza, nonostante le premesse e i tentativi di integra-zione di azioni diverse, di interventi di tipo fisico (edilizio e urbanistico). Inquesto modo, la sperimentazione continua di modalità di intervento in cui losviluppo economico e sociale diventi il volano per la rigenerazione comples-siva dei luoghi è di fatto messa in secondo piano, superata dalle più consoli-date modalità di intervento sul piano del degrado fisico degli immobili e deiquartieri. La seconda difficoltà è quella di dare continuità a un’azione di tipointersettoriale da parte della pubblica amministrazione, a fronte dei cambia-menti di contesto, dei cicli elettorali, della sostituzione di alcuni attori chia-ve. Emerge in questo modo un tema fortemente richiamato nel dibattitointernazionale: la necessità, e parallelamente la difficoltà, dell’apprendi-mento, del capacity building, da parte delle pubbliche amministrazioni (Cars
F R A N C E S C A G O V E R N A / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
176
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 176
8. T O R I N O E L E S U E P E R I F E R I E
177
et al., 2002). La terza difficoltà è quella di tradurre nelle pratiche l’ipotesi,in vero ambiziosa, della città policentrica superando l’idea più semplicisticadi un policentrismo derivante unicamente dalla decentralizzazione difunzioni centrali e valorizzando compiutamente le differenze locali. La quar-ta difficoltà rimanda alla partecipazione, per quanto attiene sia i partenariatipubblico/pubblico, e soprattutto pubblico/privato, sia la partecipazionediffusa degli abitanti. L’azione pubblica infatti non sembra aver offerto aiprivati ragioni sufficienti per superare la barriera della scarsa convenienzaeconomica a realizzare investimenti nelle aree periferiche. Parallelamente,anche l’esperienza torinese testimonia le difficoltà e i limiti delle pratiche dipartecipazione degli abitanti e delle cosiddette azioni inclusive, così comedescritte da un’ormai ampia letteratura critica (cfr. Cammelli, 2005; Donolo,2005; Regonini, 2005)4. La quinta difficoltà infine è quella di agire nella cosid-detta “periferia normale”, dove le condizioni di disagio e segregazione sonopuntiformi, dove lo sviluppo economico e urbano ha sedimentato mix difunzioni e di ceti sociali, dove il tessuto urbano è caratterizzato da insedia-menti edilizi privati di maggiore o minore qualità (Governa, Rossignolo,Saccomani, 2008).
Nel complesso, il tema delle periferie sembra progressivamente appan-narsi, la loro tematizzazione e il loro ruolo nelle dinamiche di sviluppo etrasformazione della città diventa meno chiara e netta. Negli Indirizzi di poli-tica urbanistica, redatti dall’assessorato all’Urbanistica nel 2008 è definito ilquadro generale in cui si inseriscono le scelte di trasformazione della città afronte della necessità di un progressivo adeguamento del Piano del 1995 edella necessità di “allargamento” delle politiche urbane della città all’areametropolitana. Nel documento, i temi delle periferie urbane, della rigenera-zione urbana e della coesione sociale non sono esplicitamente richiamati, senon a supporto degli obiettivi di competitività che costituiscono il vero oriz-zonte delle trasformazioni in corso e di quelle prospettate. Che cosa succe-de? Torino dimentica le periferie o le periferie torinesi non hanno più biso-gno di una politica di rigenerazione urbana o, ancora, sono altre le direzioniverso le quali si sta lavorando?5
8.3Riflessioni conclusive
L’interesse dell’esperienza della rigenerazione urbana torinese, in particola-re nella fase iniziale del Progetto speciale periferie, non risiede solo nell’aversperimentato nelle pratiche i principi chiave delle politiche urbane comuni-tarie, traducendo in chiave torinese il metodo Urban, quanto soprattutto
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 177
nell’aver indotto una diversa immagine delle periferie della città e delle possi-bilità di azione al loro interno. Attraverso questa esperienza, la città sembra-va quindi potersi avvicinare a quella quadratura del cerchio cui si accennavanel PAR. 8.1: l’attuazione di iniziative e progetti di respiro e di importanzadiversa in grado di definire una combinazione accettabile fra sviluppoeconomico, benessere sociale e libertà democratica. Questa è stata la verainnovazione del PSP: un’innovazione fortemente dipendente dal momento,dalla ricca stagione di programmi promossi a livello europeo e nazionale,dalle risorse disponibili, dalle persone coinvolte, dagli entusiasmi individua-li, dalla presenza di forti leadership, dai luoghi cui si rivolgeva. E, come tale,un’innovazione fortemente a rischio, difficile da consolidare. Ciò che stupi-sce tuttavia è il fatto che il progressivo affievolimento della spinta innovativasul tema della rigenerazione urbana, a Torino, si sia svolto sotto traccia,senza un’esplicita discussione dei risultati, dell’efficacia, dei limiti di un’e-sperienza. Progressivamente è infatti andata definendosi una crescente sepa-ratezza fra il tema (e la retorica) della competitività, intrecciata alle trasfor-mazioni strutturali e di crescita dell’economia urbana, ai processi dimutamento fisico e sociale, anche in relazione al rilancio del mercato urbanoe immobiliare e ai grandi eventi, e il tema della coesione sociale, declinato inrelazione alla crisi dei modelli tradizionali di welfare territoriale, al tratta-mento dei due grandi fenomeni demografici che caratterizzano Torinonell’ultimo decennio (invecchiamento e aumento degli immigrati regolari eirregolari), alla rinnovata centralità assunta dal tema della casa6.
Alcune possibilità per provare a quadrare il cerchio a partire dalla rige-nerazione urbana vanno però segnalate. Questi segnali risiedono, a nostroavviso, nella possibilità di ridefinire le politiche di rigenerazione urbana tori-nesi all’interno di una più ampia strategia urbana definita alla scala dell’areametropolitana, vero terreno di confronto (e di attenzione) delle attuali sceltedella politica urbana comunale (cfr. Associazione Torino Internazionale,2006; Città di Torino, Assessorato all’Urbanistica, 2008). È proprio in questadirezione che bisogna guardare se si vuole rilanciare la trasformazione dellacittà senza dividere sviluppo economico, coesione sociale e processi inclusi-vi e confrontandosi con alcuni fenomeni molto evidenti: la diffusione urba-na, la crescita di popolazione straniera (che in molti comuni esterni ha vistouna variazione 2007-08 spesso superiore al 30%7), i nuovi vuoti industrialicreati dalla recente crisi (soprattutto lungo l’asse della tangenziale torinese),le grandi aree di trasformazione dell’area metropolitana (in primis sull’assenord l’area BORSETTO e la Tangenziale verde). Forse qualcosa sta cambiandonel tentativo di ricucire il tessuto urbano metropolitano: non si tratta però didefinire accordi limitati su programmi intercomunali, ma di una sfida diffi-cile da affrontare con una diversa visione della città nel suo complesso.
F R A N C E S C A G O V E R N A / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
178
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 178
8. T O R I N O E L E S U E P E R I F E R I E
179
Note
1.@Un unico articolo delle Norme tecniche (art. 24, ##ffoonnttee?? pppp..??##) fa riferimento alle peri-ferie attraverso la previsione di possibili «ambiti di riqualificazione residenziale», individuabi-li dall’amministrazione nelle zone periferiche della città, «in particolare nelle aree già costruitecon interventi di edilizia pubblica», con l’obiettivo di «migliorare la qualità di vita di parti dicittà introducendo servizi, attività pubbliche e private in grado di ridurne l’isolamento, dimigliorarne l’abitabilità e meglio qualificare i centri di quartiere». A questo scopo è da valuta-re la possibilità di sostituire edifici residenziali esistenti, incrementando fino a un 5% l’utiliz-zazione edificatoria esistente.
2.@Il Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Urban I (1994-99) è indirizzato a promuo-vere la rigenerazione socioeconomica di quartieri urbani in crisi attraverso la ricerca di solu-zioni integrate e l’adozione di forme di partenariato locale.
3.@I due Piani strategici di Torino sono presenti nel sito dell’Associazione Torino Interna-zionale: http://www.torino-internazionale.org/.
4.@Un’azione inclusiva è un’azione cui «prendono parte, su un piano di parità, tutti colo-ro che sono coinvolti dalle conseguenze della decisione» (Bobbio, 2005, p. 68). Il problemadelle condizioni di uguaglianza dei partecipanti è discusso in Cammelli (2005), che sottolineacome essa sia praticabile solo in ordine a microdecisioni relative a oggetti e ambiti fortementelimitati (e che quindi non intercettano interessi di maggior rilievo). Un altro problema riguar-da ovviamente la definizione di chi sono coloro coinvolti dalle conseguenze della decisione eche, quindi, devono prendere parte all’azione per connotarla come azione inclusiva.
5.@Ad esempio, il nuovo corso della politica per la casa della città di Torino, per il quale sirimanda al CAP. 7. Sul rapporto fra politiche per la casa e politiche per la rigenerazione urbana(cfr. Governa, Saccomani, 2009).
6.@Il dibattito pubblico del resto non sembra dare segnali molto confortanti, come sostie-ne Sergio Pace (2008, p. 45): «La stessa mediatizzazione delle questioni urbane, in sé positivosegnale di partecipazione, conduce a una spettacolarizzazione delle questioni più complesse,tradotte quasi sempre in monadi polemiche: da piazzale Valdo Fusi al grattacielo di IntesaSanpaolo, tutto si trasforma in casi unici, dove la città si riduce non alle sue architetture ma allacaricatura di poche icone».
7.@Si vedano i dati della Banca dati demografica evolutiva (BDDE) della Regione Piemon-te, elaborazione dell’Ufficio statistica della Provincia di Torino.
Bibliografia
AMIN A., THRIFT N. (2005), Città. Ripensare la dimensione urbana, il Mulino, Bologna.ARTESIO E. (2002), Strumenti di intervento e pratiche di riqualificazione urbana:
il Progetto speciale periferie di Torino, in F. Governa, S. Saccomani (a cura di),Periferie tra riqualificazione e sviluppo locale. Un confronto sulle metodologie esulle pratiche in Italia e in Europa, Alinea, Firenze, pp. 49-53.
ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE (2006), Secondo piano strategico dell’areametropolitana di Torino, Torino, http://www.torino-internazionale.org.
BAGNASCO A. (2008), La città si discute, in Bagnasco, Olmo (2008), pp. 15-24.BAGNASCO A., OLMO C. (a cura di) (2008), Torino 011. Biografia di una città, Mondadori
Electa, Milano.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 179
BARBERA F., PACETTI V. (2009), Torino. Rete policentrica e leadership municipale, inL. Burroni, F. Piselli, F. Ramella, C. Trigilia (a cura di), Città metropolitane epolitiche urbane, Firenze University Press, Firenze, pp. 53-68.
BELLICINI L., INGERSOLL R. (2001), Periferie italiane, Meltemi, Roma.BELLIGNI S., RAVAZZI S., SALERNO R. (2008), L’élite che governa Torino, in “Teoria
Politica”, 1, pp. 85-105.BIANCHETTI C. (2008a), Urbanistica e sfera pubblica, Donzelli, Roma.ID. (2008b), Spina 3 e i paradossi della politica urbana, in Bagnasco, Olmo (2008),
pp. 47-53.ID. (2009), Introduzione. Quantità e quiete: il discorso ideologico sull’abitare, in
“Archivio di Studi Urbani e Regionali”, 94, pp. 9-22.BIANCHETTI C., TODROS A. (2009), Abitare Spina 3, in “Archivio di Studi Urbani e
Regionali”, 94, pp. 63-72.BLANC M., BEAUMONT J. (2005), Local Democracy within European Urban Development
Programmes, in “Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”, 96, 4,pp. 409-20.
BOBBIO L. (2005), La democrazia deliberativa nella pratica, in “Stato e Mercato”, 73,pp. 66-88.
ID. (2009), Un dibattito senza opposizione, in “Archivio di Studi Urbani e Regionali”,94, pp. 149-51.
BOBBIO L., DENTE B., SPADA A. (2005), Government o governance per l’innovazionemetropolitana?, in “Studi Organizzativi”, 2, pp. 29-47.
CAMMELLI M. (2005), Considerazioni minime in tema di arene deliberative, in “Stato eMercato”, 73, pp. 89-96.
ID. (a cura di) (2007), Territorialità e delocalizzazione nel governo locale, il Mulino,Bologna.
CARS G., HEALEY P., MADANIPOUR A., DE MAGALHAES C. (eds.) (2002), Urban Gover-nance, Institutional Capacity and Social Milieux, Aldershot, Ashgate.
CAVALLO PERIN M. (2009), La programmazione territoriale integrata: tra giochi di ruolo,finalità sociali e obiettivi di sviluppo, in “Notiziario dell’Archivio Osvaldo Piacen-tini”, 13, p. 85.
CITTÀ DI TORINO (2003), Periferie. Il cuore della città. 100 buone pratiche, sei anni disviluppo locale partecipato nelle periferie di Torino (1998-2003), Torino.
CITTÀ DI TORINO, ASSESSORATO ALL’URBANISTICA (2008), Indirizzi di politica urbanisti-ca, Torino, http://www.comune.torino.it/indirizzipoliticaurbanistica/pdf/indi-rizzi_politicaurbanistica.pdf.
DEMATTEIS G. (1998), Vecchie e nuove periferie urbane, in C. Cabodi, C. Rossignolo (acura di), Le periferie urbane tra locale e globale, DITer, 11, pp. 81-90.
DE ROSSI A., DURBIANO G. (2006), Torino 1980-2011. La trasformazione e le sue immagi-ni, Allemandi & C., Torino.
DE SANTIS G., RUSSO G. (a cura di) (1997), Crescere, in rete, 18 idee per Torino e per ilPiemonte, Torino Incontra, Torino.
DI BIAGI P. (2006), La periferia pubblica da problema a risorsa per la città contemporanea,in A. Belli (a cura di), Oltre la città. Pensare la periferia, Cronopio, Napoli.
F R A N C E S C A G O V E R N A / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
180
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 180
8. T O R I N O E L E S U E P E R I F E R I E
181
DONOLO C. (2005), Dalle politiche pubbliche alle pratiche sociali nella produzione dibeni pubblici? Osservazioni su una nuova generazione di policies, in “Stato eMercato”, 73, pp. 33-65.
FIORETTI C. (2009), Buone pratiche in Italia, in “Planum”, http://www.planum.net/topics/documents/edinburgh_fioretti3_i.pdf (ultimo accesso ottobre 2009).
FREGOLENT L. (a cura di) (2008), Periferia e periferie, Aracne, Roma. GARELLI M. (1998), Centralità e periferie nell’area torinese, in Associazione Torino
Internazionale (a cura di), I dati fondamentali. Informazioni sintetiche di base perla costruzione del Piano, Torino, http://www.torino-internazionale.org/Page/t04/view_html?idp=2706 (ultimo accesso dicembre 1998).
GOVERNA F., ROSSIGNOLO C., SACCOMANI S. (2008), Torino. Le molte periferie della cittàpost-industriale, in Fregolent (2008), pp. 438-75.
IDD. (2009), Turin: Urban Regeneration in a Post-industrial City, in “Journal of UrbanRegeneration and Renewal”, 3, 1, pp. 20-30.
GOVERNA F., SACCOMANI S. (a cura di) (2002), Periferie tra riqualificazione e sviluppolocale. Un confronto sulle metodologie e sulle pratiche in Italia e in Europa, Alinea,Firenze.
IDD. (2004), From Urban Renewal to Local Development. New Conceptions and Gover-nance Practices in the Italian Peripheries, in “Planning Theory and Practice”, 3,pp. 328-48.
IDD. (2009), Housing and Urban Regeneration Experiences and Critical Remarks Deal-ing with Turin, in “European Journal of Housing Policy”, 9, 4, pp. 391-410.
IRES (2000), La configurazione sociale dei diversi ambiti spaziali nella città di Torino,http://sit.comune.torino.it/html/ires/ (ultimo accesso marzo 2006).
JACQUIER C. (2002), Periferie urbane, frontiere e margini della città: quali forme di gover-nance?, in Governa, Saccomani (2002), pp. 35-48.
MELA A., DAVICO L., CONFORTI L. (2000), La città, una e molte. Torino e le sue dimen-sioni spaziali, Liguori, Napoli.
MIDDLETON A., MURIE A., GROVES R. (2005), Social Capital and Neighbourhoods thatWork, in “Urban Studies”, 42, 10, pp. 1711-38.
MURIE A., MUSTERD S. (2004), Social Exclusion and Opportunity Structures in EuropeanCities Neighbourhoods, in “Urban Studies”, 41, 8, pp. 1441-59.
PABA G. (1998), Luoghi comuni. La città come laboratorio di progetti collettivi, Fran-coAngeli, Milano.
PACE S. (2008), Condizioni di partenza, in Bagnasco, Olmo (2008), pp. 34-46.PALERMO P. C. (2009), I limiti del possibile. Governo del territorio e qualità dello svilup-
po, Donzelli, Roma.REGONINI G. (2005), Paradossi della democrazia deliberativa, in “Stato e Mercato”, 73,
pp. 3-31.ROBINSON D. (2005), The Search for Community Cohesion: Key Themes and Dominant
Concepts of the Public Policy Agenda, in “Urban Studies”, 42, 8, pp. 1411-27.SACCOMANI S. (2001), Per attuare il piano occorre cambiarlo, in “Atti e Rassegna Tecni-
ca”, 55, 1-2, pp. 29-36.
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 181
ID. (2004), Programmi complessi: una rilettura delle esperienze, in Regione Piemonte,CVT – Centri valutativi territoriali, Valutare i programmi complessi, L’artistica,Savigliano (CN), pp. 15-38.
SCAMUZZI S. (a cura di) (2005), Élite e reti in una città in trasformazione, FrancoAn-geli, Milano.
SPAZIANTE A. (2008), I protagonisti dell’attuazione del PRG Valentino Castellani, Sinda-co di Torino del 1993 al 2001, in Torino. Tredici anni di attuazione del PRG, “Atti eRassegna Tecnica”, 62, 1-2, pp. 61-7.
VANDELLI L. (1997), Sindaci e miti, il Mulino, Bologna.ID. (2000), Il governo locale, il Mulino, Bologna.
F R A N C E S C A G O V E R N A / C R I S T I A N A R O S S I G N O L O
182
Santangelo_2B_XP6.qxd 2-07-2010 19:08 Pagina 182