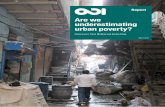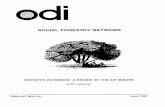L. Benelli, Il delle Odi di Saffo (Univ. di Pisa, 2008).
Transcript of L. Benelli, Il delle Odi di Saffo (Univ. di Pisa, 2008).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
3
Sommario Introduzione 5
1.Saffo: per una biografia. 5
2.Problema cronologico fondamentale 8
3.Gevnh ed oijkivai nella Grecia arcaica e classica 13
Inquadramento del problema 13
La suddivisione dell'Attica prima della riforma clistenica (509 a.C.) 14
Il gevno": modelli a confronto 18
Il gevno": storia della discussione critica 20
Alla ricerca di un nome per i "gruppi" aristocratici 34
4.Il contesto 46
Storia e società: l'isola di Lesbo fino al periodo di Saffo e di Alceo 46
5.Pittaco 68
Problemi di cronologia 68
Pittako;" oj kakopatrivdai" 70
Le Mariage du Tyran 79
6.Un'altra prospettiva: Saffo, Pittaco e la Lidia 81
Mirsilo e Kandauvlh", to;n oiJ {Ellhne" Mursivlon ojnomavzousi (Hdt. I 7) 81
I Cleanattidi e la Lidia 84
Saffo 86
Pittaco e la Lidia 90
7.Andromeda e Gorgò nei frammenti di Saffo e loro contestualizzazione nella
Mitilene del tempo 94
Problemi di individuzazione 94
8.La tradizione 99
L'edizione alessandrina. 99
9.Il libro quarto di Saffo 107
Struttura metrica, struttura strofica ed ordine delle odi 108
Il colofone del POxy. 1787 ed il titolo del libro quarto di Saffo 115
La tradizione diretta 116
“Libro Quarto” 122 Bibliografia 360
Indice degli antroponimi, dei toponimi, degli idronimi e di altri dati notevoli 373
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
5
Introduzione
1. Saffo: per una biografia.
La ricostruzione e la successiva, sintetica esposizione della biografia di un autore antico
non possono, a differenza di quanto accade per un autore moderno, fare affidamento su
dati certi: il materiale principale per uno storico, come per un biografo, saranno le fonti
ed i documenti, solitamente riuniti in quella parte di un'edizione che prende il titolo di
Testimonia. La fonte principale che abbiamo a disposizione per ricostruire la vita della
Poetessa lesbia è, come del resto per molti altri autori antichi, un lemma del lessico
Suida, precisamente S107 A. (il testo completo è, un po' infelicemente, suddiviso in due
testimonia diversi nell'edizione Voigt: 253+235 V.):
Sapfwv, Sivmwno", oiJ de; Eujmhvvnou, oiJ de;; jHeriguvou, oiJ de; jEkruvtou, oiJ de; Shvmou, oiJ de; Kavmwno", oiJ de; jEtavrcou, oiJ de; Skamandrwnuvmou: mhtro;" de; Kleidov": Lesbiva ejx jEressou', lurikhv, gegonui'a kata; th;n mbV jOlumpiavda, o{te kai; jAlkai'o" h\n kai; Sthsivcoro" kai; Pittakov". h\san de; aujth'i kai; ajdelfoi; trei'", Lavrico", Cavraxo", Eujruvgio". ejgamhvqh de;•ajndri; Kerkuvlai plousiwtavtwi, oJrmwmevnwi ajpo; [Androu, kai; qugatevra ejpoihvsato ejx aujtou', h} Klei;" wjnomavsqh. eJtai'rai de; aujth'" kai; fivlai gegovnasi trei'", jAtqiv", Telesivppa, Megavra: pro;" a}" kai; diabolh;n e[scen aijscra'" filiva". maqhvtriai de; aujth'" jAnagovra (
jAnagovra codd. : jAnaktoriva Neue 1827, 7) Milhsiva, Gogguvla Kolofwniva, Eujneivka Salaminiva. e[graye de; melw'n lurikw'n bibliva qV. kai; prwvth plh'ktron eu|ren. e[graye de; kai; ejpigravmmata kai; ejlegei'a kai; ijavmbou" kai; monwidiva". Saffo, figlia di Simone, per altri di Eumeno, per altri di E(e)rigio, per altri di Ecrito, per
altri di Semo, per altri di Camone, per altri di Etarco, per altri di Scamandronimo; Cleide
la madre. Lesbia di Ereso, poetessa lirica, fiorita nella Olimpiade quarantaduesima,
quando vi erano anche Alceo, Stesicoro e Pittaco. Ebbe tre fratelli: Larico, Carasso, ed
E(u)rigio. Fu presa in moglie da Cercila, un uomo ricchissimo proveniente da Andro, da
cui ebbe una figlia, chiamata Cleide. Le sue compagne ed amiche sono state tre: Attide,
Telesippa e Megara, a riguardo delle quali ebbe l'accusa di turpe amicizia. Sue allieve
furono Anattoria di Mileto, Gongila di Colofone, Eunica di Salamina. Scrisse nove libri
di poesie liriche e per prima inventò il plettro. Compose anche epigrammi, elegie,
giambi e monodie.
Le fonti antiche sono in profondo disaccordo tra loro, già a partire dal nome del padre di
Saffo: la Suida, lo abbiamo visto, fornisce otto nomi diversi: Simone, Eumeno,
E(e)rigio, Ecrito, Semo, Camone, Etarco, oppure Scamandronimo: di tutti questi l’ultimo
è il solo a godere, a quanto sembra, di una certa autorevolezza, in quanto citato anche da
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
6
Hdt. II 135, 11, passo su cui torneremo tra poco: che il padre di Saffo si chiamasse
Scamandronimo è oggi accettato da tutti gli studiosi.
Per l’autore di “Suida” la città natale della poetessa sarebbe Ereso, centro occidentale
dell’isola di Lesbo, un dato presentato anche da Diosc. A. P. VII 407. Altri autori,
invece, sostengono che la casa di Saffo sorgesse in Mitilene2.
Le fonti oscillano, inoltre, tra una datazione alta ed una più bassa. La cronologia più alta
è attestata, oltre che dal lessico Suida (che pone l'ajkmhv nella Olimpiade
quarantaduesima = 612-609 a.C.), anche da Eusebio3 e dal Marmor Parium (Sapph. T
251 V.), che data l'esilio in Sicilia della poetessa eolica tra il 604 ed il 591 a.C. e sulla
cui testimonianza torneremo. Poiché l'ajkmhv era solitamente posta intorno ai quaranta
anni, Saffo sarebbe nata, secondo l'ignoto autore della Suida, la sua fonte ed il Marmor
Parium verso il 650 a.C.
La Suida nomina tre fratelli di Saffo: in ordine di attestazione, Larico, Carasso ed
E(u)rigio: dei tre, quello su cui abbiamo maggiori notizie è Carasso, a proposito del
quale Hdt. II 135 racconta come, durante un viaggio di commercio in Egitto, si fosse
innamorato della cortigiana Rodopi che, per alcuni greci, era l’artefice della piramide di
Micerino. Altre fonti, invece, sostengono che l’amante di Carasso in Egitto si chiamasse
Dorica e questo trova palese riscontro in alcuni carmi di Saffo. Quanto agli altri due
fratelli di Saffo, Larico e E(u)rigio, abbiamo informazioni davvero scarse: sappiamo solo
che in qualche ode saffica veniva detto che il primo, Larico, serviva come coppiere nel
pritaneo della città di Mitilene4: secondo alcuni studiosi, che tendono a contemperare la
nascita ad Ereso e la casa a Mitilene, Saffo, già prima del matrimonio con Cercila, si
sarebbe spostata con tutta la famiglia da Ereso a Mitilene.
1 Così anche Bowra 1961, 176. Bowra ipotizza che gli altri nomi si siano diffusi con la Commedia di
Mezzo e con la Neva. 2 Athen. X 424e; Strab. 617; Mar. Par. 36.
3 Hier. (Euseb.) Chron. A Abr. Ol. XLV p. 99
b H. (2,93 Schöne) = Sapph. T 249 V.: Sappho et Alcaeus
poetae clari habebantur. 4Cfr. Ath. X 425a Sapfwv te hJ kalh; pollacou' Lavricon to;n ajdelfo;n ejpainei' wJ" oijnocoou'nta ejn tw'i prutaneivwi toi'" Mutilhnaivoi" "e la bella Saffo in molti carmi elogia il fratello Larico come
coppiere nel pritaneo dei Mitilenesi"; Eust. in Iliadem 1205, 17 ss. hJ d∆aujth; Sapfw; kai; to;n Lavricon, ajdelfo;n aujth'", ejpainei' wJ" oijnocoou'nta ejn tw'i prutaneivwi th'" Mitulhvnh"; Schol. T in Illiadem U 234 [= Sapph. T 203a-c V.] e[qo" ga;r h\n, wJ" kai; Sapfwv fhsi, nevou" eujgenei'" eujprepei'" oijnocoei'n "era usanza, come dice Saffo, che i giovani nobili e belli versassero vino".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
7
Secondo le ipotesi oggi più accreditate, Saffo sarebbe stata un membro della oijkiva dei
Cleanattidi, una potente famiglia mitilenese subentrata, nell'esercizio del potere, ai
Pentilidi: Megacle (?), Melancro e Mirsilo sarebbero stati i rappresentanti più importanti
e potenti. Dopo la morte di Melancro, tuttavia, il potere della famiglia non fu mai più
così grande e il potere fu poi consegnato a Pittaco, affinché riorganizzasse uno stato
prostrato dalle discordie civili. La famiglia di Saffo, quindi, non fu indenne dai
rivolgimenti politici che caratterizzarono la storia di Lesbo tra la fine del VII e gli inizi
del VI sec. a.C.: sappiamo, anzi, che Saffo fu, durante o prima l'esimnetia di Pittaco,
costretta ad abbandonare l'isola insieme alla sua famiglia per andare in esilio in Sicilia, a
Siracusa: la Suida non parla di questo avvenimento e la nostra fonte è, come abbiamo
accennato, il Marmor Parium (Sapph. T 251 V.; 9 Gall. = FGrHist 239 A 36):
36 ajfou| Sapfw; ejg Mitulhvnh" eij" Sikelivan e[pleuse fugou'sa......OL.....Q.....[a[rco]n≥to" jAqhvnhsin me;n Kritivou protevrou, ejn Surakouvssai" de; tw'n gamovrwn katecovntwn th;n ajrch;n
36 Da quando Saffo da Mitilene navigò verso la Sicilia in esilio 3…anni, quando ad
Atene era (arco)nte il primo Crizia ed a Siracusa avevano in mano il potere i proprietari
terrieri
Il Marmor restituisce, purtroppo, un testo lacunoso proprio nell'indicazione precisa
dell'anno ed il nome dell'arconte ateniese non è di grande aiuto, perché esso non è
presente nelle liste in nostro possesso. Tuttavia, noi conosciamo il nome dell'arconte5
ateniese dell'anno 605/604 a.C. (Aristocle, riportato dallo stesso Marmor Parium nel
precedente riferimento cronologico) e quello di tutti gli altri dagli anni 597/596
([Ky]pselo[s]) fino al 591/590 a.C. (Simone): perciò l'arcontato di Crizia ad Atene e
l'esilio di Saffo deve porsi, necessariamente, tra il 605/604 ed il 597/6: la datazione può
ancor più essere precisata qualora si consideri che, secondo Bradeen (1963, 187), la
quarta lettera del nome dell'arconte precedente (cioè del 598/597) a [Ky]pselo[s] deve
essere un alfa, un gamma o un my e quindi non può celarvisi il nome di Crizia: ecco che,
quindi, la forbice si accorcia, inglobando ora solo gli anni tra il 604 ed il 598 a.C.:
curiosamente si tratta, all'incirca, proprio del periodo che Eusebio considera come ajkmhv
della poetessa eolica. Del resto, tracce dell'esilio di Saffo si ritrovano non solo nel
5 Per la lista degli arconti ateniesi (e delle varie magistrature) si rimanda al meritorio repertorio di R.
Develin: Develin 1989, 33 s.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
8
Marmor Parium, ma anche in Cic. Verr. II 4, 126-7 sgg., dove Cicerone afferma che nel
pritaneo di Siracusa vi era una statua di Saffo, poi portata via (cioè sottratta da Verre:
nam Sappho quae sublata de prytanio), con tanto di iscrizione in greco sul piedistallo.
Recentemente, Enzo Puglia e Franco Ferrari, combinando alcuni frustoli del POxy. 1787
che già conoscevamo, hanno restituito un'intera ode, la prima di tal genere a noi
conosciuta, in cui Saffo parla direttamente del suo esilio: si potrebbe, quindi, ora
ipotizzare che gli scarsi accenni presenti nei frammenti saffici agli avvenimenti politici
dell'isola6 siano dovuti al fatto che i componimenti conosciuti sono, tuttora, piuttosto
scarsi.
Comunque sia, Saffo riuscì a tornare, dopo l'esilio, sull’isola, dove trascorse gli ultimi
anni della sua vita: al periodo della vecchiaia si legano, infatti, alcuni carmi, tra cui i due
traditi dal P.Colon. 21351+21376 ed appartenenti al libro quarto dell'edizione
alessandrina.
2. Problema cronologico fondamentale
Le fonti antiche ci tramandano due cronologie diverse: Erodoto pone tutta la storia di
Lesbo del periodo di Saffo e di Alceo alla metà del VI secolo a.C., al tempo dei
Pisistratidi, mentre gli autori successivi (Strabone, Plutarco, Diogene Laerzio, Eusebio,
la Suida) fanno di Saffo, Alceo e Pittaco dei contemporanei di Solone, retrodatando tutti
gli avvenimenti di cinquanta anni e ponendo la loro ajkmhv nell’Olimpiade
quarantaduesima, corrispondente, nel computo occidentale moderno, al 612-609 a.C.
L’evento storico più importante per quanto concerne la “politica estera” di Mitilene nel
periodo di Pittaco, di Saffo e di Alceo è la guerra che vide scontrarsi mitilenesi ed
ateniesi per il possesso del Sigeo, per cui v. infra: le fonti sono Strabone (XIII 38) ed
Erodoto (V 94-95), ma lo storiografo nativo di Alicarnasso pone la guerra al tempo dei
Pisistratidi: dopo la cacciata da Atene, Ippia trova rifugio nella fortezza del Sigeo:
Erodoto ne approfitta per narrare come essa fu conquistata da Pisistrato sui Mitilenesi e
come il tiranno ateniese ne aveva affidato il governo al figlio Egesistrato, il quale aveva
dovuto resistere agli attacchi dei Mitilenesi: in uno scontro il poeta Alceo era fuggito e
compose un carme per Melanippo, informandolo che era ancora in vita; la guerra fu
6 Cfr. Ferrari 1987, 79-80.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
9
risolta con un arbitrato di Periandro (anche lui considerato contemporaneo di Egesistrato
e Pisistrato): ognuno doveva mantenere ciò che aveva e così Sigeo rimase sotto gli
Ateniesi. Invece, per tutte le altre fonti, la più importante delle quali è Strabone (XIII
38), la guerra per il possesso del Sigeo a cui parteciparono Pittaco ed Alceo sarebbe
avvenuta almeno cinquanta anni prima, alla fine del VII secolo e non è l’unica
divergenza di Erodoto rispetto agli altri autori: egli, infatti, non parla in alcun modo di
Frinone, vincitore al pancrazio nel 636 a.C. e capitano dell’armata ateniese nella
spedizione al Sigeo, contro cui Pittaco, a stare a molte fonti (Strab. XIII 1, 38; Plut.
Herod. Mal. 858a; Diog. Laert. I 74; Polyaen. I 25), si sarebbe scontrato in singolar
tenzone. L’omissione dello scontro tra Pittaco e Frinone non sfuggì a Plutarco (De
Herodoti malignitate 858a-b), che accusò lo storico di avere assunto, nella composizione
della sua opera, un atteggiamento maligno e tendenzioso.
Anche per Pittaco e per i suoi attriti con la vicina Lidia Erodoto propone una cronologia
ben più bassa, facendo di Pittaco un contemporaneo di Creso. In questo caso, tuttavia, la
problematica è ben più vasta, visto che anche altre fonti, alcune delle quali testimoniano
la cronologia “alta” (Diogene Laerzio, soprattutto), parlano di un supposto incontro tra
Pittaco ed il re lidio: la contemporaneità di Pittaco e Creso non creerebbe molti
problemi, visto che Creso nacque nel 596 a.C. e Pittaco sarà morto negli anni ’70 del VI
secolo a.C., senonchè alcune di queste fonti parlano di un Creso re della Lidia, ma ciò
non può essere vero per il periodo in cui Pittaco era ancora vivo: il re lidio, infatti, salì al
trono nel 560/561 a.C., all'età di trentacinque anni7. Dunque, se si accetta il racconto
delle nostre fonti, Pittaco deve aver incontrato Creso quando quest’ultimo non era
ancora re: Gentili8, ad esempio, propende per porre l'incontro intorno al 575 a.C.,
quando un Creso ventunenne fu mandato dal padre Aliatte, che in quegli anni stava
conducendo una campagna in Caria, a governare le città di Adramyttium e di Tebe nella
Troade9: se, però, si accetta la cronologia proposta dallo Jacoby (v. infra), in quell'anno
Pittaco doveva essere già morto, anche se da pochissimi anni (due o, forse, tre).
7Cfr. Hdt. I 26 teleuthvsanto" de;•jAluavttew ejxedevxato th;n basilhivhn Kroi'so" oJ jAluavttew, ejtevwn ejw;n hJlikivhn pevnte kai; trihvkonta "Morto Aliatte, ereditò il regno Creso, figlio di Aliatte,
all'età di trentacinque anni". 8 Cfr. Gentili 2006, 150 (n. 50).
9Cfr. Nicol. Damasc. FGrHist 90 F 65 {Oti jAluavtth" oJ Kroivsou path;r, tou' Ludw'n basilevw", ejpi; Karivan strateuvwn, perihvggeile toi'" eJautou' strato;n a[gein eij" Savrdei" ejn hJmevrai takth'i, ejn oi|" kai; Kroivswi, o{sti" h\n aujtou' presbuvtato" tw'n paivdwn, a[rcwn ajpodedeigmevno" jAdramuttivou te kai; Qhvbh" pedivou. "…che Aliatte, padre di Creso, re dei Lidi, mentre stava
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
10
La cronologia di Erodoto presuppone anche postdatazioni di fatti attinenti alla vita
privata dei singoli personaggi. È il caso (Hdt. II 135 = Sapph. T 254 a V.), famoso, della
confusione tra Dorica, l’etera amata dal fratello di Saffo, Carasso, e Rodopi, una
cortigiana che, secondo alcuni greci, avrebbe costruito la piramide di Micerino: costei
sarebbe vissuta al tempo di Amasi, re d'Egitto tra il 569 ed il 528 a.C.:
Rodw'pi" de; ej" Ai[gupton ajpivketo Xavnqew tou' Samivou komivsantov" [min], ajpikomevnh de; kat∆ ejrgasivhn ejluvqh crhmavtwn megavlwn uJpo; ajndro;" Mutilhnaivou Caravxou tou' Skamandrwnuvmou paidov", ajdelfeou' de; Sapfou'" th'" mousopoiou'. Rodopi giunse in Egitto condotta da Xanto di Samo e, una volta giunta per esercitare la
prostituzione, fu liberata con una forte somma di denaro da un uomo di Mitilene,
Carasso, figlio di Scamandronimo e fratello della poetessa Saffo.
Le differenze, cronologiche e non, che Erodoto dimostra rispetto ad altre tradizioni (per
noi essenzialmente la Suida) non sfuggirono ad Ath. XIII 596 b-c:
ejndovxou" de;• eJtaivra" […] h[negken kai; hJ Nauvkrati": Dwrivcan te, h}n hJ kalh; Sapfw; ejrwmevnhn genomevnhn Caravxou tou' ajdelfou' aujth'" kat∆ ejmporivan eij" th;n Nauvkratin ajpaivronto" dia; th'" poihvsew" diabavllei wJ" polla; tou' Caravxou nosfisamevnhn. JHrovdoto" d∆ aujth;n JRodw'pin kalei'.
Famose cortigiane procurò anche Naucrati: tra le quali vi era anche Dorica di cui la bella
Saffo denuncia nelle sue poesie che, divenuta l'amante del fratello Carasso quando egli
giunse a Naucrati per motivi commerciali, gli avrebbe sottratto molte sostanze. Erodoto,
invece, la chiama Rodopi.
Questa datazione fornita da Erodoto mal si concilia con la data del floruit fornita dalla
Suida: infatti, ponendo la nascita di Saffo intorno al 650 a.C. (come ci obbliga il lessico
bizantino) saremmo portati a ritenere che i F 5 e 15 V. siano stati composti, abbastanza
inverosimilmente, da una Saffo ultraottantenne10
: è possibile, tuttavia, eliminare le due
difficoltà ipotizzando che Rodopi fosse un vezzeggiativo11
e che Carasso avesse
riscattato Rodopi, poi rimasta in Egitto, prima dell'inizio del regno di Amasi.
Una tale situazione, ovvero la presenza, fin dall’antichità, di due cronologie per gli stessi
avvenimenti, non poteva che mettere in seria difficoltà gli studiosi moderni, in primo
compiendo una campagna militare contro la Caria, recò dappertutto a quelli, tra cui vi era anche Creso,
il più anziano dei figli, che aveva ricevuto il comando della piana di Adramittio e di Tebe, l'ordine di
ricondurre l'esercito a Sardi nel giorno fissato". 10
Cfr. Di Benedetto 1982, 228 sgg. 11
È significativo che Strab. XVII 1, 33 conosca sia il nome della Suida, sia quello riportato da Erodoto e
criticato da Ateneo.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
11
luogo gli storici, ma anche i grecisti, dato che alcuni protagonisti di queste vicende
furono anche lirici arcaici.
A favore della cronologia “bassa”, che rende Saffo, Alceo e Pittaco contemporanei dei
Pisistratidi e di Creso, si schierò per la prima volta lo storico tedesco Julius Beloch (GG,
I 330 n. 2) il quale, non credendo alla cronologia fornita da Eusebio, che risaliva ai
cronografi alessandrini, dette ragione a Erodoto. Il più importante seguace della
cronologia proposta dal Beloch è stato Gaetano De Sanctis (SG, I 351, 521), seguito da
Santo Mazzarino (1943, 75s.): quest’ultimo, rendendo Pittaco contemporaneo di Creso,
torna a ventilare l’ipotesi che un incontro tra i due possa essere realmente avvenuto.
E tuttavia il numero dei favorevoli ad una cronologia “alta” è sempre stato maggiore di
quelli che, invece, sostenevano la necessità di una cronologia “bassa”. Sostenitori di una
cronologia alta furono, tra gli altri, Eduard Meyer e lo stesso Wilamowitz, seguiti a
distanza di qualche tempo da Wade-Gery e dal Bowra (1961, 176). L’opinione di Beloch
oggi non riscuote molti sostenitori: ad esempio David Asheri (1988, 280) ritiene che “il
tentativo di alcuni studiosi di abbassare la cronologia di tutti i personaggi coinvolti può
considerarsi fallito”.
Converrà ora analizzare i pro ed i contro delle due cronologie. La cronologia “bassa”
consentirebbe di prestar fede ad Erodoto quando costui parla di Rodopi come se si
trattasse di Dorica, l’amante di Carasso, oppure quando parla dell’incontro tra Pittaco e
Creso (del resto dell’incontro dei due personaggi parlano anche altre fonti); questa
possibilità eviterebbe, inoltre, la necessità di dover pensare a due guerre del Sigeo, una
al tempo di Pittaco ed Alceo (a cavallo tra il VII ed il VI secolo a.C.) e l’altra al tempo di
Egesistrato (metà del VI secolo).
Accettare la cronologia erodotea, tuttavia, significa eliminare la figura di Frinone, il
capitano dell’armata ateniese che si scontrò contro Pittaco: nella narrazione erodotea non
è presente e, del resto, la sua presenza non avrebbe senso in età Pisistratica. E, certo, non
poteva essere presente nella versione erodotea, visto che fu olimpionico col pancrazio
nel 636 a.C. Dal punto di vista cronologico, inoltre, se si accetta la cronologia bassa si è
costretti a porre la nascita di Saffo nella Olimpiade quarantaduesima (612-609 a.C.):
Suida, infatti, dice che Saffo gegonui'a kata; th;n mbV jOlumpiavda: gevgone può
riferirsi, nel linguaggio del lessico bizantino al floruit oppure, più raramente, alla
nascita: chi ritiene valida la cronologia “bassa” sarà costretto ad intendere gegonui'a
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
12
come indicazione della data di nascita, ma così si creano delle circostanze inverosimili:
il Canone di Eusebio [= Hieron. 99 b 6 H.] pone una data importante nella vita di Saffo
e di Alceo nel primo (= 600 a.C.) o nel secondo anno (= 599 a.C.) della XLV Olimpiade:
«Sappho et Alcaeus poetae clari habentur»: se, dunque, nella vita di Saffo una data
importante è costituita dal 600 ca. a.C., non potrà essere nata nella Olimpiade
quarantaduesima (612-609 a.C.) perché, altrimenti, avrebbe avuto all’epoca, al massimo,
solo tredici anni. L’altro documento che costringe a collocare la vita di Saffo (e quindi
anche quella di Alceo, Pittaco, Mirsilo, Melancro, Andromeda, Gorgò etc.) tra la fine del
VII e l’inizio del VI secolo a.C., è, probabilmente, il Marmor Parium che, come
abbiamo visto, data l’esilio di Saffo tra il 604 ed il 598 a.C., ovvero circa allo stesso
periodo in cui il Canone di Eusebio pone il floruit. Se si considera, come si è costretti a
fare se si collocano tutti gli avvenimenti verso la metà del VI secolo, che Saffo sia nata
nella Olimpiade quarantaduesima (612-609 a.C.), anche a prendere gli anni più estremi
dell’intervallo (il 612 ed 598 a.C.), Saffo sarebbe andata in esilio a quattordici anni: se
così fosse molto probabilmente lo sconosciuto autore del Marmor non avrebbe riportata
la notizia nella sua cronaca perché per lui (ed anche per noi) irrilevante. Il Marmor non
viene citato dal Beloch.
Anche un altro documento si pone contro la datazione “bassa”, è la Vita di Solone di
Plutarco: Beloch (GG, I 330) sostiene che il silenzio di Plutarco in quest’opera sia
indicativo, ma lo storico tedesco non si è accorto che proprio in Solone c’è un dato che
va contro la sua cronologia: Plut. Sol. 14, 7 dice, infatti, che quando il legislatore Solone
arrivò al potere ad Atene Pittaco, a Mitilene, governava già, anche se da poco tempo
(nu'n). Il Beloch, seguendo Erodoto, risolve il problema alla radice: spostando anche la
vita di Solone più avanti di cinquanta anni e rendendolo, quindi, contemporaneo di
Creso. A favore della cronologia “alta” è tutto ciò che è contrario alla “bassa”: tutte le
testimonianze antiche (e tra di esse una posizione di primo piano spetta al Marmor
Parium), tranne Erodoto; il duello tra Frinone e Pittaco di cui parlano molte fonti antiche
tranne Erodoto e che non avrebbe senso nel VI secolo. A sfavore della datazione “alta”
è, invece, la necessità di postulare due guerre del Sigeo tra Ateniesi e Mitilenesi e la
testimonianza di vari autori che parlano di un incontro e di una corrispondenza tra
Pittaco e Creso, il ricco sovrano della Lidia, ma nessuno dei due argomenti, a ben
vedere, è definitivo: non conosciamo a tal punto la storia del periodo per negare in modo
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
13
incontrovertibile che due guerre possano essersi svolte; e per quanto riguarda il secondo
argomento la datazione “alta” non preclude alcunché: non sappiamo con certezza la data
della morte di Pittaco e nulla vieta di pensare ad un incontro tra Pittaco ed un Creso
diciottenne o poco più, che all’epoca non era una data troppo bassa: sicuramente, però,
Creso non sarà stato ancora il re della Lidia.
La conclusione che si deve trarre, dunque, è che Saffo non può essere nata nella
quarantaduesima Olimpiade, ma a quella data andrà posta la sua ajkmhv, come del resto
quella degli altri due protagonisti, Pittaco ed Alceo, sicchè tutti gli avvenimenti, rispetto
ad Erodoto, andranno retrodatati di una cinquantina di anni, come del resto fanno le altre
fonti antiche, alcune direttamente, altre indirettamente; ed esse sono la maggioranza:
Strabone, Plutarco, Diogene Laerzio, Polieno, la Suida, etc.
3. Gevnh ed oijkivai nella Grecia arcaica e classica
Inquadramento del problema
Prima di proseguire nell'analizzare il contesto storico e sociale in cui visse Saffo, sembra
utile, ai fini di una più corretta comprensione del séguito, affrontare alcuni problemi di
carattere terminologico, primo fra tutti il concetto di gevno". Partiamo, come spesso
avviene, dalla presa di coscienza di alcuni realia, ovvero l'esistenza, nella Grecia dell'età
arcaica, dopo la fine delle "Età oscure", di una serie di gruppi o di comunità che si
designano con un nome collettivo, generalmente un patronimico o gentilizio. Gli esempi
di cui abbiamo conoscenza sono diffusi un po' ovunque nella penisola ellenica e nelle
isole prospicienti, ma i casi più famosi sono, senza ombra di dubbio, gli Alcmeonidi, i
Licomidi, i Pisistratidi (se si possono considerare membri di un gevno") e gli Eteobutadi
ad Atene; i Bacchiadi ed i Cipselidi a Corinto; gli Agiadi e gli Euripontidi a Sparta e, per
quanto attiene maggiormente alla nostra discussione, i Cleanattidi, gli Archeanattidi, i
Polianattidi ed i Pentilidi a Lesbo.
A questi gruppi aristocratici si è soliti dare il nome di gevnh o, più genericamente, di
clan. La prima caratteristica di queste formazioni è una qualche forma di legame, reale o
presunto, di parentela e, conseguentemente, la supposta discendenza da un antenato
comune: del resto, è ben rispecchiata sia dal suffisso –id-, sia dallo stesso sostantivo
gevno". Altre caratteristiche di queste formazioni sarebbero: l'elevato numero di membri,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
14
la chiusura in sé stesse, la presenza di un capo, il possesso di un klh'ro" e di iJerav
peculiari.
Secondo l'opinione tradizionale, condivisa soprattutto dagli storici ed antropologi
dell'Ottocento (Grote, Morgan, Fustel de Coulanges) e di alcuni dei primi anni del
Novecento (Glotz)12
, si tratterebbe di un relitto fossile, ancora presente in epoca storica,
della preistorica società indoeuropea, ma destinato rapidamente a scomparire al
momento della comparsa della povli" e dei suoi nuovi valori, politici, giuridici e,
soprattutto, economici. L'antica origine indoeuropea sarebbe dimostrata dalle
somiglianze formali tra il gevno" greco e la gens romana, due termini, non a caso,
derivati dalla stessa radice.
La suddivisione dell'Attica prima della riforma clistenica (509 a.C.)
Le quattro tribù "ioniche"
Filocoro, autore del III sec. a.C., afferma (Philoc. apud Strab. IX 396) che Cecrope
avrebbe, all'origine, suddiviso l'Attica in dodici distretti:
Tosau't∆ou\n ajpovcrh prosqei'sin o{ti fhsi; Filovcoro" porqoumevnh" th'" cwvra" ejk qalavtth" me;n uJpo; Karw'n ejk gh'" de; uJpo; Boiwtw'n, ou{" ejkavloun [Aona", Kevkropa prw'ton eij" dwvdeka povlei" sunoikivsai to; plh'qo", w|n ojnovmata Kekropiva Tetravpoli" jEpakriva Dekevleia jEleusi;" ]Afidna (levgousi de; kai; plhquntikw'" jAfivdna") Qovriko" Braurw;n Kuvqhro" Sfhtto;" Khfisiav A tutto ciò, che è bastevole, aggiungono che Filocoro dice che, essendo devastata la
regione dal mare dai Cari e dalla terra dai Beoti, che chiamavano Aoni, Cecrope per
primo unificò la popolazione in dodici città, i cui nomi sono Cecropia, Tetrapoli,
Epacria, Deceleia, Eleusi, Afidna (ma dicono anche al plurale, Afidne) Torico,
Braurone, Citero, Sfetto, Cefisia.
In altri racconti si parla, invece, di una distribuzione per quattro tribù, i cui nomi
sarebbero stati, al tempo di Cecrope, Cecropide, Autoctono, Actéa e Paralia. Al tempo
del re Cranao queste quattro tribù avevano i nomi seguenti: Cranaide, Attide,
Mediterranea e Diacria. Al tempo del re Erittonio si chiamavano, invece, Diade,
Atenaide, Posidonia ed Efestia. Da ultimo, poco dopo il regno di Eretteo, assunsero il
nome dei figli di Ione (figlio di Apollo e di Creusa, figlia di Eretteo), ovvero Geleonti,
Opleti, Egicorei ed Argadei Queste quattro tribù, con i nomi menzionati da ultimo,
12
Per la storia della discussione critica sul concetto di gevno" v. infra.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
15
vengono comunemente dette "ioniche" per il fatto di derivare il nome, secondo la
tradizione, dai quattro figli di Ione13
: rimasero a quanto sembra, in funzione fino alla
riforma clistenica del 509 a.C., quando vennero introdotte dieci tribù. Esse trovano un
riscontro anche nel mondo dorico, dove le tribù più documentate, come sappiamo, erano
tre: Illei ( JUllei'"), Dimani (Duma'ne") e Panfili (Pavmfuloi). Si è molto discusso sulle
quattro tribù ioniche, sulle tre doriche e sulla loro funzione: si notò, nel corso del XIX
secolo, che i loro nomi, soprattutto quelli delle tribù "ioniche", sembravano essere in
relazione etimologica con alcune attività o professioni: gli Opleti sarebbero guerrieri, gli
Egicorei pastori, gli Argadei artigiani ed i Geleonti contadini14
. Una simile tesi ha piano
piano perso credibilità presso gli studiosi, a partire dalla metà del XIX secolo e,
soprattutto, dalle riflessioni che Grote sviluppò nella sua History of Greece: come già
notò lo storico ottocentesco (1849, III, 70), anche lo stesso argomento etimologico può
risultare fallace, soprattutto qualora si consideri che i Greci potevano conoscere un'altra
etimologia o, addirittura, un'altra grafia15
. De Sanctis (SG I, 100) mostrò come a sfatare
l'argomento su cui si era fondata la storiografia della prima metà dell'Ottocento bastasse
una semplice considerazione: se il re della singola tribù si sceglieva all'interno degli
Eupatridi, allora c'erano nobili in ognuna delle quattro tribù ioniche e, dunque, i loro
membri non potevano essere, certo, contadini o pastori! Un secondo argomento
apportato da De Sanctis è di tipo lessicale ed etimologico: se anche Opleti deriva da
o{pla e Pavmfuloi può significare "di origine varia", tutto ciò è per noi di scarso aiuto,
13
Che il loro nome le tribù lo derivassero dai figli Ione lo afferma Hdt. V 66 Ou|toi oiJ a[ndre" ejstasivasan peri; dunavmio", eJssouvmeno" de; oJ Kleisqevnh" to;n dh'mon prosetairivzetai. Meta; de; tetrafuvlou" ejovnta" jAqhnaivou" dekafuvlou" ejpoivhse, tw'n [Iwno" paivdwn Gelevonto" kai; Aijgikovreo" kai; jArgavdew kai; {Oplhto" ajpallavxa" ta;" ejpwnumiva", ejxeurw;n de; eJtevrwn hJrwvwn ejpwnumiva" ejpicwrivwn, pavrex Ai[anto": tou'ton de;, a{te ajstugeivtona kai; suvmmacon, xei'non ejovnta prosevqeto. "questi uomini lottarono per il potere, ma Clistene, riuscito inferiore, si rende
compagno il popolo. Successivamente rese gli Ateniesi, che prima erano divisi in quattro tribù, in dieci,
dopo aver modificato le denominazioni (che derivavano dai nomi dei figli di Ione, Geleonte, Egicoreo,
Argade e Oplete) ed aver trovato nomi di altri eroi locali, escluso Aiace: ma costui lo aggiunse, benché
fosse straniero, in quanto vicino della città ed alleato". 14
Una tale argomentazione si basa, soprattutto, su Plut. Sol. 23.5ss. kai; ta;" fula;" eijsi;n oiJ levgonte" oujk ajpo; tw'n [Iwno" uiJw'n, ajll∆ ajpo; tw'n genw'n eij" a} dihirevqhsan oiJ bivoi to; prw'ton wjnomavsqai, to; me;n mavcimon {Oplhta", to; d∆ ejrgatiko;n jArgadei'", duei'n de; tw'n loipw'n Gelevonta" me;n tou;" gewrgouv", Aijgikorei'" de; tou;" ejpi; nomai'" kai; probateivai" diatrivbonta". "e vi sono alcuni che sostengono che le tribù sono chiamate non dai figli di Ione, ma dai generi in cui le
vite erano suddivise fin dal primo momento, quello guerriero Opleti, quello operoso Argadei, ma, degli
altri due, i Geleonti trascorrevano la vita come contadini e gli Egicorei nei pascoli e nella pastorizia" 15
Cfr. Grote 1849, III, 70 e n. 1. Eur. Ion. 1581, ad esempio, anche se il passo è corrotto, sembra far
derivare il nome degli Egicorei non da ai[x "capra", ma dall'egida di Atena.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
16
"perché in età primitiva tutti andavano intorno armati (ciò che si disse sidhroforei'n) e
perché «d'origine varia» può interpretarsi nei modi più diversi".
Tribù, trittie e gevnh
Le nostre fonti non si fermano solo alle quattro tribù "ioniche", ma forniscono altre
notizie, la cui comprensione, tuttavia, risulta a noi difficile in quanto mancano molti
dettagli. La fonte più estesa ed importante è il lemma gennh'tai del Lexicon Patmense
(Arist. Ath. fr. 3 M.-H. = Lexicon Patmense p. 162) pubblicato per la prima volta da
Sakkelion nel 1876; l'autore di questo lessico cita direttamente la Costituzione degli
Ateniesi di Aristotele:
gennh'tai: pavlai to; tw'n jAqhnaivwn plh'qo", pri;n h] Kleisqevnh dioikhvsasqai ta; peri; ta;" fulav", dihvirhto eij" gewrgou;" kai; dhmiourgou;". Kai; fulai; touvtwn h\san dV: tw'n de; fulw'n eJkavsth moivra" ei\ce gV, a}" fratriva" kai; trittuva" ejkavloun. touvtwn de; eJkavsth suneisthvkei ejk triavkonta genw'n, kai; gevno" e{kaston a[ndra" ei\ce triavkonta, tou;" eij" ta; gevnh tetagmevnou", oi{tine" gennh'tai ejkalou'nto, ãejxà w|n aiJ iJerwsuvnai ãaiJà eJkavstoi" proshvkousai ejklhrou'nto, oi\on Eujmolpivdai, kai; Khvruke", kai; jEteoboutavdai, wJ" iJstorei' ejn th'i jAqhnaivwn politeivai jAristotevlh" levgwn ou{tw": «Fula;" de; aujtw'n sunnenemh'sqai dV ajpomimhsamevnwn ta;" ejn toi'" ejniautoi'" w{ra", eJkavsthn de; dihirh'sqai eij" triva mevrh tw'n fulw'n, o{pw" gevnhtai ta; pavnta dwvdeka mevrh, kaqavper oiJ mh'ne" eij" to;n ejniautovn, kalei'sqai de; aujta; trittu;" kai; fratriva". Eij" de; th;n fratrivan triavkonta gevnh diakekosmh'sqai, kaqavper aiJ hJmevrai eij" to;n mh'n, to; de; gevno" ei\nai triavkonta ajndrw'n«.
gennh'tai: anticamente il popolo ateniese, prima che Clistene regolasse la questione
delle tribù, era suddiviso in contadini ed in artigiani. E le tribù di costoro erano quattro
ed ognuna comprendeva tre gruppi, che chiamavano fratrie e trittie. Ciascuna di esse era
composta di trenta gevnh ed ogni gevno" comprendeva trenta uomini, che erano ordinati
in gevnh e che si chiamavano gennh'tai. Fra costoro si assegnavano i sacerdozi spettanti
a ciascuno gruppo, ad esempio gli Eumolpidi, i Kerykes e gli Eteobutadi, come racconta
Aristotele nella "Costituzione degli Ateniesi", dicendo così: "le loro tribù erano
distribuite in quattro parti, avendo imitato delle stagioni in un anno; ciascuna tribù era
divisa in tre gruppi, affinché in tutto fossero dodici gruppi come i mesi in un anno: si
chiamavano trittie e fratrie. Nella fratria erano ordinati trenta gevnh, come i giorni in un
mese; il gevno" era di trenta uomini”.
Di contenuto simile, anche se privo di una citazione diretta, è Schol. in [Plat.] Axioc.
371d:
jAristotevlh" fhsi; tou' o{lou plhvqou" dihirhmevnou jAqhvnhsin eij" te tou;" gewrgou;" kai; tou;" dhmiourgou;", fula;" aujtw'n ei\nai dV, tw'n de; fulw'n eJkavsth" moivra" ei\nai trei'", a}" trittuva" te kalou'si kai; fratriva", eJkavsth" de; touvtwn triavkonta ei\nai gevnh, to; de; gevno" ejk triavkonta e{kaston ajndrw'n sunestavnai. Touvtou" dh; tou;" eij" ta; gevnh tetagmevnou" gennhvta" kalou'sin.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
17
Aristotele afferma che, poiché l'intero popolo ad Atene era suddiviso in contadini ed
artigiani, le tribù erano quattro e ciascuna di esse comprendeva tre gruppi, che chiamano
trittie e fratrie. In ogni gruppo vi erano trenta famiglie ed ognuna era composta di trenta
uomini. Costoro, ordinati per famiglie, li chiamano gennh'tai16.
Aristotele, dunque, sembra che spiegasse la suddivisione in questo modo: vi erano
quattro tribù (le tribù "ioniche" a cui abbiamo prima accennato), ognuna divisa in tre
trittie o fratrie, per cui si avevano, complessivamente, dodici fratrie o trittie. Ogni fratria
o trittia comprendeva trenta gevnh ed ogni gevno" trenta uomini. Si avevano, dunque,
trecentosessanta gevnh attici, divisi in dodici fratrie e, a loro volta, in quattro tribù.
Poiché, inoltre, trecentosessanta erano i gevnh ed ognuno comprendeva trenta gennh'tai,
allora i singoli gennh'tai erano diecimilaottocento nella sola Attica. Vi era, tuttavia,
anche un'ulteriore aggregazione, la naucraria, di cui serbano memoria varie fonti, ma la
più dettagliata è Poll. VIII 108:
Dhvmarcoi, oiJ kata; dhvmou" a[rconte". jEkalou'nto de; tevw" nauvkraroi o{te kai; oiJ dh'moi naukrarivai. naukrariva d∆h \n tevw" fulh'" dwdevkaton mevro", kai; naukravroi h\san dwvdeka, tevttare" kata; trittu;n eJkavsthn.
Demarchi: coloro che comandano sui demi. Erano chiamati, invece, naucrari fino a
quando i demi venivano chiamati naucrarie. La naucraria era, fino a quel momento, la
dodicesima parte di una tribù ed i naucrari erano dodici, quattro per ciascuna trittia.
Dunque la naucraria era la dodicesima parte di una tribù. Ognuna delle quattro tribù
comprendeva tre fratrie e tre trittie, ogni fratria trenta gevnh ed ogni trittia quattro
naucrarie, per un totale di trecentosessanta gevnh e quarantotto naucrarie. Se, quindi,
ogni tribù era suddivisa sia in tre trittie sia in tre fratrie, è lecito chiedersi quale fosse la
differenza tra l'aggregazione per trittie e quella, invece, per fratrie. Per Grote (1849, III,
71s.) si tratterebbe di due piani diversi: da un punto di vista sociale e religioso si
avrebbero tre fratrie e novanta gevnh per ogni tribù, mentre dal punto di vista politico tre
trittie e dodici naucrarie. In altre parole, fratrie e gevnh sembrano a Grote (1849, III, 73)
aggregazioni di piccole unità primitive in altre più larghe e sarebbero indipendenti dalla
tribù stessa, in quanto preesistenti all'attività del legislatore che organizzò una simile
struttura politica. Se da un lato la ricostituzione aristotelica sembra poco credibile,
perché indurrebbe un simile schema entro confini troppo rigidi, dall'altro però ci
16
E cfr. anche Harpocr. s.v. trittuv": trittuv" ejsti to; trivton mevro" th'" fulh'": au{ ga;r dihvirhtai eij" triva mevrh, trittu'" kai; e[qnh kai; fratriva", w{" fhsi jAristotevlh" ejn th'i jAqhnaivwn politeivai "trittia: la trittia è la terza parte della tribù: questa, infatti, si suddivide in tre parti, trittie,
ethnē e fratrie, come afferma Aristotele nella "Costituzione degli Ateniesi"".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
18
troviamo di fronte ad un fatto concreto: la reale e documentata esistenza dei gevnh in
epoca storica. È doveroso, dunque, chiedersi se questi gevnh di cui parla Aristotele siano
lo stesso tipo di aggregazione di cui stiamo qui discutendo. Grote (1849, III, 73s.), con
molta naturalezza, sembra non porsi affatto questo problema: per lo storico inglese i
gevnh sono preesistenti a questa gerarchia e vengono, semplicemente, adattati alla nuova
struttura: sono, in altre parole, "real, ancient and durable associations among the
Athenian people, highly important to be understood"17
. Gli storici successivi sono giunti,
invece, a conclusioni opposte rispetto a quelle di Grote.
Per Roussel i genh aristocratici o sacerdotali ed i gevnh di cui parla Aristotele sono due
tipi diversi di aggregazione18
. Il fatto che Aristotele riporti dei numeri precisi non deve
indurre a credere che la sua ricostruzione sia del tutto inventata. Roussel pensa,
piuttosto, che, al momento del sorgere della povli", si sarebbero strutturate suddivisioni
diverse della cittadinanza per garantire la partecipazione a funzioni molteplici e varie,
ma soprattutto militari.
Il gevno": modelli a confronto
Il metodo più diretto a cui è possibile ricorrere per comprendere la funzione e la natura
di un certo institutum è confrontarlo con altri simili su cui, invece, siamo meglio
informati. Nel corso della storia della discussione critica, quattro sono state le strutture
messe a confronto con il gevno": casta professionale, gens, clan e signoria medievale.
Nelle prime opere dedicate a questa istituzione, nella prima metà dell'Ottocento, il gevno"
veniva considerato una casta professionale improntata al modello di quelle egiziane: in
quest'epoca, infatti, si poneva, all'inizio della civiltà ellenica, una fase d'impronta egizia
dopo l'arrivo sul suolo greco di popolazioni provenienti proprio da quel paese: ci si
basava, come fonte, sul mito di Danao e delle sue figlie. Erodoto, nel secondo libro delle
Storie19
, aveva elencato le varie caste in cui si suddividevano i sudditi del faraone: era,
dunque, naturale pensare che queste caste fossero state costruite sul modello egiziano. A
sostegno di questa tesi si poteva comodamente richiamare il dato delle quattro tribù
17
Grote 1849, III, 74. 18
Cfr. Roussel 1976, 79ss. 19
Hdt. II 164 e[sti de; Aijguptivwn eJpta; gevnea, kai; touvtwn oiJ me;n iJreve", oiJ de; mavcimoi keklevatai, oiJ de; boukovloi, oiJ de; subw'tai, oiJ de; kavphloi, oiJ de; eJrmhneve", oiJ de; kubernh'tai. Gevnea me;n Aijguptivwn tosau'tav ejsti, oujnovmata dev sfi kevetai ajpo; tw'n tecnevwn "vi sono sette
classi di egiziani e di questi alcuni sono chiamati sacerdoti, altri guerrieri, altri pastori, altri porcari, altri
bottegai, altri interpreti, altri piloti. Tante sono le classi, ma i nomi derivano dai mestieri ".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
19
ioniche poste alla base della storia di Atene (accennano alle quattro tribù anche due
frammenti dell' jAqhnaivwn Politeiva aristotelica): l'etimologia sembrava palesare che
dietro il nome di ogni singola tribù potevano celarsi delle attività professionali e la stessa
classificazione si doveva ritrovare anche al livello del gevno", essendo quest'ultimo
nient'altro che una suddivisione interna della singola tribù. Questo modo di concepire il
gevno" divenne più sfumato allorché si prese a considerare non tanto la tribù in generale,
quanto il singolo gevno": non si parlò più di caste professionali, ma di corporazioni. E
proprio dal gevno" stesso venne un ulteriore argomento a questa ipotesi: i nomi di alcuni
gevnh, infatti, sembravano anche essi, come quelli delle tribù, derivati da un'attività
professionale. Accanto ai nomi derivati da attività professionale si collocano, tuttavia,
dei patronimici. Un gevno" come categoria professionale è, tuttavia, una palese
contraddizione: infatti, se c'è qualcosa su cui gli studiosi sono d'accordo, è proprio la
nobiltà del gevno" stesso.
Un altro parallelo per la comprensione del gevno" è fornito dalla gens: il confronto tra le
due istituzioni, latina e greca, è suscitato anche dalla sola etimologia. Nell'Ottocento, del
resto, il latino era ancora la lingua di cultura e della maggior parte delle opere erudite: in
questo quadro, come nota Bourriot (1976, 167), l'impiego del sostantivo latino gens per
tradurre gevno" non poteva che facilitare l'assimilazione. Un esempio lampante è fornito
dal libro di Fustel de Coulanges, il cui capitolo sul gevno" è intitolato La gens en Grèce et
à Rome, come se si trattasse dello stesso institutum.
Paralleli per queste formazioni aristocratiche si rintracciano non solo nel mondo romano,
ma anche in quello celtico: non sarà un caso, dunque, se in antropologia è invalso, per
indicare questi gruppi, l'uso di un termine di origine, appunto, celtica20
, ovvero clan.
Dato il suo carattere paradigmatico, il termine celtico è stato esteso ed ad esso
l'antropologia ha ricorso come pietra di paragone in confronto ad altre realtà. Il clan
celtico è caratterizzato dall'esogamia (cioè il divieto del matrimonio all'interno del
gruppo), unità cultuale, solidarietà dei membri, vendetta di sangue, alleanza militare tra i
vari membri del clan, proprietà comune.
Il confronto tra il gevno" greco e la signoria medievale è stato istituito, invece, dallo
storico tedesco Eduard Meyer, nell'ambito di una più generale, nuova interpretazione del
gevno" e delle sue origini, per cui v. infra.
20
Deriva dal gaelico clann, dalla stessa radice del latino planta.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
20
Il gevno": storia della discussione critica
Opere sul gevno" nell'Antichità
È significativo che già gli antichi abbiano scritto delle opere su questo argomento:
probabilmente, gli storici ed i filologi dell'epoca tardo ellenistica ed imperiale, per
quanto riguarda il gevno", si trovavano nella condizione di dover comporre opere tese a
spiegare la storia e la funzione di queste istituzioni ad un pubblico non molto informato
in materia, essendo ormai passati diversi secoli dal periodo arcaico e classico. Le fonti
antiche ricordano o citano le seguenti opere: 1) Sui gevnh, attribuita ad un certo
Dracone21
; 2) Sui gevnh di Atene di Melitone22
; 3) Sul gevno" dei Kerykes di Teodoro23
;
4) Sugli Aleuadi di Euforione di Calcide24
.
Di queste opere non ci è giunto niente ed è per questo motivo che, in mancanza di fonti
antiche più precise e, soprattutto, più estese, la storiografia moderna si è trovata nella
condizione di dover fare delle ipotesi, sia sulla natura del gevno" e sulle sue funzioni, sia
sulla sua origine.
Il gevno" nella storiografia moderna
Vi sono state, nel corso del tempo, varie discussioni che hanno avuto per oggetto il
gevno", soprattutto per quanto concerne l'origine di questo institutum e la sua natura,
dove per natura inglobiamo aspetti diversi, ovvero le sue funzioni, la sua composizione,
il legame con la sfera cultuale etc. Per quanto riguarda l'origine del gevno", si possono
21
È citata da Harpocr. s.u. jEteoboutavdai: Lukou'rgo" ejn tw'i peri; th'" iJereiva". gevno" par∆ jAqhnaivoi", oi|on oiJ ajlhqw'" ajpo; Bouvtou: ejteovn ga;r to; ajlhqev". ejk de; touvtwn kaqivstato hJ iJevreia th'" Poliavdo" jAqhna'", kaqav fhsi Dravkwn peri; genw'n "Eteobutadi: Licurgo nell'orazione
"Sulla sacerdotessa". È un génos presso gli ateniesi, cioè quelli che veramente derivano da Bute. Eteón,
infatti, significa il vero. Da costoro fu incaricata la sacerdotessa di Atena Polias, secondo quanto dice
Dracone, "Sui gevnh"". 22
Harpocr. s.u. Kavqeto": oJ kaqievmeno" eij" to; pelago" ajmnov": Lusiva" ejn tw'i kata; Telamw'no". dieivlektai peri; tou' kaqevtou Melivtwn ejn a peri; tw'n jAqhvnhsi genw'n. "Kathetos. L'agnello
gettato nel mare: Lisia in "Contro Telamone". Parla del Kathetos Melitone nel primo libro "Sui genē in
Atene"". 23
Etym. Magn. 424, 45-47, s.u. JJHmerokallev": [Anqo" speirovmenon oJ Divdumo" fhsivn. Oujk e[sti de; a[nqo", ajlla; foinikou'n e[rion diapepoikilmevnon, w|i crw'ntai pro;" ta;" iJerourgiva" jAqhvnhsin, wJ" Qeovdwro" oJ Panavgh" prosagoreuovmeno" ejn tw'i prwvtwi peri; Khruvkwn gevnou": levgei de;, o{ti kalei'tai hJmerokalle;" dia; to; pepluvsqai kai; bebavfqai ejn mia'i hJmevrai. Kavllh de; prosagoreuvetai ta; a[nqh. JRhtorikhv. "hēmerokallés: Didimo afferma che si tratti di un fiore seminato.
Tuttavia non è un fiore, ma lana variegata tinta di porpora, che ad Atene è usata per le cerimonie sacre,
come dice Teodoro il Santo nel primo libro "Sul genos dei Kērykes": afferma che è chiamato hēmerokallés
a causa dell'essere stato lavato ed immerso nell'acqua in un giorno. I fiori, invece, si chiamano
"Bellezze". È un termine retorico". 24
Schol. in Theocr. Idyll. XVI 34-35.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
21
constatare due posizioni diverse da parte degli studiosi, una prima che la colloca in un
periodo primordiale (per cui il gevno" non sarebbe altro che un fossile di un ancestrale
sistema indoeuropeo) ed una seconda, invece, che tende a porre la sua origine in un
tempo molto più recente, ovvero durante le "Età oscure", quel periodo che, a partire da
Theodor Bergk, si è soliti definire anche, non senza un palese anacronismo, "Medioevo
ellenico". Per gli studiosi che hanno sostenuto la seconda possibilità il gevno" non
sarebbe, dunque, altro che il risultato di un'evoluzione sociale recente. Prima di passare
ad evidenziare le singole opinioni espresse in materia, basti aggiungere che, delle due
posizioni, la seconda è cronologicamente recenziore.
Il primo studioso ad aver cercato di definire il concetto di gevno" è stato George Grote:
lo storico inglese, nella sua monumentale History of Greece, affronta il gevno" partendo
dalla narrazione degli avvenimenti storici conosciuti e dalla descrizione della struttura
sociale dell'Atene presoloniana25
. Per Grote (1849, III, 73), come abbiamo visto, il
gevno" e la fratria sono indipendenti dalle quattro tribù ioniche, perché queste ultime
sarebbero state create solo successivamente: il legislatore che si preoccupò di creare la
struttura tribù / fratria – trittia / gevno" – naucrarie trovò fratrie e gevnh preesistenti. Per
Grote, insomma, la fratria ed il gevno", all'origine instituta indipendenti, vennero
inglobati in una struttura a loro estranea, diventando, così, suddivisioni della singola
tribù: questa ricostruzione è valida, ovviamente, se si presta fede ai frammenti
aristotelici di cui sopra si è parlato26
. Il gevno" sarebbe, per Grote (1849, III, 74), fondato
su casa, focolare e famiglia e l'aggregazione sembra a lui assicurata da:
Common religious cerimonies and exclusive privilege of priesthood, in honour of the
same god, supposed to be the primitive ancestor and characterised by a special
surname;
By a common burial-place;
By mutual rights of succession to property;
By reciprocal obbligations of help, defence and redress of injuries;
By mutual rights and obbligation to intermarry in certain determinate cases,
especially where there was an orphan daughter or heiress.
By possession, in some cases at least, of common property, an archon and a
treausurer of their own.
25
Grote 1849, III, 65ss. 26
Cfr. supra. Grote (1849, III, 73) si dimostra abbastanza scettico nei riguardi della realtà di cui ci parla
Aristotele: la ricostruzione aristotelica è per lui poco attendibile, perché presuppone uno schema troppo
rigido: ciò non di meno, fratrie e gevnh (Grote parla di gentes) sono reali.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
22
La fratria, ovvero un'aggregazione di più gevnh, sarebbe stata caratterizzata da diritti,
doveri ed obblighi del tutto simili a quelli interni al gevno": vi sarebbe stata, insomma, "a
communion of particolar sacred rites and mutual privileges of prosecution in the event of
a phrator being slain". Al livello più esteso, la fratria sarebbe stata considerata membro
di una tribù: tutte le fratrie di una stessa tribù avrebbero goduto "a certain periodical
communion of sacred rites, under the presidency of a magistrate called the Phylobasileus
or Tribe King, selected from the Eupatrids". Tutte e quattro le tribù attiche, inoltre,
sarebbero state accomunate dalla venerazione verso uno stesso dio, ovvero Apollo
Patrōus: Apollo, del resto, era il padre di Ione e gli eponimi delle quattro tribù non erano
altro che suoi nipoti, in quanto figli di Ione.
Grote (1848, 81s.) passa poi a notare come questi instituta greci trovino palesi
parallelismi anche presso altri popoli, anche non indo-europei. La fratria greca
corrisponderebbe alla curia latina, mentre gevnh e gentes sarebbero lo stesso tipo di
aggregazione. I gevnh sono rintracciabili, inoltre, non solo ad Atene, ma anche in altre
parti della Grecia ed un po' ovunque troviamo dei gevnh che, come nome, hanno un
patronimico, "the stamp of their believed common paternity"27
.
Secondo l'antropologo americano Lewis Henry Morgan sarebbero due le forme di
instituta della società umana: la societas e la civitas. Nel caso della societas, il primo
sistema di governo che si è manifestato sulla Terra, contano i legami di parentela e, più
genericamente, le relazioni personali28
: è il livello della gens latina e, ciò che per
Morgan è identico, del gevno" della Grecia arcaica. La gens, o gevno", è l'unità primaria
di questa organizzazione, considerando come stadi successivi di "integrazione", durante
il periodo arcaico, la gens, la fratria, la tribù e la confederazione di tribù che venne a
costituire il popolo o nazione (populus): "in una fase più tarda […] la fusione tribale
entro la stessa area in una nazione prese il posto della confederazione di tribù occupanti
aree indipendenti". La gens non sarebbe altro che un gruppo costituito da consanguinei
che vantano una discendenza da uno stesso capostipite. Per Morgan, tuttavia, le gentes
latine ed i gevnh greci sarebbero uno sviluppo ulteriore rispetto agli instituta originari, in
27
Grote 1849, III, 84. 28
Cfr. Morgan 1970, 3ss.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
23
quanto fondati su una discendenza patrilineare, invece che matrilineare29
: la
matrilinearità sarebbe, per lui, il tratto più arcaico. "Nella gens antica"- scrive Morgan
(1970, 49) – "la discendenza si stabiliva soltanto in linea femminile. In essa erano
compresi tutti gli individui in grado di dimostrare la loro discendenza in linea femminile
da una supposta capostipite comune. […] Questa era la struttura della gens, nella sua
forma arcaica, quando la paternità non era accertabile con sicurezza e quando la
maternità forniva l'unico criterio sicuro di discendenza". La civitas, al contrario, sarebbe
fondata sul territorio e sulla proprietà: quest'ultima è parte della circoscrizione urbana, a
sua volta considerata da Morgan (1970, 4) come l'unità dello stato stesso: la società
politica è il risultato pieno dell'intero sviluppo.
D'importanza centrale sullo studio del concetto di gevno" è il capitolo La gens à Rome et
en Grèce del libro di Fustel de Coulanges (1878, 110ss.) la Cité antique. Il metodo di
Fustel è evidente già nel titolo del capitolo: ricorre ad un comparativismo così esteso che
tratta della gens e del gevno" come se si trattasse della stessa struttura in due contesti
diversi: "Nous voulons parler de ce que les Latins appellaient gens et les Grecs gevno"".
Il gevno" greco non può essere stato, per Fustel (1878, 112), una divisione
amministrativa: è significativo in tal senso che Demostene, in una sua orazione (in
Neaer. 61) riporti la testimonianza di sette persone che si dicono membri del gevno" dei
Brutivdai: poiché essi, a quanto dice lo stesso oratore ateniese, appartengono a sei demi
diversi, si dovrà dedurre che il gevno" non doveva essere una suddivisione
amministrativa. Per Fustel (1878, 111) la gens (il gevno" nel mondo greco) "formait un
corps dont la constitution était tout aristocratique" ed ogni gruppo aveva non solo "un
culte spécial"30
, ma anche dei luoghi peculiari adibiti ai sacrifici e/o iniziazioni31
, tombe
29
Cfr. Morgan 1970, 170. 30
Fustel (1878, 113) cita, a questo riguardo, tre passi diversi, ovvero Hsch. g 357 L. gennh'tai: oiJ tou' aujtou' gevnou" metevconte" kai; a[nwqen ajp∆ajrch'" scovnte" koina; iJerav. oiJ de; oJmogavlakta", kai; fravtora", suggenei'" tou;" gennhvta" "coloro che sono parte dello stesso genos e che possiedono, fin
dall'inizio, culti comuni. Altri chiamano i gennētai anche compagni di latte, fratelli e consanguinei", Poll.
III 52 to; d∆ iJero;n eij" o} sunhviesan, fratrei'on ejkalei'to, kai; to; suvsthma fratriva, oiJ de; kaq∆ e{kaston fravtore". kai; o[i>" frathvr, kai; fravtrio" ai[x hJ quomevnh toi'" fravtorsin. ejkalou'nto de; kai; fravtere". fratrivai d∆h \san ibV, kai; ejn eJkavsthi gevnh triavkonta, e{kaston ejk triavkonta ajndrw'n: ejkalou'nto d∆ ou|toi kai; oJmogavlakte" kai; ojrgew'ne" "ed il luogo sacro in cui si
incontravano era chiamato phratreîon e la lega phratría, mentre essi, presi per ciascuno, phrátores. E la
pecora era detta phratēr e phrátrios la capra sacrificata per gli altri membri. Erano chiamati anche
phráteres. Le phratríai erano dodici ed in ognuna di esse vi erano trenta génē e ciascun génos era
formato da trenta uomini. Costoro erano chiamati anche consanguinei e orgeônes" e Harpocr. s.v. jOrgew'na": jIsaivou lovgo" ejsti ; pro;" ojrgew'na", ojrgew'ne" d∆ eijsi;n oiJ ejpi; timh'i qew'n h] hJrwvwn
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
24
comuni32
ed un capo come guida. Del resto ad Atene ogni gevno" venerava un antenato
divinizzato, il cui nome era sempre legato, per etimologia popolare, al gentilizio dei
discendenti: così gli Eumolpidi Eumolpo, i Fitalidi l'eroe Fitalo, i Butadi Bute, i Buselidi
Buselo etc.33
.
Per Fustel (1878, 119) coloro che vedono nella gens (e nel gevno") "une association
artificielle" non colgono nel segno, o almeno "partent d'une donne qui est fausse": il
gevno" non sarebbe stato fondato su legami di parentela fittizi, ma "la gens était la
famille"34
: "cette famille indivisible, qui se développait à travers les âges, perpétuant de
siècle en siècle son culte et son nom, c'était véritablement la gens antique". Che la
famiglia, sostiene Fustel, sia la più antica forma associativa si può inferire dai singolari
parallelismi, presenti sia a livello strutturale, sia a livello semantico, tra le varie
popolazioni che oggi come nell'antichità parlano una lingua indoeuropea. Lo stesso,
invece, non può essere detto delle istituzioni politiche, ergo due sono le conclusioni che
trae Fustel: 1) la nascita delle istituzioni domestiche e familiari è precedente alla
suniovnte": ojrgiavzein ga;r ejsti to; quvein kai; ta; nomizovmena dra'n, h[toi para; to; ojrevgein tw; cei're, h] para; ta; o[rgia, h] dia; to; ejn tai'" ojrgavsi kai; toi'si a[lsesi ta; iJera; dra'n. oiJ mevntoi poihtai; e[tatton tou[noma aJplw'" ejpi; tw'n iJerevwn, wJ" jAntivmaco" tev pou kai; Aijscuvlo" ejn Musoi'". mhvpote de; u{steron nenovmistai to; ejpi; timh'i tina;" tw'n ajpoqanovntwn sunievnai kai; ojrgew'na" oJmoivw" wjnomavsqai, wJ" e[sti sunidei'n ejk tw'n Qeofravstou diaqhkw'n. "Orgheônas: il
discorso di Iseo è "In risposta agli Orgheoni" e gli orgheônes sono coloro che si riuniscono nel nome
degli dei o degli eroi; il compiere misteri è il sacrificare ed il fare ciò che è ritenuto dovuto, invero per il
protendere (oréghein) le mani, oppure deriva da orghia, oppure per il fatto di compiere azioni sacre nelle
praterie e nei boschi. I poeti assegnavano il nome, semplicemente, alle azioni sacre, come Antimaco in
qualche passo ed Eschilo nei Misi. Successivamente non fu mai in uso chiamare allo stesso modo il
ritrovarsi in nome di qualcuno dei morti e gli orgheônes, come è possibile comprendere dalle disposizioni
testamentarie di Teofrasto". 31
Abbiamo informazioni esclusivamente su Atene: in particolare, per i Licomidi cfr. Plut. Them. I 2
to;...Fluh'si telesthvrion, o{per h\n Lukomidw'n koinovn "il sacello di Flia, che era dei Licomidi",
invece per i Butadi (chiamati, dopo la riforma clistenica, Eteobutadi) cfr. Aesch. De falsa leg. 147 ei\nai d∆ejk fratriva" to; gevno", h} tw'n aujtw'n bwmw'n jEteoboutavdai" metevcei "per stirpe è della stessa
fratria che condivide gli stessi altari con gli Eteobutadi". 32
Per i Buselidi cfr. Demosth. In Macart. 79 ajlla; kai; mnhvmato" o[nto" koinou' a{pasin toi'" ajpo; tou' Bousevlou genomevnoi" (kai; kalei'tai to; mnh'ma Bouselidw'n, polu;" tovpo" peribeblhmevno", w{sper oiJ ajrcai'oi ejnovmizon), ejn touvtwi tw'i mnhvmati oiJ me;n a[lloi a{pante" oiJ ajpo; tou' Bousevlou kei'ntai, kai; oJ jAgniva" kai; oJ Eujboulivdh" kai; oJ Polevmwn kai; oiJ a[lloi a{pante" tosou'toi o[nte" suggenei'", oiJ ajpo; tou' Bousevlou, a{pante" ou|toi koinwnou'sin tou' mnhvmato" touvtou "ma vi è anche un monumento funebre comune a tutti i discendenti di Buselo (e viene chiamato
"Tomba dei Buselidi", è un luogo ampio, recintato come usavano gli antichi): in questo mausoleo
riposano tutti i discendenti di Buselo, sia Agnia, Eubulide e Polemone, sia tutti gli altri, così numerosi,
che sono membri della stessa famiglia, i discendenti di Buselo: tutti costoro hanno in comune questa
tomba". E cfr. anche Demosth. In Eubul. 28 e[ti toivnun paivdwn aujtw'i tettavrwn genomevnwn oJmomhtrivwn ejmoi; kai; teleuthsavntwn, e[qaye touvtou" eij" ta; patrw'ia mnhvmata, w|n o{soipevr eijsin tou' gevnou" koinwnou'sin "inoltre quattro bambini che aveva avuti dalla stessa madre che ho io
sono morti: li ha seppelliti nella tomba avita che hanno in comune quanti, appunto, sono di quella
famiglia". 33
Cfr. Demosth. In Macart. 79, per cui v. n. 20; Paus. I 37. 34
Fustel 1878, 121.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
25
separazione delle varie stirpi della famiglia indoeuropea; 2) le istituzioni politiche,
invece, sono molto più recenti, non trovandosi paralleli sistematici tra le forme di
organizzazione politica delle varie stirpi indoeuropee.
Come avvenne, per Fustel, la nascita della povli"? Attraverso un processo lento, ogni
tanto una singola gens o, nel mondo greco, un gevno" si poteva unire ad un altro per la
celebrazione di un culto che era comune ad entrambi: si arrivò, così, alla nascita della
fratria (a Roma chiamata curia), ovvero un gruppo di più gevnh (o gentes). Ogni fratria
manteneva le strutture e le funzioni di un singolo gevno". Le fratrie organizzavano delle
feste durante le quali avvenivano dei pasti in comune in onore della divinità: ad Atene,
ad esempio, avvenivano durante la festa delle Apaturie35
. Ogni fratria aveva un capo
chiamato fratriarca, la cui funzione principale per Fustel era quella di presiedere ai
sacrifici. Ed il processo sarà continuato fino a formare insiemi di più fratrie (o curie),
chiamate fulaiv o tribù36
. Ogni singola tribù aveva, come il gevno" e la fratria, una
divinità protettrice, ossia un uomo divinizzato, dal quale la tribù prendeva il suo nome:
in suo onore si organizzavano delle feste annuali, durante le quali si davano banchetti a
cui partecipavano i membri della tribù. Ogni tribù era organizzata al suo interno ed
aveva un capo, esattamente come il gevno" e la fratria: egli aveva il titolo di
fulobasileuv", letteralmente "re della tribù", che equivale al latino tribunus. La città non
sarà, dunque, altro che una confederazione di varie tribù.
Nell'ultimo decennio del XIX secolo, Eduard Meyer, nella sua Geschichte des Altertums,
porta avanti, per la prima volta, una tesi del tutto diversa ed opposta alle precedenti.
Meyer fonda la sua argomentazione su un principio di fondo elementare: le migrazioni
doriche, avvenute alla fine del II millennio a.C., avrebbero posto fine alla società
costituitasi nei secoli precedenti37
, rivoluzionando il panorama complessivo e facendo sì
35
Sono nominate in Ar. Ach. 146 e Ath. IV 171e. 36
L'esistenza delle tribù (fulaiv) è dimostrata dai seguenti passi, tutti riportati da Fustel: Il. II 362
kri'n∆a[ndra" kata; fu'la, kata; frhvtra", jAgamevmnon "ordina gli uomini per tribù e per fratrie,
Agamennone"; II 668 tricqa; de; w[ikhqen katafuladovn, hjde; fivlhqen "e vi si stabilirono divisi in tre
tribù ed amati"; Od. XIX 177 Dwrieve" te tricavi>ke" di'oiv te Pelasgoiv "i dori divisi in tre stirpi ed i
Pelasgi"; Hdt. IV 161 Ou|to" w\n wJnh;r ajpikovmeno" ej" th;n Kurhvnhn kai; maqw;n e{kasta tou'to me;n trifuvlou" ejpoivhse sfea" "costui, un uomo, giunto a Cirene e venuto a conoscenza di ciascuna cosa, li
divise in tre tribù". 37
Cfr. Meyer 1954, III, 269: "Wie die Institutionen des deutschen Mittelalters nicht aus den
Mischbildungen erwachsen sind, welche germanische Häuptlinge auf römischem Boden geschaffen haben,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
26
che i rapporti sociali fossero dominati dalla nozione di "vicinato". Le migrazioni
doriche, portando ad una nuova forma di sedentarizzazione e di collocazione della
popolazione, avrebbero determinato la nascita di forti legami di vicinato (appunto) e di
parentela. Questi gruppi familiari, alla fine del II millennio, impossessatisi di alcuni
territori, vi avrebbero costruito dei villaggi, assegnando a ciascun membro un lotto di
terra, che successivamente, divenuto una proprietà privata, sarebbe stato oggetto di
trasmissione ereditaria: proprio su queste eredità si sarebbe fondato, in seguito, il
privilegio del singolo gevno".
Meyer, inoltre, partendo semplicemente dal titolo Das griechischen Mittelalter,
"Medioevo ellenico" creato dal Bergk per indicare il periodo post-miceneo, l'epoca delle
migrazioni doriche e, più in generale, delle metanastavsei", paragona quelle che oggi
vengono chiamate "Età oscure" al medioevo tedesco38
: come le migrazioni dei "barbari"
hanno posto fine all'impero romano creando le premesse per il sorgere della nuova
civiltà, quella medievale, così le migrazioni doriche avrebbero posto fine ai vari regni
micenei, portando poi alla nascita, alcuni secoli dopo, della Grecia classica. Meyer, però,
va anche oltre, perchè paragona l'instaurarsi dei gevnh con quello dei vari signorotti
tedeschi: la disuguaglianza in fatto di beni e di forza, l'impossibilità dei più poveri di
armare degli eserciti personali per la propria difesa ha portato i più deboli a farsi
difendere dai più forti.
Inutile dire, dunque, che le due posizioni non potrebbero che essere più distanti e
tuttavia, almeno su un punto esse concordano, ovvero sugli attributi e la struttura del
gevno" di età storica, così come sembrano essere testimoniati dalle fonti antiche.
Il 1904 è l'anno della pubblicazione della tesi di Gustave Glotz La solidarité de la
famille dans le droit criminel en Grèce. Glotz sembra non seguire assolutamente le
teorie di Meyer ed adottare, invece, la ricostruzione fornita da Fustel. Glotz (1904, 3),
fin dalla prima pagina, nota come in tutte le società primitive gli individui siano uniti tra
loro da legami di parentela reali o fittizi. Immediatamente dopo elenca i due significati
con cui la parola gevno" è attestata, ovvero: 1) una comunità dove parenti di più
generazioni vivono spesso sotto lo stesso tetto o, comunque, sulla stessa terra e, per
sondern aus einer Fortbildung der ursprünglichen Stammesordnungen, so ist auch die politische
Gestaltung des griechischen Mittelalters nicht aus dem mykenischen Staat hervorgegangen". 38
Cfr. Meyer 1954, III, 269.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
27
estensione, un gruppo composto di patrizi o, meglio, di Eupatridi che pretendono di
derivare la loro origine da un antenato comune; 2) la famiglia nel senso moderno del
termine39
. Il gevno", nel primo senso della parola, fino alla fine dell'età arcaica o, come la
chiama Glotz (1904, 599), dell'"epoca omerica", conserva nella città la propria
organizzazione e la sua sovranità: "les petits groupes n'admettent pas qu'elle s'occupe de
leurs affaires intérieures, ni même qu'elle intervienne d'autorité dans leurs sanglantes
querelles". In questo periodo vi sono ancora due forme di "giustizia": la prima, la qevmi",
appartenente ad ogni gevno" preso singolarmente e consacrata per i suoi dei e la seconda,
la divkh, che entra in gioco, invece, quando si ha a che fare con relazioni di pace o di
guerra, di amicizia o di offesa, tra due o più gevnh diversi. I membri di uno stesso gevno"
erano solidali sia nel chiedere soddisfazione di un'offesa, sia anche nel subire la pena
inflitta per il reato commesso anche da uno solo dei suoi membri. Dal momento in cui si
formano i villaggi, invece, i legami fondati sulla parentela tendono a cedere ed il reo
deve cercare l'aiuto anche di altri, piuttosto che solo dei suoi parenti: deve, dunque,
cominciare a tenere in conto anche l'opinione pubblica. Avviene, poi, un ulteriore
passaggio fondamentale, ovvero l'abbandono del colpevole: il gevno" che finora era
sempre accorso in difesa dei suoi membri colpevoli di reati, comincia ora a liberarsi del
reo per scappare ad un castigo che, altrimenti, finirà per colpire tutti i suoi membri. Si
crea, così, la responsabilità personale. Alle défaillances del diritto privato viene in
soccorso la religione: mentre prima essa stava alla base della giustizia interna al gevno",
ora allarga la qevmi" a tutta la città: la religione, per la prima volta, inizia a dettare leggi
valide per un'intera comunità cittadina. Un'idea nuova comincia a circolare in Grecia
verso la metà dell'VIII secolo e viene come sostegno all'azione della religione: si tratta
del mivasma, cioè della souillure, come afferma Glotz (1904, 602), attaccata al morto e
del relativo contagio: il reato trascurato dai parenti del reo diventa, così, un danno
pubblico e, lentamente, la responsabilità inizia ad essere giudicata anche al di fuori della
famiglia.
Le leggi di Dracone ad Atene, per la prima volta, nel tentativo di porre un freno alle
azioni di vendetta privata, vietano ai gevnh di farsi giustizia da sé: d'ora in poi si dovrà
ricorrere ai giudici per risolvere una contesa o per giudicare un reo. Negli stessi anni in
cui Pittaco esercitava la sua esimnetia a Lesbo, Solone, ad Atene, demoliva
39
Ovvero la famiglia "ristretta", come la definisce anche lo stesso Glotz (1904, 4 n.1).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
28
l'organizzazione stessa dei gevnh, allargando a tutti i cittadini i diritti di cui godevano i
singoli membri di un gevno" e creando, così, le premesse per la società politica. "Il a vu
dans le crime un attentat contre l'ordre social, et non plus seulement une offense à un
petit groupe de particuliers". In epoca classica le città sorrette da un governo
democratico, sull'esempio di Atene, tendono a rendere l'individuo sempre più libero,
mentre quelle oligarchiche preferiscono mantenere il vecchio sistema dei privilegi dei
gevnh. Atene stessa, dopo la parentesi della tirannia dei Pisistratidi, continua nel suo
intento: la riforma clistenica può essere considerata, infatti, quale "la mort politique des
gevnh"40
. Atene, dunque, non dominava solo per i suoi capolavori d'arte e di letteratura,
ma anche per le sua alta concezione del diritto: un'azione civilizzatrice, quella della
"Scuola della Grecia", che si interruppe solo a Cheronea, davanti all'esercito di Filippo.
Le teorie di Meyer sopra esposte trovarono un seguace di peso nello storico Gaetano De
Sanctis il quale, nel riprendere le parole di Meyer, aggiunge che, poiché né il diritto
criminale, né quello civile prevedono un ruolo per il gevno"41, bisognerà convenire che
quest'ultimo è stato aggiunto alla tribù ed alla fratria: “la gente è una superfetazione
nell’ordinamento per fratrie e tribù”42
. Tuttavia, De Sanctis non adotta come modello per
il gevno" la signoria medievale, come aveva fatto, invece, lo stesso Meyer. Lo storico
italiano si distacca da quello tedesco anche per un'altra differenziazione: adotta la teoria
di Meyer anche per la gens latina, come se gevno" e gens non fossero solo due realtà
della stessa natura, ma fossero anche scaturite da uno stesso processo.
La prima presa di posizione sull’argomento da parte di Louis Gernet risale al breve
studio Alcune designazioni omeriche della parentela, databile tra il 1915 ed il 1921: in
quell’occasione l’antropologo arrivò addirittura alla negazione dell’esistenza storica
della formazione sociale corrispondente al termine greco gevno"43: egli osservò,
anticipando così di diversi decenni le opinioni di Bourriot, che in Omero il sostantivo
40
Glotz 1904, 604 41
Cfr. De Sanctis, [Atqi" 56: “appunto perchè è una maniera più recente di associazione, né il diritto
civile, né il criminale danno importanza alla gente”; De Sanctis 1940, I, 102: "nel diritto successorio attico
infatti dopo i parenti stretti per parte di padre subentrano i parenti stretti per parte di madre; nel diritto
gortinio agli agnati subentrano come aspiranti alla mano dell'ereditiera i fileti; e nessuna funzione legale
ha il genos nel perseguire gli omicidi o nel patteggiare con essi". 42
Così De Sanctis, [Atqi" 57. 43
Gernet 1997, 58-59. E cfr. anche Di Donato 2006, 72s.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
29
gevno" non assume mai un significato diverso dal latino genus (discendenza, filiazione,
origine, famiglia ristretta) e dunque non è mai un sinonimo di clan44
. Successivamente lo
studioso francese assunse posizioni meno definitive: nel suo saggio Anthropologie de la
Grèce antique45
, per quanto attiene all'origine del gevno", prende nettamente le distanze
dalla tesi di Meyer46
. Il grecista ed antropologo francese ha notato (seguendo in questo la
linea inaugurata da Fustel) che, se da un lato la nobiltà è organizzata in gevnh, dall'altro i
gevnh sono una caratteristica esclusiva della nobiltà: "en grec, quand le mot génos se
rapporte à un groupe, c'est toujours à un groupe noble". Altra caratteristica dei gevnh è
l'attività religiosa: per Gernet non si tratta soltanto di un culto legato alla tradizione della
singola famiglia, ma di un vero e proprio "monopole de certaines liturgies", molto
antico, addirittura preesistente alla città stessa ed in qualche modo connesso con certe
funzioni rituali o magiche: prova di ciò sarebbe non solo il nome stesso di alcuni gevnh,
ma anche una tradizione storica che attribuisce ai nobili dei tempi più antichi dei
privilegi religiosi. Se, dunque, il buon nome degli a[ristoi sembrerebbe legato ad alcuni
privilegi religiosi, la loro forza sarebbe derivata, invece, da qualcosa di ben più terreno,
ovvero la loro ricchezza, fondata, soprattutto, sulle loro proprietà fondiarie. In qualche
modo connessa con le altre due caratteristiche della nobiltà, tradizione religiosa e
ricchezza, è la terza, quella che Gernet (1968, 340) chiama luxe. Il lusso, derivato a sua
volta dalla ricchezza, aveva nelle cerimonie religiose, organizzate dai gevnh, una delle
occasioni principali per essere messo in mostra: ad esempio durante sacrifici, matrimoni
o funerali. Il motivo dell'ostentazione di questo lusso sembrerebbe a Gernet (1968, 340)
adombrato nello stesso nome dei nobili (a[ristoi): "à tous les moments de leur vie
sociale se manifeste le souci de ajristeuvein", cioè di "primeggiare, essere i primi, essere
i migliori". Gernet nota, a questo riguardo, un comportamento contraddittorio da parte
del governo delle città: da un lato, per via della tradizione consolidatasi delle liturgie, si
44
Gernet 1997, 49. 45
Gernet 1968, 336. 46
Gernet (1968, 336), infatti, afferma: "On comprendra qu'il y a du moins une théorie que nous ne serions
pas disposé à adopter: c'est celle qui représente la noblesse comme un fait relativement tardif, résultant
mécanique d' une inégalité croissante de richesse". Lo studioso francese non cita direttamente Meyer, ma
che stia parlando proprio della sua tesi appare inequivocabile. Sbaglia, dunque, Roussel (1976, 22, 25 n.
30) a considerare Gernet un seguace delle teorie dello storico tedesco: in più, la citazione gernetiana
riportata in nota da Roussel non può in alcun modo dimostrare che Gernet fosse seguace di una simile
teoria e le parole sopra riportate non possono che confermare il contrario.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
30
incoraggiava la spesa da parte dei nobili ed il lusso, dall'altro per mezzo di alcune leggi
si proibiva la stessa trufhv47.
Alla nobiltà sarà fatale per Gernet (1968, 341), negli anni a venire, la nascita della
moneta: quest'ultima, importata in Grecia proprio dai nobili come ostentazione di
ricchezza e strumento di prestigio ("elles (scil. les monnaies) peuvent servir à renforcer,
à étendre des clientèles"), darà, per la prima volta, a chiunque la possibilità di costituire
una propria ricchezza, non più legata al possesso di proprietà fondiarie.
Il 1976 è un anno importante nello studio del concetto di gevno" nella Grecia antica:
nello stesso arco temporale vengono pubblicati due contributi diversi sull'argomento,
ovvero le Recherches sur la nature du génos di Bourriot e Tribu et cité di Roussel.
Bourriot (1976, 1349ss.) distingue tre "tipologie" diverse di gevnh. Nel primo caso,
quello che Bourriot considera il gevno" vero e proprio, vi è un rapporto stretto tra gevno"
e religione: il gevno" forma una famiglia sacerdotale e la sua stessa esistenza è effetto
delle attività connesse con la sfera religiosa, che si presentano come una sorta di eredità
trasmessa dal fondatore ai suoi discendenti. Per Bourriot è sbagliato parlare, per i gevnh
di questo primo tipo, di una aristocrazia esistente fin dall'origine: si tratterebbe,
piuttosto, di una categoria di piccoli mestieri connessi con la sfera religiosa. Solo
successivamente ed, inoltre, in modo non uniforme, alcuni gevnh riuscirono a
guadagnare prestigio e potenza. Di questa prima tipologia di gevnh farebbero parte, per
Bourriot, i Kerykes, i Krokonides, i Praxiergides, gli Hesychides e gli Euneides.
Il secondo tipo di gevno" è costituito, per Bourriot (1976, 1362ss.) da alcune antiche
comunità dell'Attica, anteriori ai demi, sopravvissute alla riforma di Clistene. Di questa
tipologia di gevnh farebbero parte gli Eteobutadi (nome che i Butadi presero dopo la
riforma clistenica) ed altri gruppi eterogenei o marginali come i Salamini. Non si tratta
di gruppi aristocratici, né sacerdotali (come invece sarebbero stati, almeno
originariamente, i gevnh del primo tipo), ma di comunità comunque legate a dei culti
propri.
47
Non sarà dunque un caso se coloro che si ponevano come obiettivo una più equa distribuzione delle
ricchezze (Solone) e/o la fine delle lotte intestine tra gevnh cittadini (Pittaco) iniziarono a far approvare
leggi suntuarie con l'obiettivo di bandire dalla città l'eccesso di sfarzo e l'importazione di beni dai paesi
vicini: ad esempio, per il caso di Lesbo, dalla vicina Lidia.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
31
Al terzo tipo Bourriot (1976, 1365s.) attribuisce quei gevnh che non sono caratterizzati da
alcun culto comune: si tratta, piuttosto, di famiglie ordinarie che, in un modo od in un
altro, sono riuscite à faire parler d'elles, a costituire delle vere e proprie dinastie di
governo. Sotto questa categoria andrebbero, secondo Bourriot, elencati, ad esempio, gli
Alcmeonidi, i Buselidi ed anche i Pisistratidi, anche se per questi ultimi sembra
improprio parlare di un gevno".
Roussel (1976, 39ss.) innanzitutto si schiera contro il parere di Fustel secondo il quale la
città sarebbe fondata, almeno all'origine, su una confederazione di gruppi (cioè di tribù)
diversi: se fosse così, si comprenderebbe male per quale motivo gruppi in grado di
bastare a sé stessi avrebbero dovuto stringere accordi con altri gruppi per ottenere
benefici comuni, almeno senza l'intervento di un qualche fattore esterno. Ed anche la tesi
di Glotz, secondo la quale il singolo individuo avrebbe scoperto lentamente i vantaggi
derivati dal privarsi della giustizia della famiglia, la qevmi", legata ai legami di parentela,
in vista del proprio successo, è ben poco concepibile per Roussel: ciò equivale ad
opporre la povli" ai gruppi familiari. Del resto Platone, nel terzo libro delle Leggi, non
pone la questione in questi termini, bensì in altri: ipotizza, infatti, che singole famiglie
avrebbero stretto, col tempo, legami di parentela sempre più estesi fino a costituire dei
gruppi più vasti e numerosi. Ogni gruppo familiare, venendo da esperienze diverse e da
lunghi periodi di tempo trascorsi separatamente, avrebbe apportato in dote ai nuovi
gruppi la propria legge, diversa da quella degli altri. Vi sarebbe, dunque, stata una sorta
sì di compromesso, ma non mirante tanto a dei benefici comuni, quanto, invece (e più
banalmente), ad uniformare le leggi ed i costumi delle diverse famiglie (ijdivou" novmou")
per una migliore coesistenza: i delegati di ogni famiglia avrebbero esaminato i singoli
costumi e scelto quello migliore per la comunità; in seguito il capo di ogni famiglia
avrebbe fatto applicare il nuovo "corpus".
Del resto, la nozione dell'inalienabilità dei beni familiari non poteva essersi imposta
all'inizio delle "Età oscure", periodi caratterizzati proprio dallo spostamento di popoli
che, come ricorda lo stesso Tucidide, con le loro scorrerie, minacciavano l'esistenza
stessa della proprietà privata. Al contrario, per Roussel furono proprio le città, le povlei"
dell'età arcaica, ad imporre questo principio trasformandolo in una vera e propria
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
32
legge48
, per evitare che i beni continuamente cambiassero di padrone o che si
disgregassero intere famiglie, minacciando, così, la coesione stessa della città.
Per Roussel solo le corporazioni religiose possono essere dette gevnh: del resto è proprio
nell'ambito religioso che l'uso tecnico di questo termine è meglio attestato. La
definizione che Roussel fornisce dei gevnh sacerdotali è la seguente: "un véritable
groupe, stable, bien délimité, bien défini par ses attributions et ses manifestations
collectives dans la vie tant privée que publique des Athéniens, un groupe se recrutant
dans son propre sein, par l'hérédité et portant le plus souvent, mais pas toujours, un nom
en –ides ou en –ades". I gevnh, dunque, non sarebbero dei fossili di un'antica struttura
organizzativa fondata sulla parentela, bensì delle corporazioni religiose costituitesi in
epoca storica in seno all'aristocrazia per assicurarsi il monopolio dei culti principali e
delle relative liturgie. Le poche informazioni che abbiamo sui gevnh provengono da
autori di epoca successiva, soprattutto ellenistica e romana, quando di questi gevnh si
aveva un ricordo molto vago ed i lessicografi cercavano di preservare quel poco
(supponiamo) di cui potevano avere conoscenza. Tuttavia un dato, fornito da più
lessicografi49
, sembra certo: i membri dei gevnh sacerdotali, diversamente da quelli di
48
Per Elide cfr. Arist. Pol. VI 1319 h\n de; tov ge ajrcai'on ejn pollai'" povlesi nenomoqethmevnon mhde; pwlei'n ejxei'nai tou;" trovpou" klhvrou": e[sti de; kai; o}n levgousin jOxuvlou novmon ei\nai toiou'tovn ti dunavmeno", to; mh; daneivzein ei[" ti mevro" th'" uJparcouvsh" eJkavstwi gh'" "anticamente in molte città vi era una legge che non autorizzava a vendere i primi lotti: di un qualcosa di
simile è capace anche la legge che dicono di Oxilo, cioè il prestare denaro prendendo come ipoteca una
parte della terra che spetta ad ognuno". Per Locri cfr. Arist. Pol. II 1266b ejn Lokroi'" novmo" ejsti; mh; pwlei'n eja;n mh; fanera;n ajtucivan deivxhi sumbebhkui'an, e[ti de; tou;" palaiou;" klhvrou" diaswvizein "a Locri c'è una legge che vieta la vendita, a meno che si dimostri che è accaduta una
disgrazia evidente, ma essa prescrive anche di preservare i lotti antichi". Per Leucade cfr. Arist. Pol. II
1266b tou'to de; luqe;n kai; peri; Leukavda dhmotikhvn ejpoivhse livan th;n politeivan aujtw'n: ouj ga;r e[ti sunevbainen ajpo; tw'n wJrismevnwn timhmavtwn eij" ta;" ajrca;" badivzein "il fatto di aver abolito
ciò rese, per quanto concerne Leucade, la costituzione troppo democratica: infatti non accadeva più che
un censo limitato fosse la condizione per avvicinarsi alle cariche pubbliche". Per Tebe cfr. Arist. Pol. II
1274b. 49
Cfr. Harpocr. s. u. gennh'tai: oiJ tou' aujtou' gevnou" koinwnou'nte". dihirhmevnwn ga;r aJpavntwn tw'n politw'n kata; mevrh, ta; me;n prw'ta kai; mevgista mevrh ejkalou'nto fulai;, eJkavsth de; fulh; trich'i dihvirhto, kai; ejkalei'to e{kaston mevro" touvtwn trittu;" kai; fratriva. pavlin de; tw'n fratriw'n eJkavsth dihvirhto eij" gevnh l, ejx w|n aiJ iJerwsuvnai aiJ eJkavstoi" proshvkousai eJklhrou'nto. e[sti de; para; polloi'" tw'n rJhtovrwn tou[noma, wJ" kai; Dhmosqevnh" ejn th'i pro;" Eujboulivdhn ejfevsei. JIsai'o" d ejn tw'i peri; tou' jApollodwvrou klhvrou tou;" gennhvta" suggenei'" wjnovmasen: oujc oiJ suggenei'" mevntoi aJplw'" kai; oiJ ejx ai{mato" gennh'taiv te kai; ejk tou' aujtou' gevnou" ejkalou'nto, ajll∆ oiJ ejx ajrch'" eij" ta; kalouvmena gevnh katanemhqevnte". Filovcoro" d∆ ejn th'i de; fhsi; provteron oJmogavlakta" ojnomavzesqai ou}" nu'n gennhvta" kalou'sin. "gennêtai: coloro
che hanno a comune lo stesso genos. Infatti tutti i cittadini venivano suddivisi in parti e le prime e più
grandi venivano dette phylaì, ma ogni phylè era divisa in tre e ciascuna parte di esse era detta trittia e
phratría. Di nuovo ogni phratría era divisa in trenta génē e fra tutti venivano assegnati a sorte i sacerdozi
spettanti a ciascuno. Il nome è presente in molti retori, ad esempio Demostene nell'"Appello ad Eubulide".
Iseo, invece, nell'orazione "Sull'eredità di Apollodoro" chiamò i gennētai "consanguinei". Non venivano
detti, semplicemente, "consanguinei" i gennētai derivanti da parentela di sangue e dallo stesso genos, ma
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
33
quei gruppi che Roussel chiama "lignaggi" e che non sono dei gevnh veri e propri, non
appartenevano alle stesse famiglie, cioè, in altri termini, non si fondavano su legami di
sangue.
Per Sally Humphreys (1978, 194) occorre distinguere tra le suddivisioni ufficiali dello
stato (tribù, fratrie, demi etc.), il clan aristocratico (gevno"), la parentela bilaterale e la
famiglia (l’oi\ko"). Tribù, fratrie ed altre suddivisioni ufficiali dello stato organizzavano
la società “in sets of superimposed segments” : ogni tribù consisteva di tre trittie ad
Atene, ogni trittia conteneva un numero prestabilito di fratrie (forse tre, se si ipotizza che
la trittia assumesse il nome non dall’essere un terzo, ma dall’essere composta da tre
parti). L’antropologa inglese (1978, 196) nota come oggi vi sia accordo nel ritenere il
gevno" una organizzazione che fu “predominantly if not entirely confined to the
nobility” (cfr., per un’idea identica, anche Humphreys 1983, 142). Per la studiosa
inglese i gevnh dovevano variare, dall’uno all’altro, a seconda delle regole con cui
avveniva la successione: quando essa era per via ereditaria il gevno" così contraddistinto
era formato come un clan conico, con una genealogia ben strutturata e concentrata
intorno ad alcune linee di successione di primaria importanza. Un secondo tipo di gevno",
invece, era basato non sulla successione, ma sull’elezione, sicchè la discendenza sarà
stata un criterio meno importante. Un altro problema è costituito dalle fonti che ci
coloro che, fin dall'inizio,erano stati suddivisi nei cosiddetti génē. Filocoro, invece, nel quarto libro,
sostiene che prima venivano chiamati homogalaktes coloro che ora chiamano gennētai"; Etym. Magn. s.u. gennh'tai: Gevnou" ejsti; suvsthma ejk triavkonta ajndrw'n sunestw;", ou| oiJ metevconte" ejkalou'nto gennh'tai: ouj kata; gevno" ajllhvloi" proshvkonte", oujde; ajpo; tou' aujtou' ai{mato", ajll∆ w{sper oiJ dhmovtai kai; fravtore" ejkalou'nto, novmwn koinwnivan tina; e[conte", ou{tw" kai; oiJ gennh'tai suggenikw'n ojrgivwn h] qew'n, ajf∆w|n ojrgew'ne" wjnomavsqhsan. ]H oiJ taujtou' gevnou" metevconte": h] ajp∆ ajrch'" koina; iJera; e[conte": oiJ de;, oJmogalavktou", fravtora", suggenei'" tou;" gennhvta". "essendo la lega del genos composta da trenta uomini, coloro che vi fanno parte sono detti gennētai. Non
sono parenti tra di loro né per stirpe, né per discendenza dallo stesso sangue, ma come i membri di un
demo sono anche chiamati phratores, poiché hanno una certa comunanza di leggi, così i gennētai l'hanno
di dei o di riti legati alla parentela, per i quali erano chiamati orgeônes. Oppure coloro che fanno parte
dello stesso genos; oppure possedendo, fin dall'inizio, riti comuni. Altri chimanano i gennētai
homogalaktoi, phratores, syngeneis". E cfr. anche Poll. VIII 111 oiJ fulobasilei'". ejx eujpatridw'n de; o[nte", mavlista tw'n iJerw'n ejpemelou'nto, sunedreuvonte" ejn tw'i basileivwi tw'i para; to; boukolei'on. o{te mevntoi tevttare" h\san aiJ fulaiv, eij" triva mevrh eJkavsth dihvirhto, kai; to; mevro" tou'to ejkalei'to trittu;" kai; e[qno" kai; fratriva. eJkavstou de; e[qnou" gevnh triavkonta ejx ajndrw'n tosouvtwn, a} ejkalei'to triakavde". kai; oiJ metevconte" tou' gevnou" gennh'tai kai; oJmogavlakte", gevnei me;n ouj proshvkonte", ejk de; th'" sunovdou ou{tw prosagoreuovmenoi. triva d∆ h\n ta; e[qnh pavlai, Eujpatrivdai Gewmovroi Dhmiourgoiv. "hoi phylobasileis: essendo parte degli
Eupatridi, si occupavano soprattutto di riti sacri, partecipando al consiglio nella reggia accanto al
palazzo dell'arconte re. Quando quattro erano le tribù, ciascuna era divisa in tre parti e la parte (derivata
da questa suddivisione) era detta trittia, stirpe e fratria. Di ciascuna stirpe trenta erano i genē, che erano
detti triacadi, composti da altrettanti uomini. E coloro che avevano parte al gevno", gennētai e
homogalaktes, non erano parenti, ma venivano chiamati così dalla consorteria. Tre erano, anticamente, le
stirpi: Eupatridi, Gheomori e Demiurghi."
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
34
parlano di un gevno" come suddivisione della fratria: non era, del resto, poco frequente
che un gevno" acquistasse una posizione di preminenza all’interno di una fratria. Certo si
potrebbe pensare a due organizzazioni sortite “from a single source”, ma i documenti
micenei dimostrano l’esistenza, all’epoca, di un elaborato sistema di gradi militari ed
amministrativi ed anche il mondo omerico, pur in una forma semplificata, mostra una
simile organizzazione: ergo in una società del genere doveva esserci un confine tra la
fratria ed il gevno", ovvero tra persone comuni e nobili, sicchè è più ragionevole pensare,
secondo la Humphreys (1978, 197), che gevno" e fratria fossero due fenomeni separati,
con funzioni e forme diverse, sebbene i singoli membri di ognuno di essi potevano
sovrapporsi ed essere, dunque, membri sia del gevno", in quanto nobili, sia della fratria.
Alla ricerca di un nome per i "gruppi" aristocratici
Attestazioni della parola gevno" dal miceneo al IV secolo
Prima di proseguire, è utile passare in rassegna le varie attestazioni della parola gevno": il
nostro fine sarà quello di isolare il significato che qui a noi interessa, cioè come
sinonimo greco della parola celtica clan, usata in antropologia, ovvero secondo la
definizione di gevno" data, per la prima volta, da Grote.
La parola micenea corrispondente a gevno", ovvero, in via di ipotesi, *ke-no, non è mai
attestata nel corpus della lineare B: è un fatto inquietante per coloro che considerano il
gevno" un'istituzione primitiva e, quindi, premicenea. Il dato, tuttavia, va preso con il
solo beneficio di inventario: che la parola sia priva di attestazioni non significa,
necessariamente, che l'institutum non fosse presente nella Grecia del II millennio a. C.:
per arrivare ad una tale conclusione occorrerebbero maggiori informazioni.
In mancanza di attestazioni micenee, dobbiamo scendere di alcuni secoli, per arrivare ai
primi documenti successivi in lingua greca, cioè, in altre parole, all'epica arcaica. Il
termine è attestato quindici volte nell'Iliade e venti nell'Odissea. Nell'Iliade la parola
assume, talvolta, il significato di "categoria", usato sia per gli animali50
, per cui andrà
inteso come "razza", sia per gli uomini51
, ovvero "genia". Tuttavia, si riscontrano
50
Cfr. Il. II 852 ejx jEnetw'n, o{qen hJmiovnwn gevno" ajgroteravwn "dagli Eneti, donde proviene razza di
mule selvagge". 51
Cfr. Il. XII 23 hJmiqevwn gevno" ajndrw'n "genia di uomini semidivini".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
35
maggiori attestazioni per il significato di "nascita" (e sui derivati): è piuttosto attestato
come accusativo di relazione52
(lett.: "quanto alla nascita"). Tra le varie attestazioni di
questa parola nell'Iliade la più interessante è Il. XIII 354 h\ ma;n ajmfotevroisin oJmo;n
gevno" hjd∆ i[a pavtrh "per entrambi era uguale la stirpe e l'origine": il poeta sta
parlando, qui, di Zeus e di Poseidone. Questo passo venne citato da Glotz (1904, 11-12)
per dimostrare che la società omerica conosceva i gevnh53: "La cité homérique a donc
conservé les organes primitifs de la vie sociale. Elle renferme des tribus, des phratries et
des gevnh". Glotz, tuttavia, non presta la minima attenzione ad un fatto non secondario: il
poeta qui non sta parlando di uomini, ma di dei: in altre parole non si tratta della "città
omerica", bensì di quella dell'Olimpo. Per Bourriot (1976, 244), invece, questo verso
non prova affatto l'esistenza, nella società omerica, di gevnh e di fratrie: la parola andrà
intesa, piuttosto, nel significato di "ascendence paternelle"54
.
Nell'Odissea il termine è attestato cinque volte in più: due volte nel significato di
"categoria", usato sia per gli animali, sia per gli uomini55
. Il poeta odissiaco ricorre
spesso alla parola gevno" in domande e risposte vertenti sull'origine (gevno", appunto),
sia geografica (del resto prevedibile in un poema di viaggio qual è l'Odissea), sia sociale,
di una persona56
. Altrimenti, il termine può assumere il significato di "lignaggio, stirpe,
52
Curiosamente un'attestazione è in riferimento ad un animale, il cavallo di Adrasto, che viene detto
nobile "per nascita" in Il. XXIII 347 jAdrhvstou tacu;n i{ppon, o}" ejk qeovfin gevno" h\en "il veloce
cavallo di Adrasto, che per nascita era proveniente dagli dei". Ovviamente, quest'accusativo di relazione
si trova usato anche per gli uomini: cfr. Il. V 544s. (Diocle); XIV 113 e 126 (Diomede); V 896 (Ares). E
cfr. anche Il. IX 538 (e non IX 358 come erroneamente segnalato da Bourriot 1976, 241: Artemide); VI
180 (Chimera); XI 186 (Asteropéo); XIX 124 (Euristeo); VI 209 (Glauco riceve l'ordine di non
"macchiare" la stirpe degli avi); IV 58 (Hera è della stessa origine di Zeus); III 251 (Menelao, "quanto a
nascita", viene dopo Odisseo). 53
Glotz (1904, 12 n. 1) aggiunge: "Dans ce vers, il est question de gevnh et de pavtrai, sans qu'on puisse
dire si les pavtrai sont des phratries comprenant des gevnh ou des gevnh comprenant des familles". 54
Cfr. Bourriot 1976, 243. Lo studioso francese cita, a sostegno della sua interpretazione, lo scolio ad loc.,
ovvero Schol. in Hom. Il. XIII 354 ...e[stin ou\n ajnti; tou' miva patriav, oJ aujto;" pathvr. 55
Per l'uso in riferimento ad animali, cfr. Od. XX 212 bow'n gevno" eujrumetwvpwn "razza dei buoi dalla
larga fronte", mentre per quello ad uomini (re, in questo caso) cfr. Od. XVI 401 (e non XVII 401 come
riportato da Bourriot 1976, 244-5) deino;n de; gevno" basivlhi>ovn ejsti / kteivnein "terribile è uccidere
una stirpe regale" (Anfinomo sostiene che, prima di uccidere Telemaco, è necessario ascoltare la volontà
degli dei). 56
Cfr. Od. XV 267 ejx jIqavkh" gevno" eijmi;, path;r dev moiv ejstin jOdusseuv" "di stirpe provengo da
Itaca e mi è padre Odisseo"; Od. XXIV 269 (vantarsi di essere originario di Itaca); XIV 199 (vantarsi di
essere originario di Creta); XVI 62 (idem); XVII 523 (la stirpe di Minosse è originaria di Creta). Per
l'origine sociale cfr., invece, Od. XXI 335 (vantarsi di essere di nobile padre quanto ad "origine"); XIV
204 (vantarsi di essere discendente di Castore Ilacide); XVII 373 (non sapere di quale stirpe vantarsi);
XIX 116 ("ma la stirpe non chiedermi e la terra dei padri"); XIX 162 (Penelope chiede ad Odisseo,
nascosto dalle sembianze di mendicante, la sua stirpe e donde provenga).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
36
discendenza"57
, donde quello di "generazione"58
. Le attestazioni passate in rassegna
finora non rientrano, dunque, nella sfera del gevno" di cui qui stiamo parlando. Le ultime
due attestazioni sono un po' più interessanti. La prima che affronteremo è un passo
piuttosto famoso, ovvero Od. VIII 581ss.:
h\ tiv" toi kai; pho;" ajpevfqito jIliovqi prov, ejsqlo;" ejwvn, gambro;" h] penqerov" oi{ te mavlista khvdistoi televqousi meq∆ ai |mav te kai; gevno" aujtw'n. h\ tiv" pou kai; eJtai'ro" ajnh;r kecarismevna eijdwv", ejsqlov"; ejpei; ouj mevn ti kasignhvtoio cereivwn givnetai, o{" ken eJtai'ro" ejw;n pepnumevna eijdh'i"
Forse un congiunto di fronte ad Ilio ti è morto,
che era valoroso, genero o suocero, che più di tutti
sono degni d'affetto, dopo il sangue ed il genos?
O forse un compagno, che conosceva ciò che è a te caro,
valoroso? Poiché non è meno di un fratello
chi ti è compagno e conosce sapienza.
Glotz (1904, 79-80) ricorre a questo passo per dimostrare la solidarietà della famiglia in
caso di vendetta di sangue, ma qui, come nota Bourriot (1976, 251) gevno" non è un
sinonimo di clan: se infatti fosse così, si avrebbe una situazione inammissibile, ovvero i
membri del gevno" più cari di un genero o di un suocero. Il poeta, dunque, non sta
parlando del gevno" come definito da Grote, ma della famiglia ristretta o di qualche altra
tipologia di parentela effettiva. Resta da affrontare l'ultimo caso, ovvero quello di Od.
XV 525ss.:
}W" a[ra oiJ eijpovnti ejpevptato dexio;" o[rni", kivrko", jApovllwno" tacu;" a[ggelo": ejn de; povdessi tivlle pevleian e[cwn, kata; de; ptera; ceu'en e[raze messhgu;" nhov" te kai; aujtou' Thlemavcoio. to;n de; Qeokluvmeno" eJtavrwn ajponovsfi kalevssa" e[n t∆a[ra oiJ fu' ceiri; e[po" t∆e[fat∆e[k t∆ojnovmaze: "Thlevmac∆, ou[ toi a[neu qeou' e[ptato dexio;" o[rni": e[gnwn gavr min ejsavnta ijdw;n oijwno;n ejovnta. uJmetevrou d∆oujk e[sti gevno" basileuvteron a[llo ejn dhvmwi jIqavkh", ajll∆ uJmei'" karteroi; aijeiv.
57
Cfr. Od. IV 62-3 ouj ga;r sfw'in ge gevno" ajpovlwle tokhvwn / ajll∆ajndrw'n gevno" ejste; diotrefevwn basilhvwn / skhptouvcwn "infatti non si è persa in voi la schiatta dei padri / ma siete stirpe di uomini, di
re alunni di Zeus, / portatori di scettri..."; Od. XXIV 508 mhv ti kataiscuvnein patevrwn gevno" "non
recare onta, in qualche modo, alla stirpe dei padri". 58
Cfr. Od. III 245 tri;" ga;r dhv mivn fasin ajnavxasqai gevne∆ajndrw'n "dicono che abbia già esercitato
il comando su tre generazioni".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
37
Volò incontro a lui, mentre diceva così, un uccello da destra,
un falco, veloce nunzio d'Apollo: e tra le zampe tenendo
una colomba la spennava e le penne a terra cadevano
in mezzo tra la nave e lo stesso Telemaco.
E Teoclimeno, in disparte dai compagni chiamatolo,
lo prese per mano, parlava parola, diceva:
"Telemaco, non senza un dio ti volò incontro
l'uccello da destra: ho capito, dopo averlo guardato,
che è un uccello augurale.
Altra stirpe più regia della vostra non c'è
tra il popolo d'Itaca, ma voi sarete sempre possenti.
Per questo passo non possiamo basarci sui dati semantici, lessicali o logici: occorrono
anche quelli sociali: non considerando questi ultimi, questa sarebbe l'unica volta in cui,
nei poemi omerici, la parola greca gevno" corrisponderebbe alla definizione ed alla
caratterizzazione data dagli storici del XIX secolo, segnatamente da Grote. Occorre,
però, prendere coscienza di questi dati sociali: essi ci dicono che il gruppo di Odisseo
non può essere paragonato ad un gevno": Laerte dovrebbe essere il capo del gevno" e, in
quanto tale, circondato da un folto stuolo di altre persone, non tutte parenti di sangue. La
situazione descritta dai poemi omerici mal corrisponde al gevno" degli storici
ottocenteschi: Laerte, il padre di Odisseo, invece, vive solo, in disparte rispetto al centro
dell'isola, lontano dalla reggia: egli vive, secondo Bourriot (1976, 254), come un
eremita, senza darsi alcun peso delle vicende dell'isola. Laerte, dunque, se si deve
parlare di un gevno", non può essere il capo. Neanche Telemaco e Penelope possono
essere a capo di un ipotetico gevno": entrambi sono soli, senza alcun aiuto esterno, a
dover affrontare la situazione contingente. Bisogna, dunque, concludere che quello di
Odisseo non è un gevno" che risponda alla descrizione data da Grote: si tratta, piuttosto,
di una famiglia ordinaria. In conclusione: l'epica omerica e, dunque, il suo autore (o i
suoi autori), sembra non conoscere una struttura simile al gevno" come descritto, per la
prima volta, da Grote.
Abbandonato Omero, non possiamo che passare ad Esiodo e ripetere la stessa ricerca. La
parola gevno" è attestata dieci volte nella Teogonia, undici volte nelle Opere ed i giorni
e quattro volte nei frammenti superstiti: in tutto si tratta di venticinque passi, ma in
nessuno di essi questa parola corrisponde all'institutum descritto da Grote. Più in
particolare, nella Teogonia la parola gevno" assume sempre un significato relato alla
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
38
nozione generale di "categoria"59
: "razza, stirpe"60
, donde anche "stirpe, discendenza"61
.
Nelle Opere ed i giorni, invece, la parola gevno" ricorre soprattutto quando si parla del
mito della successione delle razze62
, quella d'oro, quella d'argento e quella di bronzo. Le
ultime due attestazioni della parola nelle Opere ed i giorni sono Op. 11 (dove assume il
significato di "genere, tipologia"63
) e Op. 299, dove Perse, il fratello del poeta, viene
invocato, per inciso, come di'on gevno"64. Nei frammenti a noi giunti si hanno tre
attestazioni, su quattro totali, in cui la parola assume un significato qui già discusso65
;
l'ultima attestazione esiodea, ovvero Hes. fr. 26bis.31a, è quella per noi più problematica
e l'unica che, così come è stata tradita, potrebbe presentare la parola gevno" nel senso
definito dal Grote. Il testo è il seguente:
jAntiovch kreivousa palaio;n gevno" Naubolivdao
Antioche che è a capo dell'antico gevno" di Naubolide
Il genitivo posto in fine di verso può far credere che si tratti di un gevno" vero e proprio,
ma per molti il passo è corrotto e si è provato a correggere palaio;n in Puvlwno", sicchè
gevno" non sarebbe più l'institutum di cui qui si sta parlando, ma significherebbe, più
semplicemente, "figlio, discendente di, rampollo", come, del resto, in altri passi esiodei
od omerici. Altrimenti si è ipotizzato che palaio;n gevno" non sia altro che una glossa
per Naubolivdao. In ogni modo, Bourriot (1976, 268) ha sostenuto che, poiché qui si sta
parlando di eroi e non di uomini, questo passo non apporta nulla alla nostra indagine. In
conclusione, anche in Esiodo non appare alcuna attestazione di gevno" nel senso che a
noi interessa.
59
Per gevno" nel senso generico di "categoria" cfr. Hes. Theog. 161 gevno" poliou' ajdavmanto" "categoria
del livido adamante". 60
Cfr. Hes. Theog. 21 ajqanavtwn...gevno"; Theog. 33 makavrwn gevno"; Theog. 44 qew'n gevno"; Theog. 50
ajnqrwvpwn te gevno" kraterw'n te Gigavntwn; Theog. 105 ajqanavtwn iJero;n gevno"; Theog. 590
gevno"...gunaikw'n; Theog. 591 gevno" kai; fu'la gunaikw'n; Theog. 346 qugatevrwn iJero;n gevno". 61
Cfr. Hes. Theog. 336 tou'to me;n ejk Khtou'" kai; Fovrkuno" gevno" ejstiv "questa è la discendenza di
Cetó e di Phorcy". 62
Ben nove attestazioni in questo contesto su undici complessive: Hes. Op. 109; 121; 127; 140; 143; 156;
159; 176; 180. 63
Cfr. Hes. Op. 11 Oujk a[ra mou'non e[hn jErivdwn gevno", ajlla; ejpi; gai'an / eijsi; duvw "Di Erides non
vi era un sol genere, ma sulla terra / ce ne sono due". 64
Cfr. Hes. Op. 299 ejrgavzeu Pevrsh, di'on gevno" "lavora Perse, rampollo divino". 65
Cfr. Hes. fr. 43a.53 wJ" ou[ oiJ doi'en Glauvkwi gevno" Oujranivwne" / ejk Mhvstrh" "che i figli di
Úrano non avrebbero dato a Glauco una stirpe"; 123.2 ou[reiai nuvmfai qeai; ãejxÃegevnonto / kai; gevno" oujtidanw'n Satuvrwn kai; ajmhcanoergw'n / kourh'tev" te qeoi; filopaivgmone" ojrchsth're" "le ninfe, dee montane, nacquero / e la stirpe dei Satiri privi di valore ed inabili al lavoro / e gli dei curati
amanti dei giochi e ballerini"; 204.98 gevno" merovpwn ajnqrwvpwn "razza degli uomini mortali".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
39
La parola gevno" ricorre una trentina di volte nei lirici arcaici e, come primo significato,
assume quello di “categoria”66
e quindi “stirpe” (anche come accusativo di relazione67
),
"stirpe degli antenati"68
e “generazione” (anche con valore temporale69
). Dal significato
di “stirpe" deriva anche quello di “discendente”70
: del resto, il significato più attestato è
quello di "discendenza, prole, posterità"71
. In nessuna delle attestazioni della lirica
arcaica finora passate in rassegna, dunque, la parola gevno" indica una struttura simile al
clan. Veniamo ora, però, ai casi più incerti e discussi: in un componimento della Silloge
teognidea (Thgn. 891-894) si accenna, a quanto sembra, ad un gevno" dei Cipselidi:
w[ moi ajnalkivh": ajpo; me;n Khvrinqo" o[lwlen, Lhlavntou d∆ajgaqo;n keivretai oijnovpedon: oiJ d∆ajgaqoi; feuvgousi, povlin de; kakoi; dievpousin. wJ" dh; Kuyelidw'n Zeu;" ojlevseie gevno".
Ohimè la debolezza! Persa è Cerinto,
devastata la bella vigna di Lelanto:
fuggono i buoni, i cattivi governano la città.
Che Zeus mandi in rovina il gevno" dei Cipselidi.
Nei primi due versi del componimento si parla di località dell'Eubea, mentre nell'ultimo,
il quarto, il poeta formula l'augurio che Zeus possa sterminare il gevno" dei Cipselidi.
Che si faccia, effettivamente, riferimento ai Cipselidi non è, tuttavia, così pacifico: il
manoscritto A presenta kuyelivzwn, mentre OXDUrI hanno kuyellivzon72: il testo di tutte
66
Cfr. Xenoph. fr. 5.4 Diehl ajoidavwn...gevno" JElladikovn; Bacchyl. 17.93 S.-M. jAqanaivwn...gevno"; Thgn.
1141 euJsebevwn...ajndrw'n gevno"; Sem. 7.51 Edm. th;n d∆ ejk galh'", duvsthnon oijzuro;n gevno" “ma
un'altra dalla donnola, razza miserabile e sciagurata”; Alcm. 89.4 P. gevno" melissa'n; Mimn. 17.4
Edm. gevno" i{ppwn. Al senso generico "categoria" si possono anche attribuire passi caratterizzati da un
significato più definito del termine; in Thgn. 191-2, ad esempio, gevno" vale per "razza degli ejsqloiv":
ou{tw mh; qauvmaze gevno", Polupai?dh, ajstw'n / maurou'sqai: su;n ga;r mivsgetai ejsqla; kakoi'" "non ti meravigliare, Polipaide, del fatto che la razza dei cittadini dabbene / imbastardisce: ciò che è
bene, infatti, si è mescolato ai mali". 67
Cfr. Alcm. fr.16.3 P. oujde; Sevssalo" gevno" “nè tessalo di stirpe”; Thgn. 1210-1 Ai[qwn me;n gevno" eijmiv, povlin d∆eujteivcea Qhvbhn / oijkw' “Etone sono di stirpe, ma vivo a Tebe dalle solide mura”. 68
Cfr. Tyrt. fr. 10.9 W. (=6.9 Diehl) aijscuvnei te gevno" "disonora la stirpe (degli antenati)". 69
Cfr. Thgn. 928 ejn de;; toiw'ide gevnei “nella generazione presente”(cioè “ai giorni nostri”). 70
Cfr. Callin. fr. 1.13 W. (=1.13 Diehl) progovnwn...gevno" ajqanavtwn "discendente di antenati
immortali". 71
Sem. fr. 7.87 W. (=7, 87 Edm.= 7,87 Diehl) afferma che una donna simile ad un'ape tekou'sa kalo;n kwjnomavkluton gevno" "genera una prole bella ed ammirata". E cfr. anche Tyrt. fr. 9.30 Diehl kai; paivdwn pai'de" kai; gevno" ejxopivsw “ed i figli dei figli e la discendenza dopo di lui"; Sol. 1.32 Diehl
ajnaivtoi e[rga tivnousin / h] pai'de" touvtwn h] gevno" ejxopivsw "pagano il fio gli innocenti / o i figli di
costoro o la discendenza a venire"; fr. 23.7 Diehl kajpitetrivfqai gevno" "la discendenza se ne vada pure
in malora"; fr. 7.2 Diehl kai; gevno" uJmevteron. 72
Cfr. West 1971, xi-xii ed app. ad loc. p. 216: questa è la lettura di West, ma Bourriot (1976, 280) aveva
a disposizione ancora la sola edizione di Diehl nella quale (Diehl1 1923, 161) la lezione del codice A è
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
40
le edizioni moderne è, infatti, dovuto a congettura ma è, molto probabilmente, corretto.
Posto, dunque, che si parli della grande "famiglia" di Corinto, è lecito chiedersi se essi
possono essere considerati un vero e proprio gevno" come descritto da Grote. I Cipselidi
non possono essere una famiglia così antica da far perdere la loro origine nella notte dei
tempi e non risalgono ad un antenato così lontano nel tempo da far cadere in oblio i
legami di parentela: Cipselo, il fondatore, non visse, secondo Bourriot (1976, 285), che
tre generazioni prima di Teognide ed inoltre non si fregiava, certo, di una qualche
discendenza divina, né era oggetto di un qualche culto. Ed anche la sua origine non era,
certo, "nobile". gevno" non può qui, dunque, essere inteso come corrispettivo del clan,
ma significa, piuttosto, "famiglia", come avveniva anche nei poemi omerici.
Escludendo, dunque, la lirica, è stato rintracciato un solo passo, in età arcaica, in cui il
significato della parola gevno" corrisponde, almeno superficialmente, alla descrizione
fatta da Grote: si tratta, probabilmente, di una legge soloniana ed è stata tradita da Ath.
234e-f:
ejn de; toi'" kuvrbesi toi'" peri; tw'n Dhliastw'n ou}tw" gevgraptai: “kai; tw; khvruke ejk tou' gevnou" tw'n Khruvkwn tou' th'" musthriwvtido". touvtou" de; parasitei'n ejn tw'i Dhlivwi ejniautovn”. E nelle tavole a riguardo dei Deliasti così è stato scritto: "anche i due araldi provenienti
dal gevno" dei Kerykes, quello che ha a che fare con i misteri. Costoro devono servire da
parásitoi per un anno nel recinto di Apollo Delio".
Non a caso abbiamo detto "superficialmente": il gevno" di cui qui si parla non sembra
avere, infatti, alcuna forza negli affari pubblici della città e lo scopo di questa legge non
è, certo, quello di togliere potere ad un tale gevno": i Kerykes, piuttosto, devono,
semplicemente, fornire ogni anno due parásitoi per il tempio: si ha a che fare, dunque,
con una funzione religiosa. "On peut donc penser que le signe distinctif du génos est
beaucoup plus une activité de type que l'on pourrait appeler professionnel que la
descendance d'un commun ancêtre héroïque"73
.
Per quanto attiene al V secolo, Bourriot (1976, 357ss.) rintraccia solo due attestazioni
della parola gevno" come corrispettivo greco del clan celtico: entrambe si riferiscono al
presentata come kuyelivzwn. Le abbreviazioni dei manoscritti qui usate sono quelle di West. Il primo a
tentare di sanare il testo fu Hermann, che propose di scrivere Kuyelidw'n: Bergk, nella prima edizione
(Bergk1 1843, 401) accolse la congettura di Hermann, mentre nella seconda edizione dei lirici (Bergk
2
1853, 430) corresse il testo in Kuyelidevwn. 73
Bourriot 1976, 330-331.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
41
gevno" degli Iamidi. La prima si trova nella Olimpica VI di Pindaro: Agesia di Siracusa,
il personaggio lodato in questo epinicio, appartiene al gevno" degli Iamidi: Iamo, figlio
di Apollo e di Evadne, aveva ricevuto dal padre il dono della profezia ed esso era
diventato ereditario, sicché tutti i discendenti erano caratterizzati da questa facoltà. Gli
Iamidi sono, dunque, un gevno" (Pi. O. VI 71-72):
ejx ou| poluvkleiton kaq∆ {El- lana" gevno" jIamida'n:
o[lbo" a{m∆e{speto da quel tempo è molto illustre
tra gli Elleni il gevno" degli Iamidi:
insieme seguì prosperità
La seconda attestazione dell'uso specifico della parola gevno" nel senso di clan si trova
in Hdt. IX 33 e riguarda anche essa, come abbiamo detto, gli Iamidi. Erodoto, nel nono
libro delle Storie, poco prima di narrare la battaglia di Platea, fa una digressione per
presentare Tisameno, colui che era stato incaricato dai greci di compiere i sacrifici
prebellici:
{Ellhsi me;n Teisameno;" jAntiovcou h\n oJ quovmeno": ou|to" ga;r dh; ei{peto tw'i strateuvmati touvtwi mavnti": to;n ejovnta jHlei'on kai; gevneo" tou' jIamidevwn Klutiavdhn, Lakedaimovnioi ejpoihvsanto lewsfevteron Per i greci il sacrificante era Tisameno, figlio di Antioco: costui, infatti, aveva seguito
questa spedizione come indovino: era eleo di origine ed appartenente al gevno" degli
Iamidi, Clitiade; i Lacedemoni gli avevano dato la loro cittadinanza.
In conclusione, il termine greco gevno" nel V secolo non è utilizzato, come ci saremmo
aspettati, per identificare quelle grandi "famiglie" che fecero la storia dell'Atene del V
secolo, gli Alcmeonidi, i Filaidi (da cui provenivano Milziade e Cimone) e i Buzigi (a
cui apparteneva Pericle), ma per un gruppo, quello degli Iamidi, che non ebbe alcuna
importanza nello sviluppo delle vicende storiche: gli Iamidi, come i Kerykes in Ateneo,
sono, piuttosto, un gruppo dedito a funzioni religiose.
Che il ragionamento fin qui sviluppato sembra essere corretto lo dimostra il fatto che gli
stessi Pindaro ed Erodoto utilizzano altri termini per indicare "gruppi" aristocratici come
gli Alcmeonidi ed i Filaidi: se per Pindaro si può sempre giustificare questa terminologia
in base a motivi metrici, per Erodoto questo non avviene e non possiamo fare altro che
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
42
accettare la divergenza. Veniamo ai passi che devono essere oggetto, ora, della nostra
attenzione. Il primo è Pi. P. VII 1ss.:
Kavlliston aiJ megalopovlie" jAqa'nai prooivmion jAlkmanida'n eujrusqenei' genea'i krhpi'd∆ajoida'n i{ppoisi balevsqai. ejpei; tivna pavtran tivna oi\kon naivwn ojnumavxeai ejpifanevsteron JEllavdi puqevsqai;
Bellissimo proemio, la grande città di Atene,
per gettare la base dei canti
alla potente stirpe degli Alcmeonidi
vincitrice con i cavalli. Poiché abitando quale patria,
quale casa sarai chiamato in un modo più illustre
in Grecia ad udirsi?
Pindaro, quindi, per indicare il "gruppo" aristocratico degli Alcmeonidi ricorre al
sostantivo geneav, piuttosto che al più semplice gevno", oppure, significativamente, ad
oi\ko"; ma veniamo, invece, al termine usato da Erodoto: è attestato in Hdt. VI 125, dove
viene narrato il modo in cui gli Alcmeonidi, dunque la stessa famiglia di cui parla
Pindaro, si arricchirono ancora di più ed accrebbero, così, la loro forza:
oiJ de; jAlkmewnivdai h\san me;n kai; tav ajnevkaqen lamproi; ejn th'isi jAqhvnhisi, ajpo; de; jAlkmevwno" kai; au\ti" Megaklevo" ejgevnonto kai; kavrta lamproiv. tou'to me;n ga;r jAlkmevwn oJ Megaklevo" toi'si ejk Sardivwn Ludoi'si para; Kroivsou ajpikneomevnoisi ejpi; to; crhsthvrion to; ejn Delfoi'si sumprhvktwr te ejgivneto kai; sunelavmbane proquvmw", kaiv min Kroi'so" puqovmeno" tw'n Ludw'n tw'n ej" ta; crhsthvria foiteovntwn eJwuto;n eu\ poievein metapevmpetai ej" Savrdi", ajpikovmenon de; dwrevetai crusw'i to;n a]n duvnhtai tw'i eJwutou' swvmati ejxeneivkasqai ejsavpax. oJ de; jAlkmevwn pro;" th;n dwrehvn, ejou'san toiauvthn, toiavde ejpithdeuvsa" prosevfere: ejndu;" kiqw'na mevgan kai; kovlpon baqu;n katalipovmeno" tou' kiqw'no", koqovrnou" ou}" eu{riske eujrutavtou" ejovnta" uJpodhsavmeno", h[ie ej" to;n qhsauro;n ej" o{n oiJ kathgevonto. ejspesw;n de; ej" swro;n yhvgmato", prw'ta me;n parevsaxe para; ta;" knhvma" tou' crusou' o{son ejcwvreon oiJ kovqornoi, meta; de; to;n kovlpon pavnta plhsavmeno" crusou' kai; ej" ta;" trivca" th'" kefalh'" diapavsa" tou' yhvgmato" kai; a[llo labw;n ej" to; stovma ejxhvie ejk tou' qhsaurou', e{lkwn me;n movgi" tou;" koqovrnou", panti; de; tewi oijkw;" ma'llon h] ajnqrwvpwi: tou' tov te stovma ejbevbusto kai; pavnta ejxwvgkwto. ijdovnta de; to;n Kroi'son gevlw" ejsh'lqe, kai; oiJ pavnta te ejkei'na didoi' kai; pro;" e{tera dwrevetai oujk ejlavssw keivnwn. ou{tw me;n ejplouvthse hJ oijkivh au{th megavlw", kai; oJ jAlkmevwn ou|to" ou{tw teqrippotrofhvsa" jOlumpiavda ajnairevetai.
Gli Alcmeonidi erano illustri ad Atene fin dalle origini, ma a partire da Alcmeone ed, in
seguito, anche da Megacle divennero ancora più illustri. Anzitutto, infatti, Alcmeone,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
43
figlio di Megacle, fu collaboratore per i Lidi giunti da Sardi per volere di Creso a
consultare l'oracolo che è in Delfi e li accolse volentieri e Creso, informato dai Lidi che
frequentavano l'oracolo del fatto che egli aveva agito bene, lo fa venire a Sardi e, una
volta giunto, gli regala tanto oro quanto quello che avrebbe potuto portar via sul suo
corpo in una sola volta. Alcmeone, tuttavia, di fronte ad un simile dono, dopo averci
studiato un po', applicò una simile trovata: indossato un largo chitone, lasciata una piega
profonda e calzati i coturni più grandi che trovò, andò verso quel tesoro al quale lo
conducevano. Gettatosi su un cumulo di polvere d'oro, per prima cosa stipò lungo le
gambe quanto oro contenevano i coturni e poi, riempita d'oro tutta la piega del chitone,
cosparse della polvere d'oro le chiome del capo e, presa altra polvere in bocca, uscì dal
tesoro, trascinando a fatica i coturni e somigliando a tutto meno che ad un uomo: la
bocca era piena e tutto era gonfio. Alla sua vista il riso penetrò in Creso: a lui dette tutto
e gli donò altro in misura non minore. Così questa oijkivh si arricchì grandemente e
Alcmeone, fattosi allevatore di cavalli da quadriga, riportò una vittoria ad un'Olimpiade.
Se Pindaro aveva usato geneav ed oi\ko", lo storiografo ionico ricorre, invece, ad oijkivh:
non possiamo non segnalare l'affinità etimologica tra oi\ko" ed oi\kiva, tanto più che
quest'ultimo termine non è attestato solo per gli Alcmeonidi, ma anche per altri "gruppi"
aristocratici che la storiografia, da Grote in poi, ha sempre chiamato gevnh. Esso è
presente, ovviamente nella sua variante ionica, in Erodoto (Hdt. VI 35,1), ad esempio,
per i Filaidi, ai quali apparteneva Milziade:
ejn de; th'isi jAqhvnhisi thnikau'ta ei\ce me;n to; pa'n kravto" Peisivstrato", ajta;r ejdunavsteuev ge kai; Miltiavdh" oJ Kuyevlou, ejw;n oijkivh" teqrippotrovfou, ta; me;n ajnevkaqen ajp∆ Aijakou' te kai; Aijgivnh" gegonwv", ta; de; newvtera jAqhnai'o", Filaivou tou' Ai[anto" paidov", genomevnou prwvtou th'" oijkivh" tauvth" jAqhnaivou.
In Atene, all'epoca, aveva tutto il potere Pisistrato, ma era potente anche Milziade, il
figlio di Cipselo, che era di una oijkiva allevatrice di cavalli da quadriga, discendente da
Eaco e da Egina, ma ateniese più recentemente, dato che il primo ateniese di questa
oijkiva era stato Fileo, il figlio di Aiace.
Dato che abbiamo nominato gli Alcmeonidi, non possiamo non parlare anche dell'altro
"gruppo" che, in qualche modo, subito dopo la fine della tirannia ad Atene, contese il
potere con Clistene e con la sua, abbiamo visto, oijkiva: di esso non possediamo il nome,
semplicemente perché Erodoto non lo tramanda, ma sappiamo che (Hdt. V 66,1):
jAqh'nai ejou'sai kai; pri;n megavlai, tovte ajpallacqei'sai turavnnwn ejgevnonto mevzone", ejn de; aujth'isi duvo a[dre" ejdunavsteuon, Kleisqevnh" te ajnh;r jAlkmewnivdh", o{" per dh; lovgon e[cei th;n Puqivhn ajnapei'sai, kai; jIsagovrh" Teisavndrou oijkivh" me;n ejw;n dokivmou, ajta;r ta; ajnavkaqen oujk e[cw fravsai: quvousi de; oiJ suggeneve" aujtou' Dii; Karivwi.
Atene, che anche prima era potente, allorché fu liberata dai tiranni divenne ancora più
potente: in essa primeggiavano due uomini, l'Alcmeonide Clistene (che possiede fama di
aver corrotto la Pizia) e Isagora, figlio di Tisandro, che era di una oijkiva illustre, ma io
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
44
non sono in grado di dirne l'origine: i membri della sua stessa famiglia, però, sacrificano
a Zeus Cario.
Anche per il "gruppo" a cui faceva capo Isagora, dunque, Erodoto ricorre non al
sostantivo gevno", bensì allo ionico oijkivh. In un frammento del comico Eupoli (Eupol. fr.
117.4ss.) si parla, in chiave generica, degli strateghi ateniesi e si dice che essi
provenivano "dalle famiglie più importanti"; anche qui il termine utilizzato non è gevnh,
ma oijkivai:
ajll∆ h \san hJmi'n th'i povlei prw'ton me;n oiJ strathgoi; ejk tw'n megivstwn oijkiw'n, plouvtwi gevnei te prw'toi, oi|" wJsperei; qeoi'sin hujcovmesqa: kai; ga;r h\san.
Prima, invece, avevamo nella città gli strateghi,
provenienti dalle oijkivai più in vista, primi per ricchezza e nascita,
ai quali rivolgevamo preghiere come agli dei: e difatti lo erano.
Dobbiamo, dunque, prendere coscienza di un fatto sconosciuto alla linea storiografica ed
antropologica inaugurata dall'opera di Grote: nei documenti a nostra disposizione, dalle
tavolette micenee fino al V secolo, la parola gevno" non è mai utilizzata per indicare una
struttura sociale simile al clan. gevno", piuttosto, sembra essere una parola a cui si ricorre
per indicare dei gruppi sacerdotali (misterici nel caso dei Kerykes, mantici in quello
degli Iamidi): tali gruppi, tuttavia, non sembrano avere avuta alcuna influenza sulle
vicende storiche delle povlei" greche dell'età arcaica e classica. Quei gruppi aristocratici
che, invece, influenzarono in una misura sì grande la storia e la società delle povlei" di
quei periodi sembrano, se è possibile estendere il risultato di una simile ricerca
incentrata necessariamente su Atene a tutte le altre città greche, prendere il nome, nei
testi a nostra disposizione, di oijkivai, invece del supposto gevnh. Il gevno", così come
definito e descritto da Grote, sembra, piuttosto, una struttura confusa che ingloba, al suo
interno, sia i gevnh veri e propri, ovvero dei gruppi sacerdotali la cui più intima natura ci
sfugge (ad esempio gli Iamidi ed i Kerykes), sia le più generiche famiglie aristocratiche
che, di volta in volta, assumevano il potere nelle singole povlei", passando così
dall'oscurità alla storia: queste ultime, tuttavia, non sono veri e propri gevnh, bensì oijkivai.
Perciò, come gli Alcmeonidi ed i Filaidi di Atene, anche i Cleanattidi, gli Archeanattidi,
i Polianattidi ed i Pentilidi di Mitilene dovranno essere chiamati non già gevnh, ma
oijkivai.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
45
Le occorrenze della parola gevno" nel senso di clan sono, stranamente, ben più numerose
nel IV secolo che non nei periodi precedenti. Generalmente si è sempre sostenuto
(soprattutto Glotz, per cui v. supra) che la riforma clistenica avrebbe abolito i gevnh
creando, così, le necessarie premesse per l'instaurarsi di una società fondata su leggi da
tutti condivise: in questo quadro, il fatto che la parola gevno" nel senso tecnico sia più
attestata nelle opere del IV secolo, che non in quelle del VI e del V, non può che suonare
come una palese stranezza.
Nei testi del IV secolo la parola gevno" è attestata per indicare due tipologie diverse di
"gruppi": la famiglia reale74
e, ancora in quest'età, i gruppi sacerdotali: per quanto attiene
a questi ultimi, è significativo che due dei testi più importanti del IV secolo concernenti
in misura inequivocabile i gevnh si riferiscano proprio a due gruppi già nominati ed
individuati come gevnh nei documenti dei periodi precedenti a cui abbiamo accennato,
gli Eumolpidi75
ed i Kerykes76
.
Si dovrà, dunque, convenire che fino ai testi del IV secolo gevnh ed oijkivai sono
presentati come due tipologie ben diverse di "aggregazioni": gruppi sacerdotali i primi;
grandi, potenti e ricche famiglie aristocratiche i secondi. Donde sarà nata, invece, quella
confusione che ha portato gli storici e gli antropologi, soprattutto a partire da Grote, a
considerare entrambe dei gevnh o, addirittura, lo stesso tipo di entità? È evidente che in
questo fenomeno un ruolo di primo piano è stato giocato dalla comune etimologia dei
termini, latino e greco, gens e gevno". È possibile, tuttavia, pervenire ad un risultato ben
più preciso ed acuto nella nostra ricerca: sappiamo infatti che esiste un'opera precisa, tra
quelle a noi arrivate, in cui, a quanto sembra, per la prima volta gevno" ed oijkiva sono
tratteggiate come il medesimo tipo di aggregazione: essa è aristotelica, è la Costituzione
degli Ateniesi. Affinché avvenga questa confusione occorre, evidentemente, che un
"gruppo" precedentemente chiamato oijkiva divenga d'improvviso, nel linguaggio
74
Cfr. e.g. [Dem.] In Neae. 98 tou' gevnou" tou' basileivou. 75
Cfr. Bourriot 1976, 525ss. [Dem.] In Neae. 117ss. nomina un certo Archia accusato, davanti al
tribunale, di aver compiuto dei sacrifici in una modalità contraria alle regole; l'autore fornisce un'utile
informazione: il reo apparteneva al gevno" degli Eumolpidi (ou[koun deino;n to;n me;n kai; ejk gevnou" o[nta tou' Eujmolpidw'n "non sarà scandaloso il fatto che un uomo del gevno" degli Eumolpidi…"). 76
Cfr. Bourriot 1976, 527s. Eschine, nell'orazione Contro Ctesifonte (Aesch. III 17s.) rinfaccia a
Demostene il fatto di credere di non dover (e voler) essere sottoposto al famoso obbligo delle eujquvnai, cioè del rendiconto a cui ogni magistrato ateniese doveva sottostare dopo il termine del suo mandato;
l'oratore ateniese cita, come esempio, i sacerdoti e le sacerdotesse: anche essi venivano sottoposti a tale
obbligo e non solo come singoli individui, ma anche come membri di "gruppi sacerdotali", Eumolpidi,
Kerykes e quanti altri: kai; ouj movnon ijdivai, ajlla; kai; koinh'i ta; gevnh, Eujmolpivda" kai; Khvruka" kai; tou;" a[llou" a{panta".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
46
dell'autore, un gevno" (accettare il contrario, ovviamente, è impossibile, perché ciò
avrebbe condotto al risultato opposto): ciò è quanto accade non in uno solo, ma in ben
due passi della stessa opera. Quando Aristotele passa a narrare la situazione di Atene
dopo la caduta della tirannia, ovvero dell'ultimo rappresentante dei Pisistratidi, Ippia,
presenta, fin da subito, i due uomini che si contesero il primato, Isagora figlio di
Tisandro e l'Alcmeonide Clistene; ecco il testo aristotelico (Arist. Athen. XX 1):
kataluqeivsh" de; th'" turannivdo" ejstasivazon pro;" ajllhvlou" jIsagovra" oJ Teisavndrou fivlo" w]n tw'n turavnnwn, kai; Kleisqevnh" tou' gevnou" w]n tw'n jAlkmewnidw'n Rovesciata la tirannide, lottavano tra loro Isagora, figlio di Tisandro (che era amico dei
tiranni) e Clistene del gevno" degli Alcmeonidi.
Lo stesso avviene qualche capitolo dopo (Athen. XXVIII 2), dove il testo è abbastanza
simile a quello del passo precedente:
kataluqeivsh" de; th'" turannivdo" Kleisqevnh", tou' gevnou" w]n tw'n jAlkmewnidw'n, kai; touvtwi me;n oujdei;" h\n ajntistasiwvth", wJ" ejxevpeson oiJ peri; to;n jIsagovran. Rovesciata la tirannide, ci fu Clistene, del gevno" degli Alcmeonidi: e costui non ebbe
alcun avversario, dopo che andarono in esilio Isagora ed i suoi seguaci.
La Costituzione degli Ateniesi è dunque, la prima opera, nella storia della “letteratura
greca" in cui ci si riferisca agli Alcmeonidi come ad un gevno" invece che ad una oijkiva.
Tuttavia tutto ciò avviene, in Aristotele, esclusivamente per gli Alcmeonidi: tutti gli altri
capi politici in vista, invece, non vengono ricollegati ad alcun gevno"77.
4. Il contesto
Storia e società: l'isola di Lesbo fino al periodo di Saffo e di Alceo
I miti di fondazione
È utile, ai fini che ci proponiamo, poter ricostruire la storia dell'isola di Lesbo
cominciando proprio dalla sua epoca antichissima, che si perde nella notte dei tempi.
Prima della storia possiamo, ovviamente, usufruire solo delle narrazioni mitiche: nostra
fonte sarà un passo del libro quinto della Biblioteca storica di Diodoro Siculo (V 81-82).
L'isola, secondo Diodoro, fu colonizzata per la prima volta dai Pelasgi e l'"ecista", anche
se questo termine è forse qui improprio, fu un certo Xanto:
77
Cfr. Bourriot 1976, 556s.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
47
tauvthn ga;r th;n nh'son to; palaio;n w[ikhse pleivw gevnh, pollw'n metanastavsewn ejn aujth'i genomevnwn. ejrhvmou ga;r ou[sh" aujth'" prwvtou" Pelasgou;" katascei'n aujth;n toiw'idev tini trovpwi. Xavnqo" oJ Triovpou tw'n ejx [Argou" Pelasgw'n basileuvwn, kai; katascw;n mevro" ti th'" Lukiva" cwvra", to; me;n prw'ton ejn aujth'i katoikw'n ejbasivleue tw'n sunakolouqhsavntwn Pelasgw'n, u{steron de;• peraiwqei;" eij" th;n Levsbon ou\san e[rhmon th;n me;n cwvran toi'" laoi'" ejmevrise, th;n de;• nh'son ajpo; tw'n katoikouvntwn aujth;n Pelasgivan wjnovmase, to; pro; tou' kaloumevnhn [Issan.
Quest'isola nell'antichità la abitarono molte stirpi poiché molte furono le migrazioni lì
dirette. Quando ancora era deserta di abitanti, per primi i Pelasgi la occuparono in un
modo simile a questo: Xanto, figlio di Triopa che regnava sui Pelasgi provenienti da
Argo, dopo aver occupato una parte della Licia, dapprima, colà vivendo, regnava sui
Pelasgi che lo avevano seguito, ma poi, passato a Lesbo, che era deserta, divise la terra
tra le popolazioni e diede all'isola, che prima era chiamata Issa, il nome di Pelasgia,
derivandolo dal nome di coloro che l'avevano colonizzata.
Il nome del primo colonizzatore dell'isola è per noi significativo, in quanto presenta la
sequenza di fonemi –nq-: è, verosimilmente, un nome di origine anatolica e d'altronde
sono attestati molti idronimi simili nella regione: basti solo pensare a quello più famoso,
lo Xanto-Scamandro. La parola è di etimologia sconosciuta, ma è significativo che si sia
ipotizzata una qualche relazione con l'etrusco zamqic "aureo"78
.
La narrazione di Diodoro, comunque sia, continua:
u{steron de; geneai'" eJpta; genomevnou tou' kata; Deukalivwna kataklusmou' kai; pollw'n ajnqrwvpwn ajpolomevnwn, sunevbh kai; th;n Levsbon dia; th;n ejpombrivan ejrhmwqh'nai. meta; de; tau'ta Makareu;" eij" aujth;n ajfikovmeno", kai; to; kavllo" th'" cwvra" katanohvsa", katwvikhsen aujthvn. h\n d∆ oJ Makareu;" uiJo;" me;n Krinavkou tou' Diov", w{" fhsin JHsivodo" [Hes. Fr. 184 M.-W.] kai; a[lloi tine;" tw'n poihtw'n, katoikw'n d∆ ejn jWlevnwi th'" tovte me;n jIavdo", nu'n d∆ jAcai?a" kaloumevnh". ei\ce de;• laou;" hjqroismevnou", tou;" me;n [Iwna", tou;" d∆ ejx a[llwn ejqnw'n pantodapw'n sunerruhkovta". kai; to; me;n prw'ton th;n Levsbon katwvikhse, meta; de;• tau'ta ajei; ma'llon aujxovmeno" diav te th;n ajreth;n th'" nhvsou kai; th;n ijdivan ejpieivkeiavn te kai; dikaiosuvnhn ta;" suvneggu" nhvsou" katekta'to, kai; diemevrize th;n cwvran e[rhmon ou\san.
Sette generazioni più tardi, dopo che vi fu il diluvio all'epoca di Deucalione e molti
uomini morirono, accadde che anche Lesbo rimanesse deserta di uomini a causa
dell'inondazione. Poi, però, una volta giuntovi, Macare, dopo essersi accorto della
bellezza della regione, la colonizzò. Macare era figlio di Crinaco, il figlio di Zeus (come
affermano Esiodo ed altri poeti) e prima abitava ad Oleno della Iade, la regione che ora
si chiama Acaia. Con sé aveva gente raccolta qua e là, gli Ioni e gli altri confluiti da ogni
sorta di popoli. Dapprima Macare colonizzò Lesbo, ma dopo, crescendo sempre più di
potenza, per via della fertilità dell'isola e per la sua mitezza e giustizia, si impossessò
delle isole vicine e divise la regione che era deserta.
78
Cfr. Chantraine, DELG s.u., p. 763.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
48
Ecco, quindi, che compare nella nostra narrazione Macareo (o Macare): di questo re, la
cui storia è strettamente connessa con Lesbo, parla anche l'autore dell'Iliade: infatti, in Il.
XXIV 544 l'isola natale di Saffo, Alceo e Pittaco è definita Mavkaro" e{do", "sede di
Macare", ma è considerata sotto la sfera di influenza di Priamo. La genealogia di questo
personaggio è abbastanza complessa79
. Secondo una tradizione, Macare (o Macareo)
sarebbe stato figlio di Eolo e perciò gli abitanti di Lesbo, suoi discendenti, eolici: a
questa diretta discendenza divina sembra accennare l'ignoto autore dell'inno pseudo-
omerico Ad Apollo quando riprende in [Hom.] Hymn. ad Apoll. (III) 37 la tessera
omerica Mavkaro" e{do", aggiungendo, però, Aijolivwno"80; ma si tratta, qui, di un
unicum, perché ad una discendenza di Macareo da Eolo non accenna alcun altro autore,
ovviamente se si eslcude il periegeta Pausania, il quale riporta la notizia che un Macareo
figlio di Eolo sarebbe stato attivo nella Locride e sarebbe stato il padre di Anfissa, poi
eponima della città locrese81
. Come nota Diodoro, alcuni autori, segnatamente Esiodo82
,
conoscevano anche un'altra discendenza, cioè Macare (proveniente da Oleno in Acaia)
figlio di Crinaco e Crinaco figlio di Zeus83
. Inoltre, Diodoro, circa trenta capitoli prima
(V 57.2) aveva parlato anche di un Macare figlio di Elio e di Rodo, originario di Rodi,
ma che fuggì a Lesbo dopo aver ucciso il fratello Tenage: anche questa versione trova
riscontri alibi84
. Tra i figli di Elio e di Rodo viene nominato anche Triopa, forse il padre
79
Per la figura di Macare un'estesa ed utile silloge di testimonianze antiche è stata raccolta da Coppola
2005a con l'aggiunta di varie considerazioni. 80
[Hom.] Hymn. ad Apoll. (III) 37 Levsbo" t∆ hjgaqevh Mavkaro" e{do" Aijolivwno" "...e la sacra Lesbo,
sede dell'eolide Macare". E cfr. anche Paus. X 38.4 th'" Mavkaro" tou' Aijovlou. 81
Cfr. Paus. X 38.4 teqh'nai de;• th'i povlei to; o[noma ajpo; jAmfivssh" th'" Mavkaro" tou' Aijovlou fasi; kai; jApovllwna ejrasth;n genevsqai th'" jAmfivssh" "alla città è stato imposto il nome da quella
Anfissa figlia di Macare e si dice che anche Apollo fosse amante di Anfissa". 82
Hes. Fr. 184 M.-W.: è tratto dal Catalogo delle donne. Cfr. Mele 2005, 23. 83
Testimoni di questa tradizione sono, oltre al Catalogo esiodeo anche Scholia in Homeri Iliadem XXIV
544c: tine;" de; aujto;n Krinavkou tou' JUrãiÃevw" tou' Poseidw'no" kai; jAlkuovnh". ...e[ktise ga;r th;n Levsbon Mavkar oJ Krinavkou kai; ejbasivleusen aujth'". "Per alcuni è il figlio di Crinaco, figlio di Irrieo,
figlio di Poseidone e di Alcione. Al.ibidem : Infatti Macare fondò Lesbo e regnò su di essa". Anche D. H.
Ant. Rom. I 18,1 sembra accennare a questa genealogia, ma il testo presenta la specificazione patronimica
tou' Kriavsou e per correttezza di metodo non possiamo dare per certo che si tratti di una svista di qualche
copista poco accorto. 84
Cfr. Schol. In Pind. Ol. VII 132a Drachmann (=Hellan. FGrHist 4 F 137) JHlivou kai; JRovdh" (ou{tw ga;r aujth;n JEllavniko" kalei') eJpta; givnontai pai'de": [Ocimo", Kevrkafo", jAkti;", Mavkaro", Kavndalo", Triovph", Faevqwn oJ newvtero", o}n oiJ kata; th;n nh'son Tenavghn kalou'si. peri; de; tw'n ojnomavtwn aujtw'n diafwnou'si: pavnte" de; eJptav fasin aujtouv". "Di Elio e di Rode (così la chiama Ellanico) sette
sono i figli: Ochimo, Cercafo, Attine, Macaro, Candalo, Triope ed il più giovane Fetonte, che sull'isola
chiamano Tenage. Riguardo ad i loro nomi differiscono, ma tutti dicono che sono sette"; Diod. V 5.5 ei\nai de; tou;" eJpta; uiJou;" [Ocimon, Kevrkafon, Mavkara, jAkti'na, Tenavghn, Triovpan, Kavndalon, qugatevra de; mivan, jHlektruwvnhn, h}n e[ti parqevnon ou\san metallavxai to;n bivon. "i figli erano
sette: Ochimo, Cercafo, Macare, Attine, Tenage, Triopa, Candalo, ma aveva anche una figlia, Elettrione,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
49
di Xanto, il primo colonizzatore dell'isola, ma Triopa è anche il nome del figlio di
Perifante, figlio di Lapite, che per Diodoro, come tra poco vedremo, è, invece, il padre di
Lesbo. Secondo un'altra tradizione Macare sarebbe stato figlio di Licaone85
. A
complicare una situazione già di per sé insolubile, si aggiunge un ulteriore dato che la
sconvolge totalmente: Alc. 306Ea.21-22 Liberman fa venire Macare da Foloe e quindi si
tratta di un eroe di altra origine, "collocazione e genealogia"86
. Macare sembra, dunque,
essere l'ecista ed a questo contesto è riferibile anche D. H. Ant. Rom. I 18.1, anche se
Dionigi, a meno di prendere in considerazione l'ipotesi di un errore di qualche copista,
considera Macare figlio di un certo Criaso:
Skedasqevnte" (scil. oiJ Pelasgoi;) de; kata; th;n fugh;n oiJ me;n eij" Krhvthn ajph'lqon, oiJ de; tw'n Kuklavdwn nhvswn tina;" katevscon, oiJ de; ãth;nà peri; to;n [Olumpovn te kai; th;n [Ossan, kaloumevnhn de; JEstiaiw'tin w[ikisan, a[lloi de; ei[" te Boiwtivan kai; Fwkivda kai; Eu[boian diekomivsqhsan: oiJ d∆ eij" th;n jAsivan peraiwqevnte" th'" peri; to;n JEllhvsponton paralivou polla; cwriva katevscon kai; tw'n parakeimevnwn aujth'i nhvswn a[lla; te sucna;" kai; th;n nu'n kaloumevnhn Levsbon, ajnamicqevnte" toi'" ejk th'" JEllavdo" stevllousi th;n prwvthn ajpoikivan eij" aujth;n a[gonto" Mavkaro" tou' Kriavsou.
I Pelasgi, dispersisi durante la fuga, se ne andarono, alcuni a Creta, altri invece
occuparono alcune delle isole Cicladi, altri abitarono la zona intorno all'Olimpo ed
intorno all'Ossa, chiamata Estiotide, altri furono trasportati in Beozia, Focide ed Eubea.
Quelli che attraversarono fino all'Asia, occuparono molte terre della costa intorno
all'Ellesponto e, tra le molte isole che vi si trovavano, ne presero molte, tra le quali
anche quella che ora è chiamata Lesbo, dopo essersi mescolati a quelli che provenivano
dalla Grecia e che vi fondarono la prima colonia, al comando di Macare figlio di Criaso.
Si nota una differenza tra il racconto fornito da Diodoro e quello presente in Dionigi di
Alicarnasso: nella narrazione di Diodoro i Pelasgi colonizzano l'isola prima dell'arrivo di
che morì quando era ancora ragazza"; Nonn. Dionys. XIV 44-45 su;n Makarh'i kai; ajglao;" h[lasen Au[gh", / uiJeve" jHelivoio: "insieme a Macare e lo trascinò via lo splendido Auge, figli del Sole"; Schol. in
Homeri Iliadem XXIV 544c Mavkar oJ JHlivou kai; JRovdou, foneuvsa" to;n ajdelfo;n Tenavghn, ejkei'se ãajpÃwvikhse kai; povlin oijkivsa" ajpo; th'" gunaiko;" [Antissan wjnovmasen "Macare, figlio di Elio e di
Rode, dopo aver ucciso il fratello Tenage, andò là per colonizzare e, fondata una città, la chiamò Antissa,
dal nome della moglie". 85
Cfr. Apoll. Bibl. III 8.1 touvtou kai; th'" jWkeanou' qugatro;" Meliboiva", h] kaqavper a[lloi levgousi nuvmfh" Kullhvnh", pai'" Lukavwn ejgevneto, o}" basileuvwn jArkavdwn ejk pollw'n gunaikw'n penthvkonta pai'da" ejgevnnhse: ...Makareva ... "da lui e da Melibea, figlia di Oceano, o secondo altri
della ninfa Cillene, nacque un figlio, Licaone, che regnò sugli Arcadi e da molte mogli generò cinquanta
figli:…Macareo…"; Paus. VIII 3.1-3, che riporta il nome delle città fondate dai figli di Licaone e tra di
esse c'è anche una che porta il nome Macaria, evidentemente da Macare (o –eo). Cfr. anche Steph.
Byz.s.u. Makarevai, povli" jArkadiva", ajpo; Makarevw" tou' Lukavono". to; ejqniko;n Makareuv" kai; Makareavth". kai; Makariva. [kata; de;• JRwmaivou" Bevata.] to; ejqniko;n Makarieuv". "città
dell'Arcadia che trae il nome da Macareo, figlio di Licaone. L'aggettivo etico è macareo, macareate e
macaria. [Per i romani Beata]. L'etnico è macarieo." 86
Cfr. Mele 2005, 23.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
50
Macare, mentre nelle Antiquitates Romanae essi provengono dal Peloponneso e,
dispersisi, si uniscono poi alla spedizione di Macare(o) e vi si stabiliscano come
"coinquilini": le due tradizioni potrebbero provenire da due fonti diverse, o almeno da
due versioni della stessa narrazione.
Al di là delle differenze, centrale è, invece, la figura di Macare(o): ed a documentare
questo ruolo stanno alcuni passi che legano etimologicamente varie città dell'isola con la
discendenza di Macare(o)87
, ma al colonizzatore di Lesbo è attribuita, come ha ben
documentato Coppola (2005a, 81-86) anche la fondazione del tempio di Dioniso a
Brise/Brese, località, appunto, di Lesbo88
; la notizia è riportata da Androzione, citato
nell'Etymologicum Magnum s.u. Brisai'o" :
Brisai'o", ou{tw" oJ Diovnuso": kai; eij me;n dia; tou' i, para; to; brivzein ejsti;n, oJ oJrmhtikov": eij de;• dia; tou' h, ajpo; a[kra" Lesbiakh'" Brhvsh", h|" mevmnhtai jAndrotivwn: o{ti to; iJero;n tou' qeou' ejn th'i Brivshi fhsi;n iJdru'sqai uJpo; Mavkaro".
Briséo: così è (detto) Dioniso. E se è con lo iota sta per brizein, "colui che è impetuoso",
ma se è con l'eta, deriva dalla punta di Brese dell'isola di Lesbo, che rammenta
Androzione: dicono, infatti, che il santuario del dio a Brise sia stato edificato da Macare.
Del resto, tracce di una relazione sacrale tra Dioniso e la località lesbia si rintracciano in
alcuni epiteti di Dioniso, quali breiseuv"89, brhsagenhv"90
, brhssai'o"91, brhseuv"92
,
87
Per Ereso, città natale di Saffo, cfr. Hdn. III 1, 210.10 (= Steph. Byz. s.u.) [Ereso" povli" Levsbou ajpo; jErevsou tou' Mavkaro"."Ereso, città di Lesbo, dal nome di Ereso figlia di Macare". Per Metimna cfr.
Hdn. III 1, 256.33 Mhvqumna hJ Mavkaro" qugavthr ...kai; povli" ejn Levsbwi th'i nhvswi oJmwnuvmw" "Metimna la figlia di Macare…ed una città nell'isola di Lesbo con lo stesso nome"; Steph. Byz. s.u.
Mhvqumna, povli" ejn Levsbwi th'i nhvswi, ajpo; Mhquvmnh" th'" Mavkaro" qugatro;"“Metimna: città
sull’isola di Lesbo, che deriva il nome da Metimna figlia di Macare".Per Issa cfr. Hdn. III 1, 267.2 [Issa povli" ejn Levsbwi ajpo; [Issh" th'" Mavkaro" "Issa, una città nell'isola di Lesbo da Issa, figlia di
Macare"; Steph. Byz. s.u. [Issa, povli" ejn Levsbwi, klhqei'sa JImevra, ei\ta Pelasgiva kai; [Issa ajpo; th'" [Issh" th'" Mavkaro". "Issa: città sull'isola di Lesbo, chiamata poi Imera, poi Pelasgia, poi Issa, da
quell'Issa figlia di Macare". Per Antissa cfr. Hdn. III 1, 268.17-18 [Antissa: e[sti de; povli" Levsbou ...ajpo; th'" jAntivssh" th'" Mavkaro" qugatrov" "Antissa: è una città di Lesbo…da quell'Antissa figlia di
Macare". Per Agamede cfr. Hdn. III 1, 311.27 (= Steph. Byz. s.u.) jAgamhvdh tovpo" peri; Puvrran th'" Levsbou ajpo; jAgamhvdh" th'" Mavkaro" "Agamede, luogo nei pressi di Pirra di Lesbo da Agamede figlia
di Macare". Per Mitilene cfr. Hdn. III 1, 332.30 (= Steph. Byz. s.u) Mutilhvnh· povli" ejn Levsbwi megivsth. JEkatai'o" Eujrwvphi. ajpo; Mutilhvnh" th'" Mavkaro" h] Pevlopo" qugatrov". "Mitilene…è la
città più grande sull'isola di Lesbo. Ecateo (lo afferma) nell'"Europa". Da Mitilene, figlia di Macare,
oppure dalla figlia di Pelope". 88
Cfr. Steph. Byz. s.u. Bri'sa, a[kra Levsbou, ejn h|i i{drutai Diovnuso" Brisai'o" "Brisa: città di Lesbo
nella quale fu edificato il tempio di Dioniso Briséo". 89
SIG 851 90
IG12(2).478.2 91
Hsch. s.u. Brhssai'o": oJ Diovnuso" 92
CIG 3160 (Smyrna)
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
51
briseuv"93. E siamo anche a conoscenza di una tradizione che ritiene Macareo, o
comunque un suo omonimo, come sacerdote di Dioniso a Lesbo: Claudio Eliano, nella
sua Varia Historia (XIII 2), parla, appunto, delle turpi venture di questo personaggio94
.
Macar(eo) sembra, dunque, a Coppola, una figura legata al culto dionisiaco ed al tempio
sito a Lesbo.
Al di là della tradizione sul tempio dionisiaco, Macare(o) è conosciuto soprattutto come
ecista: ci sarebbe stata quindi, a quanto sembra, un'occupazione eolica dell'isola e
Macare(o) sarebbe stata la guida: come tra poco vedremo, quest'ultimo dato sembra in
aperta contraddizione con quanto Diodoro racconta poche righe dopo.
Sarebbe, però, Lesbo l'eroe eponimo, colui che dette il proprio nome all'isola. Scrive,
difatti, Diodoro nel prosieguo della narrazione (V 81.6-8):
93
Aristid. Or. 41(4).5; Macr. Sat. I 18.9. 94
Ael. V.H. XIII 2: Mutilhnai'o" ajnhvr, Makareu;" o[noma, iJereu;" tou' Dionuvsou, o{sa me;n ou{tw" ijdei'n pra'o" h\n kai; ejpieikhv", ajnosiwvtato" de;•ajnqrwvpwn ta; mavlista. xevnou de; h{konto" par∆ aujjto;n kai; dovnto" aujtw'i parakataqhvkhn crusivou plh'qo", ejn tw'i mucw'i tou' ajnaktovrou th;n gh'n diaskavya" oJ Makareu;" katwvruxe to; crusivon. crovnwi de; ajfikovmeno" oJ xevno" to; crusivon ajphvitei. o} de; eijsagagw;n e[ndon, wJ" ajpodwvswn, katevsfaxe, kai; to; crusivon ajnwvruxen, ajnt∆ aujtou' de; to;n xevnon katevqeto: kai; w[ieto, w{sper tou;" ajnqrwvpou", lanqavnein ou{tw kai; to;n qeovn. plh;n oujk ajphvnthse tau'ta tauvthi: povqen crovnou de; ojlivgou dielhluqovto", aiJ me;n tou' qeou' triethrivde" ajfivkonto, o} de; e[que megaloprepw'". kai; o} me;n peri; th;n bakceivan ei\cen, oiJ de; pai'de" aujtou', duvo o[nte", e[ndon ajpeleivfqhsan ejn th'i oijkivai, kai; mimouvmenoi th;n tou' patro;" iJerourgivan tw'i bwmw'i tw'i patrwviwi prosh'lqon e[ti kaiomevnwn tw'n ejmpuvrwn: kai; oJ me;n newvtero" parevsce to;n travchlon, oJ de;• presbuvtero" hjmelhmevnhn euJrw;n sfagivda to;n ajdelfo;n ajpevkteinen wJ" iJerei'on: oiJ de; kata; th;n oijkivan ijdovnte" ajnebovhsan. ajkouvsasa de; hJ mhvthr th'" boh'" ejxephvdhse, kai; qeasamevnh to;n me;n nekrovn, to;n de; katevconta e[ti th;n sfagivda hJimagmevnhn, scivzan aJrpavsasa tw'n ejk tou' bwmou' hJmivkauton, tauvthi to;n pai'da ajpevkteinen. h|ke de;•ajggeliva pro;" to;n Makareva, kai; ajpolipw;n th;n teleth;n, wJ" ei\ce su;n ojrgh'i kai; qumw'i ejsephvdhsen ej" th;n oijkivan, kai; tw'i quvrswi w|i katei'ce th;n eJautou' gunai'ka e[kteinen. e[kpusta ou\n ejgevneto ta; tolmhqevnta eij" pavnta", kai; sullhfqei;" oJ Makareu;" kai; streblouvmeno" wJmolovghsen o{sa ejn tw'i ajnaktovrwi e[drasen: ejn aujtai'" de; tai'" kolavsesi th;n yuch;n ajpevrrhxen... "un uomo mitilenese, di nome Macareo, sacerdote di Dioniso, almeno così a vederlo
mite e buono, ma era, al massimo grado, il più empio tra gli uomini. Giunto presso di lui uno straniero
che gli dette in deposito una gran quantità di oro, dopo aver scavato il terreno nel recesso del santuario,
Macareo vi seppellì l'oro. Tempo dopo giunse lo straniero a richiedere l'oro. Macareo, dopo averlo
condotto dentro, come se lo stesse riconsegnando, lo sgozzò e disseppellì l'oro, al posto del quale pose il
cadavere dello straniero. E pensò, così, di nasconderlo agli uomini ed al dio. Senonchè tutto ciò non
accadde così: perché? Trascorso poco tempo, giunsero le feste biennali del dio, ma egli fece riti
sacrificali con grande magnificenza. Ed egli si occupava della festa dionisiaca, ma i suoi figli, che erano
due, se ne stettero lontani, dentro casa, imitando il rito sacrificale del padre arrivarono persino a
bruciare sull'altare paterno le offerte sacrificali. Ed il più giovane offrì il collo, mentre il più anziano,
trovato il coltello sacrificale (che era conservato senza alcuna cura) uccise il fratello come se fosse la
vittima sacrificale. Quelli che erano dentro la casa, avendo visto, gridarono e la madre, udito l'urlo,
sobbalzò e, visto il cadavere e l'altro figlio che teneva ancora in mano il coltello insanguinato, afferrata
una freccia semisbruciacchiata dall’altare, con essa uccise il figlio. Giunse la notizia a Macareo e,
abbandonata la festa, poiché era oppresso dall'ira e dalla collera si precipitò d'un balzo alla casa e con il
tirso che possedeva uccise la moglie. Le azioni temerarie divennero, dunque, note a tutti e Macareo,
catturato e torturato, confessò tutte quante le azioni che aveva compiuto nel tempio. E nel corso delle
punizioni spirò...".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
52
kata; de;; touvtou" tou;" crovnou" Levsbo" oJ Lapivqou tou' Aijovlou tou' JIppovtou katav ti puqovcrhston met∆ oijkhtovrwn pleuvsa" eijj" th;n proeirhmevnhn nh'son, kai; ghvma" th;n qugatevra tou' Makarevw" Mhvqumnan, koinh'i katwvikhse, genovmeno" d∆ejpifanh;" ajnh;r thvn te nh'son Levsbon wjnovmasen ajf∆eJautou' kai; tou;" laou;" Lesbivou" proshgovreuse. Makarei' de;• qugatevre" ejgevnonto su;n a[llai" Mutilhvnh kai; Mhvqumna, ajf∆ w|n aiJ povlei" e[scon th;n proshgorivan. oJ de;• Makareu;" ejpiballovmeno" ta;" suvneggu" nhvsou" ijdiva" kataskeuavzein ejxevpemyen ajpoikivan eij" prwvthn th;n Civon, eJni; tw'n eJautou' paivdwn paradou;" th;n hJgemonivan: meta; de;•tau'ta eij" th;n Savmon e{teron ejxevpemye to;n ojnomazovmenon Kudrovlaon, o}" ejn tauvthi katoikhvsa" kai; th;n nh'son kataklhrouchvsa" ejbasivleuen aujth'": trivthn de;•th;n Kw' katoikivsa" ajpevdeixen aujth'" basileva Nevandron: eJxh'" d∆ eij" th;n JRovdon Leuvkippon ejxevpemye meta; sucnw'n oijkhtovrwn, ou}" oiJ th;n JRovdon katoikou'nte" dia; th;n spavnin tw'n ajndrw'n a[smenoi prosedevxanto kai; koinh'i th;n nh'son w[ikhsan.
A quei tempi Lesbo, figlio di Lapite, figlio di Eolo, figlio di Ippote, obbedendo ad un
oracolo pitico, insieme a dei coloni navigò verso l'isola di cui si è detto e, sposata la
figlia di Macare, Metimna, vi si stabilì insieme a lei; divenuto uomo illustre, chiamò
l'isola Lesbo dal nome di lui stesso e denominò la popolazione Lesbii. Tra le altre figlie
di Macare vi furono Mitilene e Metimna, dalle quali le città ebbero nome. Macare, nel
tentativo di far proprie le isole poste vicino, mandò una colonia prima a Chio, dopo aver
affidato il governo ad uno dei suoi figli; successivamente inviò a Samo un altro figlio,
chiamato Cidrolao, che dopo esservisi stabilito e aver diviso i lotti, divenne re. Dopo
aver colonizzato Cos come terza isola, designò re di essa Neandro; a seguire, mandò a
Rodi Leucippo insieme a molti coloni, che gli abitanti di Rodi volentieri accolsero per
via della scarsezza di uomini: ed insieme abitarono l'isola.
Lesbo, quindi, è l'eroe eponimo dell'isola ed anche per lui, come per Macare, Diodoro
presenta una genealogia eolica, cioè "Lesbo, figlio di Lapite, figlio di Eolo", ma questa
genealogia non sembra essere antica, perché tra i figli di Eolo non è attestato alcun
Lapite95
, così come tra i figli di Lapite, attivi in Tessaglia o in Elide, non è attestato
alcun Lesbo96
. Il motivo per cui l'isola abbia preso il nome da lui, così come le città
storiche di Mitilene e Metimna dal nome delle figlie di Macare è solo una delle tante
attestazioni di un tovpo" mitico abbastanza diffuso in tutto il mondo mediterraneo
antico: basti pensare, per esempio, alla città di Roma. Diodoro, quindi, sembra conoscere
entrambe le possibilità e tradizioni, ovvero Lesbo fondata da Macare e Lesbo eponimo
dell'isola e marito della figlia di Macar(eo), essa stessa eponima di Metimna. Se, dunque,
la genealogia di Lesbo come viene tratteggiata da Diodoro è un unicum, quale, o meglio,
chi è la fonte di Diodoro? Coppola (2005b, 155) ha notato che un dettaglio di
95
Secondo la tradizione, infatti, figli di Eolo sarebbero stati Atamante, Creteo, Sisifo, Salmoneo, Periere,
Dione, Magnete e Xuto. Cfr. Mele 2005, 16 (e nn. 16-31) e 22. 96
È lo stesso Diodoro (IV 69) a riferirci i nomi dei figli che Lapite ebbe da Orsinome, Forbante e
Perifante. Forbante era legato alla Tessaglia ed all'isola di Rodi; Diodoro (IV 58) menziona Triopa come
figlio di Forbante.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
53
toponomastica antiquaria è presente sia in Diodoro, sia in Strabone (I 3.19C); si tratta del
toponimo "Issa":
JH de;• [Antissa nh'so" h\n provteron, wJ" Mursivlo" fhsiv: th'" de;• Levsbou kaloumevnh" provteron [Issh", kai; th;n nh'son [Antissan kalei'sqai sunevbh: nu'n de;•th'" Levsbou povli" ejstivn.
Antissa prima era un'isola, come afferma Mirsilo: poiché l'isola di Lesbo era anticamente
chiamata Issa, accadde che anche l'isola fu chiamata Antissa; ora, invece, è una città di
Lesbo.
Strabone attribuisce questa informazione a Mirsilo di Lesbo, autore dei Lesbiaká: è
molto probabile che sia la fonte di entrambi gli autori, anche considerando che Plutarco
stesso alcune volte lo cita.
Poi l'isola venne, si accenna nell'Iliade, conquistata da Achille97
. Dopo la guerra di
Troia, subì la colonizzazione eolica ed i lesbii fondarono alcune città anche sulla costa,
come afferma Strab. XIII 1.38: w|n dh; kai; ktivsmatav eijsin aiJ plei'stai tw'n
katoikiw'n, aiJ me;n summevnousai kai; nu'n aiJ d∆ hjfanismevnai "la maggior parte
delle città (scil. della Troade) sono insediamenti dei colonizzatori: alcune rimangono
tutt'ora, altre sono scomparse". Tracce di essa si trovano nel nome di una delle oijkivai
lesbie protagoniste della storia del VII-VI sec. a.C., i Pentilidi che riprendono il nome da
Pentilo, il figlio illegittimo che Erigone diede ad Oreste, di cui si vantavano discendenti.
Erigone, secondo il mito, sarebbe stata figlia di Egisto e di Clitemestra, ma intorno alla
sua figura si sono diffuse tradizioni discordanti: secondo alcuni autori sarebbe stata
proprio lei ad accusare Oreste di fronte all'Areopago98
e poi si sarebbe tolta la vita alla
notizia della sua assoluzione99
; un'altra tradizione, invece, racconta che ella sposò100
97
Cfr. Il. IX 128-9 dwvsw d∆ eJpta; gunai'ka" ajmuvmona e[rga ijduiva" / Lesbivda", a}" o{te Levsbon eju>ktimevnhn e{len aujto;" "darò sette donne capaci di compiere impeccabilmente lavori / di Lesbo, che
quando egli stesso prese Lesbo ben costruita...": quasi le stesse parole vengono ripetute anche in Il. IX
269-71. 98
Cfr. Apoll. Ep. 6.25; Et. Magnum s.u. Aijwvra: Levgetai ga;r jHrigovnhn th;n Aijgivsqou kai; Klutaimnhvstra" qugatevra su;n Tundarevwi [tw'i pavppwi] ejlqei'n jAqhvnaze, kathgorhvsousan jOrevstou· "si dice, infatti, che Erigone, la figlia di Egisto e di Clitemestra, sia giunta ad Atene insieme a
Tindareo, [il nonno], per accusare Oreste". 99
Ditti Cretese, Bell. Tr. VI 4. 100
Cfr. Apoll. Ep. 6.28 aujto;" de; ghvma" JErmiovnhn, h] katav tina" jHrigovnhn, teknoi' ã...Ã "egli stesso
sposa Ermione o, secondo alcuni, Erigone, genera …", ma solo l'epitome vaticana (Vaticanus graecus
950, E) parla del matrimonio di Oreste e di Erigone: necessaria è l'integrazione di una lacuna perchè
l'epitomatore non riporta il nome di Pentilo. Lo schol. in Lycophronis Alexandram 1374 sembra seguire lo
stesso testo che E riassume: aujto;" de; ...e[ghmen JErmiovnhn, ejx h|" genna'i Tisamenovn. h] katav tina" jHrigovnhn ghvma" th;n Aijgivsqou Pevnqilon genna'i "egli stesso…sposò Ermione, dalla quale generò
Tisameno, oppure, secondo alcuni, avendo sposato Erigone, figlia di Egisto, genera Pentilo".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
54
Oreste e gli diede un figlio, Pentilo101
appunto. Pentilo ebbe due figli, Damasia102
ed
Echela; racconta, infatti, Paus. III 2.1:
Lakedaimovnioi...sunhvranto de;• kai; Gra'i tw'i jEcevla tou' Penqivlou tou' jOrevstou stellomevnwi nausi;n ej" ajpoikivan. kai; oJ me;n th;n th'" jIwniva" metaxu; kai; Musw'n, kaloumevnhn de;•Aijolivda ejf∆ hJmw'n, kaqevxein e[mellen: oJ dev oiJ provgono" Penqivlo" Levsbon th;n uJpe;r th'" hjpeivrou tauvth" nh'son ei|len e[ti provteron. Gli spartani parteciparono pure alla spedizione colonizzatrice di Gra, figlio di Echela,
figlio di Pentilo, figlio di Oreste, mandato con le navi a fondare una colonia. Ed egli
avrebbe occupato quella terra, tra la Ionia ed i Misi, chiamata da noi Eolide: e Pentilo,
suo nonno, ancor prima aveva conquistato Lesbo, isola posta davanti a questa parte del
continente.
Gra è, dunque, figlio di Echela(o)103
. Su questo evento decisivo per il futuro della
regione abbiamo anche un racconto più dettagliato in Strab. XIII 13.3.582, che fa
coincidere la migrazione-colonizzazione eolica con il ritorno degli Eraclidi: tevttarsi
ga;r dh; geneai'" presbutevran fasi; th;n Aijolikh;n ajpoikivan th'" jIwnikh'",
diatriba;" de; labei'n kai; crovnou" makrotevrou". jOrevsthn me;n ga;r a[rxai tou'
stovlou, touvtou d∆ ejn jArkadivai teleuthvsanto" to;n bivon diadevxasqai to;n uiJo;n
aujtou' Penqivlon, kai; proelqei'n mevcri Qravikh" eJxhvkonta e[tesi tw'n Trwikw'n
u{steron, uJp∆ aujth;n th;n tw'n JHrakleidw'n eij" Pelopovnnhson kavqodon: ei\t∆
jArcevlaon uiJo;n ejkeivnou peraiw'sai to;n Aijoliko;n stovlon eij" th;n nu'n Kuzikhnh;n
th;n peri; to; Daskuvlion: Gra'n de; to;n uiJo;n touvtou to;n newvtaton proelqovnta
mevcri tou' Granivkou potamou' kai; pareskeuasmevnon a[meinon peraiw'sai to;
plevon th'" stratia'" eij" Levsbon kai; katascei'n aujthvn: “Dicono che la
colonizzazione eolica abbia preceduto di quattro generazioni quella ionica, ma subì
ritardi e tempi più lunghi. Infatti fu Oreste il primo capo ma, dopo che costui morì in
Arcadia, suo figlio Pentilo gli successe ed avanzò fino alla Tracia sessanta anni dopo la
guerra di Troia, al tempo del ritorno degli Eraclidi nel Peloponneso. Poi Archelao, il
figlio di Pentilo, fece attraversare la spedizione eolica fino all'odierna Cizicene, vicino a
Dascilio. Il figlio più giovane di Archelao, Gra, giunse fino al Granìco ed essendo
101
Cfr. Paus. II 18.6: to;n de; jOrevstou novqon Penqivlon Kinaivqwn e[grayen ejn toi'" e[pesin jHrigovnhn th;n Aijgivsqou tekei'n. "quanto, invece, al bastardo di Oreste, Pentilo, scrisse Cinetone nei suoi versi che
lo generò Erigone, figlia di Egisto". 102
Cfr. Paus. V 4.3. 103
Cfr. anche Demon, FGrHist 327 F 17 = Schol. A in Eur. Rhes. 251 Schwartz kata; ãde;Ã th;n ejcomevnhn genea;n ãGra' tou' jEcevla tou'Ã Penqivlou... "nella generazione successiva <Gra figlio di Echela, figlio
di> Pentilo…" .
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
55
meglio equipaggiato fece attraversare alla maggior parte dell'esercito il mare fino a
Lesbo e la conquistò”.
Pausania sostiene che il figlio di Pentilo si chiamasse Echela, Strabone che si chiamasse
Archelao: sono, evidentemente, la stessa persona. Dal nostro punto di vista, incentrato
come è sull'isola di Saffo e di Alceo, è importante notare che per Strabone sarebbe stato
Gra, nipote di Pentilo, a colonizzare l'isola di Lesbo e non Pentilo stesso, come invece
affermava Pausania; è questa una versione condivisa anche da altre fonti104
.
104
Cfr. Schol. in Lyc. Alex. 1374 Scheer, dove si afferma anche che la colonizzazione fu decisa per via di
un oracolo: crhsmo;n e[labe stevllesqai eij" ajpoikivan: oJ de; suntavxa" ejk diafovrwn ejqnw'n laouv", ou}" ejkavlesen Aijolei'" dia; to; ejk poikivlwn tovpwn ei\nai, h\lqen eij" Levsbon: kai; aujto;" me;n tacu; ajpoqanw;n povlin ktivsai oujk hjdunhvqh: ajpovgono" de; touvtou kalouvmeno" Grau'" meta; r e[th ejkuriveuse th'" Levsbou kai; povlin e[ktise. […] ta; de;•peri; th'" ajpoikiva" th'" Levsbou JEllavniko" oJ Levsbio" iJstorei' ejn a Aijolikw'n. "intese che un oracolo li avviava alla colonizzazione. Egli, dopo
aver radunato popoli di origini diverse, che chiamò Eoli per il fatto di (essere provenienti) da luoghi
diversi, andò a Lesbo. Ed egli in breve tempo morì, non potè fondare la città. Tuttavia, un suo discendente
chiamato Graus dopo un centinaio di anni divenne signore di Lesbo e fondò la città. […]Ellanico di
Lesbo, nel primo libro degli Aioliká racconta delle vicissitudini della colonia di Lesbo". Lo scolio cita
come fonte il primo libro degli Aioliká e si comporta, quindi, allo stesso modo dello scoliasta di Schol. in
Pi. N. XI 43, di cui può essere considerato un'utile integrazione: ou|to" dev (sc. Peivsandro" Spartiavth"), fhsiv, su;n jOrevsthi ajpwvikhsen ejk Spavrth" kai; th;n Tevnedon katwvikhse: Tenevdio" ga;r oJ jAristagovra". peri; de; th'" jOrevstou eij" th;n Aijolivda ajpoikiva" JEllavniko" ejn tw'i prwvtwi [peri;] Aijolikw'n iJstovrhken. "Lo spartiate Pisandro, afferma, fece, partendo da Sparta, una
spedizione colonizzatrice insieme ad Oreste e colonizzò il Tenedo: di Tenedo è, difatti, Aristagora.
Ellanico narra nel libro primo degli Aioliká della colonia di Oreste nell'Eolide ". E cfr. anche FGrHist
327 F 17 = Schol. A in Eur. Rhes. 251 Schwartz Dhvmwn gou'n ejxhgouvmeno" [peri;] aujthvn fhsin [wJ"] u{steron tw'n Trwikw'n loimou' kai; fqora'" karpou' perielhluquiva" ãeij"à th;n JEllavda, manteuomevnwn peri; tw'n parovntwn, crh'sai th;n Puqivan thnikau'ta pau'lan aujtoi'" tw'n deinw'n, ejpeidavn tine" tw'n ajpo; jAgamevmnono" eJlkovntwn to; gevno" pleuvsante" eij" Troivan ta;" povlei" ktivswsi kai; ta;" tw'n qew'n tima;" ajnalavbwsin a}" hjfanivsqai sunevbainen uJpo; tou' polevmou. tauvthn th;n manteivan paradexavmenon to;n jOrevsthn sunevbh lipei'n to;n bivon. meta; de; jOrevsthn Teisameno;n labei'n th;n ajrch;n kai; met∆ ejkei'non Komh vthn. w|i crwmevnwi poi' devoi plei'n (kata; ga;r eujlavbeian kai; di;" kai; tri;" peri; tw'n aujtw'n ejpanerevsqai) ãuJpo;à tou' qeou' doqh'nai crhsmo;n ejpi; to;n e[scaton Musw'n plei'n. katoligwrhvsanta" de; pollou;" tw'n sunhqroismevnwn tou' crhsmou' ajfivstasqai kai; to;n Komhvthn katalipei'n mikro;n pefrontikevnai levgonta" aujtou' te kai; tou' Musw'n ejscavtou. kata; ãde;à th;n ejcomevnhn genea;;;n ãGra' tou' jEcevla tou'à Penqivlou pavlin sunageivranto" th;n stratia;n kai; tou' qeou' to;n aujto;n proenevgkanto" crhsmo;n dia; to; paravdoxon eij" paroimivan [dia;] tou'to peristh'naiv fasin. eijsi; de; oi} Thlevfwi genevsqai to;n crhsmo;n tou'ton: manteuomevnwi ga;r aujtw'i peri; gonevwn, ejpi; tivna" a]n tovpou" planhqei;" ejxeuvroi tou;" eJautou' gonei'", to;;n qeo;n prostavxai ejlqei'n ejpi; to;n e[scaton Musw'n. ajfikovmenon de; eij" th;n Teuqranivan (nevmesqai ga;;r ãtau'taà ta; cwriva tovte Musouv") ejpitucei'n th'i mhtriv. "Demone, invero, spiegandolo (sc. il proverbio dell'"ultimo dei Misi") dice che in seguito, essendosi
diffusasi una peste ed una corruzione della frutta in Grecia, i Troiani consultarono l'oracolo a riguardo
della situazione presente: la Pizia vaticinò in quella situazione una cessazione dei danni, poiché alcuni di
coloro che trascinavano la stirpe di Agamennone, dopo aver navigato fino a Troia, avrebbero fondato
città ed avrebbero ristabilito gli onori degli dei che erano stati deturpati dalla guerra. Accadde che
Oreste, accolto questo vaticinio, abbandonò la vita. Dopo Oreste, Tisameno prese il comando e dopo di
lui Comete. A costui fu vaticinato come dovesse compiere la traversata (con circospezione e due e tre
volte interrogò l'oracolo su questi argomenti), dalla divinità fu dato l'oracolo di navigare fino all'ultimo
dei Misi. Però, avendo molti dei soldati radunati trascurato del tutto l'oracolo, dicevano di allontanarsi e,
abbandonato Comete, di darsi ben poco pensiero di lui e dell'ultimo dei Misi. Nella generazione
successiva Gra figlio di Echela, figlio di Pentilo, dopo aver nuovamente radunato l'esercito, avendo il dio
riferito il medesimo oracolo dicono che, per la meraviglia, si rivolsero perciò al proverbio. Però vi sono
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
56
Precedentemente abbiamo accennato ai Lesbiaká di Mirsilo di Lesbo: ebbene,
quest'opera avrà narrato sicuramente anche della colonizzazione pentilide, se Plutarco,
nei Moralia (Soll. An. 36.984E = FGrHist 477 F 14 = FHG IV 459 fr. 12), cita Mirsilo di
Lesbo come sua fonte di una storia che va raccontando: si tratta della vicenda di Enalo,
un giovane che partecipò, al seguito dei Pentilidi, alla colonizzazione dell'isola e che,
innamoratosi della figlia di Sminteo, uno dei capi della spedizione, si gettò in mare per
salvarle la vita:
[Enalon de; to;n Aijoleva Mursivlo" oJ Levsbio" iJstorei', th'" Sminqevw" ejrw'nta qugatro;" rJifeivsh" kata; crhsmo;n th'" jAmfitrivth" uJpo; tw'n Penqilidw'n, kai; aujto;n ejxalovmenon eij" th;n qavlassan uJpo; delfi'no" sw'on ejxenecqh'nai pro;" th;n Levsbon. hJ de; pro;" to;n jIaseva pai'da tou' delfi'no" eu[noia kai; filiva di∆ uJperbolh;n e[rw" e[doxe: sunevpaize ga;r aujtw'i kai; sunenhvceto kaq∆ hJmevran kai; parei'cen ejn crw'i yauovmeno": e[peita peribaivnonto" oujk e[feugen, ajll∆ e[fere caivrwn, pro;" o} e[kampte klivnwn, oJmou' pavntwn jIasevwn eJkavstote suntrecovntwn ejpi; th;n qavlattan. Mirsilo di Lesbo racconta che l'eolide Enalo, innamoratosi della figlia di Sminteo che,
secondo un oracolo di Anfitrite, fu gettata in mare dai Pentilidi: costui fatto un balzo in
mare fu portato sano e salvo a Lesbo da un delfino. L'amicizia e la benevolenza del
delfino per il figlio di Iase, per via dell'esagerazione, sembrò amore: infatti giocava con
lui, di giorno lo frequentava e permetteva di essere toccato sulla pelle. Poi, quando gli
montava sopra non fuggiva, ma gioendo lo portava verso il luogo dove lo guidava
spostandolo, mentre gli Iasi accorrevano in massa al mare ogni volta che ciò accadeva.
Questo racconto, a metà strada tra la favola d'amore, la mitologia e la leggenda di
fondazione, doveva piacere particolarmente a Plutarco, se consideriamo che lo riporta
anche in un altro passo degli stessi Moralia, pur con qualche dettaglio in più; si tratta di
Septem Sapientium Conuium 19-20.163.a-d:
mevmnhmai de; kai; para; Lesbivwn ajndrw'n ajkouvsa" swthrivan tina; kovrh" uJpo; delfi'no" ejk qalavtth" genevsqai: ajll∆ ejgw; me;n oujk ajkribw' ta[lla, oJ de; Pittako;" ejpei; gignwvskei, divkaiov" ejsti peri; touvtwn dielqei'n. [Efh toivnun oJ Pittako;" e[ndoxon ei\nai kai; mnhmoneuovmenon uJpo; pollw'n to;n lovgon. crhsmou' ga;r genomevnou toi'" oijkivzousi Levsbon, o{tan e{rmati plevonte" prostuvcwsin o} kalei'tai Mesovgeion, tovt∆ ejntau'qa Poseidw'ni me;n tau'ron jAmfitrivthi de; kai; Nhrhivsi zw'san kaqei'nai parqevnon: o[ntwn ou\n ajrchgetw'n eJpta; kai; basilevwn, ojgdovou de;•tou' jEcelavou puqocrhvstou th'" ajpoikiva" hJgemovno", ou|to" me;n hjivqeo" h\n e[ti, tw'n d∆ eJpta; klhroumevnwn, o{soi" a[gamoi pai'de" h\san, katalambavnei qugatevra Sminqevw" oJ klh'ro". h}n ejsqh'ti kai; crusw'i kosmhvsante" wJ" ejgevnonto kata; to;n tovpon, e[mellon eujxavmenoi kaqhvsein. e[tuce dev ti" ejrw'n aujth'" tw'n sumpleovntwn, oujk ajgennh;" wJ" e[oike neaniva", ou| kai; tou[noma diamnhmoneuvousin [Enalon. ou|to" ajmhvcanovn tina tou'
anche quelli che (dicono) che questo oracolo fu dato a Telefo: ad egli che interrogava l'oracolo riguardo
ai genitori, avendo girovagato fino a quali luoghi li avrebbe trovati, il dio ordinò di andare all'ultimo dei
Misi. Giunto in Teutrania (questa terra a quel tempo l'abitavano i Misi) incontrò la madre".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
57
bohqei'n th'i parqevnwi proqumivan ejn tw'i tovte pavqei labw;n para; to;n kairo;n w{rmhse kai; periplakei;" oJmou' sugkaqh'ken eJauto;n eij" th;n qavlattan. eujqu;" me;n ou\n fhvmh ti" oujk e[cousa to; bevbaion, a[llw" de;•peivqousa pollou;" ejn tw'i stratopevdwi dihnevcqh peri; swthriva" aujtw'n kai; komidh'". uJstevrwi de; crovnwi to;n [Enalovn fasin ejn Levsbwi fanh'nai kai; levgein wJ" uJpo; delfivnwn forhtoi; dia; qalavtth" ejkpevsoien ajblabei'" eij" th;n h[peiron, e[ti d∆ a[lla qeiovtera touvtwn ejkplhvttonta kai; khlou'nta tou;" pollou;" dihgei'sqai, pavntwn de; pivstin e[rgwi parascei'n. kuvmato" ga;r hjlibavtou peri; th;n nh'son aijromevnou kai; tw'n ajnqrwvpwn dediovtwn, ajpanth'sai movnon th'i qalavtthi, kai; e{pesqai poluvpoda" aujtw'i pro;" to; iJero;n tou' Poseidw'no": w|n tou' megivstou livqon komivzonto" labei'n to;n [Enalon kai; ajnaqei'nai, kai; tou'ton [Enalon kalou'men.
Ricordo anche di aver ascoltato da uomini di Lesbo che il salvataggio di una fanciulla
dal mare avvenne grazie ad un delfino; ma io non posso riferire correttamente i vari
dettagli, mentre Pittaco, poiché li conosce, è giusto che racconti questi fatti.
Disse, dunque, Pittaco che era una storia famosa ed anche ricordata da molti. A
coloro che stavano per colonizzare Lesbo venne riferito un oracolo che quando, nel
corso della navigazione, si sarebbero imbattuti in uno scoglio chiamato "Mediterraneo"
ed allora lì in quel posto avrebbero dovuto gettare un toro in offerta a Poseidone ed una
vergine viva ad Anfitrite ed alle Nereidi. I comandanti della spedizione erano sette e(d
erano) re, ma l'ottavo era Echela(o), capo della colonia per volere dell'oracolo pitico:
costui era ancora celibe, mentre i sette, che avevano figlie non ancora sposate, tirarono a
sorte ed essa ricadde sulla figlia di Sminteo. Come furono davanti a quel luogo, dopo
averla adornata con una veste e dell'oro, non appena furono pronti a pregare, la gettarono
in mare. Accadde che uno di quelli che stavano compiendo la traversata sul mare un
giovane di origini, a quanto pare, non umili ed il cui nome ricordano, secondo la
tradizione, essere Enalo, fosse innamorato di lei. Costui, avendo concepito un desiderio
invincibile di salvare la fanciulla nella sua presente sventura, al momento decisivo fece
un balzo e, avendola abbracciata, si gettò in mare. Subito una diceria si diffuse che non
aveva alcuna prova sicura, ma non dimeno convinse molti nell'accampamento sulla loro
salvezza e sul loro salvataggio.Tempo dopo, dicono che Enalo apparve a Lesbo e
raccontò come fossero stati portati dai delfini attraverso il mare e come fossero andati a
finire indenni sulla terraferma, ma fatti ancor più miracolosi di questi riferì, fatti che
sbalordivano ed ammaliavano i più, ma tramite un'azione provocò la fiducia di tutti:
infatti, essendosi un'onda altissima sollevatasi sull’isola ed essendo tutti terrorizzati, egli
solo andò incontro al mare e lo seguivano fino al santuario di Poseidone dei polipi, il più
grande dei quali portava una pietra che Enalo prese e dedicò in quel luogo: e noi oggi lo
chiamiamo Enalo.
Questo racconto doveva essere piuttosto famoso, se è vero che lo raccontava, pur se con
qualche differenza, anche Anticlide Ateniese (FGrHist 140 F 4 = Athen. XI 466c ss.), un
autore dell'età dei diadochi:
jAntikleivdh" d∆ oJ jAqhnai'o" ejn tw'i iıV Novstwn peri; Gra' dihgouvmeno" tou' th;n ajpoikivan eij" Levsbon steivlanto" su;n a[lloi" basileu'si, kai; o{ti crhsmo;" h\n aujtoi'" dhlwvsa" kaqei'nai diaplevonta" tw'i Poseidw'ni eij" to; pevlago" parqevnon, gravfei kai; tau'ta: muqologou'si de;• [peri;] tw'n ejn Mhquvmnhi tine;" peri; th'" ajfeqeivsh" eij" th;n qavlassan parqevnou kai; fasi;n ejrasqevnta aujth'" tw'n hJgemovnwn tinav, w|i h\n tou[noma [Enalo", ejkkolumbh'sai boulovmenon ajnasw'sai th;n paidivskhn. tovte me;n ou\n uJpo; kuvmato" aujtou;" ajmfotevrou"
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
58
krufqevnta" ajfanei'" genevsqai, crovnwi d∆ u{steron h[dh th'" Mhquvmnh" oijkoumevnh" paragenevsqai to;n [Enalon kai; dihgei'sqai to;n trovpon, kai; o{ti hJ me;n parqevno" para; tai'" Nhrh'isi dievtriben, aujto;" de; ta;" tou' Poseidw'no" e[bosken i{ppou": kaiv pote [kai;] kuvmato" ejpiferomevnou megavlou sugkolumbhvsanta aujto;n ejkbh'nai e[conta kuvpellon crusou' ou{tw qaumasivou wJ" to;n par∆ aujtoi'" aujjtw'i paraballovmenon oujde;n diavforon ei\nai calkou'.' Anticlide Ateniese nel libro sedicesimo dei Ritorni raccontando la storia di Gra, colui
che portò la colonia a Lesbo insieme ad altri re, dice che c'era un oracolo che dichiarava
loro di gettare in mare, durante la navigazione, una ragazza come dono a Poseidone; egli
scrive anche le seguenti informazioni: alcuni degli abitanti in Metimna raccontano la
storia della fanciulla gettata in mare e dicono che uno dei capi della spedizione, il cui
nome era Enalo, che era innamorato di lei, volendo salvare la fanciulla, si tuffò dalla
nave. A questo punto entrambi furono nascosti da un'onda e scomparvero alla vista, ma
tempo dopo, quando Metimna era già abitata, apparve Enalo e riferì come avevano
vissuto quel tempo e che la fanciulla trascorreva il tempo presso le Nereidi, mentre lui
nutriva i cavalli di Poseidone; e quando una grande onda li trascinò via, vi si tuffò e
riemerse portando in mano una coppa fatta di un oro così meraviglioso che l'oro che era
presso di loro, paragonato con quello, non differiva per niente dal rame.
Escludendo i dettagli minori, la differenza tra la versione di Mirsilo riportata da Plutarco
nei due passi citati e quella di Anticlide riportata da Ateneo consiste in pratica nella
diversa guida a capo della spedizione, ovvero Echelao/Archelao per Mirsilo, Gra per
Anticlide: tra i due personaggi, come nota Coppola (2005b, 161) c'è una differenza
cronologica, per la precisione di una generazione: Gra, infatti, come abbiamo detto, è il
figlio di Echelao/Archelao. La versione tratteggiata da Anticlide (apud Ateneo) trova
sostegno nei passi precedentemente citati: abbiamo visto, infatti, che sia per Strabone,
sia per la letteratura scoliastica sopra citata (cfr. n. 104), è Gra ad aver colonizzato l'isola
e non Echela(o).
Il nostro excursus sulla tradizione leggendaria legata ai Pentilidi non è affatto fine a sé
stesso; i Pentilidi sono, infatti, in epoca storica un'importante oijkiva mitilenese: essi,
ovviamente, si ritenevano gli ultimi discendenti dei primi colonizzatori ed attraverso
questi ultimi anche dell'Atride Agamennone attraverso suo figlio, il matricida Oreste.
Sono i Pentilidi a fornirci l'appoggio per balzare dal mito alla storia.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
59
La storia
La caduta dei Pentilidi. I Cleanattidi al potere?
Legata ai Pentilidi è la prima notizia certa che abbiamo sull'isola: Arist. Pol. 1311 b 29
sgg. attribuisce la caduta dei Pentilidi a Megacle meta; tw'n fivlwn
oi|on ejn Mutilhvnhi tou;" Penqilivda" Megaklh'" periiovnta" kai; tuvptonta" tai'" koruvnai" ejpiqevmeno" meta; tw'n fivlwn ajnei'len, kai; u{steron Smevrdh" Penqivlon plhga;" labw;n kai; para; th'" gunaiko;" ejxelkusqei;" dievfqeiren ad esempio in Mitilene Megacle insieme ai suoi compagni assalendoli soppresse i
Pentilidi che andavano in giro e colpivano con delle mazze. E successivamente Smerdi,
dopo essere stato percosso e sottratto alla moglie, uccise Pentilo
Tra le due azioni compiute contro i Pentilidi, da Megacle prima e da Smerdi poi, deve
esserci stato un certo periodo intermedio, purtroppo per noi imprecisabile. Non
sappiamo chi fosse questo Megacle, ma Mazzarino105
, basando la sua ricostruzione sulla
presenza dell'etimo kleÛ- nella parte finale del nome, ha ipotizzato (e forse tale ipotesi
non è molto lontana dal vero) che si tratti di un membro dei Cleanattidi, che nelle fonti
sono presenti come attori principali nella storia della Lesbo del periodo successivo a
quello dei Pentilidi. Ignota per noi è anche l'identità di Smerdi106
. Il Pentilo ucciso da
Smerdi è, molto probabilmente, il padre di Draconte e di quella Pentilide che Pittaco
avrebbe sposato qualche tempo dopo107
. Il dato fondamentale, al di là dei dettagli che ci
sfuggono a causa della lontananza temporale, è la caduta dei Pentilidi, che da secoli
erano stati sovrani sull'isola, fondando il loro predominio sulla discendenza di sangue;
essi, tuttavia, non furono totalmente eliminati: ritroveremo appartenenti a questa dinastia
anche nei decenni successivi.
La turanniva di Melancro
Messi a tacere violentemente i Pentilidi, iniziano le lotte tra le varie oijkivai lesbie per il
predominio su Mitilene e sull'isola. Il periodo successivo vede la turanniva di Melancro,
probabilmente a capo dell'oijkiva cleanattide. L'avvento al potere dei Cleanattidi segna un
nuovo periodo nella storia della politica estera di Mitilene: la nuova oijkiva al potere
105
Cfr. Mazzarino 1943, 70 sgg. 106
Gallavotti 1948, 14-15 ritiene che si trattasse di un popolano. 107
V. Infra.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
60
stringe stretti rapporti commerciali con la vicina Lidia, come si evince da una famosa
ode di Saffo, il F 98 V. su cui torneremo.
Con la quarantaduesima Olimpiade (612-608 a.C.) inizia un periodo piuttosto turbolento,
ma decisivo nella storia dell'isola ed è indicativo il fatto che la Suida collochi a questa
data l'ajkmhv dei tre protagonisti: Alceo, Saffo e Pittaco. La Suida (s.u. Pittakov", v.
infra) data a questa Olimpiade due fatti decisivi, il primo dei quali è l'uccisione del
tuvranno" Melancro, che Diog. Laert. I 74 dice essere stata compiuta da Pittaco e dai
fratelli di Alceo (Antimenida e Kikis), se così può essere interpretato il giro di frase del
biografo:
ou|to" meta; tw'n jAlkaivou genovmeno" ajdelfw'n Mevlagcron kaqei'le to;n th'" Levsbou tuvrannon
costui (scil. Pittaco), alleatosi con i fratelli di Alceo, abbatté Melancro, il
tyrannos di Lesbo.
Si è, infatti, discusso se con queste parole Diogene Laerzio voglia indicare solo i fratelli
di Alceo, oppure anche Alceo con loro108
.
La guerra per il possesso del Sigeo
Come apprendiamo dal lemma della Suida, il nome di Pittaco è legato, almeno all'inizio,
al suo ruolo di comandante109
mitilenese nella guerra che vide opposte Atene e Mitilene
per il possesso del promontorio del Sigeo: il promontorio fu prima fortificato da un certo
108
Così pensa Gallavotti 1948, 17, traendo motivazioni dal fatto che Alceo, di lì a pochissimo tempo, non
sarebbe stato troppo giovane per partecipare alla guerra per il possesso del Sigeo tra Ateniesi e Mitilenesi.
L'opinione di Gallavotti è stata ripresa da Di Benedetto 1955 (ora in Di Benedetto 2007, II, 784) il quale
nota che, se a riguardo di uno dei fratelli di Alceo, Antimenida, siamo ben informati, sull'altro, invece,
ovvero Kikis, non sappiamo quasi niente. Di Benedetto arrivava persino a negare l'esistenza storica di
Kikis, basandosi su Etym. Gud. 322.5 dove si dice: oJ de; jAlkai'o", oJmoivw" JOmhvrwi to;n ijscuro;n kivkun kalei'. L'unica fonte che abbiamo sul nome del fratello di Alceo è Suida s.u. Kivki" (K1598): o[noma kuvrion. oJ ajdelfo;" jAlkaivou. Per Di Benedetto il testo di Diogene doveva essere, originariamente, il
seguente: meta; tw'n ajdelfw'n, jAlkaivou kai; jAntimenivda, genovmeno", poi corrotto. Non riteniamo vi
siano prove sufficienti per una simile argomentazione e dunque, in mancanza di testimonianze più certe, è
meglio accettare quello che sostiene il lessico bizantino. 109
Cfr. Strab. XIII 1.38 Pittako;" d∆ oJ Mitulhnai'o", ei|" tw'n eJpta; sofw'n legomevnwn, pleuvsa" ejpi; to;n Fruvnwna strathgo;n diepolevmei tevw" diatiqei;" kai; pavscwn kakw'" "Pittaco di Mitilene,
uno dei cosiddetti "Sette Sapienti", dopo aver navigato contro lo stratego Frinone, per un po' di tempo
porta avanti la guerra, male equipaggiato e con cattive consequenze"; Diog. Laert. I 74 kai; peri; th'" jAcileivtido" cwvra" macomevnwn jAqhnaivwn kai; Mutilhnaivwn ejstrathvgei me;n aujtov", jAqhnaivwn de;•Fruvnwn pagkratiasth;" jOlumpionivkh". "e quando gli Ateniesi e i Mitilenesi combattevano per il
possesso della regione dell'Achilletide, egli (scil. Pittaco) era generale, mentre degli ateniesi era Frinone,
vincitore nel pancrazio ad Olimpia".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
61
Archeanatte di Mitilene110
, ma poi fu occupato dagli Ateniesi al comando
dell'olimpionico Frinone111
, forse profittando della situazione caotica in cui versava
Mitilene. Le nostre fonti per la ricostruzione dei fatti sono, essenzialmente, Strabone
(XIII 38) ed Erodoto (V 94-95). Inutile dire che il possesso del Sigeo garantiva il
controllo degli scambi commerciali che avvenivano attraverso lo stretto del Bosforo. Le
truppe mitilenesi e quelle ateniesi erano poste, inizialmente, ad Achilleio ed a Sigeo112
e
poi mossero dalle loro rispettive basi di partenza. L'equilibrio della guerra dovette
“pendere” inizialmente dalla parte ateniese113
, al punto che Alceo fu costretto a gettare le
armi e fuggire. È a questo punto che si pone il famoso racconto della monomaciva,
secondo il quale Pittaco, dopo essersi accordato con Frinone di confrontarsi in singolar
tenzone, lo avrebbe sopraffatto con una rete e quindi ucciso114
. Il duello tra Pittaco e
Frinone, conclusosi con la morte di quest'ultimo, non fu, tuttavia, risolutivo e le due parti
in lotta dovettero ricorrere all'arbitrato di Periandro che stabilì che entrambe le parti
110
Cfr. Strab. XIII 1.38: jArcaiavnakta gou'n fasi to;n Mitulhnai'on ejk tw'n ejkei'qen livqwn to; Sivgeion teicivsai "comunque sia, dicono che Archeanatte di Mitilene abbia edificato il Sigeo con pietre
provenienti da lì (scil. Troia)". 111
Cfr. Strab. XIII 1.38 tou'to de;•katevscon me;n jAqhnai'oi Fruvnwna to;n ojlumpionivkhn pevmyante", Lesbivwn ejpidikazomevnwn scedovn ti th'" sumpavsh" Trwiavdo" "ma quel luogo lo occuparono gli
Ateniesi, avendo mandato Frinone, il vincitore ad Olimpia, sebbene i lesbii rivendicassero quasi tutta la
Troade"; Plut. Herod. Mal. 858a, per cui v. infra. 112
Cfr. Hdt. V 94 jEpolevmeon ga;r e[k te jAcillhivou povlio" oJrmwvmenoi kai; Sigeivou ejpi; crovnon sucno;n Mutilhnai'oiv te kai; jAqhnai'oi "infatti Mitilenesi ed Ateniesi, muovendo rispettivamente dalla
città di Achilleio e da Sigeo, combattevano per molto tempo". 113
Cfr. Strab. XIII 1.38 Pittako;" d∆ oJ Mitulhnai'o", ei|" tw'n eJpta; sofw'n legomevnwn, pleuvsa" ejpi; to;n Fruvnwna strathgo;n diepolevmei tevw" diatiqei;" kai; pavscwn kakw'" "il mitilenese
Pittaco, uno dei cosiddetti Sette Sapienti, dopo aver compiuto la traversata in mare contro Frinone,
condusse per un po' innanzi la guerra, disponendo di equipaggiamente non adeguato e subendo
avvenimenti sfavorevoli". 114
Cfr. Strab. XIII 1.38 u{steron d∆ ejk monomaciva", prokalesamevnou tou' Fruvnwno", aJlieutikh;n ajnalabw;n skeuh;n sunevdrame, kai; tw'i me;n ajmfiblhvstrwi perievbale th'i triaivnhi de;•kai; tw'i xifidivwi e[peire kai; ajnei'le. "successivamente, però, avendolo Frinone invitato a singolar tenzone,
dopo aver preso una rete da pesca corse incontro a lui e lo circondò con la rete, lo infilzò con un tridente
ed un pugnale e lo uccise"; Plut. Herod. Mal. 858a polemouvntwn ga;r jAqhnaivwn kai; Mutilhnaivwn peri; Sigeivou kai; Fruvnwno" tou' strathgou' tw'n jAqhnaivwn prokalesamevnou to;n boulovmenon eij" monomacivan, ajphvnthsen oJ Pittako;" kai; diktuvwi peribalw;n to;n a[ndra rJwmalevon o[nta kai; mevgan ajpevkteine: "Gli Ateniesi ed i Mitilenesi stavano combattendo per il Sigeo e Frinone, stratego
degli Ateniesi, avendo invitato a combattere in singolar tenzone chi volesse, si presentò Pittaco e, dopo
averlo circondato con una rete, uccise quell'uomo forte e grande"; Diog. Laert. I 74 sunevqeto dh; monomach'sai pro;" aujtovn: kai; divktuon e[cwn uJpo; th;n ajspivda laqraivw" perievbale to;n Fruvnwna, kai; kteivna" ajneswvsato to; cwrivon. "si accordò di combattere con lui in singolar tenzone e
poiché aveva una rete sotto lo scudo circondò Frinone e, dopo averlo ucciso, salvò la regione"; Polyaen. I
25 Pittako;" kai; Fruvnwn ejmonomavcoun Sigeivou pevri: e[doxen ajmfoi'n i[sa e[cein o{pla. ta; me;n dh; fanera; o{pla i[sa h\n. Pittako;" de;•uJpo; th'i ajspivdi kruvya" ajmfivblhstron peribavllei to;n Fruvnwna kai; rJaidivw" ejpispasavmeno" ktinnuvei kai; Sivgeion toi'" Lesbivoi" tw'i livnwi ejqhvreusen. "Pittaco e Frinone combattevano in singolar tenzone per il Sigeo: sembrò ad entrambi di avere armi
uguali e le armi manifeste erano uguali. Pittaco, però, avendo nascosto una rete sotto lo scudo, circondò
Frinone e, dopo averlo trascinato facilmente, lo uccise e con la rete prese Sigeo per i Lesbii".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
62
avrebbero mantenuto i possedimenti che avevano prima e perciò Sigeo passò agli
Ateniesi115
. Sembra comunque molto probabile che la guerra per il possesso del Sigeo si
sia protratta fino all'esimnetia di Pittaco a Mitilene116
.
Mirsilo al potere
Probabilmente in questo periodo Mirsilo, figlio di Cleanore, tentò di riportare i
Cleanattidi, in ombra dopo la morte di Melancro e durante lo scontro per il Sigeo, ai
vertici dello stato mitilenese: siamo scarsamente informati su queste manovre, ma
nondimeno Alceo le denuncia117
. Il nome di questo personaggio è chiaramente lidio118
e
con la Lidia, molto probabilmente, strinse dei legami politici. Pittaco invece,
contrariamente ad ogni aspettativa degli Alceidi, si allea proprio con Mirsilo. Il
tradimento di Pittaco sarebbe, quindi, da cercare nel fatto che il futuro esimnete lesbio
non volle proseguire la lotta contro Mirsilo e scese a patti con il nemico di sempre. Da
questo momento, quindi, Alceo prese in odio il figlio di Irra come fino ad allora aveva
odiato i Cleanattidi. Ecco, quindi, che Pittaco, da xevno" ed alleato che era, tradisce gli
115
Cfr. Strab. XIII 38 mevnonto" d∆ e[ti tou' polevmou Perivandro" diaithth;" aiJreqei;" uJpo; ajmfoi'n e[luse to;n povlemon "poiché la guerra perdurava, Periandro, scelto da entrambe le parti, pose fine allo
scontro"; Hdt. V 95 Mutilhnaivou" de;•kai; jAqhnaivou" kathvllaxe Perivandro" oJ Kuyevlou: touvtwi ga;r diaithth'i ejpetravponto: kathvllaxe de;•w|de, nevmesqai eJkatevrou" th;n e[cousi. Sivgeion mevn nun ou{tw ejgevneto uJp∆ jAqhnaivoisi. "Periandro, figlio di Cipselo, riconciliò Mitilenesi ed Ateniesi:
infatti si erano rivolti a lui come arbitro. E li riconciliò in questo modo, cioè che ciascuno mantenesse la
terra che aveva. Così Sigeo passò ora agli Ateniesi"; Diog. Laert. I 74 u{steron mevntoi fhsi;n jApollovdwro" ejn toi'" Cronikoi'" [FGrHist 244 F 27] diadikasqh'nai tou;" jAqhnaivou" peri; tou' cwrivou pro;" tou;" Mutilhnaivou", ajkouvonto" th'" divkh" Periavndrou, o}n kai; toi'" jAqhnaivoi" proskri'nai. "Successivamente, poi, dice Apollodoro nelle "Cronache", gli Ateniesi citarono in giudizio i
Mitilenesi riguardo a quella regione; giudice del processo era Periandro, il quale emise un verdetto a
favore degli Ateniesi". Gallavotti (1948, 19) fa rientrare tra le fonti di questo arbitrato anche Arist. Rhet. I
15.1375b 31 (oi|on jAqhnai'oi JOmhvrwi mavrturi ejcrhvsanto peri; Salami'no", kai; Tenevdioi e[nagco" Periavndrwi tw'i Korinqivwi pro;" Sigeiei'" "ad esempio gli Ateniesi, a proposito della questione di
Salamina si avvalsero di Omero come testimone e gli abitanti di Tenedo poc'anzi ricorsero a Periandro di
Corinto contro i Sigei"), ma a ben guardare sembra che Aristotele qui si riferisca ad un altro avvenimento
a noi ignoto. 116
Se così si possono interpretare il seguente passo: Val. Max. VI 5 (ext.). 1 Verum ne alienigenae
iustitiae obliti uideamur, Pittacus Mitylenaeus, cuius aut meritis tantum ciues debuerunt aut moribus
crediderunt, ut ei <suis> suffragiis tyrannidem deferrent, tam diu illud imperium sustinuit, quam diu
bellum de Sigeo cum Atheniensibus gerendum fuit "perché non sembriamo dimentichi della giustizia
straniera, Pittaco di Mitilene – per i meriti del quale tanto dovettero i suoi concittadini o ai costumi del
quale tanto si affidarono, da crearlo tiranno con il loro stessi suffragi – tenne quel potere per quanto a
lungo durò la guerra con gli Ateniesi per il possesso del promontorio Sigeo". 117
Cfr. Alc. 6 V.: Heracl. 5.7 riporta i primi tre versi dell'ode alcaica definendoli un'allegoria della
tirannide di Mirsilo. 118
Così Mazzarino 1943, 59 (e n.4); Gallavotti 1948, 24. Su questo argomento e, più in generale, sulla
politica filolidia dei Cleanattidi ritorneremo più oltre.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
63
Alceidi alleandosi con un Cleanattide ed ora, sposata una Pentilide119
, agli occhi di
Alceo, peda; Mursivlw davptei ta;n povlin (Alc. F 70.6-7V e cf. anche F 129.23-24
davptei ta;n povlin):
kh'no" de; pawvqei" jAtrei?da[.].[ daptevtw povlin wj" kai; peda; Mursiv≥≥[l]w≥[
ed egli, fattosi parente degli Atridi,
divori pure la città, anche insieme a Mirsilo
Dai frammenti di Alceo risulta evidente che Mirsilo andò in esilio o comunque cadde in
disgazia e che un certo Mnemone, legato da filovth" ad Alceo, gli offrì
un'imbarcazione per il ritorno120
in patria: non possediamo alcuna altra fonte che accenni
a questo evento, ma si è pensato che si tratti della stessa occasione che portò Pittaco ad
allearsi con Mirsilo ed a mandare in esilio gli Alceidi. Evidentemente gli Alceidi
avrebbero voluto continuare la lotta contro i Cleanattidi, uccidendo Mirsilo, ma
l'attentato contro il Cleanattide fallì ed anzi sortì un effetto contrario: Alceo dovette
andare, per la prima volta, in esilio, come ci informa un uJpovmnhma ad un carme alcaico
(schol. in Alc. 114.1ss.):
kata; th;n fugh;n th;n prwvthn [ej]pi; Mursivlon katask(eu)asavm(en)oi ejpiboulh;n oiJ peri; to;n jAlk[ai']on …, pri;n h] divkh[n] uJposcei'n e[fugon eij" Puvrran
119
V. infra. 120
La notizia è tratta da un frammento papiraceo (POxy. XXI 2306) di un commento antico ai carmi di
Alceo (F 305 a-b V.): al rigo 14 è presente una coronide sul margine sinistro ed il nuovo lemma sembra,
quindi, essere tratto dall'incipit di un nuovo componimento, diverso da quello precedentemente glossato.
Cfr. Porro 1994, 33-43. Ai nostri fini può essere utile riportare il testo:
s[oi;] ka[moi povlemo" mhvte gevnoit ≥[o]· gevgra- ptai prov" tina ojnovmati ka- louvmenon Mnhvmona o}" aj- kavtion parevsthsen eij" th;n Mursivlou kavqodon. fhsi;n ou\n o{ti oujk aijtia'tai aujto;≥[n] oujde;• diafevretai peri; to[uv]tou. Vorrei che tra te e me
guerra non fosse: è indirizzato
ad un tale di nome Mnemone, che
offrì un naviglio per il ritorno
di Mirsilo. Dice, dunque,
che non lo accusa, né
contende con lui per questo.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
64
durante il primo esilio, quando Alceo ed i suoi compagni, avendo organizzato una
congiura contro Mirsilo […] prima di subire il processo fuggirono a Pirra
Ecco che quindi, nei primissimi anni del VI sec. a.C., Alceo e gli Alceidi sono in esilio,
lontano da Mitilene: sappiamo, ad esempio, che uno dei due fratelli del poeta,
Antimenida, era impegnato in una campagna militare in Asia al séguito di
Nabuchadrezzar / Nabuchodonosor II contro Ascalona121
(604 a.C.: l'ode alcaica seguirà
di poco questa data) e questo potrebbe far presagire un allontanamento da Mitilene.
Intorno al 600 a.C. muore Mirsilo ed a questa data va ricondotto uno dei più famosi
carmi alcaici, il fr. 332 V. (=332 Lib.) preso a modello, come sappiamo, da Orazio122
:
nu'n crh' mequvsqhn kaiv tina pe;r bivan
pwvnhn, ejpei; dh; kavtqane Muvrsilo"... ora bisogna ubriacarsi e con forza
finanche bere, ché Mirsilo è morto
Alceo, quindi, può finalmente tornare a Mitilene, ma la situazione, ormai, non è più a lui
favorevole e forse non lo è più neanche per i Cleanattidi. Pittaco non era stato ancora
eletto aijsumnhvth", eppure in un frammento alcaico (141 V.) si dice che un uomo
concupisce to; mevga krevto": che si tratti dello stesso figlio di Irra è evidente da una
glossa (Fivttak[o") posta da uno scriba accorto123
. In questo periodo Alceo e gli Alceidi
sono, quindi, a Mitilene, ma poco dopo Alceo fu colpito da un secondo esilio e stavolta
da Lesbo furono allontanati anche i Cleanattidi, compresa la stessa Saffo, come si evince
dal Marmor Parium: sappiamo, infatti, che Pittaco fu eletto aijsumnhvth" non solo per
porre fine alla guerra che opponeva Ateniesi e Mitilenesi per il possesso del Sigeo
(guerra che, occorre ricordare, per quanto sappiamo non era mai stata interrotta), ma
121
Cfr. Strab. XIII 2.3 [Andra" d∆ e[scen ejndovxou" ...to;n poihth;n jAlkai'on kai; to;n ajdelfo;n jAntimenivdan, o{n fhsin jAlkai'o" Babulwnivoi" summacou'nta televsai mevgan a\qlon "Mitilene ha
avuto uomini famosi...il poeta Alceo ed il fratello Antimenida, che, afferma Alceo, raggiunse una grande
vittoria combattendo al fianco dei Babilonesi". Il passo è riportato tra le testimonianze sulla vita di Alceo
nell'edizione Campbell, cfr. Campbell 1982, 206-207 e 207 n. 4. E cfr. anche Alc. F 48 Lib.; 305 Lib.: il
secondo dei quali è riportato da Strabone nel prosieguo dello stesso passo. 122
Cfr. Hor. Carmina I 37.1: Nunc est bibendum…E cfr. Fraenkel, Horace 158-159; Nisbet-Hubbard
1970, 411. 123
Cfr. Alc. 141.3 V. w[]nhr ou\t[o" oj maiovmeno" to; mevga krevto" "l'uomo, costui che concupisce il
grande potere".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
65
anche per opporsi ad Alceo ed ad Antimenida fuoriusciti da Mitilene124
: questo significa
che Alceo era in esilio quando Pittaco fu eletto.
Cacciati i Cleanattidi e gli Alceidi, è probabile che Pittaco cercasse, in quella situazione,
l'aiuto dei Pentilidi, probabilmente la sola famiglia aristocratica di Lesbo che non era
stata contagiata dal lusso e dalle raffinatezze orientali; in questa chiave può essere letta
la sua politica matrimoniale: non bisogna dimenticare, infatti, che Pittaco sposa una
Pentilide, sorella di Draconte, figlio di Pentilo, secondo quanto afferma Diog. Laert. I
81: eujgenestevra ga;r aujtw'i ou\sa hJ gunhv, ejpeidhvper h\n Dravkonto" ajdelfh; tou'
Penqivlou "più nobile di lui, infatti, era la moglie, poiché era sorella di Draconte figlio
di Pentilo"125
.
Prima di passare all'esimnetia di Pittaco ed ai problemi cronologici è necessario
soffermarci sul ruolo del figlio di Irra e sulla sua politica; è illuminante, ai nostri fini, un
passo del geografo e storico Strabone (XIII 2.3):
Pittako;" d∆ei j" me;n th;n tw'n dunasteiw'n katavlusin ejcrhvsato th'i monarcivai kai; aujtov", kataluvsa" de;•ajpevdwke th;n aujtonomivan th'i povlei. Pittaco ricorse alla monarkhía per l’abbattimento delle dynasteîai e, dopo averle
annientate, restituì la libertà alla città.126
Lo stesso concetto è ribadito da Diod. Sic. IX 11.1:
{Oti Pittako;" oJ Mitulhnai'o" ouj movnon ejn sofivvai qaumasto;" h\n, ajlla; kai; polivth" ejgevneto toiou'to" oi|on e{teron oujk h[negken hJ nh'so", dokw' d joujd∆ a]n u{steron ejnevgkai, mevcri a]n to;n oi\non fevrhi pleivw te kai; hJdivw. nomoqevth" te ga;r ajgaqo;" uJph'rce kajn toi'" kata; mevro" pro;" tou;" polivta" koino;" kai; filavnqrwpo", kai; th;n patrivda triw'n tw'n megivstwn sumforw'n ajpevluse, turannivdo", stavsew", polevmou. Pittaco il Mitilenese non era oggetto di ammirazione solo per la sua saggezza, ma fu
anche un cittadino tale quale nessun altro l'isola produsse e neanche, io penso, potrà in
futuro produrre – fino a quando essa procuri vino in numero maggiore e più dolce. Infatti
egli fu un buon legislatore, affabile e gentile con i singoli cittadini; e liberò la patria
dalle tre più grandi disgrazie: la tirannide, il conflitto intestino e la guerra.
124
La nostra fonte è Arist. Pol. 1285 a 35 ss. oi|on ei{lontov pote Mutilhnai'oi Pittako;n pro;" tou;" fugavda" w|n proeisthvkesan jAntimenivdh" kai; jAlkai'o" oJ poihthv". "per esempio i Mitilenesi
scelsero Pittaco per combattere contro i fuoriusciti guidati da Antimenida e dal poeta Alceo". 125
A questa parentela nobile di Pittaco accenna di sfuggita lo stesso Alceo in un frammento qui già
riportato, cioè F 70.6 V. Se questa ricostruzione fosse giusta, il matrimonio tra Pittaco e la sorella di
Draconte dovrebbe essere, evidentemente, precedente alla sua esimnetia e cioè quando Mirsilo era ancora
vivo e, in qualche modo, spartiva con Pittaco il potere su Lesbo. Per i Pentilidi cfr. supra. 126
Nella traduzione ricorriamo ai termini greci per evitare di creare confusione con i significati e concetti
moderni portati da tali significanti.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
66
Pittaco, quindi, per porre fine ai conflitti tra le varie oijkivai lesbie e quindi al
permanente stato di guerra civile, di stavsi", ricorse all'aiuto dei Pentilidi ed ovviamente
del dh'mo", la ultime due componenti rimaste a Mitilene e sulle quali si poteva costruire
un periodo di pace e di stabilità, mentre mandò in esilio coatto le oijkivai che negli ultimi
anni si erano scontrate le une le altre per il predominio, ad esempio i Cleanattidi e gli
Alceidi seppur di quest'ultima egli fosse stato un tempo stretto alleato.
Pittakov" oJ aijsumnhvth"
L'inizio dell'esimnetia di Pittaco a Mitilene deve essere posta prima dell'arcontato di
Solone ad Atene del 594/593 a.C. (Olimpiade 46.3)127
: sappiamo, infatti, da Plut. Sol.
14.7, che quando il famoso legislatore ateniese arrivò al potere Pittaco governava già: ed
è significativo che Plutarco usi, proprio in questo contesto, l'avverbio nu'n "poco fa, or
ora". È verosimile128
porre l'inizio dell'esimnetia di Pittaco intorno al 598/597 a.C.
L'elezione di Pittaco ad aijsumnhvth" è salutata con disprezzo dallo stesso Alceo (F 348
V.) che lo chiama tuvranno"129 e non aijsumnhvth" :
to;n kakopatrivdaãnà Fivttakon povlio" ta;" ajcovlw kai; barudaivmono" ejstavsanto tuvrannon, mevgejpaivnente" ajovllee" ...quello, di stirpe ignobile,
Pittaco, d'una città indolente e gravata dalla volontà divina
fecero tiranno, avendolo tutti acclamato a gran voce
L'esimnetia di Pittaco volle significare la fine della lotta tra le oijkivai lesbie e
l'instaurazione di una pace fondata sul novmo" (Mazzarino 1943, 71). Le ricchezze e gli
aJbrav provenienti dall’oriente, principalmente dalla Lidia (v. infra), avevano aumentato
enormemente il lusso di cui si circondavano alcune famiglie di Mitilene: tra queste si
dovranno considerare, sicuramente, sia l’oijkiva cleanattide, sia quella del poeta Alceo130
.
Per limitare questa sperequazione tra nobili e le classi più povere i nuovi nomoteti
127
Per la cronologia della magistratura ateniese di Solone, che non rientra nell'argomento di questo lavoro,
cfr. Develin 1989, 37s. 128
Per il motivo di questa cronologia V. infra. 129
Del resto, come nota Mazzarino 2007, 193-194, tuvranno" non è un concetto costituzionale preciso, ma
è un termine popolare; ed esso assumeva connotazione negativa (soprattutto intorno all'anno 600) per la
violenza con cui si è impadronito del potere: "l'etica aristocratica greca, la quale si continua nell'etica
democratica, ha sentito l'aspetto negativo della violenza politica" della turanniva. 130
Cfr. Lombardo 1983, 1100; Mazzarino 2007, 193.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
67
intrapresero linee d’intervento volte contro l' aJbrosuvnh aristocratica ed i suoi eccessi131
:
ad esempio Solone, ad Atene, impose delle norme volte a diminuire il lusso e la pompa
dei funerali132
. Anche per quanto concerne Pittaco siamo a conoscenza di leggi simili: la
più famosa, proprio perché ad essa sembra riferirsi Saffo nell’Ode della mitra (Sapph.
98 a-b V.), proibiva i commerci con la Lidia che avevano contribuito ad aumentare
l’aJbrosuvnh delle aristocrazie mitilenesi133
.
E la documentazione al riguardo non si ferma qui. Siamo informati da Diog. Laert. I 76
su una legge in cui si regolamentava il ricorso al vino: Novmou" de;• e[qhke· tw'i
mequvonti, eja;n aJmavrthi, diplh'n ei\nai th;n zhmivan: i{na mh; mequvwsi, pollou'
kata; th;n nh'son oi[nou ginomevnou "stabilì leggi: per colui che è ubriaco, qualora
commetta una colpa, la pena sia raddoppiata: il fine era che non si ubriacassero, poiché
sull'isola vi era molto vino". Di leggi simili parlano anche altre fonti, non solo Diogene
Laerzio; si confronti, ad esempio, anche Arist. Pol. 1274b 19-23:
ejgevneto de;• kai; Pittako;" novmwn dhmiourgo;" ajll∆ ouj politeiva": novmo" d∆ i[dio" aujtou' to; tou;" mequvonta", a[n ti ptaivswsi, pleivw zhmivan ajpotivnein tw'n nhfovntwn: dia; ga;r to; pleivou" uJbrivzein mequvonta" h] nhvfonta" ouj pro;" th;n suggnwvmhn ajpevbleyen, o{ti dei' mequvousin e[cein ma'llon, ajlla; pro;" to; sumfevron. Anche Pittaco fu un creatore di leggi, ma non di una costituzione: una sua propria legge
riguardava gli ubriachi: se avessero commesso qualche danno, avrebbero scontato una
pena maggiore dei sobri: perché, infatti, sono maggiori coloro che compiono violenze in
stato di ubriachezza dei sobri, non si deve tenere in conto l’indulgenza, perchè occorre
averne in misura maggiore verso gli ubriachi, ma del conveniente134
.
Gli ultimi anni
Se sull'esilio di Saffo a Siracusa, ovvero nel lato opposto del mondo greco, abbiamo una
fonte ben precisa (il Marmor Parium), del secondo esilio di Alceo abbiamo, purtroppo
ben poche notizie e, in mancanza di informazioni più precise ed attendibili, possiamo
credere ad un supposto esilio in Egitto, a cui accenna il geografo e storico Strabone135
.
Tra i vari tentativi che gli Alceidi compirono per tornare a Mitilene, vi sarà stata anche
la famosa offerta che i Lidi fecero ad Alceo: duemila stateri per armare un esercito e far
131
Cfr. Lombardo 1983, 1100; Mazzarino 2007, 207. 132
Cfr. Plut. Sol. XXI 5-6; [Demosth.] In Macart. 62; Cic. De Leg. II 23, 25-26. 133
Cfr. Mazzarino 2007, 187; Mazzarino 1943, 44, 57ss. Troppo scettiche appaiono, al riguardo, le
opinioni di Page (1955, 102-103), accolte, come sembra, da Lombardo (1983, 1101 n. 107) 134
E cfr. Arist. E.N. 1113b 30-33, che parla di una legge simile in chiave generale, ovvero senza fare il
nome di Pittaco. E cfr. anche Thphr. fr. 97 Wimmer. 135
Strab. I 37 jAlkai'o", […] fhvsa" ajfi'cqai kai; aujto;" eij" Ai[gupton.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
68
ritorno sull'isola in cambio della loro futura collaborazione136
. Non sappiamo come
Alceo poté rispondere all'offerta fattagli dai Lidi e come si concluse quella vicenda, ma
forse non positivamente per gli Alceidi: il POxy. XXIX 2506 sembra, infatti, accennare
ad una partecipazione di Antimenida e di un Alceo ormai quarantenne ad una pro;" th'i
gefuvrhi paravtaxi", un combattimento presso il ponte e si fa menzione dei re Astiage
ed Aliatte: sembrerebbe un chiaro riferimento allo scontro, avvenuto nel 585 a.C. tra i
Medi di Ciassarre ed i Lidi di Astiage, narrato da Hdt. I 74: poiché vi si dice che Alceo
ed Antimenida sopravvissero e vi si parla di un terzo ritorno, allora è legittimo collocare
la morte di Alceo ben dopo tale data.
5. Pittaco
Problemi di cronologia
Fonte principale per la ricostruzione della vita di questo aijsumnhvth" è Diogene Laerzio
che gli dedica una parte della sua opera (I 74-79), in quanto considerato nell'antichità
uno dei "Sette Sapienti". Le informazioni che abbiamo sulla storia dell'isola non sono,
come possiamo vedere, molte ed i problemi nascono già quando ci accingiamo a
ricostruire la cronologia del personaggio. Secondo Diog. Laert. I 79, l'ajkmhv di Pittaco
sarebbe da porre nel corso della quarantaduesima Olimpiade (612-609 a.C.: è lo stesso
floruit di Saffo e di Alceo) e sarebbe morto sotto l'arcontato di Aristomene137
, nel terzo
anno della cinquantaduesima Olimpiade (570/569 a.C.), all'età di oltre settanta anni, ma
questi dati sono già in contraddizione tra loro in quanto, poiché l'ajkmhv di un
personaggio cade sui quaranta anni, Pittaco deve essere nato intorno al 650 a.C. e morto
non a settanta anni, ma ad ottanta: Jacoby, perciò, ha proposto di correggere nel testo di
Diogene in n' (=50) il nb' (=52). La correzione dello Jacoby trova riscontro nelle
informazioni che ci fornisce la Suida (P1659), che colloca la nascita di Pittaco
nell'Olimpiade 32a (652-649 a.C.):
Pittakov", Mitulhnai'o", uiJo;" Kaikou' h] JUrradivou Qraikov", mhtro;" de; Lesbiva". ou|to" gevgone kata; th;n lbV ojlumpiavda, ei|" kai; aujto;" tw'n zV sofw'n. e[graye novmou" kai; th'i mbV ojlumpiavdi Mevlagcron to;n tuvrannon Mitulhvnh" ajnei'le kai; Fruvnwna strathgo;n jAqhnaivwn polemou'nta uJpe;r tou' Sigeivou monomacw'n ajpevkteine, diktuvwi peribalw;n aujtovn. ghraio;" de; ajnagkazovmeno" strathgei'n
136
Cfr. Alc. 69 V. Zeu' pavter, Luvdoi me;n ejpa[scavlante" / sumfovraisi discelivoi" stav[thra" / a[mm∆ e[dwkan, ai[ ke dunavmeq∆ i[r[ / ej" povlin e[lqhn…"Zeus padre, i Lidi sdegnatisi / per le disgrazie duemila
stateri / ci han dato, se mai potessimo…in città andare". 137
Cfr. Develin 1989, 40.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
69
e[fh: wJ" calepo;n ejsqlo;n e[mmenai. touvtou ajpovfqegma, kairo;n gnw'qi. ejpoivhse de; kai; ejlegei'a e[ph cV, kai; uJpe;r novmwn katalogavdhn. Pittaco, Mitilenese, figlio di Kaiko o del trace Irradio, di madre lesbia. Costui nacque
nella trentaduesima Olimpiade e fu uno dei "Sette Sapienti". Stabilì delle leggi e nella
quarantaduesima Olimpiade abbatté Melancro tiranno di Mitilene ed uccise in duello,
gettandogli una rete addosso, lo stratego degli Ateniesi Frinone che combatteva per il
possesso di Sigeo. Da vecchio, essendo stato costretto a comandare, disse: "Come è
difficile essere virtuoso". Il suo motto è: "Riconosci il momento opportuno". Scrisse
anche seicento versi elegiaci ed opere in prosa riguardanti le leggi.
Le informazioni fornite dalla Suida e da Diogene sono molto simili (talvolta anche alla
lettera) e si potrebbe anche sospettare che lo sconosciuto autore del lessico bizantino
avesse davanti proprio le Vite di Diogene: se fosse così, la cronologia differente ed in
parte contraddittoria a cui si è accennato potrebbe essere un banale errore di un copista
poco accorto.
Diogene (I 75) fornisce anche altre tre importanti informazioni cronologiche: 1) che la
sua esimnetia durò dieci anni; 2) che, dopo aver deposto il potere, visse ancora dieci
anni; 3) che morì quando ad Atene era arconte Aristomene, nel terzo anno della
cinquantaduesima Olimpiade. Abbiamo già detto, però, che Pittaco non può essere morto
durante l’ Olimpiade cinquantaduesima, bensì durante la cinquantesima e questo perché,
in quel caso, sarebbe morto non a settanta anni, come dice Diogene Laerzio, ma ad
ottanta. Nelle liste degli arconti eponimi del periodo non figura il nome di un
Aristomene, ma abbiamo un vacuum per gli anni tra il 580/79 (Damasia?) ed il 577/6
(Archestratide) e per l'anno 570/569 a.C.: seguendo la cronologia diogeniana, che, come
abbiamo detto, è contraddittoria, Develin (1989, 40) assegna l'arcontato di Aristomene (e
quindi la morte di Pittaco) al 570/69 a.C., ma è più verosimile ritenere che Pittaco sia
morto nel 578/7 a.C. (Olimpiade cinquantesima) poiché, togliendo venti anni, cioè i
dieci di esimnetia e i dieci rimanenti, si può così ipotizzare che Pittaco sia entrato in
carica nel 598/597 a.C., una datazione, questa, che ben si adatta alle notizie che noi
abbiamo e soprattutto a quella fornita dalla biografia soloniana plutarchea: se tutto il
ragionamento fin qui sviluppato è corretto, Saffo, al momento dell'elezione di Pittaco ad
esimnete (ca. 598/7 a.C.), era già in esilio138
.
138
Infatti abbiamo già stabilito che l'esilio di Saffo da Mitilene, sul quale oggi non si può più avere dubbi,
deve essere avvenuto tra il 604 ed il 598 a.C., ma è anche possibile che i due avvenimenti siano in qualche
modo contemporanei e che anzi l'esimnetia di Pittaco abbia portato immediatamente all'esilio dei
Cleanattidi: forse perché questi ultimi erano in lotta con i Pentilidi? Cfr. supra.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
70
Pittako;" oj kakopatrivdai"
Intorno alla figura di Pittaco vi è stata, tra gli studiosi, un'accesa discussione. Per molto
tempo si è creduto che Pittaco fosse di origine plebea e che gli attacchi che Alceo rivolge
contro di lui nelle sue poesie si inquadrassero in un normale scontro tra classe
aristocratica al potere ed il dh'mo": questa opinione era fondata sul fatto che Alceo più
volte si rivolge a Pittaco chiamandolo kakopatrivdai": F 348.1sg.; 67.4; 75.12; 106.3.
Il primo ad andare contro la visione tradizionale, cioè che Pittaco fosse un plebeo139
, uno
schiavo o il figlio di uno schiavo fu Albrecht Von Blumenthal (1940, 125): per lo
studioso tedesco non era possibile che un plebeo o, addirittura, uno schiavo avesse
potuto sposare una donna nobile, come era la Pentilide sposa di Pittaco. Lo stesso
ragionamento fu portato avanti dal Mazzarino (1943): lo storico italiano notò che se
Pittaco fosse stato un plebeo difficilmente avrebbe potuto stringere un’alleanza in
funzione anti-Cleanattide con i fratelli di Alceo140
; eppure, proprio di una tale alleanza ci
parla Diog. Laert. I 4.74: ou|to" meta; tw'n jAlkaivou genovmeno" ajdelfw'n
Mevlagcron kaqei'le to;n th'" Levsbou tuvrannon "costui (scil. Pittaco), alleatosi con i
fratelli di Alceo, abbatté Melancro, tiranno di Lesbo". Chi era, quindi, Pittaco? Le fonti
in nostro possesso141
affermano che il padre di Pittaco, Hyrras, era di origine tracia e che
139
L'idea che Pittaco fosse un plebeo, o addirittura uno schiavo, sembrava dimostrata anche da alcune
testimonianze indirette, la più significativa delle quali è Carmina Popularia PMG 23.1-3: a[lei muvla a[lei: / kai; ga;r Pittako;" a[lei / megavla" Mutilhvna" basileuvwn."macina, mola, macina: / e infatti
anche Pittaco macina / che regna sulla grande Mitilene", citata dallo stesso von Blumenthal (1940, 125)
all’inizio del suo contributo. E cfr. anche Diog. Laert. I 81 touvtwi gumnavsion si'ton ajlei'n, w{" fhsi Klevarco" oJ filovsofo" [Wehrli III, fr. 71] "Per lui esercizio fisico era macinare il grano, come afferma il
filosofo Clearco"; Plut. Sept. Sap. Conu. 157e oJ me;n Qalh'" ejpiskwvptwn eu\ fronei'n e[fh to;n jEpimenivdhn o{ti mh; bouvletai pravgmata e[cein ajlw'n ta; sitiva kai; pevttwn eJautw'i, kaqavper Pittakov". "ejgw; gavr," ei\pe, "th'" xevnh" h[kouon douvsh" pro;" th;n muvlhn, ejn jErevswi genovmeno", [Carmina Popularia PMG 23.1-3, v. supra] "Talete disse con tono di scherno che Epimenide ebbe buon
senso perchè non volle avere dei problemi macinando il grano e cuocendolo per se stesso come Pittaco.
"Infatti io"- disse- "quando ero ad Ereso ascoltai la donna che mi ospitava cantare: [Carmina Popularia
PMG 23.1-3, v. supra]"; Clem. Alex. Paed. III 10.50.2 oJ Pittako;" ejkei'no", o{ti h[lhqen oJ Mitulhnaivwn basileu;" ejnergw'i gumnasivwi crwvmeno" "quel famoso Pittaco, re dei Mitilenesi, che
macinava, ricorrendo ad un esercizio fisico rinforzante". Come si può vedere, si tratta di passi ben più
tardi del personaggio in questione e quanto meno banalizzanti: si definisce Pittaco come "re",
attribuendogli una carica che non ha mai avuto. Mazzarino 1943, 67 n. 2 ritiene che l'attribuzione di
questo canto popolare ad una donna di Ereso (ma Mazzarino parla solo di Ereso e non nomina alcuna
donna) dimostrerebbe "l'interesse che l'esimnetia di Pittaco suscita nelle altre città dell'isola", ma non
crediamo si possa ricorrere con sì grande liberalità ad un carmen populare decontestualizzato per
dimostrare una simile ipotesi: forse Plutarco più che ad una donna qualsiasi, ha pensato alla più famosa
cittadina di Ereso, Saffo stessa. 140
L'opinione di Mazzarino venne accolta da Page 1955, 170 ed oggi nutre di un consenso unanime: si
veda, da ultimo, Lapini 2007, 168. 141
Cfr. Dur. FGrHist 76 F 75 = Diog. Laert. I 4.74 Pittako;" JUrradivou Mutilhnai'o". fhsi; de; Dou'ri" to;n patevra aujtou' Qra'ika ei\nai "Pittaco, figlio di Irradio, Mitilenese. Duride sostiene che suo padre
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
71
era diventato un basileuv" a Mitilene, cioè un capo aristocratico. Il futuro aijsumnhvth",
quindi, doveva discendere da una nobile famiglia tracia142
che intratteneva da tempo
saldi vincoli di xeniva con alcune famiglie aristocratiche lesbie, segnatamente con gli
Alceidi e, dopo, con i Pentilidi. Ad Hyrras sembra riferirsi Alc. F 72.7-10, mentre i versi
successivi al figlio Pittaco (probabilmente si accenna al fatto che la madre, al contrario
del padre, era di origine lesbia):
ejn[..].la[.].....[ lavbrw" de;•sun ste≥iv ≥[.]..[..]e≥i≥a≥p≥.. pivmpleisin ajkravtw [....]p∆ ajmevrai≥[ kai; nuvkti paflavsdei...acqen, e[nqa novmo" qavm∆ ejn.[.].[.].nhn. kh'no" de; touvtwn oujk ejpelavqeto 7 w[nhr ejpei; dh; prw'ton ojnevtrope, paivsai" ga;r ojnnwvrine nuvkta", tw; de; pivqw patavgesk∆ oj puvqmhn. 10 su; dh; teauvta" ejkgegovnwn e[chi" ta;n dovxan oi[an a[ndre" ejleuvqeroi e[slwn e[onte" ejk tokhvwn....;
furiosamente con…
colmano di vino puro…giorno
e notte ribolle…
dove è costume spesso…
ma quell'uomo non ha dimenticato questi
usi non appena ha cambiato condizione (?),
infatti per intere notti ha fatto baldoria
e risuonava il fondo della giara.
Ecco, tu che sei figlio di una tale madre hai
la fama quale hanno gli uomini liberi
nati da nobili genitori
Nei versi precedenti di questo frammento alcaico si parla dell'uso tracio di bere vino
giorno e notte143
(i greci, invece, lo bevevano solo a partire dal calar della sera144
) e poi
era trace"; Schol. Dion. Thr. 368.15 Hilgard JUrravdio"...oJ tou' {Urra" uiJov", {Urra" de; Mutilhnaivwn ejgevneto basileuv", ou| uiJo;" oJ Pittakov" "Irradio…il figlio di Hyrras. Hyrras divenne basileuv" tra i
Mitilenesi, il cui figlio era Pittaco". 142
In questo quadro è significativo che Pittakov" fosse, come afferma Thuc. IV 107.3, anche il nome di
un basileuv" edone ucciso prima che Brasida occupasse Mircino. 143
Su tali usanze del popolo tracio e, più in generale, di altri popoli bavrbaroi, ci informa un passo dei
Novmoi platonici (Plat. Leg. 637 d-e): e[ti ga;r ou\n ei[pwmen pleivw peri; aJpavsh" mevqh": ouj ga;r smikrovn ejstin to; ejpithvdeuma oujde;•fauvlou diagnw'nai nomoqevtou. levgw d∆ oujk oi[nou peri;
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
72
si parla di un uomo che ha cambiato stato (ojnevtrope). Un primo problema è costituito
dall'individuazione del referente di kh'no" w[nhr dei vv. 7-8: alcuni studiosi ritengono che si
tratti di Pittaco, altri di Hyrras. Mazzarino (1943, 43 n. 2) ritiene, basandosi su ]k≥o≥"
(Pitta]k≥o≥v" Diels) dello scolio a margine145
, che il kh'no" w[nhr sia Pittaco, ma questa
opinione oggi non è condivisa da nessuno e d'altronde ]k≥o≥", come nota lo stesso
Mazzarino, può benissimo essere integrato anche con Kai>]kov" che, come abbiamo visto,
era un altro nome con cui era conosciuto il padre di Pittaco. L'argomento più forte contro
questa ipotesi è, però, di ordine logico-grammaticale: se il kh'no" w[nhr fosse Pittaco, si
creerebbe un forte contrasto con il su; dh; successivo, che per tutti è da identificare con
Pittaco. Oggi, a partire da Lobel (1955, 173 e n. 2) gli studiosi146
ritengono che
"quell'uomo" che "non ha dimenticato questi costumi…" sia, invece, Hyrras, il padre
trace di Pittaco. Un secondo problema è costituito proprio dal verbo ojnevtrope, che
dovrebbe letteralmente essere inteso come "si è rivoltato, rovesciato, capovolto", ma il
significato è tutt'altro che chiaro (anche se non oscuro, anzi abbastanza comprensibile) e
l'uso intransitivo/riflessivo del verbo ajnatrevpw è poco attestato e, comunque, ben più
tardo147
: perciò s'intende questo verbo come un transitivo con oggetto sottinteso, ovvero
"ha capovolto, rigirato, rivolto sé stesso", da cui "ha cambiato la sua condizione, ha
migliorato sé stesso e/o la sua posizione". Se, dunque, il kh'no" w[nhr dei vv. 7-8 è
Hyrras, è meccanico inferire che il referente di su; dh; teauvta" ejkgegovnwn sia Pittaco
stesso, figlio di Hyrras.
povsew" to; paravpan h] mhv, mevqh" de; aujth'" pevri, povteron w{sper Skuvqai crw'ntai kai; Pevrsai crhstevon, kai; e[ti Karchdovnioi kai; Keltoi; kai; [Ibhre" kai; Qra'ike", polemika; suvmpanta o[nta tau'ta gevnh, h] kaqavper uJmei'": uJmei'" me;n gavr, o{per levgei", to; paravpan ajpevcesqe, Skuvqai de; kai; Qra'ike" ajkravtwi pantavpasi crwvmenoi, gunai'kev" te kai; aujtoiv, kai; kata; tw'n iJmativwn kataceovmenoi, kalo;n kai; eu[daimon ejpithvdeuma ejpithdeuvein nenomivkasi. "Allora parliamo ancora
un po' dell'ubriacatura in generale: infatti non è un'usanza dappoco e che non può essere studiata da un
legislatore incapace. Parlo, dunque, non in generale del bere o meno vino, ma della ubriacatura stessa, se
forse bisogna ricorrervi come gli Sciti, i Persiani ed anche i Cartaginesi, i Celti, gli Iberi ed i Traci,
popoli che sono tutti bellicosi, oppure come fate voi: voi infatti, come ho detto, ve ne astenete del tutto.
Invece gli Sciti ed i Traci, che ricorrono in ogni situazione al vino puro, uomini e donne, versandolo pure
sulle vesti, si sono convinti di praticare un'usanza bella e felice". 144
Cfr. Alc. 346.1 V. pwvnwmen: tiv ta; luvcn∆ ojmmevnomen; "beviamo: perché attendiamo le fiaccole?";
poi ripreso da Asclepiade in A.P. XII 50. 145
Come secondo, ulteriore argomento Mazzarino (l.c.) nota come il presente dei primi verbi del
componimento, cioè pivmpleisin...paflavsdei, ben si adatterebbe al periodo di Pittaco, contemporaneo di
Alceo, ma i primi versi potrebbero, invece, riferirsi, piuttosto che ad un periodo cronologicamente
determinato, ad una situazione generale ed astorica, ovvero al costume di un popolo (così anche Gallavotti
1948, 109). 146
Così riteneva anche, qualche anno prima del Lobel, Gallavotti 1948, 109. 147
LSJ riporta Plut. Quaest. Conu. 631C (slip, trip up, inciampare) e D.Chr. 32.34 (capsize, capovolgersi
di nave).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
73
Un ultimo problema lo crea teauvta" al v. 11 per il quale non abbiamo un diretto
referente nel testo a nostra disposizione e non può essere, certo, il soggetto della frase
precedente perché lì abbiamo un maschile e qui un femminile: si dovrà intendere,
dunque, come riferito ad un soggetto al femminile di cui si parlava, verosimilmente, nei
primi versi della composizione. Alceo sembra qui riprendere un'espressione omerica
che, però, LSJ riassume come "to be born of a father": in effetti tutte le attestazioni che
abbiamo si riferiscono ad un tino" al maschile148
, mentre qui abbiamo, a quanto
sembra, un femminile.
Che Pittaco non fosse un plebeo lo possiamo facilmente dedurre, definitivamente ed a
scanso d'equivoco, dagli ultimi versi di quest'ode, che suonano così: " tu che sei figlio di
una tale donna (?) hai / la fama quale hanno gli uomini liberi / nati da nobili genitori":
perciò Pittaco doveva essere nobile, o almeno considerato pari ad un nobile, altrimenti
non avrebbe avuto una pari dovxa. Abbiamo quindi, crediamo, due possibilità: o la nobiltà
era trasmessa a Pittaco dal padre, oppure dalla madre. Non risulta, invece, ammissibile
né che nessuno dei due lo fosse (altrimenti oggi di Pittaco non sapremmo niente), né che
lo fossero entrambi (altrimenti il giro di frase di Alceo non avrebbe ragion d'essere).
Poiché anche in Alc. F 303 Aa V. = Sapph. F 99 col. I.1-9 L.-P., si parla di usanze e di
atmosfere simili e poiché in quel frammento si attribuiscono, a quanto pare, ad un certo
Polianattide, Ferrari149
ha dedotto che costui debba essere Hyrras, il padre di Pittaco:
a
.].ga..eda bai'o≥[n ].a
d≥[.]oi' Pwluanakt[id]ais[ ...aissamiasi.i≥e.[.]to≥i"....[.] [] covrdaisi diakrev≥khn oj≥l≥i≥s≥b≥o≥dovko≥i≥s≥ãiÃper≥kaq....eno" ..ou.[..]si filof[rov]nw" []....d∆ejl≥elivsd≥[e]t≥ai pr.tanew" [ ]w≥n≥o" de; di∆ oj[stiv]wn≥ [ ] m≥uavl≥w d∆.[.]..e≥nh≥t≥e≥[..].c..
148
Cfr. Il. III 199 (= 418) JElevnh Dio;" ejkgegaui'a "Elena nata da Zeus"; V 637 keivnwn...ajndrw'n / oi} Dio;" ejxegevnonto "di quegli uomini / che nacquero da Zeus"; XX 231 Trwo;" d∆ au \ trei'" pai'de" ajmuvmone" ejxegevnonto "da Troo nacquero tre nobili figli"; Od. X 138 a[mfw (scil. Circe ed Eèta) d∆ ejkgegavthn faesimbrovtou jHelivoio "entrambe nacquero dal Sole che porta luce ai mortali" (al.). 149
Cfr. Ferrari 2007, 84-92.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
74
b
[Lavtw"] t≥e ka≥i; D≥i≥v[o"] pavi>[.] [ ]..e...[.] e[piq∆ojrgiva≥n[ [Gruvnhan] ujl≥wv≥d≥hãnà livp≥wn [ ].e≥n≥c≥rh≥[s]th≥vrion [ ].[ ].e≥umes≥[..].[.]wn [ ]....[.....] [ ]......a[..]e≥rai" t[ ] [ ]r≥sanon[.]..rgia≥n [ ]u≥somen [ ] [ ]n ujmne[ ] k≥a≥[ ]e≥na≥[.]fo.[...]n. ajdelfevan wj" pai[ ].io≥.[...].[ ] .utisde≥[...]kei≥.qe≥l≥h[ ] dei≥c≥n≥us[...]e dhu\te P≥w≥l≥ua≥n≥aktivdan to;n mavr≥gon≥ o[n≥d≥e≥ixa≥i≥ qevlw
…dopo poco…
…Polianattide/i…
…
fare risuonare sulle corde…
che accolgono l'olisbos…
amichevolmente con simile gente…
…vibra…
…attraverso le ossa…
… e poi che è dentro il midollo corre.
Di Latona e di Zeus figlio,
…vieni al rito,
Grinea boscosa lasciata …oracolo…
…
..
…
…
…
…cantare inno…
…sorella….
….
…
di nuovo…Polianattide/i
insolente voglio mostrare
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
75
Come ha acutamente mostrato Ferrari, questi due componimenti si ricollegano, per
tematiche e soprattutto per l'ambientazione, anche ad un altro carme alcaico, ovvero Alc.
F. 70.3-5:
ajquv≥rei pedevcwn sumposivw.[ bavrmo", filwvnwn ped∆ ajlem[avtwn eujwchvmeno" au[toisin ejpa[ suona prendendo parte al simposio...
la lira, insieme a sciocchi compagnoni
banchettando ad essi…
Nel prosieguo di questo componimento (da cui abbiamo già tratto una citazione per il
comportamento di Pittaco che ormai, agli occhi di Alceo, divora la città insieme a
Mirsilo) il poeta eolico si rivolge indirettamente a Pittaco. Purtroppo ci manca l'inizio,
per cui non possiamo ricostruire con esattezza l'ambientazione, ma il legame con Pittaco
è evidente. Ci viene in soccorso il F. 72 di Alceo, dove si ha la descrizione di una scena
simile: di questo frammento abbiamo già parlato ampiamente nelle pagine precedenti ed
abbiamo visto come Alceo si rivolga, dopo aver alluso alle consuetudini barbare di
Hyrras, negli ultimi versi, in un modo un po' oscuro per noi, allo stesso futuro esimnete.
Se, dunque, la ricostruzione di Ferrari è giusta il Polianattide di cui parla Alceo deve
essere Hyrras, il padre trace di Pittaco. Seppur le nostre fonti ed i dati a nostra
disposizione continuino ad essere piuttosto deboli ed oscuri, la ricostruzione proposta da
Fearrari sembra essere abbastanza verosimile.
Simili costumi sono attribuiti anche a Pittaco da Plutarco (Quaestiones Conuiuiales VIII
6.3.726B), dove si cerca di spiegare il significato di una parola con cui Alceo rinomina
Pittaco, zofodorpivda":
JO de; Swvklaro" uJperdikw'n tw'n neanivskwn 'ajll∆ oujde; to;n Pittakovn' e[fh 'zofodorpivdan oJ jAlkai'o" wJ" ojye; deipnou'nta levgetai proseipei'n, ajll∆ wJ" ajdovxoi" ta; polla; kai; fauvloi" hJdovmenon sumpovtai": to; mevntoi prwivteron deipnei'n o[neido" h\n pavlai, kai; to; ajkravtismav fasin ou{tw" levgesqai dia; th;n ajkrasivan.' Però Soclaro parlò come avvocato dei giovani: "ma si dice che Alceo chiamasse Pittaco
Che-cena-al-buio non perché cenasse tardi, ma piuttosto perché si compiaceva di
commensali oscuri e dappoco. Infatti, nei tempi antichi il cenare presto era causa di
rimprovero e dicono che l'akratisma ("colazione") è così chiamata per l'akrasia
("incontinenza").
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
76
Zofodorpivda" è un termine alcaico conosciuto anche da Diogene Laerzio, anche se
fornisce una spiegazione leggermente diversa. Inoltre Alceo, ci testimonia Diog. Laert. I
81 (=Alc. T 429), bollava Pittaco anche con altri termini non certo lusinghieri:
Tou'ton jAlkai'o" saravpoda me;n kai; savrapon ajpokalei' dia; to; platuvpoun ei\nai kai; ejpisuvrein tw; povde: ceiropovdhn de;• dia; ta;" ejn toi'" posi; rJagavda", a}" ceiravda" ejkavloun: gauvrhka de; wJ" eijkh' gauriw'nta: fuvskwna de; kai; gavstrwna o{ti pacu;" h\n: ajlla; mh;n kai; zofodorpivdan wJ" a[lucnon: ajgavsurton de; wJ" ejpisesurmevnon kai; rJuparovn.
Quest'uomo Alceo lo chiama saravpoda e savrapon ("piedi a scopa") perché aveva i
piedi larghi e li strascicava, ceiropovdhn ("piedi con mani") perché aveva ai piedi delle
ragadi che chiamavano "screpolature", gauvrhka ("vantone") in quanto si vantava a
sproposito, fuvskwna e gavstrwna ("trippone e pancione") perché era grasso; ma anche
zofodorpivdan ("quello che cena senza lucerna") perché cenava all'oscuro ed ajgavsurton ("sordido") perché era sciatto e sudicio.
I dati e le testimonianze sin qui passate in rassegna sembrano portare a concludere che il
padre di Pittaco fosse di origine trace, che si chiamasse Hyrras e che, in quanto figlio di
Polianatte, poteva essere chiamato anche Polianattide, ma a questa ricostruzione si
oppongono un'ode alcaica ed il relativo scolio, stiamo parlando di Alc. fr. 112.23-24:
]i≥ge Kleanaktivdan t(o;n) Mursivl(on)
] h] (jA)rceanaktivdan t(o;n) Fittak(ovn) Gli scoli a questa ode ci informano, quindi, che Mirsilo era membro dei Cleanattidi (il
sostantivo Kleanaktivdan sarà da interpretare o come un accusativo singolare, o come
un genitivo plurale).
Un problema più serio presenta, invece, il secondo verso. Le interpretazioni e le
conseguenti ricostruzioni operate dagli studiosi sono state varie. Il testo presenta
chiaramente una disgiuntiva e dobbiamo presumere che nella parte precedente del testo
vi fosse un altro patronimico; due sono le possibilità: 1) che la glossa t(o;n) Fittak(ovn)
identifichi l'Archeanattide e che quindi Pittaco fosse un Archeanattide, ma questa
possibilità lascia privo di glossa il primo patronimico ed inoltre le nostre informazioni su
Pittaco, come abbiamo appena visto, mal si conciliano con una tale identificazione; 2)
che la glossa t(o;n) Fittak(ovn) identifichi, invece, il primo corno della disgiuntiva e
lasci, invece, (jA)rceanaktivdan privo di una spiegazione. La seconda possibilità è da
preferire, soprattutto qualora si consideri il perché ( jA)rceanaktivdan sia lasciato privo di
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
77
glossa: una spiegazione verosimile è che non abbisognasse di un commento in quanto
era un nome proprio o, almeno, un patronimico già precedentemente glossato: ci viene in
aiuto una testimonianza presente negli scolii a Nicandro secondo la quale in un'ode
Alceo avrebbe raccontato che ad un certo Archeanattide ed ai suoi compagni sarebbe
apparso in sogno, al tempo della guerra di Lesbo contro Eritre, Apollo con in mano un
ramo di tamerice150
. D'altronde, sugli Archeanattidi abbiamo anche qualche altra
informazione: 1) un Archeanatte di Mitilene avrebbe fortificato il promontorio del Sigeo
con pietre prelevate dalle rovine di Troia151
, presumibilmente prima dello scontro tra
Pittaco e l'ateniese Frinone del 607/606 a.C.152
; 2) un citaredo Archeanatte di Mitilene è
ricordato in un'iscrizione delfica153
della fine del VI o dell'inizio del V sec. a.C.; 3) in un
frammento di un commentario ad un carme di Saffo (Sapph. T 213) viene chiamata
Archeanassa, in base all'oijkiva, una certa Pleistodica154
.
La prima possibilità fu, invece, fatta propria da Vincenzo Di Benedetto nel 1955 in uno
dei suoi primi contributi, Pittaco e Alceo155
. Di Benedetto identificava l'Archeanattide in
Pittaco e formulava, in quella occasione, altre considerazioni, oggi per lo più respinte
dagli altri studiosi: per lui Pittaco sarebbe l'Archeanattide e dunque il figlio di quell’
Archeanatte mitilenese che avrebbe fortificato il Sigeo. Di Benedetto ipotizzava,
basandosi su alcuni lemmi di lessicografi156
che parafrasano la parola uJrravdio" con
novqo", "bastardo", che Pittaco non sarebbe stato figlio di Irra, bensì di Archeanatte e che
anzi Irra non sarebbe mai esistito. È però anche possibile il procedimento opposto,
ovvero ipotizzare che queste parole rare siano state tratte dal nome del padre di
150
Schol. in Nic. Ther. 613 kai; jAlkai'ov" fhsin ejn ãaà toi'" peri; jArceanaktivdhn kata; to;n pro;" jEruqrai'on povlemon fanh'nai to;n jApovllwna kaq∆ u{pnon e[conta murivkh" klw'na. "E Alceo dice nel
primo libro che a coloro che stavano dalla parte dell'Archeanattide nel periodo della guerra contro Eritre
sarebbe apparso nel sogno Apollo che teneva in mano un ramo di tamerice". 151
Cfr. Strab. XIII 1.38: jArcaiavnakta gou'n fasi to;n Mitulhnai'on ejk tw'n ejkei'qen livqwn to; Sivgeion teicivsai "comunque sia, dicono che Archeanatte di Mitilene abbia edificato il Sigeo con pietre
provenienti da lì (scil. Troia)". 152
Nel racconto di Strab. XIII 1.38, infatti, i due avvenimenti sono posti proprio in questo ordine. 153
Cfr. Liberman 1999, II, 261: l'iscrizione è databile tra il VI sec. o alla prima metà del V e menziona,
appunto, un kiqarwido;" jArceavãnÃax (sic) Zwi?ou Mutilhnai'o". 154
Cfr. Ferrari 2007, 96-99. 155
Cfr. Di Benedetto 1955, 97-118; poi in Di Benedetto 2007, II, 771-789. 156
Cfr. Hsch. s.u. JUrravdio": ajpov tino" tw'n progovnwn, a[[doxo", h] eijkai'o". [Urra paidivon "Irradio:
da qualcuno di quelli nati prima, ignominioso, oppure volgare. Il figlio di Irra" (ma Di Benedetto non
teneva conto del prosieguo del lemma); s.u. surravd(i)o"· novqo". miktov". eijkai'o" "bastardo, misto,
ignobile"; s.u. uJravx:mivgdhn, ajnamivx "in modo mescolato, confusamente" . E cfr. anche Theogn. C. II. 23,
22 sgg. u{rrax, mivgdhn, ajnamivx: uJrravdio" progonivo" h] a[doxo":
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
78
Pittaco157
. Forse, contro questa identificazione potrebbe valere anche un'ulteriore
considerazione: nel testo precedentemente citato a riguardo di Archeanatte di Mitilene,
cioè Strab. XIII 1, 38, nel prosieguo si parla anche di Pittaco e della sua lotta contro
Frinone: se il geografo avesse conosciuto Archeanatte come padre o parente di Pittaco, li
avrebbe messi in qualche modo in relazione, specificando il tipo di parentela.
L’altro argomento su cui verte la discussione critica intorno all’origine di Pittaco è il
significato dell’aggettivo kakopatrivdai" usato da Alceo per lo stesso Pittaco.
Mazzarino (1943, 47sgg.) è arrivato alla conclusione che il termine kakopatrivdai"
venga usato da Alceo solo in riferimento all'origine tracia dello stesso Pittaco: Pittaco
sarebbe uno straniero di origine trace, ma perfettamente integrato nell'aristocrazia
mitilenese.
Rösler (1980, 186-191) ha supposto che il termine sia usato da Alceo come una denuncia
del carattere della politica di Pittaco, che prima era alleato degli Alceidi e poi li manda
in esilio alleandosi con il Cleanattide Mirsilo: d'altronde nella Silloge teognidea i kakoiv
sono coloro che, seppur nobili, si allontanano da un supposto codice di comportamento
aristocratico attraverso dei contatti con dei non nobili158
. Per Rösler, in sostanza, kakov"
sarebbe sinonimo di ponhrov".
Tuttavia, come nota giustamente Lapini (2007, 169-70), il termine kakov" è, però, ben
lontano da kakopatrivdai": Rösler, quindi, ha tenuto in conto solo la prima parte del
composto, ritenendo, indirettamente, secondario il resto.
L’osservazione di Lapini è stata fatta propria anche da Ferrari (2007a, 92-93) che ha
dato l’interpretazione più elastica possibile: “l’aporia probabilmente si spiega con la
tensione ideologica che doveva attraversare il mondo delle élites mitilenesi”, ovvero
Pittaco poteva essere ben voluto, sebbene non completamente greco, quando era alleato,
157
Così Liberman 1999, II, 220-21, n. 192: le glosse di Esichio "pourraient indiquer un sense greffé sur le
patronymique". 158
Cfr. e.g. Thgn. 305-308: Toi; kakoi; ouj pavnte" kakoi; ejk gastro;" gegovnasin,
ajll∆ a[ndressi kakoi'" sunqevmenoi filivhn e[rga te deivl∆ e[maqon kai; e[ph duvsfhma kai; u{brin
ejlpovmenoi keivnou" pavnta levgein e[tuma.
I cattivi non tutti lo sono dalla nascita,
ma tessendo amicizia con uomini cattivi
imparano cattiverie, bestemmie e prepotenze:
credono vero tutto ciò che essi dicono.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
79
ma tornare ad essere improvvisamente kakopatrivdai" quando, abbandonati gli Alceidi,
“si rese parente degli Atridi”.
Le Mariage du Tyran
Abbiamo già ricordato il matrimonio di Pittaco: egli, probabilmente per motivi poltici,
sposa una Pentilide, sorella di Draconte, figlio di Pentilo. Il fatto che un tuvranno"
sposasse una donna di un'altra oijkiva non deve affatto sorprendere: rientra, infatti, tra i
casi catalogati da Louis Gernet nel suo famoso contributo dal titolo quanto mai
indicativo, ovvero "Mariages de tyrans": "l'idée pouvait s'indiquer, d'elle-même, d'une
alliance à la fois politique et matrimoniale entre maisons [oggi diremmo oijkivai] de
tyrans"159
.
Gernet riportava un caso "assez instructif", ovvero la politica matrimoniale che viene
tessuta tra Gelone di Siracusa e Terone di Agrigento, i due tuvrannoi più potenti
dell'isola per assicurare "une paix constante". La nostra fonte principale è Timae.
FGrHist 566 F 93a (= Schol. In Pi. Ol. II inscr. p. 58, 12 Dr.): gevgraptai Qhvrwni
jAkragantivnwi a{rmati nikhvsanti th;n oıV ojlumpiavda: h\n de; oJ Qhvrwn to;
ajnevkaqen ajpo; Oijdivpodo". ejkhvdeuse de;•Gevlwni tw'i turavnnwi, dou;" aujtw'i th;n
qugatevra Dhmarevthn, ajf∆ h|" kai; to; Dhmarevteion wjnomavsqh novmisma. kai;
aujto;" de; oJ Qhvrwn th;n Poluzhvlou tou' ajdelfou' JIevrwno" qugatevra e[ghme, kaq∆
a{ fhsi Tivmaio". "è composta per Terone di Agrigento che vinse con il carro alla
settantaseiesima Olimpiade. Terone era discendente di Edipo. S'imparentò con il tiranno
Gelone, dandogli in sposa la figlia Demarete, con il nome della quale è chiamato anche
il demareteo, una moneta. E lo stesso Terone sposò la figlia di Polizelo, fratello di
Ierone, secondo ciò che dice Timeo".
Se dal punto di vista politico e sociale Pittaco non poteva che trarre effetti positivi da
questa unione matrimoniale con una Pentilide, lo stesso non si può, certo, affermare per
quanto riguardava il lato individuale e anche, per quanto possa sembrare una palese
contraddizione, anche esteriore. Questa ipotesi trova conferma nelle stesse parole di
Diogene Laerzio (I 81):
dokei' d∆ ejk diaqevsew" aujta; eijrhkevnai. eujgenestevra ga;r aujtw'i ou\sa hJ gunhv, ejpeidhvper h\n Dravkonto" ajdelfh; tou' Penqivlou, sfovdra katesobareuveto aujtou'.
159
L. Gernet, "Mariages de tyrans", in "Hommage a Lucien Febvre", Paris 1954; poi in Gernet 1968, 350
(da cui cito).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
80
Sembra che abbia detto tutto ciò160
basandosi sulla propria situazione: infatti, più nobile
di lui essendo la moglie, poiché era sorella di Draconte figlio di Pentilo, assai con
alterigia lo trattava.
Ecco che i Pentilidi ritornano sulla scena, ma con un ruolo decisamente secondario: il
Pentilo di cui parla Diogene Laerzio è, molto probabilmente, quello ucciso da Smerdi ed
a cui accenna Aristotele (cfr. supra). L'espressione "sorella di Draconte figlio di Pentilo"
invece della ben più semplice (ed attesa) "figlia di Pentilo" è sembrata prolissa: avrà,
dunque, ragione Lapini (2007, 167) nel ritenere che essa è dovuta al fatto che, essendo il
padre già morto, era il fratello a curare gli interessi della famiglia. Probabilmente
nell'antichità si saranno diffuse molte dicerie e molti aneddoti su questo matrimonio
certamente non ben assortito; uno di essi ci è stato tramandato da Plutarco (De
tranquillitate animi 471B):
oJ gou'n Pittako;" ejkei'no", ou| mevga me;n ajndreiva" mevga de; sofiva" kai; dikaiosuvnh" klevo", eiJstiva xevnou": ejpelqou'sa d∆ hJ gunh; met∆ ojrgh'" ajnevtreye th;n travpezan: tw'n de;•xevnwn diatrapevntwn 'eJkavstwi ti' e[fh 'hJmw'n kako;n e[stin: w|i de; toujmovn, a[rista pravttei.' Quel famoso Pittaco, la cui fama di coraggio, saggezza e giustizia fu grande, stava
intrattenendo a banchetto degli ospiti. La moglie, entrata in preda all'ira, rovesciò la
tavola: poiché gli ospiti si erano sgomentati, disse "Ognuno di noi ha qualche male, ma il
mio è di riuscire ottimamente".
Come nota anche Lapini (2007, 171), questo aneddoto è del tutto analogo (per non dire
identico) ad un altro, la cui protagonista è, tuttavia, la moglie di Socrate, Santippe (Plut.
De cohib. Ira 461 D):
'tou' de;•Swkravtou" ejk palaivstra" paralabovnto" to;n Eujquvdhmon hJ Xanqivpph met∆ ojrgh'" ejpista'sa kai; loidorhqei'sa tevlo" ajnevtreye th;n travpezan, oJ d∆ Eujquvdhmo" ejxanasta;" ajphviei perivlupo" genovmeno": kai; oJ Swkravth" 'para; soi; d∆,' ei\pen 'ouj prwvihn o[rni" ti" eijspta'sa taujto; tou't∆ ejpoivhsen, hJmei'" d∆ oujk hjganakthvsamen; '
un giorno, quando Socrate aveva accompagnato a casa Eutidemo che veniva via dalla
palestra, Santippe, dopo essersi posta in preda all'ira di fronte a loro e dopo averli
ingiuriati, alla fine rovesciò la tavola; Eutidemo, fattosi profondamente afflitto, dopo
essersi alzato, stava per andarsene e Socrate disse: "a casa tua l'altro giorno non volò un
uccello dentro e non fece lo stesso, ma noi non ci irritammo?"
160
Diog. Laert. I 80, citando un epigramma di Callimaco, riporta precedentemente un'opinione di Pittaco
sul matrimonio, in cui consiglia ad un giovane di condurre a nozze una ragazza della sua stessa condizione
sociale.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
81
Al di là dei problemi di attribuzione, se alla tradizione su Socrate o a quella sul meno
conosciuto Pittaco, è importante notare che entrambi i sapienti erano conosciuti
nell'antichità per la medesima sumforav, ovvero avere una moglie con modi di
comportarsi nettamente inadeguati rispetto al prestigio intellettuale del marito. E questa
tradizione sulla Pentilide moglie di Pittaco ben si adatta, è inutile dirlo, a quel famoso
frammento saffico161
in cui ad Andromeda (che si tratti di Andromeda lo testimonia
Ateneo) vengono rimproverati modi rozzi e poco fini.
6. Un'altra prospettiva: Saffo, Pittaco e la Lidia
Mirsilo e Kandauvlh", to;n oiJ {Ellhne" Mursivlon ojnomavzousi (Hdt. I 7)
Possiamo sintetizzare storicamente i rapporti economici e politici tra Lesbo e la vicina
Sardi in questo modo: prima dei Cleanattidi non vi erano scambi commerciali; i
Cleanattidi (l'oijkiva di Saffo) instaurano dei floridi rapporti commerciali con la vicina
Lidia; Pittaco, divenuto esimnete, spezza ogni legame e riporta una storica diffidenza
verso i non greci.
Che i Cleanattidi avessero avviato rapporti non solo commerciali, ma anche culturali con
i Lidi lo dimostra il fatto che un membro di questa oijkiva, Mirsilo, sembra avere un nome
lidio: Mursivlo" è il nome "greco" del leggendario re lidio Kandauvlh", figlio di
Muvrso"162; un nobile lidio morto nel 497 si chiamava Muvrso" oJ Guvgew163
e d'altronde
Muvrso" era anche il nome del padre del Candaule più famoso, stando ad Erodoto
l'ultimo re lidio di stirpe eraclide164
.
Un problema ulteriore lo crea, però, il testo di Erodoto (I 7: Kandauvlh", to;n oiJ
{Ellhne" Mursivlon ojnomavzousi, “Candaule, che i Greci chiamano Mirsilo”), da cui
sembrerebbe di evincere il contrario, ovvero che Mursivlo" fosse un nome greco165
. Il
primo nome, Kandauvlh", non è certo greco: esso ricorre in Ipponatte166
dove viene
161
Su quest'ode e su Andromeda in generale v. infra. 162
Cfr. Hdt. I 7 \Hn Kandauvlh", to;n oiJ {Ellhne" Mursivlon ojnomavzousi, tuvranno" Sardivwn, ajpovgono" de; jAlkaivou tou' JHraklevo". "era re di Sardi Candaule, che i greci chiamano Mirsilo,
discendente da Alceo di Eracle". 163
Cfr. Hdt. III 122; V 121. 164
Cfr. Hdt. I 7 Kandauvlh" de; oJ Muvrsou u{stato". […] mevcri Kandauvlew tou' Muvrsou. 165
Per questo passo cfr. Evans 1985. 166
Cfr. Hippon. fr. 2 D.2 = 3a W.
2: JErmh' kunavgca, mhionisti; Kandau'la, / fwrw'n eJtai're, deu'rov moi
skapardeu'sai. "Hermes Strozza-cani, in meonio Candaule, / compagno di ladri, vieni qui ad aiutarmi".
Cfr. Evans 1985, 231. E cfr. Tzetzes, Chil. V 482: to; de; kandauvlh" Ludikw'" to;n skullopnivkthn
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
82
caratterizzato come di origine meonia (Mhionisti;) e considerato corrispondente ad
Hermes "Strozza-cani"; l'equiparazione presentata da Ipponatte è supportata anche
dall'etimologia167
: difatti nel sostantivo sono chiaramente riconoscibili due radici, la
prima delle quali sarà, molto probabilmente, *kan- (per cui cfr. lat. canis), mentre l'altra
è da mettere in relazione all'antico slavo daviti (<*dhau-) "strangolare": la
corrispondenza con il greco ionico kunavgca è, dunque, perfetta. Del resto il kavndaulo",
il cui rapporto con il sostantivo Kandauvlh" è molto probabilmente motivato
dall'etimologia popolare, era un ricco piatto lidio di cui non esisteva una sola varietà,
ma, stando ad Ateneo, almeno tre168
. Che il culto di Kandauvlh" fosse, in un modo o in
un altro, legato ai sacrifici di cani lo dimostrano alcune terracotte trovate a Sardi169
,
soprattutto nell'area del mercato: precisamente si tratta di ventisei manufatti in ceramica
contenenti scheletri di piccoli animali, di essi ventitré provengono dall'area del mercato
ed undici di questi ultimi contengono proprio scheletri di cuccioli di cani: la
concentrazione e la quantità di oggetti simili o identici per contenuto porta a dedurre che
si tratti di una qualche forma di un rito religioso piuttosto comune, o comunque più volte
ripetuto. Un altro dato significativo di questo ritrovamento è il luogo: accanto a questi
reperti sono venuti alla luce anche alcuni graffiti (due strati, attribuibili circa al 650-625
a.C., il primo, mentre il secondo circa al 625-550 a.C.) per noi non comprensibili perché
scritti, molto probabilmente, non in lidio, bensì in cario, lingua ancora non decifrata:
Pedley (1974, 98) ha quindi dedotto da questi dati di diversa tipologia (archeologica,
lessicografica o, più generalmente, linguistica) che si tratti, molto verosimilmente, di
pratiche religiose e, più specificamente, sacrificali carie: Kandauvlh" sembra, dunque,
essere la divinità a cui erano destinate. Kandauvlh", dunque, era un nome sacro attribuito
al re lidio170
.
levgei, w{sper JIppw'nax deivknusi gravfwn ijavmbwi prwvtwi: [Hippon. fr. 2 D.
2 = 3a West
2; v. supra]
"Nella lingua lidia lo strangola-preda si dice kandaylēs, come mostra Ipponatte componendo il primo
libro dei giambi". Cfr. Hesych. K643 Kandauvla": JErmh'" h] JHraklh'". Cfr. Gusmani 1964, 274. 167
Cfr. Chantraine, DELG s.u. Kandauvlh", kavndaulo", p. 491. Così anche Evans 1985, 231. 168
Cfr. Gusmani 1964, 274. Cfr. Athen. I 9a; IV 132f.; IV 172b; XII 516d kai; kavndaulon dev tina e[legon oiJ Ludoiv, oujc e{na ajlla; trei'": "ed i Lidi chiamavano un certo piatto kandaulos, del quale ci
sono tre varietà e non una". E cfr. anche Hesych. K646.1-2: kanduvlo": dia; lagwvwn kai; gavlakto" kai; turou' kai; mevlito" pevmma ejdwvdimon "kandylos: manicaretto commestibile composto da pezzetti di
carne di lepre, latte, formaggio e miele". 169
Cfr. Pedley 1974, 97-98. 170
Di un “sacral name for the king” parla Evans 1985, 231, ma cfr. anche Pedley 1974, 98.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
83
Se dunque Kandauvlh" è un nome anatolico, quindi non greco, tanto più lo sarà anche
Mursivlo", ma a questo riguardo crea non pochi problemi la frase di Erodoto sopracitata:
Hdt. I 7 Kandauvlh", to;n oiJ {Ellhne" Mursivlon ojnomavzousi, “Candaule, che i Greci
chiamano Mirsilo”, da cui sembrerebbe di evincere il contrario, ovvero che Mursivlo"
fosse un nome greco171
: come, giustamente, osserva Evans (1985, 230) l’espressione to;n
oiJ {Ellhne" Mursivlon ojnomavzousi attesta l’esistenza di una “Greek story about
Candaules in which Candaules he is given the name “Myrsilus””, ma di questa “story”
non abbiamo alcuna traccia, sebbene il racconto di Gige e Candaule venga tramandato
anche da altre fonti: Plat. Resp. II 359c-360b non fornisce il nome di Candaule/Mirsilo e
Nic. Dam. 90 F 49 FGrHist lo chiama (S)adiatte. E tuttavia non si vede il motivo per il
quale i lidi lo avrebbero chiamato in un modo ed i greci in un altro: è più verosimile che
il nome fosse lo stesso, ma che i greci, per via di parlare una lingua diversa, lo
storpiassero un po’, sì da diventare, in greco, Mursivlo".
Per Mursivlo", infatti, si può ipotizzare un'origine ittita, ma per comprendere il
significato e la diffusione di questo antroponimo occorre un breve excursus di linguistica
anatolica. Nelle lingue anatoliche si trovano tracce davvero scarse del morfema del
genitivo singolare comunemente presente nelle altre lingue indoeuropee: solo l'ittita (-aš)
ed il palaico ne mostrano (ancora?) traccia, mentre le altre lingue hanno sviluppato
forme diverse: il luvio cuneiforme ha riutilizzato un aggettivo possessivo in –ašša/i-; il
licio un aggettivo in -a/ehe/i- (e cfr. anche miliaco -a/ese/i). La lingua lidia, invece, si
discosta, al singolare, sia dal morfema ittito-palaico, sia da quello usato dalle lingue del
gruppo luvio (luvio, licio e miliaco), ponendosi su un altro aggettivo, -Vl(i)-172, mentre al
plurale si ha la desinenza –an (-an; è presente anche nell'ittita), sia al genitivo, sia al
dativo173. Questo aggettivo possessivo lidio passò poi a valere anche come patronimico174.
Un'altra soluzione è stata, in alcuni casi e soprattutto in ittita, il ricorso al morfema
suffissale –il che può assumere, anche esso, funzione etnica o patronimica175
: il primo
uso denota gli e[qnh, sicchè un antroponimo quale Ziblandīel può essere inteso come
"colui che proviene da Ziblanda", così come Zalpūīl può significare come "colui che
171
Per questo passo cfr. Evans 1985. 172
Cfr. Gusmani 1964, 36-37 e 39. Ad es.: da Maneś, nome proprio, viene coniato l'aggettivo manelis "di
Maneś". 173
Cfr. Gusmani 1964, 37 e 39. 174
Cfr. Gusmani 1964, 45. La funzione patronimica acquisita da questo morfema è evidente in timleś
brdunlis "Timleś, (figlio) di Brdunś". 175
Cfr. Brandenstein, R. E. Supplb. VI, 170.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
84
viene da Zalpa", ma, accanto a questo significato, lo stesso morfema si trova usato anche
per indicare mestieri, ad es. lu-u-i-iz-zi-i-il "(colui) che fonde il metallo". Più tardi a
questi morfemi genitivali viene aggiunta una desinenza: difatti successivamente lo stesso
suffisso si trova anche all'interno dei nomi di alcuni re ittiti, come nel caso di Hattusilis I
(ovviamente derivato da Hattusa, il nome della capitale ittita, l'odierno villaggio turco di
Bogazköi) e di Murshilis I (di etimologia sconosciuta, perché suo padre non si chiamava,
per dirla alla greca, Muvrso"), entrambi databili all'incirca tra il 1650 ed il 1600 a.C. Il
nome Mursivlo" è, dunque, non propriamente lidio, bensì ittita, ma poi si è diffuso
anche nella lingua lidia: presso i lidi, inoltre, il valore patronimico poteva ancora essere
ben presente nella coscienza linguistica dei parlanti, infatti Mursivlo" (e lo stesso si dica
per l'eolico Muvrsilo") deve essere considerato un calco greco creato sulla base di un
nome lidio e può essere inteso proprio come "figlio di Muvrso"". D'altronde il nome
Muvrsilo" sembra essere attestato direttamente in una iscrizione lidia nella forma
mrslaś176
: nik mrslaś sitarfloś. Il nome del re lidio, doveva essere, dunque, qualcosa
come Mrslas (e non Candaule, come è passato alla storia), poi storpiato dai greci in
Mursivlo": Erodoto, secondo Evans (1985, 231) avrebbe preferito Kandauvlh" a
Mursivlo" perché il primo sembrava davvero lidio, mentre il secondo poteva dare l’idea
di essere greco o meglio sembrava greco ad Erodoto, perché era lo stesso del Cleanattide
mitilenese.
Nel caso, dunque, del tuvranno" di Mitilene, si potrebbe trattare, si è supposto, di un
soprannome atto ad indicare la linea filolidia che i Cleanattidi (e/o Mirsilo in particolare)
tennero quando erano al potere.
I Cleanattidi e la Lidia
Abbiamo visto che il nome di Mirsilo, appartenente ai Cleanattidi, si giustifica con i
“privilegi” che i Cleanattidi accordarono ai Lidi, il che equivale, evidentemente, a tenere
una linea filolidia. In cosa consistè la linea filolodia che i Cleanattidi tennero quando
furono al potere? E come è possibile dimostrarla? Alle due domande risponde, come
sappiamo, un famoso frammento saffico, per altro recentemente analizzato dallo stesso
Ferrari (2007a, 15-22); si tratta di Sapph. 98 V.:
176
Cfr. Gusmani 1964, s.u. mrslaś ed iscrizione 14,7
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
85
a
..].qo": aj gavr m∆ejgevnna≥[t [–]
s]fa'" ejp∆ ajlikiva" mevg[an k]ovsmon ai[ ti" e[chãià fovbaãiÃ"≥[ p≥orfuvr≥wi katelixamev[na ã–à e[≥mmenai mav≥la tou'to .[ a≥jlla ; xanqotevraãiÃ" e[ch[ t≥aãi;Ã" kovmaãiÃ" davi>do" prof≥[ [–] s]tefavnoisin ejpartiva[i" aj≥nqevwn ejriqalevwn: [ m]i≥travnan d∆ ajrtivw" kl[ [–]
p≥oikivlan ajpu; Sardivw[n ...] jI≥aoniva" povl{e}i" [ infatti, colei che mi generò (mi diceva un tempo)
che al tempo della sua giovinezza grande
ornamento se una ragazza portava le chiome
strette da un nodo purpureo
ma per colei che abbia
le chiome più bionde
di una fiaccola
con corone
di fiori sgargianti:
da poco una mitra
variopinta da Sardi
(alle) città della Ionia…
b
soi; d∆ e[gw Klevi poikivlan [ oujk e[cw povqen e[ssetai [ mitravnãanÃ:ajlla; tw;i Mutilhnavwi [ ***
[ ].[ pai.a.eion e[chn po.[ aijke≥.h≥ poikilask...(.)[ – tau'ta ta;" Kleanaktivda≥[ fuvga"≥†..i≥sa† povli" e[cei
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
86
mnavmat∆:o≥i[de ga;r ai\na dievrrue≥[n
ma io per te la mitra
variopinta non so dove trovarla
ma al Mitilenese
***
…
avere
variopint-
questi ricordi †…† la città ha
dell'esilio dei Cleanattidi (?)
costoro, infatti, terribilmente si sbandarono
Quest’ode fornisce molte informazioni: (1) l’esistenza di rapporti commerciali con la
vicina Lidia, in particolare con Sardi, tale che una mitra poteva essere acquistata dai
lesbii; (2) probabilmente, documenta del blocco dei suddetti scambi commerciali
approvato da Pittaco; (3) la realtà storica dell’esilio del Cleanattide o dei Cleanattidi. Per
queste ragioni è da considerarsi un vero e proprio documento storico ed ad essa dovremo
ancora fare riferimento in altre occasioni. Qui interessa il primo dato, quello
dell’esistenza di rapporti commerciali con la vicina Lidia: esso può avere un’eco ancor
maggiore qualora si consideri la possibile integrazione, proposta da Ferrari (2007a, 15)
pro;]"≥ jI≥aoniva" povl{e}i" al v. 12 del frammento a: il commercio di queste manifatture
lidie non era, dunque, riservato alla sola Lesbo, ma anche alla Ionia tutta. Ed è
significativo che di una mitra lidia si parli anche in Alcm. F. 1.67-69 PMGF mivtra /
Ludiva: e del resto sappiamo che lo spartano Alcmane era, secondo la tradizione, nativo
di Sardi, “capitale” della Lidia. Dunque le rotte commerciali lidie potevano estendersi
fino al centro del Peloponneso, a Sparta.
La linea filolidia dei Cleanattidi sembra, dunque, essere consistita in floridi rapporti
commerciali e culturali con i Lidi: il diffondere nuovi gusti in materia di abbigliamento o
strumenti musicali è, certamente, anche un fenomeno culturale, di costume.
Saffo
In che posizione si colloca Saffo nel rapporto tra Lesbo e la Lidia? Basterebbe, forse, il
carme precedentemente citato per dimostrare che Saffo, in quanto Cleanattide, era
favorevole a questi scambi commerciali ed amante delle manifatture che giungevano
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
87
dalla vicina Sardi, ma ci sono, in tal senso, altri documenti da analizzare e, come
sappiamo, una famosa ode del “libro quarto”. Saffo stessa sembra avere una sorta di
"amore" per ogni tipo di manifattura lidia: nel F 39 V. parla di una "sgargiante calzatura,
splendido lavoro lidio" e la ph'kti", l'arpa usata da Saffo (F 22.11; F 156), era di origine
lidia.
Veniamo, però, alla famosa ode del “libro quarto”, l’ode dell’ajbrosuvna, ovvero il
frammento dV [= 58.23-26 + 59 V.]:
]i≥mevnan nomivsdei
2 ]ai" ojpavsdoi õe[gw de; fivlhmm∆ajbrosuvnan,Õ[ ] tou'to kaiv moi
4 to; lavõmpron e[rw" ajelivw kai; to; kavÕlon levõlÕogce ejpin[ -22- ].[...]nov. [ 6 fivlei.[
kai; n[
…(morta?) considera
2 ...(il Cronide?) conceda
ma io amo la raffinatezza, [ ] questo e per me
4 l'amore del sole ottenne in sorte splendore e bellezza.
Bevev-…
am-…
6 ed (ora?)…
La comprensione del carme nel suo complesso non può che sfuggirci, perché di esso
restano ben poche parole integre ed anche su di esse non c’è accordo tra gli studiosi177
,
ma l’affermazione per noi saliente è quella del v. 3, sul quale non possono sussistere
dubbi: e[gw de; fivlhmm∆ajbrosuvnan, “io amo la raffinatezza”. È significativo, come nota
Ferrari178
, che il termine ajbrosuvna (= aJbrosuvnh), oltre che nella famosa ode saffica,
sia attestato solo un'altra volta in età arcaica, cioè in Xenoph. 3 W.2 [= 3 G.-P.] proprio
in relazione al fatto che gli abitanti della ionica Colofone, prima che sopraggiungesse la
tirannide, avevano appreso dai Lidi ad andare in giro portando ogni sorta di manifattura
lussuosa:
aJbrosuvna" de; maqovnte" ajnwfeleva" para; Ludw'n, o[fra turannivh" h\san a[neu stugerh'",
h[iesan eij" ajgorh;n panalourgeva favre∆ e[conte", ouj meivou" w{sper ceivlioi wJ" ejpivpan, 177
Cfr. commento ad loc. 178
Cfr. Ferrari 2007, 74-76; Kurke 1992, 92-93; Lombardo 1983, 1079, 1083; Mazzarino 2007, 187.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
88
aujcalevoi, caivthisin ÊajgallomenÊ eujprepevessin, ajskhtoi'" ojdmh;n crivmasi deuovmenoi.
...ed avendo appreso vane mollezze dai Lidi,
finché furono senza l'odiosa tirannide,
andavano all'assemblea avendo addosso mantelli sgargianti,
non meno di un migliaio in tutto,
superbi, †adornati†con le splendide chiome,
bagnati di unguento dagli aromi ricercati.
Senofane, quindi, attribuiva questa nuova cultura (l'aJbrosuvnh) all’influsso lidio, ma essa
non dipende dai Lidi, ma piuttosto è un modo di vivere della classe aristocratica della
grecità arcaica: “questa è la descrizione dell’aristocrazia colofonia, orgogliosa nella
raffinata «mollezza» o aJbrosuvnh, di cui fa sfoggio nell’agorà” sentenziava Santo
Mazzarino (2007, 187). I Lidi, piuttosto, con i loro commerci hanno favorito l’aJbrosuvnh
dell’aristocrazia colofonia. Senofane non apprezza né l'aJbrosuvnh aristocratica, né
l’odiosa tirannide, ma quest’ultima ha posto fine ad esse. Saffo, invece, si pone
esattamente sul piano opposto: dichiara di amare l' ajbrosuvna, che per lei non è lo sfarzo
arrogante ed inutile, ma è una ricchezza, una raffinatezza, un qualcosa che la differenzia
da tutto ciò che la circonda. E non sarà certo un caso che il qivaso" fosse aperto a tutte le
ragazze della Grecia d'Asia, quindi provenienti anche dalla stessa Ionia, di cui Senofane
critica l'aJbrosuvnh.
La ricerca, tuttavia, non dovrà limitarsi al solo termine ajbrosuvnh, ma ad anche, ad
esempio, all’aggettivo aJbrov"179: esso non è mai attestato in Omero
180 e secondo molti
neanche in Esiodo. Tra i lirici, l’aggettivo è attestato tra il VII ed il VI secolo; difatti è
assente in quelli più antichi (Callino, Archiloco, Tirteo ed Alcmane); cfr. Sol. 24 W.2
[=18 G.-P.] (l’intera poesia, salvo un lieve cambiamento, ricorre anche in Thgn. 719sgg.)
i\sovn toi ploutevousin, o{twi polu;" a[rgurov" ejsti / kai; cruso;" kai; gh'"
purofovrou pediva / i{ppoi q∆hJmivonoiv te, kai; w |i movna tau'ta pavresti, / gastriv te
kai; pleurai'" kai; posi;n aJbra; paqei'n ktl. “sono ugualmente ricchi colui che
possiede molto argento, / oro, campi di terreno fertile di frumento, / cavalli e muli e
colui che ha solo quanto basta / e prova delicate sensazioni allo stomaco, ai polmoni ed
ai piedi”; Sem. 7.57sgg. th;n d∆ i{ppo" aJbrh; caitevess∆ ejgeivnato, / h} douvli∆ e[rga
kai; duvhn peritrevpei, / kou[t∆ a]n muvlh" yauvseien, ou[te kovskinon / a[reien,
179
Cfr. Lombardo 1983, 1080. 180
Cfr. Treu 1968, V, 177; Lombardo 1983, 1088.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
89
ou[te kovpron ejx oi[kou bavloi, / ou[te pro;" ijpno;n ajsbovlhn ajlãeoÃmevnh / i{zoit∆.
“l’altra la generò la delicata cavalla dalla bella criniera / rifiuta i lavori servili e
l’infelicità / e non toccherebbe macina, neppure lo staccio / solleverebbe, né getterebbe
via l’immondizia da casa, / neppure al focolare, per evitare la fuliggine, / si
siederebbe”; Sapph. 100 V. ajmfi; d∆a[brois∆ã à lasivois∆eu \ ãÛà ejpuvkassen “le
avvolse per bene attorno morbidi (panni?) villosi”
Queste attestazioni bastino sul piano letterale, ma su quello concettuale la
documentazione è ben più estesa ed è stata raccolta da Mazzarino (2007, 208s.). Si può
partire dalla descrizione del lusso dei Sami che si recano al tempio di Hera che ci ha
lasciato Asio (Fragm. Ep. 13 oi} d∆ au[tw" foivteskon o{pw" plokavmou" ktenivsainto
/ eij" {Hrh" tevmeno", pepukasmevnoi ei{masi kaloi'", / cionevoisi citw'si pevdon
cqono;" eujrevo" ei\con: / cai'tai d∆ hjiwreu'nt∆ ajnevmwi crusevoi" ejni; desmoi'", /
cruvseiai de;• koruvmbai ejp∆ aujtw'n tevttige" w{": “quelli così si aggiravano, non
appena si fossero pettinate le chiome, / al recinto sacro di Hera, avvolti in belle vesti, /
con i chitoni color della neve toccavano il terreno della vasta terra. / Le chiome in aurei
legami al vento che oscilla / e su di esse aurei fermagli, come cicale”), per poi passare a
Semonide di Amorgo (16 W.2 kajleifovmhn muvroisi kai; quwvmasin / kai; bakkavri: kai;
gavr ti" e[mporo" parh'n “e mi ungevo di unguenti, di profumi / e di baccaride, ché
c’era un mercante”) ed ad Efeso, dove troviamo Ipponatte (Hippon. 104.21-22 W.2
bakkavri de; ta;;" rJi'na" / h[leifon “con la baccaride ungevo le narici”) ed Eraclito
(DK 22 B 125a = Tzetz. Ad Ar. Plut. 88 mh; ejpilivpoi uJma'" plou'to", e[fh, jEfevsioi,
i{n∆ejxelevgcoisqe ponhreuovmenoi “che non venga mai meno a voi la ricchezza, diceva,
Efesini, affinchè vi manifestiate come malvagi”).
Tutte le attestazioni dell’aggettivo aJbrov" e dei suoi derivati si collocano, dunque, tra la
seconda metà del VII ed il VI secolo a.C.: è in questo periodo e soprattutto a partire dalla
metà del VII secolo (Semonide è il caso più antico, ma notare che egli non ricorre alla
radice aJbr-), se si deve prestar fede alla cronologia delle attestazioni, che si sarà definito
e diffuso il concetto di aJbrav.
Questo si dica per il piano cronologico, ma ogni fatto storico abbisogna di un’altra
cordinata, quella spaziale: abbiamo visto che già Senofane considera le aJbrosuvnai
come un influsso lidio, ma questo dato del rapporto tra gli aJbrav ed il mondo orientale
viene posto in evidenza anche altrove: ad esempio Stes. 212.2 P. utilizza l’avverbio
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
90
aJbrw'" in connessione alla musica frigia; lidia è la bavkkari" menzionata da Semonide
ed Ipponatte (cfr. Ath. XV 690 a ss.); un Luvdion kavlon e[rgon è la poivkilo" mavslh"
di cui parla Saffo (39 V.) etc. Insomma gli oggetti di pregio (vestiti, calzature, mitre) o
tutto ciò che è aJbrovn ai cinque sensi (tatto, udito, gusto, olfatto, vista)181
è, per la
maggior parte, di importazione orientale, in particolare lidia.
La conclusione che trarremo da questi dati è che Saffo, come gran parte delle classi
aristocratiche, era favorevole ai commerci con la vicina Lidia e, più in generale, con il
mondo microasiatico non greco perché proprio da quelle regioni, come dall’Oriente
tutto, provenivano quelle ricchezze che permettevano alle aristocrazie della Grecia
arcaica di mantenere un regime di vita lussuoso, di poter comprare dai mercanti orientali
vestiti, calzature, profumi, unguenti, mitre ed ogni altra sorta di manufatto lussuoso,
ovvero di porre alla base del proprio stile di vita l’ajbrosuvna: essa però, per quanto
attiene a Saffo, andrà intesa non come una “vana mollezza”, ma come una divaita
raffinata e ricercata, in grado di distinguerla dalle altre.
Pittaco e la Lidia
L’operato di Pittaco si inscrive nel più generale comportamento di coloro che, nomoteti
od esimneti, prutavnei" o basilei'", nelle varie città della Grecia arcaica posero fine,
anche con la forza (ed il caso di Mitilene è lampante), ai conflitti che opponevano tra
loro i vari gruppi aristocratici e cercarono, per quanto era nei loro nuovi mezzi, di
diminuire le laceranti sperequazioni esistenti tra le classe aristocratiche (divenute ora
ancor più ricche per il possesso di aJbrav provenienti dall’oriente) ed i semplici
cittadini182
. Per limitare questa sperequazione tra nobili e le classi più povere i nuovi
nomoteti intrapresero linee d’intervento volte contro l' aJbrosuvnh aristocratica ed i suoi
eccessi183
: ad esempio Solone, ad Atene, impose delle norme volte a diminuire il lusso e
la pompa dei funerali. E Pittaco? Anche Pittaco portò avanti misure di questo tipo: già
abbiamo parlato del fr. 98 V. di Saffo, che sembra documentare una sorta di blocco,
approvato da Pittaco, delle importazioni di manufatti di lusso, nello specifico di mitre,
prodotti, come sembra, a Sardi ed esportati in tutta la Ionia e nelle isole prospicienti;
181
aJbrov" sembra, dunque, indicare qualcosa che risulta tale tramite l’uso dei cinque sensi, tanto che Treu
(1968, 176) parla di “körperlichen Sehweise”. 182
Cfr. Lombardo 1983, 1100; Mazzarino 2007, 193. 183
Cfr. Lombardo 1983, 1100; Mazzarino 2007, 207.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
91
Saffo, infatti, dice ai vv. 1-3 del fr. 98 b: soi; d∆ e[gw Klevi poikivlan [ / oujk e[cw povqen
e[ssetai [ / mitravnãanÃ: ajlla; tw;i Mutilhnavwi [ “ma io per te la mitra / variopinta non so
dove / trovarla ma al Mitilenese”.
La critica si è interrogata su chi fosse il Mitilenese di cui qui si parla: la ricostruzione più
accreditata è, ovviamente, che si tratti di Pittaco184
e che quindi questo frammento sia
stato composto durante la sua esimnetia e dopo la promulgazione della nuova legge
suntuaria che proibiva i commerci con la Lidia. I rapporti tra Pittaco ed i sovrani lidi non
saranno stati, quindi, “idilliaci”: sintomatico, in tal senso, è un passo di Plutarco (Sept.
Sap. Conv. 153e) in cui si parla di uno scambio di scortesie occorso tra Pittaco ed
Aliatte, re dei Lidi:
oJ de;• propivnwn th;n qavlattan jAmavsidi bavrbaro" ejdei'to th'" Pittakou' braculogiva", h|i pro;" jAluavtthn ejcrhvsato prostavttontav ti kai; gravfonta Lesbivoi" uJperhvfanon, ajpokrinavmeno" oujde;n ajll∆ h] movnon keleuvsa" krovmmua kai; qermo;n a[rton ejsqivein. Però il barbaro che avrebbe bevuto il mare alla salute di Amasi ebbe bisogno della
laconicità di Pittaco, alla quale egli fece ricorso nei riguardi di Aliatte quando
quest'ultimo scriveva e mandava ai Lesbii un ordine arrogante: non formulò alcuna
risposta, ma soltanto gli consigliò di mangiare cipolle e pane caldo.
E se tale fu il mal celato astio tra Pittaco e Aliatte, l'esimnete lesbio non si comportò
certo diversamente nei riguardi del figlio di Aliatte, Creso. Erodoto (I 27) riporta un
sagace scambio di battute tra Creso e Pittaco, oppure tra Creso e Biante di Priene:
l'indecisione tra i due saggi dimostra che non si tratta di evento storicizzabile in modo
preciso: l'intento di Erodoto non era di raccontare un evento storico, ma di fornire un
apoftegma, un esempio di dialogo didattico tra un re ed uno dei sette sapienti185
.
Intorno alla contrapposizione tra Pittaco e la Lidia sorse, inoltre, una tradizione che
voleva che l’esimnete lesbio avesse rifiutato le ricchezze offertegli da Creso: si tratta,
evidentemente, di un racconto davvero paradigmatico delle relazioni che il figlio di
Hyrras intrattenne con la vicina Sardi: così come sul piano pubblico, come aijsumnhvth",
bloccava le importazioni di oggetti di lusso dalla Lidia per evitare l’accrescersi degli
aJbrav degli aristocratici mitilenesi, allo stesso modo, sul piano personale, rispediva al
mittente l’oro che il re lidio gli offriva. Di questa vicenda, adatta a colui che aveva fama
184
Questa individuzione, oggi largamente accolta, fu proposta già dall'editore del papiro, Achille Vogliano
(id., Saffo. Una nuova ode della poetessa, Milano 1941): Cfr. Ferrari 2007, 13-22; Gentili 2006, 149;
Mazzarino 1943, 57-61. Contra, seppur indirettamente, Page 1955, 102. 185
Così anche David Asheri in Asheri-Antelami ad loc.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
92
di essere uno dei “Sette Sapienti”, tramanda notizia il biografo Diogene Laerzio (I
75.81) che, dopo avervi accennato brevemente, riporta, alla fine, anche una lettera di
Pittaco a Creso, uno dei davvero rari esempi di prosa eolica:
ajlla; kai; Kroivsou didovnto" crhvmata oujk ejdevxato, eijpw;n e[cein w|n ejbouvleto diplavsia: a[paido" ga;r tajdelfou' teleuthvsanto" keklhronomhkevnai. Ma anche quando Creso gli diede delle ricchezze non le accettò, dicendo che aveva il
doppio di quanto voleva: infatti il fratello era morto senza figli e lui aveva ereditato il
patrimonio. Kai; aujtou' ejstin ejpistovlion toiovnde:
Pittako;" Kroivswi Kevleaiv me iJknevesqai ej" Ludivhn, o{pw" soi to;n o[lbon i[doimi: ejgw; de;• kai; mh; ojrei;" pevpeismai to;n jAluavttew pai'da tw'n basilhvwn polucrusovtaton pevlein. oujdevn te plevon a[mmin iJkomevnoi" ej" Savrdi": crusou' ga;r ouj deuvmeqa, ajlla; pevpamai a[rkia kai; toi'" ejmoi'" eJtavroi". e[mpa" d∆ i{xomai, wJ" ajndri; xeivnwi genoivmhn toi sunovmilo".
E sua è questa breve lettera:
«Pittaco a Creso,
mi inviti a venire in Lidia al fine di vedere la tua ricchezza, ma io, anche non avendo
visto, sono persuaso che il figlio di Aliatte sia il più ricco d’oro tra i re. Per me, a venire
a Sardi, non vi sarebbe niente di guadagnato: infatti non ho bisogno di oro, ma quello
che possiedo è bastevole anche per i miei compagni. Tuttavia, io verrò, per essere
compagno ad uno straniero»
Una versione più dettagliata della vicenda viene riferita da Diod. Sic. IX 11.2:
{Oti suvmfwna touvtoi" e[praxe kai; pro;" Kroi'son didovnta tw'n ejk tou' gazofulakeivou crhmavtwn labei'n oJpovsa bouvloito. kai; ga;r tovte th;n dwrea;n ouj prosdexavmenon fasin eijpei'n, kai; nu'n e[cein w|n h[qele diplavsia. qaumavsanto" de;• tou' Kroivsou th;n ajfilargurivan kai; peri; th'" ajpokrivsew" ejperwthvsanto", eijpei'n wJ" teleuthvsanto" a[paido" tajdelfou' keklhronomhkw;" oujsivan ei[h th;n i[shn h|iper ei\cen, h}n oujc hJdevw" proseilhfevnai.
Pittaco compì azioni consone a questi principi anche nei riguardi di Creso che gli
concedeva di prendere quante ricchezze volesse del suo tesoro. Ed infatti narrano che,
avendo rifiutato il dono, disse che ora aveva il doppio di quello che voleva. Essendosi
Creso stupito per la sua mancanza di avidità ed avendogli chiesto informazioni a
riguardo della risposta, disse che poiché il fratello era morto senza figli, lui aveva
ricevuto in eredità un patrimonio che era uguale a quello che possedeva e non con
piacere l’aveva preso in aggiunta186
.
Il supposto incontro tra Pittaco e Creso crea, tuttavia, non pochi problemi cronologici,
soprattutto partendo dalla cronologia precedentemente qui proposta per l'esimnete.
186
E cfr. anche Plut. De frat. am. 484c.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
93
Creso, infatti, era nato nel 596 a.C. e salì al trono nel 560/561 a.C., all'età di trentacinque
anni187
, mentre Pittaco, nato nel 652-649 a. C., deve essere morto prima della
cinquantaduesima Olimpiade, cioè nella cinquantesima, circa nel 598/597 a.C. Gentili188
propende per porre l'incontro intorno al 575 a.C., quando un Creso ventunenne fu
mandato dal padre Aliatte, che in quegli anni stava conducendo una campagna in Caria,
a governare le città di Adramyttium e di Tebe nella Troade189
: in quell'anno, tuttavia,
Pittaco era probabilmente già morto. Inoltre il racconto fornito da Erodoto mostra, come
abbiamo visto, una contraddittorietà nel nome dell'interlocutore di Creso, perciò non vi
si potrà troppo far affidamento, perché si tratta di un aneddoto senza alcuna presunzione
di valore storico.
La contemporaneità tra Creso e Pittaco sembra presupposta, però, anche dall’altro
racconto, ovvero quello del rifiuto, da parte di Pittaco, dell’oro lidio: si dovrà
considerare, a riguardo, la fama che nell’antichità avevano Creso e le sue ricchezze e la
tradizione aneddotica riguardante le figure dei “Sette Sapienti”: sarà stato naturale che
circolassero aneddoti a riguardo dell’incontro di Creso e di Pittaco, considerato che
quest’ultimo aveva posto un blocco ai commerci mitilenesi con Sardi.
Se, dunque, queste narrazioni non possono avere valore storico, ciò non toglie che siano
comunque importanti, quali spie della diffidenza, che presso gli antichi doveva essere
famosa, che l’esimnete lesbio mostrava verso i re lidi, il loro oro e la loro vita lussuosa:
quegli aJbrav che avevano aumentato enormemente la sperequazione tra le classi
aristocratiche ed i normali cittadini ed a cui Pittaco aveva cercato di porre rimedio.
187
Cfr. Hdt. I 26 teleuthvsanto" de; jAluavttew ejxedevxato th;n basilhivhn Kroi'so" oJ jAluavttew, ejtevwn ejw;n hJlikivhn pevnte kai; trihvkonta "Morto Aliatte, ereditò il regno Creso, figlio di Aliatte,
all'età di trentacinque anni". 188
Cfr. Gentili 2006, 150 (n. 50). 189
Cfr. Nicol. Damasc. FGrHist 90 F 65 {Oti jAluavtth" oJ Kroivsou path;r, tou' Ludw'n basilevw", ejpi; Karivan strateuvwn, perihvggeile toi'" eJautou' strato;n a[gein ei'" Savrdei" ejn hJmevrai takth'i, ejn oi|" kai; Kroivswi, o{sti" h\n aujtou' presbuvtato" tw'n paivdwn, a[rcwn ajpodedeigmevno" jAdramuttivou te kai; Qhvbh" pedivou. "…che Aliatte, padre di Creso, re dei Lidi, mentre stava
compiendo una campagna militare contro la Caria, recò dappertutto a quelli, tra cui vi era anche Creso,
il più anziano dei figli, che aveva ricevuto il comando della piana di Adramittio e di Tebe l'ordine di
ricondurre l'esercito a Sardi nel giorno fissato".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
94
7. Andromeda e Gorgò nei frammenti di Saffo e loro contestualizzazione nella Mitilene del tempo
Problemi di individuzazione
Una buona parte delle odi della poetessa eolica dovevano riguardare i rapporti tra Saffo
ed altre due donne della Lesbo del periodo che avevano, molto probabilmente, istituito
delle “scuole” del tutto simili a quella saffica. La fonte che ci permette di individuare tali
"nemiche" della poetessa è un celebre passo del retore Massimo di Tiro (XVIII 9):
o{ tiv ga;r ejkeivnwi jAlkibiavdh" kai; Carmivdh" kai; Fai'dro", tou'to th'i Lesbivai Guvrinna kai; jAtqi;" jAnaktoriva: kai; o{ tiv per Swkravtei oiJ ajntivtecnoi, Provdiko" kai; Gorgiva" kai; Qrasuvmaco" kai; Prwtagovra", tou'to th'i Sapfoi' Gorgw; kai; jAndromevda: nu'n me;n ejpitima'i tauvtai", nu'n de;•ejlevgcei, kai; eijrwneuvetai aujta; ejkei'na ta; Swkravtou":
to;n [Iwna caivrein fhsi;n oJ Swkravth":
pollav moi ta;n Pwluanaktivda pai'da caivrein, Sapfw; levgei: ouj prosievnai fhsi;n oJ Swkravth" jAlkibiavdhi, ejk pollou' ejrw'n, pri;n hJghvsato iJkano;n ei\nai pro;" lovgou": smikrav moi pai'" e[ti faivneo ka[cari" e[ssa ... Sapfw; levgei: kwmwidei' sch'mav pou kai; katavklisin sofistou', kai; au{th tiv" de;•ajgroiw'tin ejpemmevna stolhvn ...· Ciò che per lui (scil. Socrate) erano Alcibiade, Carmide e Fedro per la poetessa di Lesbo
erano Girinno (Girinna codd. : corr. Dübner), Attide ed Anattoria, E come, appunto, per
Socrate erano nemici Prodico, Gorgia, Trasimaco e Protagora, allo stesso modo per
Saffo erano Gorgò ed Andromeda. Ora le biasima, ora le mette alla prova; e ricorre
all'ironia allo stesso modo di Socrate:
saluti a Ione
Socrate dice.
tanti saluti da parte mia alla figlia del Polianattide
Afferma Saffo. Socrate, pur amandolo da molto tempo, dice ad Alcibiade di non essersi
accostato a lui, prima di averlo ritenuto idoneo per i discorsi;
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
95
una bambina piccola mi parevi un tempo e sgraziata
Dice Saffo. E prende in giro l'atteggiarsi ed il modo di stare a letto di un sofista; e lei
dice:
chi è che non è capace di sollevare la rustica veste
Dalla lettura del passo del retore di Tiro si evince che due sarebbero state le "nemiche"
di Saffo, ovvero Andromeda e Gorgò. Successivamente Massimo mette a confronto
alcuni passi o comportamenti paralleli tra Saffo e Socrate: vi sono due forme di saluto,
una di Socrate a Ione ed una di Saffo ad una non meglio precisata figlia di/del
Polianattide; una critica da parte di Socrate al modo di comportarsi di un sofista
(vedremo tra poco di chi si tratta) ed una da parte di Saffo ad una donna non precisata,
verosimilmente Andromeda. Invece, la citazione smikrav moi pai'" e[ti faivneo ka[cari"
e[ssa ... si riferisce ad Attide e perciò non può essere sommata, come invece fa Ferrari,
all' altra citazione come se fosse rivolta anche essa contro la stessa Andromeda190
: il
confronto è qui stabilito tra due ejrwvmenoi, Alcibiade per Socrate191
e la "bambina
piccola" per Saffo: Andromeda non rientra in questo contesto, se non indirettamente. A
questo punto abbiamo due "nemiche" e due citazioni da poesie in cui Saffo sembra
manifestare ostilità verso qualcuno (il supposto squilibrio paventato da Ferrari, quindi,
sembra non esserci, anzi, così ricostruita, l'"economia" del passo appare ben più logica):
ora dobbiamo volgerci a capire di chi si tratta e la nostra ricerca non risulterà fine a sé
stessa, perché, come afferma Gentili, a queste rivalità non erano, forse, "estranee
implicazioni connesse con le vicende politiche della città di Mitilene (e quindi dell'isola
tutta) tra VII e VI sec. a.C."192
. Nella prima citazione Saffo si rivolge contro qualcuno
definendola "figlia di/del Polianattide": si tratta di Andromeda o di Gorgò? Escluso,
ovviamente, il caso per cui nessuna delle due sia una Polianattide (altrimenti non
avrebbe senso la citazione fatta da Massimo, perché si riferirebbe a qualche altra donna
190
Ferrari 2007, 32-33 afferma, invece: "Massimo non dà più di tre brevissimi assaggi – cioè F 155 (tanti
saluti alla figlia del Polianattide), F 49.2 (su Attide, transfuga verso Andromeda) e F 57.2 (sulla rustica
veste della stessa Andromeda) - …due esempi riguardano la stessa Andromeda" 191
Massimo, infatti, aggiunge ejk pollou' ejrw'n, espressione che non indica certo un legame di ostilità.
Inoltre, il retore greco allude qui, molto probabilmente, a due passi dell'Alc. I (103 a;105 e-106 a) in cui
Platone fa dire a Socrate che, a causa della volontà del dio (103 a ti daimovnion ejnantivwma; 105 e oujk ei[a oJ qeov" dialevgesqai), era stato impossibilitato a parlare con il futuro stratego ateniese: le parole di
Socrate/Platone vengono parafrasate da Ath. V187e. 192
Gentili 2006, 149 (nostro il corsivo).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
96
sconosciuta e di cui non viene riportato il nome), non rimangono che tre possibilità: (1)
che entrambe fossero Polianattidi; (2) che Gorgò fosse una Pentilide ed Andromeda una
Polianattide; (3) che Gorgò fosse una Polianattide ed Andromeda una Pentilide. Alla
prima possibilità ha accennato la Williamson (1995, 88), secondo la quale Massimo
"continues with a quotation implying that both are members of the Polyanactid family":
probabilmente questa studiosa è stata indotta ad una tale affermazione dal fatto che
Massimo prima riporta il nome delle due avversarie di Saffo (Gorgò ed Andromeda) e
poi cita in questo contesto il Fr. 155 Voigt: ebbene, l'espressione Pwluanaktivda pai'da
implica, non occorre dirlo, che si tratti di una sola persona e non di due; inoltre, il fatto
che il frammento sia riportato in questo contesto non significa necessariamente che si
riferisca direttamente ad entrambe, anche e soprattutto considerando il fatto che pochi
righi dopo Massimo fa un'altra citazione riferita ad una delle due avversarie con un
"destinatario" probabilmente diverso rispetto al precedente: a ben guardare, quindi, la
prima ipotesi dell'elenco sopra riportato è la meno felice tra tutte. Rimangono due
possibilità, ma, nessun argomento davvero forte che si possa imporre. La seconda ipotesi
(2), ovvero che Gorgò fosse una Pentilide ed Andromeda una Polianattide, è portata
avanti da Treu (1976, 146), il quale, tuttavia, non fornisce alcuna prova della sua
ricostruzione; egli si limita ad affermare: “Andromeda war in fr. 61 D. und 150 D.
gemeint”: 61 D. [= 57 V.] non è altro che il passo di Ateneo che tra poco citeremo dove,
effettivamente, il testimone indiretto parla direttamente di Andromeda, ma Treu non
fornisce alcuna dimostrazione di come abbia fatto ad attribuire Sapph. 150 D. alla sola
Andromeda: Sapph. 150 D., difatti, è proprio il frammento tradito da Massimo di Tiro
(18, 9: pollav moi ta;n Poluanaktivda pai'da caivrein) che abbiamo sopra riportato:
ebbene, partendo solo da esso non è possibile arrivare a dimostrare che Andromeda fosse
una Polianattide, perché il testimone indiretto, come abbiamo visto, riporta anche il
nome di Gorgò. Per individuare correttamente l’appartenenza di Gorgò e di Andromeda
ai Polianattidi ed ai Pentilidi occorrono, quindi, delle prove più solide, magari il
confronto tra frammenti diversi, anche di poeti diversi, dove con “poeti” si può intendere
soltanto Saffo ed Alceo. E proprio paralleli di questo tipo possono dimostrare, piuttosto,
la terza possibilità (3), ovvero che Andromeda fosse una Pentilide e Gorgò una
Polianattide: essa fu avanzata già da Wolfgang Schadewaldt (1936, 365, n. 1) con una
dimostrazione che, ora, non sembra più essere valida: egli notava, comunque sia, che in
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
97
uno stesso frammento Saffo parlava di Andromeda e dei Tindaridi a pochi versi di
distanza e poiché, come abbiamo visto, i Pentilidi pretendevano di essere discendenti di
Pentilo, il figlio di Oreste ed il nipote di Elena, figlia di Tindareo, era dunque possibile
che Saffo in quell’ode, dopo essersi riferita alla nemica Andromeda, chiamasse i
Pentilidi Tindaridi per il tramite di questa parentela: la ricostruzione del carme,
recentemente data da Franco Ferrari, sembra tuttavia negare la possibilità che con
Tindariti Saffo si riferisse ai Pentilidi: in quel passo sembrano essere invocati i
Tindaridi, ovvero i Dioscuri Castore e Polluce, senza alcuna relazione diretta, sembra,
con Andromeda. È però significativo, riteniamo, che in una stessa ode si parli di
Andromeda e dei Tindaridi. Lo stesso Ferrari ha, tuttavia, apportato nuovi e più solidi
argomenti alla tesi dello Schadewaldt: essa è, dunque, la più verosimile e di seguito la
riassumeremo, aggiungendo qualche minimo nostro contributo. È possibile, ma
purtroppo non certo, ritenere che una delle due citazioni di Massimo si riferisca a Gorgò,
mentre l'altra ad Andromeda: l'ordine in cui abbiamo riportato i due nomi non è casuale,
ma è proprio quello in cui li riporta Massimo: la logica, difatti, ci induce a sospettare che
la prima citazione sia rivolta a Gorgò perché il primo nome citato da Massimo è proprio
il suo, mentre la seconda ad Andromeda: rimane solo da considerare se le nostre scarse
fonti possano confermare o smentire un tale quadro.
Rivolgiamo la nostra attenzione, quindi, al primo frammento tradito da Massimo di Tiro:
si hanno qui due espressioni si saluto, la prima rivolta da Socrate ad Ione193
, la seconda
(sarcastica) da Saffo ad una certa Polianattide: la logica fin qui seguita ci induce a
credere che dietro a quel patronimico si celi il nome di Gorgò. La corretta
identificazione della “figlia del Polianattide” è un fatto decisivo: abbiamo, infatti, visto
che Polianattide doveva, probabilmente, essere Hyrras, il padre di Pittaco, sicchè la
“figlia del Polianattide” deve essere la sorella di Pittaco. Non possiamo, tuttavia ancora
193
Vengono qui citate da Massimo le prime tre parole con cui comincia lo Ione platonico (530 a): to;n [Iwna caivrein. Di Ione, l'interlocutore di Socrate nel dialogo omonimo, sappiamo ben poco: viene
presentato da Platone come un rapsodo appena giunto ad Atene da Epidauro, dove è stato premiato in una
gara di recitazione omerica: era, però, originario di Efeso: tutti questi dati, ben pochi in verità, ci vengono
forniti nell'inizio stesso del dialogo (cfr. Ion 530 a-b). L'importanza di Ione nella vicenda socratica è
davvero minima in confronto alla "figlia del Polianattide" per Saffo: la scelta di Massimo di mettere in
paragone questi due personaggi è stata, forse, poco felice, ma giustificata dall'evidente richiamo verbale.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
98
dire chi sia costei, perché dalla citazione non riusciamo a trarre alcunché di notevole,
tranne che costei sarà stata la sorella di Pittaco.
Passiamo, dunque, alla seconda citazione: essa, al contrario della prima, ci fornisce
molte informazioni. Dice Massimo di Tiro:
kwmwidei' sch'mav pou kai; katavklisin sofistou', kai; au{th tiv" de;• ajgroiw'tin ejpemmevna stolhvn ...·
E prende in giro l'atteggiarsi ed il modo di stare a letto di un sofista; e lei dice:
chi è che non è capace di sollevare la rustica veste…
Il passo citato da Massimo è abbastanza simile ad un altro, citato Ateneo (I 21b):
l’autore dei Deipnosofisti sta dicendo che gli uomini dei tempi antichi si facevano beffe
di coloro che non erano capaci di tirarsi su la veste e cita, per dimostrare ciò, un passo
tratto da un’ode di Saffo, informandoci del fatto che la frase citata riguarda Andromeda:
e[mele de; aujtoi'" kai; tou' kosmivw" ajnalambavnein th;n ejsqh'ta kai; tou;" mh; tou'to poiou'nta" e[skwpton. Sapfw; peri; jAndromevda" skwvptei: tiv" d∆ ajgroiw'ti" qevlgei novon oujk ejpistamevnh ta; bravke∆ e{lkein ejpi; tw'n sfurw'n;
Ad essi stava a cuore anche il sollevare in modo corretto la veste e prendevano in giro
coloro che non lo facevano. Saffo si fa beffe di Andromeda:
chi è la rustica che ammalia la mente
pur non essendo capace di sollevare gli straccetti sopra le
caviglie?
Il frammento citato da Massimo di Tiro e quello citato da Ateneo non sono, è evidente,
corrispondenti, ma colpisce che in entrambi vi sia un inizio simile e soprattutto che sia
presente ajgroiw'ti", ajgroi?wti", ovviamente, in eolico: tutto ciò non può certo passare
inosservato e si è pensato che si trattasse di un medesimo componimento, perciò i due
frammenti si trovano, nelle edizioni moderne, riuniti sotto uno stesso numero194
:
194
Cfr. Sapph. 57 V. La fusione delle due citazioni in un unico frammento, portata avanti per la prima
volta dal Casaubon [Animadversionum in Athenaei Deipnosophistas (1600), Lugduni 1612, p. 54], fu poi
riproposta prima dal Blomfield [«Museum Criticum» 1 (1813), p.19] (che espungeva il tiv" de; tradito da
Massimo in quanto ripetizione di quello dell'ipotetico verso precedente, ma la ripetizione è un fenomeno
che si trova spesso nei carmi saffici: cfr. Di Benedetto 1982; ora in Di Benedetto 2007, II, 812-815) e poi
da Th. Gaisford [Poetae minores Graeci, III, Lipsiae 1813, p. 304].
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
99
un'operazione, quest'ultima, da ritenere poco felice, date anche le perplessità che sono
state sollevate da più parti195
; non è, però, verso le vicende filologiche che qui è
indirizzato il nostro interesse. Tuttavia, al di là del fatto che le due citazioni possano o
meno provenire dalla medesima composizione, è significativo ed evidente il richiamo
verbale tra i due passi di tradizione indiretta: di conseguenza, se Ateneo riporta il nome
di Andromeda come destinataria dell'ode ostile da lui tradita in misura frammentaria,
non vi sono argomenti per negare che anche le parole citate da Massimo fossero rivolte
contro Andromeda, magari in qualche altro componimento: è perciò logico pensare che
Andromeda fosse la destinataria di entrambi i frammenti196
. Si può così dimostrare,
quindi, che la seconda citazione (non considerando gli ejrwvmenoi e le ejrwmevnai) fatta da
Massimo si deve riferire ad Andromeda, il che torna perfettamente con la ricostruzione
fin qui delineata. E se la seconda citazione si riferisce ad Andromeda la prima non può
che riferirsi a Gorgò, perché altrimenti Massimo parlerebbe di entrambe (Gorgò ed
Andromeda) senza citare alcun frammento al riguardo di Gorgò: ecco che, dunque,
Gorgò deve essere stata la figlia del Hyrras e, quel che più conta, la sorella di Pittaco.
8. La tradizione
L'edizione alessandrina.
Le edizioni di Saffo nell’antichità
L’obiettivo che si pone quest’opera è di costituire, dopo la pubblicazione del testo
presentato dal PKöln 21351+21376 ed i collages proposti da Franco Ferrari, il nuovo
testo del quarto libro della poetessa di Lesbo. Per “quarto libro” intendiamo,
evidentemente, quello dell’edizione alessandrina. I papiri che ci tramandano i frammenti
dei “lirici arcaici” risalgono, nella maggior parte dei casi (questo non è il caso, però, del
PKöln 21351+21376 che, essendo databile all’inizio del III secolo a. C., è
prealessandrino), alle loro edizioni (notare il plurale) stese dai filologi alessandrini. Non
essendo possibile avere a disposizione un numero consistente di papiri che ci possano
“fotografare” la situazione del testo di un singolo poeta prima nel periodo classico, i
195
Cfr. Di Benedetto 1982 (ora in Di Benedetto 2007, II, 812-815); Ferrari 2007, 47; Nicosia 1976, 267 e
soprattutto n. 14; West 1970, 320. Da notare che il testo così come viene citato da Ateneo sembra essere
consecutivo: infatti anche Philemo 162 p. 107 s. = Eust. 1916, 46 ss. citano le stesse parole presenti in
Ateneo ed anche nello stesso ordine. 196
Così anche Di Benedetto 1982 (ora in Di Benedetto 2007, II, 812-815).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
100
filologi ed i papirologi sono costretti a limitarsi alle edizioni su cui, a quanto pare, hanno
maggiori informazioni, ovvero quelle alessandrine. Ecco che alla dizione “quarto libro”
occorrerebbe aggiungere “dell’edizione alessandrina”, ma anche così la definizione
continuerebbe, tuttavia, ad essere ambigua: di quale edizione alessandrina si tratta?
Saffo ed Alceo: differenze tra ejkdovsei"
Per delimitare maggiormente la definizione occorre istituire un confronto tra le edizioni
alessandrine dei due lirici lesbii, quelle di Alceo e quelle di Saffo: su quella di Alceo
siamo, per uno strano caso della sorte, meglio informati. Non sembrerà, quindi,
particolarmente strano fare una breve digressione sull'edizione alcaica, al fine di mettere
in mostra le basi in comune e le differenze tra le due edizioni alessandrine dei poeti
lesbii: vedremo che parte del materiale così raccolto potrà rivelarsi utile anche per la
stessa Saffo.
Da Hephaes. Peri; shmeivwn 2s. p. 74 C. (II sec. d.C.) apprendiamo dell'esistenza di due
edizioni alessandrine197
dell'opera alcaica: l'informazione tradita da Efestione è
incidentale ed in riferimento ad un'osservazione pratica, utile a coloro che, a quel tempo,
avessero dovuto prendere in mano l'edizione alcaica: nell’edizione di Aristofane di
Bisanzio l'asterisco veniva usato per indicare il passaggio ad una composizione di metro
differente, mentre Aristarco se ne servì più genericamente per segnalare l'inizio di una
nuova composizione. Ecco che, così, siamo venuti a conoscenza del nome dei due editori
alessandrini di Alceo (e forse anche di Saffo), Aristofane di Bisanzio (ca. 260-180 a.C.)
ed Aristarco di Samotracia (ca. 215-144 a.C.). Quanto al primo, sappiamo che lavorò ad
alcuni poeti lirici e non solanto ad Alceo: le fonti parlano, sicuramente, di un’edizione di
Alceo, di una di Anacreonte ed una di Pindaro198
. Il nome di Aristofane di Bisanzio è
legato, come sappiamo, ad un nuovo modo di pubblicare i testi lirici, cioè divisi per
kw'la e non più in scriptio continua: è possibile estendere questa caratteristica anche
all’edizione di Aristarco? Per rispondere a questa domanda occorre tornare alla
testimonianza su Aristofane: Efestione, infatti, ci informa che, al momento in cui egli si
accingeva a comporre le sue opere metriche e grammaticali, l'edizione aristarchea era
197
Cfr. Porro 1994, 3ss.; Nicosia 1976, 30. Per il testo v. Nauck 1848, 17, 61, ma cfr. infra. 198
L’edizione di riferimento dei frammenti e delle testimonianze di Aristofane è stata, per quasi un secolo
e mezzo, quella di Nauck 1848. Le testimonianze sul lavoro esegetico ed editoriale di Aristofane sui poeti
lirici sono raccolte, appunto, in Nauck 1848, 60-62. Nauck (l.c.) e Schneidewin erano incerti se attribuire
ad Aristofane anche un’edizione di Archiloco ed una di Laso di Ermione.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
101
quella in uso (th;n nu'n th;n jAristavrceion): perciò, per ben quattro secoli, dal II a. C.
al II d.C. nessuno "editore" fu in grado di rivaleggiare con Aristarco. Dunque, quando
Dionigi di Alicarnasso, De comp. verb. 19.7 dice che le composizioni alcaiche erano
costituite da mikrai; strofai;, a loro volta formate da ojlivga kw'la, deve, dunque,
riferirsi all’edizione di Aristarco199
.
Venuti a conoscenza dei responsabili delle edizioni alessandrine, ci manca ora un dato
fondamentale, ovvero il criterio su cui si fondava l'edizione aristofanea e quella
aristarchea, il modo in cui i singoli componimenti si susseguivano nelle edizioni antiche:
ci muoviamo su un terreno sdrucciolevole ed una conclusione sicura non può essere
definita. Anche se, in mancanza di prove attendibili, la parola "fine" in queste
discussioni non può mai essere detta, gli studi recenti sono giunti alla conclusione che il
cri terio posto alla base delle edizioni alcaiche fosse tematico e che facesse capo alla
suddivisione tra carmi stasiwtikav e non stasiwtikav. Altri200
hanno ipotizzato che il
criterio di queste edizioni alcaiche fosse metrico negativo, cioè che esse si basassero
sulla poikiliva tra metra e temi diversi: quest'ultimo argomento non è sostenuto da
alcuna prova ed il confronto con l'edizione oraziana, solitamente richiamato in questo
contesto, non ha valore.
Se questa è la nostra ricostruzione delle edizioni alcaiche, di quantità ben diversa sono le
informazioni che abbiamo sull'edizione saffica. Innanzitutto è lecito chiedersi di quale
edizione alessandrina stiamo parlando; laconico, a riguardo, è Nicosia (1976, 30):
“sebbene manchino nelle scarse notizie pervenuteci precisi riferimenti in questo senso, si
attribuisce comunemente ad Aristofane l’edizione di tutti gli ejnneva lurikoiv, e quindi
anche di Saffo”. Nonostante lo scetticismo di qualcuno, si è imposta l’opinione che sia
Aristofane sia Aristarco siano stati editori di Saffo201
. Le incertezze che tuttora
rimangono sono dovute, in parte, al lasso di tempo intercorso tra l'edizione stessa e le
testimonianze, nonché alla non precisione di queste ultime. Il primo problema che si
pone alla nostra attenzione è quantitativo, ovvero: quanti erano i libri dell'edizione
alessandrina di Saffo? Abbiamo già citato, in questa sede, la biografia di Saffo presente
nella Suida ed abbiamo visto che lì si parla di nove libri (e[graye de; melw'n lurikw'n
199
Così la Porro 1994, 4. 200
Cfr. Gallavotti 1957, 12. 201
Così ritiene, ad esempio, Liberman 2007, 41; 1999, XLVII n. 148.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
102
bibliva qV): questo dato non è affatto isolato e coincide con quello presente in A. P VII 17
(un epigramma di Tullio Laurea, il copista di Cicerone)202
:
h]n dev me Mousavwn ejtavshi" cavrin, w|n ajf∆ eJkavsth" daivmono" a[nqo" e jmh 'i qh'ka par∆ e jnnea vdi
ma se mi consideri per la grazia delle Muse, di ciascuna dea delle quali
ho posto un fiore accanto alla mia enneade
Il giro di frase di Tullio Laurea potrebbe, quindi, significare che ogni libro di Saffo era
contraddistinto dal nome di una delle nove Muse203
, cioè Clio per il primo, Euterpe per il
secondo, Talia per il terzo, Melpomene per il quarto, Tersicore per il quinto, Eratò per il
sesto, Polinnia per il settimo, Urania per l'ottavo e Calliope per il nono: questo ordine,
oltre ad essere lo stesso dei nove libri di Erodoto, è quello tramandato da Esiodo in uno
dei suoi celebri cataloghi204
.
Queste testimonianze vanno, quindi, nella direzione di una reale esistenza storica del
nono libro di Saffo: questa conclusione, tuttavia, non è affatto pacifica in quanto non è
stata rintracciata una sola testimonianza diretta sul nono libro ed inoltre nessun
frammento tradito da tradizione indiretta è attribuito al nono libro. D'altronde, il
problema si riallaccia ad uno di genere diverso, ovvero l'esistenza reale o meno,
nell'ambito dell'edizione alessandrina, di un libro intitolato nelle nostre fonti Epitalami:
ipotizzando, come sembra ragionevole per via del ragionamento che stiamo per portare
avanti, che essi fossero l'ultimo libro, dobbiamo chiederci se esso era l'ottavo o il nono?
Come possiamo vedere, troppe domande si pongono alla nostra attenzione ed anche su
argomenti centrali siamo poco informati a causa della scarsità delle fonti a nostra
disposizione. Occorrerà procedere con ordine, partendo da ciò che risulta ormai certo ed
assodato: l'edizione alessandrina dei carmi di Saffo aveva come criterio dominante
quello metrico. Converrà, dunque, passare ora in rassegna i singoli libri dell’edizione
202
Sapph. T 28 Campbell │T 49 Gall.│om. Voigt. Benchè il passo sia di facile interpretazione, è stato
inteso in maniera diversa da alcuni editori e studiosi: Lobel (1925, xiv) ha sostenuto la possibilità che
Tullio Laurea sia stato indotto in errore a causa dell’ambiguità di qV che, secondo Lobel, “may stand
equally well for the eighth or the ninth term in a series of books”. Questa ipotesi è stata, riteniamo,
efficacemente respinta da Page (1955, 112-113), secondo il quale il numero dei libri di Saffo doveva
essere, nel I secolo a.C., qualcosa di molto noto e non era possibile per Laurea intendere male tale numero
senza l’eventualità di essere, in qualche modo, contraddetto. Liberman (2007, 45 n. 19) mostra scetticismo
sia verso l’ipotesi di Lobel, sia verso la confutazione di Page, ma si tratta, rispetto alla nostra indagine, di
un dato secondario. 203
Così, giustamente, Liberman 2007, 43. 204
Per il catalogo delle Muse cfr. Hes. Theog. 75-79.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
103
alessandrina, fissando le informazioni che abbiamo su di essi e dedicando al quarto libro
una trattazione più estesa nel prosieguo di questa introduzione.
Saffo, libro I-III
Partiamo, ovviamente, dai libri su cui non ci può essere discussione, in quanto lo stesso
Efestione usa l'espressione o{lon (di seguito tradotto in corsivo) che non lascia adito ad
alcuna incertezza.
Il primo libro dell'edizione alessandrina dei carmi di Saffo era composto completamente
in strofi saffiche205
, ognuna di tre versi . Una subscriptio presente nel POxy. X
1231 ci informa, inoltre, che esso constava di 330 strofi di quattro versi, per un totale di
1320 versi, circa sessantasei odi. Un opinione oggi condivisa da tutti gli studiosi vuole
che il primo libro di Saffo si aprisse con la celeberrima ode ad Afrodite206
(Sapph. 1 V.),
tradita da molti autori antichi e da alcuni papiri. Edgar Lobel ha posto l’accento su un
fenomeno del tutto particolare: secondo lo studioso inglese, poiché le odi tradite dal
POxy. 1231 inziano per o(ij) [= Sapph. 16 V.], p(lavsion) [=Sapph. 17 V.], P(avn) [=
Sapph. 18 V.] e poiché la loro successione non sembra dovuta ad un principio di
classificazione tematico (le odi trattano di argomenti diversi), sarebbe lecito intravedere
la possibilità di un ordine alfabetico: vedremo che una simile ipotesi è stata avanzata,
forse non senza ragiore, dallo studioso anche per il libro quarto, ma questo criterio non
deve essere stato seguito lungo tutto il corso dell’opera od anche di uno stesso libro207
.
Il secondo libro, invece, era composto completamente da pentametri eolici208
oppure, per riprendere le parole di Efestione, “versi saffici di quattordici sillabe”, un tipo
di struttura metrica che oggi viene interpretato come un gliconeo con doppia espansione
dattilica (gl2d
). Efestione per un “verso saffico di quattordici sillabe” cita Sapph. 49.1 V.
jHravman me;n e[gw sevqen [Atqi pavlai potav “Un tempo io ero innamorata di te,
Attide”: Liberman (2007, 47) nota, giustamente, che se questo verso, come è verosimile,
fosse stato il primo del secondo libro, difficilmente avrà potuto rispondere ad un criterio
205
Cfr. schol. in Pi. Pyth. II, p. 5-6 Drachm.; Sacerd. Gr. Lat. VI 546.8s. Keil. 206
Così, ad esempio, Campbell 1982, 55 n. 1; Liberman 1999, LVI. 207
Difatti, come nota Liberman (2007, 46), quella che si presume essere l’ode incipitaria di tutta
l’ediizione alessandrina comincia con poikilovqron∆, ovvero con la lettera p. Notare che, comunque, i tre
frammenti citati da Edgar Lobel non mostrano una successione alfabetica precisa. 208
Cfr. Heph. pp. 14.63 Consbruch.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
104
alfabetico: comincia, difatti, con un h. Abbiamo visto, tuttavia, come tutto ciò si riscontri
anche nel primo libro.
I carmi del terzo libro erano tutti, sostiene Efestione (X 6, p. 34 Consbruch), composti
in “versi saffici di sedici sillabe”, un metro che oggi viene interpretato come un gliconeo
con doppia espansione coriambica (gl2c
) e chiamato, talvolta, anche asclepiadeo
maggiore. Schol. in Theoc. XXVIII arg., p. 334 Wendel cita Sapph. 53 V.
brodopavcee" a[gnai Cavrite", deu'te Divo" kovrai “venerande Cariti dalle braccia di
rosa venite qui, figlie di Zeus” come un esempio di “verso saffico di sedici sillabe” e
secondo Liberman (2007, 48) si tratterebbe del primo verso del III libro di Saffo.
Dal libro quarto in poi non vi può essere, purtroppo, una simile sicurezza, a causa della
mancanza di testimonianze solide ed univoche: tuttavia, poiché quest'opera si occuperà
esclusivamente del libro quarto, riteniamo necessario rimandare la trattazione su di esso
ai capitoli seguenti, ove sarà possibile approfondire l'argomento in maniera esauriente.
Saffo, libro V
Cesio Basso VI, p. 258, 15ss. GLK [= Sapph. Test. 230 V.], metricista di età neroniana, e
Terenziano Mauro (De metris 2545-2550, VI, p. 401 GLK), metricista dell’epoca di
Marco Aurelio affermano che dell’endecasillabo falecio (gl ba) si trovavano molti
(complures; saepe) esempi sparsi (dispersi; dispersos…inter carmina disparis figurae).
Secondo Liberman (2007, 53) dispersi significherebbe che nel quinto libro di Saffo
l’endecasillabo falecio si trovava come kw'lon all’interno di una struttura metrica più
estesa e formata anche da elementi metrici differenti; continuati, invece, indicherebbe
l’attestazione, nel quinto libro alessandrino, di endecasillabi faleci utilizzati kata;
divsticon, esattamente come l’ipponatteo acefalo espanso con due coriambi nel quarto
libro. Nel quinto libro, però, si trovava anche l’asclepiadeo, che i moderni chiamano
“minore”, ovvero un gliconeo espanso con un coriambo (glc), secondo quanto afferma
Fortunaziano (IV sec. d.C.?) VI, p. 295, 21 GLK [=Sapph. Test. 231 V.]: Liberman
(2007, 53) ha avanzato l’ipotesi che anche questo metro fosse usato kata; divsticon. Al
libro quinto è espressamente attribuito da Ath. IX 410e il fr. 101 V., che non presenta,
tuttavia, né endecasillabi faleci, né asclepiadei “minori”, ma uno schema metrico, a
quanto pare, simile se non identico a quello di Sapph. 94 V., ovvero strofe tristiche del
tipo aaB costituite da due gliconei (gl) (a) e da un gliconeo con espansione dattilica (gld)
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
105
(B). Sapph. 94 V. è tradito dalla celeberrima pergamena di Berlino, il P. Berol. 9722
[MP3 1451, LDAB 3901], che tramanda il testo di altre due odi (Sapph. 96; 95 V.)
organizzate kata; stivcon, ma ogni verso delle quali, essendo troppo lungo, veniva ad
essere sviluppato su tre linee susseguenti, come se si trattasse di tre stivcoi diversi (cr gl
gl gl ba), l’ultimo dei quali, se preso da solo, poteva essere considerato, appunto, un
endecasillabo falecio (gl ba). Per ricapitolare, nel libro V sarebbero stati presenti, a
quanto possiamo saperne, odi in strofe distiche di endecasillabi faleci (gl ba), odi in
strofe distiche (?) in asclepiadei minori (glc) ed odi tristiche o formate da tre kw'la la cui
unità di base era il gliconeo (gl), ad esempio: gl gl gld
gl gl cr gl cr gl
gl gl ba . Probabilmente nel quinto libro saranno state presenti anche altre strutture
metriche, ma sempre aventi, come unità di base, il gliconeo.
Libri VI-VII
Sul sesto libro di Saffo non sappiamo assolutamente niente, fuorchè il fatto ovvio (ma è
già tanto) che è esistito, visto che le fonti ci parlano di un libro VII e, almeno, di un VIII.
L’unica testimonianza che abbiamo sul libro settimo la dobbiamo, ancora una volta, ad
Heph. 10.5, p. 34 Consbruch che attesta la presenza, nel libro settimo, di carmi aventi
come struttura metrica versi di quindici sillabe composti da un giambo (ia), un gliconeo
(gl) ed un baccheo (ba): ia gl ba. Il testo di Efestione fornisce, tuttavia, un’altra
informazione, ma per apprezzarla occorre leggere il testo greco: ejpi; th'" tou' eJbdovmou,
dove l’articolo al genitivo femminile th'" abbisogna di un completamento, ma sia che
esso sia ãajrch'"Ã (Westphal), sia che sia ãteleuth'"/telou'"Ã (Bergk), la diretta
conseguenza sarà che anche il libro settimo era eterometrico, perché questa struttura
metrica era presente all’inizio o alla fine. Con il settimo libro terminano, purtroppo, le
testimonianze più strettamente metriche che ci tramandano gli autori antichi.
Libro VIII ed "Epitalami": un nono libro di Saffo?
Che esistesse un ottavo libro di Saffo lo attesta Phot. Bibl. 161, p. 103a, 19ss. Bekker [=
Sapph. Test. 233 V.], in cui si afferma che Sopatro il Sofista citava ajpo; ojgdovou lovgou
th'" Sapfou'", “dall’ottavo libro di Saffo”, ma su di esso non sappiamo niente. Che
esistesse un libro intitolato o, come meglio riteniamo, portante come sottotitolo
jEpiqalavmia lo attesta principalmente Serv. Ad Georg. 1.31 (3, 1, 139 Thilo-H.)
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
106
Sappho, quae in libro, qui inscribitur jEpiqalavmia ait, “Saffo che, nel libro intitolato
Epitalami, dice…”. Il problema della corretta identificazione dei libri VIII e IX è, come
nota giustamente Liberman (2007, 56), “un des problèmes les plus délicats des études
sapphiques” e dipende, in larga misura, dalla corretta interpretazione di Sapph. 103 V.,
che sembra riportare un elenco del primo verso di dieci poesie che si susseguivano: non
è possibile passare in rassegna tutti i problemi che pone agli studiosi questo frammento e
conviene limitarsi solo a qualche osservazione. Ferrari (2007a, 114 n. 2) e Puglia (apud
Ferrari, l.c.) prospettano, rispetto all’interpretazione tradizionale, secondo la quale gli
Epitalami sarebbero il nono libro, una differenza notevole: per loro “Epitalami”
dovrebbe essere (da quanto si deduce dal testo di Ferrari: la frase diretta non è
presente209
) il titolo dell’ottavo libro (?) e non del nono. Ferrari e Puglia, tuttavia, non
sembrano prendere in considerazione il testo che precede stivc(oi) r —l[, ovvero quello
che sembra proprio essere un ]H—: dunque il testo del papiro dice “ottavo versi
centotrenta-“: i 130-139 versi sembrano essere, dunque, quelli del libro ottavo. Questa
nota sticometrica sembra avere, dunque, valore finale (soprattutto considerando il fatto
che è posta dopo gli incipit di dieci odi susseguenti e, del resto, non avrebbe senso porla
a metà di un indice) ed ad essa corrisponde, al r. 17, un’altra notazione ( jEpiqa]lavmia—)
ed anche essa sembra essere un titolo, perché, come già notava Page (1955, 118) essa è
posta “in the middle…of the line” ed inoltre sembra sormontata, almeno alla fine (forse,
però, lo era anche all’inizio) da una cornice costituita da una linea orizzontale posta
sopra ed una sotto. jEpiqa]lavmia —, dunque, sembra essere il titolo del libro successivo e
non del precedente, come lo intende Ferrari; del resto, se fosse il titolo del libro
precedente, mancherebbe quello del libro successivo: se è così, questa sarà un’altra
prova dell’esistenza di un nono libro e del fatto che esso portasse, appunto, il titolo
“Epitalami”. Più suggestiva, invece, è l’ipotesi proposta dal Puglia, ovvero che questo
papiro rechi una schedatura o un indice delle poesie più belle (bevlt∙e‚i≥o≥n al r. 18) di
ogni singolo libro: Puglia sostiene che il copista del papiro avrebbe prima elencato il
numero di tutte le poesie che erano contenute, poi il numero delle poesie più belle e ne
citasse tutti i versi iniziali. Mossi dall’istinto si potrebbe spiegare proprio in questo modo
il fatto che del libro ottavo (?) il copista abbia trascritto gli incipit di sole dieci poesie,
209
La frase che più di tutte si presta ad una tale conclusione è quella in cui si dice “a partire dal r. 18 non si
parlerebbe più del libro intitolato “Epitalami”, ma di un nuovo libro”.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
107
ma ragionando attentamente sembra poco probabile applicare questa ipotesi a quei dieci
versi iniziali e proprio a causa di quello che segue, ]H— stivc(oi) r—l[, ovvero “(libro)
ottavo versi centotrenta-“: considerando che si trovano elencate dieci poesie,
centotrenta-centotrentanove versi sembrano essere un numero proporzionato, seppur
esiguo rispetto ai 1320 stivcoi che il POxy. 1231 testimonia per il primo210
, per l’intero
libro ottavo. bevlt∙e‚i≥o≥[n (la parte finale della parola non è, comunque, di lettura
agevole) al r. 18 è, tuttavia, presente veramente: lo si dovrà riferire al libro successivo,
ovvero agli Epitalami. È tuttavia possibile che questo dato fosse presente anche per il
libro precedente, nella parte di testo in lacuna: si potrebbe, quindi, ipotizzare una schema
generale del tipo “Libro x. Di questo libro la poesia più bella è…Sono in tutto tot poesie,
di ciascuna delle quali il primo verso è…Libro x, numero dei versi…Breve nota metrica.
Libro y. Di questo libro la poesia più bella è…Sono in tutto tot poesie, di ciascuna delle
quali il primo verso è…Libro y, numero di versi…Breve nota metrica. Libro z. Di
questo libro la poesia più bella è…etc.”. Qualche considerazione va dedicata anche al
metro dei dieci incipit citati: come ha ben notato Ferrari (2007a, 114 n. 2), sulla scorta di
Page (1955, 118-119), nove su dieci sembrano avere come metro proprio l’ipponatteo
acefalo con doppia espansione coriambica, il metro del nostro “libro quarto”, o
comunque sembrano non essere “incongruenti” con una tale struttura metrica: o si cerca
di dare una spiegazione diversa e ciò sembra poco probabile, oppure dobbiamo
arrenderci all’evidenza che anche nel libro ottavo predominasse (quasi nove poesie su
dieci) lo stesso metro del libro quarto211
: è un osservazione davvero sconcertante per chi
si deve apprestare a fare un’edizione del libro quarto basandosi solo sul metro.
9. Il libro quarto di Saffo
Riteniamo corretto affrontare ora le problematiche attinenti al quarto libro dell'edizione
alessandrina: poiché questo lavoro verterà solo su di esso, è giusto poter esaminare in
modo esaustivo ogni particolare del libro e dei frammenti di cui andremo ad occuparci.
Prima di proseguire occorre fare una puntualizzazione: la nostra ricostruzione non potrà
fondarsi su elementi solidi ed ogni ricostruzione qui proposta (o proposta da altri) dovrà
essere considerata una mera ipotesi.
210
Cfr. Liberman 2007, 58 211
Non sarà inutile notare che otto è il doppio di quattro: il libro quarto ed il suo doppio, il libro ottavo,
sembrano avere lo stesso metro: non sembra essere, certo, un caso della sorte.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
108
Struttura metrica, struttura strofica ed ordine delle odi
Il metro: testimonianze e criteri di attribuzione al libro quarto
Il primo obiettivo che qui ci poniamo è quello di delimitare il libro quarto ed in
subordine l'estensione di questa edizione: tuttavia, come presto ci accorgeremo, ciò non
sarà possibile se non accettando una buona percentuale di ipotesi. Abbiamo visto,
parlando degli altri libri della edizione alessandrina, che riguardo ad essi (tranne che al
sesto) abbiamo delle testimonianze precise (Efestione o altri autori, in altre parole,
indicano direttamente il numero del libro a cui si riferiscono) o più vaghe: questo non
avviene per il libro quarto e quindi non c'è alcuna testimonianza che possa rivelarsi
direttamente utile. C'è, però, una testimonianza che può essere attribuita al quarto libro e
si trova, ancora una volta in Efestione: egli, parlando dei tetrametri ionici a maiore
acatalettici, rileva (11, p. 36 C.):
kai; tetravmetra de; ajkatavlhkta diafovrw" sunevqesan: h] ga;r trisi;n ijwnikai'" mivan trocai>kh;n th;n teleutaivan ejphvgagon: kalei'tai de;• Aijoliko;n, o{ti Sapfw; pollw'i aujtw'i ejcrhvsato: oi|on: eujmorfotevra Mnasidivka ta'" aJpala'" Gurivnnw": ajsarotevra" oujdamav pw Ei[rana sevqen tucoi'san: parathrei'n de;• crhv, o{ti th;n prwvthn suzugivan kai; ajpo; braceiva" ajrcomevnhn poiou'sin, w{sper kai; ejn toi'" trimevtroi"
Composero in modo eccellente anche tetrametri acatalettici, oppure aggiunsero ai tre ionici una
clausula trocaica: è chiamato eolico, perché Saffo lo ha usato molto, ad esempio:
Mnasidica è più bella della delicata Girinno.
Non avendo mai incontrata una ragazza più fastidiosa di te, Irene.
Occorre, però, prestare attenzione al fatto che rendono la prima coppia di elementi iniziante
anche con un breue, come anche nei trimetri ionici.
Efestione non parla esplicitamente del libro quarto212
, ma è evidente che la struttura
metrica dei versi che cita come esempio è la stessa di tutti i frammenti traditi dal POxy.
1787. D'altronde, dal colofone (?) dello stesso papiro (Sap[ / Me≥[) è evidente che si tratti
di odi saffiche, anche se, a causa di un guasto, non viene specificato il libro di
appartenenza. C'è da fare, poi, un'ulteriore considerazione: come è stato notato dai vari
editori, la sequenza iniziale delle lettere del primo verso citato dal metricista è
congruente con un frammento del POxy. 1787, ovvero il fr. 34, dove si ha, al v. 5,
]morfo≥[, una sequenza ben integrabile con euj]morfo≥[tevra: è per questo che
212
E non poteva certo farlo se, come nota Ferrari, esso è anche il metro forse, addirittura, di nove su dieci
degli incipit elencati in Sapph. 103 V., ma cfr. supra.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
109
nell'edizione Voigt la citazione di Efestione ed il frammento papiraceo sono compresi
sotto un'unica numerazione, F 82. Quanto si è detto fino ad ora, tuttavia, dimostra
soltanto che i frammenti traditi dal POxy. 1787 sono parti di odi saffiche e che sembrano
condividere la stessa struttura metrica con i due versi traditi dal metricista, ma tutto ciò
non può, sic et simpliciter, indurre ad attribuire queste odi mutile al libro quarto.
L’appartenenza di questi frammenti al libro quarto è suggerita, per la prima volta, non
già dal Lobel (1925, xii), come pensa Liberman (2007, 48), ma dallo stesso editore del
papiro ossirinchita, Arthur S. Hunt (1922, 26), il quale nota: “Since the fifth book was of
a different character, consisting partly, at any rate, if the Berlin fragments belonged to it,
of poems in strophes of three lines, it seems that the only book to which the two lines
strophes of 1787, which are entirely analogous to those of Books ii and iii, can be
logically referred is Book iv”. Per Liberman, invece, il prw'to" euJrethv" sarebbe Edgar
Lobel, ma l’editore inglese avrebbe operato in tal senso senza fornire alcuna prova o
dimostrazione: si tratta, evidentemente, di un errore213
di Liberman. La stessa
spiegazione fornita da Hunt la dobbiamo anche a Denys Page214
, il quale affema: “the
evidence, so far a sit goes, indicates that these manuscripts (scil. POxy. 1787) come from
a book wholly or largerly homogeneous in metre: if so, it appears reasonable to assign to
it the fourth place in the series, since the first three books were metrically homogeneous
whereas the fifth was not”.
Occorre fare, ora, alcune precisazioni di carattere metrico. Efestione parla di tetrametri
ionici acatalettici con l'ultimo, il quarto, ionico realizzato con una clausula trocaica, ma
la sua non è la terminologia corretta. Egli sta, ovviamente, parlando di tetrametri ionici a
maiore ( ) ed interpreta la sequenza metrica dei due versi
citati come un tetrametro ionico a maiore acatalettico con l'ultimo ionico realizzato
come un trocheo ed il primo elemento passibile anche di una realizzazione come breue,
cioè:
213
Lobel (1925, xii) non fornisce alcuna spiegazione dell’attribuzione dei frammenti del POxy. 1787 al
libro quarto; ma ecco il testo di Lobel: “Bk. IV (?): POxy. 1787+PHal. 18 (III sec. A.D.)”. Lobel, dunque,
non doveva alcuna spiegazione di quella operazione, visto che essa si trovava già nell’editio princeps; e se
qualcosa si deve rimproverare a Lobel è di non aver riportato il pensiero di Hunt. Comunque sia, l’editio
princeps del POxy. 1787 fu pubblicata da Hunt nel 1922, mentre la Preface dell’edizione di Lobel porta la
data “Oxford, July 1923” e del resto Lobel non avrebbe potuto pubblicare i frammenti del papiro
ossirinchita senza l’editio princeps di Hunt. Su questo dato dell’anteriorità dell’attribuzione di Hunt non
bisogna, tuttavia, insistere troppo, perché, come afferma lo stesso Hunt (1922, 26), Lobel stesso collaborò
all’editio princeps del maggior testimone del “libro quarto”. 214
Page 1955, 114-115.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
110
Tuttavia, secondo la metrica moderna, non solo questa sequenza non può essere
interpretata come un tetrametro ionico, ma addirittura attestazioni sicure del tetrametro
ionico a maiore non vi sarebbero, se non a partire dal IV secolo a. C., quando si data il
poeta Cleomaco di Magnesia, da cui prese il nome il cleomacheo, dimetro ionico a
maiore acataletto215
.
Si tratta, quindi, di tutt'altro: l'interpretazione che identifica il metro di questi
componimenti nel parasclepiadeo maggiore non solo è più economica (l'asclepiadeo è,
come sappiamo, un metro eolico), ma potrebbe anche giustificare l'attribuzione di tutti i
frammenti del POxy. 1787 e della citazione di Efestione al quarto libro alessandrino:
considerando che il metro del libro terzo era l'asclepiadeo maggiore, ovvero la stessa
struttura di base ma con assenza dello slittamento di un elemento della base eolica
dall'inizio alla fine, è verosimile ritenere che i parasclepiadei fossero a stretto contatto
con gli asclepiadei, ovvero li seguissero nel corso dell'edizione. Liberman (2007, 49) ha,
inoltre, notato come il metro dei primi tre libri fosse omogeneo, mentre quello di ogni
libro dal quinto in avanti non doveva esserlo; il libro secondo era caratterizzato da un
verso di quattordici sillabe, mentre il terzo da un verso di sedici, proprio come sedici è il
numero di sillabe del metro del supposto libro quarto.
Lo schema metrico generale dei componimenti per i quali si ipotizza l'appartenenza al
quarto libro sarà, quindi, il seguente:
ovvero asclepiadeo maggiore con un elemento libero della "base" eolica slittato
dall'inizio alla fine. Una tale sequenza metrica può, però, essere interpretata anche in
altri modi e perciò ricadere sotto altre nomenclature, prima tra tutte quella di ipponatteo
acefalo con doppia espansione coriambica, ovvero hipp2cho
(è preferibile, per evitare
confusioni, ricorrere a quest'ultima abbreviazione, piuttosto che a hipp2c
usata dalla
Voigt). La sequenza dell'ipponatteo acefalo è soggetta ad essere chiamata in modo
diverso a seconda degli studiosi: enopolio coriambico A, oppure paragliconeo (cioè
gliconeo con un elemento libero slittato dall'inizio alla fine: Koster), oppure enopolio
cratineo (Gentili): da ultimo M. L. West ha proposto per un tale schema metrico il nome
215
Cfr. Martinelli 1995, 220 e 230-2.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
111
di agesicoreo, derivandolo da un famoso luogo del Partenio del Louvre di Alcmane (F
1.57 Davies = 3.57 Calame: JAghsicovra me;n au{ta), un componimento dove ricorre
spesso la sequenza di cui si sta parlando.
La suddivisione strofica
Abbiamo così stabilito che sia molto verosimile (se pure non certo) attribuire tutti i
frammenti composti in parasclepiadei maggiori al libro quarto, ma non possiamo
dimostrare che tutte le odi di quel libro fossero in tale metro: questo, a ben guardare, non
è dimostrabile, data la penuria di testimonianze in nostro possesso.
Affrontiamo, ora, i problemi relativi alla suddivisione strofica dei carmi del supposto
“libro quarto”.
La stragrande maggioranza dei carmi traditi dal POxy. 1787, i due traditi dal PKöln
21351+21376 e, con ogni versosimiglianza, quelli di tradizione indiretta sembrano
essere organizzati in strofe distiche (kata; divsticon), ovvero in strofe di due versi
ciascuna216
. La suddivione tra una strofa e l’altra è data, per nostra fortuna, da un
simbolo grafico, la paravgrafo", una breve linea orizzontale che corre nell’interlinea:
dove essa è presente e ben visibile, siamo certi della corretta suddivisione strofica del
carme. Esistono, tuttavia, due tipi diversi di paravgrafoi, quelle accompagnate e quelle
non accompagnate sul margine da una coronide. La paravgrafo" con coronide non
indica fine di strofe, ma fine di strofe con contemporanea fine di componimento: dato,
quest’ultimo, che assume ovviamente un’importanza maggiore. Dato il cattivo stato di
conservazione dei papiri (ovvero in caso di completa perdita dell’intercolumnio),
talvolta può risultare difficile dire se una paravgrafo" indica, in una certa parte del
papiro, fine di strofe o fine di componimento. La stragrande maggioranza dei carmi
traditi dal POxy. 1787 e dal PKöln 21351+21376 presenta, dunque, una suddivisione per
strofe distiche, esattamente come kata; divsticon erano organizzati i carmi del libro
secondo e del libro terzo217
: questa osservazione non può che confermare l’attribuzione
216
Per la suddivisione in strofe distiche della stragrande maggioranza delle odi tradite del supposto quarto
libro cfr. Fassino-Prauscello 2001, 12-13. 217
Sull’articolazione distica delle odi dei libri secondo e terzo cfr. Fassino-Prauscello 2001, 9-12.
L’organizzazione per strofe distiche è sostenuta da Heph. p. 59, 7-10 ~ p. 63, 4-8 e 15-24 Consbruch. I
testimoni diretti dei due libri non presentano, purtrpoppo, le paravgrafoi, ma che la suddivisione a cui
accenna il metricista antico sia corretta è dimostrata dai papiri di Alceo che tramandano odi nello stesso
metro dei libri II-III di Saffo: si tratta di Alc. 38a per i pentametri eolici (gl2d
) e di Alc. 50 e, forse, 44 per
gli asclepiadei maggiori (gl2c
): essi presentano tutti una suddivisione distica.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
112
dei carmi che più tardi commenteremo al quarto libro218
. Una struttura strofica kata;
divsticon comportava, probabilmente, che ogni due versi si ripetesse la stessa melodia
musicale su cui veniva cantata una singola strofe219
.
Le varie considerazioni fin qui sviluppate non devono in alcun modo indurci a pensare
che tutte le odi del supposto quarto libro fossero in distici di parasclepiadei maggiori, o
ipponattei acefali con doppia espansione coriambica che dir si voglia. C’è un caso in
particolare, nel numero delle odi del “libro quarto” che merita la nostra attenzione: la
Hamm (1954, 455) fu la prima ad accorgersi che la disposizione delle paravgrafoi
operata da Lobel nell’edizione del POxy. 2290220
non era corretta e che i versi 7, 10, 13
e 16 sembravano essere più brevi degli altri (offenbar kürzer als die übrigen): si doveva
trattare, dunque, non di strofe distiche, ma tristiche, con il terzo verso più breve dei
primi due. L'argomentazione non era banale e poteva portare, anche, ad attribuire questo
frammento ad un altro libro, senonchè Gallavotti e la Voigt notarono, pur non potendo
averne la certezza, che anche alcuni frammenti del POxy. 1787 potevano essere
ricondotti ad una tale struttura: si tratta dei fr. 64a, 65, 73 ed 86 V.221
. Lobel, al momento
di preparare la nuova edizione di Saffo e di Alceo, stavolta in collaborazione con Denys
Page (Lobel-Page 1955, 66-67), accolse le argomentazioni della Hamm e modificò la
posizione delle paravgrafoi nel testo critico. L'ode tradita dal POxy. 2290 è, dunque, in
strofe tristiche, ma la struttura metrica non è definibile con precisione, a causa della
mancanza della parte centrale di tutti i versi: i primi due di ogni strofe dovrebbero essere
ipponattei acefali con x espansioni coriambiche (choriambisch erweitertes
Hipponakteum, nella terminologia usata da Hamm 1954, 455), mentre il terzo verso un
ipponatteo espanso con un coriambo in meno degli altri due, ovvero hippxcho
║ hippxcho
║ hippx-1cho
. Secondo Fassino-Prauscello (2001, 13), Ferrari (2005, 19-20 n. 14) e
Liberman (2007, 49) l’ode tradita dal POxy. 2290 sarebbe costituita da strofe tristiche
formate da due ipponattei acefali con due espansioni coriambiche e da un ipponatteo
218
Così Liberman 2007, 49. 219
Cfr. Fassino-Prauscello 2001, 13. Il dato musicale, ovviamente, non è per noi più ricostruibile. 220
Lobel 1951, 7-10. Il POxy. 2290, era stato pubblicato per la prima volta da Edgar Lobel nel 1951,
all'interno del ventunesimo volume de "The Oxyrhynchus papyri": il primo editore lo attribuì a Saffo,
precisamente al IV libro, "on grounds of dialect, metre and contents" e lo dotò di quelle paravgrafoi di
cui era privo a causa di guasti materiali, basandosi, però, sulla suddivisione distica della maggioranza dei
frammenti traditi dal POxy. 1787. 221
Su quali siano effettivamente i frammenti che dimostrano una organizzazione in strofe tristiche non c’è
un vero e proprio accordo tra gli studiosi, ma ne parleremo ad loc.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
113
acefalo con una sola espansione coriambica, ovvero da due parasclepiadei maggiori e da
uno minore (in simboli: hipp2cho
║ hipp2cho
║ hippcho
): si tratta, nel complesso, di un
opinione condivisibile222
. Sull’attribuzione di quest’ode al “libro quarto” (ciò che
probabilmente è di più stretto interesse) gli ultimi studiosi intervenuti nella discussione
mostrano due opinioni diverse: se Fassino-Prauscello (2001, 13) e Liberman (2007, 49)
mostrano di condividere l’opinione della Voigt e di approvare un’attribuzione dell’ode
tradita dal POxy. 2290 al “libro quarto”, Ferrari (2005, 19-20 n. 14; 2007, 29 n. 3) si
mostra più scettico: la conclusione di quest’ultimo studioso è che “F 88 proviene da un
rotolo diverso e non sappiamo a quale libro appartenesse”.
Assumere una posizione univoca in questa discussione sull’attribuzione dell’ode tradita
dal POxy. 2290 al “libro quarto” risulta difficile: se, da un lato, la posizione di Ferrari
sembra, forse, troppo scettica223
, dall’altro, l’ipotesi di Liberman (2007, 49-50), secondo
cui il libro IV sembrerebbe la giusta transizione tra un libro terzo completamente
omometrico ed un quinto del tutto eterometrico e dunque sarebbe in parte omometrico
ed in parte eterometrico, sembra troppo ben costruita, soprattutto tenendo in
considerazione i secoli che passano tra la morte di Saffo e la presunta edizione di
Aristofane, per non parlare di quella successiva, quella di Aristarco (e proprio di
quest’ultima, presumibilmente, i POxy. 1787 e 2290 dovrebbero essere due testimoni).
Abbiamo, dunque, accolto l’ode sospetta nella nostra edizione del libro quarto, ma
l’abbiamo posta in penultima posizione (l’ultima è occupata da un commentario che,
vista la sua natura, non poteva assumere una posizione precedente).
Tracce di un ordine alfabetico?
“Lobel n’a pas manqué de constater un ordre alphabétique dans la succession de
fragments de poèmes en distiques consécutifs dans le papyrus (59, 62 et 63 V.)” nota
Liberman (2007, 50), ma di tutto ciò si era già accorto Hunt (1922, 27): “it is noticeable
222
Marco Fassino, Lucia Prauscello e Franco Ferrari (che cita esplicitamente il contributo dei due autori
sopramenzionati) parlano della struttura metrica hipp2cho
║ hipp2cho
║ hippcho
come se fosse già stata
ipotizzata dalla Voigt, ma l’ultima editrice di Saffo (1971, 97) non accenna minimamente a questa
possibilità, anzi resta nel vago: nella sua edizione, alla voce “metrum:” troviamo scritto hippxcho
║
hippxcho
║ hippx-1cho
. 223
Se, dunque, il POxy. 2290 non è con sicurezza un testimone del “libro quarto”, Franco Ferrari, in
particolare, dovrebbe dire come è possibile spiegare la presenza, evidente, di componimenti in strofe
tristiche (probabilmente hipp2cho
║ hipp2cho
║ hippcho
) anche nel numero dei frustoli del POxy. 1787,
questo sì un testimone certo del “libro quarto”.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
114
that three out of the four poems of which the initial letter has survived begin with E, but
the fact that in Fr. 3.ii E is succeeded by O, while not definitely excluding an
alphabetical arrangement, is certainly not in favour of it”. Per Liberman è lecito dubitare
che un ordine alfabetico prevalesse in tutto il libro quarto: un altro frustolo dello stesso
POxy. 1787, il fr. 34 sembra essere il testimone diretto del primo verso citato da
Efestione e che è stato attribuito, sulla base della spiegazione del metricista e di altre
considerazioni, al libro quarto, ovvero euj]morfo≥[tevra Mnasidivka ta'" aJpala'"
Gurivnnw":: se l’integrazione recata al testo del papiro è corretta e se le odi si susseguissero in
uno stretto ordine cronologico questo verso, a partire dalla Voigt considerato l’attacco di una
nuova ode, dovrebbe essere posto tra l’ode che comincia con ejptavxate e la successiva, quella
che inizia con o[noire, ma ciò non avviene perché sul testimone questi ultimi due componimenti
si susseguono senza alcun vacuum nel mezzo.
Conclusioni sulla delimitazione del “libro quarto”
L’attribuzione dei componimenti traditi dal POxy. 1787, dal POxy. 2290, dal POxy.
2293 e dalla tradizione indiretta (Efestione, Ateneo) al libro quarto dell’edizione
alessandrina della poetessa eolica non è, dunque, altro che un’ ipotesi, un ragionamento
logico sviluppato da Hunt, da Lobel (probabilmente insieme ad Hunt stesso) e dal Page,
accolto prima dal Diehl e poi dalla Voigt e, tacitamente, da tutti gli altri studiosi
successivi che si sono occupati delle odi saffiche in parasclepiadei maggiori. Le scarse
conoscenze a nostra disposizione e più di due millenni di distanza non ci permettono di
stabilire se questa attribuzione sia veritiera o meno: essa è soltanto “logica”, con ogni
sconcertante risvolto che si cela dietro questa conclusione. Che il carme tradito dal
POxy. 2290 appartenesse anche esso al “libro quarto” è anche questo frutto di un
ragionamento logico, sviluppato dalla Voigt, ma è del tutto privo di una dimostrazione.
Qualcosa di più si può dire sul carme commentato nel testo del POxy. 2293: sembra aver
ragione il Lobel a sostenere che i lemmi rientrano nella struttura metrica del supposto
“libro quarto” dell’edizione alessandrina di Saffo: e quelli che deviano apparentemente
da essa o si possono leggere in modo diverso, oppure sono del tutto ametrici e, dunque,
facenti parte dell’esegesi e non del lemma, ma cfr. infra ad loc.
Bisogna, tuttavia, aggiungere che non è affatto sicuro che il “libro quarto” includesse
solo componimenti in strofe distiche di parasclepiadei maggiori o in strofe tristiche di
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
115
due parasclepiadei maggiori ed uno minore: le informazioni disponibili sono troppo
scarse per giungere a simili conclusioni e la prudenza non è mai troppa. In conclusione:
la nozione stessa di “libro quarto”, rispetto a quella di libro primo, libro secondo, libro
terzo, è un artificio e come tale converrebbe porre questo nome, quando si riferisce non
al libro quarto storico, ma a quello restituito dai moderni, tra virgolette.
Il colofone del POxy. 1787 ed il titolo del libro quarto di Saffo
Vale la pena soffermarsi su un fatto extratestuale che all’apparenza può sembrare di
poca importanza, ma che non lo è affatto: stiamo parlando del fr. 45 del POxy. 1787. La
filologia ci insegna che tutto ciò che è extratestuale in un manoscritto o in papiro (titoli,
sottotitoli, scholia etc.) non è mai da mettere in secondo piano, perché può recare
informazioni notevoli: dunque hanno sbagliato Lobel (1925), Lobel-Page (1955) e Voigt
(1971) a non tenere in alcuna considerazione il fr. 45 del POxy. 1787: esso doveva
essere, a quanto pare, il colofone del papiro ossirinchita sopramenzionato. Che la mano
che ha tracciato il titolo sia, come afferma Hunt (1922, 46) “not identical, though similar
in type” non significa assolutamente che esso appartenesse ad un altro rotolo papiraceo: i
titoli erano spesso trascritti da altre mani o dalla stessa mano, ma con una grafia diversa.
Ecco il testo:
S—AP[
——ME≥[
—
Hunt (1922, 41) propose di integrare Sap[fou'" / Me≥[lw'n dV, supplemento accolto dal
Diehl1(1923, 365), ma è possibile, riteniamo, anche un’altra possibilità, tanto probabile
quanto quella di Hunt:
S—AP[FOUS DV
——ME≥[LPOMENH
—
Se il ragionamento fin qui sviluppato è corretto, il libro quarto avrà avuto, come
sottotitolo, proprio il nome della Musa Melpomene e questo nome può essere integrato
nel testo tanto bene quanto Me≥[lw'n dV. La posizione delle linee orizzontali potrebbe
dimostrare la bontà della nostra interpretazione ed integrazione: quella più alta e quella
più bassa tra le tre saranno servite per l’effetto estetico, ma quella centrale potrebbe
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
116
anche dividere il titolo dal sottotitolo. Il titolo così restituito sarebbe più proporzionale e
più equilibrato nelle dimensioni: l’effetto estetico sarebbe migliore. Inutile dire che la
possibilità di integrare Me≥[lpomevnh nel titolo del papiro fornisce una prova ulteriore
dell’attribuzione dei frammenti del POxy. 1787 al libro quarto della edizione
alessandrina di Saffo. Possibile, tuttavia, anche:
S—AP[FOUS MELWN DV
— ——ME≥[LPOMENH —
La tradizione diretta
Parlare di tradizione diretta di Saffo nel XIX secolo sarebbe stata davvero un’utopia nel
senso letterale del termine, un “non-luogo”, un qualcosa di inesistente, il ricordo di un
tempo che fu. Parlare di tradizione diretta oggi, nel XXI secolo, è la realtà e questo lo
dobbiamo a tutti coloro che, negli ultimi cento-centodieci anni, si sono occupati del
reperimento e della pubblicazione dei papiri: i principali autori di questo “miracolo”
sono, per Saffo e, soprattutto, per il quarto libro, Bernard P. Grenfell, Arthur S. Hunt ed
Edgar Lobel.
Quasi tutti i testimoni diretti del “libro quarto”, tranne il PKöln 21351+21376,
provengono da Ossirinco e sono databili, secondo le opinioni correnti, alla tarda seconda
metà del II secolo d.C. e non sarà un caso che datazioni simili vengono proposte anche
per la maggior parte dei papiri di Alceo e di altri autori: è il periodo della cosiddetta
“rinascenza” di età antonina224
.
Il P.Oxy. XV 1787+ P.Oxy. XVIII 2166(d) + P.Hal. 3 (inv. 18)
Il POxy. 1787 [MP3
1449, LDAB 3899], uno dei più importanti ed estesi testimoni della
tradizione dei frammenti di Saffo ed in particolare del supposto libro IV, fu pubblicato
nel 1922 da Bernard P. Grenfell e Arthur S. Hunt nel volume XV della serie The
Oxyrhynchus Papyri225
e datato al III secolo d.C.: è costituito da una galassia di
quarantacinque frammenti, alcuni dei quali hanno subito le sorti più varie: il POxy. 1787
224
La Porro (2006, 179) conta almeno quattordici papiri alcaici attribuibili al II secolo d. C. ed una
datazione simile viene proposta anche per altri poeti, Esiodo, Pindaro e Callimaco, ma cfr. Porro 2006,
189. 225
Cfr. Hunt 1922, 26-46.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
117
fr. 44 è la riedizione del P. Hal. 3 (inv. 18), un frustolo appartenente allo stesso rotolo
trafugato e poi rivenduto dagli stessi scavatori; un altro frammento, appartenente allo
stesso fondo, fu scoperto solo successivamente e pubblicato dal Lobel226
come POxy.
XVIII 2166(d). Tutti questi frammenti, tranne, ovviamente, il POxy. 2166(d), all'atto
della scoperta risultavano frammisti al centinaio di frustoli ora contrassegnati come
POxy. 2442, attraverso il quale si recuperano passi da varie opere di Pindaro,
segnatamente degli Inni, dei Peani, delle Pitiche etc.: gli editori, non potendo distinguere
i singoli rotoli originari, si accontentarono di suddividere tutti i reperta in base al
dialetto (evidentemente dorico o eolico) ed all'ipotetico autore: Pindaro per il POxy.
2442, Saffo per il POxy. 1787. Il nostro papiro di Saffo (POxy. 1787) vide la luce
contemporaneamente al POxy. 1788 (Alceo) ed al POxy. 1604 (Pindaro, Ditirambi),
ovvero durante lo stesso ritrovamento avvenuto alla fine del gennaio 1906 nel corso
della quinta campagna di scavo ad Ossirinco, nel kôm Ali el Gamman. La situazione,
tuttavia, è molto più complessa di quella che fino a qui si è potuta tratteggiare: il POxy.
1788, infatti, che contiene frammenti eolici attribuiti ad Alceo e che fu pubblicato, come
si nota dalla numerazione, nelle pagine seguenti dello stesso volume POxy. XV, fu
ritrovato insieme al POxy. 2445, che per il primo frammento si può associare al POxy.
1604: ecco, quindi, che si formano due gruppi: il primo costituito dai POxy. 1787 e
2442; il secondo dai POxy. 1788, 2445 e 1604. Arthur S. Hunt distingueva nettamente lo
scriba del POxy. 1787 da quello del POxy, 1788: "the following lyric fragments (scil.
POxy. 1788) in Aeolic dialect proceed from the same find as 1787 and are in a script
which, though smaller, is very similar in type; the formation of some letters, however,
notably m, is different and the two MSS. cannot be taken for the work of a single
scribe"227
: perciò gli editori, nel complesso, datarono il papiro di Saffo al III secolo d.C.
(come, del resto, il POxy. 2442) e quello di Alceo al tardo II secolo d.C.: tuttavia, Maria
Serena Funghi e Gabriella Messeri Savorelli hanno notato228
che la scrittura di tutti i
frammenti qui richiamati (1604-1787-1788-2442-2445) ha un "carattere assai poco
formale" e sembra identificarsi con quella di un solo copista: le differenze possono
essere “mitigate” considerando il fatto che si potrebbe trattare di molti rotoli di autori
diversi (Pindaro, Saffo, Alceo, Alcmane). La Funghi e la Messeri hanno proposto il
226
Cfr. Lobel 1941, 44. 227
A. S. Hunt, Alcaeus? in B. P. Grenfell – A.S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, XV (1922), pp. 46 ss. 228
Cfr. Funghi-Messeri Savorelli 1992, 43-62.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
118
confronto con altri papiri: si trovano delle caratteristiche comuni tra questo complesso
fondo papiraceo ed alcuni papiri databili tra il 160 ed il 200 d.C. (P. Mil. Vogliano II 71,
contratto di matrimonio datato tra il 161 ed il 180 d.C.; P. Harris II 194, domanda per
ottenere in affitto il diritto di pesca, databile tra il 183/4 ed il 215/6 d.C.; P.Oxy. Hels.
36, mutuo di denaro dietro garanzia, databile al 167 d.C. etc.); su questa base hanno
sostenuto che tutti questi papiri debbano essere datati all'ultimo quarto del secondo
secolo d.C., con conseguente retrodatazione ad un tale periodo del POxy. 2442 e, per
quello che a noi qui interessa, del nostro POxy. 1787, il più importante testimone del
libro quarto della poetessa eolica.
Tutti questi prodotti papiracei considerati dalla Funghi e dalla Messeri vanno, dunque,
attribuiti alla mano di un unico copista, lo scriba 20 di Ossirinco, o “scriba di Pindaro”.
Nello stesso kôm Ali el Gamman furono trovati, ad una profondità di 6-10 m., da
Evaristo Breccia molti frammenti letterari e vari documenti appartenenti all’archivio di
Serapione Apolloniano. Si è dunque ipotizzato che tutti questi prodotti dello “scriba di
Pindaro” appartenessero alla biblioteca della famiglia di Serapione Apolloniano229
, ma
non vi sono prove per stabilirlo con certezza.
Il P. Köln (inv.) 21351+21376
Il P.Köln 21351+21376 [MP3
1449.01, LDAB 10253] è stato pubblicato tra il 2004 ed il
2005, a più riprese, da M. Gronewald e R.W. Daniel. Il testimone mostra una scrittura
caratterizzata, ancora, da alcune lettere in “stile” epigrafico (per gli editori, ed a ragione,
le lettere e, z, q e talvolta anche w sono scritte in un modo del tutto simile al
celeberrimo P.Berol. 9780, “Persiani” di Timoteo): la datazione proposta230
, dunque,
non può che essere gli inizi del III secolo a.C.: si tratta del più antico papiro di Saffo mai
pubblicato finora. Il caso vuole che il papiro più antico sia anche quello più
recentemente edito. Il repertum presenta un testo, più o meno leggibile, distribuito su
due colonne di scrittura.
Sul papiro sono presenti tracce di tre componimenti diversi: una prima ode, finora
inedita e sconosciuta, in parasclepiadei maggiori, è trascritta nei righi 1-11 della prima
colonna; una seconda ode, già precedentemente in parte conosciuta, anche essa in
229
Così, da ultimo, ad esempio Porro 2006, 182; Funghi-Messeri Savorelli 1992, 57. 230
Gronewald-Daniel 2004a, 1.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
119
parasclepiadei maggiori, occupa i righi 12-15 della prima colonna ed i righi 1-8 della
seconda, per complessivi dodici versi; il terzo componimento, che si estende per tredici
righe (9-21) sulla colonna di destra del papiro, non è saffico, perché presenta patine
dialettali che possono essere interpretate in modo diverso (eoliche o doriche, con la
prevalenza delle seconde sulle prime, anche se non sembrano essere univoche) e perché
reca, innegabilmente, una struttura metrica (ovviamente, se essa è presente) non solo non
identica a quella delle due odi precedenti (ipponattei acefali espansi, il metro del
supposto “libro quarto” di Saffo), ma che risulta del tutto estranea ai metri eolici usati da
Saffo, fondati, come essi sono, sull’impossibilità che in uno stesso verso si susseguino
più di due brevi231
: il primo verso, infatti, presenta otto sillabe brevi una di seguito
all’altra232
. Dei tre componimenti traditi dal papiro, il secondo è l’unico che già
conoscevamo: il POxy. 1787 fr. 1, infatti, presentava già la sua parte finale di ogni verso
ed il nuovo papiro ha, qundi, dato la possibilità di completare gran parte dei versi che
conoscevamo per metà o poco meno.
Il carme presentato sia dal papiro ossirinchita, sia da quello di Colonia e che gli studiosi,
per brevità, hanno intitolato in modo diverso (“Carme della vecchiaia” il Di Benedetto,
“Senilità” il Ferrari, “The Tithonos poem” il West) è preceduto, nei due testimoni, da
due odi diverse e questo ha causato molte discussioni tra gli studiosi. Il POxy. 1787 reca,
molto verosimilmente, il testo saffico dell’edizione alessandrina (quella di Aristarco?) e
dunque tutte le odi che presenta sono, ovviamente, saffiche, mentre il nuovo papiro, oltre
(a quanto sembra) a presentare un ordine diverso, fa seguire a due odi saffiche un altro
componimento che non è saffico (e nemmeno eolico). Il POxy. 1787 fr. 1 reca così
traccia di tre odi diverse, ma prima della pubblicazione del PKöln 21351+21376 nessuno
metteva in dubbio che il carme ora tradito da entrambi i papiri continuasse nei versi
seguenti, ovvero che il POxy. 1787 fr. 1 fosse il testimone di due soli carmi. Il nuovo
papiro presenta, invece, una situazione testuale diversa: i versi che seguono il “Carme
della vecchiaia” nel papiro di Ossirinco non sono presenti nel papiro di Colonia: si è
accesa, così, una discussione tra coloro che, rassegnatisi al testo del nuovo papiro,
pongono la coronide a fianco dell’ultimo rigo del carme tradito da entrambi i testimoni e
tra coloro che, invece, non accettando il testo di Colonia, ipotizzano per quest’ultimo
231
Cfr. Lundon 2007, 156 (e n. 33). 232
Così Gronewal-Daniel 2005, 7; West 2005, 1; Magnani 2005, 44; Nicolosi 2005, 87.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
120
papiro una costituzione diversa, ad esempio un’antologia, i cui curatori o autori
avrebbero potuto non inglobare alcuni versi di un carme (in questo caso i finali) se non
attinenti al tema prestabilito (forse la vecchiaia).
Il POxy. 2290
Il POxy. 2290 fu pubblicato nel 1951 da Edgar Lobel (1951a, 7-10), succeduto a
Grenfell e Hunt, nel volume XXI de The Oxyrhynchus Papyri. Il papiro è scritto in una
“angular script of a common type ordinarily assigned to the late second or early third
century”. Il primo editore attribuì l’ode tradita dal papiro a Saffo, precisamente al IV
libro, "on grounds of dialect, metre and contents" e la dotò di quelle paravgrafoi di cui
era priva a causa di guasti materiali. Prese a modello, dunque, i frammenti editi da Hunt
quasi trenta anni prima nel quindicesimo volume dei Papiri di Ossirinco, ovvero quelli
del POxy. 1787: una paravgrafo" ogni due versi, ovvero odi in strofe distiche. La
Hamm (1954, 455) fu la prima ad accorgersi che la disposizione delle paravgrafoi
operata da Lobel non era corretta e che i versi 7, 10, 13 e 16 sembravano essere più brevi
degli altri (offenbar kürzer als die übrigen): si doveva trattare, dunque, non di strofe
distiche, ma tristiche, con il terzo verso più breve dei primi due. Per la suddivisione
strofica e la struttura metrica dell’ode tradita da questo testimone cfr. anche supra et
infra ad loc.
Frammenti di un uJpovmnhma: POxy. 2293
Il POxy. 2293 fu pubblicato da Lobel (1951b, 16-23) nello stesso volume del papiro
precedente, il XXI dei Papiri di Ossirinco. Lobel datò la mano che ha vergato il testo al
II secolo d.C., mettendola a confronto con quella del POxy. 2176 (un commentario ad
Ipponatte). Il papiro tramanda alcuni frammenti di un commentario ad alcune odi di
Saffo e già il primo editore notava, giustamente, che i lemmi seguivano la struttura
metrica del quarto libro, ovvero ipponattei acefali espansi. Il copista (o l’esegeta?) si
dimostra, tuttavia, dotato di poca professionalità: talvolta, infatti, trascrive i lemmi
atticizzandoli, sicchè sorge il sospetto di aver riscoperto, grazie alla pubblicazione del
testo, una quantità o una lunghezza dei lemmi minore di quanto sarebbe stato
possibile233
. La Voigt (1971, 97-100), rispetto all’editio princeps ed a quella di Lobel-
233
Così Lobel 1951b, 16.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
121
Page (1955, 68-73), ha avuto il demerito di trascrivere il testo privandolo completamente
delle coronidi (forse per incertezza?) di cui è corredato il testo sul papiro: un’operazione
ben poco felice che, come vedremo, ha creato non pochi problemi.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
122
Sap[fou'" Melw'n DV Me≥[lpomevnh
Saffo
Odi
“Libro Quarto”
[Melpomene]
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
123
aV (fr. ineditum) metrum: ] , ^hipp2cho
suppl. possis
].o.[ 2 ].uc≥..[
].nu'n qal[iv]a g≥ ≥[ 4 ]. n≥evrqe de; ga'" g≥e.[...]..
]..n≥ e[co≥i≥san g≥evra" w["≥ [e[]o≥ike≥n≥ 6 ].oien wj" nu'n ejpi; ga'" e[oisan
] liguv≥ran, [a]i≥[ ken e[loisa pa'ktin 8 ]....a. k≥avla, Moi's∆, ajeivdw.
…
2 …
…ora la festa
4 ...ma sotto terra (io possa trovarmi)
…tenendo (l'insigne) prerogativa, come è conveniente,
6 …(mi ammirerebbero) così come ora che sono sulla terra
…(canto) armonioso, quando avendo preso la cetra
8 …cose belle, Musa, io canti.
TEST (I) P.Köln 21351 col. I, vv.1-8 [1 - 8]
CRIT 2 ].uc..[ ed. : ]e≥u[co≥m≥[ Di Benedetto 2005, 7 : ]y≥uvca≥[ Hardie 2005, 25 ║3
qal[iv]a Gronewald-Daniel 2004a, 5sq. g≥e≥v[noito vel g≥e≥[nevsqw Gronewald-
Daniel 2004a, 5sq : p≥a≥[revstw West 2005, 3 ║4 ge≥vn≥[esq]a≥i≥ Gronewald-Daniel
2004a, 5sq. : p≥e≥r[ivsc]oi West 2005, 3 : g≥e≥[noivma]n≥: Di Benedetto 2005, 7
║5 klevo" mevga Moivse]i≥o≥n≥ West 2005, 3 : kh' moisopovlwn e[s]l≥o≥n≥ Di
Benedetto 2005, 7 : molpav m∆e[ti Moivse]i≥o≥n≥ Hardie 2005, 24
║6 pavntai de; qaumav]z≥oien West 2005,3 : yu'caiv (vel skivai) kev me qaumav]z≥oien Di Benedetto 2005, 7 : au\qi" dev me Hardie 2005, 24 ║7 ajoivdan]
Gronewald-Daniel 2004a, 5sq., rec. Di Benedetto 2005, 7 : kavleisi celivdw] West 2005,
3 : faivnhn do;" ajoivdan] Di Benedetto 2005, 7 : ai[neisi m∆a[oidon] Hardie 2005, 24
: kavleisiv m∆ajhvdwn] Ferrari 2007a, 71 ║8 c≥e≥]l≥u≥vn≥n≥an≥ k≥avla, Moi's∆, ajeivdw
Gronewald-Daniel 2004a, 5sq. : h] bavrbiton h] tavnde ce]l≥u≥vn≥n≥an≥ q≥alavmois∆ ajeivdw
West 2005, 3 : e[maisi fivlaisi(n) - - - - - - -]...k≥ai≥; k≥avla, Moi's∆,ajeivdw Di Benedetto
2005, 7 : h]≥ k≥a;t≥ k≥alavmoi" a jeivdw Ferrari 2007a, 71 Il carme si struttura in due momenti diversi, uno dei quali, quello della contemporaneità,
viene segnalato dall’avverbio nu'n: nell’ode Saffo contrappone, dunque, l’”ora” (nu'n al
v. 3 ed al v. 6) e la condizione che l’aspetta dopo la morte. Hardie (2005, 23) ha avuto
l’idea ingegnosa di strutturare i vari momenti dell’ode in uno schema:
A: possa avvenire ora la festa,
B: ma che l’onore di cantare tocchi anche a me sottoterra
C: e le anime dei morti mi guardino ammirate,
D: come i vivi mi guardano ammirati quando io, presa la cetra, canti.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
124
2 Di Benedetto (2005, 7) congettura ]e≥u[co≥m≥[ "io prego", per cui cfr. infra Sapph.
DV eV 3 [= 86.3 V.]. Hardie (2005, 25), invece, propone di leggere ]y≥uvc≥a≥[. La lettura del
testo del papiro è difficile: prima dello hypsilon si nota soltanto un tratto di inchiostro a
forma di ricciolo alla stessa altezza della parte alta della lettera successiva.
3 qal[iv]a è un'integrazione degli editori (Gronewald-Daniel 2004a, 5s.): alla fine
del verso essi leggono g≥.[ e propongono di integrare g≥e≥v[noito o g≥e≥[nevsqw. West (2005,
3) ritiene valida l'integrazione qal[iv]a degli editori (il riferimento sarebbe ad una
festività interna al tìaso, cfr. Sapph. 2.15 qalivaisi V.), ma la sua lettura p≥a≥[revstw "ci
sia" è lontana dal g≥e≥[ degli editori, a cui si attiene, invece, il Di Benedetto. Come nota
Hardie (2005, 23) qaliva nel significato di “festa” al singolare è piuttosto raro, ma cfr.
comunque Xenoph. fr. 1.12 molph; d∆ajmfi;" e[cei dwvmata kai; qalivh “il canto e la
festa invadono la casa”; Thgn. 778 terpovmenoi kiqavrhi kai; ejrath'i qalivhi “gioendo
per la cetra e per l’amabile festa”. Notare la notevole ed iterata allitterazione tra nu'n di
questo verso e nevrqe del v. 4 e tra l'ipotetico g≥e≥[ e ga'" g≥e≥.[ sempre del v. 4.
4 Gronewald e Daniel (2004a, 5s.) leggono g≥e.[...].. e propongono di integrare
g≥evn≥[esq]a≥i≥, ma West (2005, 3) legge ed integra p≥e≥r[ivsc]oi, "possa circondare", mentre
il Di Benedetto (2005, 7) seguendo in parte la proposta degli editori, integra g≥e≥[noivma]n≥
e traduce "possa io trovarmi". West dice che "chiaramente" si legge un P e non un G,
ma, anche grazie all'ausilio dei moderni strumenti informatici234
(il West stesso dice di
aver consultato la sola fotografia e non direttamente il papiro), non possiamo farci
un'idea precisa e perciò, in mancanza della visione diretta del testimone, è bene affidarci
a quello che gli editori hanno precedentemente letto ed edito, che peraltro in questo caso
è suffragato da un notevole uso dell'allitterazione: ad es. la sequenza ga'" g≥e≥.[ in
relazione a g≥.[ del verso precedente, a gevra" del v. 5, a ga'" del v. 6 ed a liguvran del
v. 7. Vi è una iterata allitterazione anche della nasale (cfr. nevrqe di questo verso con nu'n
del precedente, e[coisan, e[oiken e e[s]lon integrato dal Di Benedetto al v. 5, con nu'n,
e[oisan e qaumav]z≥oien integrato dal West e con liguvran, ken, pa'ktin del v. 7) e, ancor
più palesemente, dell'intero dittongo -oi- (v. 5 e[coisan e [e[]oiken, v. 6 e[oisan, v. 7
e[loisa, v. 8 Moi's∆). Per il Di Benedetto, si tratta di un fine gioco di contrapposizioni tra
l'"al di qua" e l'"aldilà" (ovviamente in senso figurato): "forse perché – sostiene Di
234
È possibile visionare direttamente il papiro sul sito http://www.uni-koeln.de/phil-
fak/ifa/NRWakademie/papyrologie/Verstreutepub/
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
125
Benedetto – queste corrispondenze tra l'"aldilà" e l'"al di qua", cioè tra il mondo dei
morti e quello dei vivi, assumevano un carattere di gioco lieve, che acquisiva una
valenza ideologica volta a superare il contrasto e la distanza apparentemente
incolmabile"235
. Il significato di tutta l'ode sta, per il Di Benedetto, nel complesso
rapporto di contrapposizione / corrispondenza tra il mondo dei vivi e quello dei morti:
"Io sono certa – sembra dire Saffo – che nell'aldilà continuerò a cantare così come anche
ora io canto, ma la corrispondenza (e più genericamente tutta l'ode) è finalizzata al
cantare bene adesso (cfr. v. 8 k≥avla, Moi's∆, ajeivdw "cose belle, Musa, io canti"): se
nell'aldilà questo cantare è aproblematico, in quanto dato strutturale dei cultori delle
Muse (e Saffo è una di questi), nel mondo dei vivi il cantare è personalizzato (il
richiamo all'Ade in questa forma immediata non è certo attribuibile ad una ragazza del
gruppo) e viene anche problematicizzato, diventando così un obiettivo non sicuro ed
incerto. Si intravede quindi un primo avvio verso quella che sarà la tematica di fondo del
carme della vecchiaia", così come viene enunciata nei primi sette versi (le integrazioni
più estese qui accolte sono di V. Di Benedetto):
[u[mmin fivla Moivsan ij]õok[ovv]lÕpwn kavla dw'ra, pai'de", [prevpei de; lavbhn ta;]õn≥Õ filavoidon liguvran celuvnnan [ejmoi; d∆a[palon privn]õp≥ot∆[e[]oÕnta crova gh'ra" h[dh [aijkivssato leu'kai d∆ ejg]õevnoÕnto trivce" ejk melaivnan
õbavru" dev m∆ oj [q]u'mo≥"≥ pepovhtÕai, govna d∆ ouj fevroisi, õta; dhv pota laivyhr∆ e[on o[rcÕhsq∆ i[sa nebrivoisin ãtau'Ãõta stenacivsdw qamevw". ajÕlla; tiv ken poeivhn… A voi, fanciulle, sono cari i bei doni delle Muse seno di viola
e conviene prendere la cetra armoniosa ed amante del canto.
A me, invece, il corpo, che una volta era tenero, la vecchiaia
l'ha rovinato, i capelli da neri sono diventati bianchi,
l'intimo impulso si è appesantito, le ginocchia non reggono,
esse che un tempo erano agili a ballare come i cerbiattini:
di ciò piango spesso, ma cosa avrei potuto fare?
Gli editori propongono di confrontare il verso qui in esame con Thgn. 567 sgg. h{bhi
terpovmeno" paivzw: dhro;n ga;r e[nerqen / gh'" ojlevsa" yuch;n keivsomai "mi
diverto godendo della giovinezza: a lungo, infatti, sotto / terra giacerò senza vita".
5 Di Benedetto restituisce kh' moisopovlwn e[s]l≥o≥n≥ (cioè "lì tenendo l'insigne
funzione dei cultori delle Muse"), mentre il West klevo" mevga Moivse]i≥o≥n (ovvero "la
235
Di Benedetto 2005, 8.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
126
grande fama che pertiene alle Muse"). Il sostantivo moisopovlo" è in Saffo, sempre al
genitivo plurale, nel fr. 150:
ouj ga;r qevmi" ejn moisopovlwn ãdovmwià qrh'non e[mmen∆ ã.......à ou[ k∆ a[mmi prevpoi tavde
Non è lecito che vi sia funebre canto
nella casa dei cultori delle Muse …questo a noi non converrebbe
Di Benedetto integra, tuttavia, una parola, moisopovlwn, il cui significato, specialmente
in Saffo, non è chiaro e su cui si è molto discusso, soprattutto negli ultimi quaranta anni.
In questo composto è presente la radice i.e. *kwel- (la stessa del latino colĕre "abitare,
vivere in" e del greco pevlw "essere, trovarsi"). Secondo Giuliana Lanata (1966, 67) è
possibile che con moisopovlo" la poetessa si dichiarasse "appartenente ad
un'associazione cultuale, le cui componenti hanno fra i loro legami anche quello del
culto delle Muse"236
e cita, per dimostrare la sua tesi, un’epigrafe proveniente dalla Tebe
del II secolo a.C. (I.G. VII 2484) in cui una gilda di teatranti viene definita ej[s]qlh;
tecnitw'n mousopovlwn suvnodo" “illustre corporazione di artisti cultori delle Muse” .
L’opinione di Giuliana Lanata è stata condivisa da Bruno Gentili (2006, 155), secondo il
quale “la vicinanza alle Muse non si spiega senza ammettere un particolare culto
all’interno della comunità; lo prova la presenza di una parola, moisopólos, di preciso
significato cultuale”. Dello stesso avviso anche la Grandolini (2000, 356), secondo la
quale “non c’è dubbio che moisopovlwn connoti l’attività all’interno del dovmo"” – ma i
codici hanno oijkiva – “come legata alle Muse”.
È la stessa Lanata (1966, 67), tuttavia, a notare come tale termine ricorra, in altri autori,
“con un significato ormai scolorito”. Sia l'aggettivo che il sostantivo moisopovlo"
(mousopovlo", ovviamente, in attico) hanno avuto fortuna, ad esempio, in Euripide237
, si
cfr. Alc. 445 sgg. dove il sostantivo assume, infatti, il significato riportato da Hsch. m
1754, cioè poihthv":
pollav se mousopovloi mevlyousi kaq∆ eJptavtonovn t∆ ojreivan cevlun e[n t∆ ajluvroi" klevonte" u{mnoi" I poeti a lungo ti canteranno,
sia secondo la lira montana sette toni,
236
Lanata 1966, 67; la frase viene citata alla lettera anche da Ferrari 1987, 223 (n. 2), ma su questo v.
infra. 237
Cfr. Grandolini 2000, 356.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
127
sia invocandoti senza lira nei canti
E si cfr. anche Ph. 1499, dove è in funzione di aggettivo:
tivna proswido;n h] tivna mousopovlon stonaca;n
quale armonioso,
quale melodioso gemito…!
Ricorre come aggettivo anche in Opp. Hal. I 680 mousopovlwn e[rgwn; A. P. IX 270.4
mousopovloi" cersi;n; A. P. XII 257.6 mousopovlon stevfanon238; Castor. S. H. 310.5
mousopovlo" qhvr; I.G. VII 2484 (II sec. a.C.), passo già citato, per cui v. supra, così
come in Nonn. D. XLV 185, passo, tuttavia, non riportato né dalla Lanata né dalla
Grandolini, a cui accenna comunque Ferrari (2007a, 139):
ouj tovte d∆aijpolivoisi parhvmeno" h] para; mavndrai" sumfertoi'" donavkessi melivzeto mousopovlo" Pavn non suonava allora il melodioso Pan a canne unite,
sedendo presso le greggi o i mandriani
Per la Grandolini (2000, 356), dunque, il termine sembrerebbe designare: 1) il poeta o la
sua attività; 2) l’attività scolastica (la studiosa nota come Opp. Hal. I 680 mousopovlwn
e[rgwn venga glossato da Schol. Opp. Hal. I 680 con h] scolh'", ajpo; tw'n scoleivwn,
maqhmavtwn); 3) l’attività artistica, comprendente poesia, musica e canto, svolta
all’interno di un’associazione cultuale.
Per la Grandolini, inoltre, moisopovlo" sarebbe l’equivalente di Mousavwn qeravpwn,
“ministro delle Muse”, stilema utilizzato per la prima volta in Hes. Theog. 100, dove è
utilizzato per un generico ajoido;", ma che ricorre anche in Thgn. 769 Mousw'n
qeravponta kai; a[ggelon “delle Muse ministro e nunzio”. E cfr. per una espressione
simile anche Archil. fr. 1 W.2 eijmi; d∆ejgw; qeravpwn me;n jEnualivoio a[nakto" / kai;
Mousevwn ejrato;n dw'ron ejpistavmeno" “io sono il servo del sire Enialio / e conosco
l’amabile dono delle Muse”.
In conclusione, per la Grandolini (2000, 356), seguendo una linea inaugurata da Giuliana
Lanata, ”il termine moisopovlo" sta ad indicare in Saffo non solo il rapporto della sua
scuola con le arti delle Muse, ma anche con il loro culto”.
238
Cfr. anche A. P. VII 698, 11; IX 248, 4; A. P. IX 356, 2.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
128
Aloni (1997, 248s.) ha, tuttavia, dimostrato in modo convincente che la parola
moisopovlo" ed il suo equivalente Mousavwn qeravpwn non possono avere un valore
istituzionale: il termine attestato in Saffo, lo abbiamo detto, nelle opere successive non
indica l’esistenza di una “scuola” devota al culto delle Muse e, dunque, della poesia; ed
anche il suo equivalente Mousavwn qeravpwn non indica mai niente del genere, ma andrà
inteso sempre come “aedo, poeta”, il che non può dimostrare in alcun modo l’esistenza
di un valore istituzionale.
Per Hardie (2005, 15), l’iscrizione su cui si basa l’argomentazione della Lanata e della
Grandolini è interessante, ma non ci può dire niente a riguardo della “poetic
terminology, or cult activity” della Lesbo arcaica: lo studioso ritiene che, piuttosto che
indicare i membri di una associazione cultuale, esso indichi coloro che sono impegnati in
qualche sorta di attività musicale o “those who busy themselves with the Muses”, ma
senza che tutto ciò presupponga un vincolo istituzionale, un culto delle Muse o,
addirittura, una scuola devota alle “nove figlie di Zeus”.
Franco Ferrari, rispetto al commento del 1987, sembra aver cambiato opinione in
proposito: Ferrari (1987, 223) venti anni fa riteneva, citando ampiamente la Lanata, che
fosse “possibile che con il termine moisopolos la poetessa si dichiarasse «appartenente
ad una associazione cultuale, le cui componenti hanno fra i loro legami anche quello del
culto delle Muse»”; nel saggio apparso recentemente239
, invece, sembra sposare
l’opinione di Aloni, aggiungendo il caso di Pi. Parth. 1.5s. mavnti"... / iJerapovlo":
iJerapovlo" è spesso utilizzato come titolo cultuale: nel passo dei Parteni ricorre sì come
epiteto di mavnti", ma Pindaro si serve di tutta l’espressione per la propria persona, per il
suo essere poeta.
In conclusione, moisopovlwn integrato dal Di Benedetto e presente in Sapph. fr. 150 V. è
una parola dalla comprensione tutt’altro che certa e basandosi sul testo a nostra
disposizione non è possibile stabilire con esattezza il suo significato, o meglio il
rapporto, se esiste, che lega questa parola al contesto in cui Saffo componeva le sue
poesie: e comunque non c’è alcuna prova per dimostrare la tesi di Giuliana Lanata,
ovvero che Saffo fosse membro o, piuttosto, guida di una scuola devota alle Muse: le
argomentazioni addotte non sono sufficienti (e, certamente, non potrebbero esserlo dato
il lasso di tempo che ci separa da Saffo), ma non vi sono neanche argomenti davvero
239
Cfr. Ferrari 2007, 140.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
129
incontrovertibili per negarlo, perché i raffronti sono costituiti da passi lontani dal mondo
di Saffo.
L’unica parola significativa del verso tradita nella sua interezza è, tuttavia, gevra": non è
possibile comprendere il significato di questa parola isolandola dal contesto. Il termine
gevra" nei poemi omerici assume una varietà di significati, a seconda del contesto, del
modello di civiltà di immediato riferimento. Nel caso della formazione guerriera, quindi
soprattutto nell’Iliade, assume un significato particolare: “il gevra" appare ben definito
come risultante di una serie di operazioni collettive: l’azione bellica finalizzata alla
preda, la divisione di questa ed infine la attribuzione in parti ai singoli guerrieri”240
. “La
parte d’onore, corrispondente allo status del singolo guerriero, derivata dall’azione
bellica comune e dalla spartizione sancita dalla collettività, è indispensabile alla
condizione del guerriero”241
: senza il geras, poiché esso è attribuito in base allo status
del singolo, il guerriero vede rotto il suo legame con la società che lo circonda. Il
carattere materiale del gevra" è dimostrato da un passo del primo libro dell’Iliade (Il. I
116-126), in cui Agamennone richiede, al posto del rilascio di Criseide, un gevra"
adeguato; Achille gli risponde che ciò non è possibile, perché al momento non vi sono
da parte beni comuni e la preda delle città devastate è già stata spartita: ajlla; kai; w|"
ejqevlw dovmenai pavlin eij tov g∆ a[meinon: / bouvlom∆ ejgw; lao;n sw'n e[mmenai h]
ajpolevsqai: / aujta;r ejmoi; gevra" aujtivc∆ eJtoimavsat∆ o[fra mh; oi \o" / jArgeivwn
ajgevrasto" e[w, ejpei; oujde; e[oike: / leuvssete ga;r tov ge pavnte" o{ moi gevra"
e[rcetai a[llhi. / To;n d∆ hjmeivbet∆ e[peita podavrkh" di'o" jAcilleuv": / jAtrei?dh
kuvdiste filokteanwvtate pavntwn, / pw'" gavr toi dwvsousi gevra" megavqumoi
jAcaioiv; / oujdev tiv pou i[dmen xunhvi>a keivmena pollav: / ajlla; ta; me;n polivwn
ejxepravqomen, ta; devdastai, / laou;" d∆ oujk ejpevoike palivlloga tau't∆ ejpageivrein.
"«ma anche così acconsento a ridarla, se ciò è meglio; / voglio che il mio esercito sia
salvo o muoia, / ma subito per me approntate un geras, che io non sia il solo / tra gli
Argivi ad essere privo di geras, poiché non sarebbe giusto. / Lo vedete tutti che il mio
geras se ne va altrove» / A lui poi rispose il pié veloce, glorioso Achille: /
«Gloriosissimo figlio di Atreo, tra tutti il più avido, / come potranno darti un premio i
magnanimi Achei? / Non vediamo da qualche parte molti beni comuni: / il bottino delle
240
Così Di Donato 2006, 57-58. 241
Di Donato 2006, 63-64.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
130
città che conquistammo è stato spartito / e non conviene che i soldati di nuovo lo
ammassino insieme»”. Achille non si oppone alla richiesta di Agamennone, ma si limita
a fargli presente che per lui ottere quel geras è in quel momento impossibile e non è
conveniente, secondo un supposto codice di convenienza (notare che Achille riusa quasi
la stessa parola di Agamennone: Il. I 119 oujde; e[oike; Il. I 126 oujk ejpevoike),
riammassare le parti di bottino che sono state già divise tra i vari guerrieri achei. Per
Agamennone, però, non è ammissibile che Achille mantenga il suo geras mentre lui, il
comandante dell’esercito acheo, sia stato sottratto della schiava Criseide; si pongono,
così, due soluzioni: o gli achei gli concederanno un altro geras dello stesso valore,
oppure lui stesso si andrà a prendere quello di Achille, di Aiace o di Odisseo (Il. I 130-
139), provocando in essi il covlo".
Il termine gevra" indica, dunque, in questi casi il bottino che l’esercito abbia trafugato
da una città e l’abbia poi suddiviso trai singoli guerrieri, ma la suddivisione non è affatto
egualitaria o proporzionale alle azioni commesse; Agamennone è sempre colui che
ottiene, in virtù del suo status più geras degli altri, ma cfr. Il. I 160-168: tw'n ou[ ti
metatrevphi oujd∆ ajlegivzei": / kai; dhv moi gevra" aujto;" ajfairhvsesqai ajpeilei'",
/ w|i e[pi polla; movghsa, dovsan dev moi ui|e" jAcaiw'n. / ouj me;n soiv pote i\son
e[cw gevra" oJppovt∆ jAcaioi; / Trwvwn ejkpevrsws∆ eu \ naiovmenon ptoliveqron: / ajlla;
to; me;n plei'on poluavi>ko" polevmoio / cei're" ejmai; dievpous∆: ajta ;r h[n pote
dasmo;" i{khtai, / soi; to; gevra" polu; mei'zon, ejgw; d∆ ojlivgon te fivlon te /
e[rcom∆ e[cwn ejpi; nh'a", ejpeiv ke kavmw polemivzwn. “Di ciò non ti dai cura, né ti
preoccupi, / e proprio tu minacci di portarmi via il geras / per il quale molto soffersi ed
a me lo diedero i figli degli Achei. / Non ho mai un geras uguale al tuo, quando gli
Achei / devastino qualche città molto popolata dei Troiani: / la parte maggiore della
violenta guerra / le mie mani la guidano; però quando giunga il momento della
spartizione, / ha un geras di gran lunga maggiore: io me ne vado / alle navi con uno
piccolo e caro, dopo che io abbia faticato a combattere”.
Fra le attestazioni della parola gevra" nel senso appena descritto si segnalano due passi
che possono, soprattutto il primo, essere dei buoni paralleli per l’espressione integrata
dal Di Benedetto, cioè e[s]l≥o≥n≥ e[co≥i≥san g≥evra"; si tratta di Od. XI 184a e, soprattutto, di
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
131
XI 533-534. Nel primo caso a parlare ad Odisseo è l'ombra di Antìclea, sua madre242
;
Odisseo le ha appena chiesto che fine ha fatto il suo gevra" ad Itaca, in quale mano è
passato, se lo hanno ancora il padre o il figlio. Anticlea risponde:
so;n d∆ ou[ pwv ti" e[cei kalo;n gevra"
In nessun modo qualcuno ha il tuo bel privilegio
Nel secondo caso, che costituisce l’unico passo della “letteratura greca” dove sia
attestata l’espressione in parte integrata dal Di Benedetto, a narrare la distruzione di
Troia è Odisseo ed il riferimento è a Neottolemo, di cui l'ombra di Achille chiede
notizie:
ajll∆ o{te dh; Priavmoio povlin diepevrsamen aijphvn, moi'ran kai; gevra" ejsqlo;n e[cwn ejpi; nho;" e[bainen
ma quando dunque di Priamo l'alta città distruggemmo,
con la sua parte e l'onorevole dono sulla nave salì
Nel primo caso il sostantivo è utilizzato per il geras che Odisseo aveva ad Itaca prima
della guerra, mentre nel secondo si riferisce al geras, cioè al bottino di Neottolemo
quando costui, conquistata Troia, salì sulla nave del ritorno. In entrambi i casi, dunque, il
termine geras assume un carattere materiale piuttosto marcato: indica, infatti, il bottino
conquistato sul campo o, più genericamente, il patrimonio di un singolo personaggio.
Il sostantivo gevra" nei poemi omerici può, però, ricorrere anche in altri contesti e,
dunque, assumere un significato diverso da quello dei passi precedenti. Per il Di
Benedetto, l'uso del genitivo plurale insieme a gevra" sembra, infatti, presupporre Il.
XXIII 9b (e questo sulla scorta degli editori del Papiro di Colonia), in cui il poeta fa dire
ad Achille nei riguardi del corpo di Patroclo:
o} ga;r gevra" ejsti; qanovntwn
Questa, infatti, è la prerogativa dei morti
E si confronti anche il seguente passo, di Il. XVI 457b (= Il. XVI 685b = Od. XXIV
190b = Od. XXIV 296b), con cambiamento minimo: to; ga;r gevra" ejsti; qanovntwn.
In questi passi appena citati, il termine gevra" andrà inteso, dunque, come “omaggio,
onore funebre”. Tuttavia, gevra" seguito da un genitivo atto ad indicare una precisa
categoria di uomini che usufruiscono di un certo "privilegio" è ricorrente altre volte in
242
Su questo passo cfr. Di Donato 2006, 62.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
132
clausula nell'Iliade e nell'Odissea; si consideri ad es. Il. IV 323b (= IX 422b) to; ga;r
gevra" ejsti; gerovntwn "quello è il privilegio degli anziani". Ovviamente, però, tale uso
sarebbe, per il Di Benedetto, "riscattato" dal fr. 150, per cui v. supra.
In questo passo di Saffo, invece, il sostantivo gevra" non può avere il significato
materiale, ma quello astratto: andrà inteso, dunque, come “privilegio, prerogativa,
onore”.
Per e[s]l≥o≥n≥...g≥evra" oltre al passo di Od. XI 533-534 precedentemente citato, si cfr. anche
[Orph.] Hymn. LXXXVII 12 wJ" a]n e[oi gevra" ejsqlo;n ejn ajnqrwvpoisi to; gh'ra"
“che la vecchiaia sia un buon privilegio tra gli uomini”: si tratta delle due uniche
attestazioni di gevra" ejsqlo;n in tutta la “letteratura greca”.
Per nevrqe de; ga'"...e[coisan gevra" si confronti Od. XI 302 in riferimento ai Dioscuri,
Castore e Polluce, anche se con timhv al posto di gevra" e senza l'aggettivo atto a
qualificare l'"onore":
oi} kai; nevrqen gh'" timh;n pro;" Zhno;" e[conte"
essi, avendo anche sotto terra onore da parte di Zeus
Notare come tutti questi tre passi citati appartengano al libro XI e non occorre ricordare
che questo libro dell'Odissea narra della Nevkuia, ovvero il rito di evocazione dei morti:
un famoso episodio (un paradigma per le future, vere e proprie katabavsei" del VI libro
dell'Eneide virgiliana e della Commedia dantesca) del poema che è tematicamente affine
al frammento saffico qui in analisi.
Per e[s]lon≥ e[co≥i≥san cfr. Sapph. 19.6 ] e[coisan e[sl[ e cfr. anche Il. V 516a in
riferimento ad Enea kai; mevno" ejsqlo;n e[conta "avendo nobile ardore"; Il. XVII 143
in riferimento ad Ettore h\ s∆ au[tw" klevo" ejsqlo;n e[cei fuvxhlin ejovnta "invano
nobile fama circonda colui che è vile"; Od. X 287 sgg. th', tovde favrmakon ejsqlo;n
e[cwn ej" dwvmata Kivrkh" / e[rceu "ecco, entra in casa di Circe con questa utile
erba". Questi confronti (in particolare il primo) puntano tutti in direzione
dell'accettazione del testo integrato dal Di Benedetto (e[s]l≥o≥n) e del relativo contesto.
A conferma della sua interpretazione generale dell'ode qui in analisi, Di Benedetto nota
una singolare, ma notevole corrispondenza fonica tra questo verso ed il v. 3 del fr. gV
(suppl. Di Benedetto):
kh' moisopovlwn e[s]l≥o≥n≥ e[co≥i≥san g≥evra" w["≥ [e[]o≥ike≥n≥
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
133
[ejmoi; d∆a[palovn privn]õp≥ot∆[e[]oÕnta crova gh'ra" h[dh
6 Di Benedetto (2005,7) restituisce yu'caiv (vel skivai) kev me qaumav]z≥oien, mentre
West pavntai dev me qaumav]z≥oien. Per qaumavzw nel significato di “ammirare,
giudicare positivamente qualcuno” e detto da un poeta (Eschilo) nell’Ade o in
riferimento alla vita ultraterrena cfr. Ar. Ranae 1008 ajpovkrinaiv moi, tivno" ou{neka
crh; qaumavzein a[ndra pohthvn; “rispondimi: per quale motivo occorre ammirare un
poeta?”; qaumav]z≥oien del West è accolto da tutti, compreso Di Benedetto, il quale, però,
chiama in causa un passo di Orazio (Carmina II 13.21-30) dove si dice243
:
Quam paene furuae regna Proserpinae
et iudicantem uidimus Aeacum
sedesque discriptas piorum et
Aeoliis fidibus querentem
Sappho puellis de popularibus
et te sonantem plenius aureo,
Alcaee, plectro dura nauis,
dura fugae mala, dura belli.
Vtrumque sacro digna silentio
mirantur umbrae dicere, sed magis
pugnas et exactos tyrannos
densum umeris bibit aure vulgus.
Per quanto non vidi i regni della fosca Proserpina
ed Eaco nel suo ruolo di giudice
e le sedi assegnate dei buoni e Saffo che,
con le corde eoliche, si lamenta delle fanciulle
sue conterranee e te che con più pieno suono,
Alceo, canti, con l'aureo plettro,
i duri mali della navigazione,
le durezze della guerra e dell' esilio.
Le ombre ammirano entrambi
che proferiscono parole degne di religioso silenzio; ma più
è densa la folla che spalla a spalla beve
con le orecchie le battaglie e i tiranni cacciati.
L'interpretazione di questa ode data da Eduard Fraenkel (Horace, 167) vuole che essa
assolva alla funzione di esaltare Alceo, per mezzo di una catabasi: “a Nekyia on a small
243
Il parallelo, messo in evidenza da Di Benedetto (2005, 9s.) è stato accolto da Hardie (2005, 23) e da
Ferrari (2007, 70).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
134
scale as an impressive setting for the glorification of Alcaeus”244
. Tuttavia, ora, capiamo
come il tutto (ed in particolare il brusco snodo attraverso il quale dal ricordo del pericolo
di morte occorso a lui si passa all'evocazione dei due poeti eolici nell'aldilà) sia stato
agevolato dal fatto che Saffo stessa, proprio nel frammento in esame, si riferiva ad una
sua futura permanenza nell'Ade come moisopovlo". Sebbene sia da accettare l'ipotesi del
La Penna (1972, 208-209), secondo il quale questa ode sarebbe fondata, altresì, sulla
suvgkrisi" tra Saffo ed Alceo (con quest'ultimo messo su un piano decisamente
superiore: Alceo sonat plenius), tuttavia Saffo garantiva la permanenza nell'Ade anche
agli altri poeti, quindi anche ad Alceo, per il solo fatto di essere moisopovloi. Orazio,
quindi, immagina che lei abbia ottenuto nell'Ade quello che desiderava, cioè conservare
lo status che aveva sulla terra, quello di cantare. Ai vv. 24-25 Orazio con Aeoliis fidibus
querentem / Sappho puellis de popularibus non può che far riferimento alla sola Saffo,
ma nei versi immediatamente successivi (26-28) il riferimento è ad Alceo in
concomitanza con un ostentato cambio di registro espressivo. Saffo non poteva essere
"dimenticata": l'utrumque del v. 29 individua sia Saffo che Alceo, i quali vengono così a
costituire una diade inscindibile, ma, per il Di Benedetto, la preferenza che Orazio, sulla
spinta del clima augusteo, attribuisce dichiaratamente ad Alceo dal sed del v. 30 in poi
riduce l'ambito di quel pronome e dei vv. 29-30 (fino a sed magis) alla sola Saffo:
perciò, l'espressione sacro digna silentio per la sua tonalità ieratica trova riscontro nel
modo come in Saffo l'esecuzione poetica si intreccia con la ritualità religiosa e nel modo
come Saffo parla dei "cultori delle Muse" nel fr. 150. Da sed in poi la narrazione si
sviluppa ulteriormente e Saffo esce completamente di scena.
Il tovpo" del cantare nell’altra vita non ricorre solo in questi due passi, quello di Saffo e
quello di Orazio. In A. P. VII 25.9-10 viene detto che Anacreonte non rinuncia (ouj
lhvgei) mai a cantare e che anche nell’aldilà, una volta morto, non si lascia assopire: non
sappiamo, tuttavia, se lo stesso Anacreonte abbia mai espresso in un suo carme un simile
desiderio. E tuttavia colui che compie l’azione non è sempre dotato di personalità
“storica”, ma si può parlare anche di un cantare “generico”. Ad esempio in Pi. Fr. 129
Sn.-M., un passo che affronteremo anche altrove, si parla di alcuni che nell’aldilà si
dilettano (tevrpontai) con le fovrmigge". In Ar. Ranae 154 Eracle parla a Dioniso di
244
Fraenkel, Horace 167.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
135
un’aria di flauti (aujlw'n...pnohv) presente nell’aldilà e, per non limitarci all’ambito greco,
di cori e di canti ultraterreni parlano anche Tibullo (I 3.59) e Properzio (IV 7.61-62). Ed
ovviamente il tovpo" non poteva che essere presente nella più famosa catabasi della
“letteratura latina”, il sesto libro dell’Eneide (Verg. Aen. VI 644): pars pedibus plaudunt
choreas et carmina dicunt “parte accompagnan le danze col battere i piedi ed intonano
canti”.
7 Di Benedetto (2005, 7) restituisce faivnhn do;" ajoivdan; West, invece, integra
kavleisi celivdw. Il Di Bendetto trae la sua congettura da un verso del libro VIII
dell'Odissea (v. 499): è l'aedo Demodoco a narrare, nel palazzo di Alcinoo, la fine della
guerra di Ilio
}W" favq∆ oJ d∆ oJrmhqei;" qeou' a[rceto, fai'ne d∆ ajoidhvn
Così disse; e quello, cominciando dal dio, tesseva il canto…
Questi passi dell'Odissea sono, senza dubbio, i più tecnicamente elaborati in riferimento
alla figura ed all'operare degli aedi: Demodoco stesso può essere considerato quale
"l'aedo di tutti gli aedi", simbolo stesso di ciò che in quei tempi doveva essere il mestiere
del "cantare"; perciò, a Saffo che si dichiarava moisopovlo", saranno stati
particolarmente cari: tra l'altro, proprio in questi passi, il sostantivo Mou'sa (al
singolare, per cui cfr. Moi's∆ del frammento in esame) ricorre ben due volte. Si confronti
anche ai[ ken di Od. VIII 496 e quello presente nel nostro frammento. Ed inoltre
l'apparato della Voigt al fr. 5.9-10 (ta;n kasig]nhvtan de; qevloi povhsqai / e[mmoron]
tivma" "e dell'onore voglia rendere partecipe sua sorella") registra un'integrazione
(e[mmoron] tivma" Wil.) che il Wilamowitz trasse da Od. VIII 479-480 (ajoidoiv / timh'"
e[mmoroi "i cantori / d'onore son degni") e quindi poco prima del passo di Od. VIII 499
precedententemente citato: Saffo riferirebbe e[mmoron tivma" a se stessa rivolgendosi al
fratello Carasso, mentre il poeta dell' Odissea riferiva timh'" e[mmoroi agli aedi: come se
Saffo rivendicasse, per l'ennesima volta, il suo essere moisopovlo".
Per [a]i≥[ ken e[loisa pa'ktin cfr. Sapph. 22.10 sgg. lavboisa...[pa']ktin; 21.11 sgg.
lavboisa...a[eison; gV 2 (suppl. Di Benedetto) [prevpei de; lavbhn ta;]õn≥Õ filavoidon
liguvran celuvnnan.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
136
8 Abbiamo una lacuna un po' più estesa, anche se già gli editori, proponevano
ce]l≥u≥vn≥n≥an≥: Di Benedetto qui non segue la proposta degli editori ("al v. 8 ce]l≥u≥vn≥n≥an≥ è
suggerito solo nelle note…, ma non nel testo …ed è dissonante con la descrizione delle
tracce"); al contrario, West accoglie la proposta degli editori, ma solo in parte,
costituendo il verso come h] bavrbiton h] tavnde ce]l≥uv≥n≥n≥an≥ qalavmois∆ ajeivdw: egli,
infatti, sostiene che "a last-minute apostrophe of the Muse does not look natural,
elsewhere in Sappho (six times) the Muses are always plural. On the photograph I can
see nothing at all of the letter before alamoi", and if qalavmois∆ is a possible reading, I
should prefer it". Il Di Benedetto propone il confronto con Hor. Carmina III 30 ed in
particolare dei vv. 14-16
Sume superbiam
quaesitam meritis et mihi Delphica
lauro cinge uolens, Melpomene, comam
Sii superba,
Melpomene, l' hai meritato, e cingi volentieri,
con l'alloro delfico, a me la chioma
Perciò, secondo lui, è possibile postulare un'invocazione finale alla Musa: notare che
proprio in questa ode oraziana abbiamo un'invocazione alla Musa prima dell'ultima
parola del verso, anzi del terzo libro delle Odi ed ultimo della prima edizione, ed anche,
due versi prima, sume, che corrisponde, in modo più o meno diretto, ad e[loisan in
posizione omologa nel nostro frammento in questione. Un'indicazione molto
significativa in tal senso ci viene data immediatamente prima (Carmina III 30.13-14) da
Orazio che dichiara "dicar…princeps Aeolium carmen ad Italos / deduxisse modos" "io
sarò detto…primo ad aver tratto ai ritmi italici il canto eolico": il poeta venosino
sembra quasi voler palesare l'eolicità dei tre versi finali (estremamente importanti,
poiché, come abbiamo detto, avrebbero dovuto essere gli ultimi dell'intera opera). E
d'altra parte "a last-minute apostrophe of the Muse" trova riscontro nei versi finali di
quel frammento che qui viene indicato come bV [= 58.1-10 V.], per cui v. infra. Quanto
alla clausula di questo verso, è necessario, per il Di Benedetto, mantenere kavla, Moi's∆,
ajeivdw, proprio per il fatto che questo frammento farebbe parte di quel sistema di moduli
introduttivi: togliendo l'invocazione alla Musa, il West, oltre a discostarsi notevolmente
dagli editori del papiro, eliminerebbe il collegamento con Sapph. DV bV = 58.1-10 V. ed
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
137
in buona parte la formula con cui si introduceva il canto. Inoltre il West non tiene in
alcun conto i seguenti passi, che sono paradigmatici del modo in cui Saffo richiamava o
dichiarava che cosa o chi diveniva oggetto del canto: 21.13 a[eison a[mmi / ta;n
ijovkolpon "cantaci / lei dal seno di viola"; 22.9-10 [...k]evlomai s.[ / Go]g≥guvlan≥ "(ti)
invito (a cantare) Gongila": se ne deduce che insieme al verbo ajeivdw veniva indicato
l'oggetto del cantare e non il luogo (in più, come sottolinea Di Benedetto, Saffo non
cantava nei talami). In ultima analisi, si può confrontare questo frammento anche con il
160, dove tevrpoisa è un emendamento del Sitzler al posto del tradito, ma ametrico
tevrpna:
tavde nu'n ejtaivrai" taiv" e[mai" ãtevrpoisaà kavlw" ajeivsw
Ora intonerò bene questo canto
per rallegrare le mie compagne
notare l'espressione kavlw" ajeivsw che è del tutto analoga a quella posta alla fine del
frammento aV (kavla, Moi's∆, ajeivdw), ma anche il nu'n presente in entrambi i frammenti e
che, nel frammento del Papiro di Colonia torna per individuare due momenti differenti.
Si recupera così un sistema di moduli introduttivi, secondo l'opinione del Di Benedetto.
A partire dalla formula, tratta dal frammento 160, ejtaivrai" taiv" e[mai"...ajeivdw, il Di
Benedetto ha integrato, quindi, e[maisi fivlaisi(n) per l'inizio del v. 8 del fr. aV. Per
kavla...ajeivdw cfr. anche Il. XVIII 570 kalo;n a[eide "cantava un bel canto"; Od. I 155
ajnebavlleto kalo;n ajeivdein "si mise a cantare un bel canto"; Alcm. 35 Page kavlla
melisdovmenai; Pi. N. I 20 kala; melpovmeno".
Hardie (2005, 24ss.) ha apportato, riteniamo, argomenti davvero interessanti ed
innovativi alla discussione critica su questo argomento: l’apostrofe finale alla Musa può,
per questo studioso, essere accolta, ma abbisogna di una giustificazione, un appiglio nei
versi precedenti del carme ed esso potrebbe essere il sostantivo q≥a≥l≥[iv]a al v. 3, che,
come abbiamo detto, è raramente usato al singolare, ma richiama il nome di una delle
nove Muse, Talìa. Simili giochi etimologici e fonici con parole che alludono al nome di
una Musa sono ben attestati. Come non ricordare che nella Teogonia, prima del catalogo
delle Muse (Theog. 75-79), i nomi delle nove figlie di Zeus vengono anticipati da
almeno una parola che rimanda etimologicamente o foneticamente ad esse? E simili
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
138
giochi si trovano anche nei epoeti lirici: cfr. Pi. O. VI 22.106 Moi'sai...eujterpe;"; N. III
67-68.83 boa; de; nikafovrwi su;n / jAristokleivdai prevpei / o}" tavnde na'son eujklevi>
prosevqhke lovgwi...eujqrovnou Kleou'" ejqeloivsa" “il canto è adatto ad Aristoclide
vincitore, / che ha associato questa isola alla fama gloriosa…essendo Clio
consenziente”; Pi. P. III 90 melpomena'n ejn o[rei Moisa'n “le Muse cantando sul
monte”; Stes. Fr. 210 Mou'sa.../ kleivousa “Musa…/celebrando…”. Del resto,
l’associazione tra il nome della musa Talìa ed il sostantivo qaliva non è affatto nuova:
ricorre già proprio in Hes. Theog. 65.75.77 qalivh≥"...Mou'sai...Qavleiav (e non poteva
essere altrimenti). Le qalivai, inoltre, sono associate con le Muse già in Hes. Theog. 916-
17 Mou'sai.../ th'isin a}don qalivai kai; tevryi" ajoidh'" “a loro sono graditi le feste
ed il piacere del canto”. Per l’associazione qaliva / qavllw...Moi'sa cfr. Pi. P. X 34.37
qalivai"...Moi'sa; Pi. Paen. VI 181.183 eujqalevo" uJgieiva"...Moisa'n...q≥[aliv]an;
Bacchyl. Ep. IX 1-6 Mousa'n ge ijoblefavrwn...eujqale;" pevdon “delle Muse dalle
palpebre viola…terreno ben florido”. Tematicamente più prossimo all’ode di Saffo che
stiamo commentando è Bacchyl. Ep. III 88-92 (per Ierone di Siracusa) ajndri; d∆ ouj
qevmi", polio;n p[ar]evnta / gh'ra", qavl[eia]n au\ti" ajgkomivãsÃsai / h{ban. jAreta'[j"
ge m]e;n ouj minuvqei / brotw'n a{ma s[wvm]ati fevggo", ajlla; / Mou'sav nin
tr[evfei.] "non è lecito per l'uomo evitare la canuta / vecchiaia e recuperare la florida /
giovinezza. Della virtù dei mortali / il bagliore non diminuisce col corpo, / ma la Musa
lo nutre”, un passo a cui accenneremo anche altrove.
Qualche parola conclusiva va spesa, invece, sulla proposta di lettura di Ferrari (2007a,
71): egli non accoglie la lettura proposta dagli editori e difesa, con validi argomenti, da
Di Benedetto e da Hardie, ma neppure il testo di West (q≥alavmoi" ajeivdw); trascrive,
invece, l’ultimo verso così: ]..h≥] k≥a;t≥ k≥alavmoi" ajeivdw. Egli traduce: “o al suono degli
auli io canto”. Le argomentazioni del Di Benedetto e di Hardie sembrano, tuttavia,
sufficienti a difendere il testo degli editori del papiro, almeno per quanto concerne la
parte finale del verso.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
139
bV (58, 1-10 L.-P. = V.) metrum: ] , hipp2cho
suppl. possis
].[ 2 ].da[
]
4 ].a ]uvgoisa[ ]
6 ]. [.. ].. [ ]i≥ davcqhn ]cu q[ev]o≥i≥[.]all[......]uvtan
8 ].cqo. [.]ativ.[.....]eisa ]mevna tan [....wv]numovn se
10 ]ni qh'tai st[uv]ma[ti] provkoyin
...essendo fuggita
6 fu morsa...dal dente di un vipera proprio gli dei: e tu Calliope lei
8 …
invocando te, la dea dai molti nomi,
(con l'auspicio) che realizzi una prestazione con una voce migliore.
TEST (I) POxy. 1787 fr. 1,1-10 [1-10] prim. rec. Diehl1
1923, 357
CRIT 2 ]i vel ]u da –[ potius quam dav[║4 ]m≥a vel ]n≥a leg. Lobel 1925, 26 ║5
]ivgoisa[.]Hunt 1922, 28-29 : f]uvgoisa[ Diehl2
1936, 4]43: f]uvgoisa[n Di Benedetto
2005, 13 ║6 ]idavcqhn Hunt 1922, 28-29 : ]id∆avcqhn vel ]i davcqhn Voigt 1971,
77-79 : ejcivdna"... o[dont]i davcqhn Di Benedetto 2005, 13 dav–c║7 v]utan : a]uvtan Hunt 1922, 28-29: pavg]cu q[ev]oi:[K]all[iovpa su; dVa]u[tan Di Benedetto 2005, 13
║8 fort. ]a≥c vel ]l≥c leg. Lobel 1925, 26-27; Voigt 1971, 77-79 fort. ]a[≥cqo"≥[ Voigt 1971, 77-79 ]a±tiv, mox k[, vel l[,vel n[, vel
simm. legit Voigt 1971, 77-79║9 ]mevna – : keklo]mevna Di Benedetto 2005, 11
v]numovn : [poluwv]numovn Lobel 1925, 26-27 ║10 krevsso[ni Di Benedetto 2005,
11 q, ut vid., m.1 corr. qh' st[uv]ma[si] potius quam
st[uv]ma[ti] Hunt 1922, 29, 42 : st[uv]ma[ti] Lobel 1925, 26-27, rec. Stiebitz 1926, col.
1259, Voigt 1971, 77-79 provk
Il frammento non risulta restituibile fino al v. 5.
5 Grenfell-Hunt (Hunt 1922, 28-29) leggevano, sul papiro, ]ivgoisa[.], ma già il
Diehl2 (1936, 4[43) nella sua seconda edizione, proponeva di restituire f]uvgoisa; anche
solo una forma verbale di tal genere può fornirci delle informazioni preziose: in questo
caso veniamo a conoscenza che il soggetto (materialmente "chi compie l'azione") è una
donna e che, se si accetta la congettura, è fuggita, o, come dice il Di Benedetto (2005,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
140
13), "è coinvolta in una fuga". Se, come sembra, si aveva qui la narrazione di un
episodio mitico, è probabile che esso venisse riferito tramite la frase oggettiva introdotta
da un verbum dicendi: tale costruzione è ben attestata in Saffo, per cui cfr. fr. 166 fai'si
dhv pota Lhvdan ujakivnqinon / ã...Ã w[i>on eu[rhn pepukavdmenon "dicono che un giorno
Leda trovò un uovo color del giacinto, nascosto…"; gV 9-10
kaiv gavr p[o]ta Tivqwnon e[fanto brodovpacun Au[wn 10 e[rwi d ≥e≥vp ≥a≥"≥ eijsavmbamen∆eij" e[scata ga'" fevroisa[n ed infatti una volta dicevano di Titono che Aurora braccia di rosa
per amore salì sulla coppa, portandolo ai confini della Terra.
E cfr. anche il fr. 54, purtroppo per noi ben poco definibile:
( [Erwta) e[lqont∆ejx ojravnw porfurivan perqevmenon clavmun (Eros) che venne dal cielo indossando clamide purpurea
Sembra quindi opportuno che il participio sia declinato all'accusativo: Di Benedetto
integra perciò f]uvgoisa[n, dato che già nell'editio princeps del papiro si indicava una
lettera incerta in più dopo l'alpha.
6 I primi editori del papiro ossirinchita, Grenfell ed Hunt
(1922, 28-29),
trascrivevano ]ida–vcqhn, ma restituivano ]id∆a–vcqhn. La Voigt (1971, 77-79), nel suo
apparato, propone di restituire ]i da–vcqhn: si tratta, quindi, di un infinito aoristo passivo
eolico del verbo davknw, "mordere", preceduto dallo iota finale della parola precedente.
Di Benedetto (2005, 12s.) su questa base, riferisce il frammento al mito di Euridice, per
il quale cfr. Verg. Georg. IV 457-459: Proteo si rivolge ad Aristeo dicendo:
Illa quidem, dum te fugeret per flumina praeceps,
immanem ante pedes hydrum moritura puella
seruantem ripas alta non uidit in herba.
Ella, mentre ti fuggiva precipitosamente lungo le acque,
non vide, fanciulla destinata alla morte, davanti ai suoi piedi,
tra la folta erba, il mostruoso serpente che custodiva le rive.
E cfr. anche Ov. Metam. X, 8-10 e 23-24:
nam nupta per herbas
dum noua naiadum turba comitata uagatur,
occidit in talum serpentis dente recepto
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
141
Infatti la fresca sposa, mentre, accompagnata da un gruppo di
Naiadi, vagava tra l'erbe, morì, avendo ricevuto al tallone il morso
di un serpente
causa uiae est coniunx, in quam calcata uenenum
uipera diffudit crescentesque abstulit annos
La causa del viaggio è mia moglie che è stata avvelenata da una
vipera, che, calpestata, le ha sottratto gli anni fiorenti
E così il Di Benedetto (2005,13) restituisce ejcivdna"...o[dont]i davcqhn, cioè "fu morsa
dal dente d'una vipera"
7 Gli editori di questo papiro di Ossirinco già avevano proposto a]uvtan. Di
Benedetto restituisce, sulla base del mito di Euridice, pavg]cu q[ev]oi:[K]all[iovpa su;
d∆a]u[tan: Euridice era, infatti, la moglie di Orfeo, la cui madre era Calliope.
Per Calliope si cfr. Alcm. 84 Calame
Mw's∆a[ge Kalliovpa, suvgater Diov" Orsù Musa, Calliope figlia di Zeus
Per Kalliovpa su; d∆au[tan si confronti il fr. 124, anche se lì, a differenza del
frammento oggetto della nostra analisi, il pronome si riferisce proprio a Calliope e
l'ordine delle parole è opposto:
au[ta de; su; Kalliovpa
…e tu stessa, o Calliope...
Più recentemente, Di Benedetto (2006, 17) ha proposto il confronto con l'epigramma 53
A.-B. v. 1 di Posidippo:
Kalliovph, su; me;n wj~de: se; de; klaivousin eJtai'rai Calliope, tu sei qui: ti piangono le compagne
Di Benedetto fa notare come in tutti e due i componimenti, cioè quello di Saffo e quello
di Posidippo, sia coinvolta una giovane donna morta: in Saffo è Euridice ad essere
seppellita da Calliope, mentre in Posidippo Calliope è proprio il nome della ragazza
deceduta a séguito della caduta da un tetto durante una pannuciv", ovvero una veglia
notturna.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
142
Per su; d∆ a]u[tan un confronto lo possiamo stabilire con l'Ode ad Afrodite (1.27-28):
su; d∆au[ta suvmmaco" e[sso
…e tu stessa siimi alleata
Per su; d(ev) preceduto da un vocativo che così viene enfatizzato si pongono alla nostra
attenzione alcuni confronti; ad es. Il. XXI 448
Foi'be, su; d∆ejlivpoda" e{lika" bou'" boukoleveske" E tu, Febo, i buoi zampe ricurve e corna ritorte pascevi
Si confronti anche Emp. fr. 1 (= DK 31 B 1)
Pausanivh, su; de; klu'qi, dai?frono" jAgcivtew uiJev Pausania, e tu ascolta, o figlio dell'assennato Anchite
E si cfr. anche, per su; d(ev) seguito da un vocativo, 1.13-16
su; d∆, wj~ mavkaira, meidiaivsais∆ajqanavtwi prosovpwi
h[re∆o[tti dhujjjjjjjjjjjjj~te pevponqa kw[tti dhujjjjjjjjjjj~te kavlhmmi E tu, o beata,
sorridendo nel tuo volto immortale,
mi domandasti che cosa di nuovo soffrivo
e perché, di nuovo, ti invocavo.
Per su; d(ev) seguito da un vocativo, ma a più lunga distanza, si confronti qui fr. eV 17-19
(le integrazioni sono di F. Ferrari):
su; d∆, eu\ ga;r oi\sqa
18 [.]rovthn Nevme[sin kh'non o]" ai\scr∆oi \de kr]evtei t∆aj[o]llevwn Yavpfoi
…ma tu, difatti, ben sai
che Nemesi colpisce colui che medita infamie e domina tutti,
o Saffo…
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
143
Ritorniamo al frammento bV: qui Saffo, per il Di Benedetto (2005, 13), farebbe
riferimento ad una reazione di rabbia da parte dei numi, cfr. Verg. Georg. IV 454 (la
madre spiega ad Aristeo):
non te nullius exercent numinis irae
non proprio di nessun nume ti travaglian le ire
Per gli dei irati in presenza dell'avverbio pavgcu, cfr. Il. XIV 143; Poseidone si presenta
da Agamennone e dice:
soi; d∆ou[ pw mavla pavgcu qeoiv mavkare" kotevousin Non fino in fondo i numi beati sono irati con te
9-10 Già Grenfell-Hunt (1922, 28) restituivano st[uv]ma[ti], oppure st[uv]ma[si],
anche se preferivano il secondo, perché, a parer loro, meglio si adeguava allo spazio
della lacuna. st[uv]ma[ti], invece, fu accolto dal Lobel (1925, 26-27) e, poco tempo
dopo, dallo Stiebitz (1926, col. 1259): errata è, dunque, la sequenza cronologica
Stiebitz245
-Lobel presentata dalla Voigt (1971, 77-78). Di Benedetto (2005, 11)
restituisce, per mezzo di due sue congetture (v. 9 keklo]mevna; v. 10 krevsso]ni) e di una
del Lobel (1922, 26: v. 9 [poluwv]numovn), il testo
keklo]mevna ta;n [poluwv]numovn se krevsso]ni qh'tai st[uv]ma[ti] provkoyin
invocando te, la dea dai molti nomi,
(…con l'auspicio…) che realizzi una prestazione con una voce
migliore
provkoyi", al contrario di quello che siamo portati a pensare, non deriva direttamente dal
verbo prokovptw, cioè "avanzare, fare progressi", ma è un composto di un sostantivo non
attestato, ovvero *kovyi", un nome d'azione di cui abbiamo però traccia nelle seguenti
parole: il termine del linguaggio medico ajnavkoyi" "intervallo, interruzione" (Herod.
Med. in Rh. Mus. 58,91), ajntivkoyi" "scontro di venti" attestato nel trattato Sui venti
(55) di Teofrasto, ajpovkoyi", ancora un termine del gergo medico per indicare "sezione,
taglio" ed attestato in Ippocrate (Art. 68), diavkoyi" "taglio", parola attestata
nuovamente in Teofrasto (Periv futw'n aijtiw'n 5.9.11), provkoyi", appunto, e
245
L’aricolo dello Stiebitz è un’ Auszug di un contributo, ben più esteso, pubblicato a Praga in lingua ceca
su “Listy filologické” 52 (1925): che l’originale fosse successivo all’edizione del Lobel è forse dimostrato
dal fatto che lo Stiebitz riporta direttamente nel testo st[uv]ma[ti] senza darne notizia.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
144
provskoyi" "attrito, strofinamento" attestato in due passi di Aristotele (Mech. 852 a 32 e
Pr. 940 a 12).
Il radicale è kop- ed è da ricollegare al lituano kapiù "tagliare, abbattere", all'antico
slavo kopajo "fendere, tagliare" ed al latino capus, capo "cappone". Il senso originario
dei composti con pro- (prokovptw, prokophv e provkoyi") doveva essere "stirare,
distendere", donde "procedere, avanzare, progredire" e, quindi, "svilupparsi,
migliorarsi" (anche in senso morale); provkoyi", come tutti i composti di *kovyi", sembra
essere di uso abbastanza ristretto, limitato a determinati campi delle attività e della vita
umana: il Di Benedetto (2005, 11) la considera una parola di uso tecnico, se non
addirittura gergale. Al contrario, prokophv (già gli editori del POxy. 1787 lo
consideravano come un suo sinonimo), è un termine che compare spesso in letteratura:
soprattutto, ma non solo, nel linguaggio filosofico, assunse il significato di "progresso",
generalmente riferito alla sfera morale e sociale (ed un tale significato ha mantenuto
anche nel neogreco): lo storico Polibio indicava lo svilupparsi, il progredire, con
l'espressione prokoph;n poiei'sqai. Il numero piuttosto scarso delle attestazioni (3x) non
fa che confermare ciò: Grenfell e Hunt commentavano "provkoyi" as a synonym of
prokophv has not occured previously" ed a ciò occorre aggiungere che questa parola
scompare dalle nostre fonti per molti secoli: ricompare di nuovo solo in un trattato
medico del I sec. d.C. (Herod. Med. in Rh. Mus. 58,77), ma con il significato di
"attacco" in riferimento ad una crisi epilettica:
Th'i de; dia; touvtwn ejkdromh'i tou' pneuvmato" th;n provkoyin givnesqai e[fh kai; th;n sunolkh;n kai; to;n spasmovn
Diceva che dall'emissione di respiro, che avviene a causa di ciò,
derivava l'attacco, la contrazione e lo spasmo.
Successivamente, dopo un salto di altri quattro secoli, la ritroviamo in un luogo del
lessicografo Orione (V sec. d.C) (n, 109, 8 s.u. nuvx)
para; to;n ginovmenon ejk tw'n prokovyewn tou' skovtou nugmovn
a causa dell'urto che deriva dall'avanzare delle tenebre
ma è una lectio dubia, soprattutto alla luce di ciò che segue nello stesso lemma:
aujto; de; to; nuvxai ajpo; tou' nuvssw, tou' dhlou'nto" to; plh'xai e lo stesso nuvxai "urtare" da nuvssw "io urto", che significa
"colpire"
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
145
sembra quindi opportuno emendare tw'n prokovyewn in tw'n proskopw'n (oppure tw'n
proskovyewn) ejn tw'i skovtei, intendendo, quindi: "a causa della botta che deriva dagli
urti nelle tenebre", soprattutto alla luce di Hellad. Chrestomathia in Phot. Bibliotheca,
cod. 279, 535 a: {Oti to; nuvx me;n ajpo; tou' nuvxw gevgone, kata; ajpokophvn:
nuttovmeqa ga;r ejn tw'i skovtei prosptaivonte" kai; oujc oJrw'nte", ejx w|n nugmoiv
te kai; plhgaiv. "(diceva) che la parola nuvx ("notte") è derivata da nuvxw ("io urterò")
per apocope: infatti noi nel buio urtiamo, poiché inciampiamo e non vediamo, donde gli
urti e i colpi".
L'Etymologicon Magnum, che riassume questo passo di Elladio in Fozio con dia; to;
nuvssesqai kai; prosptaivein toi'" ejnergou'si ti; ejn skovtei "a causa dell'urtare e
dell'inciampare per coloro che fanno qualcosa al buio", aggiunge h[ para; to;
proskovptein kai; plhvttesqai tou;" badivzonta" ejn aujth'i th'i w{rai "oppure a
causa di quelli che, camminando, inciampano e sono colpiti proprio nelle ore notturne".
Risulta quindi nettamente preferibile, in base a questi passi ora citati, emendare quel
luogo di Orione: così le attestazioni di provkoyi" si riducono a due.
Il significato astratto presente in Saffo, cioè "progresso, miglioramento, sviluppo", lascia
spazio a significati più concreti e maggiormente connessi con la sfera originaria del
verbo prokovptw, ovvero "procedere, avanzare": possiamo quindi affermare, non avendo
altre testimonianze scritte (soprattutto contemporanee, precedenti o di poco successive
alla poetessa) che il significato che tale parola assume in questo passo di Saffo è un
a{pax. Inoltre, è interessante notare come diverso sia il registro dei tre passi: ciò non
toglie che essi abbiano una caratteristica in comune, l'essere costituiti da un linguaggio
attinente alla sfera tecnica: il linguaggio dei cultori delle Muse, quello dei medici e
quello dei grammatici (se si accoglie il testo tradito di Orione).
L'espressione qh'tai provkoyin "realizzi una prestazione, realizzi un miglioramento" è
chiaramente una perifrasi, per altre espressioni perifrastiche si cfr. ad es. Il. XXIV 402
qhvsontai peri;a[stumavchneJlivkwpe" jAcaioiv"battaglia faranno intorno alla rocca
gli Achei dagli occhi vivaci"; Od. I 116 (Telemaco spera che il padre torni) mnhsthvrwn
tw'n me;n skevdasin kata; dwvmata qeivh "scacciasse i pretendenti che sono in casa";
Pi. O. II 97 to; lalagh'sai ejqevlwn kruvfon te qevmen ejslw'n kaloi'" / e[rgoi"
"bramando che il ciarlare avvolga le belle opere degli uomini illustri"; O. VII 42b kai;
semna;n qusivan qevmenoi "e facendo il sacro rito"; O. XIII 53 kai; ta;n patro;" ajntiva
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
146
Mhvdeian qemevnan gavmon "e Medea che contro il padre si sposò"; N. I 4-6 sevqen
aJdueph;" / u{mno" oJrma'tai qevmen/ai\non ajellopovdwn mevgan i{ppwn, Zhno;"
Aijtnaivou cavrin: "da te il canto dolce parola si slancia ad attribuire un grande elogio
ai cavalli dai piedi come il turbine, per grazia di Zeus Etneo"; Aeschl. Ag. 1059b mh;
scolh;n tivqei "non indugiare" etc.
Per l'aggettivo [poluwv]numovn, cioè "(la dea) dai molti nomi" (ma qui assume anche il
significato derivato e ben più significativo di "rinomata, famosa"), cfr. Hes. Theog. 75-
79 ed in particolare proprio l'ultimo verso, dove con proferestavth si indica la qualità
che nel nostro frammento saffico viene indicata con [poluwv]numovn, ovvero l'essere
"famoso, illustre":
tau't∆a[ra Mou'sai a[eidon jOluvmpia dwvmat∆e[cousai, ejnneva qugatevre" megavlou Dio;" ejkgegaui'ai, Kleiwv t∆ jEujtevrph te Qavleiav te Melpomevnh te Teryicovrh t∆ jEratwv te Poluvmniav t∆ jOujranivh te Kalliovph q∆: hJ de; proferestavth ejsti;n aJpasevwn.
Dunque questo cantavano le Muse che hanno dimora sull'Olimpo,
le nove figlie nate dal grande Zeus,
Clio, Euterpe, Talia, Melpomene,
Tersicore, Eratò, Polimnia, Urania
e Calliope: ma lei è la più illustre tra tutte.
Qui proferestavth si riferisce a Calliope, proprio come [poluwv]numovn nel frammento
saffico. Ciò che occorre sottolineare, di questo famoso "catalogo delle muse" esiodeo, è
che "the last-named is also the most important": come osserva il West246
si tratta di una
formula ben attestata, per cui si cfr. Theog. 361b h} dhv sfewn proferestavth ejsti;n
aJpasevwn alla fine del lungo catalogo delle Oceanine ed Hymn. Cer. 110b h} tw'n
progenestavth hj~en aJpasw'n "era la maggiore di tutte". Perciò, osserva il Di Benedetto
(2005, 13): "Calliope non era in Esiodo solo una tra le nove Muse: […]invocare Calliope
significava riconoscere la nozione di una Musa al singolare, che rappresentava anche le
altre". L'interpretazione dei versi successivi a questo catalogo esiodeo è abbastanza
controversa, soprattutto per il brusco passaggio dalla terza persona singolare alla terza
plurale: prima si celebra la sola Calliope, ma immediatamente dopo tutte le Muse
diventano soggetto attivo dell'azione. Improvvisamente compaiono anche i "re": "They
are not" -dice il West- "usually regarded by the Greeks as being dependent upon the
246
West 1966, 180 sgg.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
147
Muses, except for the celebration of their renown".West ritiene che Esiodo abbia
introdotto l'elogio dei re proprio perchè il poema era a loro destinato: al di là di questo
particolare, il senso del passo è tutto nei vv. 83-84 a, dove si dice che al re
tw'i me;n ejpi; glwvsshi glukerh;n ceivousin ejevrshn, tou' d∆ e[pe∆ ejk stovmato" rJei' meivlica
quello al quale sulla lingua versano dolce rugiada,
dalla sua bocca le parole scorrono dolci
Perciò: "the effect of the glukerhv e{rsh (cioè il miele) is that the king's words rJei'
meivlica". Martin West, sulla base del confronto con [Hom.] Hymn. Merc. 558-
559ejnteu'qendh;e[peitapotwvmenaia[llotea[llhi/khrivabovskontaikai;tekraivnous
ine{kasta"di lì, volando ora qui ora là, si nutrono dei favi ed ogni profezia si avvera",
spiega che il miele è associato con la capacità di formulare profezie veritiere: chi se ne
cibava diventava capace di profetizzare. Non sono quindi i poeti a cantare, ma sono le
Muse per il tramite della lingua e della voce dell'uomo: perciò Saffo invoca la più
illustre tra le Muse, Calliope, affinché Calliope / Saffo realizzi krevssoni stuvmati una
provkoyi".
Per l'uso ed il significato di [poluwv]numovn, cfr. Hes. Theog. 784-787:
Zeu;" dev te \Irin e[pemye qew'n mevgan o{rkon ejnei'kai thlovqen ejn crusevhi procovwi poluwvnumon u{dwr, yucrovn, o{ t∆ejk pevtrh" kataleivbetai hjlibavtoio uJyhlh'"
Zeus mandò Iride a portare il gran giuramento degli dei
da lontano, in un'aurea brocca, l'illustre acqua,
fredda, che zampilla dalla roccia scoscesa ed elevata.
Ed anche Pi. P. I 17, in riferimento al mostro Tifone:
tovn pote Kilivkion qrevyen poluwvnumon a[ntron:
lui un tempo il famoso antro cilicio allevò.
Per l'uso di questo aggettivo in riferimento, non ad un oggetto inanimato, ma ad una
persona o, ancor meglio, ad una divinità, cfr. [Hom.] Hymn. Cer. 17-18, in riferimento
ad Ade che rapisce la figlia di Demetra, Persefone,
th'i o[rousen a[nax poludevgmwn i{ppoi" ajqanavtoisi, Krovnou poluwvnumo" uiJov".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
148
…ne uscì con i cavalli immortali
il signore che molti accoglie, l'illustre figlio di Crono
E cfr. anche [Hom.] Hymn. Ap. 82b, un passo in cui la stessa isola di Delo chiede a
Latona la promessa che il figlio, Apollo, una volta nato, non la distrugga (cfr. anche
Allen - Sikes 1904, ad [Hom.] Hymn. Cer.17-18):
ejpei; h\ poluwvnumo" e[stai.poiché certamente sarà famoso.
Il Di Benedetto (2005, 11-12) nota come questo frammento, tratto dal POxy. 1787 ed il
fr. 160 (per cui v. supra) costituisca un sistema di moduli introduttivi al canto: essi
avevano come punto di riferimento la stessa esecuzione pratica del canto (voce bene
impostata, canto musicalmente adeguato etc.) ed in essi, sostiene il Di Benedetto, un
ruolo importante lo giocava l'invocazione alle Muse, o alla Musa (keklo]mevna tan
[poluwv]numovn se), come nel fr. aV che recentemente ci è stato reso noto dalla
pubblicazione del P.Köln 21351 e che si conclude, anche esso, con una invocazione alla
Musa.
gV (58, 11-22 L.-P.=V.) metrum: hipp2cho
[ ij]õo≥k[ov]l≥Õpwn kavla dw'ra, pai'de", [ ta;]õn≥Õ filavoidon liguvran celuvnnan. [ privn]õp≥ot∆[e[]oÕnta crova gh'ra" h[dh [ leu'kai d∆ ejg]õevnoÕnto trivce" ejk melaivnan
5 õbavru" dev m∆ oj [q]u'mo≥"≥ pepovhtÕai, govna d∆ouj fevroisi, õta; dhv pota laivyhr∆e[on o[rcÕhsq∆ i[sa nebrivoisin õ—ãtau'Ãta stenacivsdw qamevw". ajÕlla; tiv ken poeivhn… õaj≥g≥h≥vraon a[nqrwpon e[ont∆Õouj duvnaton gevnesqai. õ—kaiv g≥avr p≥[ ≥o]t≥a≥ Tivqwnon e[fantoÕ brodovpacun Au[wn
10 õe[rwi d≥e≥vp≥a≥" eijsavmbamen∆ eij" e[sÕcata ga'" fevroisa[n õ—e[onta≥ [k]a≥vl≥o≥n kaiv nevon, ajll∆ au[tÕon u[mw" e[marye õcrovnwi p≥o≥vl≥i≥o≥n≥ gh'ra" e[c≥≥≥[o]n≥t≥∆ ajqanÕavtan a[koitin.
(…),fanciulle, i bei doni delle Muse dal cinto viola
(…) la cetra armoniosa ed amante del canto,
la pelle che un tempo era (tenera) la vecchiaia (me)
(l' ha rovinata): i capelli da neri sono diventati bianchi,
5 l'intimo impulso si è appesantito, le ginocchia non reggono,
esse che un tempo erano agili a ballare come i cerbiatti:
di ciò mi lamento spesso: ma che si potrebbe fare?
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
149
Indenni da vecchiaia non si può essere, giacché si è uomini:
ed infatti un tempo di Titono dicevano che Aurora braccia di rosa
10 per amore salì sulla coppa, portandolo ai confini della Terra,
lui che era giovane e bello, tuttavia col tempo se lo prese
la canuta vecchiaia, lui che aveva una sposa immortale.
TEST (I) POxy. 1787 fr. 1, 11-22 [1-12] (II) P.Köln 21351+21376 col.
I et II vv. 9-20 [1-12] ad v. 12 coronidem collocandam esse censuerunt Di
Benedetto 2004a, 21; 2004b,6; Ferrari 2005, 26-27; West 2005, 5
prim. rec. Diehl1 1923, 356-357
CRIT 1 ]pwn (I): ]o≥k[.]l≥pwn (II) Moivsan ij]ok[ov]lpwn Stiebitz 1926,
col. 1260 : geraivrete Moivsan ij]ok[ov]lpwn Di Benedetto 1985, 148 : e. g. fevrw tavde Moivsan ij]ok[ov]lpwn Gronewald et Daniel 2004a, 7 : [Ummin fivla Moivsan ij]ok[ov]lpwn Di Benedetto 2005, 18 : [Umme" peda; Moivsan ij]ok[ov]lpwn West 2005, 5
: Tevttix a[te Moivsan ij]ok[ov]lpwn Livrea 2007, 75-76 : Aij stevrgete Moivsan ij]ok[ov]lpwn Ferrari 2007a, 180 kav (I) pai'de" (I): paid[ (II) ║2 fort. ]n≥ lavboisai] filavoidon liguvran celuvnnan Di Benedetto 1985, 149, ante P.Köln
21351+21376 editum esset: lavboisa vel e[loisa pavlin ta;]n≥ filavoidon e. g.
Gronewald et Daniel 2004a, 7 : e[man ka;t] filavoidon Ferrari 2003, 73, ante P. Köln
editum esset : coreuvsate ka;t ta;]n filavoidon Di Benedetto 2004b, 5 : prevpei de; lavbhn ta;]n filavoidon Di Benedetto 2005, 18 : spoudavsdete kai; ta;]n filavoidon West 2005, 5 : e[cw ka;t e[man ta;]n≥ filavoidon Livrea 2007, 72-73 : coreuvsate (olim Di Benedetto) vel ejlivssete ka;t ta;]n filavoidon Ferrari 2007 a, 180
]fil∆avoidon(I), filavoidon tamen legendum esse intellegit Maas 1922, 179 :
filaoidon (II) guvr(I) celuvnnan (I): ..[ (II) uvnna –n (I) ║3 e[moi me;n e[kary(en) e. g. Snell : kevkarf∆ a[palovn moi] Gronewald et Daniel 2004a, 7 : e[moi d∆a[palon privn] Di Benedetto 2004b, 5, rec. West 2005, 5, Livrea 2007, 72-73
]nta (I): p≥ot∆[.]onta (II) [e[]onta Gronewald et Daniel 2004, 5
crova (I): [...]a (II) gh'ra" (I): ghra[.] (II) hvdh(I) ║4
leu'kai t∆ ejg]evnonto Grenfell-Hunt 1922, 29 : leu'kai d∆ ejg]evnonto Lobel 1927, lxxxiii
: diwvlese: leu'kai d∆ ejg]evnonto Di Benedetto 2004b, 5 : ejpevllabe, leu'kai d∆ ejg]evnonto West 2005, 5 : aijkivssato, leu'kai d∆ ejg]evnonto Di Benedetto 2006, 18 :
ejpevsceqe, leu'kai d∆ ejg]evnonto Livrea 2007, 72-73 trivc (I)
melaivnan (I): melaivn[ (II) ║5 [q]u'mo" Gronewald et Daniel 2004a,5
gona (I): g[...] (II) fevroisi (I) ║6 ]hsq∆ (I), sed -orc]hsq∆ integrandum esse
iam vidit Edmonds 1927, 23 : o[rchsq∆ (II) ivsa (I) ║7 ]ta stenacivzw, una
syllaba deficitur (II): ãtau'Ãta Gronewald et Daniel 2004, 8, rec. Di Benedetto 2004a: ta; ãme;nà West 2005, 5: tavãdeà vel ãza;à ta; Burzacchini 2007, 98 stenacivzw (II):
stenacivsdw corr. Di Benedetto 2004a, West 2005, 5, Livrea 2007, 73 tiv (I) evihn (I) ║8 gevnesqai (I): ge.[ (II) ║9 p[o]ta Gronewald et Daniel 2004a, 5
brodovpacun (I): brodovpacu[(II) dovpa–c (I) auvwn (I) ║10
d≥.[.]..eisanbamen (II): d≥e≥v[p]a≥"≥ eijsavmbamen∆ Gronewald et Daniel 2004b, 2, rec. Di
Benedetto 2005, 18-20: †f..aqeisan† bavmen West 2005, 5 : d≥i≥v[fr]o≥n≥ Magnani 2005, 47
: l≥a≥[l]a≥vg≥e≥isan bavmen∆ Janko 2005 : d≥e≥v[m]a≥" Livrea 2007, 73 : d≥i≥e≥[l]av≥q≥e≥isan bavmen∆ Ferrari 2007a, 180 fevroisa[ (I): f[ (II) fevroisa[n Stiebitz║11 [k]avlon Gronewald et Daniel 2004b, 2 ajllV au[ton suppl. Di
Benedetto 1985, 152 ante P.Köln 21351+21376 editum esset uvm (I)
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
150
evmarye (I): em[(II) ║12 e[c[o]nt∆ Gronewald et Daniel 2004b, 2 aqanatan (II): ]avta –n (I) avkoitin (I): a[ (II)
La pubblicazione, avvenuta nel 2004247
, del PKöln 21351+21376 [MP3 1449.01; LDAB
10253] ha permesso di integrare la parte sinistra di un'ode di Saffo che già conoscevamo
parzialmente: il testo più completo al momento disponibile è quello costituito dall'unione
del suddetto papiro coloniense e del fr. 1, 11-22 del POxy. 1787 [MP3 1449; LDAB
3899], quest'ultimo pubblicato per la prima volta da Hunt (1922, 28-29) nel volume XV
de The Oxyrhynchus Papyri. L’evento ha suscitato, come era naturale, molto interesse
negli studiosi e si sono date alle stampe molti contributi specialistici: al centro del
dibattito sono state due questioni fondamentali, ovvero le possibili integrazioni a quelle
poche parti dell’ode rimaste sconosciute a causa delle lacune materiali del papiro
coloniense e la lunghezza originaria dell’ode che qui stiamo per commentare248
. Urge
ora, invece, occuparsi delle discussioni a riguardo della lunghezza originaria dell’ode e,
più genericamente, del suo significato. Il problema principale è dato dal fatto che i due
componimenti frammentari che precedono e seguono questo carme nei due papiri
sopramenzionati sono diversi: mentre per la differenza delle due odi (quella presente nel
papiro coloniense e quella del papiro ossirinchita) che la precedono non ci si è
interrogati, sulle due odi che seguono si è aperto un forte dibattito che ha visto gli
studiosi porsi su posizioni diverse. In realtà il dibattito si deve restringere alla sola ode
che segue nel papiro ossirinchita, perché l’altra, quella del papiro recentemente
pubblicato, è stato dimostrato non essere di Saffo249
e su questo non ci sono posizioni
divergenti. Si devono registrare due posizioni fondamentali: quella di chi sostiene, come
Di Benedetto, West, Luppe, Bernsdorff, Hardie, Ferrari ed Austin, che l’ode qui
analizzata doveva terminare al v. 12250
e coloro, come gli editori principi, Puelma-
Angiò, Magnani, Lardinois, Edmunds, Livrea e Burzacchini251
, che sostengono che l’ode
247
Cfr. Introduzione. L'editio princeps del papiro è stata pubblicata in varie fasi, ma per quello che qui ci
interessa cfr. Gronewald-Daniel 2004a; Gronewald-Daniel 2004b. Per le vicissitudini editoriali cfr.
Lundon 2007, 149-153; Nicolosi 2005, 87. 248
Un riassunto dello status quaestionis relativo soprattutto a quest’ode, ma tuttavia rimasto al 2006 si
trova, accanto a considerazioni personali dell’autore, in Burzacchini 2007, 98-110. Utile, da questo punto
di vista, anche Livrea 2007, 68-72. 249
Cfr. Gronewald-Daniel 2005, 7; Burzacchini 2007, 101. 250
Di Benedetto 2004a,21; 2004b, 6; 2006, 9-11; West 2005, 3-7; Luppe 2004, 8s.; Bernsdorff 2005, 1;
Ferrari 2005, 26-27; Hardie 2005, 1 n. 3, 27-29; Austin 2007, 120ss.. 251
Puelma-Angiò 2005, 13-15; Magnani 2005, 43ss.; Lardinois 2006; Edmunds 2006, 24-25; Livrea 2007,
71ss.; Burzacchini 2007, 108.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
151
doveva continuare anche nei quattro versi successivi che il papiro ossirinchita riporta
dopo l’ode qui in oggetto: questi ultimi sostengono, in particolare, che porre la fine di
componimento dopo il termine di una narrazione mitica suonerebbe sehr abrupt, ma
Hans Bernsdorff252
ha dimostrato che questo è ciò che accade con sicurezza anche in Pi.
O. IV; N. I; Pae. IV; Hor. Ep. XIII; Carm. I 7; Carm. I 8; Carm. III 11; Carm. III 27. È
bene, comunque, precisare che nessuno, prima della pubblicazione del papiro
coloniense, aveva mai dubitato dell’appartenenza del “tetrastico”, ovvero dei quattro
versi che nel papiro ossirinchita seguono il carme presente anche nel nuovo papiro, a ciò
che precede253
: si segnala, in particolare, la posizione assunta da Vincenzo Di Benedetto
che, prima della pubblicazione del papiro coloniense considerava gli ultimi quattro versi
come prosieguo di ciò che precede, mentre ora li considera come un’ode separata254
.
1 Di Benedetto ha integrato l'imperativo geraivrete ("onorate"). Il West255
,
invece, notando la contrapposizione tra lo status fisico delle ragazze e quello di Saffo,
preferisce restituire u[mme" pedav: successivamente, il Di Benedetto, sulla scorta del
West, ha proposto di restituire u[mmin fivla Moivsan]256
. Livrea (2007, 72-73, 78)
propone di integrare, invece, tevttix a[te Moivsan ij]ok[ov]lpwn “come una cicala”.
Moivsan ij]ok[ov]lpwn (o baqukov]lpwn) è la congettura dello Stiebitz (1926, col. 1260)
prima della pubblicazione del P.Köln 21351+21376: lo studioso proponeva il confronto
con Pi. P. I 12 baqukovlpwn te Moisa'n e rimaneva incerto tra le due possibilità, ma Di
Benedetto (1985, 147-148), partendo dalle considerazioni di Stiebitz, aveva già
ipotizzato che nel testo di Saffo doveva esserci Moivsan ij]okovlpwn: l’aggettivo, infatti,
ricorre in altri passi della poetessa eolica, per cui cfr. infra. Il nuovo papiro ha
confermato l'integrazione ij]ok[ov]lpwn. Tutti accolgono l’integrazione dello Stiebitz
(1926, col. 1260), anche se, talvolta, con lievi modificazioni: Austin (2007, 118-119)
integra, ad esempio, Moivsan ejpideivxasq∆ij]ok[ov]lpwn kavla dw'ra pai'de" “montrez,
mes enfants, la beauté des dons des Muses à la ceinture violette”. L’integrazione di
252
Bernsdorff 2005, 2-5. 253
Cfr. Hunt 1922, 27. 254
Cfr. Di Benedetto 1985, 152, dove si afferma che il tono conclusivo dei vv. 25-26 dimostrerebbe la
“fine di carme” (notare il singolare) “al v. 26”. In realtà Di Benedetto, nel corso di quell’articolo, non
afferma mai direttamente che si tratti di un carme unico e certo non poteva perché all’epoca nessuno aveva
conoscenza del Papiro di Colonia e delle problematiche suscitate dalla sua pubblicazione, ma questa che
abbiamo delineato sembra essere la conclusione che è possibile trarne. 255
West 2005, 4 256
Di Benedetto 2005, 18
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
152
Austin è quella che si regge su un numero maggiore di paralleli e, del resto, era stata in
qualche modo anticipata da Alex Hardie (2005, 95), il quale, pur non arrischiandosi nel
proporre un’integrazione, proponeva di confrontare questo passo con Alcm. Fr. 59b
tou'to Ûadei'an e[deixe Mwsa'n / dw'ron mavkaira parsevnwn / aJ xanqa;
Megalostravta “questo dono delle soavi Muse lo mostrò, / beata tra le fanciulle, / la
bionda Megalostrata”; Thgn. 769-772 Crh; Mousw'n qeravponta kai; a[ggelon, ei[ ti
perissovn / eijdeivh, sofivh" mh; fqonero;n televqein, / ajlla; ta; me;n mw'sqai, ta;
de; deiknuven, a[lla de; poiei'n: / tiv sfin crhvshtai mou'no" ejpistavmeno";
“occorre che il servo ed il messaggero delle Muse, se qualcosa di eccellente / conosce,
non divenga invidioso della sapienza, / ma ricerchi, mostri e produca: / a che serve
conoscere da solo?” Ai passi forniti da Hardie, Austin ha aggiunto Pi. Hymn. fr. 22
Kavdmo" h[kouse tou' jApovllwno" mousika;n ojrqa;n ejpideiknumevnou “Cadmo ascoltò
Apollo che faceva una dimostrazione di una musica sul modo ortio”.
Moivsan è un genitivo plurale corrispondente all'attico Mousw'n: questo sostantivo
presenta un allungamento di compenso prima del sigma e probabilmente deriva da una
radice originaria *mont-ya o monq-ya, tuttavia varie sono le ipotesi dei linguisti, poiché
varie sono le direzioni di senso verso cui l'impiego di questo termine rimanda: alcuni
studiosi l' hanno messo in relazione con il sostantivo mevno", ma così la dentale non
sarebbe spiegabile; altri ancora, seguendo la paraetimologia presentata dallo stesso
Platone (Cra. 406 a), con il verbo mw'sqai ("desiderare, aspirare a qcs"); una
spiegazione accettabile potrebbe essere quella che mette in relazione questo sostantivo
con il verbo manqavnw e con il sanscrito mànthati, sulla base della presunta radice *men-;
l'altra spiegazione verosimile è quella che fa derivare questo sostantivo dalla stessa
radice i.e. presente nel sostantivo latino mons, montis, vedendo così la Musa come una
"ninfa della montagna": a quest'ultima ipotesi si può solo controbattere che tale radice
non è in alcun modo attestata nella lingua greca.
ij]ok[ov]lpwn "dal cinto viola" è un aggettivo composto da due radici, ovvero quella del
termine botanico i[on "viola, violetta" e quella di kovlpo". i[on presuppone,
probabilmente, un digamma (Ûivon): deriverebbe, come il latino uiōla, da una lingua
mediterranea. kovlpo", invece, è di origine i.e. e presuppone una radice originaria
*kwolp- (>*kÛovlpo"): questa parola costituisce un'eccezione, perché, come sappiamo,
generalmente la labiovelare sorda i.e. dà origine in greco ad occlusiva labiale sorda (per
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
153
cui ad es. i.e. sekwo-, lat. sequor, ma gr. e{pomai); in kovlpo" abbiamo invece un caso di
dissimilazione preventiva: il gruppo iniziale *kw- si è ridotto ad una semplice velare (k-)
differenziandosi così dalla labiale (-p-) con cui inizia la sillaba successiva (un altro
esempio è la parola kapnov", per cui cfr. lit. kvāpās) 257
. Alla radice *kwolp- si
ricollegherebbero infatti anche alcuni termini germanici: cfr. a. norvegese hualf, ted.
wölben "inarcare", medio alto tedesco walb "formare una volta, un arco", ags. hwealf
"volta, arco", a. norvegese holfinn "voltare". L'aggettivo è attestato altre quattro volte in
Saffo: di cui 1x nel fr. 21.13 (a[eison a[mmi / […] ta;n ijovkolpon "Cantaci /… lei dal
cinto viola"), 1x in fr. 30.4-5 (sa;n ajeivdois≥[i]n f[ilovtata kai; nuvm-/fa" ijokovlpw
"cantano l'amore tuo e della / sposa dal seno di viola") e 2x nel fr. 103.2-4 ajeivs]ate
ta;n eu[poda nuvmfan [ / ]t≥a pai'da K≥r≥onivda ta;n ijovk[olp]on [ / ]."≥ o[rgan qemevna
ta;n ijovk[ol]p≥o" a[ "…cantate la sposa piede leggiadro…/ …la figlia di Zeus seno di
viola…/…deponendo l'ira che colei che ha il seno di viola…"). Per l’associazione
viole/Muse cfr., invece, Pi. P. I 1-2 ijoplokavmwn...Moisa'n; I. VII 23 ijoplovkoisi
Moivsai". E cfr., soprattutto, Thgn. 250 Mousavwn dw'ra ijostefavnwn “doni delle Muse
coronate di viola”.
Per Moivsan...dw'ra cfr. Hes. Theog. 103b tacevw" de; parevtrape dw'ra qeavwn
"presto lo dirigono altrove i doni delle dee", dove con qeaiv si indicano proprio le Muse,
oppure si cfr. Alcm. 59(b).1s. Page = 149.1s. Calame tou'to Ûadha'n e[deixe Mwsa'n /
dw'ron mavkaira parsevnwn / aJ xanqa; Megalostravta "questo dono delle dolci Muse
lo insegnò, beata tra le fanciulle, lei, Megalostrata bionda "; Archil. 1.2 W.2 kai;
Mousevwn ejrato;n dw'ron ejpistavmeno" "e conoscendo l'amabile dono delle Muse";
Thgn. 250 ajglaa; Mousavwn dw'ra "i fulgidi doni delle Muse"; Sol. 13.51-52 W.2 a[llo"
jOlumpiavdwn Mousevwn pavra dw'ra didacqeiv", / iJmerth'" sofivh" mevtron
ejpistavmeno" "quello che, avendo appreso i doni delle Muse olimpie, conosce il limite
dell'amabile sapienza"; Bacchyl. 19.1-4 pavresti muriva kevleuqo" / ajmbrosivwn
melevwn, / o}" a]n para; Pierivdwn lav- / chisi dw'ra Mousa'n "c'è uno smisurato
cammino / di canti immortali / per colui che dalle Pierie / Muse abbia ottenuto i doni";
Pl. Lg. 796e ta;tw'nMousw'ntekai;jApovllwno"dw'ra"i doni delle Muse e di Apollo":
tutti questi passi dimostrano la fondatezza dell’integrazione dello Stiebitz.
257
Lejeune 1972, §72 (n. 3).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
154
pai'de", da pa-Û-id: questa parola greca appartiene ad una famiglia di termini con il
significato di "piccolo", cfr. latino pau-per.
2 Anche all'inizio del secondo verso di questo componimento abbiamo una lacuna:
Di Benedetto ha prima restituito coreuvsate ka;t ta;]n filavoidon "danzate secondo la
cetra armoniosa ed amante del canto" (ta;]n≥ è un'integrazione degli editori del papiro di
Colonia, mentre ka;t è del Ferrari), ma poi, sulla scorta di spoudavsdete ("occuparsi di
qualcosa") del West, ha congetturato prevpei de; lavbhn...("conviene prendere la cetra
armoniosa…"). Livrea (2007, 72-73), invece, integra e[cw ka;t∆e[man ta;]n≥ ed intende i
primi due versi così: “come una cicala possiedo, fanciulle, i bei doni delle Muse dal
seno di viola, nella mia canora cetra che ama il canto”. Austin (2007, 118-119) propone
di integrare, invece, ejgevrrate t∆au \ ta;]n≥ filavoidon liguvran celuvnnan “svegliate di
nuovo la cetra armoniosa ed amante del canto” e propone il cfr. con Pi. N. X 21
eu[cordon e[geire luvran “sveglia la lira dalle belle corde”.
Il POxy. 1787 presenta ]fil∆avoidon, ma che si dovesse leggere ]filavoidon aveva intuito
Paul Maas (1922, 179). La pubblicazione del papiro coloniense ha confermato l’ipotesi
di Maas.
3 Negli anni venti Edgar Lobel riteneva molto probabile l'integrazione pav]nta258
proposta da Grenfell e Hunt e la stessa Voigt la accettava addirittura nel testo edito: il
nuovo papiro ha dimostrato la sua infondatezza. Lo Snell molto prima della
pubblicazione del Papiro di Colonia aveva integrato e[moi me;n e[kary(en). Gronewald e
Daniel nell'editio princeps del papiro proponevano di integrare kevkarf∆ a[palovn moi] e
questo sulla base del confronto con Archil. fr. 188.1 sgg. oujkevq∆oJmw'" qavllei" aJpalo;n
crova: kavrfetai ga;r h[dh / o[gmoi" "non più sei in fiore nella tenera pelle: già, infatti,
si dissecca per via delle rughe". Di Benedetto restituisce, invece, e[moi d∆a[palon privn]
pot∆[e[]onta: questa congettura ha ottenuto un notevole successo tra gli studiosi
intervenuti nella discussione: il West dice "it is perfect" e l’accoglie anche Livrea (2007,
72). Per privn] pot∆[e[]onta il Di Benedetto invita al confronto con Ar. Vesp. 1063 sgg.
privn pot∆ h \n, pri;n tau'ta, nu'n / d∆ oi[cetai, kuvknou te poliwvterai dh; / ai{d∆
ejpanqou'sin trivce" "una volta era prima, prima, ma ora / è finita e queste chiome
fioriscono più bianche del cigno", Eur. Troad. 581 privn pot∆ hj~men "lo eravamo, un
tempo". a[palovn moi] degli editori è accolto, invece, da Austin (2007, 118-119), ma lo
258
Lobel 1925, 26 sgg.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
155
studioso fa precedere questa integrazione da ojrh't∆ “voyez” e per quest’ultima parola
propone di confrontare Alcm. Fr. 1.50 PMGF h\ oujc oJrh'i" “forse non vedi?”; Ar.
Thesm. 1029 oJra'i".
La sequenza crova gh'ra" h[dh ritorna anche nel fr. 21.6: il contesto sembra ancora
quello del rimpianto della giovinezza ormai trascorsa, se ovviamente si accettano le
integrazioni dello Snell (21.6 moi kavrfei] crova gh'ra" h[dh "oramai la vecchiaia mi
dissecca la pelle"). Del contatto tra questi due frammenti si era già accorto lo Stiebitz
(1926, 1260).
4 Hunt (1922, 29), nell’editio princeps del papiro ossirinchita, proponeva di
integrare leu'kaiv t∆ejgevno]nto, supplemento accolto nella maggior parte delle edizioni
successive259
, con la sola eccezione di Lobel (1927, lxxxiii), che è stato il primo a
scrivere leu'kai d∆ ejg]evnonto, senza fornire, tuttavia, alcuna spiegazione260
: il te in
Saffo ed in Alceo serve, infatti, a porre sullo stesso piano sostantivi con funzione di
soggetto o di complemento, ma non intere proposizioni261
. Ed inoltre il modulo
paratattico del dev è usato, nella descrizione dei sintomi della vecchiaia, anche da Archil.
SLG 478b.2-3 e da Anacr. fr. 36 Gentili-Prato [= 50 Page] e, nell’ambito di questo stesso
frammento di Saffo, al v. 5 govna d∆ouj fevroisi “e le ginocchia non reggono”.
L’avversativa è ora accolta da tutti gli studiosi262
e, come ha ben visto Jerzy Danielewicz
(2006, 19), sembra confermata anche da Bacchyl. fr. 20A, 12 Sn.-M. leukai; d∆ejn
kefal[h'i.........t]rivce" ”e bianchi sulla testa…capelli”, che sembra riprendere questo
passo di Saffo. Di Benedetto integra diwvlese: leu'kai d∆ ejg]evnonto trivce" ejk
melaivnan, ma stavolta il West non lo segue, perché per lui il verbo diwvlese "seems too
strong a word", mentre gli sembra più corretto presumere un verbo con il significato di
"catturare, occupare", quale ejpevllabe. Per il Di Benedetto l'integrazione diwvlese
sembrava presuppore Od. XVIII 251 sgg. ―Eujruvmac∆, h \ toi ejmh;n ajreth;n ei\dov" te
devma" te / w[lesan ajqavnatoi, o{te [Ilion eijsanevbainon / jArgei'oi, meta; toi'si d∆
259
È accolta dai seguenti editori e studiosi: Voigt 1971, 77; Diehl1 1923, 358; Edmonds
21928, 434; Treu
1976, 58; Page 1955, 49 n. 4. 260
Lobel riporta direttamente il testo con l’avversativa, senza spiegarne il motivo: egli non cade in
contraddizione, perché sia nell’edizione precedente (Lobel 1925, 26-27), sia in quella curata a quattro
mani con Denys Page (Lobel-Page 1955, 41-42) l’integrazione di Hunt non solo non viene accolta, ma
neppure riportata nella sua interezza: scrive soltanto ejg]evnonto. 261
Così Di Benedetto 1985, 150. 262
L’accolgono West 1970, 326; Di Benedetto 2004a; 2004b, 5;Luppe 2004. 8; West 2005, 4-5;
Danielewicz 2006, 19-21 (21); Livrea 2007, 72; Burzacchini 2007, 98; Austin 2007, 118.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
156
ejmo;" povsi" h\ien jOdusseuv" "Eurimaco, certo il mio valore, la forma ed il corpo /
l'han distrutti gli immortali, quando per Ilio partivano / gli Argivi e con loro anche il
mio sposo andava, Odisseo". Recentemente263
Di Benedetto ha proposto, invece, di
integrare aijkivssato leu'kai d∆ ejg]evnonto. E Livrea (2007, 72), invece, integra
ejpevsceqe, leu'kai d∆ejgev]nonto, cioè “la mia pelle, che una volta era delicata,
l’opprime ormai la vecchiaia”.
Per l'immagine dei "capelli che da neri sono diventati bianchi" si cfr. Anacr. 395.1 PMG
sgg. polioi; me;n hJmi;n h[dh / krovtafoi kavrh te leukovn "ormai ho grige le tempie,
canuta la testa" e Soph. Ant. 1092 sgg. ejx o{tou leukh;n ejgw; / thvnd jejk melaivnh"
ajmfibavllomai trivca "dal momento in cui io da neri porto dei capelli bianchi".
5 Per l'espressione bavru" dev m' oj [q]u'mo" pepovhtai cfr. Theoc. I 96
baru;nqumo;ne[coisa. q[u']mo" è l'eolico per l'attico qumov" per baritonesi: il termine,
sostiene il Di Benedetto, è qui usato ad un livello di elementarità animalesca, per
indicare l'impulso intimo, lo slancio che induce il movimento.
pepovhtai: attico pepoivhtai. Il passaggio da -oih- / -oie- a -oh- / -oe-è un fenomeno
peculiare del dialetto eolico: cfr. al v. 7 poeivhn.
Per govna dVouj fevroisi si cfr. Alcm. 90.1 sgg. C. = 26.1 sgg. P. ou[ m∆ e[ti,
parsenikai;, meligavrue" iJarovfonoi / gui'a fevrhn duvnatai "Me non più, ragazze
parola di miele, sacre voci, le membra possono sorreggere". Il greco antico ha
mantenuto un arcaismo molto evidente, peraltro comune ad altre lingue i.e.: il neutro
plurale assume valore collettivo e pertanto quando funge da soggetto richiede la terza
persona singolare del verbo e non la terza plurale (un fenomeno che invece non è proprio
della lingua latina, almeno nella sua fase documentata). Qui il sostantivo neutro plurale
eolico govna (= att. govnata, om. gou'na) non può avere valore collettivo, proprio perché
funge da soggetto di un verbo coniugato alla terza persona plurale e non alla terza
singolare come ci aspetteremmo: govna non è collettivo, ma tende ad individuare "i
ginocchi" come costituiti da due entità diverse che compiono però la stessa azione.
Diverso è, invece, il caso del passo di Alcmane, dove gui'a "le membra" indica proprio
qualcosa di collettivo e funge da soggetto del sintagma verbale fevrhn duvnatai al
singolare. In rapporto al numero di frammenti di Saffo e di Alceo a noi traditi, il
263
Di Benedetto 2006, 18.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
157
fenomeno, ovvero l’accordo tra un neutro plurale ed un verbo alla terza persona plurale,
non è raro: si trova anche in Sapph. 96.12ss. teqav- / laisi de; brovda ka[pal∆ a[n- /
qruska “sono in fiore le rose ed i teneri cerfogli”; Alc. 383.2 V. ta[rmena lavmpra
kevont∆ejn Mursinhvwi; “le armi lucenti giacciono nel Mirsineo?”264
Quest’uso non deve
stupire: è opportuno ricordare che i grammatici antichi definivano sch'ma jAttikovn
l’accordo tra un neutro plurale ed un verbo alla terza persona singolare, il che pare
qualificare questa costruzione come una caratteristica specifica del dialetto attico265
. Ed
una conferma può venire anche dalle iscrizioni eoliche d’Asia, laddove esse (di)mostrino
un accordo tra un neutro plurale ed un verbo al plurale: così, ad esempio266
, IK 4, 3
[=ASS 03.1 Hodot] (IV sec.?) ta; skeuveav ejssi damovsia “le attrezzature sono
pubbliche”; IG XII Suppl., 142, l.73 [= I. Perg. 245; MYT 024, b 73 Hodot] [ta; de;
krivqenta uj]pavrxoisi kuvria kai; ajmetavqeta “le decisioni stabilite sono valide ed
immutabili”; EOL 07, 49-50 Hodot (III sec.) sunt]eleivhn de; a{ ke ujpo; tw'n a[drwn
k≥riqevwsi h] dialu≥[q]evw[si h] - -]sqevwsi “[si comp]iano le cose che siano state decise
dagli uomini o risol[te o…]te”.
6 Per govna...laivyhr∆ cfr. Il. XX 193b (= Il. XXII 104b) laiyhrav te gou'na, Il. X
358 (= Il. XXII 144) laiyhra; de; gouvnat∆.
e[on è un imperfetto IIIa persona plurale lesbio di eijmiv: è attestato anche in un’iscrizione
di Ege (DGEE 644) della prima metà del III sec267
. E cfr. anche Sapph. 63.7 o≥u≥j gavr
k∆e[on ou[tw "infatti non sarei così". E per l’uso di questa forma da parte di Alceo cfr.
Eustath. Ad Od. 14, 212, p.1759, 26 levgei de; (scil. JHrakleivdh") kai; crh'sin ei\nai
tou' e[on para; jAlkaivwi.
nebrivoisi è l'eolico per nevbroi", ma è anche un vezzeggiativo molto legato all'ambiente
familiare (Di Benedetto traduce "cerbiattini"). In greco abbiamo due desinenze per il
dativo plurale, ovvero -oi" e oisi: la prima è quella originaria dello strumentale i.e.
(sscr.-ais, lat.-īs), mentre la seconda è quella di un antico locativo (cfr. sscr.-aišu). Delle
due desinenze, la seconda si ritrova nel dialetto ionico (salvo l'Eubea), in quello lesbio
264
Queste due occorrenze sono addotte dalla Voigt (Hamm 1958, 162). 265
Cfr. Bettarini 2005, 34 (n. 11); Schwyzer 1939-1950, II, 607; Humbert Synt., 74s. Un errore evidente è
presente in Bettarini (2005, 34 n. 11): il testo di Saffo ha govna e non gui'a: l’autore del contributo è stato
condotto in errore, a quanto sembra, dal suddetto parallelo di Alcmane. 266
Cfr. Hodot 1990, 166 (e n. 45). La classificazione toponomastica delle iscrizioni è quella di Hodot
(1990, 269ss.). 267
Cfr. Bettarini 2005, 34ss.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
158
ed in quello attico (in quest'ultimo è però attestata nelle iscrizioni fino al 450 a.C.,
mentre poi si è generalizzata la desinenza –oi"). Negli altri dialetti (dorico, beotico,
arcadico-cipriota e quello ionico dell'isola Eubea) abbiamo solo -oi". Il caso del dialetto
dell'isola di Lesbo è particolare: si è generalizzata la desinenza -oisi (fenomeno
spegabile con il pericolo di commistione e confusione di due desinenze, ovvero quella
del dativo -oi" e quella dell'accusativo –oi"< -*on"<*-om-s, di contro all'attico -ou",
per cui si cfr. il lat. lupōs< *lupom-s), mentre l'articolo è toi'".
7 Gli editori del Papiro di Colonia restituiscono ãtau'Ãta, altrimenti il verso
difetterebbe di una sillaba. Il West integra, invece, ta; ãme;nÃ. Possibili anche tavãdeà e
ãza;Ã ta; proposti da Burzacchini (2006, 98). Gronewald e Daniel leggono stenacivzw e
così riporta anche il papiro, ma è preferibile, restituire la forma del tutto eolica
stenacivsdw.
Per l'espressione stenacivsdw qamevw", cfr. Il. XXIII 225 (= Od. XXIV 317) aJdina;
stenacivzwn "piangendo fortemente". ajlla; tiv ken poeivhn… è un'espressione poetica,
ma ha un qualcosa di colloquiale: sarebbe, per il Di Benedetto, una formula ripresa da
Omero, cfr. Il. XIX 90 a ajlla; tiv ken rJevxaimi… "Ma che avrei potuto fare?".
La novità più importante di questo componimento è l'affermazione che Saffo, a causa
delle invalidità procuratele dalla vecchiaia, piange: è un punto di vista nettamente
opposto rispetto agli ultimi versi del fr. 95 V.268
, in cui la morte viene sublimata
attraverso immagini gratificanti e viene preferita ad uno stato esistenziale turbato e pieno
d'angosce (e[pt≥[akon oujdavmw"269 et a[ga[n a[saisin suppl. Di Benedetto):
eij~pon: wj~ devspot∆, e[pt≥[akon oujdavmw" o]uj ma; ga;r mavkairan≥ [
o]ujde;n a[dom∆ e[parq∆ a[ga[n a[saisin katqavnhn d ji[merov" ti" [e[cei me kaiv
lwtivnoi" drosoventa" [o[- c[q]oi" i[dhn jAcer[
io dissi: "o signore, (non ho proprio paura).
No, per la dea…
Non mi piace affatto essere (troppo) agitata (dalle ansie).
Mi possiede il desiderio di morire e
di vedere le rugiadose rive dell'Acher(onte)
fiorite di loto…"
O anche rispetto al già citato fr. 150:
268
Cfr. Di Benedetto 2004a. 269
L'integrazione e[pt≥[akon oujdavmw" è stata proposta da Di Benedetto 1982, 18.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
159
ouj ga;r qevmi" ejn moisopovlwn ãdovmwià qrh'non e[mmen∆ ã.......à ou[ k∆ a[mmi prevpoi tavde Non è lecito che vi sia funebre canto
nella casa dei cultori delle Muse …questo a noi non converrebbe.
Nel fr. 94, invece, il desiderio di morte è da collegare alla tristezza di Saffo causata dalla
partenza di una ragazza del qivaso" cui la poetessa era particolarmente legata (se,
ovviamente, la frase iniziale deve essere attribuita a Saffo):
teqnavkhn d∆ajdovlw" qevlw: a[ me yisdomevna katelivmpanen povlla... sinceramente vorrei esser morta:
lei mi lasciava piangendo
molto…
Ma Saffo la consola e consola se stessa con il ricordo dei bei momenti passati insieme.
Nel Carme della vecchiaia, invece, non c'è niente di tutto questo: Saffo non piange per
l'approssimarsi della morte, ma per lo sfiorire del suo corpo (e questo è evidente nelle
stesse parole di Saffo).
8 Cfr. fr. 16.21-22 ouj duvnaton gevnesqai /…ajnqrwp[. E cfr. anche Bacchyl. III
88 sgg. ajndri; d∆ouj qevmi", polio;n p[ar]evnta / gh'ra", qavl[eia]n auj~ti" ajgkomivssai
/ h{ban "non è lecito per l'uomo evitare la canuta / vecchiaia e recuperare la florida /
giovinezza".
9 Che a partire da questo verso Saffo narrasse, per lo meno in parte, il mito di
Aurora / Eos e di Titono aveva intuito, molti decenni prima della pubblicazione del
PKöln 21351+21376, il Lobel (1925, 26), seguito dallo Stiebitz (1926, coll. 1261-2).
kai; gavr, quando segue un’affermazione di valore generale, una massima (in questo
caso, che se si è uomini non si può essere privi di vecchiaia), “served from the earliest
period of the Greek literature to introduce a precedent that was to prove the validity of
the maxim”, come afferma Fraenkel, Horace 185-186: cfr. Il. IX 502 kai; gavr te
Litaiv eijsi Dio;" kou'rai megavloio “ed infatti le preghiere sono figlie del grande
Zeus”; IX 533 kai; ga;r toi'si kako;n crusovqrono" [Artemi" w\rse “ed infatti
Artemide dall’aureo trono fece per loro sorgere un male”; XIX 95 kai; ga;r dhv nuv
pote Zeu;" a[sato “ed infatti una volta anche Zeus fu accecato”; XXIV 602 kai; gavr
t∆ hju?komo" Niovbh ejmnhvsato sivtou "ed infatti anche Niobe bella chioma si ricordò
di mangiare…"; Alc. 38a.5 kai; ga;r Sivsufo" Aijolivdai" basivleu" ktl. "anche Sisifo
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
160
Eolide il re…"; Pi. O. VII 27 kai; ga;r jAlkmhvna" kasivgnhton novqon “ed infatti il
fratello bastardo di Alcmena…”; P. I 10s. kai; ga;r bia- / ta;" [Arh" “infatti anche
Ares possente…”; N. I 67 kai; ga;r o{tan qeoi; ejn pedivwi Flev- / gra" “ed infatti
quando gli dei nella piana di Flegra…”270
. Direttamente connesso con la storia di Lesbo
del periodo è, invece, un parallelo segnalato da Fraenkel, Horace 186 e già citato in
quest’opera, si tratta di Carmina Popularia PMG 23.1-3: a[lei muvla a[lei: / kai; ga;r
Pittako;" a[lei / megavla" Mutilhvna" basileuvwn "macina, mola, macina: / e infatti
anche Pittaco macina / che regna sulla grande Mitilene". Allo stesso modo in latino è
utilizzato namque271
, per cui cfr. Hor. Carm. I 22ss. Integer uitae scelerisque purus / non
eget Mauris iaculis neque arcu / nec uenenatis grauida sagittis, / Fusce, pharetra, / siue
per Syrtis iter aestuosas / siue facturus per inhospitalem / Caucasum uel quae loca
fabulosus / lambit Hydaspes. / namque me silva lupus in Sabina, / dum meam canto
Lalagen et ultra / terminum curis uagor expeditis, / fugit inermem, / quale portentum
neque militaris / Daunias latis alit aesculetis / nec Iubae tellus generat, leonum / arida
nutrix “l’integro di vita ed il puro / non ha bisogno dei mauri giavellotti né dell’arco /
né, Fusco, della faretra di frecce avvelenate / ricolma / sia che per le Sirti roventi un
viaggio / farà, sia per l’inospitale / Caucaso o quei luoghi / che lambisce il favoloso
Idaspe. / Ed infatti un lupo, mentre in un bosco sabino / io canto la mia Lalage ed oltre /
il confine io vago con lievi affanni, / mi ha messo in fuga, / un mostro quale non nutre la
bellicosa / Dania nei vasti farneti / né genera la terra di Giuba, di leoni / madre riarsa”;
Prop. IV 7.1ss. Sunt aliquid Manes: letum non omnia finit, / luridaque euictos effugit
umbra rogos. / Cynthia namque meo uisast incumbere fulcro, / murmur ad extremae
nuper humata uiae “I Mani esistono: la morte non pone fine a tutto / e la pallida ombra
rifugge i vinti roghi. / Ed infatti Cinzia, da poco sepolta al mormorio del margine della
strada, / mi apparve mentre si gettava sul letto…”; [Sen.] Oct. 9 grauior namque his
fortuna tua est “ed infatti la tua sorte è più dura della loro”.
e[fanto...eijsavmbamen∆...fevroisa[n è la tipica frase oggettiva che serve ad introdurre
narrazioni mitologiche, per cui cfr. fr. 166 fai'si dhv pota Lhvdan ujakivnqinon / ã...Ã
w[i>on eu[rhn pepukavdmenon "dicono che un giorno Leda trovò un uovo color del
giacinto, nascosto…"; fr. 54 ( [Erwta) e[lqont∆ejx ojravnw porfurivan perqevmenon
270
Cfr. Edmunds 2006, 24. Lo studioso cita anche Hes. Op. 803 e Theog. 306, ma questi ultimi sembrano
paralleli meno significativi: del resto, essi non sono citati nemmeno da Fraenkel, Horace 185-6. 271
Cfr. Fraenkel, Horace 184-185; Nisbet-Hubbard 1970, 268.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
161
clavmun "(Eros) che venne dal cielo indossando clamide purpurea"; fr. b, 5-6 (per cui
v. supra) [= 58.5-6 V.] f]uvgoisa[n / ejcivda"...o[dont]i≥ davcqhn "essendo fuggita / fu
morsa…dal dente di una vipera" (suppl. Di Benedetto). E cfr. anche Alc. 360 wj" ga;r
dhv pot∆ jAristovda- / mon fai's∆ oujk ajpavlamnon ejn Spavrtai lovgon / ei[phn,
crhvmat∆ a[nhr, pevni- / cro" d∆ oujd∆eij~" pevlet∆ e[slo" oujde; tivmio" "giacchè
Aristodemo un giorno a Sparta – dicono– non malvagio discorso pronunciò, «denaro è
l'uomo», non si trova nemmeno un povero onesto ed onorato". Per il Di Benedetto i
precedenti di e[fanto sono da ricercare in quei commenti anonimi presenti nei poemi
omerici in riferimento ad un evento o ad una situazione allora percepiti: brevi discorsi
introdotti dall'espressione formulare w|de dev ti" ei[peske(n), attestata 20x in Omero e
per cui cfr. e. g. Od. II 324 sgg: w|de dev ti" ei[peske nevwn uJperhnoreovntwn: / h\
mavla Thlevmaco" fovnon h{min mermhrivzei ktl. "Così andava dicendo qualcuno dei
giovani tracotanti: / certamente Telemaco medita per noi la morte". I verbi fhmiv e levgw
sono spesso utilizzati per introdurre simili narrazioni mitiche, ma sempre, negli altri casi,
il verbo è coniugato al presente272
: cfr. e. g. Il. XIX 95-96 kai; ga;r dhv nuv pote Zeu;"
a[sato, tovn per a[riston / ajndrw'n hjde; qew'n fas∆e[mmenai “infatti una volta anche
Zeus fu accecato, colui che più grande / degli uomini e degli dei dicono essere”.
brodovpacun è l'eolico per l'attico rJodovphcun: nel dialetto eolico il suono labiale che
precede un r- rimane: la grafia br- indicherebbe proprio una pronuncia ur-. Negli altri
dialetti, soprattutto del gruppo ionico-attico, la semivocale labiale si assimila alla
liquida, per cui abbiamo Ûr- > rr- > rJ-. Così si spiegano parole micenee come wi-ri-no
(att. rJi –nov") e wi-ri-za (att. rJivza).
Per l'uso dell'epiteto rJodovphcu" riferito ad Aurora si cfr. [Hom.] Hymn. XXXI 6
jHw...rJodovphcun"Aurora braccia di rosa" e Theoc. II 148 jAw'... rJodovpacun "Aurora
braccia di rosa". Questo epiteto richiama il più famoso rJododavktulo" "dita di rosa"
riferito ad Aurora, per cui si cfr. e. g. Il. I 477 (al.) h\mo" d∆ hjrigevneia favnh
rJododavktulo" jHwv" "Ma quando comparve Aurora dita di rosa che presto nasce", un
verso che costituisce una formula molto famosa, attestata complessivamente 22x in
Omero. Sono noti per Saffo due termini per indicare l'aurora, au[w" e au[a: il primo
272
Così Edmunds 2006, 23ss..E cfr. anche Il. XIII 631; XXIV 615; Od. VII 323; Ibyc. Fr. 303.3 PMG,
PMGF; Alc. Fr. 42.1 V.; 339 V.; 343 V.; Sapph. 166V.; Stes. Fr. 192.1 P.; Thgn. 1287; Pi. P. II 52; II 21;
VI 21; O. II 28; IX 49; N. VII 84; Pae. Fr. 52m.9 Sn.-M.; Dith. Fr. 70a.15 Sn.-M.; Bacchyl. V 57 Sn.-M.;
XXA.14 Sn.-M.; Scol. Att. 894,.1 P.; e.g. Aeschl. Suppl. 291.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
162
presuppone la radice aus- con suffisso tematico, cioè aus-ōs (è la stessa radice del latino
aurōra <*aus-ōs-a); il secondo termine (citato da A.D. Adv. 183.23 S. [= fr. 175 V.])
sembra presupporre, invece, la radice senza suffisso, cioè aus-. Alla radice aus- con
suffisso tematico -ōs- risalgono l'antroponimo miceneo A-wo-i-jo, lesb. au[w", le voci
doriche ajÛwv" e a–jwv", ion. hjwv", att. e{w". 273
10 eijsavmbamen∆ cioè eijsambavmenai, ovvero un infinito (è un'oggettiva sorretta da
e[fanto) aoristo atematico di tipo arcaico eolico del verbo eijsanabaivnw "imbarcarsi,
salire": caratteristica dell'eolico è l'apocope delle proposizioni, anche in funzione di
preverbo. Non vi è però accordo tra il West, altri studiosi e gli editori del papiro: il
primo restituisce, infatti, un testo lacunoso, cioè e[rwi f..aqeisan bavmen, mentre la
lettura degli editori viene recepita e difesa dal Di Benedetto. Il West pensa che –eisan
sia la desinenza o di un aoristo passivo, oppure, più verosimilmente, di un participio di
un verbo: tenta di ricostruire e[rwi davmeisan, ma, come avverte lui stesso, tale sequenza
è ametrica. La soluzione immediata, per il West, sarebbe ipotizzare e[rwti davmeisan,
ma una tale forma di dativo non trova attestazione in Saffo (è comunque attestato il
genitivo e[rwto" in Sapph. 23.1) ed inoltre, come conferma lo stesso West, sul papiro è
chiaramente visibile e[rwi. Quindi, non essendo risuscito a trovare il verbo giusto per
quell'ipotetico participio, West dice di aver letto e[rwi f..aqeisan bavmen∆ e così
restituisce il testo con una lacuna e giunge quasi a contradirsi nel corso dello stesso
articolo. Per il Di Benedetto, proprio il fatto che il West non sia riuscito a trovare il
participio giusto, non può che significare che quel participio non esiste. Inoltre se
guardiamo l'ingrandimento della fotografia, presente in «ZPE» 149 (2004), p. 1, risulta
chiara non solo la presenza di e[rwi, ma anche quella di un delta posto dopo ("Das
folgende Wort beginnt wahrscheinlich mit D", affermano Gronewald e Daniel274
). Il Di
Benedetto sostiene che non vi sia un "gap" tra l' eijsambavmen(ai) usato da Saffo e
l'ejskatabaivne usato da Stesicoro per indicare la stessa azione del salire sul devpa", ma
che, anzi, Saffo abbia fatto uso di questo verbo proprio per richiamare il passo di
Stesicoro (PMGF 185 = S17);
aj~mo" d∆ jUperionivda ãi["Ã devpa" ejskatevbainen cruvseon o[-
fra di∆ jWkeanoi'o peravsai"
273
Cfr. Di Benedetto 1983, 149-150. 274
Gronewald – Daniel 2004b, 3.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
163
ajfivkoiq∆ iJara'" poti; bevnqea nu- kto;" ejremna'"
poti; matevra kouridivan t ja[locon paivda" te fivlou",
oJ d∆ ej" a[lso" e[ba davfnaisi kata-
skioven posi; pai'" Dio;" [ ]
Quando il gagliardo figlio di Iperione
salì sull'aurea coppa
affinché, attraversando l'Oceano,
giungesse negli abissi della sacra notte cupa
presso la madre, la legittima sposa ed i cari figli,
egli verso il boschetto ombreggiato di allori
si avviò a piedi il figlio di Zeus…
in più, il verbo usato da Saffo è presente anche in Mimnermo (fr. 5 Gentili-Prato = fr.12
West) per indicare Aurora, o meglio Eos, che sale al cielo.
JHevlio" me;n ga;r e[lacen povnon h[mata pavnta ouj dev kot j a[mpausi" givnetai oujdemiva i{ppoisivn te kai; aujtw'i, ejph;n rJododavktulo" jHwv" jWkeano;n prolipou's joujrano;n eijsanabh'i: to;n me;n ga;r dia; ku'ma fevrei poluhvrato" eujnhv koivlh jHfaivstou cersivn ejlhlamevnh crusevou timhvento", uJpovptero" a[kron ejf ju{dwr eu{donq∆ aJrpalevw" cwvrou aJf∆ JEsperivdwn gai'an ej" Aijqiovpwn, i{na dh; qoo;n a{rma kai; i{ppoi eJsta's∆, o[fr∆ jHw;" hjrigevneia movlhi. e[nq ejpebhvseq j eJw'n ojcevwn uJperivono" uiJov".
Il Sole, infatti, ebbe in sorte la fatica tutti i giorni,
e non vi è mai riposo alcuno,
per i cavalli e per lui, dopo che Aurora dalle rosee dita,
lasciato l'Oceano, va su nel cielo.
Il concavo letto, molto desiderato, lavorato dalle mani
d'Efesto, d'oro prezioso, alato, in fretta sull'onde lo trasporta,
mentre dorme, dalla regione delle Esperidi alla
terra degli Etiopi, dove il veloce carro e i cavalli
ristanno, finché giunga Aurora che presto nasce.
Qui monta sul suo carro il figlio d'Iperione.
Nel complesso, l’argomento linguistico del West, ripreso anche da Magnani (2005, 46),
contro la ricostruzione offerta dagli editori e dal Di Benedetto non sembra molto
convincente e, comunque, non è certo definitivo.
Critiche sono state espresse anche a riguardo del devpa". Del devpa" del Sole parla anche
un frammento di Antimaco di Colofone tradito da Ateneo (Antim. 66 Wyss apud Athen.
XI 469e), ã Ã tovte dh; crusevwi ejn devpai> / jHevlion povmpeuen ajgaklumevnh
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
164
jEruvqeia "allora Eritea molto famosa portò in giro Helios nell'aurea coppa", uno della
Titanomachia (Titan. 8 PEG = Athen. XI 470b) Qeovluto" d∆ ejn deutevrwi JWrw'n ejpi;
levbhtov" fhsin aujto;n (sc. to;n {Hlion) diapleu'sai, tou'to prwvtou eijpovnto" tou'
th;n Titanomacivan poihvsanto" "Teolito, nel secondo libro delle Ore dice che Helios
ha compiuto la traversata su una vasca, dopo che per primo disse questo colui che
compose la Titanomachia" ed uno dell'Eraclea di Pisandro (Pisand. 5 PEG = Athen. XI
469c) Peivsandro" ejn deutevrwi JHrakleiva" to; devpa", ejn wj~i dievpleusen oJ
JHraklh'" to;n jWkeanovn, eijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj~nai mevn fhsin JHlivou, labei'n d∆aujtov par∆ jWkeanou'
ãto;nà JHrakleva "Pisandro, nel secondo libro dell'Eraclea dice che la coppa, nella quale
Eracle attraversò l'Oceano, è di Helios, ma Eracle la prese dall'Oceano". Del devpa"
del Sole parlava anche Eschilo nelle Eliadi (fr. 69 R.) e negli Eraclidi (fr. 74 R.).
E tuttavia la proposta degli editori ha suscitato altre critiche, non solo quelle di West.
L’argomento più forte contro il testo degli editori è, riteniamo, il fatto che la coppa del
Sole non è mai attestata se non in connessione con il viaggio notturno del Sole da
occidente ad oriente e per Eracle275
. Aurora, piuttosto, è sempre rappresentata mentre
guida un carro e West fornisce dei passi che possono ben giustificare la sua opinione:
Eur. Tro. 847ss. to; ta'" de; leukoptevrou / fivlion JAmevra" brotoi'" / fevggo"
ojloo;n ei\de gai'an, ei\de Pergavmwn o[leqron, / teknopoio;n e[cousa ta'sde / ga'"
povsin ejn qalavmoi", / o}n ajstevrwn tevqrippo" e[la- / be cruvseo" o[co"
ajnarpavsa", / ejlpivda ga'i patrivai megavlan “la luce distruttrice di Aurora dall’ali
bianche, cara ai mortali, rimirò la terra, osservò la rovina della stirpe di Troia, pur
avendo nel talamo, genitore dei figli, un uomo, di questa terra, che, dopo averlo rapito
lo prese l’areo cocchio dai quattro cavalli degli astri, speranza grande per la terra
patria”; Stat. Silv. I 2.44s. nec si alma per auras / te potius pensa ueheret Tithonia biga
“né se l’alma Titonia per il cielo / traesse te, piuttosto, sull’equilibrata biga”; Nonn. D.
XV 279sg. Tiqwno;" rJodovei" pevle boukovlo", o}n dia; kavllo" / divfron eJo;n
sthvsasa faesfovro" h{rpase jHwv" “il roseo Titono, che era mandriano, colui che
per la sua bellezza / Aurora che porta la luce, fermato il carro, rapì”. Per Magnani
(2005, 46) la presenza del devpa" crea non poche difficoltà perché l’elemento mitico
sarebbe reimpiegato ex abrupto, senza il suo epiteto cruvseon e, soprattutto, non
riferendolo all’Iperionide, ma all’Aurora. Magnani anticipa le argomentazioni di West e,
275
Così West 2005, 4.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
165
basandosi sul passo di Nonno, propone di leggere e di integrare, piuttosto, d≥i≥v[fr]o≥n≥,
accolto positivamente anche dalla Nicolosi (2005, 92). Le stesse critiche sollevate da
West e da Magnani (e, indirettamente, anche dalla Nicolosi) vengono riproposte anche
da Livrea (2007, 75) che, dopo aver scartato l≥e≥v[c]o≥", propone di integrare d≥e≥v[m]a≥", da
intendere o come oggetto di fevroisan o come accusativo di relazione con [k]a≥vl≥o≥n kaiv
nevon276, ma la proposta di Livrea appare, tra quelle finora esaminate, la meno
convincente: se lo intendiamo come lui propone, eijsavmbamen∆ rimarrebbe del tutto privo
di un referente spaziale ed inoltre d≥e≥v[m]a≥" risulterebbe, riteniamo, troppo distante sia da
fevroisan (quattro parole nel mezzo), sia, a maggior ragione, da [k]a≥vl≥o≥n kaiv nevon (ben
sei parole nel mezzo, cambio di strofe con tanto di paravgrafo"), sicchè la sintassi ne
risulterebbe troppo innaturale: d≥e≥v[m]a≥" eijsavmbamen∆ finirebbe per essere considerato
un’unica iunctura, con comici effetti finali. d≥e≥v[m]a≥", dunque, non appare la soluzione
migliore.
Ben più acuta è l’osservazione di Austin (2007, 117): egli, infatti, sembra aver
dimostrato che la terza lettera della parola non può essere un p: alla prima lettera, che gli
editori leggevano come un d≥, segue uno spazio privo di alcuna lettera (non si tratta di
uno spatium vacuum: una lettera all’origine doveva esserci e difatti si nota una certa
ombreggiatura diffusa, segno evidente di inchiostro) e poi la lacuna del papiro, ma sopra
quest’ultima, si nota, effettivamente, l’estremità superiore di un tratto verticale. Austin
ipotizza che sia la traccia di un m e propone di leggere [Erwi a[≥r≥m≥∆ãajnÃavqeisan bavmen∆:
“l’Aurore aux bras de rose confia son char à Éros et s’en alla aux extrémités de la terre
en emmenant Tithonos”.
Da ultimo Ferrari (2007a, 180), nel suo recente saggio, ha proposto di integrare
d≥i≥e≥[l]av≥q≥e≥isan (l. zelavqeisan), intendendo “trafitta dalla passione” e citando Archil.
Fr. 193.2s. caleph'isi qew'n ojduvnhisi e{khti / peparmevno" di∆ojstevwn “dai duri
dolori per volere degli dei / trafitto nelle ossa”, un frammento che delinea una
descrizione della passione amorosa, ma la sua proposta non sembra molto felice: il verbo
dielauvnw nel significato di “trafiggere, essere trafitto” sembra avere attestazioni
276
Livrea (2007, 75) riporta dei paralleli per devma" accusativo di relazione, ma in tutti questi casi, non a
caso, la parola integrata da Livrea è posta accanto a ciò a cui si riferisce, cfr. Od. XIII 222 ajndri; devma" eijkui'a nevwi “simile nel corpo ad un giovane”; Od. XVII 307 kalo;" me;n devma" ejstivn “è bello di
corpo”; [Hom.] Hymn. Ven. 241 toiou'to" ejw;n ei\do" te devma" te “essendo qual sei nell’aspetto e nel
corpo”. Nel testo di Livrea, invece, c’è troppa distanza tra i vari componenti dell’espressione e la sintassi,
risulta, di conseguenza, innaturale.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
166
piuttosto tarde e mai in poesia: Plut. Marc. 29.15 Mavrkellon dev ti" lovgchi plateivai
dia; tw'n pleurw'n dihvlasen “qualcuno trafisse ai fianchi Marcello con una spada
larga”; Plut. Pomp. 35.4 Pomphvio" d∆ejkei'non ejk ceiro;" dielavsa" ajnei'len
“Pompeo lo uccise, dopo averlo trafitto di sua mano”; Luc. D.M. 27.4 dielauvnetai de;
kai; oJ jArsavkh" ejk tou' boubw'no" diampa;x a[cri uJpo; th;n pughvn “ed anche
Arsace viene trafitto da parte a parte dall’inguine fino alle natiche”. E si riscontra
anche un’altra difficoltà: tutti questi passi, oltre ad essere molto più tardi ed in prosa,
presentano il verbo nel significato concreto e non, come occorrerebbe, astratto. Anche
d≥i≥e≥[l]av≥q≥e≥isan, dunque, fa difficoltà.
Prendere una decisione è difficile, perché tutte le proposte hanno, oltre ad un pro, anche
un contro da non sottovalutare: nessuna proposta sembra veramente convincente.
Abbiamo deciso, quindi, di mantenere dev≥p≥a≥"≥ proposto dagli editori, anche se fa
difficoltà.
Per l'espressione e l'idea di e[scata ga'" cfr. e. g. Il. IX 284 ejpi; peivrasi gaivh" "ai
confini della terra"; [Hom.] Hymn. Ven. 227b (un precedente significativo, poiché è
posto proprio nella lunga narrazione su Eos e Titono, per cui v. infra) ejpi; peivrasi
gaivh""ai confini della terra"; Hes. Theog. 731b pelwvrh" e[scata gaivh" "gli estremi
della terra smisurata".
11 Gli editori integrano [k]avlon e non a[[[p]alon, per due motivi: p di solito "sehr
breit geschrieben ist" ed inoltre kavlo" è usato da Saffo al maschile (cfr e. g. Sapph. 50.1
V. oj me;n ga;r kavlo" o[sson i[dhn pevletai ãkavlo"Ã / oj de; ka[gaqo" au[tika kai;
kavlo" e[sãseÃtai "colui che è bello è bello solo per il tempo che lo si guarda, / ma colui
che è virtuoso subito sarà anche bello"), "während sie a[palo" nur von weiblichen
Personen gebraucht in Sapph. DV ibV a = 82a V. ta;" ajpavla" Gurivnnw" "della
delicata Girinno"); fr. 122 pai'd∆ a[gan ajpavlan ("una fanciulla molto delicata"); fr.
126 ajpavla" ejtaãivÃra" ("di una tenera compagna") ". ajllV au[ton è un'integrazione,
verificatasi giusta, del Di Benedetto che precede di venti anni277
la lezione del Papiro di
Colonia.
277
Di Benedetto 1985, 145-63.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
167
u[mw" è la forma eolica corrispondente all'attico oJmw'", per baritonesi, yivlwsi" ed
oscuramento vocalico. Per ajll∆ au[ton u[mw" e[marye cfr. Od. XXIV 390 ejpei; kata;
gh'ra" e[maryen "da che l'aveva raggiunto la vecchiezza".
12 Per l'uso di crovnwi in poesia cfr. e. g. Xenoph. 18 [= DK 21 B 18] ou[toi ajp∆
ajrch'" pavnta qeoi; qnhtoi's∆ uJpevdeixan / ajlla; crovnwi zhtou'nte" ejfeurivskousin
a[meinon "no, non fin dal principio gli dei hanno mostrato tutte le cose ai mortali / ma
col tempo, ricercando, trovano ciò che è meglio"; Aeschl. Ag. 126 (lyr.) crovnwi me;n
ajgrei' Priavmou povlin a{de kevleuqo" "col tempo questa spedizione si impadronisce
della città di Priamo". E per il suo uso nella prosa cfr. e. g. Hdt. I 80 crovnwi de;
pesovntwn ajmfotevrwn pollw'n ejtravponto oiJ Ludoiv "ma, alla fine, dopo che molti di
entrambi gli eserciti furono caduti, i Lidi si volsero in fuga" .
Per povlion gh'ra" cfr. Pi. Isthm. VI 15 gh'ra"...polio;n; Bacchyl. Ep. III 88sgg.
polio;n...gh'ra"; Eur. Suppl. 170 gh'ra"...polio;n; Eur. Ion. 700 polio;n...gh'ra"; Eur. Ba.
258 gh'ra"polio;n.
Eos / Aurora è la personificazione dell’aurora ed appartiene alla prima generazione
divina, quella dei Titani: è figlia di Iperione e di Teia e sorella di Helios (il Sole) e di
Selene (la Luna): a causa della sua unione con Ares era stata condannata ad una lunga
serie di amori, tra cui si annoveravano quelli con il gigante Orione, figlio di Poseidone,
che ella rapì e portò a Delo; Cefalo, il figlio di Deione e di Diomeda che rapì e portò in
Siria e qui gli diede un figlio, Fetonte. L’ultimo amore fu quello con Titono, figlio di Ilo
e di Placia (o di Leucippe), della stirpe troiana: lo portò in Etiopia e lì gli diede due figli,
Memnone ed Emazione: Memnone regnò sugli Etiopi e morì davanti a Troia
combattendo contro Achille.
Nei poemi di Omero e di Esiodo si allude soltanto alla vicenda: Il. XI 1 (= Od. V 1) jHw;"
d∆ ejk lecevwn par∆ ajgauou' Tiqwnoi'o "Aurora dal letto, lasciando Titono glorioso",
Hes. Theog. 984-985 Tiqwnw'i d∆ jHw;" tevke Mevmnona calkokorusthvn, / Aijqiovpwn
basilh'a, kai; jHmaqivwna a[nakta "A Titono Aurora partorì Memnone elmo di bronzo,
re degli Etiopi, ed il sire Emazione". La narrazione più estesa la dobbiamo all'autore
dell'Inno ad Afrodite ([Hom.] Hymn. Ven. 218-238):
w}" d∆ au\ Tiqwno;n crusovqrono" h{rpasen jHw;" uJmetevrh" geneh'" ejpieivkelon ajqanavtoisi. bh' d∆ i[men aijthvsousa kelainefeva Kronivwna ajqavnatovn t∆ ei\nai kai; zwvein h[mata pavnta: th'i de; Zeu;" ejpevneuse kai; ejkrhvhnen ejevldwr.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
168
nhpivh, oujd∆ ejnovhse meta; fresi; povtnia jHw;" h{bhn aijth'sai, xu'saiv t∆ a[po gh'ra" ojloiovn. to;n d∆ h \ toi ei{w" me;n e[cen poluhvrato" h{bh, jHoi' terpovmeno" crusoqrovnwi hjrigeneivhi nai'e par∆ jWkeanoi'o rJoh'i" ejpi; peivrasi gaivh": aujta;r ejpei; prw'tai poliai; katevcunto e[qeirai kalh'" ejk kefalh'" eujhgenevo" te geneivou, tou' d∆ h \ toi eujnh'" me;n ajpeivceto povtnia jHwv", aujto;n d∆ au\t∆ ajtivtallen ejni; megavroisin e[cousa, sivtwi t∆ ajmbrosivhi te kai; ei{mata kala; didou'sa. ajll∆ o{te dh; pavmpan stugero;n kata; gh'ra" e[peigen oujdev ti kinh'sai melevwn duvnat∆ oujd∆ ajnaei'rai, h{de dev oiJ kata; qumo;n ajrivsth faivneto boulhv: ejn qalavmwi katevqhke, quvra" d∆ ejpevqhke faeinav". tou' d∆ h \ toi fwnh; rJevei a[speto", oujdev ti ki'ku" e[sq'∆ oi{h pavro" e[sken ejni; gnamptoi'si mevlessin.
Così a sua volta Aurora trono d'oro rapì Titono,
della vostra stirpe, simile agli immortali.
Andò dal Cronide nere nubi chiedendogli
che fosse immortale e vivesse tutti i giorni.
Zeus a lei acconsentì con un cenno e realizzò il desiderio.
Ingenua, non pensò nella mente, la venerabile Aurora,
di chiedere la giovinezza e far scomparire la rovinosa vecchiaia.
Finchè lo protesse la molto amabile giovinezza,
godendosi Aurora trono d'oro che presto nasce
viveva presso la corrente d'Oceano, ai confini della terra.
Ma quando i primi bianchi crini scesero giù
dalla bella testa e dal nobile mento,
la venerabile Aurora si allontanò dal letto,
ma, mantenendolo in casa, lo nutrì
con cibo divino, dandogli belle vesti.
Ma quando l'odiosa vecchiaia afflisse completamente Titono,
non poteva muovere o alzare le membra,
questa in cuor suo le apparve la decisione migliore:
lo mise in una stanza e pose delle fulgide porte.
Da lui certo la voce scorre infinita, il vigore non è
come quello che prima aveva nelle agili membra.
E cfr. anche Mimn. fr. 4.5 West (= 1.1-2 PETFr Gentili-Prato; suppl. Gesner):
Tiqwnw'i me;n e[dwken e[cein kako;n a[fqiton ãoJ Zeuv"Ã
gh'ra" o} kai; qanavtou rJivgion ajrgalevou
un male infinito donò Zeus a Titono
la vecchiaia, più agghiacciate della terribile morte
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
169
Anche in questo componimento di Mimnermo il paradigma mitico di Titono sembra sia
atto ad enfatizzare, nei versi successivi (1.3-7 PETFr Gentili-Prato = 4.8 W.2), i malanni
della vecchiaia:
ajll∆ ojligocrovnion gi vnetai w{sper o[nar h{bh timhvessa: to; d∆ajrgalevon kai; a[morfon gh'ra" uJpe;r kefalh'" aujtivc∆ uJperkrevmatai, ejcqro;n oJmw'" kai; a[timon, o{ t∆ a[gnwston tiqei' a[ndra, blavptei d∆ojfqalmou;" kai; novon ajmficuqevn Ma come un sogno breve è
la preziosa giovinezza: subito la terribile e deforme
vecchiaia incombe sulla testa,
parimenti nemica e spregevole, che rende l'uomo irriconoscibile,
danneggia gli occhi e la mente, avviluppandoli.
Già gli antichi ipotizzavano che questi due frammenti facessero parte di un unico
componimento e Stobeo, che li cita e ce li ha traditi, li attribuisce entrambi alla Nannò.
Secondo alcune versioni il mito si concludeva con Titono trasformato in cicala, cfr.
Hellan. 4 fr. 140 FGrHist Tiqwnou' tou' Laomevdonto", Priavmou de; ajdelfou', hjravsqh
hJ JHmevra, ejx ou|per ejpoivhsen uiJo;n Mevmnona. makrw'i de; bivwi dapanhqevnto"
ejkeivnou metevbalen aujto;n eij" tevttiga hJ qeov". dio; dh; aujtou' tou;" suggenei'"
dhmogevronta" tevttixin eijkavzei oJ poihthv". iJstorei' JEllavniko". “L’Aurora era
amata da Titono, figlio di Laomedonte, fratello di Priamo: da costui dette alla luce il
figlio Memnone. E Titono, dopo che fu consumato per la lunga vita, la dea lo trasformò
in una cicala. Perciò il poeta rende simili a cicale gli anziani suoi affini. Lo racconta
Ellanico”; Scholia in Lycophronem 18 <Tiqwno;n ejn koivthisi>: kata; to; muqiko;n
kai; th;n iJstorivan oJ Tiqwno;" ajdelfo;" h\n Priavmou ajmfimhvtrio": <Tiqwno;n>:
ajpo; JRoiou'" th'" Skamavndrou qugatrov" ejstin oJ Tiqwnov", oJ de; Privamo" ajpo;
Leukivpph". oJ me;n ga;r Privamo" h\n Leukivpph", oJ de; Tiqwno;" JRoiou'" h]
Strumou'" th'" Skamavndrou qugatro;" uiJov", ajmfovteroi de; patro;" Laomevdonto".
fasi; gou'n o{ti to;n Tiqwno;n tou'ton suvneunon e[scen hJ JHmevra, ejx ou| genna'i
Mevmnona kai; jHmaqivwna. ajqavnaton de; to;n Tiqwno;n poihvsasa ejpelavqeto
poih'sai kai; ajghvrw. ghravsanta de; tosou'ton wJ" ejn talavrwi kai; livknwi aujto;n
peristrefovmenon divkhn brefullivou kaqeuvdein eij" tevttiga metevbalen. ktl.
“<Titono nel letto>: Secondo il mito ed il racconto Titono era fratello di Priamo, ma di
madre diversa: <Titono>: nasce da Roio, la figlia di Scamandro, mentre Priamo da
Leucippe. Infatti Priamo era figlio di Leucippe, mentre Titono era figlio di Roio o di
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
170
Strimno, figlia di Scamandro. Entrambi erano figli del padre Laomedonte. Dicono,
dunque, che l’Aurora ebbe come compagno di letto Titono, dal quale genera Memnone
ed Emazione. Dopo aver reso immortale Titono, si dimenticò di renderlo anche indenne
da vecchiaia. E quando costui fu invecchiato lo trasformò in una cicala tanto grande
che dormiva in un paniere ed in un cesto rigirandosi come un frugoletto etc.”. Per Eos e
Titono cfr. anche Hes. fr. 353 M.-W.; Diod. Sic. II 22.1-5 movnh ga;r tevteucen
ajnagrafh'" hJ pemfqei'sa summaciva toi'" Trwsi;n uJp∆ jAssurivwn, h|" ejstrathvgei
Mevmnwn oJ Tiqwnou' “il solo fatto che ha trovato menzione è la spedizione di alleanza
mandata dagli Assiri ai Troiani, a capo della quale vi era Memnone, il figlio di Titono;
IV 75, 4ss. [Ilou de; genovmeno" uiJo;" Laomevdwn Tiqwno;n kai; Privamon ejgevnnhsen:
w|n Tiqwno;" me;n strateuvsa" eij" ta; pro;" e{w mevrh th'" jAsiva" kai; diateivna"
e{w" Aijqiopiva" ejmuqologhvqh ejx jHou'" teknw'sai Mevmnona to;n toi'" Trwsi;
bohqhvsanta kai; uJp∆ jAcillevw" ajnaireqevnta “Laomedonte, figlio nato da Ilo, generò
Titono e Priamo: di essi, Titono condotta una spedizione verso le regioni dell’Asia ad
oriente e spintosi fino in Etiopia, viene raccontato che con Eos procreò Memnone, il
quale accorse in aiuto ai Troiani e fu ucciso da Achille”; Ig. Fab. 270.2 Tit<h>onus
Laomedontis filius Aurorae coniunx “Titono, figlio di Laomedonte, sposo di Aurora”. E
cfr. anche Serv. Ad Verg. Georg. 1.447; 3.48.328; Ael. Nat. An. 5.1; Schol. in Il. XI 1-2.
Resta da affrontare un ultimo problema a riguardo di quest’ode, ovvero se il v. 12 possa
essere o meno l’ultimo. Per Di Benedetto (2004b, 6) il problema non si pone: il nuovo
Papiro di Colonia non presenta i quattro versi seguenti traditi dal papiro ossirinchita e
perciò il componimento doveva essere concluso con il v. 12. C’è forse un indizio,
riteniamo, per dimostrare che l’ode doveva terminare con il v. 12 ed esso è la formula
con cui inizia la narrazione mitologica a riguardo di Eos e di Titono: i versi precedenti,
infatti, si concludono con un’affermazione rassegnata (“ma che potrei farci? / Indenni
da vecchiaia non si può essere, giacchè si è uomini”) ed il gavr successivo si ricollega,
spiegandolo, a ciò che precede: Saffo ricorre alla narrazione mitologica (“ed infatti un
tempo dicevano…”) come ad una spiegazione, ma una volta conclusa la funzione di
quest’ultima, non vi è necessità di continuare: Saffo ha già detto al v. 8 che non si può
essere indenni da vecchiaia. Il mito di Eos e di Titono non è altro che un prolungamento
della stessa affermazione: è quasi, oseremmo dire, un’esegesi, una parabola.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
171
dV (58, 23-26 + 59 L.-P. = V.) metrum: hipp2cho
]i≥mevnan nomivsdei 2 ]ai" ojpavsdoi
õe[gw de; fivlhmmVajbrosuvnan,Õ[ ] tou'to kaiv moi 4 to; lavõmpron e[rw" ajelivw kai; to; kavÕlon levõlÕogce ejpin[ -22- ].[...]nov. [ 6 fivlei.[
kai; n[
…considera
2 ...(il Cronide) conceda
ma io amo la raffinatezza, [ ] questo e per me
4 l'amore per il sole ottenne in sorte splendore e bellezza.
Bev-…
6 amand-…
e…
TEST (I) POxy.1787 frr.1, 23-26 et 2, 1-4 [1 - 4] (II) Clearch. fr. 41 Wehrli = Ath. 15,
687b (cod. A) uJmei'" de; oi[esqe th;n aJbrothta cwri;" ajrhth'" e[cein ti
†truferovn†… kaivtoi Sapfw v...hjidevsqh to; kalo;n th'" aJbrovthto" ajfelei'n levgousa w|de: [3 - 4], fanero;n poiou'sa pa'sin wJ" hJ tou' zh'n ejpiqumi‰a to; lampro;n kaiv to; kalo;n eijj~cen aujth'i (prim. rec.Ursin., metrum cogn. F-G. 1806, 140)
prim. rec. Diehl.11923, 358 v. 1 novi carminis initium esse censuerunt
Di Benedetto 2004b, 6, Ferrari 2005, 26-27 ad v. 4 coronidem collocandam esse
censuerunt Di Benedetto 2006, 11 cum fr. DV dV 5-7 = 59 V. coniungendum
esse censuerunt West 2005, 2005, 7-9 (III) POxy.1787 fr. 2, 2-4 et
fr. 1, 26 [5-7] prim. rec. Diehl.1
1923,358
CRIT 1 pai'san de; cavran vel simm. in init. versus Snell ].mevnan (I):
fq]i≥mevnan Hunt : ]u≥mevnan Luppe: Krevtiston o] me;n...kekr]i≥mevnan West 2005, 9:
qavnoisan a[oidon to; pa;n oujdei;" fq]i≥mevnan Di Benedetto 2006, 5 sgg. : a[ban de; Favwno" qanavtwi pai'" fq]i≥mevnan nomivsdei Livrea 2007, 72-73 : e.g. a[riston oj me;n sumposivan kekr]i≥mevnan nomivsdei Austin 2007, 122║2 ]ai" ojpavsdoi (I):
Kroniv]ai" ojpavsdoi Di Benedetto 1985, 161 : o] d∆ eujporivan, ta;n qevo" a[mmaisi fivl]ais∆ West 2005, 9 : a[lloisi tuvchn o[ssa qevlwsi Kronivd]ai" Di Benedetto 2006,
5sgg. : ajghvraon, a]n mh; Kronivdai" parqenivk]ai" ojpavsdoi Livrea 2007, 73 :
kajleuqerivan, ta;n Mutilhnai Kronivd]ai" ojpavsdoi Austin 2007, 122-123║ 3 fivlhmmi (II) codd. AB : fivlhm∆ rell. ut videtur [e[xoca] vel [kai; diav] Diehl
1 1923, 358. :
[kevklute] Edmonds : [i[sqi de;] Perrotta 1935, 36 n. 1 : [oi[date] Gallavotti 1957, 122 :
[i[ste de;] Di Benedetto 1985, 154 : [au\tov ge] West 2005, 9 : [a\sdev me] Livrea 2007,
73 : [u[mmi de;] Ferrari 2007a, 73 tou'to(I): om. (II) ║4 tovla≥[-21-
]l≥onl≥e≥v[.]o≥gce (I): to; lampro;n †erosa eliw† kai; to; kalo;n levlogce (II)
†erosa eliw† (II): e[ro" ajelivw Canter : e[rw" ajelivw F–G. 1806, 140, Blass
1874, 151, rec. Voigt 1971, 78-79, Di Benedetto 1985, 154sgg., Ferrari 2005, 27sgg.,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
172
Livrea 2007, 72-73, Burzacchini 2007, 98, contra locutus est Hoffmann 1893, 153 et
contra cog. Pasquali apud Burzacchini 1991, 394: e[ro" twjelivw Sitzler 1898, 121: [Ero" twjelivw West 2005, 8sg., rec. Austin 2007, 124 lev ║5 ejpi –n[ :
e[pwn[e me;n [Alkao" a[i>n corr. et suppl. Austin 2007, 126 : fort. ejpivn[ete ga;r Ferrari
2007a, 73 rell. huius versus, a POxy. 1787 fr. 1, 26 tradita, om.
Ferrari 2007a, 73 ║6 fiv fivleis[a West 2005, 9 : fivlei [ Austin 2007, 126
: fort. fivleit≥[e Ferrari 2007a, 73 ║7 kain[ : kai; n[ Hunt 1922, 29 : kai; n[u'n West 2005, 9, rec. Austin 2007, 126
Questo frammento segue gV nel POxy. 1787 e fino a poco tempo fa lo si considerava
come costituente un unico componimento con i versi precedenti278
: il Papiro di Colonia,
invece, non riporta, dopo il frammento gV, questi quattro versi, che quindi
probabilmente costituivano un carme a se stante: questa è l'opinione di insigni studiosi,
tra cui il West, il Ferrari e lo stesso Di Benedetto279
. Altri, invece, come Livrea e
Burzacchini, ritengono che non ci si possa affidare al solo P.Köln 21351 per dirimere la
questione: essi, infatti, considerano tale testimone al pari di un'antologia280
che avrebbe
quindi potuto non riportare interi versi poiché non attinenti alla tematica su cui si basava
la selezione dei carmi. La discussione critica, tuttavia, ha avuto per oggetto non solo ciò
che precede il “tetrastico”, ma anche ciò che segue. Luppe (2004, 9) è giunto al punto di
negare che con ejpin[ di Sapph. DV dV 5 cominciasse un nuovo componimento, ha
dubitato fortemente del fatto che to; la[ del POxy. 1787 fr. 2, 1 riportasse veramente il
testo citato da Clearco in Ateneo (su questo cfr. infra) ed ha dubitato persino che la
citazione presente in Ateneo derivi effettivamente da un unico passo della poetessa
lesbia. Il West, muovendo in parte dai dubbi espressi dal Luppe, ritiene che questo
frammento ed il DV dV 5sgg. [= 59 V.] costituissero un unico componimento: il Di
Benedetto rifiuta questa ipotesi fornendo come esempio di un carme di soli quattro versi
Sapph. 55 V. Il Di Benedetto ed il West divergono anche sull'interpretazione del carme.
Austin (2007, 121ss.), sebbene non lo affermi direttamente, ritiene anche lui che la
coronide a Sapph. DV dV 5 = 59, 1 V. non vada integrata ed unisce ciò che segue la
coronide con il “tetrastico”. Ferrari (2007a, 73) ha recentemente riproposto la tesi del
278
Cfr. Perrotta 1935, 36; Marzullo 1994, 189. 279
Cfr. Di Benedetto 2004a,21; 2004b, 6; West 2005, 3-7; Luppe 2004, 8s.; Ferrari 2005, 26-27; 2007, 73;
Hardie 2005, 1 n. 3, 27-29; Austin 2007, 120ss. 280
Livrea (2007, 67) già nella prima pagina del suo contributo parla del papiro coloniense come se si
trattasse di una “raccolta antologica da assegnare alla prima età tolemaica”. Il grecista ipotizza che il
papiro coloniense fosse un’antologia dedicata al tema della vecchiaia, un Peri; ghvrw". Di “aggregazione
antologica”, di “raccolta antologica tematica di testi la cui scelta rispondeva, forse, a criteri contingenti”,
di “antologia di testi non esclusivamente saffici” parla anche Burzacchini (2006, 101, 102,103-104).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
173
West: come ha dimostrato Lundon (2006, 151-152) è tutt’altro che certa la presenza di
una coronide nel POxy. 1787 fr. 2 tra i versi 1 e 2281
, sicchè i tre versi che Lobel-Page
(1955, 42) e la Voigt (1971, 78-79) numeravano come Sapph. 59 possono essere
benissimo considerati come il prosieguo di ciò che precede e perciò dobbiamo ipotizzare
che il tutto costituisse un’ode unica. Della non presenza della coronide si era accorto
anche Di Benedetto (molti anni prima di Luppe, West, Lundon e Ferrari: Di Benedetto
1985, 152), ma per lui più che dell’assenza si dovrebbe parlare della non-presenza: il
tono conclusivo del verso precedente dovrebbe dimostrare, secondo lui, la necessità di
porre fine di componimento, anche senza la presenza della coronide. In effetti,
ricontrollando l’immagine del frustolo papiraceo, è possibile accorgersi che della
coronide non vi è alcuna traccia e perciò sembra metodologicamente improprio
considerare i vv. 5-7 come appartenenti ad un altro carme o, comunque, ad un altro
frammento.
1 Sul papiro si legge chiaramente la sequenza ].mevnannomisdei; Hunt identifica la
traccia presente sul margine del papiro come iota, mente W. Luppe come un hypsilon.
Hunt, l’editore principe, aveva integrato fq]i≥mevnan, accolto dal Di Benedetto, ma non
dal West.
Per il West questo componimento inizia con una Priamel, per cui cfr. i primi versi del fr.
16:
O]ij me;n ijpphvwn strovton, oij de; pevsdwn, oij de; navwn fai's jejp[i;] ga'n mevlai[n]an e[]mmenai kavlliston, e[gw de; kh'n jo[t-
tw ti" e[ratai
Alcuni dicono che sulla nera terra
la cosa più bella sia un esercito di cavalieri,
altri di fanti, altri di navi,
281
Lobel-Page (1955, 42) presentano nel testo paravgrafo" e coronide, ma quest’ultima è posta entro una
parentesi quadra piuttosto grande (cfr. West 2005, 3; Lundon 2007, 152 n. 17): i due grecisti inglesi
leggevano, quindi, sicuramente una paravgrafo" ed ipotizzavano che essa fosse accompagnata, sul
margine (perduto per noi e per loro), da una coronide, ma non potevano averne la certezza: avevano un
cinquanta per cento di possibilità. Lundon (2006, 152 n. 17) nota come in questo papiro le paravgrafoi accompagnate alle coronidi si prolungano “fino a toccare la lettera iniziale dell’ultimo verso del
componimento poetico da esse individuato”, mentre le numerose paravgrafoi prive di coronidi, atte ad
indicare il semplice cambio di strofe, sono sempre poste a metà strada tra i due righi. Da queste
osservazioni si dovrebbe concludere, dunque, che in quel passo di cui stiamo parlando la coronide forse
non era presente e che perciò non dovrebbe esserci l’inizio di una nuova ode, ma il semplice cambio di
strofe: una conclusione definitiva non è, tuttavia, possibile. Anche West (2005, 3) è arrivato alle medesime
conclusioni di Lundon, anche se in misura più drastica: per lui Lobel non aveva alcuna autorità per porre
la coronide e, quindi, essa va tolta.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
174
io, invece, quel che si ama…
Perciò il West individua una sequenza-tipo oij me;n..., oij de;..., e[gw de;..., ritenendo,
così, che l'ottativo ojpavsdoi appartenga ad una subordinata. Su questa base, il West
rende il primo verso come Krevtiston (oppure kavlliston) o] me;n (o mevn ti")
kekr]i≥mevnan nomivsdei, non accogliendo quindi la congettura di Hunt (fq]i≥mevnan).
L'ipotesi della Priamel è ritenuta "di per sé verosimile" dal Di Benedetto, ma viene da
lui rifiutata perché fa difficoltà l'ottativo del verso 2 (ojpavsdoi) e questo perché, sia il Di
Benedetto sia il West ritengono che il soggetto di questo verbo sia una divinità: Saffo
non poteva certo mettere in secondo piano un auspicio solenne, sostiene il Di Benedetto.
Scartata l'ipotesi della Priamel, Di Benedetto restituisce il v. 1 così: qavnoisan a[oidon
to; pa;n oujdei;" fq]i≥mevnan nomivsdei: "la cultrice del canto, quando è morta, nessuno
la considera del tutto estinta" e istituisce il raffronto con Eur. Alc. 995:
mhde; nekrw'n wJ" fqimevnwn cw'ma nomizevsqw non sia considerata come tumulo dei defunti morti
In ambedue i passi si tratta di una donna morta (la "cultrice delle Muse" ed Alcesti) e di
un permanere dopo la morte, in tutti e due casi c'è il verbo nomivzei alla fine del verso
preceduto dal participio del verbo fqivw, in entrambi i casi si tratta del primo verso (del
componimento in Saffo e dell'antistrofe in Euripide) e viene preceduto dalla parola
a[koitin (gV 12 e Alc. 994) in clausula. Inoltre vi è una similitudine tra i metra dei due
passi: il parasclepiadeo maggiore in Saffo (con tre coriambi) e la sequenza
in Euripide, sempre con tre coriambi
( ). Di Benedetto ha integrato oujdei;": se si accetta la sua
integrazione, in tutti e due i casi avremmo una enunciazione in negativo. Se la
coincidenza relativa ad a[koitin non è frutto del caso, l'edizione alessandrina (ovvero
quella riportata dal POxy 1787 del III sec. d.C.) riprodurrebbe una situazione editoriale
già in atto intorno al quartultimo decennio del V sec. a.C. (come infatti sappiamo,
l'Alcesti viene datata al 438 a.C.). Il sostantivo ajoidov" è attestato al femminile già in
Hes. Op. 208.
Livrea (2007, 72-73ss.) che, come abbiamo visto, ritiene che questi quattro versi
costituissero il prosieguo dell’ode precedente, integra a[ban de; Favwno" qanavtwi pai'"
fq]i≥mevnan nomivsdei “e la giovinezza di Faone, consumatasi con la morte, ognun
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
175
crede…”. Per Livrea, dunque, la figura di Titono è speculare a quella di Faone, il
barcaiolo lesbio che traghettò senza costi Afrodite travestita da vecchia ottenendone in
ricompensa un ringiovamento che fece innamorare tutte le donne, compresa la stessa
dea282
. Per Livrea, comunque, Saffo avrebbe solamente riportato un mito, parallelo a
quello di Titono, di cui era a conoscenza e che aveva a che fare con la sua terra: lo
studioso non crede assolutamente alla leggenda degli amori tra Saffo e Faone: essa
sarebbe nata, piuttosto, proprio dall’errata interpretazione degli ultimi sei versi dell’ode.
Livrea non esclude che il testo lirico adespoto presente nello stesso Papiro di Colonia
possa costituire un rielaborazione comica o mitica del mito di Saffo e Faone283
.
Austin (2007, 121-122) ritiene possibile che in questo carme Saffo opponesse i suoi
costumi a quelli di Alceo (si dà per scontato, ovviamente, che un incontro tra i due poeti
possa essere effettivamente avvenuto) ed integra il primo verso così: [a[riston oj me;n
sumposivan kekr]i≥mevnan nomivsdei “l’un” – c’est-à-dire Alcée- “estime que le bien
suprême c’est un banquet”.
2 Il Di Benedetto, in un articolo di qualche anno fa284
, già aveva proposto di
restituire Kronivd]ai" ojpavsdoi. Il West, invece, integra oj d∆ eujporivan, ta;n qevo"
a[mmaisi fivl]ais∆ ojpavsdoi. Recentemente Di Benedetto, intervenendo nuovamente con
un suo contributo, ha, come abbiamo detto, rifiutato l'ipotesi della Priamel ed insieme
tutta la ricostruzione del West: in particolare per il Di Benedetto risulta inammissibile
che Saffo ponga in secondo piano ciò che viene fatto oggetto di un auspicio solenne.
Inoltre, mentre Saffo augura eujporivan alle sue compagne, per se stessa si riserverebbe
qualcosa d'altro: si evidenzierebbe l'originalità di Saffo, ma a danno delle ragazze del
qivaso". Perciò Di Benedetto integra: a[lloisi tuvchn o[ssa qevlwsi Kronivd]ai"
ojpavsdoi "agli altri il Cronide conceda di ottenere ciò che vogliono". Per Kronivdai"
ojpavsdoi si confrontino questi due passi epici in cui l'oggetto è la gloria: Il. VIII 141 nu'n
me;n ga;r touvtwi Kronivdh" Zeu;" ku'do" ojpavzei "gloria ora dona a costui Zeus
282
La letteratura antica sul mito di Saffo e Faone è sterminata, ma occorre almeno rimandare alle
testimonianze citate dalla Voigt in Sapph. 211 V. 283
Su questo cfr. anche Lundon 2007, 165s., per il quale, tuttavia, una tale ipotesi è poco convincente. E se
le ipotesi di Livrea fossero corrette vi sarebbe da chiedersi perché il copista o, forse meglio, i copisti del
PKöln 21351+21376 avrebbero trascritto l’ode di Saffo ed il testo lirico adespoto in sequenza, privando la
prima, però, proprio della parte finale riguardante il mito di Faone che li accomunava: sarebbe più naturale
il contrario, ovvero che due testi riguardanti lo stesso soggetto fossero traditi dallo stesso papiro. 284
Di Benedetto 1985, 145-63.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
176
Cronide"; Il. XXI 570 aujtavr oiJ Kronivdh" Zeu;" ku'do" ojpavzei. "Zeus Cronide gli dà
gloria".
Livrea (2007, 73) propone di integrare, invece, ajghvraon, a]n mh; Kronivdai"
parqenivk]ais∆ojpavsdoi “priva di vecchiaia: possa il Cronide non donarla mai alle
vergini!”, ovvero recependo Kronivdai" ojpavsdoi di Di Benedetto, ma ponendolo in
un’altra sede metrica.
Anche Austin recepisce Kronivd]ai" ojpavsdoi del Di Benedetto e per il resto integra
[kajleuqerivan, ta;n Mutilhvnai Kronivd]ai" ojpavsdoi “e la libertà, che il Cronide la
conceda a Mitilene”.
3 Entra a questo punto prepotentemente in gioco la citazione di Ateneo.
Si noti la tendenza, propria del dialetto eolico, ad estendere le desinenze atematiche
anche ai verbi che in attico hanno quelle della coniugazione tematica (fivlhmmi
corrisponde all'attico filevw).
La comprensione del passo dipende in larga misura dalla comprensione del termine
ajbrosuvna. Il sostantivo aJbrosuvnh "raffinatezza, delicatezza" è derivato dall'aggettivo
aJbrov",-av,-ovn "delicato, tenero, effeminato" di etimologia ignota, anche se si tende a
collegarlo al sostantivo h{bh "giovinezza".
Non sarà un caso che tale termine sia attestato, unico altro passo della “letteratura greca
arcaica”, in Senofane di Colofone (Xenoph. 3.1 = DK 21 B 3.1): aJbrosuvna" de;
maqovnte" ajnwfeleva" para; Ludw'n “e dopo aver appreso inutili raffinatezze dai
Lidi” (per il testo intero del carme di Senofane cfr. supra, Introduzione): si tratta della
descrizione dell’aristocrazia colofonia, orgogliosa dell’ aJbrosuvnh di cui fa sfoggio
recandosi all’agorà285
.
Del termine si contano davvero poche attestazioni, ma si confronti almeno Eur. Or. 349
(†polu; d j† è il testo edito dal Di Benedetto nella sua edizione critica, mentre G. Murray
congettura pollh'i in riferimento ad aJbrosuvnhi "dalla molta eleganza"):
kai; mh;n basileu;" o{de dh; steivcei,
Menevlao" a[nax, †polu; d j† aJbrosuvnhi dh'lo" oJra'sqai tw'n Tantalidw'n ejx ai{mato" w[n
285
Così Mazzarino 2007, 187. Cfr. Ferrari 2007, 74ss. Si è parlato di tutto ciò già nell’introduzione, per
cui cfr. infra.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
177
Ed ecco che arriva il re,
il sire Menelao, dall'eleganza
è molto chiaro a vederlo che
discende dal sangue dei Tantalidi.
Anche qui, come possiamo vedere, questo sostantivo funge da "strumento di
dissociazione", per usare un'espressione recentemente utilizzata dallo stesso Di
Benedetto: è grazie alla stessa aJbrosuvnh che Menelao viene riconosciuto come
appartenente alla stirpe di Tantalo: "il Coro dimostra il suo stupore per le splendide vesti
di Menelao ed in questo vede il segno della sua regalità" commentava, quattro decenni
fa, lo stesso Di Benedetto286
.
Posto tutto ciò, occorre dire che nel testo di Livrea (2007, 72-73) sembra non esservi
alcun rapporto tra quel precede e l’affermazione di Saffo di amare l’ajbrosuvna287. Dopo
la constatazione dei malanni della vecchiaia e l’enunciazione dell’impossibilità per
l’uomo di essere indenni da quest’ultima, Saffo passa a spiegare la sua affermazione con
il mito di Eos e di Titono e (ma questa è un’aggiunta di Livrea) con quello di Faone: in
tutto questo sviluppo non sembra esserci il minimo appiglio per l’affermazione
successiva, ovvero “ma io amo la raffinatezza”: nella traduzione di Livrea questo scarto
sembra ridursi, ma solo perché lo studioso traduce l’avversativa con “da parte mia”: un
de; dopo un pronome personale (e per giunta di prima persona), però, non può che avere
un forte valore avversativo, quasi, oseremmo dire, contrappositivo.
Nel testo di Austin (2007, 126), invece, l’ajbrosuvna ha senso e questo perché l’editore
ritiene che il frammento sia isolato da ciò che precede e che costituisca una Priamel,
anche se solo a due membri, Alceo e Saffo che parla in prima persona: oj me;n...e[gw de;.
Non riteniamo che il dato dell’ajbrosuvna sia stato presentato da Saffo senza motivo:
l’avversativa posta dopo un pronome personale di prima persona singolare sembra avere
un marcato valore contrappositivo e dato il significato e le attestazioni del termine siamo
portati a pensare che qui Saffo si schierasse contro qualcuno che non condivideva il suo
286
Di Benedetto 1965, 75-76. Per l’editore il termine aJbrosuvnh sarebbe qui impiegato da Euripide per
indicare lo sfarzo dei vestiti di Menelao. E vi potrebbe essere un ulteriore punto di contatto tra questo
passo euripideo e la nostra ode: un riferimento alle splendide vesti che Menelao aveva portato dall’Asia si
trova, come sostiene Di Benedetto, in Eur. Hel. 423s. pevplou" de; tou;" pri;n lamprav t∆ajmfiblhvmata / clidav" te povnto" h{rpas∆: “i vestiti di prima, i manti splendenti / e le raffinatezze li ha rubati il
mare”: da notare che lamprav e clidav" (sinonimo di ajbrosuvna) richiamano, seppur indirettamente, il
nostro passo di Saffo. Anche in Euripide, dunque, l’Asia è in qualche modo terra delle raffinatezze. 287
Il legame con quello che segue esiste: evidentemente, perché ciò che segue è presente tradito dal papiro
e non restituito da Livrea.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
178
modo di vivere, l’ajbrosuvna stessa: e chi se non Andromeda o, forse più probabilmente,
Gorgò? Questo, tuttavia, non significa che il nome di Andromeda o quello di Gorgò
fossero presenti nel testo: può anche trattarsi solo di una semplice allusione: sembra
trasparire un certo tono polemico. Una simile espressione potrebbe trovare un parallelo
in Sapph. 120 V. ajllav ti" oujk e[mmi paligkovtwn / o[rgan, ajll∆ajbavkhn ta;n
frevn∆e[cw... “…ma io non sono una dalle ire piene di rancore, ma ho il cuore mite…”,
ovviamente se in quel passo a parlare è Saffo. Per il passo da noi citato cfr. anche infra.
Blass, in un articolo miscellaneo su alcuni lirici arcaici (1874, 151), ritiene di essere il
primo a porre una lacuna dopo ajbrosuvnan ed a costituire il testo così come si presenta
nelle edizioni moderne, ma era già stato anticipato da F-G. (1806, 140), uno sconosciuto
recensore della monumentale edizione di Ateneo pubblicata ad inizio Ottocento da
Schweighäuser. La lacuna ipotizzata da F-G. e da Blass (separatamente?), accolta da
Sitzler (1898, 121), sembra essere confermata dalla disposizione del testo presentata dal
POxy. 1787 frr. 1-2. Molti studiosi hanno cercato di supplire alla lacuna: il primo è stato
lo stesso F-G. (l.c.) che trascrive il testo integrandovi direttamente [kai; to; kalovn ge],
traendolo da Ateneo: così, però, si avrebbe una fastidiosa ripetizione del kai; e del kai;
to; kalovn: “ma io amo la raffinatezza ed il bello e per me / l’amore del sole ottenne in
sorte lo splendore ed il bello”. La pubblicazione del POxy. 1787 fr. 1-2 ha ridotto
sensibilmente la lunghezza della lacuna (ora solo un dattilo: [ ]), aggiungendo
tou'to che non veniva citato da Ateneo. Tra gli studiosi del Novecento si segnalano:
Hunt (1922, 42), il quale proponeva di integrare un avverbio che qualificasse il verbo
fivlhmmi, per esempio e[xoca, oppure dh; mavla, o povll∆ e[ti "molto", o altrimenti un
aggettivo per tou'to, qualcosa come a\duv ge; Diehl integrava il causale [kai; dia;];
Edmonds [kevklute]. Come notava il Di Benedetto (1985, 153) [kai; dia;] di Diehl crea
non pochi problemi, soprattutto in considerazione del kaiv successivo. Gli studiosi
italiani, invece, si sono posti su una stessa linea di significato generale, ovvero una
forma del perfetto oi\da: l'imperativo [i[sqi de;] il Perrotta ("e tu sappi")288
, [oi[date] il
Gallavotti (ma questa è una forma ionica289
e non eolica), mentre il Di Benedetto290
ha
288
Perrotta (1935, 36 n. 1) nel proporre questa integrazione istituisce il confronto con Sapph. 35.7 Diehl
[=23.7 Voigt] tovde d∆i[sqi. tou'to, tuttavia, non è presente, come invece afferma Perrotta, nel testo di
Ateneo. 289
La coniugazione anomala dell'antico perfetto oij~da (< i.e. *uid-/ueid-/uoid-, cfr. lat. uidĕō) è stata
normalizzata in diversi modi, a seconda dei dialetti: lo ionico ( e poi anche la koinhv), ad esempio, ha
generalizzato la radice apofonica a grado o, per cui, in tale dialetto, la flessione doveva essere: oij~da,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
179
ipotizzato [i[ste de;] ("e voi lo sapete"). Il West propone di integrare [au\tov ge] e
traduce "loveliness, just this per se", recepito anche da Austin (2007, 126). Livrea (2007,
77) propone di integrare [a\sdev me] tou'to “questo mi ardeva” e propone di confrontare
Alc. 347.6 a[cei d∆ejk petavlwn a[dea tevttix... / a[nqei de; skovlumo", nu'n de;
guvnaike" miarwvtatai / levptoi d∆a[ndre", ejpei; ã Ã kefavlan kai; govna Seivrio" /
a[sdei “soave risuona dalle frasche la cicala…/ è in fiore il cardo ed ora le donne son
più lascive / molli gli uomini, giacchè Sirio la testa e le ginocchia / riarde”. Ferrari
(2007a, 73), invece, ha proposto di integrare [u[mmi de;] che dovrebbe coinvolgere
direttamente anche le altre ragazze. Secondo la più recente interpretazione di Ferrari,
inoltre, tou'to dovrebbe riferirsi ai due neutri sostantivati del verso successivo. Occorre,
innanzitutto, chiedersi per quale motivo Ateneo non abbia citato la parte di testo
compresa tra ajbrosuvnan e kaiv moi, ovvero [ ] tou'to: una risposta quale, ad
esempio, “perché non occorreva per comprendere il testo, perché era di più” non è
affatto banale. Si noti, inoltre, che Ateneo non cita nemmeno tou'to, come se esso non
avesse a che fare con quel che segue o costituisse un inciso insieme a ciò che lo
precedeva immediatamente: se è così, [ ] tou'to doveva aggiungere ben poco di
notevole al testo che abbiamo. Escludendo, dunque, le integrazioni problematiche
(quella del recensore di Jena, quelle di Hunt, quella di Diehl, quella di Edmonds, quella
di Gallavotti) ed [au\tov ge] di West, che sembra essere troppo prosastico e filosofico,
rimangono [i[sqi de;] del Perrotta, [i[ste de;] del Di Benedetto, [a\sdev me] del Livrea,
[u[mmi de;] di Ferrari: tra tutte, l’ultima è l’integrazione che modifica maggiormente il
significato della frase. [i[ste de;] del Di Benedetto è, molto probabilmente,
l’integrazione che ha avuto maggior successo, ma occorre notare che essa fu proposta
quando si riteneva che questi versi fossero il prosieguo dei precedenti: essa era,
insomma, giustificata dalla presenza delle pai'de" al v. 11 di quello che già si riteneva
l’incipit di una nuova ode. Dopo la pubblicazione del PKöln 21351+21376 lo stesso Di
Benedetto è stato costretto, come abbiamo visto, a cambiare idea e, tuttavia, mantiene
l’[i[ste de;] che, con la nuova situazione testuale (sparite, dunque, le “ragazze”), a meno
oij~daß, oij~de, oi[damen, oi[date (appunto), oi[da –sin; il dorico, invece, ha normalizzato quella a grado Ø is-
(<*id-): i[ste quindi può essere sia una forma attica, sia eolica, sia dorica. Cfr. Chantraine, Morph., pp.
189-190. Di Benedetto (1985, 153 n. 30) nota, del resto, come i[dmen sia sicuramente attestato in Sapph.
19, 7 V., mentre ]o≥vidamen di Alc. 167.9 è incerto. 290
Di Benedetto 2005, 153ss.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
180
di considerare la possibilità di introdurre un nuovo soggetto “fisico” nei versi precedenti
(e Di Benedetto non propone niente del genere) o di un apostrofe metatestuale, rimane
privo del suo soggetto. [u[mmi de;] di Ferrari, invece, non richiede che le “ragazze” siano
già menzionate, perché le introduce ex novo, anche se il riferimento sembra ancora
essere piuttosto vago, perché dal testo non è chiaro chi siano i “voi”. Con [u[mmi de;],
inoltre, tou'to crea non pochi problemi: Ferrari, come abbiamo detto, lo collega con i
due aggettivi sostantivati del verso successivo, ma il testo così risulterebbe troppo
forzato.
4 Gli studiosi, da generazioni, si interrogano su come intendere questo verso: ciò
non può prescindere, tuttavia, da una corretta restituzione del passo: per la parte centrale
del verso, infatti, noi dipendiamo esclusivamente dalla citazione di Ateneo; il codice A
riporta erosa eliw: questa lezione non può essere accettata così come è, perché, in
primo luogo, è portatrice di un testo impossibile ed in secondo luogo perché, anche se
corretta, con il Canter, in e[ro" ajelivw, contrasta con il metro: perciò già nel lontano
1806 il solito sconosciuto recensore di Schweighäuser, F-G.291
, dopo aver riconosciuto il
metro (la terminologia utilizzata dallo sconosciuto recensore è ionici a maiore) aveva
proposto292
di correggere erosa eliw in e[rw" ajelivw. Molti decenni dopo, nel 1874, il
Blass (1874, 151), propose lo stesso emendamento del recensore di Jena: evidentemente,
non era a conoscenza del fatto che e[rw" era già stato proposto. E come Blass non era a
conoscenza della proposta del recensore di Schweighäuser, così non lo erano neanche i
suoi detrattori, a cominciare da Otto Hoffmann (1893, 153) che, dando notizia della
costituzione del testo proposta dal Blass (e, prima ancora da F-G., ma questo Hoffmann
non lo sapeva, a quanto pare), afferma: “die Aeoler sagten indessen nicht e[rw", sondern
e[ro"”. Sitzler (1898, 121), ventiquattro anni dopo l’articolo del Blass, propose e[ro"
291
F-G. 1806, 140. Il contributo apparve sulla Jenaische Allgemeine Litteratur-Zeitung suddiviso in
cinque parti, le prime quattro su quattro pagine di due colonne ciascuna, la quinta, invece, su due pagine di
due colonne: la prima parte apparve sul numero 247 del 18 ottobre 1806, la seconda sul numero 248 del 20
ottobre 1806, la terza sul numero 249 del 21 ottobre 1806, la quarta sul numero 250 del 22 ottobre 1806 e
l’ultima, di complessive tre colonne e dieci righe, sul numero 251 del 23 ottobre 1806. In realtà, stando al
significato letterale della parola, non è corretto parlare di un anonimo: alla fine dell’ultima parte
(Jenaische Allgemeine Litteratur-Zeitung 251, 23 october 1806, 156) è presente la firma abbreviata
dell’autore, F-G., come già notava la Voigt (1971, 3): da essa, tuttavia, non è possibile arrivare ad un
nome proprio completo, per cui continueremo, per comodità, a chiamarlo “Anonimo di Jena”. Per il testo
rimandiamo a http://zs.thulb.uni-jena.de/content/main/journals/jalz.xml. 292
È giusto sottolineare, tuttavia, che lo sconosciuto autore non accenna minimamente alla sua congettura,
presenta direttamente il testo del verso come si presenta nella edizione della Voigt, senza precisare altro,
se non la proposta di integrare [kai; to; kalovn ge], tratto dal testo di Ateneo, nella lacuna del verso
precedente.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
181
twjelivw: “Vers wendet O. Hoffmann mit Recht gegen Blaß ein, daß e[rw", wie er (i.e. Fr.
Blass) schreibt, nicht äoilisch ist“. Sitzler, dunque, non parte dall’interpretazione del
testo per proporre la sua congettura, ma dal semplice argomento linguistico, lo stesso di
Hoffmann (1893, 153): e[rw" non era eolico e quindi non poteva essere attestato in
Saffo. Sitzler, tuttavia, non specifica come debba essere inteso e[ro" twjelivw, ma è
verosimile che lui ritenesse valido tradurre “l’amore del sole”: nel suo articolo, infatti,
non si fa cenno ad alcun problema interpretativo. Coloro che accolgono la congettura di
Sitzler, modificano l’interpretazione di Clearco in Ateneo (hJ tou' zh'n ejpiqumiva) ed
intendono twjelivw non come, forse, lo intendeva Sitzler, ma come crasi di to; ajelivw, ma
cfr. infra. Secondo West nel processo di citazione twjelivw sarebbe stato sciolto nella
scriptio plena (EROSTWAELIW) e successivamente l'articolo eolico sarebbe caduto.
Inoltre, la forma e[ro" ha due vantaggi: può essere considerata lectio difficilior ed è
caratteristica del dialetto di Lesbo. Tuttavia la congettura trova una decisiva opposizione
nella osservazione fatta dal Lobel, secondo la quale con il sostantivo ajevlio" non si
troverebbe mai l'articolo293
. Per quest'ultima ipotesi si cfr. il fr. 56 V. favo" ajlivw "la
luce del sole", cioè "la vita" dove il sostantivo "sole" è privo dell'articolo (questa
espressione trova riscontro in quella omerica ed esiodea favo" hjelivoio anche essa in
clausula). L'osservazione del Lobel trova conferma nel testo dell'Iliade, in quello
dell'Odissea ed anche in Esiodo: nelle 154 volte che hjevlio" (h{lio" solo in Od. VIII
271) ricorre in queste opere, sia al nominativo, che al genitivo, al dativo o all'accusativo,
non presenta mai l'articolo. Cade così l'ipotesi principale del Sitzler, perché non
possiamo interpretare twjelivw come tw' ajelivw, cioè come una crasi tra l'articolo ed il
sostantivo cui si riferisce (cfr. e. g. Sapph. 31.2 V. w[nhr da oj a[nhr).
Veniamo, però, all’argomento di Hoffmann, ovvero che e[rw" non era eolico e, dunque,
non poteva essere attestato in Saffo: è ancora possibile, a più di centodieci anni di
distanza, condividere questa opinione? In Omero è attestato il nominativo e[ro" solo in
Il. XIV 315, l'accusativo e[ron e. g. in Od. I 150 (al.) 294
, il dativo e[rwi solo in Od.
293
Lobel 1927, xc-xci. Lobel cita anche questo passo di Saffo: pur di non accettare il testo dell’Anonimo
di Jena, ovvero e[rw" ajelivw, accoglie il testo di Sitzler, e[ro" twjelivw, considerandolo un’eccezione alla
regola appena formulata. Lobel non prende in considerazione la possibilità che twjelivw possa essere una
crasi per to; ajelivw. 294
L'accusativo e[ron è attestato in Omero 24x e quasi sempre nell'espressione formulare in clausula ejx e[ron e{nto (Il. I 469; II 432; VII 323; IX 92; IX 222; XXIII 57; XXIV 628; Od. I 150; III 67; III 473; IV
68; VIII 72; VIII 485; XII 308; XIV 454; XV 143; XV 303; XV 501; XVI 55; XVI 480; XVII 99; XXIV
489): uniche modificazioni in Il. XIII 638 ejx e[ron ei|nai e Il. XXIV 227 ejx e[ron ei{hn.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
182
XVIII 212. Il nominativo e[rw" in Omero non si trova che due volte (Il. XIV 294 e III
442) e sempre prima di consonante: queste due attestazioni sono inoltre le uniche del
sostantivo e[rw", perché in Omero non è attestato né al genitivo, né al dativo, né
all'accusativo: perciò, a veder bene, nella lingua dell'Iliade, la presenza di un nominativo
e[rw" non è dimostrata. Nota, quindi, lo Chantraine: "Pour ce mot la forme thématique
qui est éolienne apparait toujours possible, souvent nécessarie"295
. Inoltre in Omero non
è attestato neanche il genitivo di e[ro". Nel caso di Il. III 442 e XIV 294 si potrebbe
trattare, quindi, di un atticismo: tutti i manoscritti riportano, infatti, e[rw" per questi due
passi e già il Leaf (1900, ad loc.), più di un secolo fa, proponeva di restituire in entrambi
i passi analizzati e[ro", notando come per Il. XIV 315 la maggior parte dei manoscritti
avesse e[rw", mentre e[ro", come abbiamo detto, è richiesto dal metro: la traccia più
antica del nominativo e[rw" sarebbe, invece, per il Leaf l'accusativo e[rwtadi Hymn.
Merc. 449, dove chiaramente è richiesto dal metro. Non ci sono quindi prove
inconfutabili per dimostrare che e[rw" sia attestato già in Omero (diversa è l'opinione
della Voigt: "Schon hom. steht e[ro", e[rwi, e[ron neben e[rw"…so auch bei S. und A.
e[ro", e[ron, e[rw neben e[rw", e[rwto""296
); che e[ro" sia una forma eolica lo dice invece
Eustazio nel commento ad Od. XVIII 212 (un passo già precedentemente citato dove
compare l'unica attestazione del dativo e[rwi): II 176.7 to; de; e[rwi dokei' Aijoliko;n
eij~nai.
Quanto al verso qui analizzato, la Voigt proponeva di emendare erosa eliw in e[rw"
ajelivw già molti anni prima della sua edizione critica dei frammenti di Saffo e di Alceo:
"S. 65A.26 Diehl [= gV 4 v. supra] ist vielleicht aus metrischen Gründen e[rw" für das
überliefertee[ro" einzusetzen"297
Se si esclude il componimento qui analizzato, il sostantivo e[ro" al nominativo compare
altre 4x in Saffo, delle quali in tre su quattro la sillaba finale risulta chiusa, perché
seguita dalla dentale d (nel quarto caso, cioè nel fr. 159, [Ero" è alla fine del testo
tradito, perciò ciò che seguiva è a noi ignoto).
Ed inoltre è da portare sotto la nostra attenzione un dato oggettivo: è attestato in Saffo
non solo il genitivo e[rwto" (23.1 V,), ma anche, forse, lo stesso nominativo e[rw" (se
sarà confermata la lettura ]e≥vrw"[ in Sapph. DV ieV b.7 = 67b.7 V. = POxy. 1787 fr. 18.
295
Chantraine, Gramm. hom., I, p. 211 296
Hamm 1958, 46. 297
Hamm 1958, 155ss.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
183
7, per cui cfr. infra)298
. Ecco che, dunque, l’argomento forte di Hoffmann, accolto e
sviluppato da Sitzler, cade inesorabilmente, perché abbiamo dimostrato che in Saffo è
attestato sia e[ro", la forma eolica originaria, sia e[rw". Fin qui i problemi testuali, ma
passiamo ad analizzare quelli di interpretazione.
Recentemente, Colin Austin (2007, 124) ha avuto cura di ripresentare alcune opinioni
espresse da Giorgio Pasquali sull’ultimo verso: lo studioso italiano, nel 1933, intendeva
il passo e lo traduceva nel modo seguente: “io amo la mollezza e per me (trascuro tou'to
che poteva infatti dipendere da un diav) l’amore ha lo splendore del sole e la sua
bellezza”299
. Pasquali aggiungeva anche: “congiungendo ajelivw ad e[rw", non so trovar
senso.” Per Austin è sorprendente che gli allievi di Pasquali interpretino il testo in
maniera differente: nell’articolo fa il nome di Franco Ferrari, ma è possibile, tornare
molto più indietro nel tempo.
Un allievo diretto di Pasquali, Gennaro Perrotta (1935, 36), traduceva “Io amo la
raffinatezza: l’amore del sole mi ha dato in sorte splendore e bellezza” e parafrasava “il
desiderio di vivere, di vedere la luce del sole, è così identificato col desiderio di cose
splendide e belle”.
Schadewaldt (1950, 161), invece, senza averne coscienza, ripropone l’interpretazione di
Pasquali: traduce, infatti, “und ist mir / In der Liebe das Leuchten des Sonnenlichts und
auch das Schöne geworden”.
Page (1955, 130 e n. 1) è ancora più drastico: egli, dopo avere introdotto, davvero
brevemente, l’ex fr. 58 Lobel-Page = Voigt, dichiara di avere “no conception of the
meaning of the last two lines”, ma si tratta, evidentemente, di un’ affermazione che
nessuno si sentirebbe di condividere.
Per Di Benedetto (1985, 154ss.) “l’ordine delle parole non lascia nessun dubbio sul fatto
che e[rw" ajelivw costituisca un nesso unico”: egli accetta l’interpretazione di Gennaro
Perrotta e ritiene che “l’amore per il sole” coincida con il desiderio di vivere. La luce del
sole era associata con il nascere dell’uomo, per cui cfr. Il. XVI 188 aujta;r ejpei; dh; tovn
298
Per Di Benedetto (1985, 154s. n. 33) risulta eccessiva la norma per cui i poeti lesbii potrebbero usare
e[rwto" al genitivo, mentre al nominativo ed all’accusativo dovrebbero usare solo e[ro" ed e[ron. 299
Cfr. Austin 2007, 124. Le parole di Pasquali sono tratte da una lettera del 21 aprile del 1933 a Manara
Valgimigli: per il testo cfr. Burzacchini 1991, p. 394. Il contributo di Burzacchini è una recensione ad una
edizione del carteggio Valgimigli-Pasquali pubblicata dal compianto Dino Pieraccioni: D. Pieraccioni,
Manara Valgimigli-Giorgio Pasquali. Storia di un’amicizia. 1912-1952 («Studi Valgimigliani» a c. di P.
Pellegrino, 5), Milazzo (Spes) 1989. Su questa opinione espressa dal Pasquali cfr. anche Marzullo 1994,
189.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
184
ge mogostovko" Eijleivquia / ejxavgage pro; fovwsde kai; hjelivou i[den aujgav" “ma
quando Ilizia, la dea che governa i dolori del parto, / lo fece uscire alla luce e vide i
raggi del sole”; Hymn. Apoll. 71 tw'i rJ∆aijnw'" deivdoika kata; frevna kai; kata;
qumo;n / mh; oJpovt∆a]n to; prw'ton i[dhi favo" hjelivoio “perciò temo terribilmente nella
mente e nel cuore / che quando egli abbia visto per la prima volta la luce del sole”;
Hymn. Ven. 256 to;n mevn ejph;n dh; prw'ton i[dhi favo" hjelivoio “non appena vedrà
per la prima volta la luce del sole”. La morte, al contrario, si identifica con il lasciare la
luce del sole, ad es. in Il. XVIII 11 Murmidovnwn to;n a[riston e[ti zwvonto" ejmei'o /
cersi;n u{po Trwvwn leivyein favo" hjelivoio “il miglior dei Mirmidoni, con me ancor
vivo, / per mano dei Troiani avrebbe lasciato la luce del sole”; [Hom.] Hymn. Ven. 256
tw'n dev q∆oJmou' yuch; leivpei favo" hjelivoio “ed insieme alla loro anima lascia la
luce del sole”. La luce del sole, insomma, era associata con il vivere dell’uomo e Saffo
stessa fornisce un esempio davvero suggestivo, ovvero Sapph. 56 V.: oujd∆ i[an
dokivmwmi prosivdoisan favo" ajlivw / e[ssesqai sofivan pavrqenon eij" oujdevna pw
crovnon / teauvtan... “non credo che in alcun tempo vedrà la luce del sole una ragazza
simile in saggezza”. In Omero è, inoltre, attestata l’espressione zwvein kai; oJra'n favo"
hjelioio “vivere e vedere la luce del sole”, che ha tutta l’aria di essere una dittologia: Il.
XVIII 61; XVIII 442; XXIV 558; Od. IV 540; IV 833; X 498; XIV 44; XX 207. Il Di
Benedetto non elenca i casi in cui è attestata la tessera oJra'n favo" hjelioio, ma tra
questi almeno due sembrano davvero adatti a dare un senso a questo contrastato passo di
Saffo, ovvero Od. IV 540 e X 498, dove si ha, in entrambi i casi, h[qel∆e[ti zwvein kai;
oJra'n favo" hjelivoio “non voleva più vivere e vedere la luce del sole”: si tratta,
riteniamo, dei due passi più prossimi a quello saffico.
Burzacchini (1995, 94) accoglie l’interpretazione di Vincenzo Di Benedetto ed anche la
sua traduzione: per lui anche l’ordine stesso300
delle parole suggerisce il nesso e[rw"
ajelivw, mentre e[ro" twjelivw è un ingannevole “rapporto associativo”.
"Molti studiosi"-sono parole del West (2005, 8)
- "hanno collegato (tw') ajelivw con e[ro"
(o e[rw") e quindi nel senso di "l'amore per (la luce) del sole", cioè per la vita: questo era
il significato che ne dava Clearco, parafrasandolo in hJ tou' zh'n ejpiqumiva". West
ammette di non aver compreso il collegamento tra "l'amore per il sole" e l' ajbrosuvnan
300
Così Burzacchini 1995, 94 n. 79.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
185
precedente: egli, infatti, intende, sulla scorta dello Schadewaldt301
, "l'amore ha ottenuto
per me la brillantezza del sole…", intendendo twjelivw come crasi di to; ajelivw e con to;
in riferimento a to; lavmpron: questa congettura concorderebbe con l'osservazione fatta
dal Lobel, perché to; non si riferirebbe ad ajelivw. In secondo luogo essa ci autorizzerebbe
a vedere in Eros una personificazione e sarebbe, per il West, più coerente con il termine
ajbrosuvnan del verso precedente.
A questa idea del West si è opposto Franco Ferrari302
, il quale spiega "la fruizione dello
splendore e della bellezza del sole costituisce di per sé un'esperienza condivisa da tutti
gli uomini fin dalla nascita e non una sorte individuale concessa dall'eros (o dal dio
Eros): diversa è la sorte di chi, come Saffo, aspira quotidianamente ad uno splendore e
ad una bellezza che derivano dall'amore per tutto ciò che sia luminoso come il sole: la
luce del sole è la misura di tutte le cose belle". Perciò, per il Ferrari, i due nessi fivlhmm∆
ajbrosuvnan e e[rw" ajelivw si rivelano come "due facce dello stesso atteggiamento di
fondo": l' e[rw" ajelivw ha dato in sorte a Saffo to; lavmpron kai; to; kavlon. Inoltre,
secondo Ferrari (2007a, 73) e Cavallini (1985, 76) il fatto che to; lavmpron kai; to;
kavlon fossero, all’origine, separati dal sostantivo ajelivw lo dimostrerebbe Ar. Pl. 144sg.
kai; nh; Div∆ ei[ tiv g∆ejsti; lampro;n kai; kalo;n / h] cariven ajnqrwvpoisi, dia; se;
givgnetai “e, per Zeus, se c’è una cosa splendida, bella / o appena caruccia per gli
uomini, avviene per merito tuo”, dove secondo Cavallini il poeta comico riprenderebbe
le parole di Saffo: del resto, ad un rapido controllo risulta chiaro che questi due passi
poetici, quello di Saffo e quello di Aristofane, sono gli unici in cui ricorra a breve
distanza lampro;n kai; kalo;n. Perciò Ferrari invita a sottolineare il valore dei pronomi
di prima persona singolare e[gw...moi del penultimo verso: e nell'ipotesi della Priamel
(per altro, come abbiamo detto, scartata dallo Di Benedetto), ciò è ancor più giusto.
Il Di Benedetto, ritornando, ancor più recentemente, su questo frammento, ha rifiutato in
toto la tesi del West: per lui è inammissibile che il dio Eros sia soggetto di levlogcen,
perché questo verbo "comporta l'idea dell'acquisizione di proprietà inerenti al soggetto
301
Cfr. Schadewaldt (1950, 161). West cita direttamente la traduzione dello studioso tedesco:
evidentemente non ha coscienza del fatto che quella linea interpretativa era stata inaugurata da Pasquali.
L’opinione di West non è nuova: egli l’aveva già manifestata nell’articolo del 1970 (West 1970, 330),
dove il passo viene tradotto “my liking is for what is graceful; [because of] this it is love that shows me
even the brightness of the sun, and what to hold fair”. E si veda anche la traduzione di Campbell (1982,
101): “but I love delicacy…love has obtained for me the brightness and beauty of the sun”. Campbell
nota: “End of the poem: meaning of the last lines uncertain: perhaps “love has kept me alive””. 302
Ferrari 2005, 26ss.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
186
del verbo": da questo punto di vista, Eros per Saffo "ha consistenza in quanto persona" e
non può "assolvere alla funzione di smistare a favore di Saffo delle proprietà (o facoltà)
che lui stesso avrebbe acquisito in precedenza".
Ad avvalorare il testo dell’”Anonimo di Jena”, o F-G., viene anche in aiuto l'esegesi di
Clearco che ci trasmette Ateneo: se veramente il senso del passo era quello ritenuto
valido dallo Schadewaldt, difficilmente lo stesso Ateneo avrebbe capito l'intera
citazione, o meglio il collegamento tra il testo citato del componimento saffico e
l'esegesi che formulava Clearco.
Per tutte queste ragioni, non ultima la parafrasi di Clearco, sembra a noi condivisibile il
testo proposto dallo sconosciuto recensore dell’edizione di Schweighäuser.
5 Su PIN è presente il simbolo di vocale lunga: verrebbe subito da pensare al
verbo pivnw ma il presente di questo verbo, nella sua forma eolica, è pwvnw. Per il West,
quindi, l'unica possibilità è leggere un lambda al posto del ny (vedere, ad es., come esso
è scritto pochi versi prima nello stesso frammento papiraceo). Austin (2007, 121) non si
fa alcuno scrupolo di correggere ejpin[ in e[pwn[e (il soggetto del verbo è per lui Alceo),
ma la sua non appare, certo, un’azione felice: non è raccomandabile correggere il testo
perché non risponde alle nostre aspettative. Certo pwvnw è la forma eolica, ma come
abbiamo dimostrato in Saffo è presente ad esempio e[rw" a fianco dell’eolico e[ro".
Ferrari (2007a, 73) propone di integrare ejpivn[ete ga;r e mantiene inalterata la lezione
del papiro: per lui Saffo farebbe riferimento al nettare della poesia bevuto dalle ragazze e
da lei stessa; cfr. Pi. I. V 1ss. Ma'ter jAelivou poluwvnume Qeiva, / sevo e{kati kai;
megasqenh' novmisan / cruso;n a[nqrwpoi periwvson a[llwn / kai; ga;r ejrizovmenai /
na'e" ejn povntwi kai; ãuJf∆à a{rmasin i{ppoi / dia; teavn, w[nassa, tima;n wjkudinav- /
toi" ejn ajmivllaisi qaumastai; pevlontai “Madre del Sole, Theia dai molti nomi, /
grazie a te gli uomini stimano / anche l’oro possente in misura più grande delle altre
cose: / anche le navi, infatti, gareggiano / in mare e le cavalle sotto i carri / per il tuo
onore, o sovrana, son mirabili nelle contese vorticose”. L’integrazione di Ferrari può
essere corretta, ma il verbo (ejpivnete è un imperfetto) non può indicare un’azione finita,
come traduce Ferrari (“[Infatti] avete bevuto…”), ma occorre pensare ad un’azione che
ha avuto una sua durata imprecisata nel tempo, forse ad un costume, una tradizione:
verso questa interpretazione può indirizzare anche il verbo fivlei.[ al verso successivo
che, oltre ad “amare”, può significare, appunto “essere soliti”. L’azione che era
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
187
costume compiere è il bere. Austin (2007, 121) si chiede: “Qui donc buvait à Lesbos à
l’époque de Sappho? Qui donc sinon Alcée?” Ebbene, al di là di quello che pensi Austin,
a Mitilene, al tempo di Saffo, non beveva, certo, soltanto Alceo, tanto più che il verbo
sembra indicare un’azione prolungata nel tempo: Alceo non passava, certo, intere
giornate davanti ad una damigiana.
Si ricordi, piuttosto, la famosa ode di Alceo (72 V.) di cui abbiamo parlato
nell’introduzione, quella che descrive i costumi della famiglia di Pittaco:
ejn[..].la[.].....[ lavbrw" de;• sun ste≥i v≥[.]..[..]e≥i≥a≥p≥.. pivmpleisin ajkravtw [....]p∆ ajmevrai≥[ kai; nuvkti paflavsdei...acqen, e[nqa novmo" qavm∆ ejn.[.].[.].nhn. kh'no" de;• touvtwn oujk ejpelavqeto 7 w[nhr ejpei; dh; prw'ton ojnevtrope, paivsai" ga;r ojnnwvrine nuvkta", tw; de;• pivqw patavgesk∆ oj puvqmhn. 10 su; dh; teauvta" ejkgegovnwn e[chi" ta;n dovxan oi[an a[ndre" ejleuvqeroi e[slwn e[onte" ejk tokhvwn....;
furiosamente con…
colmano di vino puro…giorno
e notte ribolle…
dove è costume spesso…
ma quell'uomo non ha dimenticato questi
usi non appena ha cambiato condizione (?),
infatti per intere notti ha fatto baldoria
e risuonava il fondo della giara.
Ecco, tu che sei figlio di una tale madre hai
la fama quale hanno gli uomini liberi
nati da nobili genitori
E si noti che prima Saffo ha detto di amare l’ajbrosuvna, una scelta di vita che si oppone
completamente a quella di Hyrras, il supposto padre trace di Pittaco. L’impressione che
si può ricavare da queste tracce di testo davvero minime è che Saffo stia opponendo il
proprio modo di vivere, l’ajbrosuvna, di cui ha parlato poco prima rivendicandola come
sua prerogativa, a quello delle rivali.
6 Lo iota porta l'accento sul papiro ed il West congettura fivleis[a.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
188
7 kain[ potrebbe essere, per il West, un kai; n[u'n (già Hunt aveva pensato a kai;
n[). kai; n[u'n di West è stato accolto anche da Austin (2007, 126).
eV (60+65+66c+67+86 L.-P. = V.) metrum: hipp
2cho suppl. possis
].akavla.[2 ] a≥i≥jgiovcw l≥a≥v[
].K≥u≥qevrh∆, e≥u≥jc≥om[
4 ]o≥n je[coisa qu'mo≥[n kl]u'qiv m≥ ja[ra" ai[ p[
6 ]a" p≥rolivpois≥a K[uvpron ]"≥ ped j e[man ijwv[an
8 ].n ca≥levpai m≥[erivmnai ]tuvcoisa
10 ]qevl j †wntapaivsan†
tev]l≥eson novhmma 12 ]evtwn kavlhmãmÃi
] peda; qu'mon ai\ya. 14 o[]s≥sa tuvchn qelhvsh["
a]p≥u≥f≥a[ ]r e[moi mavcesqa[i
16 jAnd]romev[dan c]l≥idavnai pivqeisa ].ela.[ ]i,su; d j, eu\ ga;r oi\sqa
18 .]rovt≥hn Neme[ ]evtei t jaj[o]l≥levw≥n≥. Yavpfoi, se fivl[ ]kl≥a s[oiv te 20 Kuvprw b≥[a]sivl[h j sev]mna
kaiv toi mevga dw≥'[ron ]i≥ kat≥evn≥[ 22 o[]ssoi" faevqwn≥[ jAevlio" fevggesin ajmfib]a≥vs≥k[ei pavntai klevo" [
24 k —aiv sVejnnVAcevr[ont ..[......]n≥p≥[
…placid…
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
189
2 …avendo (tu) ricevuto in sorte da Zeus egioco
..o Citerea, ti prego...
4 ...avendo l'animo ben disposto...
..ascolta la mia preghiera, se mai un'altra volta
6 ...lasciata Cipro
…(venisti) al mio grido
8 …per un'ansia opprimente
…avendo ottenuto
10 …che dunque tu voglia di tutte
..esaudisci il mio pensiero
12 ...io chiamo
…subito secondo l'animo
14 …tutto ciò che vuoi ottenere
io non rifiuto che tu lo ottenga: infatti tu di combattere con me non
16 hai bisogno, ma per ciò che Andromeda, confidando in una vita lussuosa,
ha fatto, non sarà possibile sfuggire agli immortali, ma tu, difatti, ben sai
18 che Nemesi colpisce colui che medita infamie e domina tutti.
O Saffo, poiché ti ama, applicò le ruote al carro per te
20 la veneranda regina di Cipro ed andò subito a supplicare Zeus
ed il Cronide le accordò di concederti un grande dono:
22 tutti quelli che il Sole splendente contempla con i raggi
ovunque fama…
24 e te sulle rive dell'Acheronte…
TEST (I) POxy. 2166 (d) 1 = POxy.1787 fr. 45 postmodo repertum, prim. receptum a
Gallavotti1, editum a Voigt 1971, 94 ut fr. 86 [1 - 8] v. 8 huius fragm. adiung.
Sapph. DV kqV g 1 = 87b, 1 V. m]erimna[ vol. Diehl 1944, 9 (II) PHal. 3,
prim. editum in Dikaiomata 1913, 182sqq.., iterum editum a Hunt 1922, 40-41 ut POxy.
1787 fr. 44 et a Voigt 1971, 79-80 ut fr. 60 [9 - 19] v. 9 fort. e regione primi
versus carminis Sapph. 61 (e[gent≥.) collucandum esse censuit Lobel 1925, 27
prim. rec. Diehl1 1923, 365 (III) POxy. 1787 fr. 4, 1-11 editum a Voigt 1971,
82-83 ut fr. 65 [15-25] vv. 19-21 simm. esse Sapph. 87e, 1-3 (v. infra) vid.
Treu 1976, 205 prim. rec. Diehl.1 1923, 360 (IV) POxy. 1787
fragmentum (= Sapph. 66c), prim. editum a Lobel 1925, 30-31 qui e regione carminis
65, 6-8 collocandum esse censuit [20-22] (I) cum (II) coniungendum esse
censuit E. Fraenkel 1942, 54-56 (III) cum (IV) coniungendum esse
censuerunt Lobel 1925, 30, West 2005, 2 (I),(II),(III) et (IV) coniungenda esse censuit
Ferrari 2005, 13sqq. (I),(II),(III) et (IV) et Sapph. DV ieV = 67 V. coniungenda
esse censuerunt Ferrari 2007a, 62-63 et Puglia apud Ferrari 2007a, 62-63, sed non recte,
ut vid. v. 2 fort. novi carminis init.esse censuit Ferrari 2005, 18
CRIT 1 ]n≥, simm. leg. Voigt 1971,94-95 a±kav (I) n≥[, simm. leg. Voigt 1971,
94-95 fort. ajkavlan≥ ].a kavlan[ dist. Diehl 1944, 8
║2 tivman Divo" ejx] aijgiovcw lav[coisa West 1970, 316 n. 21, magna ex parte
(Divo" ejx] aijgiovcw lav[coisa ) rec. Ferrari 2005, 17, 19 ║3 Cythereae
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
190
nomen cogn. Diehl 1944, 8 e.g. e≥u≥jcom≥[evnai m∆a[rhxon Ferrari 2005, 17-
18 ║4 provfr]o≥n∆ e[coisa qu'mo≥[ vn Fraenkel 1942, 245 : i[lla]o≥n Diehl 1944,
8 evc (I) ║ 5 ]u'qivm∆avra–" (I) avi (I) a]u\qi Lobel
1941, 44 p[ota Lobel 1941, 44 : kl]u'qiv m≥∆a[ra" ai[ p[ota kajtevrwta Fraenkel 1942, 245 ║6 ejravnn]a" Diehl 1944, 8 K[uvpron vel
k[avpoi" Fraenkel 1942, 245 : K[uvprw Diehl 1944, 8 ║7 h\lqe]" Ferrari
2005, 18 pe;dev (I) i>wv[ (I): ijwv[an Gallavotti ║8 ]h≥n vel ]i≥n (I) calevpa –i (I) m≥[erivmnai Fraenkel 1942, 254
║10 fort. ej]qevl∆? ]qevl∆ wvnta±pavisa±n (II): ]qevl∆wj~n t∆†ajpaivsan† Lobel 1925, 27 et Lobel-Page 1955, 42 ║11 tev]leson Hunt
1922, 40-41 ║12 kavlhmãmÃi Diehl 19173
║13 moi] peda; qu'mon ai\ya Ferrari 2005, 18 ║14 o[s]sa Hunt 1922,41, rec. Lobel 1925, 27
(o[]s≥sa), Lobel-Page 1955, 42 qelhvsh[i Dikaiomata 1913, 183 :
qelhvsh[i(") Hunt 1922, 41 : qelhvsh[i" Lobel 1925, 27, rec. Lobel-Page 1955, 42 : qelhvsh[" Voigt 1971, 79 Ætovd∆ ai[tion ou[ t∆ [ ai\scronÆ, e[fa, Ækw[]s≥sa tuvchn qelhvshi" Puglia apud Ferrari 2007a, 62-63 ║15 Fränkel
1928, 269, Wilamowitz 1931-1932, II, 111 n. 1, alii Venerem loqui put.
....]...a[(III): ]r e[moi mavcesqa[.(II) ga;]r Hunt 1922, 41, 46 :
pa;]r Puglia apud Ferrari 2007a, 62-63 mavcesqa[i Hunt 1922, 41, 46
fort. .....]p≥u≥f≥a[ Lobel 1925, 30, rec. Lobel-Page 1955, 46 : e[gwu[ s j]ajpuvfa[im jau\ta lavchn: ouj ga;]r e[moi mavcesqa[i Ferrari 2005, 18
║16.....]rome[(III): ]l≥idavnai pivqeisa± (II): ]l≥idavnai jpivqeisa (II), i.e.
participium ael. verbi ejpitivqhmi, lectum in Dikaiomata 1913, 183 : jAnd]romev[ vda Hunt
1922, 43 : c]l≥idavnai Hunt 1922, 41 : c]l≥idavnaãià legit et suppl. censuit Voigt 1971, 80,
sed non recte, ut vid. : dei' s∆, jAnd]romev[dan d∆ oi \a diaivtai c]l≥idavnai pivqeisa Ferrari 2005, 18 ║17.....].ela.[(III): ]i,su; d∆ eu\ ga;r oi\sqa (II): ]l≥elaq≥[ leg. Treu 1976, 205, rec. Ferrari 2005, 18 : ].elas≥[ leg. Voigt 1971, 82-83 : e[rx jouj ]l≥elavq≥[hn ajqavnatoi" e[st]i,su; d∆, eu\ ga;r oi\sqa Ferrrari 2005, 18 ║18
.]rot≥hvnneme[ (III): ]evteita±[.;]l≥le..(II): fort. k]rovthn D'Alessio apud Ferrari 2005, 18, 22
: k]rovt≥hn Nevme[sin kh'non o]" ai\scr∆ oi \de kr]evtei t jaj[o]l≥levw≥n≥ Ferrari 2005, 18
║19 Yavpfoi, sefivl[ (III): ]kl≥as[ (II): se fivl[hmmV Diehl1 1923, 360 : Yavpfoi,
se fivl[hs∆ e[xoca kallivqrono" jAfrodivta] West 2005, 2 : yavpfoi, se fivl[eis∆ ajmf∆ ojcevess∆ h[rmose kuv]kl≥a s[oiv te Ferrari 2005, 18 ║ 20
Kuvprwi≥b≥[.]sivl[ (III), leg. et suppl. Hunt 1922, 33 : ]mna– (IV): Kuvprw leg. Lobel 1925,
30: b≥[a]sivl[h(a) Snell : sev]mna Snell, rec.West 2005, 2, Ferrari 2005, 18 : Kuvprw b[a]sivl[h∆ ejnnaliva" ojlbodovterra sev]mna West 2005, 2 : Kuvprw b[a]sivl[h∆ h\lq∆ ijketeuvoisa Div∆ ai\ya sev]mna Ferrari 2005, 18 ║21 fieri posse ut
paragraphos sub v. 21 deperdita esse censuit Hunt 1922, 43 kavitoimevgad.[ (III): ].kat≥e.[ (IV): kaiv toi Fränkel 1928, 269 : kaivtoi Lobel-Page 1955, 46, Voigt
1971, 82-83 dw'≥[ron Fränkel 1928, 269 ].kat≥eg≥[ Voigt 1971, 81-82
kaiv toi mevga dw'≥[ron Kronivdai" Ûo]i'≥ kat≥evn≥[eus jojpavsdhn Ferrari 2005, 18
║ 22 ]ssoisfaevqwn[ (III), dist. et suppl. Hunt 1922, 33 : ]..k[(IV): ]k≥ek[ leg.
Lobel 1925, 31 : o[]ssoi" Faevqwn[ interpr. Hunt 1922, 33, Wilamowitz 1931-1932, II,
111 n. 1, al. : o[]ssoi" faevqwn[ jajevlio" Fränkel 1928, 269 : o[]ssoi" faevqwn[ jAevlio" fevggesin ajmfib]a≥vs≥k[ei West 2005, 2, rec. Ferrari 2005, 18
║23 pa;ntai– (III): pavn corrig. esse vidit Lobel 1925, 30 [e[slon Diehl
1 1923, 360 ejpivkesq(ai) Ferrari 2005, 18 ║24 kavi
ejnn = eijn epicum Voigt 1971, 83 jAcevr[onto" Diehl1 1923, 360
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
191
Secondo la Voigt (1971, 97) il fr. 65 V. di Saffo, corrispondente, nella nostra ode ai vv.
15-25 sarebbe suddiviso in strofi tristiche e non distiche come il resto dei frammenti
numerati come POxy. 1787. E la studiosa esprime lo stesso parere anche per il fr. 86,
corrispondente ai vv. 1-8 della nostra ode. Per quanto attiene al solo fr. 65 la Voigt
pensò di poter leggere una paravgrafo" sotto il v. 6, precedente a quella, di lettura
certa, posta sotto il v. 9. Nel caso la paravgrafo" fosse davvero posta tra i vv. 20 e 21,
il v. 20 dovrebbe risultarne più breve, visto che la struttura metrica presupposta dalla
Voigt e documentata, a quanto sembra, da Sapph. DV lV = 88 V., prevede che il terzo
verso di ogni strofe contenga un coriambo in meno degli altri due. Ciò è impossibile
perché, come ha notato West, il fr. 66c dovrebbe testimoniare la parte finale di tre versi
in sequenza, tutti della stessa lunghezza. Per Ferrari la collocazione della paravgrafo"
tra il v. 6 e 7 è sbagliata e, anche nel caso fosse confermata, si potrebbe spiegare
benissimo come frutto di un errore: notare come entrambi i versi, il 20 ed il 21 (= 6 e 7),
cominciano con la stessa lettera, un k.
Eduard Fraenkel, nel lontano 1942, aveva tentato di combinare303
insieme i fr. 60 e 86V.,
ma questa proposta non ebbe seguito, così che non fu accolta né nell'edizione Lobel-
Page, né in quella di Eva-Maria Voigt: tuttavia, per il Ferrari304
, è altamente probabile,
perché produce uno sviluppo tipico della preghiera greca ed inoltre perché la tematica e
l'andamento del testo che viene così alla luce sono molto simili alla famosissima Ode ad
Afrodite [= Sapph. 1 V.], il componimento con il quale forse si apriva l'edizione
alessandrina di Saffo: abbiamo la richiesta di una liberazione dagli affanni e la promessa
della dea. Già il Lobel, invece, aveva ipotizzato una combinazione tra il fr. 65 ed il 66c:
West305
ha recentemente riportato in auge questa ipotesi, "dimenticandosi" però di
evidenziare con una forte sottolineatura il fatto che quella via già era stata proposta dal
Lobel diversi decenni prima. La restituzione operata da Ferrari è avvenuta in due
momenti diversi. In un primo momento, concretizzatosi, nel 2005, nella pubblicazione di
un articolo su «MD», Ferrari ha cercato, con ottimi risultati, di combinare insieme, oltre
ai fr. 86 e 60, anche il 65 e, conseguentemente, il 66c: ciò che viene fuori da questa
303
Fraenkel 1942, 54-56. 304
Ferrari 2005, 15-17 305
West 2005, 1-3
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
192
combinazione è possibile apprezzarlo alle p. 17-18 del suo contributo (Ferrari 2005, 17-
18): un'ode di ben ventiquattro versi, purtroppo in gran parte lacunosi, ma comunque
unitari dal punto di vista tematico: una preghiera di Saffo ad Afrodite e la promessa che
la dea colpirà "colei che confida nella vita lussuosa", cioè Andromeda. Le ragioni di
questo lavoro di sovrapposizione e di ricostruzione sono ben evidenziate dal suo autore:
essendo tutti i componimenti del POxy 1787 nello stesso metro ( hipp2cho
), non è
possibile che tre odi diverse, ma comunque pertinenti alla stessa tematica dell'ode
incipitaria e tra loro accomunati dallo stesso metro, "passassero inosservate" davanti agli
occhi degli eruditi antichi; il contatto diretto con una tematica già da tempo conosciuta
grazie a Sapph. DV laV fr. 1 col. III, 12-18 = 90, col. III, 12-18, ovvero il contrasto
insanabile con Andromeda, a causa del quale Saffo si rivolge a Cipride; l'accordo tra
prolivpoisa K[uvpron del fr. 86, 6 V. (v. supra v. 6) e Kuvprw b[ ≥a]sivl[h(a) del fr. 65, 6
(v. supra v. 20); sul piano materiale, la congruenza tra due frammenti papiracei (POxy.
1787 fr. 4, 1-5 = 65, 1-5 V. e PHal. 3, 7-11= 60, 7-11 V.).
In un secondo momento, successivo alla pubblicazione dell’articolo del 2005, Enzo
Puglia, un papirologo collaboratore di Ferrari, ha sottoposto a quest’ultimo altre ipotesi
di combinazione che lo studioso ha provveduto a recepire ed a darne notizia, fornendo
così una nuova ipotesi di restituzione, apparsa nel saggio che lo stesso Ferrari ha
pubblicato nel 2007 (Ferrari 2007a, 62-64). La nuova restituzione diverge non poco dalla
precedente e non solo per aver aumentato il numero dei frustoli coinvolti nel collage. I
meriti precedenti si son trasformati in demeriti. Combinando i frustoli in questo modo
nuovo, lo studioso ha omesso del tutto le poche, ma evidenti, tracce del verso iniziale
dell’ex frammento 65 Voigt, che Lobel proponeva di leggere ]p≥u≥f≥a[ e che lo stesso
Ferrari, nel primo tentativo di restituzione, proponeva di integrare e[gwou[ s∆] aj≥p≥u≥vf≥a[im∆
(la fase va attribuita ad Afrodite, ma v. infra). Si tratta, certo, di una serie di caratteri di
lettura ostica e nondimeno essi sono presenti sul papiro e, dunque, bisogna tener conto
anche di essi. A questo punto c’è da chiedersi se la presenza di una tale sequenza di
lettere possa in qualche modo inficiare la seconda restituzione di Ferrari. Inoltre Puglia
propone, al v. 20, un’integrazione che riteniamo improbabile, ma cfr. ad loc.
Per tutte queste ragioni, abbiamo deciso di riprodurre il testo proposto da Ferrari (2005,
17-18), quello che risulta più ragionevole.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
193
1 Sarebbe, per il Ferrari (2005), il verso finale del componimento precedente. Il
nuovo collage proposto da Ferrari (2007a, 62-63) costringerebbe a considerare questo
verso come il primo di quest’ode. Forse ajkavlan≥ (suggerito, oltre che dalla posizione
dell'accento e dal contesto metrico, anche dalle tracce poste sul papiro) accusativo
singolare o genitivo plurale. Si cfr. Hes. fr. 339.1-3 ajkala; prorevwn (o procevwn) "che
scorre placidamente" (di un fiume) e Sapph. 43.5 a[kala klovnei "agita dolcemente"
(forse del vento che "agita" le foglie?). Si tratta di un aggettivo tratto dalla radice i.e.
*sēk-, donde l'avverbio hj~ka "lievemente", l'aggettivo greco h[kalo" (che assume lo stesso
significato di a[kalo" in Call. fr. 198 jArgwv kot∆ ejmpnevonto" h[kalon novtou "Argo
una volta, mentre placidamente soffiava noto") e quello latino seg-nis (<*sec-nis)
"debole, fiacco, lento".
2 Al verso 2, secondo il Ferrari, comincerebbe un nuovo componimento. Il Ferrari
ritiene giusta la congettura del West, ovvero Divo" ejx ]aijgiovcw lav[coisa. Per Divo"] ejx
aijgiovcw cfr. Alc. 343 V.: Nuvmfai, tai;" Divo" ejx aijgiovcw fai'si tetucmevnai"
"Ninfe, (voi) che dicono generate da Zeus egioco". Si cfr. anche Il. III 426b (al.) in
riferimento ad Elena di cui si dice che è kouvrh Dio;" aijgiovcoio "figlia di Zeus egioco".
La tessera Dio;" aijgiovcoio è attestata 14x nell'Iliade, 9x nell'Odissea e 10x in tutto
Esiodo.
aijgiovcw: è un genitivo eolico, corrispondente all'omerico aijgiovcoio. La lingua di Omero
utilizza tre desinenze, -oio (attestata regolarmente nelle tavolette micenee), *-oo (che
non è attestata, ma è restituibile) e -ou: quest'ultima è frutto della contrazione di *-oo ed
è comune anche ad altre varietà come, ovviamente, lo ionico e l'attico. Sulla contrazione
di *-oo si pone anche la desinenza lesbia –w. La desinenza –oio deriva da *-osyo,
mentre quella restituita *-oo si posa su *-oso: sono probabilmente entrambe di origine
pronominale e, più semplicemente, potrebbero ambedue derivare da una desinenza
originaria *–osyo, donde in greco comune *-oyo: lo yod avrebbe avuto un diverso
trattamento a seconda se pronunciato o no geminato.
Tale aggettivo è composto da due radici: quella di aijgiv" "egida" e *wegh- (>*Ûoco"),
la stessa del latino ueho e del tedesco Wagen: il significato è, quindi, "che brandisce
l'egida". Una descrizione dell'egida la dobbiamo all'autore dell'Iliade (V 738-42: ajmfi;
d∆ a[r∆ w[moisin bavlet∆ aijgivda qussanovessan / deinhvn, h}n peri; me;n pavnthi
Fovbo" ejstefavnwtai, / ejn d∆ [Eri", ejn d∆ jAlkhv, ejn de; kruovessa jIwkhv, / ejn dev
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
194
te Gorgeivh kefalh; deinoi'o pelwvrou / deinhv te smerdnhv te, Dio;" tevra"
aijgiovcoio "Sulle spalle gettò l'egida ornata di frangia, / terribile, cui tutt'intorno si
dispongono a corona il Terrore, / la Lotta, la Violenza, l'Inseguimento agghiacciante, il
capo della Gorgòne, terribile, spaventoso, portento di Zeus egioco"), mentre Erodoto
(IV 189: ejk de; tw'n aijgevwn toutevwn aijgivda" oiJ {Ellhne" metwnovmasan "da
queste pelli di capra i Greci hanno derivato il nome di egida") ci riferisce l'etimologia
popolare del termine aijgiv".
Ferrari propone il confronto con Pi. O. XIV 1-5:
Kafisivwn uJdavtwn lacoi'sai ai{te naivete kallivpwlon e{dran, w\ lipara'" ajoivdimoi basivleiai Cavrite" jOrcomenou', palaigovnwn Minua'n ejpivskopoi, klu't∆, ejpei; eu[comai Voi che, avendo avuto in sorte le acque cefisie,
abitate una sede bella di puledri,
o celebrate Cariti regine dell'opulenta
Orcomeno, degli antichi Mini custodi,
udite, chè io vi prego.
In entrambi i passi si fa uso del verbo lagcavnw (coniugato al participio aoristo) in
riferimento alla divinità (o alle divinità) "destinatarie" dell'inno che "hanno ottenuto in
sorte" qualcosa che, comunque, è loro proprio (il Ferrari pensa ad un "onore sommo",
ma forse la sua ipotesi è troppo generica, soprattutto se si pensa a /
, per cui v. supra, e ad [Hom.] Hymn. VI 1ss.aijdoivhn, crusostevfanon, kalh;n
jAfrodivthn / a[isomai, h} pavsh" Kuvprou krhvdemna levlogcen / eijnalivh" "canterò
la veneranda, bella, Afrodite dall'aurea corona, / che ha ottenuto le mura di tutta la
marina Cipro"). In entrambi i passi, inoltre, si fa uso dell'imperativo del verbo kluvw e
del verbo eu[comai, ma soprattutto in entrambi gli inni la presentazione dell'oggetto
dell'invocazione (Afrodite in Saffo, le Cariti in Pindaro) viene ritardata (è al secondo
verso in Saffo, addirittura al quarto in Pindaro).
E cfr. Damag. A. P. VI 277 (= 1 G.-P.).1 [Artemi, tovxa lacou'sa kai; ajlkhventa"
oji>stouv" "Artemide, che hai ottenuto in sorte gli archi e le forti frecce", [Orph.] Hymn.
Proem. 11 ajfrogenhv" te qeav, megalwvnuma dw'ra lacou'sa "dea nata dalla schiuma
del mare, che hai ottenuto dono molto celebre".
Più genericamente, il verbo lagcavnw è attestato nel fr. 33.2 V.
ai[q je[gw, crusostevfan j jAfrovdita,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
195
tonde to;n pavlon ã......Ã lacoivhn
Magari ottenessi questa sorte,
o Afrodite dall'aurea corona.
ed anche in Sapph. DV dV 4, che già abbiamo analizzato, ma non in riferimento ad
alcuna divinità.
3 Per Kuqevrh∆, si confronti il commentarius di Sapph. DV laV fr. 1 col. II 5 = fr. 90a
col. II 5 V: il commentatore cita prima un passo di Saffo, dove si dice di Peithò che è
nutrice di Afrodite, Kuqerhva" trovfo", ma poi si accorge che altrove Saffo aveva detto
che Peithò ne era la figlia. Questo epiteto ritorna anche nel fr. 140.1, un vero e proprio
dialogo drammatico tra Afrodite ed un coro di ragazze:
- katqnavskei, Kuqevrh∆, a[bros∆ ―Adwni": tiv ke qei'men… - kattuvptesqe, kovrai, kai; katereivkesqe civtwna".
- Muore, Citerea, il delicato Adonis: che faremo?
- Percuotetevi il petto, fanciulle, e laceratevi la tunica.
Tale epiteto deriva dal fatto che sull'isola di Citera (davanti al Golfo Laconico, al largo
di Capo Malèa, a metà strada tra la costa del Peloponneso e quella dell'isola di Creta) vi
era un antico santuario dedicato a Cipride: v. nota al v. 6.
Kuqevreia è accompagnato dall'aggettivo eujstevfano" "bella corona" 2x nell'Odissea
(VIII 288 e XVIII 193) e 2x nella Teogonia (vv. 196 e 1008), da ijostevfano" in [Hom.]
Hymn. VI 18, da kuprogenhv" in [Hom.] Hymn. X 1, mentre l'epiteto del sostantivo
jAfrodivth (al vocativo) è crusostevfan(e) nel fr. 33, 1 (ed anche in [Hom.] Hymn. VI
1): epiteti come eju>stevfane o, ancor meglio, crusostevfan(e) o ijostevfan(e) (per il
quale cfr. l'aggettivo ijovkolpo" di cui già abbiamo parlato nel commento al fr. gV) ben si
adattano alla sequenza iniziale di un parasclepiadeo maggiore: è, quindi, lecito ipotizzare
che il verso 1 o il 2 iniziasse con uno di questi epiteti, o similia.
Ferrari propone di integrare e≥u≥jcom≥[evnai m∆a[rhxon, per cui cfr. Aeschl. Sept. 116-117
ajll∆, w\ Zeu' pavter pantelev", / pavntw" a[rhxon dai?wn a{lwsin "Ma, o Zeus, padre
che tutto compi, salvaci in ogni modo dai nemici e dalla conquista"; Eur. HF. 494-496
a[rhxon, ejlqev: kai; skia; favnhqiv moi: "vieni a soccorrerci e mostrati a me anche
ombra" riferito ad Eracle ed Eur. Cycl. 350-351 w\ Pallav", w\ devspoina Diogene;"
qeav, / nu'n nu'n a[rhxon "O Pallade, o dea, signora figlia di Zeus, soccorrici ora, ora".
4 Per l'integrazione provfr]on∆ e[coisa qu'mo[ vn del Fraenkel, cfr. Alc. 129, 9-11 V.:
eu[noon / qu'mon skevqonte" ajmmetevra" a[ra" / ajkouvsate "con animo benevolo
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
196
ascoltate le nostre preghiere". Si cfr. anche qumw'i provfroni 3x nell'Iliade (VIII 40,
XXII 184 e XXIV 140), 1x nell'Odissea (XVI 257) e 2x nella Teogonia (vv. 536 e 661),
come anche Aeschl. Suppl. 349 klu'qiv mou provfroni kardivai (e kl]u'qiv viene
integrato dal Fraenkel al v. 5 del componimento qui in esame). Diehl (1944, 8) propose
di integrare, invece, i[lla]on e[coisa qu'mo≥[n], per il quale invitava a confrontare [Hom.]
Cer. 204 i{laon scei'n qumovn “avere il cuore propizio”.
5 Già il Maas ed il Fraenkel306
(il secondo per avvalorare la sua integrazione)
invitavano al confronto tra l'espressione kl]u'qiv m ja[ra" e quella di Od. IV 767:
w}" eijpou's∆ ojlovluxe, qea; dev oiJ e[kluen ajrh'".
Così detto gridò, la dea ascoltò la preghiera.
p[ota è un'integrazione del Lobel, mentre kajtevrwta è del Fraenkel. Per l'espressione
ai[ p[ota kajtevrwta si confronti la medesima espressione di Sapph. 1.5 V. (ai[ p[ota
kajtevrwta "se mai un'altra volta…"): è un modulo tipico della preghiera greca, come
risulta chiaro dal confronto con Alc. 38a.11 ai[ pota ka[llota "se mai un'altra volta",
Soph. OT. 164 sgg., in riferimento ad Atena, Artemide ed Apollo,
ei[ pote kai; protevra" a[ta" u{per ojrnumevna" povlei hjnuvsat j ejktopivan flovga phvmato" e[lqete kai; nu'n
se mai un'altra volta rintuzzaste
la rovinosa fiamma
del male sorto per la città,
venite anche ora.
e Aristoph. Th. 1157sgg.: Eij provterovn pot j ejphkovw / h[lqeton, ãkaiÃ; nu'n ajfivke-
/sqon, iJketeuvomen, ejnqavd∆ hJmi'n "se mai altra volta veniste ad ascoltarci, anche ora
venite qui da noi, vi preghiamo". E si noti anche la struttura fissa "se mai altra
volta…anche ora", per cui si cfr. fr. Sapph. 1.5-25 V. ai[ pota kajtevrwta...e[lqe moi
kai; nu'n: è quindi ipotizzabile, in base all'integrazione del Lobel ed a quella del
Fraenkel, che anche in questo secondo Inno ad Afrodite Saffo chiedesse alla dea di
venire da lei anche in quel momento.
306
Fraenkel 1942, 54-56.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
197
6 Per l'espressione prolivpoisa K[uvpron, si confronti pavtro" de; dovmon livpoisa
"avendo abbandonato la casa del padre" di Sapph. fr. 1.7 V. e la nota al verso
successivo di questo componimento, ma anche Hor. Carm. I 30.1-2a
O Venus, regina Cnidi Paphique,
sperne dilectam Cypron…
O Venere, regina di Cnido e di Pafo,
sprezza la prediletta Cipro…
Tale modulo ritorna, quindi, più volte per indicare la partenza della dea Afrodite che
abbandona una sede a lei congeniale per presentarsi a Saffo. E si confronti anche Alcm.
55 Page:
Kuvpron iJmerta;n lipoi'sa kai; Pavfon perirruvtan
Avendo abbandonato la cara Cipro e Pafo bagnata dal mare… E questo modulo viene usato non solo in riferimento a Cipride, ma anche ad altre
divinità: cfr. Alc. 34.1 V., na']son Pevlopo" livponte[" "avendo lasciato l'isola di
Pelope", un'invocazione ai Dioscuri, Castore e Polluce, protettori dei naviganti, affinché
essi vengano in soccorso ad Alceo, rimasto vittima di un naufragio.
Cipro è, per tradizione, la sede e l'isola di nascita della dea Afrodite. Per la connessione
tra Cipro (in particolare la località di Pafo) ed Afrodite, si cfr. Sapph. fr. 35 V., dove il
pronome se indica probabilmente proprio Cipride:
h[ se Kuvpro" h] Pavfo" h] Pavnormo" Te o Cipro o Pafo o Panormo…
E cfr. Aeschl. fr. 463 N.2 ( = 744 Mette = 402 a Radt)
Kuvprou Pavfou t∆ e[cousa pavnta klh'ron
Che governa tutto il territorio di Pafo e di Cipro307
…
Sappiamo, infatti, che a Pafo, dell'isola di Cipro, vi era un tempio dedicato alla dea
Afrodite, per cui si cfr. Od. VIII 359 sgg.:
w}" eijpw;n desmo;n ajnivei mevno" jHfaivstoio. tw; d j ejpei; ejk desmoi'o luvqen, kraterou' per ejovnto",
307
Meineke ha però proposto di attribuire questo frammento (tradito, così come Alcm. 55 Page, da Str.
VIII 340 = CUF VIII,3,8) ad Archiloco e non ad Eschilo.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
198
aujtivk j ajnai?xante oJ me;n Qrhvikhnde bebhvkei, hJ d j a[ra Kuvpron i{kane filommeidh;" jAfrodivth, ej" Pavfon, e[nqa tev oiJ tevmeno" bwmov" te quhvei".
Così detto, la forza d'Efesto scioglieva la catena,
e i due, liberi dalla trappola, sebbene possente,
subito, balzati su, uno andò in Tracia,
l'altra, invece, Afrodite che ama sorridere, andò a Cipro,
a Pafo, dove ci sono un tempio ed un altare odoroso.
Questo passo funge da modello evidente per Hymn. Ven. 58-59, dove abbiamo la ripresa
di un intero verso:
ej" Kuvpron d jejlqou'sa quwvdea nho;n e[dunen, ej" Pavfon: e[nqa dev oiJ tevmeno" bwmov" te quwvdh".
Giunta a Cipro, entrò nel tempio odoroso,
a Pafo: dove ci sono un tempio ed un altare odoroso.
Cfr. anche Verg. Aen. I 415-417, in riferimento ad Venere, un passo non richiamato
dalla Voigt e dal Ferrari:
Ipsa Paphum sublimis abit, sedesque reuisit
laeta suas, ubi templum illi centumque Sabaeo
ture calent arae sertisque recentibus halant.
Lei stessa in alto s'invola verso Pafo e lieta rivede
le sue dimore, dove il tempio e cento altari per lei
ardono d'incenso sabeo e profumano di fresche ghirlande.
Per l'origine del culto di Afrodite e per la fondazione del tempio di Pafo, cfr. Hdt. I 105,
2-3 e Paus. I 14.7:
oi} de; ejpeivte ajnacwrevonte" ojpivsw ejgevnonto th'" Surivh" ejn jAskavlwni povli, tw'n pleovnwn Skuqevwn parexelqovntwn ajsinevwn, ojlivgoi tine;" aujtw'n uJpoleifqevnte" ejsuvlhsan th'" oujranivh" jAfrodivth" to; iJrovn. e[sti de; tou'to to; iJrovn, wJ" ejgw; punqanovmeno" euJrivskw, pavntwn ajrcaiovtaton iJrw'n o{sa tauvth" th'" qeou': kai; ga;r to; ejn Kuvprw/ iJro;n ejnqeu'ten ejgevneto, wJ" aujtoi; Kuvprioi levgousi, kai; to; ejn Kuqhvroisi Foivnikev" eijsi; oiJ iJdrusavmenoi ejk tauvth" th'" Surivh" ejovnte".
Ma essi quando, ritirandosi, furono nella città di Ascalona di Siria, mentre la maggior
parte degli Sciti attraversarono innocui, pochi di loro, rimasti indietro, saccheggiarono il
tempio di Afrodite Urania. Questo santuario è, per quanto abbia io scoperto essendomi
informato, il più antico tra i templi di questa divinità: e difatti il tempio che è a Cipro è
derivato da quello di qui, come dicono gli stessi Ciprioti, ed anche quello di Citera lo
edificarono i Fenici, i quali sono di quella parte della Siria.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
199
plhsivon de; iJerovn ejstin jAfrodivth" Oujraniva". prwvtoi" de; ajnqrwvpwn jAssurivoi" katevsth sevbesqai th;n Oujranivan, meta; de; jAssurivou" Kuprivwn Pafivoi" kai; Foinivkwn toi'" jAskavlwna e[cousin ejn th'i Palaistivnhi, para; de; Foinivkwn Kuqhvrioi maqovnte" sevbousin: jAqhnaivoi" de; katesthvsato Aijgeuv", auJtw'i te oujk ei\nai pai'da" nomivzwn - ouj gavr pw tovte h\san - kai; tai'" ajdelfai'" genevsqai th;n sumfora;n ejk mhnivmatoj th'" Oujraniva". Nelle vicinanze c'è il tempio sacro di Afrodite Urania. Primi tra gli uomini, gli Assiri
istituirono il culto di Urania; dopo gli Assiri, gli abitanti di Pafo di Cipro e i Fenici che
abitano ad Ascalona, in Palestina; e gli abitanti di Citera la venerano, avendo appreso dai
Fenici. Tra gli ateniesi, Egeo, pensando di non avere figli – infatti allora ancora non ne
aveva– e che alle sorelle era accaduta una disgrazia a causa del risentimento di Urania,
ne istituì il culto.
E cfr. anche Tac. Hist. II 3: Conditorem templi regem Aeriam vetus memoria, quidam ipsius deae nomen id
perhibent. fama recentior tradit a Cinyra sacratum templum deamque ipsam conceptam
mari huc adpulsam; sed scientiam artemque haruspicum accitam et Cilicem Tamiram
intulisse, atque ita pactum ut familiae utriusque posteri caerimoniis praesiderent. mox,
ne honore nullo regium genus peregrinam stirpem antecelleret, ipsa quam intulerant
scientia hospites cessere: tantum Cinyrades sacerdos consulitur. hostiae, ut quisque
vovit, sed mares deliguntur: certissima fides haedorum fibris. sanguinem arae obfundere
vetitum: precibus et igne puro altaria adolentur, nec ullis imbribus quamquam in aperto
madescunt. simulacrum deae non effigie humana, continuus orbis latiore initio tenuem in
ambitum metae modo exurgens, set ratio in obscuro.
Un’antica tradizione sostiene che il re Aeria fu il fondatore del tempio, alcuni riferiscono
che questo è il nome della stessa dea. Una notizia più recente tramanda che il tempio fu
consacrato da Cinira qui dove la stessa dea, generata dal mare, fu condotta a riva; ma
sostiene che la dottrina e l’arte degli auruspici fossero state importate e che il cilicio
Tamira le avesse portate e così fosse sancito che i discendenti di entrambe le famiglie
sovraintendessero ai riti sacri. Poi, affinchè la stirpe regia non eccellesse per alcun onore
su quella straniera, gli ospiti cessarono da quella dottrina che avevano introdotto: viene
consultato soltanto il sacerdote erede di Cinira. Le vittime son quelle che ciascuno ha
offerto, ma vengono scelti solo i maschi: fermissima è la fiducia sulle viscere dei
capretti. È vietato spargere sangue sull’ara: gli altari vengono onorati con preghiere e
fuoco puro, né sono bagnati di alcuna pioggia, benché alla porta. Il simulacro della dea
non è di effigie umana, è un blocco circolare continuo con una base più ampia ed
assottigliato man mano che si solleva verso l’alto come un cono, ma la ragione è incerta.
Diehl (1944, 8) proponeva, invece, la costruzione con il genitivo ed integrava ejravnn]a"
prolivpoisa K[vuvprw, fornendo tutta una serie di paralleli in cui ejrannov" è utilizzato per
toponimi, ma l’accusativo sembra qui da preferire, dato che esso è presente in paralleli
ben più vicini a questo passo saffico.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
200
7 Il Ferrari ha proposto di integrare h\lqe]", per cui si cfr. fr.1.7-8: pavtro" de;
dovmon livpoisa /... h\lqe" "lasciata la casa del padre, /…venisti": la dea, dopo aver
abbandonato la sua sede, si presenta a Saffo. Quanto a ijwv[an, invece, essa è
un'integrazione del Gallavotti. Nell'epica è attestata, in clausula, l'espressione h[luq∆ ijwhv
("giunse il grido"), cfr. Il. X 139 ed Od. XVII 261.
La preposizione pedav è caratteristica del dialetto eolico e corrisponde, in qualsiasi
contesto, all'attico metav da cui ha anche, probabilmente per analogia, tratto l'accento
sull'utima sillaba: deriva dalla radice apofonica pd- al grado e: cfr. i.e. *pd-/ped-/pod-,
gr. pouv", podov", lat. pēs, pĕdis, ingl. foot e ted. Fub. Il senso originario dovrebbe essere
stato "sulle tracce di", per cui si impone il collegamento con l'arm. y-et, z-het "dopo"
derivati da het "traccia, orma": l'armeno infatti è l'unica lingua indoeuropea, se si
escludono, ovviamente, le lingue germaniche, a presentare, a livello fonetico, una
rotazione consonantica (per cui i.e.*p- > arm. h- e i.e. *-d->arm. -t-).
Sembra esserci un rapporto voluto tra h\lqe"] ped∆e[man ijwv[an e peda; qu'mon ai\ya del
v. 13 (entrambi in clausula) con il quale si concluderebbe l'intervento di Saffo (dal v. 14
a parlare è Afrodite, almeno secondo l'opinione di Fränkel e Wilamowitz).
8 Le prime due lettere tradite dal testimone sono, forse, ]h≥n o ]i≥n. calevpai, con
l'accento ed il segno di lunga posti dallo scriba, non può che essere un dativo, altrimenti
avremmo avuto, al nom. plur. cavlepai. Per l'espressione cfr. Sapph. 1.25-26 ...calevpan
de; lu'son / ejk merivmnan "liberami dai tormentosi affanni".
9 Inizia qui il testo riportatoci dal fr. 60.
10 La sequenza qevl∆†wntapaivsan† (]qevl∆wvnta±pavisa±n sul papiro) è piuttosto
ostica, perciò il Ferrari la mette tra cruces. L'isolamento di qevl∆ è garantito
dall'apostrofo posto dallo scriba (facilmente si potrebbe integrare ej]qevl∆). Già
nell'edizione Lobel-Page si era provato a dividere wvnta±pavisa±n in w\n t j†ajpaivsan†:
l'unica opposizione ci viene dal segno di vocale breve presente sul papiro per la
desinenza del genitivo plurale femminile, che dovrebbe essere lunga. Il Ferrari nota che
vi è una palese contraddizione in termini tra la compresenza dell'accento acuto ed il
segno di vocale breve: vocale lunga accentata oppure dittongo accentato in penultima
posizione prima di vocale breve richiedono l'accento circonflesso. Lo scriba del papiro,
in altri casi, è stato molto diligente: l'accento circonflesso è presente, ad es., su ai\ya al
v. 13 (ai'ya sul papiro), su eu\ al v. 17 (eu' il papiro) e, molto probabilmente, anche su
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
201
qu'mon al v. 13, anche se qui abbiamo un guasto sul testimone. Data la presenza
dell'accento acuto su pavi è verosimile ritenere che l'errore consista solo nella notazione
della quantità vocalica (breve invece di lunga): siamo in sillaba finale e, ai fini metrici,
l'essere una sillaba breve o una lunga è indifferente, poiché indifferens è la quantità
dell'ultima sillaba di un parasclepiadeo maggiore. Per la Voigt (e per il Ferrari) w\n
sarebbe la forma eolica dell'avverbio attico ou\n (inesatta è, invece, l'annotazione della
Voigt "w\n = ou\n nusquam nisi hic ap. S. et Alc."308
, poiché tale forma eolica è attestata
anche in Alc. 48.8, dove ]k≥w'n del papiro sarebbe da interpretare come ]k≥∆w\n). w\n per
ou\n è comunque attestato per i dialetti dorici ed ionici (cfr. e. g. Pi. P. III 82 ed Hdt. III
80,1).
11 tev]l≥eson è un'integrazione di Hunt, a cui Ferrari antepone tw\mon "il mio
pensiero, il mio desiderio." Per tw\mon tev]l≥eson novhmma si confronti Sapph. 1, 26 V.
sgg....o[ssa dev moi tevlessai / qu'mo" ijmevrrei, tevleson... "…tutto ciò che il mio
animo brama che si avveri, avveralo tu…"; Sapph. 5, 3 V. kw[ssa Û]o≥i≥ quvmwãià ke
qevlh gevnesqai / pavnta te]levsqhn "che si avveri tutto ciò che vuole nel suo animo
avvenga"; Sapph. 41, 1 tai;" kavlais j u[mmin ãto;Ã novhmma tw\mon / ouj diavmeipton
"Per voi belle, il mio pensiero non potrà cambiare…"; Alc. 361 aij dev k∆a[mmi Zeu'"
televsh novhma "se Zeus ci porta a compimento il progetto", Il. X 104 sgg. ou[ qhn
{Ektori pavnta nohvmata mhtiveta Zeu;" / ejktelevei "certamente il saggio Zeus non
porterà a compimento per Ettore tutti i piani"e XXIII 149b su; dev oiJ novon oujk
ejtevlessa" "ma tu non hai compiuto il suo desiderio".
12 L'azione dell'invocare è indicata con lo stesso verbo kavlhmmi anche nell'Ode ad
Afrodite (Sapph. 1, 15 V.):
h[re jo[tti dhujjjjjjjjjjjjj~te pevponqa kw[tti dhujjjjjjjjjjj~te kavlhmmi Mi domandasti di cosa di nuovo soffrivo e perché
di nuovo t'invocavo.
13 È l'ultimo verso in cui a parlare è Saffo, secondo l'ipotesi portata avanti dallo
Schadewaldt. Ferrari integra moi]. Sembra, come abbiamo detto, esserci un rapporto
voluto tra moi] peda; qu'mon ai\ya e ped∆ e[man ijwv[an del v. 7. Per peda; qu'mon ai\ya
cfr. Il. XV 51 sgg. twv ke Poseidavwn ge, kai; eij mavla bouvletai a[llh/, / ai\ya
308
Ugualmente in Hamm 1958, 115 (w\n: nur S.84.2 [=60.2V])
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
202
metastrevyeie novon meta; so;n kai; ejmo;n kh'r "in tal modo Poseidone, anche se
piuttosto volesse altrimenti, / subito cambierebbe pensiero, secondo il tuo ed il mio
volere!"
14 Il breve commento steso da Ferrari a corredo della prima resituzione di questo
verso309
presenta, a quanto sembra, un’imprecisione non da poco; afferma, infatti,
Ferrari: “che a partire di qui cominciasse a parlare Afrodite aveva intuito Schadewaldt”.
Se “aveva intuito Schadewaldt” significa “aveva intuito per la prima volta Schadewaldt”
l’errore è evidente, perché già Fränkel, nel 1928, aveva esposto questa ipotesi; egli,
infatti, nel recensire le edizioni di Lobel dei lirici eolici degli anni Venti del secolo
scorso, dà inizio alle sue considerazioni su questo carme dicendo: “Jemand – gewiß
Aphrodite – verheißt der Dichterin, daß sie auch im Totenreich nicht vergessen werden
wird”. A questo proposito, occorre muovere qualche critica anche alla Voigt (1971, 83):
nel suo apparato è possibile leggere “Wil., GldHell. 2, 1111, H. Fränkel ’28, 269, al.
Venerem loqui put.”: occorrerebbe esporre i vari contributi critici in ordine cronologico
e non vi è alcun dubbio, in questo caso, che la palma della scoperta vada attribuita ad
Hermann Fränkel310
. Dopo Fränkel viene sicuramente, in ordine di tempo, il Wilamowitz
(1931-1932, 111 n. 1), ma la formulazione della frase, ovvero “Fr. 110 hat auch
Aphrodite gesprochen, wohl auch 68, in dem faevqwn Helios ist”, denuncia una palese
dipendenza da Fränkel. Lo Schadewaldt (1950, 94s.) rientra, piuttosto, tra gli alii di cui
parla la Voigt. L'ipotesi del Fränkel, accettata dal Ferrari, è confermata dalla lettura
]p≥u≥f≥a[ del Lobel: cfr. verso successivo.
15 Da questo verso in poi, il testo ci è riportato anche dal fr. 65. ]p≥u≥f≥a[, come già
abbiamo detto, è la lettura del Lobel, mentre il fr. 60 ci riporta ga;]r e[moi mavcesqa[i
(ga;]r è una congettura di Hunt): il Ferrari ha integrato e[gwu[ s j]ajp≥u≥vf≥a[im jau\ta
lavchn: ouj ga;]r e[moi mavcesqa[i. Forme in sinalefe come qui e[gwuj (e[gw ouj) sono
caratteristiche della lingua di Saffo: si confronti, ad es. e[gwujk di Sapph. DV zV 2 = 71,
2 V. Il senso dei versi 15 e 16 è che Saffo non ha bisogno di combattere "contro
Afrodite", ma neanche come alleata di Afrodite (perciò Ferrari non accetta la congettura
309
Ferrari 2005, 21 n. ad v. 14. 310
L’articolo di Hermann Fränkel è stato pubblicato nel 1928, mentre la prefazione alla prima edizione di
“Der Glaube der Hellenen” di Wilamowitz porta la data 1931. Il secondo volume de Der Glaube der
Hellenen, dove alla nota 1 della pagina 111 si trova la frase di nostro interesse, fu curato dagli editori,
anticipato da una Vorbemerkung des Herausgebers e pubblicato nel 1932: il filologo tedesco, infatti, era
morto il 25 settembre del 1931.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
203
dello Snell su;n ga;]r...mavcesqai): la dea concederà a Saffo ciò che desidera di buon
grado. Snell invece proponeva qualcosa che andava ben al di là del suvmmaco" e[sso di
1.28: nel fr. 1, infatti, era Afrodite ad essere alleata di Saffo, mentre, seguendo
l'integrazione dello Snell, qui risulterebbe il contrario, cioè sarebbe Saffo a porgere aiuto
alla dea, che, ovviamente, non ne aveva bisogno: invece il testo del Ferrari presenta una
situazione in cui Saffo non ha bisogno di combattere "contro Afrodite" (e[moi mavcesqa[i
"combattere contro di me"). Fin qui abbiamo parlato del primo tentativo di restituzione,
quello presentato da Ferrari (2005, 18). Il secondo tentativo, operato da Puglia e da
Ferrari (2007a, 62), ha recato, temiamo, esiti negativi: nel testo della nuova restituzione,
infatti, scompare del tutto il primo verso dell’ex fr. 65 V. Lobel, abbiamo appena detto,
leggeva ]p≥u≥f≥a[ e nella prima ipotesi di restituzione Ferrari aveva proposto delle
integrazioni che partivano dal testo letto da Lobel. ]p≥u≥f≥a[ nella nuova restituzione non
viene sostituito da qualche altra ipotesi di lettura, ma semplicemente scompare, come se
non fosse mai esistito e, quel che è peggio, come se il testo presentato dal fr. 65 V.
cominciasse al verso successivo: le tracce presenti sul frustolo non sono considerate,
l’ipotesi di lettura del testo presentato dal testimone del tutto sparite e non solo nel testo,
ma anche nell’apparato. L’operazione di Ferrari sembra, dunque, scorretta: per
dimostrare la veridicità della sua ipotesti fa scomparire dal testo l’intero primo verso di
un frustolo. Sono possibili, sic rebus stantibus, due possibilità: o è possibile aggiungere
anche ]p≥u≥f≥a[ (o qualsiasi altra sequenza di lettere sia presentata dal papiro al primo
verso dell’ex fr. 65 V.) al v. 20 del testo di Ferrari, oppure il secondo tentativo operato
da Ferrari perde, così, ogni suo fondamento e credibilità. È possibile, riteniamo,
aggiungere un’altra osservazione: se si accoglie il testo di Ferrari (2007a, 62), ga;]r e[moi
mavcesqai ed al verso successivo oujd∆ jA≥[nd]romevda, si creerebbe una situazione
paradossale, ovvero Andromeda che non combatte contro Afrodite, ma questo non
poteva, certo, essere il desiderio di Saffo e, nell’ideologia saffica, neppure quello di
Afrodite. Ferrari (2007a, 63), per risolvere il problema, traduce “infatti combattere con
me non può neppure Andromeda”, ovvero, riteniamo, “Andromeda non è in grado di
combattere contro di me, perché io sono una dea”: “può”, però, non è presente nel testo
greco, ma solo nella traduzione e non viene suggerito alcun supplementum che possa
risolvere il problema. Gli interventi di Ferrari e di Puglia non si fermano qui: il secondo,
infatti, propone di integrare pa;]r e[moi invece del ragionevole ga;]r e[moi di Hunt: pa;]r
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
204
e[moi non può che significare “secondo me, secondo la mia opinione”: scompare,
dunque il necessario complemento del verbo mavcesqai: “secondo me combattere /
neppure Andromeda” non ha, tuttavia, alcun senso, perché manca di un riferimento
imprescindibile per la comprensione. E, considerando solo il testo che abbiamo e
l’integrazione di Puglia, non vi è un’altra possibilità: il verbo mavcesqai non è mai
attestato con parav ed il verbo paramavcomai non è mai attestato in greco. E se proprio
volessimo accogliere le proposte di Puglia e di Ferrari si potrebbe pensare che il
necessario referente di mavcesqai fosse in lacuna, ma ancora una volta Ferrari e Puglia
non propongono alcuna integrazione (come se il problema non esistesse), sicchè il testo
di Puglia risulta incomprensibile ed ovviamente diverso da quello tradotto da Ferrari.
Difficilmente, inoltre, il referente di mavcesqai potrà essere in lacuna, ovviamente a
meno di ipotizzare un forte iperbato, ma non è necessario perché è già stata data un’altra
ipotesi che non crea alcun problema.
16 Con questo verso entra in scena apertamente l'antagonista di Saffo, Andromeda:
è un personaggio che già conoscevamo, di cui si parla, a parere di Ferrari, nel
commentario riportatoci da Sapph. DV laV fr. I col. III = 90a col. III V. (cfr. infra et ad
loc.), dove ai vv. 12-18 si fa riferimento a
ajge-]
rwvcou[" a[gan ejcouv-] sa" gevra"...
donne arroganti che possiedono in modo eccessivo un privilegio…
Tali donne sarebbero l'obiettivo di un carme di cui sappiamo che (fr. 90a col.III 26-27):
pro;"]
JAndromev]dhn gevgra[ptai
è stato scritto contro Andromeda.
Questo è quanto afferma Ferrari (2005, 16; 2007, 55-56), ma, come vedremo proprio a
riguardo di quel commentario, la presenza (evidente) di una coronide sembra contraddire
apertamente l’ ipotesi dello studioso: il carme “contro Andromeda” deve, dunque,
essere quello successivo alla coronide e non anche il precedente. Riconosciamo, quindi,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
205
che con l'espressione diaivtai c]l≥idavnai pivqeisa Saffo non poteva far riferimento che
ad Andromeda, di cui, ci informa Ateneo (I, 21 b-c), Saffo parla in maniera derisoria nel
fr. 57, di cui riporto qui il v. 1 ed il v. 3, gli unici citati dall'autore originario di Naucrati:
tiv" d∆ ajgroi?wti" qevlgei novon... oujk ejpistamevna ta; bravke j e[lkhn ejpi; tw;n sfuvrwn…
Chi è la rozza che ti ammalia la mente…
e non è capace di sollevare i suoi straccetti sopra le caviglie?…
Di Andromeda si parla anche in Sapph. DV iV 4sgg. = 68, 5 V. (cfr. infra), ove di lei si
dice (il testo seguente è stato così stabilito ed integrato da Ferrari stesso, cfr. infra e ad
loc.):
nu']n≥ dei\m ejÕ[pi; o[]õnivan [ ]Õa[san ajlivtrai≥ 5 ejpo]r≥somevnÕ[a su;n doj]õd≥uvn≥[aisjAn]Õdromevdan [uj]pavx[ei
ajpav]likujpa[Õ[rmujy]õimevdo[is]Õ [Ar[temi]" aj mavka[ir]a, aj d]o≥u≥jk≥ [aj]bavÕ[khn]õ ma;n≥ stev[r]Õe≥≥on de; trovpon a[ijs]cuvnhtai: ou[ti]" ga;r e[pauÕõ[s ].k[ ]Õk≥ovro≥n ouj kativsc≥ei.
Ma ora andrò slanciandomi contro la colpevole delle ansie e dei tormenti
e con dolori la beata Artemide che governa dall’alto condurrà
sotto il carro l’attempata Andromeda, sicchè lei si vergognerà
del suo carattere non quieto, ma duro:
nessuno, infatti, ha messo fine…non trattiene la sazietà.
Anche in Sapph. 130, 3 sgg. si parla di Andromeda:
―Atqi, soi; d∆e[meqen me;n ajphvcqeto frontivsdhn, ejpi; d j jAndrmevdan povthãià Ma tu, Attide, ti sei stancata di pensarmi
e voli verso Andromeda.
Così come pure in Sapph. 133, 1 in senso sarcastico ed ironico:
―Ecei me;n jAndromevda kavlan ajmoivban...
Andromeda ha avuto una bella ricompensa… Per tornare al testo, oi\a serve qui per introdurre una "indirect exclamation", secondo la
terminologia adottata dal LSJ (s. v. oi|o" A II 2): si cfr. ad es. Il. XXII 347 oi|a e[orga"
"per ciò che hai fatto"; VI 166 "il furore s'impadronì
del re, per ciò che aveva udito"; Od. XVII 479 oi|∆ ajgoreuvei" "per quello che dici";
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
206
Soph. OT. 701 oi|av moi bebouleukw;" e[cei"per ciò che ha (sc. Creonte) ordito contro
di me"
Hunt aveva già ipotizzato la presenza di jAnd]romev[ vda: Ferrari ha preferito l'accusativo,
dato l'infinito l≥elavq≥[hn da lui letto per il verso successivo.
Il sostantivo divaita ha il significato di "tenore di vita, stile di vita, modo di vivere": nel
gergo medico assumeva, invece, il senso più specifico di "regime alimentare, dieta",
appunto: perciò qui diaivtai c[l≥idavnai pivqeisa assume il significato di "confidando in
uno stile di vita lussuoso". Per diaivtai si cfr. Alc. 61, 12 V. ajmovcqhton e[c≥h≥n divaitan
"avere una vita senza pena"; Aeschl. Pr. 490-91 kai; divaitan h{ntina e[cous∆ e{kastoi
"ed il modo di vivere che ciascuno ha"; Soph. OC. 751a ptwcw'i diaivthi "con uno stile
di vita mendicante"; Hdt. I 157, 8 Ludoi; th;n pa'san divaitan th'" zovh" metevbalon
"i Lidi cambiarono tutto il loro stile di vita"; Xen. Cyr. I 3, 2 divaitai eujtelevsterai
"stili di vita più semplici". Per c]l≥idavnai (e non ]l≥idavnaãià come riportato
erroneamente dalla Voigt) si cfr., invece, Aeschl. Pers. 544a clidanh'" h{bh" tevryin
"piacere di una voluttuosa gioventù"; Eur. Cycl. 500 clidana'"...eJtaivra""della
voluttuosa compagna".
Il verbo eolico pivqhm(m)i corrisponde all'attico peivqw: per il valore intransitivo di questo
participio si cfr. Alc. fr. 43, 4 V. tav[i] prwtalivai pivqei"≥[ "confidando in questa
imbarcazione messa in acqua per la prima volta". L'integrazione pivqeisa[i o pivqeisa[n
proposta da Lobel-Page non viene accolta dal Ferrari.
17 Direttamente connessa con oi\a del v. 16 è l'intergrazione del Ferrari, cioè e[rx∆,
si cfr. Od. XXIII 312 a hjd∆ o{sa Kuvklwy e{rxe "e quello che fece il Ciclope"; Aeschl.
Ag. 1529 teivsa" a{per e[rxen "avendo pagato quel che ha fatto". lelavqhn è un infinito
aoristo II attivo eolico con raddoppiamento: una tale forma è attestata in Sapph. DV lV
11 = 88, 11 V. levlaq∆ ed in Alc. fr. 73, 8 lelavqwn. Per e[sti impersonale, integrato dal
Ferrari, cfr. Alc. fr. 140, 14 tw'n oujk e[sti lavqesq∆ "questo non è possibile
dimenticare". Per eu\ ga;r oi\sqa del Ferrari si cfr. Sapph. 19, 7 e]uj ga;r i[dmen (suppl.
Hunt); 94, 8 oij~sqa gavr e l'integrazione [i[ste de;] tou'to del Di Benedetto per il fr. DV
dV 3, per cui v. supra.
Per il motivo dell'impossibilità di sfuggire ai numi cfr. Il. XV 461 a ajll jouj lh'qe Dio;"
pukino;n novon "ma non sfuggì alla mente acuta di Zeus"; Hes. Op. 267 sgg. pavnta
ijdw;n Dio;" ojfqalmo;" kai; pavnta nohvsa" / kaiv nu tavd∆, ai[ k∆ ejqevlhis∆,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
207
ejpidevrketai, oujdev eJ lhvqei / oi{hn dh; kai; thvnde divkhn povli" ejnto;" ejevrgei
"l'occhio di Zeus, tutto vedendo e tutto notando, / anche questo, se vuole, scorge né gli
sfugge / quale è questa giustizia che la città dentro racchiude"; Sol. 13.27 aijei; d jou[
ejlevlhqe diamperev" (in riferimento a Zeus) "ma sempre nel tempo non dimentica";
Thgn. 143-144 Oujdei;" pw xei'non, Polupai?dh, ejxapavthsa" / oujd∆ iJkevthn qnhtw'n
ajqanavtou" e[laqen "nessuno, Polipaide, dopo aver tradito l'ospite / oppure un uomo
supplice ha evitato lo sguardo degli immortali"; Pi. O. I 63-64 eij de; qeo;n ajnhvr ti"
e[lpetaiv ti laqevmen e[rdwn, aJmartavnei "l'uomo, se, compiendo qualcosa, crede di
sfuggire il dio, si sbaglia"; Aeschl. Ch. 61 rJopa; d∆ejpiskopei' Divka" / tacei'a tou;"
me;n ejn favei, / ta; d∆ejn metaicmivwi skovtou / mevnei cronivzonta bruvei, / tou;"
d∆a[kranto" e[cei nuvx “ma la bilancia di Giustizia volge lo sguardo / presto su coloro
che sono nella luce, / ma ciò che al confine dell’oscurità / attende passando il tempo
germoglia, / mentre gli altri li tiene una notte vana”.
18 All'inizio di questo verso si legge (fr. 65.4).rothvnneme[, una sequenza ostica e
difficile da decifrare, ma è probabile che .rothvn sia un infinito eolico di qualche verbo
(l’unica traccia rimasta della prima lettera è un punto ed è verosimile un errore nella
posizione dell'accento posto sul papiro): il Ferrari accetta l'ipotesi già fatta da Giovan
Battista D'Alessio, il quale propone di leggere k≥rovthn (att. krotei'n "colpire") ed,
inoltre, congettura Nevme[sin o, comunque, nevme[sin. L'uso di questo verbo per indicare
il "colpire qualcuno" è piuttosto raro (cfr. Plut. Mor. 10d tou'ton...krovthson “colpisci
costui”), al contrario il significato di "colpire qualcosa" è ben attestato: Pi. Pae. VI 18
podi; krotevonti (sc. ga'n) "battono col piede il suolo"; Eur. Ba.187-188 wJ" ouj
kavmoim∆ a]n ou[te nuvkt∆ ou[q∆ hJmevran / quvrswi krotw'n gh'n: "io, né di giorno né di
notte, mi stanco battendo la terra col tirso"; Hdt. VI 58.1
"colpiscono un lebete"; Demosth. 54.9 krotei'n toi'"
ajgkw'sin...ta;" pleurav" "battere i fianchi con i gomiti".
Per aij~scra si cfr. fr. 64 a.12, Alc. 10.3 movro" aij~scro" "sorte obbrobriosa"; Thgn.
651 aijscra; dev m∆ oujk ejqevlonta bivhi kai; polla; didavskei" "tu insegni a forza a
me che non voglio molte cose turpi".
Su Nevmesi" o la nevmesi" ("indignazione, ira, sdegno") e sul suo ruolo, indicativi sono i
seguenti passi: Od. XXII 39-40 in riferimento ai Proci che hanno occupato la reggia di
Odisseo, ou[te qeou;" deivsante", oi} oujrano;n eujru;n e[cousin, / ou[te tin∆ ajnqrwvpwn
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
208
nevmesin katovpisqen e[sesqai "non temendo gli dei che l'ampio cielo possiedono, né
la vendetta che in seguito venisse dagli uomini"; Hes. Theog. 223 tivkte de; kai;
Nevmesin ph'ma qnhtoi'si brotoi'si "e generò anche Nemesi, sciagura per i mortali
uomini "; Op. 200 Aijdw;" kai; Nevmesi": ta; de; leivyetai a[lgea lugra; / qnhtoi'"
ajnqrwvpoisi: kakou' d∆ oujk e[ssetai ajlkhv "Vergogna e Nemesi: i lacrimevoli dolori
rimarranno ai mortali uomini e difesa dal male non vi sarà"; Thgn. 280 eijko;" to;n
kako;n a[ndra kakw'" ta; divkaia nomivzein, / mhdemivan katovpisq∆ aJzovmenon
nevmesin "è naturale che l'uomo cattivo abbia un'idea sbagliata di ciò che è giusto, non
temendo castigo per il futuro"; Pi. P. X 43-45 povnwn de; kai; maca'n a[ter / oijkevoisi
fugovnte" / uJpevrdikon Nevmesin "senza affanni e battaglie, essi vivono evitando la
sommamente giusta vendetta"; Aeschl. fr. 266.4 sgg. R.hJmw'n ge mevntoi nevmesi" ejsq∆
uJpertevra, / kai; tou' qanovnto" hJ Divkh pravssei kovton "vendetta è certamente
superiore a noi e la Giustizia esige vendetta per il morto"; Soph. Phil. 517 sgg. ejp∆
eujstovlou taceiva" new;" / poreuvsaim∆ a]n ej" dovmou", ta;n ejk qew'n / nevmesin
ejkfugwvn "lo trasporterei sulla nave veloce, ben equipaggiata, verso casa, evitando il
giusto sdegno degli dei"; Eur. Ph. 182-184 Nevmesi kai; Dio;" baruvbromoi brontaiv, /
keraunw'n te fw'" aijqaloven, suv toi / megalagorivan uJperavnora koimivzei"
"Nemesi e tuoni alto boato di Zeus, luce di folgori ustionante, tu certo plachi la
tracotante superbia". E si ricordi anche, tra gli inni orfici, quello "A Nemesi" ([Orph.]
Hymn. 61.1-12):
\W Nevmesi, klhvizw se, qeav, basivleia megivsth, panderkhv", ejsorw'sa bivon qnhtw'n polufuvlwn: ajidiva, poluvsemne, movnh caivrousa dikaivoi", ajllavssousa lovgon polupoivkilon, a[staton aijeiv, h}n pavnte" dedivasi brotoi; zugo;n aujcevni qevnte": soi; ga;r ajei; gnwvmh pavntwn mevlei, oujdev se lhvqei yuch; uJperfronevousa lovgwn ajdiakrivtwi oJrmh'i. pavnt∆ ejsora'i" kai; pavnt∆ ejpakouvei", kai; pavnta brabeuvei": ejn soi; d∆ eijsi; divkai qnhtw'n, panupevrtate dai'mon. ejlqev, mavkair∆, aJgnhv, muvstai" ejpitavrroqo" aijeiv:
do;" d∆ajgaqh;n diavnoian e[cein, pauvousa panecqei'" gnwvma" oujc oJsiva", panupevrfrona", ajlloprosavlla".
O Nemesi, ti glorifico, dea, regina suprema,
che tutto vedi, che osservi la vita dei mortali divisi in molti popoli:
sempiterna, augusta, sola che gioisci di ciò che è giusto,
che muti il discorso molto vario, sempre instabile,
che tutti i mortali che hanno messo un giogo al collo temono:
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
209
a te difatti sempre sta a cuore il pensiero di tutti, né ti dimentica
l'anima che si inorgoglisce con impulso indiscriminato di parole.
Vedi tutto, tutto ascolti e tutto decidi:
in te vi sono i giudizi dei mortali, dea suprema.
Vieni, beata, santa, agli iniziati sempre soccorritrice:
concedi di avere buona facoltà di comprendere, ponendo fine ai
pensieri malvagi, non devoti, molto arroganti, volubili.
oij~de qui è accompagnato da un aggettivo neutro to express character or disposition
(LSJ s. v. *ei[dw B) di qualcuno anche verso qualcun altro: è una costruzione frequente
in Omero, per cui cfr. Il. XXIV 41 a[gria oij~den "ha fierezza in cuore" (lett. "sa cose
selvagge");; Od. XIII 405 toi h[pia oij~de "ti è fedele" (lett. "sa cose propizie per te").
Dopo la lacuna, per il Ferrari, ]evtei deve esse integrato come kr]evtei ovvero la forma
eolica corrispondente all'attico kratei' (per cui cfr. fr. 20.5 krevthsai ed Alc. 351.1 nu'n
d∆ouj~to" ejpikrevtei "ora costui comanda"). Per l'immagine di qualcosa o qualcuno che
domina su tutti si cfr. Il. I 288: pavntwn me;n kratevein ejqevlei "vuole dominare tutti".
Alla fine di questo verso (fr. 60.10) gli editori Lobel-Page e Voigt leggevano ta[.].le..
ed il Ferrari propone di integrare t jaj[o]l≥levw≥n≥, perché, per lui, le tracce di inchiostro
poste sopra l'a non possono che indicare un segno di vocale breve ( ) seguito da un
accento grave: di solito, nei papiri, l'accento grave si metteva quando la vocale
successiva aveva l'accento acuto. Si cfr. fr. 44.22 ajol[le e Alc. fr. 348.3 ajovllee".
Per il motivo degli dei che puniscono i mortali per le loro colpe o in vista di un
equilibrio generale cfr. Il. XV 490-492 rJei'a d∆ajrivgnwto" Dio;" ajndravsi givgnetai
ajlkhv, / hjme;n oJtevoisin ku'do" uJpevrteron ejggualivxhi, / hjd∆o{tina" minuvqhi te kai;
oujk ejqevlhisin ajmuvnein, / wJ" nu'n jArgeivwn minuvqei mevno", a[mmi d∆ajrhvgei “la
forza di Zeus è facilmente riconoscibile per gli uomini / sia che conceda agli uni la
gloria più alta / sia che gli altri indebolisca e non voglia aiutarli, / come ora riduce la
forza degli Argivi, ma aiuta noi”; Il. XX 242s. Zeu;" d∆ajreth;n a[ndressin ojfevllei te
minuvqei te / o{ppw" ken ejqevlhisin: oJ ga;r kavrtisto" aJpavntwn “Zeus rafforza il
valore agli uomini e lo debilita / come vuole: lui, infatti, è il più forte di tutti”; Hes. Op.
5-8 rJeva me;n ga;r briavei, rJeva de; briavonta calevptei, / rJei 'a d∆ ajrivzhlon minuvqei
kai; a[dhlon ajevxei, / rJei'a dev t∆ ijquvnei skolio;n kai; ajghvnora kavrfei / Zeu;"
uJyibremevth", o}" uJpevrtata dwvmata naivei “facilmente, infatti, rende forti, ma
facilmente opprime chi è forte. / Facilmente debilita l’eccelso ed esalta l’oscuro, /
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
210
facilmente raddrizza chi è storto ed umilia il coraggioso, / Zeus l’altisonante che abita
le dimore più eccelse”.
19 Ferrari integra Yavpfoi, se fivl[eis∆ ajmf∆ ojcevess∆ h[rmose kuv]kla s[oiv te
"O Saffo, poiché ti ama, applicò al carro le ruote e per te", una congettura che segue
cronologicamente quella del West, Yavpfoi, se; fivl[hs∆ e[xoca kallivqrono"
jAfrodivta] "O Saffo, ti amò in modo straordianario Afrodite dal bel trono", per la quale
si confronti 112.5:
tetivmak∆ e[xoca s∆ jAfrodivta
in modo straordinario ti ha onorato Afrodite
Si ricordi che già il Diehl aveva congetturato una forma del verbo eolico fivlhmmi. Per
kallivqrono" del West in riferimento ad Afrodite, si confronti l'attacco dell' Ode ad
Afrodite: poikilovqron(e) v. 1.
Per ajmf∆ ojcevess∆ h[rmose kuv]kla del Ferrari, cfr. Il. V 722
{Hbh d jajmf∆ ojcevessi qow'" bavle kampuvla kuvkla
Ebe velocemente attaccò, di qua e di là, le ruote rotonde al carro
Questo modulo del preparare il carro prima di partire ritorna in 1.9 cruvsion...a[rm∆
ujpasdeuvxaisa "aggiogando un carro d'oro".
Analizziamo il testo stabilito per questo verso dal Ferrari: la frase rivolta a Saffo da
Afrodite con l'uso del pronome di seconda persona singolare, iniziata sul finire del v. 17
(su; d∆), viene ora abbandonata e la dea utilizza il vocativo Yavpfoi: questo scarto è
tipico del registro affettivo-colloquiale. Vi è però un altro scarto: la dea, che finora, per
indicare se stessa, aveva usato la prima persona singolare (cfr. v. 15 e[moi), utilizza ora la
terza persona singolare: il soggetto d'ora in avanti non sarà più "io", ma la "veneranda
regina di Cipro". Il vocativo Yavpfoi è attestato nell'Ode ad Afrodite (1.20) e nel fr.
133.2.
20 Il papiro riporta Kuvprwi≥, un dativo, ma qui si può ragionevolmente supporre un
genitivo singolare eolico Kuvprw (per il quale cfr. commento fr. eV 2-3): un simile errore
è ben attestato nella nostra tradizione, si confrontino i frammenti Alc. 38a.3: aj]elivw
kovqaron favo" "pura luce del sole" e Alc. 42.10 zw'ma parqevnw{i} "la cinta della
fanciulla", per il primo dei quali Hunt legge sul papiro (POxy.1233 fr. 1 col. II r.10)
ajelivw{i}.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
211
L'etimologia del sostantivo basileuv", donde il derivato basivleia, è e rimane oscura:
tuttavia il termine qasireu, attestato nelle tavolette micenee, mostra chiaramente una
labiovelare iniziale e, perciò, si può pensare ad un'origine indoeuropea.
Per il significato dell'espressione Kuvprw b[a]sivl[h∆ v. nota al v. 6, in particolare i
confronti con Aeschl. fr. 463 N.2
e Hor. Carm.I 30,1-2a.
Nella sua edizione311
del 1925, Edgar Lobel pubblicò tre frammenti papiracei (d— 7A L.)
appartenenti allo stesso POxy. 1787, ma fino ad allora mai accolti in una edizione di
Saffo; lo studioso si limitava a dire : "tria fragmenta nondum edita huc revocavi, quorum
(a) [= 66 a V.] (d— 7 A c L. = 66c V.) et (b) [= 66b V.] ex superiore parte eiusdem ac d— 7
[= 65 V.] columnae proficisci, (c) e regione vv. 6-8 [= eV 20-22 v. supra] collocandum
esse liquet". Del fr. d— 7Ac L. = 66c V. Lobel dava la seguente lettura
]mna–[
].kateg≥[
]k≥ek[
Il West ed il Ferrari hanno accolto la combinazione proposta dal Lobel ed hanno
integrato i versi 20-21-22. Mentre il West312
restituiva il verso come Kuvprw b[a]sivl[h∆
ejnnaliva" ojlbodovterra sev]mna "veneranda dispensatrice di felicità, regina della
marina Cipro", Ferrari integra per Kuvprw b[a]sivl[h∆ h\lq∆ ijketeuvoisa Div∆ ai \ya
sev]mna "la veneranda regina di Cipro andò subito a supplicare Zeus"
Per l'espressione Kuvprw b[a]sivl[h∆ ejnnaliva" del West si impone il confronto con un
passo già citato in questo commento, al v. 6, ovvero Alcm. 55 P. Per Kuvprw...ejnnaliva"
si confronti, invece, Eur. Hel. 148 a: ej" gh'n ejnalivan Kuvpron.
Per sevmna in connessione con Afrodite, cfr. 5.18 Kuvp[ri]...[sevm]na (integrazione del
Milne).
21 Il Cronide, ovvero Zeus, grazie all'opera promessa e prestata da Afrodite,
concede a Saffo un "gran dono" (dw'[ron è una congettura di H. Fränkel): in questo
senso, risulta da preferire kaiv toi del Fränkel, rispetto a kaivtoi riportato nelle edizioni
Lobel-Page e Voigt: così si sottolinea il dato che il mevga dw'ron sia proprio destinato a
Saffo (è lo stesso Zeus a sancirlo), come ricompensa per ciò che le ha fatto Andromeda.
Per mevga dw'ron (solo altre 2x) si cfr. Il. IX 576b uJposcovmenoi mevga dw'ron
311
Lobel 1925, 30-31. 312
West 2005, 2.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
212
"promettendo un gran dono" e Hes. fr. 211.8 M.-W. hj~ povre] so[i] mevga dw'ron
jOluvmpio" eujruvopa Zeuv" "certamente Zeus Olimpio vasta voce sonante ti offrì un gran
dono". Per toi per l'attico soi cfr. Sapph. 31.2; 40.2; inc. auct. 34a.3. V.
Altrove Saffo parla dei doni concessi a lei dalle Muse o dalle Cariti, basti pensare al
famoso fr. 32:
ai[ me timivan ejpovhsan e[rga ta; sfa; doi'sai
Che mi resero onorata,
concedendomi le loro opere…
In quel caso, però, ciò che le Muse (?) concedono è l'arte del canto (e[rga / ta; sfa;). I
bei doni delle Muse compaiono pure in 44Ab.5 (Moivsan ajgla[av dw'ra "gli splendidi
doni delle Muse" è però un' integrazione del Treu), così come, lo abbiamo visto, in
Sapph. DV gV 1 Moivsan ij]ok[ov]lpwn kavla dw'ra. E il "dono" o i "doni" delle Muse o
delle Cariti compaiono anche altrove, per cui si ricordino i confronti riportati nel
commento a Sapph. DV gV 1.
Qui si tratta di qualcosa di ben diverso: si tratta, infatti, del klevo", la "fama universale",
come leggiamo al v. 23 (pavntai klevo" "la gloria…ovunque"), probabilmente collegata
a qualcosa che attende Saffo nell'oltretomba (cfr. v. 24 kaiv s∆ ejnn∆ Acevr[onto").
Afrodite, quindi, supplica Zeus affinché Saffo ottenga questo mevga dw'ron; il modello
della supplica a Zeus è rintracciabile in Il. I 493 sgg.: Tetide si presenta sull'Olimpo per
chiedere l'intercessione di Zeus, appena tornato dal pranzo presso gli Etiopi, in favore
del figlio Achille cui è stata sottratta la schiava Briseide dal sire di genti Agamennone; si
confronti soprattutto, il v. 514-515 con la richiesta, da parte della Nereide, di una
promessa del signore dell'Olimpo:
nhmerte;" me;n dhv moi uJpovsceo kai; katavneuson h] ajpoveip j
Dammi una verace promessa, fa' cenno
oppure rifiuta
In base a questo contatto, Ferrari restituisce tutto il verso come kaiv toi mevga dw'[ron
Kronivdai" Ûo]i' katevn[eus∆ ojpavsdhn "ed il Cronide accordò di concederti un gran
dono". Kronivdai" è l'eolico per l'attico Kronivdh", mentre ojpavsdhn è l'eolico per
ojpavzein. Per la compresenza di Kronivdai" e di ojpavsdhn si confronti Sapph. DV dV 2
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
213
(v. supra) e gli altri passi citati nel commento a quel verso. Per katevn[eus(e) si confronti
il già citato passo di Il. I 514-515, ma anche 44a.7-8:
]de neu'son e[man cavrin: evneu]se qevwn makavrwn pavthr:
…accordami la grazia:
…annuì il padre degli dei beati…
22 L'uso di Faevqwn per indicare il sole è tardo (si cfr., ad es., Nonn. D. V 81 in
riferimento ad Ares ed Afrodite: ajmfotevrwn eJkavterqen o{pw" Faevqwn mevso" ei[h
"affinchè il Sole sia in mezzo ad entrambi"), perciò è opportuno presupporre, come fa il
West, sulla scorta di H. Fränkel, o[]ssoi" faevqwn [ jAevlio".
Per faevqwn [ jAevlio", si cfr. Il. XI 735 eu\te ga;r hjevlio" faevqwn uJperevsceqe
gaivh" "Quando il sole splendente si sollevò sulla terra"; Od. V 479 ou[te pot jhjevlio"
faevqwn ajkti'sin e[ballen "mai il sole splendente penetrava coi raggi" etc.; Hes.
Theog. 760 jHevlio" faevqwn ejpidevrketai ajktivnessin "il sole splendente guarda coi
raggi"; Soph. El. 824 ; Eur. El. 464 faevqwn kuvklo" ajelivoio
"splendente anello del sole". Per jAevlio" fevggesin del West si cfr. Bacchyl. 5.162
ajelivou...fevggo"; Aeschl. Pe. 377 ejpei; de; fevggo" hJlivou katevfqito "ma quando
morì la luce del sole"; Soph. Tr. 606 fevggo" hJlivou; Ant. 808-809 nevaton de; fevg- /
go" leuvssousan ajelivou "(io) mentre contemplo l'estremo raggio del sole"; El. 380-
381 hJlivou fevggo"; Eur. Hipp. 850 (= El. 729) fevggo" ajelivou; Hec. 848 fevggo" hJlivou;
IA. 1282 ajelivou tovde fevggo"; El. 866 w\ fevggo", w\...hJlivou sevla" "o raggio, o
bagliore del sole"; Aristoph. fr. 188.2 fevggo" hJlivou.
Per l'idea del sole che contempla gli uomini si cfr. Sol. 14.2W2: pavnte" o{sou" qnhtou;"
hjevlio" kaqorai' "tutti quanti i mortali che il sole contempla"; Eur. Hipp. 848 sgg.:
gunaikw'n ajrivsta q∆ oJpovsa" oJra'i fevggo" q∆ aJlivoio kai; nukto;" aj- sterwpo;n sevla".
La migliore tra le donne, questa
il raggio del sole contempla
e la folgore splendente della notte
Il West restituisce, grazie ad una lettura più attenta e puntuale del 66c (per cui v. supra),
o[]ssoi" faevqwn [ jAevlio" fevggesin ajmfib]av≥s≥k[ei, integrazione che Ferrari accoglie
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
214
nel suo testo. ajmfibavskw per ajmfibaivnw "avvolgere, circondare" è presente anche nel
fr. 21.7 di Saffo, ma soprattutto si confronti, sempre in riferimento al sole, Od. IV 400:
h\mo" d j hjevlio" mevson oujrano;n ajmfibebhvkhi Quando il sole raggiungerà la metà del cielo
23 L'avverbio pavntai "dappertutto" è presente anche nel fr. 44 (v. 28 pavntai d∆
hj~" ka;t o[do[i"), così come l'immagine del propagarsi della fama, per cui si confronti il
v. 4:
tav" t ja[lla" jAsiva".[.]de.an klevo" a[fqiton:
e del resto dell'Asia…gloria imperitura
dove però è in riferimento al nozze di Ettore ed Andromaca. Per il diffondersi della
gloria si cfr. anche Il. VII 451 (= 458) tou' d∆ h[toi klevo" e[stai o{son t∆
ejpikivdnatai hjwv" "e la gloria di quello sarà vasta quanto si estende l'aurora"; Od. VIII
74 oi[mh", th'" tovt∆ a[ra klevo" oujrano;n eujru;n i{kane "un canto del quale allora la
fama al vasto cielo saliva". E si cfr., a riguardo della gloria, ciò che Ovidio mette in
bocca, o meglio fa scrivere a Saffo (Ov. Her. XV 28):
Iam canitur toto nomen in orbe meum.
Ormai in tutto il mondo il mio nome è celebrato.
Ferrari integra, dopo klevo", [ ejpivkesq(ai): si cfr. Sapph. 105a.3 ajll∆ oujk ejduvnant∆
ejpivkesqai "ma non riuscirono a raggiungerlo".
24 La Voigt avverte che ejnn∆ è una forma epica per eijn. Diehl ha integrato
jAcevr[onto": se si suppone, anche per questo verso, come metro il parasclepiadeo
maggiore, necessariamente questa congettura risulta corretta, dato che aggettivi derivati
come jAcerouvsio", jAcerousiav", jAcerovnt(e)io" e jAcerontiav" non si adattano al
contesto metrico ed inoltre sembrano essere coniazioni successive. Dal punto di vista
strettamente etimologico, il sostantivo jAcevrwn sembra presupporre una derivazione da
un ipotetico sostantivo *a[cero", da mettere in relazione con alcuni termini delle lingue
baltiche o di quelle slave. L'Acheronte è attestato per la prima volta in Od. X 513 e si
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
215
cfr. il già citato fr. saffico 95.12-13: lwtivnoi" drosoventa" [o[- / c[q]oi" i[dhn jAcer[
"di vedere le rugiadose rive di Acher(onte) fiorite di loto"; Soph. Ant. 810-815:
ajllav m∆ oJ pag- koivta" {Aida" zw'san a[gei
ta;n jAcevronto" ajktavn, ou[q j uJmenaivwn e[g- klhron, ou[t∆ ejpi; numfeivoi" pwv mev ti" u{mno" u{m- nhsen, ajll∆ jAcevronti numfeuvsw.
Ma Ade che tutti assopisce
viva mi conduce alla riva dell'Acheronte,
né partecipe degli imenei
e neppure canto si levò
per le mie nozze, ma ad Acheronte andrò in sposa.
Per il Ferrari, il componimento da qui in poi non toccava la tematica della fama, a
riguardo della cui estensione universale Saffo aveva già parlato in questo componimento
(cfr. v. 23 e relativo commento). Della persistenza della fama presso i posteri Saffo
parla, come si sa, nel fr. 147, un carme nel quale, testimonia Massimo di Tiro (18.9),
Saffo si rivolgeva alla figlia Cleide dicendo (si accoglie qui l'emendazione u[steron del
Volger, al posto del tradito e[teron):
mnavsesqaiv tina faãi'Ãmi kai; u[steron ajmmevwn
credo che qualcuno si ricorderà di noi anche in futuro…
Il Ferrari, invece, ritiene più coerente con le abitudini del dio supremo la concessione, da
parte di Zeus, di una sorta di esistenza semidivina "da trascorrere nello stesso regno di
Ade, dove la decima Musa potrà continuare a dilettare ed a dilettarsi nella poesia e nella
musica"313
: Saffo sembra quindi assunta al ruolo di iniziata; per la figura ed il ruolo del
muvsth" e dei misteri, indicativi sono alcuni passi poetici, tra cui Hymn. Cer. 480-482:
o[lbio" o}" tavd∆ o[pwpen ejpicqonivwn ajnqrwvpwn: o}" d∆ ajtelh;" iJerw'n, o}" t∆ a[mmoro", ou[ poq∆ oJmoivwn ai\san e[cei fqivmenov" per uJpo; zovfwi eujrwventi.
Beato tra gli uomini della terra colui che ha assistito a questi riti!
Ma colui che non è iniziato ai misteri, colui che non ne ha parte, giammai
di simili genti avrà il destino, pur morto, sotto la terra umida.
313
Ferrari 2005, 24-25.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
216
In particolare, sulla scorta del Rösler, si noti la corrispondenza tra i vv. 481-482 di
questo inno a Demetra ed il fr. 55.2-3 V. di Saffo, un componimento che esula dalla
nostra analisi: ouj ga;r pedevchi" brovdwn / tw;n ejk Pieriva" "tu, infatti, non hai parte
delle rose della Pieria", in riferimento ad una donna che Plutarco ci testimonia essere
ricca ed ignorante (assomiglia, per questo, alla stessa Andromeda314
) alla quale Saffo
stessa assicura uno squallido aggirarsi nell'Ade: per l'aggressività dimostrata in questo
caso, si cfr. il già citato fr. 57 (v. supra). Altri passi ci parlano di qualcuno che ha
ottenuto un'esistenza "quasi" divina: e. g. Soph. fr. 278 R. eujdaivmone" oiJ tovte gevnna"
ajfqivtou lacovnte" qeiva" "felici, avendo loro allora ottenuto una stirpe immortale,
divina". E si cfr. anche Pi. O. II, 60 sgg., dove si fa riferimento al destino ultraterreno
degli ejsloiv:
i[sai" de; nuvktessin aijeiv, i[sai" d∆ aJmevrai" a{lion e[conte", ajponevsteron ejsloi; devkontai bivoton, ouj cqovna ta-
ravssonte" ejn cero;" ajkma'i oujde; povntion u{dwr keina;n para; divaitan, ajlla; para; me;n timivoi" qew'n oi{tine" e[cairon eujorkivai"
a[dakrun nevmontai aijw'na, toi; d∆ ajprosovraton ojkcevonti povnon.
Ma i buoni, fruendo del sole per notti uguali sempre
e giorni uguali, ricevono una vita
senza fatiche, non sconvolgono il suolo
nel vigore di braccia,
né l'acqua del mare,
a causa di un vano vitto, ma tra dei venerandi,
chi era lieto per le fedeltà ai giuramenti,
trascorre un'età senza pianto,
gli altri, invece, sopportano un peso tremendo.
Si cfr. anche Pi. fr. 129 M., un frammento di qrh'no", dove il sole è detto risplendere per
le anime degli ejsqloiv, mentre nel mondo di qui è notte:
toi'si lavmpei me;n mevno" ajelivou ta;n ejnqavde nuvkta kavtw,
foinikorovdoi" t∆ejn leimwvnessi proavstion aujtw'n kai; libavnwn skiara'n kai; crusokavrpoisin bevbriqe dendrevoi" kai; toi; me;n i{ppoi" gumnasivoisi
toi; de; pessoi'"
314
Si potrebbe anche pensare che Andromeda fosse la protagonista passiva sia nel fr. 55, che nel 57, anche
se, purtroppo, Plutarco non ci dà maggiori informazioni sulla donna del fr. 55: notare l'aggressività e la
"crudele" ironia con cui Saffo si fa beffe di entrambe.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
217
toi; de; formivggessi tevrpontai, para; dev sfisin eujanqh;" a{pa" tevqalen o[lbo":
ojdma; d jejrato;n kata; cw'ron kivdnatai aijei; quvmata meignuvntwn puri; thlefanei' pantoi'a qew'n ejpi; bwmoi'"
Per essi il vigore del sole risplende là in basso,
mentre qui è notte nei prati di rose rosse, fuori della loro città;
d'ombrose piante d'incenso…
ed è pieno di frutti dorati;
ed alcuni si dilettano con i cavalli e gli esercizi fisici,
altri, invece, con le pedine,
altri con le lire, ma vicino a loro
prospera fiorente ogni felicità.
Il profumo, invece, si diffonde sempre per quell'amabile luogo,
mentre essi sempre mescolano ogni tipo di essenza
col fuoco che appare lontano sugli altari degli dei.
E si cfr. Posidipp. 43.1-4 A.-B.:
h\lqen ejp∆ eujsebevwn Nikostravth iJera; mu≥s≥tw'n
o[rgia kai; kaqaro;n pu≥'r ejpi; Triptole≥v[mou, h}n a]y hJ f..[.....]... JRadamavnquo" [
Aijako;" e[.....]. dw≥'m≥a≥ pu≥vla≥"≥ t≥ j{e≥}[ jAi?dew
È giunta Nicostrata ai sacri riti dei pii iniziati
ed al puro fuoco davanti a Trittolemo,
che indietro…di Radamanto…
Eaco…la dimora e le porte di Ade…
Lo stesso Zeus sembra, quindi, nei versi finali (?) del nostro componimento in analisi,
garantire a Saffo, come premio per ciò che ha dovuto subire da Andromeda, un'esistenza
che si distingue da quella degli altri, non solo nel mondo di qui, ma anche nell'Ade:
questo tipo di distinzione ultraterrena accomuna Saffo agli altri iniziati, per cui si
confrontino le lamine315
I A 1 Pugliese Carratelli (Hipponion) e I A 2 Pugliese Carratelli
(Petelia).
Mnamosuvna" tovde ãhÃierovn: ejpei; a]m mevllhisi qanei'sqai.
315
L'edizione di riferimento è Pugliese Carratelli 2001, pp. 39-72. Sull'esegesi di queste laminette è
intervenuto, recentemente, anche V. Di Benedetto (Fra Hipponion e Petelia, «PdP» CCCXXXVII (2004),
pp.293-306 )
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
218
Ei\" jAi?dao dovmou" eujhvrea":e[st jejpi; dexia; krhvna, pa;r d jaujta;n ãhÃestakui'a leuka; kupavrisso": e[nqa katercovmenai yuãcÃai; nekuvwn yuvcontai.
Tauvta" ta'" kravna" mhde; scedo;n ejnguvqen e[lqhi". Provsqen de; heurhvsei" ta'" Mnamosuvna" ajpo; livmna" Yucro;n ãhÃuvdwr prorevon:fuvlake" de; ejpuvperqen e[asi, toi; dev se eijrhvsontai ejnãi;Ã frasi; peukalivmnaisi o{tti de; ejxerevei" [Ai>do" skovto" ojrfãnÃhvento". ei\pon:"ãhuÃo;" Bareva" kai; Oujranou' ajsterovento", divyai d jeijm jau\o" kai; ajpovllumai:ajlla; dovt∆ wj~[ka]
yucro;n ãhÃuvdwr pievnai th'" Mnhmosuvnh" ajpo; livm[nh"]".
Kai; dh; toi; ejleou'sin ãhÃupo; cqonivwi basilh'i, kai; dh; toi dwvsousi pievn ta'" Mnamosuvna" ajpo; livmna". Kai; dh; kai; su; piw;n hodo;n e[rceaãià havn te kai; a[lloi muvstai kaiv bavccoi hiera;n steivcousi kleinoiv.
Questo (dettato) sacro è di Mnemosyne, per colui che è sul punto
di esser morto. Andrai alle case ben costruite di Ade: vi è sulla
destra una fonte,
accanto ad essa è innalzato un bianco cipresso;
le anime dei morti che lì scendono hanno refrigerio.
A questa fonte non andare vicino.
Ma più avanti troverai la fredda acqua
che scorre dal lago di Mnemosyne: vi stanno innanzi custodi,
ed essi ti chiederanno nelle loro sagge menti
che cosa cerchi nell'oscura tenebra di Ade.
Di':"sono figlia della Greve e del Cielo stellato,
sono arso di sete e svengo: ma datemi presto
da bere la fresca acqua che viene dal lago di Mnemosyne".
Ed essi son misericordiosi per il re degli inferi
Ed essi ti daranno dal bere dal lago di Mnemosyne.
E tu,una volta bevuto, percorrerai quella sacra via
che anche gli altri iniziati e invasati percorrono gloriosi.
Eujrhvssei" d∆ [Ai>dao dovmwn ejp jajristera; krhvnhn pa;r d jaujthi' leukh;n ãhÃestakui'an kupavrisson: tauvth" th'" krhvnh" mhde; scedo;n ejmpelavseia". Eujrhvsei" d jeJtevran, th'" Mnhmosuvnh" ajpo; livmnh"
Yucro;n u{dwr prorevon:fuvlake" de; ejpivprosqen e[asin. Eijpei'n:"Gh'" pai'" eijmi kai; Oujranou' ajsterovento", aujta;r ejmoi; gevno" oujravnion:tovde d ji[ste kai; aujtoiv. Divyh/ d jeijmi; au[h kai; ajpovllumai:ajlla; dovt jai[ya yucro;n u{dwr prorevon th'" Mnhmosuvnh" ajpo; livmnh"".
Kaujt[oiv] s[o]i dwvsousi piei'n qeivh" ajp[o; krhv]nh", kai; tovt j e[peit j a[[lloisi meq j]hJrwvessin ajnavxei["].
[Mnhmosuv]nh" tovde iJ[erovn:ejpei; a]n mevllh/si] qanei'sq[ai t]ovde gra[
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
219
Troverai a sinistra delle case di Ade la fonte
ed accanto ad essa un bianco cipresso innalzato:
a questa fonte non andare vicino.
Ma ne troverai un'altra, la fredda acqua che scorre
dal lago di Mnemosyne: vi stanno innanzi i custodi.
Di': "Son figlia della Terra e del Cielo stellato,
la mia stirpe è celeste: ciò lo sapete anche voi.
Sono arsa di sete e muoio: ma datemi subito
la fresca acqua che scorre dal lago di Mnemosyne".
Ed essi ti daranno da bere dalla fonte divina
ed allora dopo regnerai sugli altri eroi.
Questo (dettato) è sacro di Mnemosyne: per colui che è sul punto
di esser morto questo (scritto?)
Notare come la condizione di tali iniziati nell'Ade sia estremamente personalizzata (il
caso di Saffo è eloquente), mentre nel fr. 55 si dice di quella donna senza nome che
"vagherà oscura tra le ombre dei morti": la sua esistenza nell'aldilà sarà, in altre parole,
non separabile dagli altri e rimarrà indefinita ed indefinibile. Al contrario, Saffo
manterrà il suo ruolo di moisopovlo" anche nel mondo di là: si confronti questa ipotetica
conclusione del fr. 65 (e dell'intera ode restituita dal Ferrari) con ciò che si è detto per
Sapph. DV aV, in particolare ai vv. 4-6:
]. n≥evrqe de; ga'" g≥en≥[oim]a≥n≥ e[s]l≥o≥n≥ e[co≥i≥san g≥evra" w["≥ [e[]o≥ike≥n≥
qaumav]z≥oien wj" nu'n ejpi; ga'" e[oisan
…ma sotto terra io possa pure trovarmi
…tenendo l'insigne funzione come si conviene
…(mi) ammirerebbero così come ora che sono sulla terra
Come abbiamo già detto, V. Di Benedetto istituisce il confronto tra questi versi del fr.
aVe Hor. Carm. II, 13, 21-30, dove il poeta venosino parla del ruolo che Saffo ed Alceo
continuano ad avere anche nell'Ade.
zV (61+71 L.-P. = V.) metrum: hipp2cho
suppl. possis
oujde; qev]mi" se Mivka g]evla[n, ajl]lav s∆e[gwujk ejavsw
]n≥ filovt[at∆] h[leo Penqilhvan≥
]davkn[e, poluv]trop∆, a[mma[i" 5 ] mevl≥≥[o"] ti gluvkeron
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
220
e[ —gent≥[ ]a mellicovfwn[o" ouj gavr k[ ]dei, livgurai d∆a[h[tai
…non è lecito che tu, Mica,
…rida (di noi), ma io non ti permetterò
…tu hai scelto l'amicizia delle Pentilidi
…ha ferito, volubile, i nostri
(cuori?) …un canto dolce
fu... …dalla voce di miele
infatti non... , ma le brezze sonore
TEST (I) POxy 1787 fr. 6 [1-7]; vv. 1-2 acc. eiusdem pap. fragm. POxy. XXI p. 135
prim. ed.; coni. Lobel 1925, 34, sed vide L.-P. 1955, 50 (II) POxy. 1787 fr. 3 col. II 2
[6-7] ad v. 7 (II) marg. sin. coron. (I) prim. rec. Diehl1
1923 (II) prim. rec. Lobel 1925, 28, ut fr. 3A (I) et (II) coni. Puglia apud Ferrari
2007b, 19
CRIT 1 oujde; qev]mi" se Treu 1976, 64 mi –vka(I), nomen redit Ar. Thesm. 760
║2 g]evla[n Ferari 2007b, 19 : fort. ejp∆a[mm∆a \du g]evla[n ("di noi" iam vertit
Ferrari 2007b, 19) vel modo a\du g]evla[n ? ajl]lav Hunt, ante novum fragmentum
coniunctum avs∆(I) a –vsw (I) ║3 ovt(I) [at] Hunt 1922, 33, sed
brevius iusto iam vid. Lobel ]hv (I) hva–n(I) ║4 fort. paivdwn in init. Hunt 1922, 43 ka≥≥[ko]trop∆ Hunt 1922, 33, sed brevius vid. iam
Lobel 1925, 34 : davkn[e, poluv]trop∆ Ferrari 2007b, 19 trope (I): corr. Hunt
1922, 33 a[mma[" Hunt 1922, 33 : fort. a[mma[i" Ferrari 2007b, 19 ║5 fort.
init. frevna" Ferrari 2007b, 19 mevl(I) mevl≥≥[o"] Hunt 1922, 33, sed longius
vid. Lobel 1925, 34 luv(I) ║6 evg(II) e[gent≥[o Hunt 1922, 31 : fort.
e[gento≥ [fevrois∆ ajsuciv]a Ferrari 2007b, 19 ]a–(I) mellicovfwn[o" Hunt 1922, 33 : mellicovfwn[on w[ran Ferrari 2007b, 19
(mellicovfwn[on iam Puglia apud Ferrari 2007b, 19) ║7 k[e Hunt 1922, 31
: k[avlamo" vel k[ivqari" Puglia apud Ferrari 2007b, 19 ajeiv]dei Hunt 1922,
33 : fort. tau'ta melivs]dei Ferrari 2007b, 19 ra±id∆(I) a±vh[(I): -[doi Hunt 1922, 33 : -[tai Lobel 1925, 34, rec. Ferrari 2007b, 19
Il carme da cui è tratto questo frammento aveva per oggetto Mica, una ragazza che, per
quanto possiamo capire dai brandelli rimasti del testo originario, aveva lasciato il gruppo
di Saffo ed aveva “scelto la filovth" delle Pentilidi” o delle donne “dei Pentilidi”: è per
questo motivo che lo Schadewaldt (1950, 149) ha definito Mica “una piccola transfuga”,
ein kleiner Überläufer.
1 Il testo tradito dal papiro è ]missemiv –ka. Accogliamo pienamente l'integrazione
oujde; qev]mi" se proposta da Treu (1954, 64). Per l'espressione, piuttosto diffusa, cfr.
Sapph. 150 V. ouj ga;r qevmi". L'antroponimo Mivka, che compare anche in Ar. Thesm.
760 talantavth Mivka, dove viene corretto in MivkãkÃa da Lobeck, deriva dal dorico e
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
221
beotico mikkov", che corrisponde all'attico mikrov" "piccola". Per mikkov" cfr. Ar. Ach.
909 Mikkov" ga ma'ko" ou|to" "costui è proprio piccolo d'altezza"; Theoc. V 66
mikko;n a[kouson "senti un po'", Theoc. VIII 66 mikko;" ejw;n; Posidipp. 94.3 s. A.-B.
ajll∆ajpodou'nai / Lewfavntwi megavlhn mikko;" ejgw; cavrita "ma per dare / a
Leofanto un grande ringraziamentio io sono piccolo"; Philod. A. P. V 121.1 [= 8.1 G.-
P.] mikkh; kai; melaneu'sa Filaivnion, ajlla; selivnwn / oujlotevrh kai; mnou' crw'ta
tereinotevrh "lei è piccola e nera, Filénio, ma più crespa dei sedani, di pelle più tenera
del velluto". Per l'antroponimo maschile Mivkko" cfr. Plat. Lys. 204a, dove un certo
Micco viene detto eJtai'ro" ed ejpainevth" di Socrate; Call. Ep. 48.1 Pf. Eujmaqivhn
hj/tei'to didou;" ejme; Si'mo" oJ Mivkkou / tai'" Mouvsai" "Simo, figlio di Micco,
chiedeva, dedicandomi alle Muse, facilità di apprendimento";
Sullo i è presente il simbolo di vocale lunga e l'accento acuto: dato che si tratta, come è
sembrato a tutti gli studiosi, di un vocativo, occorrerebbe, invece, l'accento circonflesso,
perché l'alfa finale sarebbe breve. La Voigt (Hamm 1955, 147) sostiene che la desinenza
eolica del vocativo sarebbe -a± per i sostantivi ed -a– per gli aggettivi: in base a questa
regola, essendo Mivka un sostantivo, sullo iota dovrebbe essere presente l'accento
circonflesso e non quello acuto. Ferrari (2007b, 20) ipotizza che, essendo Mivka un
soprannome, rientri nella categoria degli aggettivi e quindi abbia l'alfa finale lungo, ma
forse il fenomeno può essere spiegato in un modo ben più semplice, ovvero
considerando il fatto che Mivka è sì un antroponimo, ma all'origine era, come abbiamo
visto, un aggettivo: presenterebbe, verosimilmente, l'alfa lungo "originario" come marca
desinenziale del vocativo.
2 Molto verosimile è anche la recente integrazione di Ferrari (2007b, 18) per
questo secondo verso, ovvero g]evla[n, infinito del verbo eolico gevlaimi (= att. gelavw),
che ricorre nel famoso "Carme della gelosia" (Sapph. 31.5 V. gelaivsa") ed in Alc. 349c
(gevlan d∆ajqavnatoi qevoi "ma ridevano gli dei immortali"). Sulla base della traduzione
di Ferrari (2007b, 19: "che tu rida [di noi…]") è possibile, crediamo, proporre qualche
integrazione anche per ciò che precede gevlan. Per indicare l'azione di "ridere di
qualcuno o qualcosa" il greco antico ricorre al verbo gelavw insieme a ejpiv seguito dal
dativo, oppure allo stesso verbo unito al dativo senza alcuna preposizione. La prima
possibile integrazione è, dunque, a[mmi g]evla[n. Tuttavia, a partire dall'epica omerica
(Il. II 270; XI 378; XXI 508; XXIII 784; Od. XVIII 111; XX 358; XXI 376; [Hom.]
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
222
Hymn. Ven. 49) è attestata nella lingua greca la tessera hJduv gela'n, in alcuni casi
accompagnata da ejpiv seguito dal dativo della persona o dell'oggetto neutro che si
deride: Il. II 270; Il. XXIII 784; Od. XX 358; Od. XXI 376. Ed è significativo che anche
in Thgn. 59 e 1113, ovvero in due componimenti teognidei accostabili a questo saffico
per tematica (v. infra) come ha mostrato Ferrari, si faccia ricorso allo stesso costrutto
gela'n preceduto da ejpi; e dativo. Proporremmo di integrare, quindi, ejp∆a[mm∆a \du]
gevlan: l'elisione di a[mmi(n) è si un fenomeno raro nel dialetto eolico, ma comunque
attestato (cfr. Sapph. 27.6; Alc. 69.3) e forse giustificato dalla ripresa della clausula
epica. Se non si accetta l'elisione, ejp∆a[mmi(n) a\du] gevlan oppure a\du [gevlan o, in
ultima analisi, a[mmi[ gevlan possono essere delle valide alternative.
Per il motivo del riso dei nemici cfr. Archil. 172.2 W.2 pavter Lukavmba, poi'on
ejfravsw tovde; / tiv" sa;" parhveire frevna" / h|i" to; pri;n hjrhvrhsqa; nu'n de; dh;
polu;" / ajstoi'si faivneai gevlw" "padre Licambe, quale parola è questa che hai
detto? / Chi sottrasse il tuo senno / che prima tenevi saldo? Ora, invece, davvero
oggetto di molto riso sembri ai cittadini"; Thgn. 59 ajllhvlou" d∆ ajpatw'sin
ejp∆ajllhvloisi gelw'nte" "a vicenda s'ingannano (scil. oiJ ajgaqoiv), ridendo l'uno
dell'altro" (= 1113 ajllhvlou" d∆ajpatw'nte" ejp∆ajllhvloisi gelw'sin); Thgn. 1041 sgg.
Deu'ro su;n ajlhth'ri: para; klaivonti gelw'nte" / pivnwmen, keivnou khvdesi
terpovmenoi "qui insieme al flautista: accanto a lui che piange noi ridendo / beviamo,
delle sue pene gioendo".
3 Il termine filovt[at∆] ricorre altre due volte in Saffo, ovvero in Sapph. 1.19 V. ej" sa;n
filovtata "alla tua amicizia" e 30.4 sa;n ajeivdois≥[i]n f[ilovtata "cantano la tua
amicizia". Per Alceo cfr. Alc. 42.10 V. filov[ta".
È impossibile stabilire se Penqilhvan, genitivo femminile plurale, richieda un paivdwn
(integrato da Hunt 1922, 43) oppure un gunaivkwn all'inizio del verso successivo. Per i
Pentilidi cfr. Introduzione.
4 Il testo stabilito dalla Voigt è ]da ka[kov]trop∆, a[mma[, ma già Lobel (1925, 34) si era
accorto che l'integrazione [kov] di Hunt (1922, 33) era troppo breve rispetto alla lacuna
presente sul papiro. Ferrari ha proposto un testo più verosimile. Per il nesso tra davkn≥[e e
frena", entrambi integrati da Ferrari (2007b, 18-20) cfr. Sapph. 96.16-17 [Atqido"
ijmevrw/ / levptan poi frena k[.]r...bovrhtai "consuma il fragile cuore nel desiderio di
Attide"; Alc. 70.10 calavssomen de; ta;" qumobovrw luva" "ma allentiamo la contesa
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
223
che consuma l'animo"; Il. V 493 w}" favto Sarphdwvn, davke de; frevna" {Ektori
mu'qo" "così disse Sarpedonte, ma parola morse ad Ettore il cuore"; Il. VI 202 o}n
qumo;n katevdwn "mangiando il cuore"; Il. VII 301 e[rido" pevri qumobovroio "per una
contesa che divora l'animo"; Il. XXIV 128-129 tevknon ejmovn, teo mevcri" ojdurovmeno"
kai; ajceuvwn / sh;n e[deai kradivhn...; "figlio mio, fino a quando, gemendo ed essendo
afflitto / mangerai il tuo cuore…?"; Od. X 378-379 ããTivfq∆ou{tw", jOduseu', kat∆a[r
e{zeai i\so" ajnauvdw/ / qumo;n e[dwnÃÃ..."perché così, Odisseo, te ne stai a sedere simile
ad un muto / il cuore mangiandoti…?"; Hes. Op. 451 kradivhn d∆ e[dak∆ ajndro;"
ajbouvtew "si mangia il cuore dell'uomo privo di buoi"; Hes. Op. 799 a[lgea qumoborei'n
"(che)…affanni rodano il cuore"; Thgn. 910 kai; davknomai yuch;n "e mi divoro
l'anima"; Soph. Ai. 625sgg. leukw'i de; ghvrai mavthr nin o{tan nosou'nta /
frenomovrw" (frenobovrw" corr. Dindorf) ajkouvshi "ma la madre in compagnia della
bianca vecchiaia quando ascolta che è malato / soffrendo di una calamità nella mente
(rodendosi l'animo, Dindorf)"; Soph. Phil. 705 dakevqumo" a[ta "sventura che mangia
l'animo"; Eur. Med. 110 yuch; dhcqei'sa kakoi'sin "anima morsa dai mali"; Hdt. VII
16 ejme; de; ajkouvsanta pro;" seu' kakw'" ouj tosou'ton e[dake luvph "non mi morse
tanto il dolore di averti sentito parlar male di me…"; Plat. Conv. 218a ejgw; ou\n
dedhgmevno" te uJpo; ajlgeinotevrou kai; to; ajlgeinovtaton w\n a[n ti" dhcqeivh –
th;n kardivan ga;r h] yuch;n h] o{ti dei' aujto; ojnomavsai plhgeiv" te kai; dhcqei;"
uJpo; tw'n ejn filosofivai lovgwn "io, dunque, morso da ciò che è più doloroso e nella
parte più soggetta al dolore, tra quelle in cui si potrebbe essere morsi – il cuore o
l'anima o come lo si debba chiamare, colpito e morso dai discorsi filosofici"; Sim. 88
FGE.
Se il testo proposto da Ferrari (2007b, 18-20) è corretto, davkne non avrebbe l'aumento,
come del resto altrove in Saffo ed Alceo, soprattutto per motivi metrici (cfr. Hamm
1958, §246): Sapph. 44.11 ajnovrouse (sequenza "dattilica"); 44.31 ejlevlusdon (sequenza
"dattilica"); 94.6 ajmeibovman; 105a.2 lelavqonto; 105a.3 ejklelavqonto; 112.1-2 a[rao;
Alc. 327.2 gevnnat∆; 332.2 kavtqane; 336 e[leto; 349c (= inc. auct. 8 L.-P.) gevlan (=
ejgevlwn).
Ferrari (2007b, 19-21) integra frevna" all'inizio del v. 4 o 5: il termine è già attestato in
Saffo due volte (3.15; 47.2) e tre in Alceo (336; 358.4; 359.2), di cui l'ultima (359.2) in
riferimento a dei bambini (ejk de; paivdwn cauvnwi" frevna", aj qalassiva levpa" "e
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
224
dei fanciulli riempi di boria l'animo, conchiglia marina"), cioè ad una pluralità di
persone, come probabilmente anche in questo passo di Saffo.
Hunt (1922, 33) aveva integrato ka≥≥[kov]trop∆, ma già Lobel (1925, 34) aveva notato che
[kov] era più breve della lacuna presente sul papiro. Per Aloni (1997, 125) non vi
sarebbero altre attestazioni di ka≥[kov]trop∆ nella letteratura arcaica e classica (ma ciò
non è vero: cfr. Ar. fr. 717 K.-A. = 697 Kock) ed il termine sarebbe il corrispettivo di
kakopatrivdai" usato da Alceo contro Pittaco: kakovtropo" mirerebbe contro
l'interiorità della persona, mentre kakopatrivdai" contro l'esteriorità, ovvero l'aspetto
pubblico e sociale. Tuttavia, poluv]trop∆ di Ferrari (2007b, 19-21) non solo è un termine
con una notissima ascendenza epica, ma rende anche ragione del comportamento di
Mica, che abbandona la cerchia di Saffo per acquisire l'amicizia (filovta") dell'oijkiva
rivale, quella dei Pentilidi. Il comportamento di Mica, quasi una sorta di "trasformismo"
per dirla in termini anacronistici, ben rispecchia la "norma del polipo" enunciata da
Thgn. 213sgg. Qumev, fivlou" kata; pavnta" ejpivstrefe poikivlon h\qo", / ojrgh;n
summivsgwn h{ntin∆e[kasto" e[cei: / pouluvpou ojrgh;n i[sce poluplovkou, o}" poti;
pevtrhi, / th'i prosomilhvshi, toi'o" ijdei'n ejfavnh. / nu'n me;n th'id∆ejfevpou, tote;
d∆ajlloi'o" crova givnou / krevsswn toi sofivh givnetai ajtropivh" "animo, adegua il
variegato carattere a seconda di tutti gli amici, / mescolando l'umore con uno
qualunque che ciascuno possiede: / acquista l'umore del polipo dai molti tentacoli, che
sembra alla vista come lo scoglio a cui si aggrappa. / Quando segui un colore, quando
uno diverso. / Meglio la destrezza del rigore". "L'abilità, la sofiva del nobile consiste
proprio nella sua attitudine a conformarsi alla situazione contingente, senza smarrire la
propria indole"(Gentili 2007, 208). "L'atropia si oppone nettamente alla politropia, come
l'immobilità e la fissità al continuo movimento di chi rivela ogni giorno un volto
diverso" (Detienne-Vernant 2005, 29ss.). Per un politico prendere le sembianze di un
polipo significa adattarsi alle situazioni più sconcertanti. Per poluv]trop∆ cfr.,
ovviamente, Od. I 1: [Andra moi e[nnepe, Mou'sa, poluvtropon "l'uomo cantami, Musa,
molto versatile …" e Od. X 330 h\ suv g∆ jOdusseuv" ejssi poluvtropo" "oppure tu sei
Odisseo molto versatile…"; e cfr anche [Hom.] Hymn. Merc. 13 pai'da poluvtropon e
Id. 439 poluvtrope Maiavdo" uijev. Per poluv]trop∆ nel senso della volubilità di carattere
cfr. [Phocyl.] 95 law'i mh; pivsteue, poluvtropo" ejstin o{milo" “non ti fidare del
popolo, volubile è la folla”.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
225
a[mma[i" (= att. hJmetevra") è integrazione di Ferrari (2007b, 19-21) in riferimento a
frena" da lui proposto per l'inizio del v. 4 o del v. 5. Hunt (1922, 33), invece, aveva
integrato a[mma[" (e non a[mma[n come erroneamente presente nell'apparato di Ferrari
2007b, 19).
6 Ferrari integra [fevrois∆ajsuciv]a e per il termine ajsuciva in riferimento ad una
situazione ambientale propone i seguenti paralleli: Eur. Alc. 77 tiv poq∆ hJsuciva
provsqen melavqrwn; "perché mai vi è tranquillità davanti alla reggia?" e Eur. IA. 14
e[ti d∆ hJsuciva th'ide kat∆Au \lin / kai; ajkivnhtoi fulakai; teicevwn "ma ancora vi è
pace qui in Aulide / ed immobili son le guardie delle mura". Per una formulazione simile
cfr. Od. V 390sgg. jAll∆ o}te dh; trivton h \mar eju>plovkamo" tevle" jHwv" / kai; tovt∆
e[peit∆ a[nemo" me;n ejpauvsato hjde; galhvnh / e[pleto nhnemivh "ma quando il terzo
giorno portò Auora dai bei riccioli / ed allora infine il vento cessò e bonaccia / si fece,
priva di vento…"; Od. XII 168 aujtivk∆ e[peit∆ a[nemo" me;n ejpauvsato hjde; galhvnh /
e[pleto nhvnemivh "subito poi il vento cessò e bonaccia / si fece, priva di vento".
mellicovfwn[on], coordinato con w[ran, è integrato da Puglia. Per un composto quasi
identico in Saffo cfr. Philostr. Im. II 1.3 melivfwnoi: Sapfou'" tou'to dh; to; hJdu;
provsfqegma "dalla voce di miele: questo è il dolce appellativo usato da Saffo" e
Aristaenet. Ep. 1, 10 p. 142 H. kai; pro; th'" pastavdo" to;n uJmevnaion h\idon aiJ
mousikwvterai tw'n parqevnwn kai; meilicovfwnoi: tou'to dh; Sapfou'" to; h{diston
fqevgma "e davanti alla camera da letto l'imeneo cantavano le fanciulle più canore e
dalla voce di miele: questo è il detto più dolce di Saffo".
Per altri composti in –fwno" cfr. Sapph. 30.8 liguvfwno" "dalla voce sonora"; 136
...h\ro" a[ggelo" ijmerovfwno" ajhvdwn "usignolo dalla voce che suscita desiderio,
nunzio di primavera"; 153 pavrqenon ajduvfwnon "fanciulla dalla voce dolce"; 185
melivfwno" "voce di miele". Per w[ra con il significato di "stagione" nei poeti eolici cfr.
Alc. 347.2 V. aj d∆ w[ra calevpa "la stagione è dura". Per w[ra con un significato più
generale, cfr. Sapph. 168B devduke me;n aj selavnna / kai; Phli?ade": mevsai de; /
nuvkte", para; d∆e[rcet∆w[ra, / e[gw de; movna kateuvdw "tramontata è la luna / e le
Pleiadi; al mezzo è la / notte, il tempo trascorre,/ mentre io dormo, sola".
7 Puglia integra k[avlamo" oppure k[ivqari". Per kavlamo" cfr. Pi. O. X 84
clidw'sa de; molpa; pro;" kavlamon ajntiavxei melevwn "all'aulo andrà incontro la
voce rigogliosa dei canti"; Ne. V 38; Eur. El. 702 eujarmovstoi" ejn kalavmoi" "nelle
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
226
canne armoniose"; Eur. IT 1126 surivzwn q∆oJ khrodevta" kavlamo" oujreivou Pano;"
kwvpai" ejpiqwu?xei "e la canna attaccata con la cera del montanaro Pan, zufolando,
griderà ai remi..."; Eur. IA 573 sgg. e[mole", w\ Pavri", h|ite suv ge / boukovlo"
ajrgennai'" ejtravfh" / jIdaivai" para; movscoi", / bavrbara surivzwn, Frugivwn /
aujlw'n jOluvmpou kalavmoi" / mimhvmata pneivwn "Paride qua tu giungesti (allevato
pastore fra le bianche giovenche dell'Ida), barbari suoni zufolando, nelle canne
soffiando imitazioni degli auli frigi d'Olimpo". kavlamo" è attestato anche in Alc. 115.8,
ma probabilmente non nel significato di "canna di uno strumento musicale". Il sostantivo
kivqari" è attestato in Alc. 41.15 V.; e cfr anche Od. I 153 kh'rux d∆ejn cersi;n kivqarin
perikavllea qh'ke / Fhmivwi "e pose la cetra bellissima in mano / a Femio". Per la parte
conclusiva della lacuna dell'ultimo verso le integrazioni possibili sono due: ajeiv]dei,
proposto da Hunt 1922, 33, oppure melivs]dei di Ferrari 2007b, 19-21.
Per livguro" cfr. Sapph. DV gV 2 filavoidon liguvran celuvnnan; 103.7 liguvran
[ajoiv]dan; Alc. 347b.2 L.-P. = Sapph. 101A.2 V. liguvran ajoivdan. Per livgurai
d∆a[h[ta]i non si trova un parallelo preciso, ma cfr. Il. V 526 pnoih'isin ligurh'isi;
XIII 590 = XXIII 215 pnoih'i u{po ligurh'i; Od. IV 567 zefuvroio ligu; pneivonto"
ajhvta"; Iul. A.P. IX 661, 2 liguroi'"...ajnevmoi".
Hunt (1922, 3, 43), sulla base di Schol. in Soph. Ai. 628 (hJ ajhdw; de; kata;
Mitulhnaivou") aveva proposto di integrare a[h[doi, ritenendolo una forma eolica. Il dato
oggettivo è che sono attestate nelle opere letterarie a noi tramandateci alcune forme del
tutto particolari che sembrano dimostrare davvero l'esistenza di un nominativo ajhdwv per
ajhdwvn: il voc. ajhdoi' in Arist. Av. 679 ed il gen. ajhdou'" in Soph. Ai. 628: lo scolio a
quest'ultimo verso sofocleo glossa, come abbiamo visto, questa parola non tanto o non
solo come eolica, ma addirittura come "mitilenese", ergo in qualche modo legata a Saffo
ed Alceo. Il punto è che quando si passa da testi "attici" a quelli di Saffo e di Alceo
questo dato dialettologico non trova alcuna attestazione: ajhvdwn in Sapph. 136 è un
nominativo ed ajhvdwn[ di inc. auct. 28, 5 V. può benissimo essere qualcosa di diverso da
un accusativo singolare e d'altronde del frammento non riusciamo ad individuare la
struttura metrica.
Per a[h[tai integrato da Lobel (1925, 34) cfr. Sapph. 2.10 sgg. aij ãd∆à a[htai / mevllica
pn[evo]isin "ma le brezze dolcemente spirano"; 20.9 ] m≥≥egavlai" ajhvtai[" "violenti
brezze"; Alc. 249.5 ]w katevchn ajhvtai" "…trattenere brezze". Vagliate queste ultime
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
227
attestazioni ed i passi paralleli addotti da Ferrari e qui sopra riportati, risulta che a[htai
sia nettamente da preferire.
hV (62 + 71, 8 L.-P. = V.) metrum: hipp2cho
suppl. possis
jEptavxate≥[ ] dros[ov]essa[n davfna" o[ta≥[ p —a;n da[dion≥[ h] kh'non ejlo[
5 k —ai; tai'si me;n aj≥[ ojdoivporo" a[n[....]..[ m—uvgi" dev pot∆eijsavion: ejkl≥[ yuvca d∆ajgapavta sun≥ [.v t —evauta de; nu'n e[mm≥[ata 10 i[kesq∆ajgana[
e[ —fqate: kavlan[
tav t∆e[mmata ka≥[ — Vi rintanaste dalla paura…(sotto) l'umido…
di alloro quando…
ma tutto più dolce…
oppure quello…
ed a quelle…
viandante…
ed a stento una volta udii:
anima diletta…
ed ora simili vesti…
giungere dolc-…
foste prime: bella
e le vesti… TEST (I) POxy 1787 fr. 3 col. II 3-14 [1-12] (vv. 1-2 v. supra fr. antecedens)
prim. rec. Diehl1 1923, 359 (II)POxy 1787 fr. 6 [1] (I) et
(II) coni. Puglia apud Ferrari 2007a, 25 ad v. 12 marg. sin. coronis.
CRIT 1 pta –vx (I) sive ato≥[ (I) leg. Lobel 1925, 28, L.-P. 1955, 43, Voigt
1971, 80-81, sed ate≥[ potius quam ato≥[ [mevn pai'de" Puglia apud Ferrari
2007a, 25-26 fort. ujp∆e[rnh] Puglia apud Ferrari 2007a, 25-26 droso[.]essa[ (II):
dros[ov]essa[ Hunt 1922, 33 : dros[ov]essa[n a[gna" Puglia apud Ferrari 2007a, 25-26
║2 ovt(I) ║3 pa±;ndav –d(I) ║4 h'kh'n onelo≥;[(I) leg. Hunt
1922, 30 : h;kh'nonelo;[ leg. Lobel 1925, 28 : h;kh'nonelo;[ leg. Voigt 1971 80-81: supra o punctum, fort. vestigia accentus : ejlo[ivman Puglia apud Ferrari 2007a, 25-26
║5 tai'si(I) fort. a≥[[llaisi a[ktisi Puglia apud Ferrari 2007a, 25-26
║6 o;doiv(I) a –vn[(I): a[n[qrwp]o≥"≥ Puglia apud Ferrari 2007a, 25-26
║7 muvgisdepot∆(I) -on:(I) ║8 yu–vc (I) pa–vt(I) n≥≥[ vel
k≥≥[ (I): fort. su;n≥ [e[moi Ferrari 2007a, 25-26 ║9 tevaut[.]n≥ (I), ut videtur, metro
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
228
repugnante : tevaut≥[a] corr. Hunt 1922, 30 nu'n(I) fort. e[(I) legendum
post e[- vestigia litt. inc., quarum prima veri simile m; pro altero m fort. vestigia 2
litt. legi possunt. e[mm≥[ata Diehl1 1923, 359 : fort. e[mm≥≥[at∆e[coisai? Ferrari
2007a, 25-26 ║10 i>kesq∆(I) ║11 x marg. sin. evfqate:(I) ║12 tat∆(I) ka≥[i; Diehl
1 1923, 359
Ferrari (2007a, 25-26) e Puglia (apud Ferrari 2007a, 25-26) propongono un collage tra
Sapph. 62 V., Sapph. 71.8 V. e Sapph. 87(14).3-14 L.-P.; il testo da loro stabilito si
presenta, dunque, come segue:
jEptavxate≥[ ] dros[ov]essa[n davfna" o[ta≥[ ]ai p —a;n da[dion≥[ h] kh'non ejlo[
5 k —ai; tai'si me;n aj≥[ ojdoivporo" a[n[....]..[ m—uvgi" dev pot∆eijsavion: ejkl≥[ yuvca d∆ajgapavta sun≥ [.v t —evauta de; nu'n e[mm≥[ata 10 i[kesq∆ajgana[
e[ —fqate: kavlan[
tav t∆e[mmata ka≥[ — Il collage da loro proposto, soprattutto per quanto attiene al Fr. 87(14).3-14 L.-P., non
sembra, tuttavia, cogliere nel segno per le seguenti ragioni: il frammento pubblicato da
Lobel e Page presenta un solo verso tra .v].ran ed ].ai, ma Ferrari (2007b, 19) integra
mellicovfwn[on w[ran (mellicovfwn[on iam Puglia apud Ferrari 2007b, 19) al v. 6 del
nostro frammento DV zV non considerando che tra mellicovfwn[ e ] dros[ov]essa[ c’è un
intero verso nel mezzo: ]dei, livgurai d∆a[h[tai, il v. 7 del nostro fr. zV. Nella
restituzione di Ferrari e Puglia vi sono, inoltre, altri piccoli errori: anche considerando
valida la loro restituzione, ]ai non può essere in quella posizione, ma alla fine del verso.
Per tutte queste ragioni siamo portati a non accogliere il collage proposto da Franco
Ferrari ed Enzo Puglia, almeno per quanto attiene al Fr. 87(14).3-14 L.-P., che dunque
presentiamo separatamente, come Sapph. DV kqV l.
Secondo Treu (1976, 203-204) il componimento sarebbe incentrato sul lamento di una
ragazza che si vergogna della propria veste disadorna e su Saffo che la consola: la
ragazza sarebbe presa da vergogna alla vista dell' ojdoivporo". Per Ferrari (2007a, 26) la
figura del viandante sarebbe, invece, funzionale al motivo della calura estiva e del
cercare un riparo contro di essa, per cui cfr. e.g. Leon. A. P. IX 326 Pevtrh" ejk
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
229
dissh'" yucro;n katapavlmenon u{dwr, / caivroi", kai; Numfevwn poimenika; xovana /
pevtrai te krhnevwn kai; ejn u{dasi kovsmia tau'ta / uJmevwn, w\ kou'rai, muriva
teggovmena, / caivret∆: jAristoklevh" d∆ oJdoipovro", w|iper ajpw'sa / divyan
bayavmeno", tou'to divdwmi kevra" “acqua, che sgorghi fredda da una duplice roccia, /
salve! E statue delle ninfe dovute ai pastori, / rocce delle sorgenti e queste immagini
nelle acque / di voi – o fanciulle – mille volte commosse, / salve! Io sono Aristocle, un
viandante, / dono questo corno, grazie al quale ho scacciato la sete, immergendolo
nell’acqua”.
1 ejptavxate è un aoristo seconda persona plurale di un presente ptavzw,
corrispondente all'attico pthvssw. È attestato anche in inc. auct. 10.1sgg. V. e[ptazon wj"
o[rniqe" w\kun / ai[eton ejxapivna" favnenta "si acquattavano come gli uccelli,
apparsa d'improvviso una veloce aquila".
Un errore piuttosto evidente è costituito dall’integrazione di Puglia e dalla traduzione
proposta in Ferrari (2007a, 26): Puglia, infatti, integra ujp∆e[rnh] ed il testo viene tradotto
“sotto] gli umidi[ rami”, ma e[rnh è un accusativo neutro plurale di e[rno", mentre ]
dros[ov]essa[n è un accusativo singolare femminile: il sostantivo e l’aggettivo non
possono essere coordinati insieme. Per ujp∆e[rnh], integrato da Puglia (apud Ferrari
2007a, 25-26), cfr. comunque Ibyc. fr. 5.5 PMG = 286.5 Davies aujxovmenai skieroi'sin
uJf∆e{rnesin / oijnarevoi" “crescendo sotto gli ombrosi tralci / pampinei”.
L'aggettivo drosovei" è attestato anche in Sapph. 95.12 (katqavnhn d∆i[merov" ti" [ e[cei
me kai; / lwtivnoi" drosoventa" [o[- / c[q]oi" i[dhn jAcer[ "mi possiede il desiderio di
morire e di vedere le rive dell'Acheronte fiorite di loto").
Per Ferrari (2007a, 25-26) un gruppo di ragazze, di cui faceva parte anche Cleide, la
figlia di Saffo, doveva indossare, in occasione di una festa o di un rito, abiti adatti: le
ragazze si sarebbero acquattate sotto l’umido fogliame di un lauro (forse a causa della
calura?).
2 Per davfna" cfr. Alc. 306Ab.13 ejstodafn[ ("num e[sto (e[nnumi)?" Page : ej"
to; davfn[ Treu). È il laurus nobilis, il nostro “alloro”. Si ritiene che davfnh, qui davfna
in eolico, sia un termine di origine mediterranea: il rapporto con il latino laurus
sembrerebbe in qualche modo dimostrato da un lato da alcune glosse (Hsch. lavfnh:
davfnh; Hsch. daucmovn: e[fausto xuvlon davfnh") e forme dialettali o poetiche
(tessalico *daucna, Nic. Ther. 94, Alex. 199 daucmov"), dall’altro da certi scambi tra l e
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
230
d nei prestiti e dalla grafia micenea dapu2ritojo per laburivnqoio: cfr. Chantraine, DELG
s.v. davfnh. Il termine è attestato per la prima volta in Od. IX 183, dove si dice che
l’antro di Polifemo è una grotta (spevo") ombreggiata da allori (davfnhisi kathrefev").
Il termine compare, poi, tre volte negli Inni Omerici ([Hom.] Hymn. Apoll. 394-396 kai;
ajggevllousi qevmista" / Foivbou jApovllwno" crusaovrou, o{tti ken ei[phi / creivwn
ejk davfnh" guavlwn u{po Parnhsoi'o “annunciano i responsi / di Febo Apollo dalla
spada d’oro: ciò che egli dichiara / vaticinando dal luogo del lauro, sotto le gole del
Parnaso”; Hymn. Merc. 109 davfnh" ajglao;n o[zon eJlw;n “preso uno splendido ramo
di alloro…”; Hymn. XXVI 9 kissw'i kai; davfnhi pepukasmevno" "avvolto da edera ed
alloro"), due in Esiodo (Theog. 30 kaiv moi skh'ptron e[don davfnh" ejriqhlevo" o[zon
“e mi diedero come scettro un florido ramo di alloro”; Op. 435 davfnh" d∆h] ptelevh"
ajkiwvtatoi iJstoboh'e" “di alloro o di olmo, il più possibile immuni dai tarli, siano
timoni dell’aratro”). Per le attestazioni nella “lirica arcaica” cfr. Anacr. fr. 98 Davies =
76 Gentili ãejnà melamfuvllwi davfnai clwra'i t∆ ejlai vai tantalivzei•”oscilla nel
lauro dalle foglie brune e nell’ulivo verdeggiante”; Stes. fr. S17.8 oJ d∆ ej" a[lso" e[ba
davfnaisi kata- / skioven posi; pai'" Dio;" “egli verso il bosco ombreggiato di lauri /
si avviò a piedi, il figlio di Zeus…”; Ibyc. fr. 34 Muvrta te kai; i[a kai; eJlivcruso" /
ma'lav te kai; rJovda kai; tevreina davfna “mirto e viole ed elicriso / pomi e rose e
tenero alloro”; Pi. P. X 40 davfnai te crusevai kovma" ajnadhv- / sante" “cinti
dall’aureo lauro nelle chiome”; Pi. Paen. 52i.58 Sn.-M. da- / fn≥[a; Pi. Parth. fr. 94b.8
Sn.-M. o{rpak∆ajgl≥aovn / davfna" “uno splendido germoglio di lauro”; Pi. Parth. fr.
94b.69 Sn.-M. davfna" eujpetavlou “di alloro dai bei petali”.
3 L’espressione pa;n d∆a[dion non trova riscontro altrove nella “letteratura greca”.
Per a[dion cfr. Sapph. DV lV 9 = 88.9 V. ].d∆a[dion eijsor[ “…ma più dolce a vedere”;
Alc. 123.4 V. ] a[dion[ “più dolce”.
4 Per kh'non (= att. ejkei'non; ion. kei'non) cfr. Sapph. 26.3; 31.1; 141.4; 163; 165;
Alc. 14.21; 68.4; 70.6; 72.7; 73.7; 112.11; 113.3; 127.6; 129; 200.2; 283.14; 289.5; inc.
auct. 29.2; 34a.16. E cfr. anche Sapph. 15.5; Alc. 50.6; 128A.2.
6 oJdoipovro" (ojdoivporo" in eolico) è già attestato in Il. XXIV 375 o{" moi
toiovnd∆h|ken oJdoipovron ajntibolh'sai "che mi ha fatto incontrare un simile viandante".
Cfr. Aeschl. Ag. 901 oJdoipovrwi diyw'nti phgai'on rJevo" "corrente d'acqua sorgiva per
il viandante assetato"; Soph. OT 292 qanei'n ejlevcqh prov" tinwn oJdoipovrwn "si
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
231
diceva che fosse morto per mano di alcuni viandanti"; Ar. Ach. 204-5 th'ide pa'" e{pou,
divwke kai; to;n a[ndra punqavnou / tw'n oJdoipovrwn "seguitelo per di qui, inseguitelo
ed informatevi su quell'uomo / da tutti i viandanti"; Theocr. XII 9 hjelivou fruvgonto"
oJdoipovro" e[dramon w{" ti" "sono corso come un viandante quando il sole brucia";
XXIII 47 ããtou'ton e[rw" e[kteinen: oJdoipovre mh; parodeuvshi", / ajlla; sta;" tovde
levxon, ajphneva ei\cen eJtai'ronÃÃ "Eros ha ucciso costui: viandante non passare oltre, /
ma, dopo esserti fermato, pronuncia questa parola: aveva un amico crudele"; XXV 187
oi{ dev nu kai; yeuvdesqai oJdoipovron ajnevr∆e[fanto "ed alcuni dicevano anche che il
viandante mentiva"; Ep. XV 1-2 gnwvsomai, ei[ ti nevmei" ajgaqoi'" plevon, h] kai; oJ
deilov" / ejk sevqen wJsauvtw" i\son oJdoipovr∆e[cei "saprò, viandante, se riservi
qualcosa di più agli uomini validi oppure anche il vile / da te ha parimenti l'uguale".
ojdoivporo" a[n[qrwp]o≥"≥, integrazione di Puglia (apud Ferrari 2007a, 25-26) cfr.
oJdoipovron ajnevr∆ di Theocr. XXV 187, passo appena citato. Per Treu, come si è detto,
la figura del viandante doveva essere introdotta in funzione censoria; per Ferrari (2007a,
26 n. 3), invece, essa sarebbe in relazione al motivo del riparo dalla calura estiva.
7 Per muvgi" (= movgi") cfr. Jo. Gramm. De comp. 3.10; Hdn. III 2.364.6 kai; para;
toi'" Aijoleu'sin euJrivskomen to; movgi" muvgi". Per muvgi" (= movgi") d(ev); cfr. Sapph.
213A g.46sgg. = S2 col. 2.46-47 muv- / gi"≥≥ d≥-; Il. IX 355 movgi" dev meu e[kfugen
oJrmhvn "ma a stento si sottrasse al mio assalto"; XXI 417 movgi" d∆ejsageivreto qumovn
"ma a stento riaccoglieva animo"; Od. III 119 movgi" d∆ejtevlesse Kronivwn "ma alla
fine compì l'impresa il Cronide"; XIX 189 movgi" d∆uJpavluxen ajevlla" "a stento sfuggì
alle tempeste". L'espressione non trova altre attestazioni nella poesia arcaica.
8 Per yuvca in funzione di apostrofe cfr. Pi. P. III 61 fivla yucav; Eur. Ion 859 w\
yucav; IT 839 yucav. Con ajgapavta sun≥ [ Saffo si rivolge, molto probabilmente, alla
figlia Cleide, ma cfr. Sapph. 132.1sgg.: e[sti moi kavla pavi" crusivoisin ajnqevmoisin
/ ejmfevrhãnà e[coisa movrfan Klevi" ajgapavta… "ho una bella figlia nell'aspetto simile
ai fiori dorati, Cleide diletta…". Per l'aggettivo ajgaphtov" cfr. Il. VI 401 JEktorivdhn
ajgaphtovn "il figlio amato di Ettore" (di Astianatte); Od. II 365 ejw;n ajgaphtov" "tu che
sei amato" (detto da Euríclea a Telemaco); Od. IV 817 pai'" ajgaphto;" (detto da
Penelope di Telemaco). In Omero questo aggettivo verbale si usa solo in riferimento ai
figli unici: Astianatte e Telemaco. Per il suo uso nei riguardi di Telemaco cfr. anche,
oltre ai passi sopracitati, Od. IV 727a (=V 18) nu'n au\ pai'd∆ajgaphto;n “ora anche il
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
232
figlio diletto…”. E cfr. anche Ar. Thesm. 761 th;n ajgaphth;n pai'dav sou "la figlia tua
prediletta"; Plat. Alc. I 131e ou[t∆ejgevneq∆, wJ" e[oiken, jAlkibiavdhi tw'i Kleinivou
ejrasth;" ou[t∆e[stin ajll∆h] ei|" movno", kai; ou|to" ajgaphtov", Swkravth" oJ
Swfronivskou kai; Fainarevth" "non ci fu, come sembra, un amante per Alcibiade
figlio di Clinia, né ce n'è fuorché uno solo e costui è desiderabile, Socrate figlio di
Sofronisco e di Fenarete"; Demosth. XXI 165 Nikhvrato"...oJ tou' Nikivou, oJ
ajgaphtov", oJ pai'" "Nicerato, il figlio prediletto di Nicia".
9 Per e[mm≥≥[at∆e[coisai, integrazione proposta da Ferrari (2007a, 25-26) cfr.
Fragm. Adesp. 9.2-3 PMG paivsai parqenikaiv, paivsai kala; e[mmat∆ ejcoivsa[i], /
kala; me;n e[mmat∆ ejcoivsai. E si ricordi anche un famoso verso iliadico, foneticamente
vicino a e[mmat∆ ejcoivsai: Il. I 14 (= 373) stevmmat∆ e[cwn ejn cersi;n eJkhbovlou
jApovllwno" “e tra le mani aveva le bende sacre di Apollo lungisaettante”: è il
quattordicesimo verso dell’Iliade e Saffo, molto probabilmente, lo avrà conosciuto a
memoria.
10 Per ajgana[ cfr. Sapph. 96.15-16 ajgavna"...[Atqido" "della dolce Attide"; Il. II
164 ajganoi'" ejpevessin "con cortesi parole"; Od. II 230 mhv ti" e[ti provfrwn ajgano;"
kai; h[pio" e[stw "nessuno più sia disponibile, amabile e mite"; Pi. P. II 8 ajganai'sin
ejn cevrsin "nelle piacevoli mani"; IV 101 ajganoi'si lovgoi" "con miti parole"; Isth. III
8 ajganai'" carivtessin. L'aggettivo non è mai attestato in tragedia, tranne Aeschl. Ag.
101, dove è lezione di tutti i codici (ajgana; faivnei" M : ajgana; faivnei V: ajgana;
faivnous∆ FGT), ma non è accettata dagli editori.
11 e[fqate: è l'unica attestazione del verbo fqavnw nei poeti eolici. Secondo Ferrari
(2007a, 26) Saffo starebbe qui dicendo che le ragazze hanno fatto in tempo a giungere al
luogo prefissato, indossando vesti adeguate (tevauta de; nu'n e[mm≥[ata) all’occasione.
qV (63 L.-P. = V. + 87 (13) L.-P.) metrum: hipp
2cho suppl. Possis
[Onoire mevlaina[
f[o]ivtai", o[ta t∆u[pno" [
g—luvku"≥ q≥[ev]o", h\ dei'n∆ojniva" m[ ]
za; cw'ri" e[chn ta;n duvnam[in ]
5 e[ —lpi" dev m∆e[cei mh; pedevch[n ]h≥sqa mhde;n makavrwn ejl≥[pom ka]rpon a[ban o≥—u≥j gavr k∆e[on ou[tw[ v ]
ajquvrmata ka.[ ]esqai:
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
233
g—evnoito dev moi[ ]
10 toi;" pavnta[ ]. — O Sogno, che (attraverso) la nera (notte)...
ti aggiri, quando il sonno ti…
dolce divinità, davvero terribil- affanni…
lontano tenere la forza…
ma mi possiede la speranza di non aver parte…
per niente dei beati io spero…giovinezza dai molti frutti
infatti non sarei così…
giocattoli e…
ma tocchi a me…
coloro che tutto… TEST (I) POxy. 1787 fr. 3 col. II 15-24 prim. rec. Diehl
1 1923, 359sq.
(II) POxy. 2166 (d) 3, editum a L.-P. ut Sapph. 87(13), non editum a Voigt.
(I) et (II) coni. Puglia apud Ferrari 2007a, 188-189 ad v. 10 marg. sin. (I)
coronis.
CRIT 1 e.g. melaivna[" dia; nuvkto" vel melaivna[i" pteruvgessin Hunt 1922, 31 et 42
: -[n kata; nuvkt∆o]" Snell ║2 f[.v]i(I) ovtat∆u[p(I) e.g. [kataceuvhi blefavroisi lavqan vel [blevfar∆a[mmin kata; dh; kaluvyhi Hunt 1922, 31 et 43 :
[katevchi me Latte 1949, 232 n. 1 conl. Theocr. 11, 22 o[kka gluku;" u[pno" e[chi me ║3 luv(I) q≥[.v]o"(I): suppl. Hunt 1922, 31 "gl. q. et ad u[pn. (tum [U. scribendum) et ad o[n. (sic Treu ad l.) referri potest" Voigt 1971, 81
h'dein∆(I) oniva –(I) m[navmata Diehl1 1923, 359
: gluvku" qevo":
h\ dei'n∆ojniva" m[navmat∆:e[gw ga;r oi \da Di Benedetto 2005a, 15 : m[anuvmata Ferrari
2007a, 188 e.g. fin. a[mmi faivnhi" vel fevrhi" Ferrari 2007a, 188 ║4
za;cw'risevc(I) duvnam[in Diehl1 1923, 359, rec. Ferrari 2007a, 188 : za; cw'ri"
e[chn ta;n duvnam[in ph'le qevoi" ajp∆ajmmevwn Di Benedetto 2005a, 15 ║5
devm∆(I) devc(I) pedevch[n Hunt 1922, 31 ]e≥sqa, "apex tantum litterae
e", L.-P. 1955, 63 : fevr]h≥sqa Puglia apud Ferrari 2007a, 188 ║6 e[l≥[p- Diehl1 1923,
359 : e[l≥[pom∆e[gwn Schadewaldt 1936, 371 n. 1: e[l≥[pom∆e[chn di;" poluvka]rpon Ferrari 2007a, 188 ║7 inter vv. 6 et 7 paragraphos suppl. oj≥u≥ (I) vix legi et
dispici potest gavr(I) kevon(I) ovutw≥(I) fin. w[ste Puglia apud
Ferrari 2007a, 188 ║8 qu±vr(I) l[, n[, k[ simm. omnes editores legerunt, sed
vestigia etiam ut i[ interpretari possunt : kai;≥[ scripsit Ferrari 2007a, 188 fort. fin.
mav[esqai Ferrari 2007a, 188 ║9 fort. [gh'ra" Ferrari 2007a, 188 ║10 ].(II) ut
apex hastae dextrorsum ascendentis leg. L.-P. 1955, 63 post 10 2 versuus vacui in (II)
sunt, sed in 9 vestigia hastae horizontalis ("fort. non est litterae pars" L.-P. 1955, 63)
Il carme si presenta come un'invocazione rivolta ad [Oneiro", il Sogno. Per l'invocazione
di Oneiros cfr. Il. II 6-8, dove Zeus decide di mandare ad Achille il Sogno maligno per
dare, attraverso quest'ultimo, suggerimenti dannosi all'armata greca: pevmpyai ejp∆
jAtrei?dhi jAgamevmnoni ou\lon ]Oneiron […] bavsk∆i[qi, ou\le [Oneire, qoa;" ejpi; nh'a"
jAcaiw'n "mandare all'Atride Agamennone il Sogno maligno […] / va', Sogno funesto,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
234
alle rapide navi degli Achei". [Onoiro" in quest'ode è personificato, proprio come nel
famoso passo dell'Iliade appena citato. Nell'Odissea (XIX 555sgg.) Penelope si cimenta
in una sorta di spiegazione ontologica del Sogno: to;n d∆au\te proseveipe perivfrwn
Phnelovpeia: / ããxei'n∆, h \ toi me;n o[neiroi ajmhvcanoi ajkritovmuqoi / givgnont∆, oujdev
ti pavnta teleivetai ajnqrwvpoisi. / doiai; gavr te puvlai ajmenhnw'n eijsi;n ojneivrwn:
/ aiJ me;n ga;r keravessi teteuvcatai, aiJ d∆ejlevfanti: / tw'n oi} mevn k∆e[lqwsi dia;
pristou' ejlevfanto", / oi{ rJ∆ejlefaivrontai, e[pe∆ajkravanta fevronte": / oiJ de; dia;
xestw'n keravwn e[lqwsi quvraze, / oi{ rJ∆e[tuma kraivnousi, brotw'n o{te kevn ti"
i[dhtai. "Ed a lui disse in risposta l'avveduta Penelope: / straniero, certo i sogni son
incomprensibili ed inesplicabili / e non tutto si avvera per gli uomini. / Due, infatti, son
le porte dei sogni inconsistenti: / una è fatta con battenti di corno, l'altra d'avorio: /
quelli che vanno attraverso l'avorio segato / sono ingannati, vane parole portando; /
coloro che vanno attraverso il levigato corno fuor della porta, / costoro veramente si
compiono, quando un mortale li veda". Per l'autore dell' Odissea il popolo dei Sogni si
trova presso il prato asfoldeo, dove sono anche i morti, cfr. Od. XXIV 11sgg. pa;r d∆
i[san jWkeanou' te rJoa;" kai; Leukavda pevtrhn, / hjde; par∆ jHelivoio puvla" kai;
dh'mon ojneivrwn / h[i>san: ai\ya d∆ i{konto kat∆ajsfoledo;n leimw'na, / e[nqa te
naivousi yucaiv, ei[dwla kamovntwn "giunsero presso le correnti d'Oceano ed alla rupe
di Leucade / ed alle porte del Sole e presso il popolo dei Sogni / arrivarono: e subito
giunsero presso il prato asfodelo, / dove abitano le ombre, parvenze dei morti". Esiodo
(Theog. 211-212) nomina la stirpe dei Sogni tra i figli della Notte: Nu;x d∆e[teke
stugerovn te Movron kai; Kh'ra mevlainan / kai; Qavnaton, tevke d∆ {Upnon, e[tikte
de; fu'lon jOneivrwn "E la Notte partorì Moros e la nera Ker / e Morte, generò Sonno,
generò la stirpe dei Sogni". E cfr. Ar. Ran. 1334-35, dove il Sogno è melaivna" / pai'da
nuktov" "figlio della nera notte". Euripide, all'immagine dei Sogni come figli della Notte
sostiuisce quella dei Sogni figli della Terra, per cui cfr. Eur. Hec. 70sg. w\ povtnia Cqwvn
/ melanopteruvgwn mh'ter ojneivrwn "O possente Terra, madre dei Sogni dalle nere
ali…" e Eur. IT. 1262 Cqw;n ejteknwvsato favsmat∆ojãneivrwnà "la Terra generò le
visioni dei sogni". Tra gli Innni Orfici, uno è rivolto al Sogno, [Orph.] Hymn. 86:
Kiklhvskw se, mavkar, tanusivptere, ou\le [Oneire, / a[ggele mellovntwn, qnhtoi'"
crhsmwide; mevgiste: / hJsuciai ga;r u{pnou glukerou' sighlo;" ejpelqwvn, /
prosfwnw'n yucai'" qnhtw'n novon aujto;" ejgeivrei", / kai; gnwvma" makavrwn aujto;"
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
235
kaq∆ u{pnou" uJpopevmpei", / sigw'n sigwvsai" yucai'" mevllonta profwnw'n, / oi|sin
ejp∆ eujsebivhisi qew'n novo" ejsqlo;" oJdeuvei, / wJ" a]n ajei; to; kalo;n mevllon,
gnwvmhisi prolhfqevn, / terpwlai'" uJpavghi bivon ajnqrwvpwn procarevntwn, / tw'n de;
kakw'n ajnavpaulan, o{pw" qeo;" aujto;" ejnivsphi / eujcwlai'" qusivai" te covlon
luvswsin ajnavktwn. / eujsebevsin ga;r ajei; to; tevlo" glukerwvterovn ejsti, / toi'" de;
kakoi'" oujde;n faivnei mevllousan ajnavgkhn / o[yi" ojneirhvessa, kakw'n ejxavggelo"
e[rgwn, / o[fra mh; eu{rwntai luvsin a[lgeo" ejrcomevnoio. / ajllav, mavkar, livtomaiv
se qew'n mhnuvmata fravzein, / wJ" a]n ajei; gnwvmai" ojrqai'" kata; pavnta pelavzhi"
/ mhde;n ejp∆ajllokovtoisi kakw'n shmei'a profaivnwn. "invoco te, beato, dalle ali
distese, Sogno funesto / nunzio dei casi futuri, grandissimo indovino per i mortali; /
infatti, giunto silenzioso nella quiete del dolce sonno, / parlando alle anime del mortali
risvegli la mente / e le intenzioni dei beati invii in segreto nel sonno / stando in silenzio
annunci alle anime silenziose il futuro / a quelli a cui secondo gli atti di pietà procede
propizia la mente degli dei / affinchè sempre il bel futuro, appreso in precedenza nei
pensieri, / conduca ai piaceri la vita degli uomini che prima han gioito / e, pausa dei
mali, come lo stesso dio dica, / con preghiere e sacrifici sciolgano l'ira dei sovrani. / Per
i pii, infatti, sempre il fine è più dolce, / ai malvagi, invece, non mostra la necessità a
venire / la visione dei sogni, messaggera di cattive azioni, / affinchè non trovino
liberazione dal dolore che avanza. / Ma, beato, ti supplico di esporre le indicazioni degli
dei, / affichè sempre in ogni occasione ti avvicini con retti pensieri / non mostrando
alcun presagio dei mali riguardo a situazioni sfavorevoli". Per Treu (1976, 204-205)
l'ode è un dialogo ad una sola voce con il Sogno in cui quest'ultimo non può rispondere:
negli ultimi versi l'"ego" sembra trovare autonomamente una risposta positiva.
1 Che o[noire sia la forma eolica lo afferma Choerob. Peri; ojrqografiva", An. Ox.
2, 209, 32sgg. Cramer: oiJ Aijolei'"...o[neiro" o[noiro". Il termine non sembra attestato
altrove nei frammenti a noi giunti di Saffo e di Alceo. Il primo editore, Hunt (1922, 42)
proponeva di integrare o melaivna[" dia; nuvkto" "attraverso la nera notte" oppure
melaivna[i" pteruvgessin "con le nere ali". Per melaivna" ...nuvkto" cfr. Il. XV 324
melaivnh" nukto;" "della nera notte"; [Hom.] Hymn. Merc. 68 (= 290) melaivnh"
nukto;"; 358 melaivnhi nukti;; Aeschl. Pers. 357 melaivnh" nukto;"; Eur. Cycl. 601 suv
t∆, w\ melaivnh" Nukto;" ejkpaivdeum∆, {Upmne "E tu, figlio della nera Notte, Sogno";
Hippol. 1388 mevlaina nuvkterov" t∆ajnavgka "nera, notturna fatalità"; fr. 101.1 mevlaina
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
236
nuvx; Ar. Ran. 1334-5 melaivna" /...nuktov"; A. P. VII 713.3-4 melaivnh" / Nukto;". Snell
ha proposto di integrare, invece, melaivna[n kata; nukt∆o]".
2-3 Per f[o]ivtai" come un errare notturno cfr. Aeschl. Pr. 657 nuktivfoit∆ojneivrata,
che è lezione di alcuni manoscritti, mentre altri, compreso il Mediceo M, hanno
nuktivfant∆ ojneivrata, accettato dalla maggioranza degli editori moderni. Per
nuktivfoit∆ cfr. Lyc. Alex. 225 nuktivfoita deivmata "incubi che vagano di notte"; Ant.
Lib. 15.2 nuktivfoiton...qevon "divinità che vaga di notte" (detto di Artemide); Syn. IV
37 meta; nuktivfoiton o[rfnan "dopo l'oscurità che vaga di notte". gluvku" qevo" è un
unicismo, ma per u[pno" [ / gluvku" (qevo") cfr. Il. I 609-10 Zeu;" de; pro;" o{n levco"
h[i> j jOluvmpio" ajsterophthv", / e[nqa pa;ro" koima'q∆o{te min gluku;" u{pno" iJkavnoi
"anche Zeus Olimpio che scaglia fulmini andò nel suo letto / dove solitamente si corica
quando il dolce sonno lo raggiunga" (altre 14 volte tra Iliade ed Odissea: Il. II 71; XXIII
232; Od. II 395; VII 289; VIII 445; IX 333; X 31; X 548; XII 338; XIII 282; XVIII 188;
XVIII 199; XIX 49; XXIII 342); [Hom.] Hymn. Merc. 8 o[fra kata; gluku;" u{pno"
e[coi leukwvlenon {Hrhn "finchè il dolce sonno prendeva Elena dalle bianche braccia";
Hymn. Ven. 170 th'mo" a[r∆ jAgcivshi me;n ejpi; gluku;n u{pnon e[ceuen "allora versò su
Anchise un dolce sonno"; [Hom.] Hymn. XVIII 8 eu\te kata; gluku;" u{pno" e[coi
leukwvlenon {Hrhn "mentre il dolce sonno teneva Hera dalle bianche braccia"; Pi. P.
IX 23-25 to;n de; suvgkoiton glukuvn / pau'ron ejpi; glefavroi" / u{pnon ajnalivskoisa
rJevponta pro;" ajw' "ma breve tempo consumando il sonno, il dolce compagno di letto,
che scende sulle palpebre verso l'Aurora". Questo passo di Saffo sembra essere stato
ripreso, in qualche modo, da Theoc. XI 22 foith'i" d∆au \q∆ou{tw", o{kka gluku;" u{pno"
e[chi me / oi[chi d∆eujqu;" ijoi's∆, o{kka gluku;" u{pno" ajnh'i me "qui ti aggiri, quando
il dolce sonno mi possiede / ma subito te ne vai via, quando il dolce sonno mi
abbandona", donde il Latte (1949, 232 n.1) ha tratto la possibile integrazione [katevchi
me, che può trovare sostegno, riteniamo, anche in due passi degli Inni omerici sopra
citati. E cfr. anche Opp. Cyn. II 34; Mosch. fr. 1.11; [Orph.] Hymn. LXXVIII 9; Nonn.
D. XVI 98; XVI 387; XVIII 208; XXXXVII 289; XLVIII 538; XLVIII 875; A.P. VII
260.7; XII 138.3. Hunt (1922, 31, 43) proponeva di integrare, invece, [kataceuvhi
blefavroisi lavqan oppure [blevfar∆a[mmin kata; dh; kaluvyhi. Treu (1976, 204) ritiene
che gluvku" qevo" possa riferirsi sia a ]Onoire, sia a [Upno", che, in questo caso, sarebbe
anche esso personificato ("tum ]U. scribend." riassume Voigt 1971, 81), ma non
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
237
crediamo che sia possibile riferirlo a ]Onoire, sia per i passi citati precedentemente – che
dimostrano un nesso gluvku" u{pno" –, sia per il fatto che Oneiros è talvolta qualificato
come ou\lo" "funesto" nella tradizione letteraria greca (oltre alle attestazioni riportate
nella nota precedente, cfr. [Orph.] Hymn. 86.1 - per il confronto con quest'inno orfico v.
infra-; [Orph.] Arg. 776 ou\lon o[neiron ), sia perché – terzo, ma non ultimo argomento –
se ]Onoire fosse veramente (come sembra) il soggetto di "davvero terribil- d'angoscia"
del v. 3, non si capirebbe come potrebbe essere un gluvku" qevo": gluvku" qevo" va,
dunque, riferito ad [Upno". Se, dunque, gluvku" qevo" si riferisce a [Upno", quest'ultimo
deve essere una personificazione, come per primo riconobbe non già il Treu, bensì il
Diehl1
(1923, 359). Per {Upno" come personificazione cfr., prima ancora di Hes. Theog.
212 proposto e.g. dal Diehl, Il. XIV 233 {Upne, a[nax pavntwn te qew'n pavntwn
t∆ajnqrwvpwn "Sonno, signore di tutti gli dei e di tutti gli uomini" e v. infra.
3 Treu (1976, 204) interpreta dei'n∆ come un avverbio ma, come nota la Voigt (1971,
81), non è necessario: potrebbe anche essere un neutro plurale da riferire a ciò che segue.
ojniva" è un genitivo singolare e non un accusativo plurale come sembra essere inteso da
Ferrari 1987, 151, che traduce "davvero terribilmente affanni": oltre ad un argomento
grammaticale (l'accusativo plurale eolico è ojnivai", attestato da Alc. 353.1), vale anche
uno logico, perché, nel caso di un accusativo plurale, verrebbe naturale una concordanza
con l'aggettivo precedente che, invece, è, a quanto sembra, un neutro plurale. Per ojniva"
cfr. inc. auct. 18.1 ojnivan te kujgieivan; Sapph. 1.3 mhd∆ojnivaisin "né con tormenti";
5.10 [ojn]ivan de; luvgran "dagli infelici tormenti"; Alc. 353.1 mhd∆ojnivai" "né tormenti".
m[navmata è integrazione di Diehl1 (1923, 359) anche se Diehl sembra,
inspiegabilmente, attribuirla a Hunt (se così si può intendere l'abbreviazione Gr.-Hu.). Di
Benedetto (2005a, 15) integra gluvku" qevo": h\ dei'n∆ojniva" m[navmat∆:e[gw ga;r oi \da e
traduce "dolce dio. Sì, sono tremendi i ricordi della sofferenza. Ed io lo so…". Ferrari
(2007a, 188-189) integra m[anuvmata e propone il confronto con [Orph.] Hymn. 86.16
ajllav, mavkar, livtomaiv se qew'n mhnuvmata fravzein "ma, beato, ti prego, dimmi le
volontà degli dei", che è anche uno dei pochissimi passi (due, per l'esattezza: l'altro è
Men. Epitr. 423) in cui questo termine è attestato in poesia classica.
4Per za; cw'ri" e[chn ta;n duvnam[in Schadewaldt (1936, 371 n. 1) propone il confronto
con Pi. N. 6.1 sgg. e{n ajndrw'n, e{n qew'n gevno": ejk mia'" de; pnevomen matro;"
ajmfovteroi: dieivrgei de; pa'sa kekrimevna duvnami", wJ" to; me;n oujdevn, oJ de;
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
238
cavlkeo" ajsfale;" aije;n e{do" mevnei oujranov". "una è la stirpe degli uomini, una
quella degli dei: respiriamo entrambi da una madre, ma ci divide tutta la forza divisa,
ché nulla da una parte, il cielo di bronzo, sede sicura, dall'altra sempre permane". Di
Benedetto (2005a, 15) propone di integrare za; cw'ri" e[chn ta;n duvnam[in ph'le qevoi"
ajp∆ajmmevwn e traduce"…che distinta e separata tengono gli dei la loro capacità di
azione lontano da noi". Per Ferrari e per Puglia (Ferrari 2007a, 189 n. 1) non si tratta,
tuttavia, della diversità di poteri tra uomini e dei, ma dell'impossibilità di spezzare il
legame inscindibile tra {Upno" - in Omero qualificato come nhvdumo" (cfr. Il. XIV 242 e
354; la tessera è poi ripresa da Nonn. Dionys. XV 88) ed in Sofocle come ojduvna" ajdahv"
(Soph. Ph. 828 {Upn∆ojduvna" ajdahv", {Upne d∆ajlgevwn, eujae;" hJmi'n / e]lqoi" "sonno
d'angoscia ignaro e dei mali, propizio a noi vieni") – "e quello (angoscioso) di Oneiros".
5 Per pedevch[n cfr. Sapph. 55.2 ouj ga;r pedevchi" brovdwn / tw;n ejk Pieriva" "infatti
non hai parte delle rose della Pieria"; 16.22 p]edevchn d∆a[rasqai "ma pregono di aver
parte"; Alc. 10.2 e[me deivlan, e[me paivsan kakotavtwn / pedevcoisan "me misera, me
di tutti i mali peggiori / partecipe"; 38b.5 pevdec[.].[; 70.3 ajquvrei pedevcwn sumposivw
"canta prendendo parte al simposio"; 317b ajlla; sauvtwãià pedevcwn †a[ba" pro;"
povsin† "ma con te partecipando…giovinezza al bere". Puglia ha combinato la parte
finale di questo verso con il primo verso (]h≥sqa) di un frustolo del POxy. 1787 non
pubblicato dalla Voigt, ma solo da Lobel-Page ed ha proposto di integrare fevr]h≥sqa.
6 Già Diehl1 (1923, 359) aveva proposto di integrare ej≥l≥[p (del resto occorre, in quella
sede, una sillaba lunga) e successivamente lo Schadewaldt (1936, 371 n. 1), precisando
l'ipotesi già caldeggiata dal Diehl, propose di integrare e[l[pom∆e[gwn "io spero". Ferrari
(2007a, 188-189) integra, accettando in parte il teso dello Schadewaldt ed una
integrazione proposta da Puglia (poluvka]rpon), mhde;n makavrwn ejl≥[pom∆e[chn di;"
poluvka]rpon a[ban, traduce "io non spero di avere due volte la giovinezza feconda dei
beati" e propone il confronto con Thgn. 1009sg. ouj ga;r ajnhba'n / di;" pevletai pro;"
qew'n oujde; luvsi" qanavtou / qnhtoi's∆ajnqrwvpoisi "l'essere giovani due volte, infatti,
alla presenza degli dei non si dà, né agli uomini, mortali, liberazione dalla morte". Per
makavrwn cfr. Sapph. 44 A a.8 qevwn makavrwn pavthr "il padre degli dei beati"; Alc.
5.7 pro;" makav≥rwn q≥evwn≥; 129.4 ajqanavtwn makavrwn "dei beati immortali"; 130b.13
makavrwn ej" tevmeno" qevwn "all'altare degli dei beati"; 298.19 ].:t≥a m≥akavrwn;
117b.16 ] D≥ivo["] k≥ai; m[a]ka≥vrwn qevwn "di Zeus e degli dei beati". Per questo aggettivo
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
239
/ sostantivo nei poeti eolici cfr. anche Alc. 42.6 pavnta" ej" gavmon mavk≥[ara"
kalevssai" "chiamati a nozze tutti gli immortali"(sost.); Sapph. 1.13 mavkaira (sost.
voc.); DV iV = 68a.6 V. mavka[ir]a; 95.9 o]uj ma; ga;r mavkairan≥ [ "no, per la dea
(beata)"; DV iaV 6 = 81.6 V. Cavrite" mavkairaãià "beate Cariti"; Alc. 112.19 maka....[;
Sapph. 15b.1 makai[r; 3, 16 maka[.
La tessera poluvka]rpon a[ban (integrazione di Puglia) non è altrimenti attestata e
l'aggettivo poluvkarpo" è attestato sempre nel suo senso letterale, cioè "dai molti frutti"
in riferimento ad una vigna od ad un orto: Od. VII 122 e[nqa dev oiJ poluvkarpo" ajlwh;
ejrrivzwtai "ma là una fertile vigna era piantata"; XXIV 221 a\sson i[en polukavrpou
ajlwh'" peirhtivzwn "si avvicinò all'orto ricco di frutti per fare la prova"; Eur. Ph. 230-
1 poluvkarpon...bovtrun "fecondo…grappolo". Il composto più vicino a poluvka]rpon
a[ban è, come nota Ferrari (2007a, 189 n. 2), poluavnqemo" w{rh "stagione ricca di
fiori" (riferito alla primavera) di Mimn. 2.1 W.2; d'altronde in quel passo l'autore si
riferisce, contemporaneamente, sia alla primavera come stagione della natura, sia alla
primavera come stagione umana, cioè alla giovinezza: hJmei'" de; oi|av te fuvlla fuvei
poluavnqemo" w{rh / e[aro", o{t∆aujgh'i" au[xetai hjelivou, / toi's∆i[keloi phvcuion ejpi;
crovnon a[nqesin h{bh" / terpovmeqa "noi, quali le foglie che produce la stagione dai
molti frutti della / primavera, quando subito crescono ai raggi del sole, / così simili per
il tempo d'un cubito i fiori della giovinezza / godiamo…". Per poluavnqemo" w{rh cfr.
anche Numen. 582 SH poluavnqemon ei\ar. E cfr. anche Il. XIII 484 h{bh" a[nqo"; Tyrt.
10.28 W.2 h{bh" ajglao;n a[nqo" "splendido fiore della giovinezza"; Mimn. 1.4 W.
2
h{bh" a[nqea; Pi. O. VI 58 karpo;n {Hba".
7 Il Treu (1976, 60-61) completava la frase aggiungendo, solo nella traduzione,
"töricht", cioè intendeva la frase come "infatti non sarei così sciocca". Per ou]tw...w]ste
(oppure wJ"), con w[ste integrato da Puglia, cfr. Hdt. I 32 hJ d∆hJmetevrh eujdaimonivh
ou{tw toi ajpevrriptai ej" to; mhdevn, w{ste oujde; ijdiwtevwn ajndrw'n ajxivou" hJmeva"
ejpoivhsa" "la mia felicità è valutata così da nulla da non mettermi neppure alla pari
degli uomini privati?"; Xen. An. VII 4, 3 \Hn de; ciw;n pollh; kai; yu'co" ou{tw" w{ste
to; u{dwr ejfevronto ejpi; dei'pnon ejphvgnuto "c'era così tanta neve e ghiaccio che
l'acqua che portavano per la cena si ghiacciava". Per un'attestazione in poesia cfr. Soph.
Tr. 1126 e[cei ga;r ou]tw" w{ste mh; siga'n prevpein "è in una condizione tale che
non è adatto tacere". Talvolta w{ste è sostituito dal pronome relativo: Hdt. IV 52.3
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
240
krhvnh pikrhv, ou{tw dhv ti ejou'sa pikrhv, h} megavqei> smikrh; ejou'sa kirna'i to;n
{Upanin "una sorgente amara: è in un certo qual modo così amara che, pur essendo
piccola di grandezza, altera l'Ipani". Tra le attestazioni di questo tipo di espressione si
trova anche un passo molto vicino alla linea di interpretazione prospettata dal Treu; si
tratta di Soph. Ant. 220 oujk e[stin ou{tw mw'ro" o}" qanei'n ejra'i "nessuno è così folle
da aspirare a morire". Tuttavia, né mw'ra, né nhvpia, né a[frwn possono, metri causa,
essere integrati in questa sede. Più in generale, per ou]tw o ou]tw" seguito da aggettivo
cfr. Il. III 169 kalo;n d∆ou{tw ejgw;n ou[ pw i[don ojfqalmoi'sin / oujd∆ou{tw gerarovn
"ma così bello con gli occhi non ho mai visto nessuno, / né così nobile"; Od. XIII 238-9
oujdev ti livhn / ou{tw nwvnumov" ejstin"davvero non è qualcosa di così oscuro". E per la
prosa di età successive cfr. Thuc. II 47 loimo;"...fqora; ou{tw" "una pestilenza così
distruttiva".
8 Per ajquvrmata cfr. Sapph. 44.9 poivkil∆ajquvrmata; Il. XV 362 sgg. wJ" o{te ti"
yavmaqon pavi>" a[gci qalavssh" / o{" t∆ejpei; ou \n poihvshi ajquvrmata nhpievhisin
"come sulla riva del mare la sabbia un bambino / che, dopo aver costruito per gioco un
castello nella sua puerilità…"; Od. XV 415 sgg. [Enqa de; Foivnike" nausivklutoi
h[luqon a[ndre" / trw'ktai, muriva[gonte" ajquvrmata nhi÷ melaivnhi "Qui giunsero i
Fenici, navigatori famosi, / furfanti, cianfrusaglie infinite sulla nera nave portando";
Od. XVIII 323 pai'da de; w{" ajtivtalle, divdou d∆a[r∆ajquvrmata qumw'i "l'allevò come
figlia e le dava giocattoli".
9 Per l'espressione gevnoito dev moi[ cfr Alcm. 1.74 PMGF jAstafiv" [t]ev moi gevnoito
"Astafi sia mia"; Archil. 118 W.2 eij ga;r w}" ejmoi; gevnoito cei'ra Neobouvlh" qigei'n
"Oh, se potessi infatti toccare così Neobule nella mano"; Thgn. 1300 ajllav tiv moi
tevrma gevnoito kicei'n "oh, potessi raggiungere la meta"; [Anacr.] 36.12 e[moi
gevnoito pivnein "oh, mi toccasse di bere"; Hippon. 119 W.2 ei[ moi gevnoito parqevno"
kalhv te kai; tevreina "oh, se mi toccasse una fanciulla bella e delicata"; Coppa attica
del V sec. (pubblicata da J. Boehlau, «Phil.» 60 (1901), p. 329) e]i[ moi gevnoito;
Theocr. XVI 19 aujtw'i moiv ti gevnoito. Si tratta di uno stilema tipico della poesia
arcaica popolare, soprattutto di contenuto erotico.
10 "coloro che tutto (possono?)": probabilmente si tratta di una perifrasi per indicare gli
dei, come crede Treu (1976, 204).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
241
iV (68a+70+75a L.-P. = V. = a; 68b+69 L.-P. =V. = b ) metrum: hipp2cho
suppl. possis
a
õ]..[.].Õ.gavr majpu; ta;" e[m≥[a" ga'" a≥[mi[l]lajÕ[pekivn]õh≥sajdo≥[kht u[]Õmw" de[gen[to m]n≥a'mÕ[ ]õl≥a[ ] Õi[san qevoisin, nu']n≥ dei\m ejÕ[pi; o[]õnivan [ ]Õa[san ajlivtrai≥
5 ejpo]r≥somevnÕ[a su;n doj]õd≥uvn≥[aisjAn]Õdromevdan [uj]pavx[ei ajpav]likujpa[Õ[rmujy]õimevdo[is]Õ [Ar[temi]" aj mavka[ir]a, aj d]o≥u≥jk≥ [aj]bavÕ[khn]õ ma;n≥ stev[r]Õe≥≥on de; trovpon a[ijs]cuvnhtai: ou[ti]" ga;r e[pauÕõ[s ].k[ ]Õk≥ovro≥n ouj kativsc≥ei. h\] mavn kajpu≥vq≥usÕ[w\]õk≥≥aj[gevla]n≥ T≥undarivdai[sin a[rnwn
10 ] ajrmoniva" d≥Õõajsu[c]i≥va≥[i] ka;[t] cariventa[.[g]avqhn covron, a\, aÕ[i[]õka[dolon [m]hkevti sun[
pa'ktin] d≥e; livghan≥ÕõMegavran≥ [ta;]n aj[kavl]a[n lavboisan duvn]atovn sfi.[
]pavntessi [
15 ]ep[.].[ ]..[.]..infatti lontano dalla mia terra
una contesa mi cacciò improvvisamente […] e tuttavia
il ricordo fu […]uguale agli dei
ma ora andrò ad attaccare la colpevole dei tormenti e delle ansie
5 [e con pe]na la beata Artemide che governa dall'alto
condurrà sotto il carro l'attempata Andromeda,
sì che lei si vergognerà del suo carattere non quieto, ma duro.
Nessuno, difatti, ha messo fine[…]non trattiene la sazietà.
Certo, si potrebbe sacrificare subito ai Tindaridi
10 un gregge di agnelli e bello sarebbe gioire per una melodia
in un grazioso spazio di danza, ah, se francamente non più[…]
Megara la mite, presa l'arpa sonora[…]
[…]possibile[…]
[…]a tutti[…]
15 …
b
]....f[
].[.]∆quvram≥[en ]m≥oi cavlep≥[ai mevrimnai]de kuv[
5 ij]s≥opavlhn o[l≥[
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
242
]õ ejpÕ≥e≥õ[i; s]t≥evga mÕ[e ]a" ajlivtra[
]evt∆ auj[
…
…ci divertimmo (a cantare?)…
…a me penosi affanni
…Ci[pride?…
5 …uguale….
…poiché un tetto me…
…colpevole…
…
TEST (a) (I)POxy. 1787 fr. 7, quocum nova fragmenta, S.m. d — 9 prim. edd., [5-8
fines, 9-12 init.] coni. Lobel 1925, 32; vv. 6-8 acc. fragm. novum, Ox. Pap. XXI p. 135
prim. ed., coni. Lobel 1925, 32[1-12] (II)POxy. 1787 fr. 13 [1-15]
(III)POxy. 1787 fr. 29 [1-8] (I), (II) et (III) coni. Ferrari 2007a, 29-30
(b) POxy. 1787 fr. 19 ("ex eadem pap. parte, quo distent intervallo inc." Lobel
1925, 32) (IV) POxy. 1787 fr. 32 ("ex eadem fere papyri parte qua praecedentia
proficisci videtur" Lobel 1925, 33) (V)
CRIT (a) 1 ].l≥[.].[ Lobel 1925, 36 : ]h≥l≥[ vel ]h≥m≥[ possis L.-P. 1955, 53
hasta verticalis (I): ka]i; Hunt 1922, 33 gavr (I) m(I) vestigia hastae
recurvae (I): l[ vel m[ legit Voigt 1971, 84-85 : e[m≥[a" Treu 1976, 64, rec. Ferrari 2007a,
29-30 : e[m≥[a" ga'" Ferrari 2007a, 29-30 ║ 2 a≥ma≥ll≥[ Lobel 1925, 33 : "inter m et
l aut una lettera aut i[.]" L.-P. 1955, 49 et Voigt 1971, 86 : a≥m≥i≥[.]l≥ legi potest : a[≥m≥i≥[l]l∆ Ferrari 2007a, 29-30 a;d(III) aj[pekivn]h≥sajdo≥[kht Ferrari 2007a, 29-30
a[, l[ vel al. (I) leg. L.-P. 1955, 49 et Voigt 1971, 86 ]mw" (I): u[]mw" Hunt
1922, 33 e[gen[to Lobel 1925, 32 ║3 ]n≥am≥[ (II): m]n≥a'm[(a) vel m]n≥a'm∆[ouj Ferrari 2007a, 29-30 ]l≥a vel ]d≥≥a(III) leg. L.-P. 1955, 53 : fort. ajl]l≥a; Ferrari 2007a,
29-30 ivsan (I) ║4 nu']n Ferrari 2007a, 29-30 d∆ei'm∆(II) ej[pi; Ferrari 2007a, 29-30 iva –(III): ]ivan gen. pl. cog. Hunt 1922, 45 oj]nivan Prauscello asa –nalivt (I): a[san gen. pl. interpr. Diehl
1 1923, 361 ajlivtra[ Hunt
1925, 32 : ajlivtran≥ legit Ferrari 2007a, 29-30 : ajlivtrai≥ (dat. sg.) fort. legi potest ║5
post lacunam vestigia unius litterae rotundae (II): ]r≥ vel ]o≥ vel ]w≥ leg. Hunt 1922,
34 et 44, rec. Voigt 1971, 86 mevn(II) ]r≥somevn[ Hunt 1922, 34, Lobel 1925, 33, L.-
P. 1955, 49, Voigt 1971, 86 : ejpo]r≥somevn[a Ferrari 2007a, 30 ]d≥uvl[ ≥vel ]d≥uvm[ ≥ vel
]d≥uvn≥[ leg. L.-P. 1955, 53 : su;n d∆oj]d≥uvn≥[ais∆ Ferrari 2007a, 30 jAn]dromevdan Hunt 1922, 33 ]p vel ]m vel alia legerunt Lobel 1925, 32, L.-P. 1955, 48 et Voigt
1971, 84-85 : [uj]p≥avxei Ferrari 2007a, 30 ║6 .v]lik∆ vel .–]lik∆ (II): fort. a[]lik∆ Diehl
1 1923 : ajp]avlik∆ Ferrari 2007a, 30 a[[rmujy]imevdo[is]
[Ar[temi]" Ferrari 2007a, 30 ]t≥am≥a≥[..]a Lobel 1925, 32 : ]t≥am≥a≥ka≥[ legerunt L.-P. 1955, 48 et Voigt 1971, 84-85 : m≥av≥k≥a≥[ir]a Diehl
2 1936
║7 ]...[.]ba[ Hunt 1922, 34 : ante [.] n, l, k possis Lobel 1925, 33 et L.-P. 1955,
49 : ] o≥u≥jk≥ [aj]bav[khn] Ferrari 2007a, 30 ]ma–ste≥[ (III) leg. Hunt 1922,
36, Lobel 1925, 36, L.-P. 1955, 53 et Voigt 1971, 88-89 : ]ma" te≥[ edidit Hunt 1922, 37
: ]ma– a.c., ]ma –nste[ p.c. leg. Puglia apud Ferrari 2007a, 30 et edidit ut ]ma;n≥ ste≥v[r]-
ajrgavl]e≥on Treu 1976, 64 : ste≥v[r]e≥on Puglia apud Ferrari 2007a, 30 trov(I)
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
243
].uv (I): ]kuv Lobel 1925, 32 : ≥ ]cuv, ]kuv possis L.-P. 1955, 48; Voigt 1971, 84-85 :
fort. a[ijs]c≥uvnh[ (fut.) Voigt 1971, 85 : a[ijs]c≥uvnh[tai Ferrari 2007a, 30 ║8 omnia
supplevit Ferrari 2007a, 30 ║ 9 ]mavn (II), unde liquet k∆ scribendum esse Lobel 1925,
33 et L.-P.1955, 49 : "neque –man 1. p. sg. esse" Voigt 1971, 86 qus- syll. longa
s≥[ vel e≥[(II) ]n≥ vel ]r≥(I) leg. Lobel 1925, 32, L.-P. 1955, 48 et Voigt 1971, 85
rivd(I) Tundarivdai[" Hunt 1922, 33 cetera suppl. Ferrari 2007a,
30 ║10 fort. init. h\"] Puglia apud Ferrari 2007a, 30 nivas(II) de Harmoniae
nuptiis cog. Schadewaldt 1950, 140 ka[i;] Lobel 1925, 32, rec. Voigt 1971, 84-
85: ka[.] L.-P. 1955, 48 : ka;[t] Ferrari 2007a, 30 rivent∆a±(I) e≥[, r[,s[ vel alia
legerunt Lobel 1925, 32, L.-P. 1955, 48, Voigt 1971, 84-85 fort. fin. ajr≥[hvskoi Puglia apud Ferrari 2007a, 30 ║11 fort. polug]avqhn Diehl
1 1923, 363
conl. Pi.
fr. 29, 5 Sn. ta;n Diwnuvsou polugaqeva timavn (h] gavmon...jArmoniva" uJmnhvsomen;) :
g]avqhn Ferrari 2007a, 30 covron:av –a[, ut vid. (II): covron, a\, a[i[] Ferrari
2007a, 30 kavd-(I) [m]hkevti Hunt 1922, 33 kevt(I) ║12 pa'ktin]
Ferrari 2007a, 30 livg(II) de Megara cog. Lobel 1925, 32 conl.
Suida s.v. Sapfwv pro ]n≥ etiam ]i≥ possis [ta;]n Ferrari 2007a, 30 aj[kavl]a[n Ferrari 2007a, 30 "num akalan in abakhn corrigebatur?" Lobel
1925, 32 et L.-P. 1955, 48 ║13 tovn (II) : duvn]atovn sf≥i[ Ferrari 2007a, 30 ≥ (b) 2 extr. litt. l[, etiam k[, m[, n[, p[(IV); num (aj)quravm≥[en? Voigt 1971, 85
║3 cavle? (IV) leg. Lobel 1925, 32, i. e. calev a.c., cavle p.c., rec. Ferrari 2007a,
30 "tum p expectaveris, sed vestigia haud ita idonea videntur" Lobel 1925,
32 : sed, contra verba Lobel, vestigia hastae recurvae pap. (IV) habet quae pro p leg.
potis est : e.g. cavlep≥≥[ai mevrimnai Ferrari 2007a, 30 ║4 kuv (IV): fort. Kuv[pr-
Diehl1 1923, 363, rec. Ferrari 2007a, 30 ║5 ]s≥ sive ]t≥ vel ]g≥(IV) Lobel 1925, 32 :
]s≥ (IV) legi potest, quod g huius manus habet hastam v. breviorem et h.h. longiorem :
ij]s≥opavlhn Ferrari 2007a, 30 pavlhnovl≥[(IV) fort. o[l≥[oito Ferrari 2007a,
30 "Pro l≥[ (IV) fort. i≥[, vel etiam t≥[, g≥[ simm. legi potest" Lobel 1925, 32, rec. L.-P.
1955, 48 et Voigt 1971, 85" : l≥[ potius quam i≥[, t≥[, g≥[ ║ 6 ]ep≥l≥ (V) vel alia possis
Lobel 1925, 33, L.-P. 1955, 49 et Voigt 1971, 85 : ]ep≥≥e≥ potius quam ]ep≥l≥ : ] ejp≥e≥[i; Ferrari 2007a, 30 vestigia hastae verticalis (V): ]t vel ]g Lobel 1925, 33, L.-P.
1955, 49 et Voigt 1971, 85 : s]t≥evga m[e Ferrari 2007a, 30 ║7 livt(V) /8 evt∆ (V)
L’ode che qui presentiamo è frutto di un collage operato da Ferrari (2007a, 29sgg.) e
Puglia, ovvero della combinazione di Sapph. 68a+68b+69+70+75a V.: il carme saffico
così restituito da Ferrari e da Puglia, diviso in due frammenti, è il primo ad accennare
direttamente all’esilio della poetessa eolica: per la sua contestualizzazione storica, si
veda l’Introduzione. Il dato saliente di questa ode così restituita non è tuttavia l’esilio, di
cui eravamo già a conoscenza attraverso il Marmor Parium (Sapph. T 251 V. = FGrHist
239 A 36) e, forse, un passo delle Verrine ciceroniane (Cic. Verr. II 4, 126-127sgg.),
quanto il fatto che di questo esilio venga considerata colpevole, dalla stessa Saffo,
Andromeda, una delle nemiche di sempre: la poetessa invita Artemide (e questo è un
altro dato notevole: la sorella di Apollo invece di Afrodite) a soggiogare colei che
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
244
abbiamo considerata membro dei Pentilidi. Degno di nota è il richiamo ai Tindaridi al v.
a.10 e la menzione di Megara al v. 12, che conoscevamo anche da altre fonti, ma v. infra
a.10.12. Significativa è anche la singolare convergenza tra a.4 ajlivtrai≥ e b.7 ajlivtra[.
L’ode sembra strutturarsi nei seguenti momenti successivi: accenno all’esilio (vv. 1-3);
attacco ad Andromeda e richiesta di soccorso ad Artemide (vv. 4-8); desiderio di tornare
a casa, nostalgia del ruolo che aveva a Lesbo e delle ragazze (vv. 9-14): l’ultima
tematica non sembra, tuttavia, sufficientemente tratteggiata da Ferrari.
Non possiamo sapere, purtroppo, come si concludesse l’ode, ma qualche dato, come nota
giustamente Ferrari, ci viene riferito dal fr. b: (aj)quvram[en di b.2 “è interpretabile come
richiamo a un tempo in cui entrambe le donne (Saffo e Megara) si erano dilettate a
suonare e cantare nell’ambito delle stesse feste e delle stesse occasioni”; ejp≥e[ ≥i; s]t≥evga
m[e potrebbe alludere al ritorno in patria, o meglio a casa: così Ferrari (2007a, 38).
In questo quadro, è indubbio che a.4 ajlivtrai≥ e b.7 ajlivtra[ possano, in qualche modo,
porre i due frammenti in stretto collegamento tra loro e si potrebbe anche pensare che
essi facessero parte della stessa ode: in tal caso, nei versi successivi Saffo, dopo aver
provato nostalgia per la sua isola e per il suo ruolo, potrebbe aver parlato del suo ritorno.
Il testo da noi presentato è quasi completamente identico a quello di Ferrari (2007a, 29-
30): l’unica divergenza da registrare è al v. 4 del fr. a, ovvero il dativo singolare ajlivtrai≥
invece dell’accusativo ajlivtran≥, ma su questa correzione ed i suoi motivi v. infra, a.4.
a
1 e[m≥[a" è integrazione di Treu (1952, 64), poi completata da Ferrari (2007a, 29-31) con
ga'" (e[m≥[a" ga'"): d'altronde, come nota Ferrari, la scelta è obbligata, anzi si tratta
dell'"unica" possibile integrazione, perché occorre un sostantivo monosillabico al
femminile singolare. Per la presenza della tematica dell'esilio e per l'attestazione del
sostantivo gh' nel senso di "terra patria", "madrepatria" si impone il confronto con Thgn.
1210 sgg.: Ai[qwn me;n gevno" eijmiv, povlin d∆eujteivcea Qhvbhn / oijkw' patrwvia" gh'"
ajperukovmeno". / mhv m∆ajfelw'" paivzousa fivlou" devnnaze tokh'a", / [Arguri: soi;
me;n ga;r douvlion h\mar e[pi / hJmi'n d∆a[lla mevn ejsti, guvnai, kaka; povll∆, ejpei; ejk
gh'" / feuvgomen, a jrgalevh d∆oujk e[pi doulosuvnh, / ou[q∆hJma'" perna'si..."Di stirpe
sono Etone, ma a Tebe dalle solide mura / io vivo, dalla terra patria tenuto lontano. Non
oltraggiare sfacciatamente, per scherzo, i miei genitori, / Argiride: su te, infatti,
incombe il giorno della schiavitù, / su me invece, donna, incombono altri, molti, mali, da
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
245
quando dalla patria / esule sono, ma non incombe la gravosa schiavitù, / non mi
vendono…". E cfr. anche per gh' nel significato di "madrepatria": Tyrt. 10.13 W.2 qumw'i
gh'" pevri th'sde macwvmeqa kai; peri; paivdwn / qnhvskwmen yucevwn mhkevti
feidovmenoi "con coraggio combattiamo per questa terra e per i figli / moriamo, non più
risparmiando le vite"; Tyrt. 12.33-34 W.2 marnavmenovn te / gh'" pevri kai; paivdwn
"combattendo per la terra (patria) e per i figli"; Thgn. 888 ouj ga;r patrwvia" gh'"
pevri marnavmeqa "non combattiamo, infatti, per la terra paterna"; Aeschl. Suppl. 890
ma' Ga', ma' Ga' "Terra mia, Terra mia"; Soph. OC 44 wJ" oujc e{dra" gh'" th'sde a]n
ejxevlqoim∆e[ti "perché io non mi allontanerò più da questa terra dove risiedo"; Eur. Ph.
1090 ejpei; Krevonto" pai'" oJ gh'" uJperqanw;n "dopo che il figlio di Creonte, morto
per la patria". Successivamente il legame tra il sostantivo gh' (usato nel senso sopra
descritto) e l'aggettivo possessivo diventerà così forte che il sostantivo potrà essere
addirittura omesso: cfr. e.g. Eur. Heracl. 140 ejk th'" ejmautou' touvsde drapevta"
e[cwn "ritenendo costoro fuggiaschi dalla mia patria".
2 a≥[mi[l]l è integrazione di Ferrari (2007a, 29-31): è, anche essa, piuttosto sicura.
Si tratta, a quanto sembra, della più antica attestazione di questo termine (sconosciuto ad
Omero) che qui funge da soggetto della frase. Per altre attestazioni nella lirica arcaica
(comunque più recenti) e, in special modo, in Pindaro cfr. Ibyc. 287.7 Davies h\ ma;n
tromevw nin ejpercovmenon / w{ste ferevzugo" i{ppo" ajeqlofovro" poti; ghvrai /
ajevkwn su;n o[cesfi qooi'" ej" a{mil- / lan e[ba. "Davvero tremo quando avanza, come
un cavallo aggiogato detentore di trofei quando in vecchiaia / contro voglia scende in
contesa con carri veloci"; Pi. O. V 6 pempamevroi" aJmivllai" "gare su cinque giorni";
Isthm. V 6 wjkudinav-/toi" ejn aJmivllaisi "in lotte vorticose"; Isthm. VII 49-50 povre,
Loxiva, / teai'sin aJmivllaisin "concedi, Lossia, / nelle tue gare"; N. IX 12 ijscuvo"
t∆ajdrw'n aJmivllai" "e con prove di forza tra uomini". Il termine è poi attestato,
soprattutto, nella tragedia attica: cfr. e.g. Aeschl. Pr. 129 qoai'" aJmivllai" "in gare
veloci"; Fr. 451.6 (suppl.); Soph. OC 1063 h] rJimfarmavtoi" feuvgonte" aJmivllai"
"oppure su carri celeri in gara fuggendo "; El. 861 calargoi'" ejn aJmivllai" "in gare
(di cavalli) dagli zoccoli veloci" (al).; Eur. e.g. Hippol. 1141 levktrwn a{milla "gara
per ottenere le nozze" (al., 22x). Spesso il termine è attestato "cum genitivo rei" (cfr. LSJ
s.u. 2), cioè con il genitivo di ciò su cui si fonda la contesa, per cui cfr., oltre ad alcuni
passi già citati in questo contesto, Gorg. Hel. 13 (DK 82 B 11.13) filosovfwn lovgwn
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
246
aJmivlla" "contese di discussioni filosofiche"; Eur. IA 212 a{millan...podoi'n "lotta di
piedi"; Andr. 214 a{millan...fronhvmato" "contesa d'orgoglio"; Med. 546 a{millan ga;r
su; prouvqhka" lovgwn "infatti sei stata tu a provocarmi (lett.: hai provocato la
battaglia di insulti)"; Pl. Lg. 731b a{millan ajreth'" "gara di virtù". Altrimenti il
termine è attestato anche "cum genitivo objecti", cioè con il genitivo di ciò per cui si
contende: oltre a Eur. Hipp. 1141, già citato, cfr. Gorg. Hel. 19 (DK 82 B 11.19)
a{millan e[rwto" "brama d'amore (lett.: "contesa per ottenere l'amore")". Il senso che
la cifra di questo passo richiede è diverso dai paralleli sopra citati tratti dai lirici arcaici:
non si sarà trattato, certamente, di una "contesa, gara" atletica, ma di uno scontro tra
oijkivai in vista del potere.
Del verbo ajpokinevw, se di un tale verbo si tratta (è un'integrazione di Ferrari), abbiamo
poche attestazioni nell'epoca arcaica e classica, ma è già presente in Il. XI 636 a[llo"
me;n mogevwn ajpokinhvsaske tapevzh" "un altro l'avrebbe spostata dalla tavola
faticando" ed il suffisso iterativo –skw presente in questo passo iliadico non crea alcun
problema: difatti nell'Odissea (Od. XXII 107: mhv m∆ajpokinhvswsi quravwn mou'non
ejovnta "che non mi respingano, poiché sono solo") e poi in Hp. Morb. II 69 è attestato
un congiuntivo aoristo "regolare".
ajdo≥[kht- è integrato, con molta verosimiglianza, da Ferrari. Sono possibili due diverse,
ulteriori integrazioni: ajdo ≥v[vkht(a) neutro avverbiale oppure ajdov[khton coordinato con il
m∆ accusativo precedente oggetto di aj[pekivn]h≥s(e). Il passo può essere, infatti, inteso in
due modi diversi: "cacciò me d'improvviso", oppure "cacciò me che non me l'aspettavo".
Per la prima possibilità cfr. Hes. Fr. 209.2 kruvyai d∆ajdovkhta mavcairan "nascondere
d'improvviso la spada"; Eur. Ph. 311 a[elpta kajdovkhta "d'improvviso e quando non vi
era più alcuna speranza"; TGrF 644.41 Kannicht-Snell ajd[ovk]hta. Per la seconda
possibile integrazione, cioè ajdov≥[khton, cfr. Pi. N. VII 31 ajlla; koino;n ga;r e[rcetai /
ku'm∆ jAi?da, pevse d∆ajdovkh- / ton ejn kai; dokevonta "ma comune giunge / l'onda
dell'Ade, cade su chi non l'attendeva e su chi l'attendeva"; TGF 482 N. ajlla; savf∆
oi\d∆o{ti pavnta brotoi'" / Zeu;" ejpikavrsia tevmnei, kaqelw;n me;n dokevont∆, /
ajdovkhton d∆ejxaeivrwn "ma so chiaramente che tutto per gli uomini / Zeus taglia in
obliquo, rovesciando chi se lo aspetta, / ma preservando chi non se lo aspetta". La terza
possibilità, cioè integrare ajdo≥[khvtw" appare la più improbabile, perché un tale avverbio
non è mai attestato in poesia.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
247
Per u[]mw" (suppl. Hunt 1922, 33) cfr. Sapph. DV gV 11 = 58.21 V.; DV lV 20 = 88.20
u[m[w" (suppl. Di Benedetto 1987, 62; v. infra); Alc. 1.14 u[mw[. Per e[gen[to (suppl.
Lobel 1925, 32) cfr. Sapph. 42.1; DV zV 6 = 61.1 V. e[gento≥ [ (legit Ferrari, v. supra).
3 Per m]n≥am[, integrato da Ferrari (2007a, 29-31), cfr. Sapph. 98b, 7-9 tau'ta ta;"
Kleanaktivda[ / fuvga" †...i≥sa† povli" e[cei / mnavmat∆:o≥i[de ga;r ai \na dievrrue≥[n
"questi ricordi la città ha…dell'esilio del / dei Cleanattide/i: costoro, infatti,
terribilmente si sbandarono". Come nota Ferrari (2007a, 32), se la sua integrazione è
giusta, lo stesso sostantivo sarebbe stato usato da Saffo in due frammenti diversi, in due
libri diversi, per indicare lo stesso concetto all'interno della stessa situazione. Il termine è
attestato anche in Alc. 169a.6. Il significato generale del verso dovrà essere stato, come
nota Ferrari, "il ricordo non fu" (con m]n≥a'm[∆ou integrato da Ferrari)" così duraturo o
doloroso, tanto che potei poi esser detta simile agli dei".
Per i[san qevoisin cfr. Sapph. 31.1sg. Faivnetaiv moi kh'no" i[so" qevoisin /
e[mmenw[nhr "mi sembra pari agli dei / quell'uomo…. In Saffo è presente anche un altro
nesso simile, attestato anche come singola parola composta, si tratta di i[keloi qevoi"
(Sapph. 44.21), qeoãeÃikevlo[i" (Sapph. 44.34) "uguali agli dei", dove "ha il carattere di
un augurio nuziale" (Ferrari 1987, 127 n. 31.1); lo stesso composto sembra attestato
anche in Sapph. 96.4, qevai s∆ijkevlan ajrignwvtai "tu simile a dea manifesta", dove è
correzione di Blass ed Edmonds per il tradito †qeasikelan ajrignwta†. Si tratta di un
"nesso tradizionale, modellato sull'epica" (Ferrari 1987, 127 n. 31.1). Il nesso i[so"
qevoisin, tuttavia, si trova solo in Saffo. In Omero si ha sempre o ijsovqeo" (solo al
nominativo e sempre in attestata tredici volte nell'Iliade (Il. II 565; III 310; IV 212; VII
136; IX 211;XI 428; XI clausula) o daivmoni i[so". La clausula epica ijsovqeo" fwv"
"uomo simile ad un dio" è 472; XI 644; XV 559; XVI 632; XXIII 569; XXIII 677), due
volte nell' Odissea (Od. I 324; XX 124). È poi attestato in altri epici successivi, anche in
una sede diversa da quella finale: Ap. Rh. IV 1513; Q.S. IV 503; VI 540; VII 484; XII
319. Il genitivo epico di questo composto, mai attestato in Omero, si trova in Hes. fr.
22.4 jA]ghvnoro" ijsoqevoi[o "(figlia) di Agenore, simile ad un dio" e poi solo in poesia
classica piuttosto tarda (Q.S. I 770; XIV 180). L'unico passo epico a riportare
l'accusativo è Q.S. XIII 296. Per quanto attiene alla lirica arcaica, l'aggettivo è presente
in Pi. Pae. 52g.5; Bacchyl. XIII 64; La tessera epica daivmoni i\so" è attestata nove volte
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
248
nell'Iliade (Il. V 438; V 459; V 884; XVI 705; XVI 786; XX 447; XX 493; XXI 18; XXI
227), mai nell'Odissea ed una volta negli Hymni Homerici (Hymn. Cer. 235).
4 Le integrazioni proposte per questo verso sono: nu']n (Ferrari 2007a, 29-30), ej[pi;
(Ferrari 2007a, 29-30) e oj]nivan (Prauscello). Per il verbo ei\m∆ cfr. Sapph. 182 ijoivhn;
Alc. 179.11 i[]onte" (dub.); dalle attestazioni saffiche e alcaiche di questo verbo e dei
suoi composti va tolto katiou[s di Sapph. 2. 1a, perché si tratta di un participio ionico e
appartenente ad un'altra composizione, sicuramente non saffica. Per oj]nivan integrazione
della Prauscello, cfr. Sapph. 1.3 mhd∆ojnivaisin "né con tormenti"; 5.10 [ojn]ivan de;
luvgran "dagli infelici tormenti"; DV qV 3 = 63.3 V. ojniva" (v. supra); Alc. 353.1
mhd∆ojnivai" "né tormenti"; inc. auct. 18.1 ojnivan te kujgieivan. Per a[san cfr. Sapph.
1.3; Alc. 39a.11. Non sarà un caso che Saffo riutilizzi qui la coppia di sostantivi già
presenti in Sapph. 1.3. Per ajlivtran≥, aggettivo femminile, cfr. Sapph. DViV b, 7 = 69.2 V.
ajlivtra[; il femminile è molto meno attestato degli altri due generi, ma comunque è
persente in anche in Sem. 7.7 ejx ajlitrh'"...ajlwvpeko" "dalla volpe maligna" e Call.
Aitia fr. 75.68-69 ei{nek∆ajl≥[i]t≥[rh'" / u}brio" "per una malvagia / violenza" e poche altre
volte in opere più tarde.
4-5 Dopo alivtra il papiro non presenta tracce evidenti di un'altra lettera: il punto in
basso presente dopo l'alpha può essere benissimo una traccia del ricciolo terminale
dell'alpha stesso. Due sono le possibili letture: ajlivtran≥ oppure ajlivtrai (dativo
singolare). Ferrari propone la prima (ajlivtran≥), ma riteniamo la seconda migliore per
motivi sia papirologici (un n avrebbe lasciato sul papiro una traccia, riteniamo, ben più
marcata), sia grammaticali. Il passo ha, inoltre, un'ascendenza epica piuttosto evidente:
ad esempio lo stesso i[san qevoisin del verso precedente. Ed anche il verbo
ejpo]r≥somevn[a (integrazione di Ferrari 2007a, 30), che al medio assume il significato di
"slanciarsi contro qualcuno", è di ascendenza omerica. Il verbo al medio è attestato solo
costruito con il dativo, perciò proponiamo di leggere ajlivtrai≥, dativo singolare, al posto
di ajlivtran≥ di Ferrari (2007a, 29-30): la costruzione con il dativo è testimoniata da Il.
XXI 324 kai; ejpw'rt∆ jAcilh 'i> kukwvmeno" "e balzò su Achille levandosi torbido". Nella
ricostruzione di Ferrari (2007a, 29-30), l'aggettivo sostantivato è retto da ejpi;, che può sì
reggere l'accusativo, ma qui non serve ad altro che ad anticipare il verbo successivo (cfr.
il verbo ajpokinevw costruito in modo simile, ovvero con ajpu; che anticipa il preverbo,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
249
all'inizio dell'ode), che deve reggere un dativo. Vagliate tutte queste considerazioni,
riteniamo ajlivtrai≥ la lettura migliore.
5 Per quanto attiene alla sofferenza di Andromeda, si tratterà, certamente, non tanto
di un dolore fisico, quanto di un dolore metaforico, "sofferenza, pena, tormento": in
questo senso, è giustificato il plurale nel testo greco ed il singolare nella traduzione
italiana. Il sostantivo, nel significato metaforico, è attestato una sola volta nell'Iliade
(XV 25 ajzhch;" ojduvnh JHraklh'o" qeivoio "pena incessante per il divino Eracle",
seppure al singolare, il significato è anche qui metaforico), mentre più volte nell'Odissea
e sempre al plurale, ad esempio in Od. I 242 ejmoi; d∆ojduvna" te govou" te / kavllipen
"ed a me pene e pianti / ha lasciato": nelle opere successive all'Odissea è attestato il solo
plurale.
Per Andromeda, cfr. Introduzione.
Per [uj]p≥avx[ei, integrato da Ferrari, cfr. Sapph. 44.13-14 au[tik∆ jIlivadai sativnai["]
uJp∆ejutrovcoi" / a\gon aijmiovnoi" “subito le donne di Ilio spingevano sotto i carri dalle
belle ruote / le mule”; 17 i[pp[oi"] a[ndre" u[pagon ujp∆a[r[mata / p[avnt]e" hjivq≥eoi
"tutti i giovinetti spingevano i cavalli sotto i carri". Il verbo uJpavgw, nel significato che
qui assume, cioè "ridurre in proprio potere qualcuno" non è mai attestato nell'epica
arcaica: nelle cinque occorrenze omeriche assume sempre il significato di "aggiogare
animali"(Il. XVI 148; XXIII 291; XXIV 279; Od. VI 73), oppure "sottrarre qualcuno a
qualcosa, salvare qualcuno da qualcosa" (Il. XI 163). Paralleli per questo preciso
significato si trovano tra i testi a noi giunti, ma solo a partire dal V sec., soprattutto al
medio e in prosa (Hdt. VIII 106.3 oi{ se poihvsanta ajnovsia...uJphvgagon ej" cei'ra"
ta;" ejmav" "essi (oiJ qeoiv) han condotto te, che compivi azioni empie, nelle mie mani";
Thuc. VII 46 ej" me;n jAkravganta stasiavzonta pevnte kai; devka nausi; Sikano;n
ajpevsteilan, o}pw" uJpagavgoito th;n povlin, eij duvnaito "inviarono Sicano ad
Agrigento con quindici navi, affinchè assoggettasse la città, se ne fosse stato capace"). Il
verbo andrà inteso, dunque, non tanto nel senso astratto, ma ancora in quello concreto di
"aggiogare, condurre sotto": in altre parole, Saffo riferisce ad Andromeda
un'espressione solitamente usata, da Omero in particolare, per gli animali: gli animali ed
Andromeda sono, per la poetessa eolica, sullo stesso piano.
6 Sul papiro si legge la sequenza di lettere ]likupa[ e gli editori, prima del
contributo di Ferrari, stampavano il seguente testo: ]lik∆ujpa[. Ferrari (2007a, 30)
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
250
propone di integrare ajpav]lik∆ujp∆a[[rma. L'aggettivo integrato da Ferrari, ajpavlix, non è
ajfh'lix (ion. ajph'lix, eol. *ajpavlix) cfr. [Hom.] Hymn. Cer. 139-140 i{na sfivsin
ejrgavzwmai / provfrwn oi|a gunaiko;" ajfhvliko" e[rga tevtuktai "sì che io compia
per loro / volenterosa lavori quali quelli di una donna attempata?"; Cratin. 369 CAF
ajfhvlika gevronta "vecchio attempato"; Hdt. III 14 a[ndra ajphlikevsteron "un uomo
di età più avanzata" (al.). Se si accetta l'integrazione di Ferrari, si può intendere
l’aggettivo in due modi diversi: “priva di compagna, sola”, come intende Ferrari,
oppure “attempata”. Ferrari (2007a, 34 n. 3) cita, per dimostare la correttezza della sua
traduzione, oltre a tutti i passi precedenti (che, come abbiamo visto, non danno ragione a
Ferrari), anche Il. XXII 490 panafhvlika pai'da “bambino del tutto privo di amici”,
che, forse, è l’unico passo che potrebbe giustificare la traduzione di Ferrari: senonchè in
quel passo l’aggettivo è riferito a pai'da: evidentemente, non si può dire “bambino
attempato”! Saffo, invece, si riferisce ad Andromeda che non doveva, certo, essere una
pai'" all’epoca: Saffo sta parlando dell’esilio come di un evento passato o quasi passato:
purtroppo non possiamo sapere quanti anni avesse Andromeda negli anni del ritorno di
Saffo sull'isola dopo l'esilio, ma considerandola una coetanea di Saffo avrà avuto, forse,
una sessantina di anni e dunque a lei ben si adattava l’essere “attempata”. In
conclusione: l'aggettivo ajpavlix, pur integrato dal Ferrari, non è attestato in eolico, però,
nel complesso, l'integrazione è probabile, perché può essere usato in senso ostile da
Saffo nei confronti dell'avversaria; incertezze, però, vi sono su come intendere
l’aggettivo: riteniamo che sia “sola, priva di compagna” sia “attempata” siano valide
traduzioni, ma qualche dubbio in più sorge per la prima possibilità, dato che trova un
solo parallelo (in quel caso il significato è, però, fortemente condizionato dal referente,
pai'") nella “letteratura greca” e gli altri forniti dallo stesso Ferrari depongono
palesemente a sfavore. Forse il contesto in cui compare in Saffo potrebbe dirci qualcosa
di più (il dato della vecchiaia sembra qui secondario, in fondo), ma quello storico-
cronologico può benissimo difendere il dato dell’essere attempato, sicchè entrambe le
traduzioni sembrano essere sullo stesso piano. Abbiamo scelto di tradurre l’aggettivo
con “attempata” perché appare meno neutro di “tutta sola”, inoltre meglio si adatta al
contesto cronologico e trova maggiori paralleli, anche poetici: sembra a noi avere
maggiore resa nel contesto. Per a\lix ed altri composti cfr. Sapph. DV idV a.4 = 64a.4 V.
… a]livkes≥si[; 76.7 ]a–lik[; Sapph. 30.7 soi;" ujmavlik≥[a" "i tuoi coetanei"; 103.8
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
251
gav]mbron, a[saroi g≥a;r≥ u≥jmavli≥k[ "lo sposo, infatti sfacciati i coetanei". Per il carro di
Artemide cfr. Hom. Hymn. IX 4 rJivmfa dia; Smuvrnh" pagcruvseon a{rma diwvkei
“rapidamente spinge il carro tutto d’oro attraverso Smirne”; Call. Dian. 106 i{na toi
qoo;" a{rma fevrwsi “perché portino a te il carro”; Ap. Rh. III 878 cruseivoi" Lhtwi;"
ejf∆a{rmasin eJsthui'a “la figlia di Leto ritta sul carro dorato”; Nonn. Dion. XLVIII
304 [Artemi" h[ntue divfron “Artemide preparava il carro”. Immagini di Artemide sul
cocchio sono raccolte in LIMC, pp. 1196-1225.
L'aggettivo ujy]imevdo≥[is∆ è qui, a quanto pare, attestato per la prima volta al femminile;
altrove, infatti, è un epiteto, tra gli dei, del solo Zeus: cfr. Hes. Theog. 529 oujk ajekhvti
Zhno;" jOlumpivou u{yi mevdonto" "non contro il volere di Zeus Olimpio che governa
dall'alto"; Bacchyl. I 1 Dio;" / uJyimevdonto" "di Zeus / che dall'alto governa"; XV 51
Zeu;" u{yimevdwn o{" a{panta devrketai "Zeus che governa dall'alto e che tutto vede";
Ar. Nub. 563 JUyimevdonta me;n qew'n / Zh'na tuvranno" "Zeus che in alto governa,
signore degli dei".
[Ar[temi]"≥: Per la presenza di Artemide nei frammenti di Saffo cfr. Sapph. 44 A a.4sgg.
[Artemi" de; qevwn] mevgan o[rkon ajpwvmose / kefav]lan: a[i> pavrqeno" e[ssomai / ].wn
ojrevwn koruvfais∆e[pi / ]d≥e neu'son e[man cavrin: / evneu]se≥ qevwn makavrwn pavthr: /
ejlafav]bolon ajgrotevran qevo≥i / ].sin ejpwnuvmion mevga: / ]ero" oujdavma pivlnatai.
"Ma Artemide giurò il gran giuramento degli dei / sulla testa (di suo padre): "sempre
sarò vergine / …sulle cime dei monti/ …accorda la mia grazia". / …annuì il padre degli
dei beati. / …cacciatrice di cervi, agreste gli dei /…(le danno) il titolo solenne. / …Eros
(a lei) mai si accosta"; Sapph. DVkzV 6 = 84.6 V. (v. infra) [Artemi[. Per [Ar[temi]" aj
mavka[ir]a cfr. Eur. IA. 1480sgg. eJlivsset∆ajmfi; nao;n / ajmfi; bwmo;n [Artemin, / ta;n
a[nassan [Artemin / ta;n mavkairan "danzate intorno al tempio, / intorno all'altare per
Artemide, / la sovrana Artemide, / la beata"; [Orph.] Hymn. II 12-13 [Artemi"
Eijleivquia.../ klu'qi, mavkaira "Artemide Ilizia…/ ascolta, beata". Contro una donna
Saffo si rivolge ad Artemide, che era la dea “che ha grande potere sulle donne”: cfr.
Carmina Convivalia 886.4 PMG [Artemin, a} gunaikw'n mevg∆e[cei kravto".
7 Si tratta di uno dei versi meglio conservati dell'intera ode. L'integrazione di
maggior rilievo è aj d∆] o≥uj≥k≥ [aj]bav[khn] di Ferrari. Che [aj]bav[khn] sia l'integrazione
corretta lo testimonia un altro frammento di Saffo, cioè Sapph. 120 V., dove questo
aggettivo è attestato, come nota Ferrari (2007a, 35) con il medesimo significato e,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
252
riteniamo, anche in un contesto analogo: ajllav ti" oujk e[mmi paligkovtwn / o[rgan,
ajll∆ajbavkhn ta;n frevn∆e[cw... "ma io non sono una dalle ire piene di rancore: il mio
animo è mite". Nel fr. 120 Saffo oppone, evidentemente, il suo carattere "mite" a quello
"pieno" di rancore di qualcuno, o forse, meglio ancora qualcuna: che si tratti di
Andromeda? Per [aj]bav[khn] cfr. anche E. M. 2, 45ss. (codd. DVM) ajbakhv": kevcrhtai
de; aujtw'i Sapfwv:...ajnti; tou' hJsuvcion kai; pra'ion "lo usa Saffo…invece di
tranquillo e mite"; Hsch. A 51 ajbavkhn: ajfelh'. ajsuvneton. hJsucivon "schietto, stupido,
tranquillo". Un passo molto simile al fr. 120 di Saffo è Anacr. 71.4 Page: ejgw; de;
misevw / pavnta" ão{sÃsoi cqonivou" e[cousi rJusmouv", / kai; calepou;": memavqhkav s∆,
w\ Megisth', / tw'n ajbakizomevnwn "io odio tutti quelli che hanno caratteri sotterranei /
e difficili: ti ho riconosciuto, Megiste, tra coloro che sono di animo mite". In Anacreonte
abbiamo il verbo ajbakivzw (tratto dalla stessa radice): formulazione e significati sono
pari a quelli saffici.
ste≥v[ v≥r]e≥on (integrazione di Puglia) è qui usato in senso figurato, come già in Il. XII 267
stereoi'" ejpevessi "con dure parole" (cfr. Il. IX 510; XXIII 42); cfr. anche Pi. O. X 32
uJpo; sterew'i puriv "sotto il fuoco spietato"; P. IV 221 ajntivtoma sterea'n ojduna'n
"rimedi ai dolori duri"; Aeschl. P.V. 174 stereav"...ajpeila;" "dure minacce"; Soph.
Ant. 1262 aJmarthvmata / sterea; "errori / ostinati"; Plat. Pol. 309b stereo;n h\qo"
"saldo costume di vita" .
Per trovpo" nel senso di "indole, carattere, modo di vivere" nella lirica arcaica cfr.
Thgn. 964 mhvpot∆ejpainhvth", pri;n a]n eijdh'i" a[ndra safhnw'", / ojrgh;n kai; rJuqmo;n
kai; trovpon o{sti" a]n h\i "non lodare nessuno, prima di averne conosciuto con
chiarezza l'uomo, / il temperamento, la natura ed il carattere, chiunque egli sia…"; Pi.
N. I 29 jAghsidavmou pai', sevo...trovpwi "al tuo genio, figlio di Agesidamo".
8 Il testo del verso, così integrato da Ferrari, è pienamente condivisibile. Per k≥ovro≥n
ouj kativsc≥ei cfr. Sol. 3.9 PTEFr ouj ga;r ejpivstantai katevcein kovron "non sanno
trattenere la sazietà"; Thgn. 321s. eij de; qeo;" kakw'i ajndri; bivon kai; plou'ton
ojpavsshi / ajfraivnwn kakivhn ouj duvnatai katevcein "ma se un dio offre ad un uomo
meschino la vita e la ricchezza / sragionando non sa trattenere la sua bassezza"; Pi.
Isthm. III 1-3 Ei[ ti" ajndrw'n eujtuchvsai" h] su;n eujdovxoi" ajevqloi" / h] sqevnei
plouvtou katevcei frasi;n aijanh' kovron, a[xio" eujlogivai" ajstw'n memivcqai. " se un
uomo che ha successo o con le vittorie dalla bella fama / o con la forza della ricchezza
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
253
reprime nell'animo l'esiziale sazietà, degno è d'esser mescolato alle lodi dei cittadini".
S'intravede in questo verso quella che Vincenzo Di Benedetto (1978, 37-43) ha definito
essere la linea "solonica" della morale aristocratica della grecità arcaica, ovvero il
riuscire a trattenere la sazietà: Andromeda, agli occhi di Saffo, non vi riesce (] k≥ovro≥n ouj
kativsc≥ei). Per Solone questo "non trattenere la sazietà" genera u{bri" negli uomini a cui
non sta a cuore la misura, cfr. Sol. 6.3 W.2 tivktei ga;r kovro" u{brin, o{tan polu;"
o[lbo" e{phtai / ajnqrwvpoi" oJpovsoi" mh; novo" a[rtio" h\i "sazietà genera violenza,
quando una grande ricchezza segua / quanti uomini non abbiano una saggezza
adeguata"; del resto per Solone una ricchezza non donata dagli dei, ma frutto di violenza
porta alla rovina (a[th): plou'ton d∆o}n me;n dw'si qeoiv, paragivgnetai ajndri; /
e[mpedo" ejk neavtou puqmevno" ej" korufhvn: / o}n d∆a[ndre" timw'sin uJf∆u{brio", ouj
kata; kovsmon / e[rcetai, ajll∆ajdivkoi" e[rgmasi peiqovmeno" / oujk ejqevlwn e{petai,
tacevw" d∆ajnamivsgetai a[thi: "ma la ricchezza che donino gli dei rimane per l'uomo /
solida dalla giovane base alla sommità; / quella che gli uomini acquistino con violenza
non giunge / al coronamento, ma convinta da azioni ingiuste / le segue, pur non volendo,
ma in fretta si mescola alla rovina".
9 Di un sacrificio di agnelli (bianchi) ai Tindaridi (Castore e Polluce) parla anche
[Hom.] Hymn. XXXIII 8-10 oiJ d∆ajpo; nhw'n / eujcovmenoi kalevousi Dio;" kouvrou"
megavloio / a[rnessin leukoi'sin “I marinai, dalle navi, / pregando invocano i figli del
grande Zeus / col sacrificio di bianchi agnelli”. Per aj[gevla]n≥...[ a[rnwn (integrazione di
Ferrari 2007a, 29-31) cfr. Il. XI 679 penthvkonta bow'n ajgevla" "cinquanta mandrie di
buoi"; XVIII 528 bow'n ajgevla"; Od. XII 129 ejpta; bow'n ajgevlai; XIV 100 dwvdek∆ejn
hjpeivrwi ajgevlai "dodici mandrie sul continente"; Hes. Sc. 168 ejn de; suw'n ajgevlai
clouvnwn e[san hjde; leovntwn "c'erano mandrie di cinghiali selvaggi e di leoni"; Pi. P.
IV 149 bow'n xanqa;" ajgevla" "fulvi armenti di buoi"; fr. 70b.23 qhrw'n / ajgevlai"
"mandrie di fiere"; Soph. OT 26 ajgevlai" bounovmoi" "mandrie (di buoi) al pascolo"
etc.
Il collage operato da Ferrari e da Puglia ha permesso di individuare in maniera corretta il
referente del patronimico Tundarivdaisin: prima, infatti, si riteneva che Saffo vi
ricorresse per individuare le figlie di Tindaro (Elena e Clitemestra), piuttosto che i figli, i
Dioscuri Castore e Polluce: così, ad esempio, riteneva lo Schadewaldt (1950, 149), per il
quale Elena e Clitemestra sarebbero apportate come esempi negativi (so böse Beispiele):
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
254
altrimenti sarebbe, certamente, una contraddizione sacrificare una mandria di agnelli
all'empia Clitemestra! Che qui si dovesse trattare, invece, di Castore e Polluce aveva già
intuito Aloni (1997, 121). Del resto, Tundarivdai come patronimico di Castore e Polluce
è già usato, al plurale, da [Hom.] Hymn. XVII 1-5 Kavstora kai; Poludeuvk∆ajeivseo
Mou'sa livgeia / Tundarivda" oi} Zhno;" jOlumpivou ejxegevnonto / […] / caivrete,
Tundarivdai, tacevwn ejpibhvtore" i{ppwn "Castore e Polluce canta, o Musa canora, / i
Tindaridi che nacquero da Zeus Olimpio /[…] / Salve, Tindaridi, cavalcatori di veloci
cavalli!" e [Hom.] Hymn. XXXIII 1sgg. jAmfi; Dio;" kouvrou" eJlikwvpide" e[spete
Mou'sai, / Tundarivda", Lhvdh" kallisfuvrou ajglaa; tevkna, / Kavstorav q∆iJppovdamon
kai; ajmwvmeton Poludeuvkea... "narrate, Muse dagli occhi neri, / i Tindaridi, nobili figli
di Leda dalle belle caviglie: / Castore domatore di cavalli e Polluce privo di biasimo…".
Per il femminile si usa, invece, Tundariv", cfr. e.g. Eur. Hel. 1546. In origine il
patronimico tundarivdai indicava, esclusivamente, i due figli gemelli di Leda e non
anche, rispettivamente, la coppia divina dei Dioscuri ("figli di Zeus") e la coppia di eroi
Castore e Polluce: fu in età arcaica che le tre diverse coppie furono riunite in un'unica
tradizione mitica, per la quale Castore e Polluce sarebbero entrambi figli di Leda ed in
parte figli di Zeus, ovvero "Dioscuri". Per una parte della tradizione solo Castore era
figlio di Tindaro, mentre Polluce era figlio di Zeus; cfr. Cipria fr. 8 Bernabé (= fr. 6
Davies) Kavstwr me;n qnhtov", qanavtou dev oiJ ai\sa pevprwtai / aujta;r o{ g∆
ajqavnato" Poludeuvkh", o[zo" [Arho" "Castore è mortale e per lui destino di morte è
stabilito / ma immortale è, almeno, Polluce, rampollo di Ares"; Pi. N. X 80sgg. "ejssi;
moi uiJo;". / tovnde d∆e[peita povsi" / spevrma qnato;n matri; tea'i pelavssai" /
stavxen h[rw"... "io ho un figlio. Più tardi, accostatosi a tua madre, l'eroe e sposo il suo
seme mortale stillava…". E cfr. Schol. in Pi. N. 150a:
oJ me;n JHsivodo" ajmfotevrou" Dio;" ei\nai genealogei'. oJ de; Pivndaro" eJtevroi" tw'n iJstorikw'n ejxakolouqhvsa" to;n me;n Poludeuvkhn ejk Dio;", to;n de; Kavstora ejk Tundarevw ei\naiv fhsin, wJ" kai; JHraklh'" me;n ejx jAlkmhvnh" kai; Diov" jIfiklh'" de; ejx jAmfitruvwno". levgetai ga;r tou'to, o{ti Poludeuvkh" kai; JElevnh ejk Dio;" eijsi kai; Lhvda", Kavstwr de; ejk Tundavrew.
"Esiodo indica la genealogia di entrambi da Zeus, mentre Pindaro, seguendo altri storici,
afferma che Polluce è figlio di Zeus e Castore, invece, di Tindaro, come anche Eracle di
Alcmenda e di Zeus, ma Ificle di Anfitrione. Si dice, infatti, ciò, ovvero che Polluce ed
Elena sono figli di Zeus e di Leda, ma Castore di Tindaro".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
255
Per Castore e Polluce nella lirica eolica cfr. anche Alc. 34.1sgg. V. Deu'tev moi na']son
Pevlopo" livponte[" / pai'de" ]i≥moi D[ivo"] hjde; Lhvda" / ...w]i quv[m]wi
pro[fav]nhte, Kavstor / kai; Poluvde[u]ke"... "Qui a me, lasciata l’isola di Pelope, /
nobili figli di Zeus e di Leda / con cuore…, o Castore, apparite, / e te, Polluce…" e forse
Alc. 34a, dove al v. 3 è possibile integrare Poluv]deuke", come ha mostrato Diehl1 (1923,
424). E per i Dioscuri nel resto della lirica greca arcaica cfr. Alcm. 2 Davies (= 2a
Calame) ] sioi'si pa'[si kajnqrwvpoisin aijd]oiestavtoi / n[aiv]oisi ne[
si]ovdmato[n t]evgo" / Kav[stwr te pwvlwn wjkevwn] dmath'[re]" [iJ]ppovta[i
sofoi; / kai; Pwludeuvkh" kudrov" "…i più venerabili per tutti gli dei e gli uomini /
abitano…un tetto costruito dagli dei / Castore – domatori di veloci puledri, cavalieri
abili – e Polluce illustre"; Thgn. 1087sgg. Kavstor kai; Poluvdeuke", oi{ ejn
Lakedaivmoni divhi / naivet∆ ejp∆ Eujrwvta kallirovwi potamw'i..."Castore e Polluce,
che in Sparta divina / abitate, presso il fiume Eurota dalla bella corrente…"etc.
Ferrari non spiega il motivo del sacrificio degli agnelli ai Tindaridi e dell’invocazione a
loro rivolta, ma qualcosa si può affermare anche a riguardo di questo dato. I Dioscuri
erano venerati come protettori dei naviganti: Saffo, dunque, sembra propiziarsi,
attraverso un sacrificio, i Tindaridi e, attraverso di loro, un felice ritorno sulla sua isola.
Negli ultimi versi restituiti da Ferrari Saffo sembrerebbe, dunque, avere nostalgia del
ruolo che aveva a Lesbo, delle ragazze, dei cori e delle danze: si intravede un velato
collegamento con Sapph. DV gV, il carme della vecchiaia: in entrambe le odi Saffo
rimpiange i tempi in cui ballava con le ragazze e vi è un ostacolo, la lontananza:
temporale nel caso dell’ex fr. 58 V., fisica in questa ode.
10-11 Diehl1 (1923, 363) proponeva di integrare polug[avqhn e confrontava questo
passo con Pi. fr. 29 Sn.-M. jIsmhno;n h] crusalavkaton Melivan / h] Kavdmon h]
Spartw'n iJero;n gevno" ajndrw'n / h] ta;n kuanavmpuka Qhvban / h] to; pavntolmon
sqevno" JHraklevo" / h] ta;n Diwnuvsou polugaqeva tima;n / h] gavmon leukwlevnou
JArmoniva" uJmnhvsomen; "A l'Ismeno, o a Melia dalla conocchia d'oro, / oppure alla
sacra stirpe degli Sparti, / o a Tebe dall'oscuro diadema, / o alla forza che tutto
sopporta di Eracle, / o alla dignità di Dioniso che procura molta gioia, / oppure alle
nozze di Armonia dalle bianche braccia eleveremo un inno?". Diehl fondava la sua
integrazione sul v. 5 h] ta;n Diwnuvsou polugaqeva tima;n. Schadewaldt (1950, 140)
andò molto più in là di Diehl ed ipotizzò che anche in questo passo di Saffo, come
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
256
(evidentemente) in quello di Pindaro, si narrassero le nozze di Cadmo e di Armonia, ma
la sua ricostruzione ha suscitato, già molto prima del collage di Ferrari, più critiche che
consensi: per Treu (1976, 207) una tale ipotesi contrastava fortemente con l'affermazione
del v. 4 (v. 3 prima del collage) dei\m "ma io vado", che per il commentatore tedesco
aveva tutta l'aria di essere una persönliche Aussage (forse da ricollegare al momento
della conclusione della festa), quanto meno inspiegabile (se non impossibile) in una
narrazione mitologica. Per Aloni (1997, 122-123), inoltre, la presenza di una coetanea al
v. 6 (v. 5 prima della ricostruzione di Ferrari) e di un coro (v. 11) permettono, piuttosto,
di ricostruire una situazione paragonabile a quella di Sapph. 27. Il collage di Ferrari
toglie ora ogni credito all'ipotesi di Schadewaldt, dando così ragione al Treu.
covron nel senso di “spazio (pista) di danza” ricorrerebbe, secondo Ferrari (2007a, 135),
anche in Sapph. 94.27 V.: c]ov≥ro" (suppl. et leg. Lobel-Page 1955, 76).
Ferrari (2007a, 30-31) intende a[dolon come un avverbio e traduce "davvero":
"francamente, sinceramente" è più aderente al testo. Se l'interpretazione di Ferrari fosse
confermata, si tratterebbe della prima ed unica attestazione di a[dolon con valore
avverbiale in Saffo. Un avverbio tratto da questo aggettivo è realmente attestato in Saffo
e non si tratta di un neutro avverbiale, ma, piuttosto, di un avverbio in –w": è ajdovlw" di
Sapph. 94.1 teqnavkhn d∆ ajdovlw" qevlw "francamente vorrei esser morta".
12 Per pa'ktin] cfr. Sapph. 22.11 lavboisa.a.[ / pa']ktin "presa la cetra"; 156 povlu
pavktido" ajdumelestevra...cruvsw crusotevra "dal canto più dolce di una pectis…più
aurea dell'oro"; Alc. 36.5 p]avktidi. livghan si riferisce ad uno strumento musicale,
come in Il. IX 186 (= XVIII 569) fovrmiggi ligeivhi; Od. VIII 67 (= VIII 105; VIII 254;
VIII 261; VIII 537; XXII 332; XXIII 133) fovrmigga livgeian; [Hom.] Hymn. Apoll. 3
fovrmigga livgeian; [Orph.] Arg. 419 fovrmigga ligei'an. pa'ktin... livghan, tuttavia, è
un a{pax legovmenon. Altrove, nella poesia arcaica, l'aggettivo è utilizzato in riferimento
alla Musa, cfr. Od. XXIV 62 Mou'sa livgeia; [Hom.] Hymn. XIV 2 Mou'sa livgeia;
XVII 1 Mou'sa livgeia; XX 1 Mou'sa livgeia; Alcm. fr. 14a.1 Davies = 4.1 Calame
Mwvs∆a[ge Mwvsa livgha "Musa, orsù Musa armoniosa"; fr. 36 Davies = 86 Calame aJ
Mwvsa kevklag∆aJ livgha Shrhvn "la Musa grida, l'armoniosa sirena"; Stes. fr. 240
Davies deu'r∆a[ge Kalliovpeia livgeia "orsù vieni Calliope sonora"; fr. 278 a[ge
Mou'sa livgei∆ "Orsù, Musa sonora"; Pi. Paen. XIV(=fr. 52 o).32 livgeia me;n Moi's∆.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
257
Il nome di Megara è riportato, come ha notato Lobel, anche dalla Suida s.u. Sapfwv
(S107): eJtai'rai de; aujth'" kai; filai gegovnasi trei'", jAtqiv", Telesivppa,
Megavra "tre furono le sue amiche e compagne: Attide, Telesippa e Megara".
Sopra aj[kavl]a[n nell'interlinea è presente la seguente scrittura: .b. .kh. È probabile,
come ha notato Lobel, che il copista avesse voluto ricordare di dover correggere
aj[kavl]a[n in ajbavkhn: del resto non è mai attestato aj[kavl]a[n in riferimento alle
persone, ma solo a fenomeni naturali: lo scorrere di un fiume o l'azione del vento che
agita le foglie.
b
2 ∆quvram≥[en è stato così interpretato ((aj)quvramen) ed integrato dalla Voigt. Per
un'altra attestazione di questo verbo nei lirici eolici cfr. Alc. 70.3 ajquvrei pedevcwn
sumposivw.[ / bavrmo" "suona prendendo parte al banchetto…/ la lira ", un verso che fa
parte di un frammento di cui si è già parlato in questa sede: v. supra. Il significato di
base di questo verbo, qui attestato per la prima ed unica volta all'aoristo, è "divertirsi,
giocare", ma non è detto che questo sia il senso con cui vada tradotto in questo passo.
Per ajquvrw nel significato di "divertirsi, giocare" cfr. Il. XV 364 a]y au\ti" sunevceue
posi;n kai; cersi;n ajquvrwn "di nuovo lo rovescia con i piedi e con le mani giocando".
Il verbo può anche assumere il significato di "divertirsi a cantare, a suonare" e dunque
"cantare, suonare", per cui cfr. e.g., oltre al passo di Alceo precedentemente citato,
[Hom.] Hymn. XIX 15b mou'san ajquvrwn "suonando musica" (accusativo dell'oggetto
interno);;; [Hom.] Hymn. Merc. 485 sunhqeivhisin ajquromevnh malakh'isin "suonata con
delicata esperienza".
3 Il Lobel, già nella sua edizione del 1925 (Lobel 1925, 32), scriveva, per quanto
attiene l'ultima parola presente sul rigo del papiro, "tum p[ expectaveris sed vestigia
haud ita idonea videntur": è un'affermazione che non crediamo di poter condividere,
perché cale- non può essere completato da una lettera diversa da pi. Riteniamo errata
anche la lettura fornita dalla Voigt, ovvero cavl:ev: a meno che non si tratti di un errore di
stampa, è una svista piuttosto evidente, visto che dopo il lambda non è presente alcun
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
258
punto in alto sul papiro. Avrà, dunque, ragione Ferrari a considerare il simbolo presente
sopra l'epsilon come la correzione di un errore precedente: probabilmente lo scriba, nel
trascrivere l'ode, si sarà ricordato di una clasusula presente in almeno due luoghi di
Saffo (ovvero Sapph. 1.25-26 V. calevpan de; lu'son / ejk merivmnan; DV eV 8 = 86.8 V.
calevpai m[erivmnai) ed avrà, inconsapevolmente, sbagliato a porre l'accento: tuttavia si
è subito corretto, cancellandolo e ponendone un altro sulla sillaba precedente. cavlep≥[ai
mevrimnai di Ferrari, oltre ad essere molto saffico, può anche ben spiegare l'errore nel
posizionamento dell'accento: crediamo si possa, da questo errore, trarre anche
un'osservazione ulteriore: poiché calevpai m[erivmnai è presente in Sapph. DV eV 8 =
86.8 V.: Sapph. DV eV = 86 V. avrà, quindi, preceduto di poco quella che stiamo qui
commentando.
4 kuv[pr-, anche se in Ferrari (2007a, 30-31) non è accompagnata dal nome e, per
come è riportata, sembra quasi attribuita allo stesso Ferrari, è un'integrazione proposta
da Diehl1 (1923, 363) ed è molto probabile; non è possibile, invece, integrare Ku[qevrha
(per cui cfr. Sapph. DV eV 3 = 86.3 V.; DV laV fr. 1 col. II 5 = 90a col. II 5 V.; 140.1)
poiché la parola è preceduta da una sillaba breve e si verrebbe a creare una serie di tre
brevi, insostenibile metri causa. Difficile è, però, definire meglio l'integrazione.
5 Se la lettura e l'integrazione di Ferrari sono giuste, si tratta della più antica
attestazione di un aggettivo, ijsopalhv" (ijsopavlh" in eolico), "sconosciuto" ad Omero,
Esiodo ed ai frammenti del Ciclo e della lirica greca arcaica a noi arrivati. L'aggettivo è
attestato soprattutto in prosa, salvo rare presenze in poesia, ad esempio nella poesia
filosofica di Parmen. DK 28 B 8.44 aujta;r ejpei; pei'ra" puvmaton, tetelesmevnon
ejstiv / pavntoqen, eujkuvklou sfaivrh" ejnalivgkion o[gkwi, / messovqen ijsopale;"
pavnthi "ma poiché c'è un limite estremo, è compiuto / da ogni parte, simile a massa di
una sfera ben rotonda, / a partire dal centro uguale da ogni parte", oppure in Theocr. V
30 ajlla; ga;r ou[ti / w{rifo" ijsopalhv" toi "ma il capretto / non è pari a te".
6 Per s]t≥evga cfr. Alc. 140.3 pai'sa d∆ [Arhi kekovsmhtai stevga "per Ares tutta
la sala è adornata".
7 Per ajlivtra[ cfr.DV iV a.4 e ad locum.
iaV (81 L.-P. = V.) metrum: hipp2cho
] ajpuvqes≥.[
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
259
o[tti tav]cista l≥[ ]e≥m≥p[ su; de; stefavnoi", w\ Divka, pÕevrqesõq∆ejravtai" fovbaisin 5 o[rpaka" ajnhvtw sunãaÃevõrrÕais≥õ∆ajpavlaisi cevrsin: eujavnqea †ga;r pevletai† kai; Cavrite" mavkairaãià ma'llon †proterhn†, ajstefanwvtoisi d∆ajpustrevfontai …porre…
…al più presto….
…
Tu, o Dika, posa delle corone intorno alle graziose chiome
5 intrecciando virgulti di aneto con le tenere mani:
a colei che è adorna di fiori, infatti, anche le beate Cariti più
volentieri rivolgan lo sguardo, ma lo distolgono da chi non porta corone.
TEST (I)POxy. 1787 fr. 33 [1-5] (II) Athen. XV 674c-e (cod.A) ejstefanou'nto de; kai; ta; sthvqh kai; ejmuvoun tau'ta, ejpei; aujtovqi hJ kardiva. jEkavloun de; kai; oi\" periedevonto to;n travchlon stefavnou" uJpoqumivda" (-miavda" codd.) wJ" jAlkai'o" ejn touvtoi": [Alc. 362,1.2 V.]. kai; Sapfwv: [Sapph. 94.15-16 V.]. kai; jAnakrevwn: [Fr. 52 Page]...Sapfw; d∆aJplouvsteron th;n aijtivan ajpodivdwsin tou' stefanou'sqai hJma'", levgousa tavde: [4-7]. wJ" eujanqevsteron ga;r kai; kacarismevnon ma'llon toi'" qeoi'" paraggevllei stefanou'sqai tou;" quvonta". Cf. Poll. 6, 107 (=Alc. 435 L.-P.) jAnakrevwn de; (Fr. 151 P.)...stefanou'sqai fhsi...kai; ajnhvtwi, wJ" kai; Sapfw; kai; jAlkai'o" et Schol. in Theocr. VII 63b p.
95W. ajnhtivnoi" d∆ejcrw'nto stefavnoi", wJ" jAlkai'o" kai; Sapfwv (I)
prim. rec. Diehl1 1923
, (II) rec. Steph.
2
CRIT fragmentum vix dispici potest 1 post s vestigia unius litterae, fort. q≥[ ? : ajpuvqesq≥[ai Hunt 1922, 39 ║2 o[tti tav]cista Diehl
1 1923 ║3
]emip[ (I), ut vid., sed i delet. Lobel 1925, 39 : ∆ delet. malim ║4 stefavnoi" (II): stefavnou" Casaubonus 1600, 954 : stefavnoi", "pro" quo "stefavnou" ex
Casauboni emendatione rec. Wolfius", ut "quartus casus" (i.e. acc.) prim. agnovit Koen
1766, 293 wdika(II)(codd.): Dwrivka Casaubonus 1600, p. 954 : w\ Divrka
Fiorillo 1803, 64, sed contra metrum : w\ Divka distinxit Welcker 1828, 421, qui Divka pro Mnasidivka esse cogitavit, sed contra oblocutus est Ahrens 1842, 546
pavrqesq∆ (II): pavrqeov g∆ Casaubonus 1600, 954 : pavrqe" vel pavrqeso vel
pavrqeo Schweigäuser, Anim. 1805, 74 et ad loc. : pavrqesq∆ rec. Bentley, Ad Q. Horatii
Flacci Carmina I 7,7 : corr. Seidler 1829, 195 : ]erqes[ (I): pevrqess∆ Edmonds1 1922,
264 ejravtoi" Fick 1891, 208 : ejravtai" (II), rec. Edmonds11922, 264
fovbaisi (II): corr. Casaubonus 1600, 954. ║5 annhtw (II): ajnnhvtwi II (cod.
A), rec. Schweigäuser 1805 ad locum : ajnhvtw corr. Casaubonus 1600, 954, rec. Dindorf
1827, 1501 : ajnhvttw Schneidewin 1838, 315 : ajnhvtoio Ahrens 1839, 267, rec. Kaibel
1890, 491, Wilamowitz 1913, 52 sunerrai" (II): drevyais∆ Casaubonus 1600, 954 : sunevrrais∆ (=suneivrasa) Schweigäuser Anim. 1805, 74 et ad
loc. : suneÛevrrais∆ Seidler 1829, 194 : suneevrrais∆ Schneidewin 1838, 315 :
sunãaÃevrrais∆ Ahrens 1839, 267, Ahrens 1839b, 230 : sunevrsais∆ Wilamowitz 1913,
52 : ].v[..]ais≥[ (I) ajpallageivshi (II) codd. : ajpallagivshi (II) cod. A :
ajpalai'si (aeol. ajpavl-) Casaubonus 1600, 954 ║6 eujavnqea (II): teujavnqea
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
260
Edmonds11922, 266 post eujavnqea una syllaba longa desideratur
pevletai corrupt., ut vid. : Mevletai Fick 1891, 208 : pai'd∆ejqevlhsan Wilamowitz 1913, 52 : ãparÃpevletai Edmonds
1 1922, 266 cavrite" (II)
codd. AB : cavri" te L : kecavristai Canter : kecarismevna Casaubonus 1600, 954 :
Cavrita" mavkairaã"Ã corr. et suppl. Edmonds1 1922, 266 mavkaira (II): mavkarsi
Canter, rec. Casaubonus 1600, 954 : mavkairaãià Blomfield 1823, 301 protevrhna stefanwvtoisi (II): primus recte (i.e. protevrhn ajstefanwvtoisi) distinxit Scaliger,
sed maluit dativum brevem : tav g∆ijerei'a:ajstefanwvtou" : dativum longum prim.
restituit Schweigäuser 1805 ad loc. : protevlh∆ Neue 1827, 66 protovrhn (=prosora'n)
Seidler 1829, 195, rec. Hermann 1835, 126-127 : potovrhn Hartung : prosorh'n Wilamowitz 1913, 52 : profevrhn Lobel 1925, 39 dapustrevfontai (II):
d∆ajpostrevfontai Scaliger, rec. Casaubonus 1600, 954 : d∆ajpustrevfontai rest. Koen
1766, 275 Il frammento è tradito da due testimoni diversi: per tradizione indiretta da Ath. XV 674
c-e (cod. A), che riporta i vv. 4-7; per tradizione diretta dal POxy. 1787 fr. 33, ma solo
per i vv. 1-5, tra l’altro in gran parte ben poco decifrabili. Lo stato frammentario del
carme non consente, purtroppo, di precisare l’occasione in cui occorre contestualizzarlo.
Tutto ciò che è possibile trarre dal testo è che una ragazza di nome Dika deve intrecciare
virgulti di aneto e mettersi una corona sulla testa. Un piccolo tentativo di
contestualizzazione fu fatto da Kaibel (1890, 491) che nell’apparato al passo di Ateneo
scrive: requiro participium sacrificans. Ateneo fornisce qualche informazione in più:
sostiene, infatti, che Saffo in questo carme avrebbe parlato del perché era costume, tra i
Greci, mentre facevano offerte agli dei, incoronarsi con corone di fiori: Ateneo,
certamente, poteva avere a disposizione (o comunque ricordarlo, anche soltanto il
contenuto) tutto il testo dell’ode, non solo i quattro versi dell’ode riportati nella sua
opera (così – bene – la Bartol 1997, 75). Secondo gli ultimi studiosi intervenuti (e non
solo), il carme avrebbe per oggetto “la preparazione per una cerimonia rituale, alla quale
partecipavano sia la locutrice del messaggio – cioè, certamente, Saffo stessa – sia
Dika”316
. L’esortazione del v. 4 ed il participio sunãaÃevrrais∆ (quest’ultimo indica
un’azione precedente) permettono di ipotizzare che il carme fosse costituito da una serie
di ordini rivolti a ragazze diverse317
. Carmi composti in relazione a feste o riti sono
anche Sapph. 30, dove si parla di una cerimonia nuziale, Sapph. 43 (festa notturna) e
Sapph. 140, che si riferisce, verosimilmente, ad una rappresentazione per una cerimonia
316
Bartol 1997, 76. L’opinione della studiosa polacca è accolta anche da Ferrari 2007, 7. Di una kultische
Handlung parla anche Fränkel 1962, 205. 317
Così, giustamente, la Bartol 1997, 76.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
261
rituale. È molto probabile, ma non certo, che si tratti di una festività in onore di Afrodite,
come ritiene la Bartol (1997, 76). Meno probabile sembra, invece, che “il passo citato da
Ateneo faccia parte di un carme il cui scopo era quello di dichiarare l’interessamento
amoroso” verso Dika318
. Questa ricostruzione, infatti, obbliga a postulare che Ateneo
non abbia compreso il passo di Saffo: si tratta di un’evenienza improbabile, ma cfr.
infra. E per finire diamo notizia di due interpretazioni dell’ode che non sembra possibile
condividere: del tutto incomprensibile è, ad esempio, la posizione di Lobel (1927, xii n.
1), ripresa da Page (1955, 135 n. 9): egli ritiene, per quanto è possibile comprendere
dalla frase utilizzata dal Lobel, che nell’espressione o[rpaka" ajnhvtw si celerebbe
un’allusione ad un’offerta da porre su un altare; davvero strana è la conclusione a cui
giunge Lobel: “indeed it seems improbable that a chaplet could be made of o[rpake"”.
Secondo la Pippin Burnett (1983, 296-297) il portare corone ricorre spesso in carmi in
cui Saffo si ricorda di qualche ragazza, ma che questo carme sia stato composto per
ravvivare il ricordo di Dika, ormai assente, sembra improbabile, perché Saffo sembra
riferirsi, piuttosto, ad una situazione al presente..
1 Il testo tradito dal papiro è ]apuqes.[ : la lettera dopo il sigma è, molto
probabilmente, un q e Hunt (1922, 39) ha integrato ajpuvqesq≥[ai.
2 Sul papiro vi è chiaramente scritto]cista.[: la lettera successiva all'alfa è ben
poco leggibile, ma è, probabilmente, un lambda. Per o[tti tav]cista, integrato da
Diehl1 1923, 364, cfr. e.g. Il. IV 193 Talquvbi∆, o{tti tavcista Macavona ajrhvi>on
jAtrevo" uiJovn "Taltibio, chiama qui al più presto Macaone"; IX 659 Foivniki storevsai
pukino;n levco" o{tti tavcista "di stendere in fretta un solido letto per Fenice".
3 Il testo tradito dal papiro è poco decifrabile: posto che mp siano sicuri (anche se
poco leggibili) e che la lettera che precede il my sia, forse, un epsilon, il resto è per noi
ignoto. Gli editori più recenti leggono uno iota con un tratto obliquo posto sopra (cioè
uno iota cancellato dallo scriba) tra il mi ed il pi, ma l'asta verticale non solo è,
riteniamo, troppo corta per essere uno iota (e comunque più corta delle altre lettere), ma
è anche inclinata in senso opposto rispetto al resto del testo. Leggeremmo, piuttosto,
]e≥m≥≥+p[ : che si tratti di un apostrofo cancellato dallo scriba, oppure di un segno di
richiamo?
318
Così la Bartol 1997, 80.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
262
4 A partire da questo verso al POxy. 1787 fr. 33 si affianca Ath. XV 674c-e. Come
sappiamo il testimone unico del testo di Ateneo in quindici libri è il codice A ed esso
riporta questo verso nel modo seguente: su; de; stefavnoi" w[dika parqevsq∆ejratai'"
fovbaisin.
su; de; ha valore contrappositivo e suggerisce che nei versi precedenti si desse un ordine
a qualche altra persona319
, probabilmente un’altra ragazza del gruppo.
Casaubon propose di correggere il passo di Ateneo nel modo seguente: su; de;
stefavnou" Dwrivka pavrqeov g∆ejratai'" fovbaisin.
Il primo problema testuale (per noi non è, ovviamente, più tale) per Casaubon (1600,
954) lo costituiva stefavnoi": aveva capito che qui occorreva l'accusativo e perciò
proponeva di correggere il passo modificando la desinenza, ovvero inserendo quella
attica in –ou". Koen (1766, 293) è stato il primo ad accorgersi che stefavnoi" è un
accusativo eolico320
e che dunque la correzione di Causaubon non è necessaria, anzi
sarebbe un palese errore.
Un problema più serio era costituito, per Casaubon, dalla sequenza di lettere che il
codice di Ateneo mostrava (e mostra) dopo stefavnoi", ovvero la vox nihili wdika: il
testo veniva da lui corretto in Dwrivka. Il primo ad accorgersi che wdika doveva
nascondere un vocativo preceduto dalla particella interiettiva fu Fiorillo (1803, 64), che
correggeva il testo in w\ Divrka: la sua proposta è oggi irricevibile, perché viola
manifestamente il metro di quest'ode321
(e dell'intero quarto libro), ma è sintomatica del
fatto che qualcuno avesse già ipotizzato la presenza di una invocazione. La soluzione fu
trovata da Welcker (1828, 421) che propose di scrivere (semplicemente) w\ Divka: nel
testo del codice è, dunque, presente la lezione giusta, ma mancano la separazione tra le
due parole ed i segni diacritici. Per Welcker Divka non sarebbe altro che un'Abkürzung
per Mnasidivka e per quest'ultima argomentazione fornisce dei termini di confronto
piuttosto convincenti, ad esempio: (1) in un epigramma di Trifone Terpandro viene
319
Cfr. Bartol 1997, 76. 320
Queste sono le parole di Koen 1766, 293: "Jam velim considerari, anne locum tueri possint atque adeo
debeant in Sapphus fragmento corruptissimo apud Athen. L. XV, p. 674E. voces ıefavnoi" &
ajıefanwvtoi" quarto casu, pro quibus ıefavnou" & ajıefanwvtou" ex Casauboni emendatione recepit Cl.
Wolfius Fragm. LXIII". 321
Come nota già l’”Anonimo di Jena”, ovvero F.-G. 1806, 139: " [Wdika hat keine Sinn, und Dwrivca oder w\ Divrka zu schreiben, verbietet das Metrum".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
263
chiamato Tevrph"322; (2) Etym. Magnum s.u. jAstriav" attesta [Amfi" come ipocoristico
di jAmfiavrao" etc. Contro l'opinione del Welcker si schierò l'Ahrens (1843, 546), ma
senza portare alcun argomento valido alla propria tesi323
. Per Divka e Mnasidivka cfr.
fragm. seq.
Per la parte centrale del verso abbiamo la rara possibilità di collazionare due varianti,
quella apportata dalla tradizione medievale e quella del papiro. La tradizione medievale,
cioè il codice A di Ateneo, riporta parqesq∆, mentre il testo del papiro può essere
integrato con p]evrqes[q∆. Ben prima della scoperta e della pubblicazione del papiro la
lezione del codice A era stata difesa da Richard Bentley. Nelle edizioni di Lobel (1925,
39) e Lobel-Page (1955, 57) è presente, a questo riguardo, un evidente errore, poiché si
attribuisce la correzione del testo del codice A (parqesq∆) in pevrqesq∆ al Bentley stesso,
mentre è l'esatto opposto: Bentley non aveva corretto il testo medievale, ma l'aveva
difeso. Il Bentley, nel commentare Hor. Carm. I 7.7 (Undique decerptam fronti
praeponere olivam, ovvero "mettere intorno alla fronte un ramo d'olivo colto dove che
sia"), afferma :
"atque ita locuti sunt et Greci, a quibus Noster in Carminibus totus pendet, paraqevsqai
stevfanon tai'" kovmai", quod est verbum de verbo, praeponere coronam capillis.
Sappho apud Athenaeum lib. XV p. 674. "Su; de; stefavnou", w[dika, parqevsq∆
ejratai'" fobai'si" Tu vero coronas praepone amabilibus comis”.
Inutile aggiungere, tuttavia, che il latino praeponere non corrisponde, con precisione
semantica assoluta, al greco parativqhmi. Il verbo a cui ricorre Orazio, con il preverbo
prae-, non può che significare "porre prima, porre davanti, premettere, esibire", mentre
il verbo greco significa, in primis, "porre accanto, confrontare" e solo successivamente
"porre davanti, offrire". Oltre a questa esigua differenza semantica, vi è anche un altro
scarto tra i due passi, laddove in Saffo si parli di "chiome", mentre in Orazio di "fronte":
322
Welcker non specifica le coordinate del passo, ma deduciamo che si tratti di Tryph. A.P. IX 488.1ss.
Tevrph" eujfovrmigga krevkwn skiavdessin ajoida;n / kavtqane nosthvsa" ejn Lakedaimonivoi" / oujk a[ori plhgei;" oujd∆ejn bevlei, ajll∆ejni; suvkwi / ceivlea, feu', profavsewn oujk ajporei' qavnato" "Terpe
(i.e. Terpandro) che tesse un canto dalla bella lira / morì mentre faceva ritorno sotto il pergolato
spartano / non colpito da una spada, nè per una freccia, ma da un fico / in bocca, ahimè, la morte non
manca di cause". 323
Egli si limita soltanto ad affermare: "Hoc tamen tenemus, Divka […] non posse pro Mnasidivka esse".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
264
Orazio non poteva dire "porre intorno alla fronte", così per Saffo non aveva senso "porre
davanti alle chiome": la fronte è solo sul viso e non può essere "circondata" e l'inverso
dicasi dei capelli. È stato Seidler (1829, 195) a proporre di correggere il passo di Ateneo
ed a fornire un parallelo lampante per difendere la sua correzione, ovvero Hes. Theog.
576s.: ajmfi; dev oiJ stefavnou" neoqhleva", a[nqesi poivh", / iJmertou;" perivqhke
karhvati Palla;" jAqhvnh "ed intorno a lei corone fresche, con fiori d'erba, / amabili le
pose intorno alla testa Pallade Atena". Il papiro ha poi confermato la correzione di
Seidler. Il passo della Theogonia esiodea citato da Seidler è un parallelo perfetto per
questa espressione saffica e, leggendo l’apparato della Voigt (1971, 92)324
, si potrebbe
pensare che esso abbia innescato un'ulteriore correzione, quella di Fick (1891, 208) che
partendo da stefavnou" / iJmertou;" di Esiodo, avrebbe corretto ejravtai" in ejravtoi",
coordinando l'aggettivo con stefavnoi", mentre prima lo era, per attrazione, con il
successivo fovbaisin: quest’ultima correzione non è, tuttavia, necessaria e non è detto
che si debba per forza ricopiare il testo di Esiodo. Il ragionamento di Fick è, tuttavia,
molto più fine, perché nota: “für ejravtai", welches nicht dativ sein kann, ist ejravtoi"
(zu o[rpaka") zu schreiben”. Fick non si preoccupa minimamente del parallelo fornito da
Esiodo; egli non fornisce maggiori spiegazioni sul suo intervento, ma crediamo di
cogliere nel segno interpretandolo a questo modo: si accorge che quel che segue (cfr.
anche al verso successivo) è un dativo femminile che presenta una desinenza “lunga” –
aisin e quindi non si possono trovare due forme diverse di dativo plurale a distanza di
poche parole. L’argomentazione di Fick, nella sua logicità, sembra essere definitiva, ma
se si confrontano altri passi ci accorgiamo che non è così: l’abbinamento tra dativo
“lungo” e dativo “breve” è, infatti, piuttosto attestato nei poeti eolici: Sapph. fr. 160
tavde nu'n ejtaivrai" / tai;" e[maisãià tevrpna kavlw" ajeivsw “ora queste parole
dilettevoli / io canterò bene alle mie compagne”, dove e[maisãià è una correzione di
Seidler, ma sembra garantita dal fatto che il frammento, così restituito, sembra essere
parte di una strofa saffica; Alc. fr. 130b.15 sunovdoisiv m∆au[tai" “…gli stessi convegni
me…”, dove il dativo breve è testimoniato da un papiro; Alc. fr. 308.2 V. koruvfais∆ejn
au[tai" “sulle stesse vette”. Più in generale, per la presenza di dativi “brevi” nella lirica
eolica, cfr. anche Sapph. fr. 44.21 i[]keloi qevoi[" “simili agli dei”; 55.3 kajn jAivda
324
La Voigt (1971, 92), dopo aver dato notizia dell’emendamento proposto da Fick, aggiunge “cf. Hes.
l.c.” e si potrebbe leggere questa nota come se lo studioso tedesco si basasse sul passio dei Esiodo per
correggere quello di Saffo, ma ma non è così.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
265
dovmoi" “anche nelle case di Ade”. Nel caso di quest’ultimo passo citato, ovvero Sapph.
fr. 55.3, la Voigt accoglie una correzione dello stesso Fick (1891, 207), ovvero il
singolare dovmwi al posto del plurale dovmoi", che appare, nel complesso, non
necessaria325
. Su questo problema cfr. anche da ultimo Ferrari 2007a, 178. La presenza
di dativi plurali “brevi” rientrerà, dunque, in un fenomeno più generale, quello
dell’attestazione di forme non proprio “eoliche” nelle poesie di Saffo e di Alceo, a cui
abbiamo già accennato altrove in alcune altre circostanze. La conclusione da trarre sarà,
dunque, che l’unico argomento a favore della correzione proposta da Fick non è quello
diatopico, ovvero che ejravtai" non può essere un dativo plurale e che abbiamo visto
essere facilmente contraddetto, ma il possibile contatto con il passo di Esiodo
precedentemente citato, dover però, ad onor del vero, si ha iJmertou;" e non ejratouv".
La tradizione manoscritta presenta ejravtai" ed ejravtai" fovbaisin, considerate le altre
attestazioni di dativo “lungo” preceduto o seguito da dativo “breve”, non crea problemi,
quindi non sembra esserci una ragione valida per accogliere la correzione di Fick. Inoltre
ejrataiv fovbai ricorre in Pi. Dith. fr. 75.16 ejrataiv / i[wn fovbai “amabili / ciuffi di
viole”.
Tutti, leggendo il testo della Voigt, che poi è quello di Fick, hanno coordinato ejravtoi"
con stefavnoi", come raccomanda il passo di Esiodo ed anche il buon senso, ma Fick
riteneva che ejravtoi" fosse il qualificante di o[rpaka", il che appare poco probabile:
o[rpaka" ajnhvtw sunãaÃevõrrÕais≥∆, infatti, è una parentetica, ma nell’interpretazione di
Fick risulterebbe spezzata dall’intromissione di fovbaisin: l’emendamento è giusto, ma
ejravtoi" deve essere collegato con stefavnoi".
Per l'azione di porre corone di fiori sulla testa o intorno al collo cfr., oltre al passo della
Teogonia precedentemente citato, Sapph. 94.12-17 po≥v[lloi" ga;r stefavn]oi" i[wn /
kai; br[ovdwn...]kivwn t∆u [moi / ka..[ -7- ] pa;r e[moi pãeÃreqhvkaãoà / kai; povllai"
ujpaquvmida" / plevktai" ajmf∆ ajpavlai devrai / ajnqevwn ej≥[ravtwn ] pepohmevnai"
(ej≥[ravtwn ] suppl. Schubart)"infatti accanto a me tu ponesti (sul capo molte corone) di
viole e di rose e di crochi…ed intorno al delicato collo molte ghirlande intrecciate, fatte
di fiori (gradevoli)"; Alc. 363 V. ajll∆ajnhvtw me;n peri; tai;" devraisãià / perqevtw
325
Fick (1891, 207) fonda la sua correzzione sullo stesso ragionamento (“dovmwi für dovmoi", welches kein
dativ sondern akkusativ ist”), ma qui Saffo sembra riutilizzare una famosa clausula epica, eijn jAi?dao dovmoisin, che presuppone proprio il plurale (che rende l’espressione più indefinita) e non il singolare: cfr. Il. XXII 52; XXIII 19; XXIII 103; XXIII 179; Od. IV 834; XV 350; XX 208; XXIV 264.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
266
plevktai" ujpaquvmidav" ti", / ka;d de; ceuavtw muvron a\du ka;t tw; / sthvqeo" a[mmi
"si pongano attorno al collo / delle corone d'aneto, intrecciate e si versi dolce unguento
a noi sul petto"; Anacr. 118 Gentili plekta;" d∆uJpoqumivda" / peri; sthvqesi lwtivna"
e[qento "e posero intorno al petto ghirlande di loto intrecciate"; Cypria fr. 5 Bernabé hJ
de; su;n ajmfipovloisi filommeidh;" jAfrodivth / plexavmenai stefavnou" eujwvdea"
a[nqea poivh" / a]n kefalai'sin e[qento qeai; liparokrhvdemnoi, / Nuvmfai kai;
Cavrite", a{ma de; crusevh jAfrodivth, / kalo;n ajeivdousai kat∆ o[ro" polupidavkou
[Idh" "Però, Afrodite che ama sorridere insieme alle ancelle…Le dee dallo splendido
velo, Ninfe e Cariti ed insieme l'aurea Afrodite, avendo intrecciato corone profumate,
fiori d'erba le posero sopre le teste, / cantando un bel canto sul monte Ida ricco di
fonti".
5 La lezione del codice A di Ateneo è ajnnhvtw, corretta dal Casaubon (1600, 954)
in ajnhvtw. ajnhvtw è l'eolico per ajnhvqou. Il sostantivo a[nhqon può avere due diverse
grafie: a[nhqon e a[nnhqon. Il termine è attestato in Alc. 362.1ss. ajll∆ajnhvtw me;n peri;
tai;" devraisãià / perqevtw plevktai" ujpaquvmidav" ti", / ka;d de; ceuavtw muvron a\du
ka;t tw; / sthvqeo" a[mmi "si pongano attorno al collo / delle corone d'aneto,
intrecciate e si versi dolce unguento a noi sul petto". In entrambi i casi il testo del codice
A è ajnnhvtw, corretto poi dal Casaubon. Accettare la correzione di Casaubon è per noi
inevitabile, perchè ajnnhvtw in quella sede è ametrico. ajnhvtoio, presente, invece, nel testo
dell'appendice frammentaria di Ahrens e riportato anche dall' edizione critica
teubneriana di Ateneo, quella di Kaibel (1890, 491), nonché accolto dal Wilamowitz
(1913, 52), è inaccettabile perché la desinenza genitivale –oio è epica e non eolica (il
genitivo eolico è –w): Ahrens la escogitò per far tornare il verso, dato che il suo testo
presenta sunovrrais∆ come parola successiva.
Il codice A di Ateneo presenta, dopo ajnnhvtw (corr. Casaubonus), sunerrais∆: la
sequenza ajnhvtw sunerrais∆ non può essere accolta nel testo, perché difetta di una
sillaba breve. Il primo a modificare il passo fu il Casaubon (1600, 954) che, invece di
sunerrais∆, scrisse l'ametrico drevyais∆ "avendo strappato, colto": egli non si poneva
problemi metrici, ma era, comunque, riluttante ad accettare sunerrais∆ nel testo. Lo
Schweighäuser, nel suo commento ad Ateneo, non accettò la correzione proposta dal
Causabon e mantenne sunevrrais∆, intendendolo come "foem. part. Aor. primi verbi
suneivrw", cioè equivalente all'attico suneivrasa, "dopo aver intrecciato": una soluzione
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
267
che, però, non sana il problema metrico, ovvero la mancanza di una necessaria sillaba
breve. Neue (1827, 65) propose di scrivere suneevrrai", con due epsilon come negli
omerismi e[erto, ejeivsato, ejevlmeqa etc.: tuttavia, come nota Ahrens (1839, 267), in quei
verbi omerici il primo epsilon non è altro che l'aumento e propone, invece, due diverse
congetture, non senza un po' di confusione: 1) scrive sunovrrais∆ sulla base di Choer.
An. Ox. 209, 32 Cramer ei[rw: shmaivnei de; to; sumplevkw, dia; th'" ei
difqovggou...kai; a[llw" o{ti oiJ Aijolei'" oi[rato levgousin; 2) altrimenti (?), nella nota
propone di scrivere sunaevrrais∆, ovvero la congettura che compare nelle edizioni
moderne di Saffo e che sembra garantita dalle tracce poste sul papiro (cioè ev).
sunaevrrais∆ è proposto anche da Ahrens in un articolo pubblicato sul Rheinisches
Museum dello stesso anno326
, dove comunque non si trova traccia di sunovrrais∆. Per
Ahrens ajeivrw "olim nectendi significationem habebat". In realtà la situazione è più
complessa di quanto la intenda Ahrens ed il verbo ajeivrw non può aver avuto il
significato di "attaccare, connettere" se, nel suo uso principale, va inteso come
"sollevare": il primo significato sarà da intendere come un uso tecnico e solo se
connesso con il preverbo suvn- (anche in tmesi). Chantraine, DELG riporta questi passi
come esempio di sunaeivrw nel senso di "attaccare, congiungere, aggiogare" (e cfr.
anche LSJ s.u.): Il. X 498-499 tovfra d∆a[r∆oJ tlhvmwn jOduseu;" luve mwvnuca" i{ppou"
/ su;n d∆h[eiren iJma'si..."nel frattempo, invece, il coraggioso Odisseo scioglieva i cavalli
dallo zoccolo unito/ li legò con le cinghie"; XV 679-680 wJ" d∆o{t∆ajnh;r i{ppoisi
kelhtivzein eju÷ eijdwv", / o{" t∆ejpei; ejk polevwn pivsura" sunaeivretai i{ppou" "come
quando un uomo esperto nel cavalcare, imbriglia quattro cavalli tra molti…"; Hsch.
xunaivretai: sunavptetai. I due passi dell’Iliade si trovano citati anche da Ahrens
(1839b, 230). E cfr. anche Call. Fr. 295 Pf. su;n d∆a[mudi" forutovn te kai; i[pnia
luvmat∆a[eiren "contemporaneamente ammucchiava rifiuti e sozzura di sterco", un
parallelo più recente richiamato in apparato dalla Voigt, a cui si può aggiungere anche
l'espressione sunaivrein ta; genhvmata "raccogliere i frutti" (attestata in TAM 2, 245, 9;
proveniente dalla Licia) e Dsc. I 30 oJ ejpi; toi'" balaneivoi" sunairovmeno" rJuvpo" "la
326
Ahrens 1839b, 230. L’apparato della Voigt (1971, 92) inganna e fa credere che della congettura
sunaevrrais∆ Ahrens abbia dato notizia solo sull’articolo pubblicato sul Museo Renano, ma essa si trova
anche nel De dialectis aeolicis et pseudo-aeolicis. Si pone un problema cronologico, ma cercare di capire
quale dei due contributi sia stato pubblicato per prima appare inutile: la grammatica cita l’articolo, ma
nella prima sembra possibile ravvisare, a questo riguardo, una materia in fieri.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
268
sozzura raccolta nei bagni". sunãaÃevrrais∆, congettura di Ahrens, sembra dunque la
soluzione migliore per risolvere il guasto nel testo.
Da segnalare anche un'ultima correzione in questo verso: ajpavlaisi in luogo della uox
nihili ajpallagish è una congettura del Casaubon ed è stata accolta da tutti gli editori
successivi. Per ajpavlaisi cevrsin cfr. Alc. ajpavlaisi cer[si; Od. XXI 150-151
cei'ra".../ ...aJpalav"; Aeschl. Pers. 537 aJpalai'" cersi;;; Timocl. Fr. 22.6 (= Mar. fr. 1.
6) K.-A. ajpalai'si cersivn; Theoc. XXIV 55 ceivressin...aJpalai'sin.
6 Gli ultimi due versi del frammento sono conservati ancor peggio dei percedenti,
ma il senso è chiaro e, almeno su questo, non vi è stata alcuna discussione:"a colei che si
adorna di fiori anche le beate Cariti / rivolgan lo sguardo, ma lo distolgono da chi non
porta corone". Dopo eujavnqea e prima di ga;r è necessaria una sillaba lunga, ma essa
non è stata tradita dalla tradizione medievale. Una soluzione immediata, accettata anche
da Hermann (1835, 126) sarebbe quella di integrare un me;n prima di ga;r, come propose
di fare Seidler (1829, 195): senza il me;n, il d∆ del verso successivo rimane privo di
antecedente. Tuttavia si tratta di una soluzione che non sana il testo: difatti, un ulteriore
problema è dato dallo stesso pevletai, che, anche se metricamente valido, non dà un
senso accettabile al passo, sicchè ga;r pevletai è messo tra cruces nell'edizione della
Voigt.
Il verbo pevletai richiede, come soggetto, un nominativo singolare che nel nostro testo,
così come si presenta, non c'è e non si può tentare di correggere Cavrite" in cavri" te,
come si presentava il testo prima della scoperta del codice A, perché ajpustrevfontai
richiede un soggetto plurale. pevletai non può restare senza un soggetto, non è attestato
come impersonale e non può significare, quindi, "accade che, c'è che…" uel similia. La
conclusione è, dunque, che anche pevletai è corrotto. Ed i problemi testuali non si
esauriscono qui. eujavnqea, a meno di considerarlo un aggettivo sostantivato (in questo
caso, però, occorrerebbe l’articolo), da solo non può stare: Wilamowitz (1913, 52) fu,
del resto, il primo a notare che il testo tradito dalla tradizione di Ateneo è discordante
(eujavnqea, privo come è di un referente e posto questo testo, non può che ricollegarsi a
Divka) rispetto alla spiegazione. In particolare Ateneo insiste nel ritenere le parole di
Saffo quali una considerazione generale, valida per ogni persona e non per la sola Dika.
Ecco perché Wilamowitz (1913, 52) proponeva di correggere il testo in eujavnqea ga;r
pai'd∆ejqevlhsan Cavrite" mavkairaãiÃ.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
269
Ed eujavnqea crea difficoltà non solo perché sembra privo di un sostantivo a cui si
riferisce, ma anche perché non sappiamo con esattezza che forma sia: per Neue (1827,
66) e West (1970, 321) sarebbe un neutro plurale, cordinato con protevlh∆ (congettura
dello stesso Neue del verso successivo) e non un accusativo maschile/femminile
singolare, ma questa ipotesi non sembra molto sostenibile. È più probabile, invece, che
si tratti di un accusativo singolare.
Secondo la Bartol (1997, 77) Saffo non starebbe spiegando qui perché i partecipanti ai
riti devono portare corone sulla testa, ma perché Dika deve prendere la corona di fiori e
porla sulla sua testa. Non si tratterebbe, dunque, della spiegazione di un ordine generale
delle cose, del perché si è soliti portare corone sulla testa durante i riti, ma di un invito
rivolto alla sola Dika. Questa interpretazione, tuttavia, appare francamente eccessiva:
primo perché obbliga a postulare che Ateneo abbia commesso un errore così notevole
(ed abbiamo visto che altrove le spiegazioni di Ateneo non contrastano con le sue
citazioni da Saffo) e secondo perché di quest’ode sappiamo troppo poco per portare
avanti una simile ipotesi. La Bartol (1997, 77) afferma anche che il kai; del v. 6
confermerebbe che “tutta la frase assume la funzione di una giustificazione addizionale”:
ciò significa che la giustificazione presente nel testo (e che la studiosa polacca intende
come riferita alla sola Dika) doveva essere preceduta da un’altra più generale? Eppure di
quest’altra non è presente alcuna traccia nel testo e non è conveniente pensare che
Ateneo non l’abbia citata.
È, invece, più verosimile pensare che Ateneo non abbia torto e che, effettivamente,
all’invito rivolto a Dika seguisse una spiegazione più generale. E per quanto riguarda il
testo posto tra cruces è bene sottolineare che pevletai presenta almeno tre lettere che
possono essere state sensibili ad errori da maiuscola (PELETAI), p, l e a. E pevletai è
preceduto da ga;r, con g ulteriore, possibile causa di errore: GARPELETAI. Ed il kai;
non crea meno problemi: richiama foneticamente il –tai precedente, ma anche il ca-
successivo e poteva essere anche esso causa di errore. È, dunque, molto probabile
pensare a più di un errore da maiuscola. Notare, inoltre, che –etai di pevletai potrebbe
essere stato causato da una cattiva pronuncia di AITAI, a sua volta un errore da
maiuscola per –NTAI: si avrebbe, così, la tanto desiderata III personta plurale da
concordare con Cavrite". Possibile anche -nt∆ aij Cavrite" mavkairaãiÃ. Un simile
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
270
errore, evidentemente, era stato ipotizzato da Wilamowitz anche per pevl-: egli restituiva
pai'd∆, ipotizzando una confusione tra PAID e PAIL.
Per la parte finale del verso il testimone, il codice A di Ateneo presenta kai; Cavrite"
mavkaira: mavkairaãià è presente per la prima volta nell'edizione di Blomfield (1823,
301); del resto, mavkaira da solo non può stare, perché non ha senso. Le Cariti sono
strettamente connesse con Afrodite: in Od. VIII 364-366; [Hom.] Hymn. Ven. 61 esse la
lavano e l’ungono, mentre in Od. XVIII 193ss.; [Hom.] Hymn. Apoll. 189-196; Cypria
fr. 5 Bernabé esse danzano con lei. Saffo stessa, in un’ode di cui serba memoria il retore
Imerio (Sapph. test. 194 V. = Himer. Or. IX 4 p. 75s. Colonna), presenta l’immagine di
Afrodite sul carro delle Cariti. Altrimenti, le Cariti sono ricordate insieme alle Muse: cfr.
Sapph. 44b; 103; 128; 208327
. La Bartol (1997, 79) ipotizza, quindi, che la cerimonia
rituale della quale Saffo parla nell’ambito del suo carme sia stata dedicata alle Cariti
stesse, oppure ad una divinità a cui esse erano connesse, ad esempio Afrodite: su queste
basi è possibile supporre, secondo la Bartol, che la dote concessa a Dika dalle dee che la
guardano con occhio benevolo abbia pure una dimensione erotica. Secondo la Bartol
(1997, 79 e n. 19), che cita la Pippin Burnett (1983, 296-297), il richiamo alle Cariti
dimostrerebbe, infatti, l’interessamento di Saffo per Dika perché la grazia che le Cariti
concedono non sarebbe altro che il fascino: che tutto ciò non preveda un risvolto
personale non è, certo, credibile, come non lo è come ritiene la Bartol (1997, 77), che
qui Saffo si riferisca solo a Dika e non parli anche in termini generali.
7 La tradizione di Ateneo presenta il seguente testo: ma'llon protevrhna
stefanwvtoisi dapustrevfontai. Il primo a proporre la corretta divisione in proterhn
aj. è stato lo Scaligero, che fu anche in grado di distinguere correttamente la serie di
lettere dapustrevfontai: la sua congettura, d∆ajpostrevfontai, fu poi rifinita dal Koen
(1766, 275), che propose di scrivere l'eolico d∆ajpustrevfontai. Il testo più corretto che è
stato possibile restituire è ma'llon proterhn ajstefanwvtoisi d∆apustrevfontai: il
verso così restuito non presenta alcun problema metrico, ma proterhn, tradito dal
codice A, è privo di un senso adatto: il verbo proterevw (protevrhn dovrebbe essere
l'infinito presente eolico) è attestato, ma nel significato di "essere prima, precedere,
avvenire prima, essere o riuscire superiore", che non sembra adatto a questo contesto.
327
Per la relazione tra le Cariti, le Muse ed Afrodite cfr. anche Lanata 1966, 67; Gentili 2006, 157;
Grandolini 2000, 357.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
271
Neue (1827, 66) congetturò protevlh∆ “sacrifici offerti prima” (coordinato con eujavnqea
del verso precedente), ma la congettura più felice è stata quella di Seidler (1829, 195),
che richiede solo di modificare una lettera: scrisse protovrhn, inteso come l'esatto
corrispondente dell'attico prosora'n. Il testo proposto da Seidler perde, però, consenso di
fronte ai vari verbi composti con pros- attestati in Saffo: Sapph. 16.28 pros[; Sapph.
29e.1 pros≥teto≥[; 56.1 prosivdoisan. prot(iv) non è mai attestato, nei frammenti eolici a
nostra disposizione, in funzione di preverbo. prosovrhn fu proposto dal Wilamowitz.
Hartung, invece, ha proposto potovrhn. Quale che sia la forma giusta, il significato
risulta chiaro: “rivolgono lo sguardo”. Anche l’altro verbo del verso, ajpustrevfontai,
assume significato figurato: il verbo, al medio, significa, infatti, “non essere benevolo o
benigno”. Per espressioni simili cfr. Tyrt. 8.2 Gentili-Prato = 11.2 W.2 ou[pw Zeu;"
aujcevna loxo;n e[cei “Zeus non ha certo il collo torto”. Per il ricorrere nello stesso
verso delle espressioni “rivolgere lo sguardo” e “distogliere lo sguardo” cfr. Thgn. 857-
858 tw'n de; fivlwn eij mevn ti" oJra'i mev ti deilo;n e[conta / aujcevn∆ajpostrevya"
oujd∆ejsora'n ejqevlei “se uno degli amici vede che io ho qualcosa di terribile /avendo
storto il collo non vuole guardare”. Per lo sguardo come simbolo di benevolenza cfr.
anche Hor. Carm. IV 3.1ss. Quem tu, Melpomene, semel / nascentem placido lumine
uideris / illum non labor Isthmius / clarabit pugilem, non equus impiger “colui che tu,
Melpomene, una volta che / nascere con dolce sguardo osservi, / non l’istmia fatica / lo
renderà famoso come pugile, né un fervido cavallo…”. L’ornamento di rito, usuale al
gruppo, la corona da portare in testa, diviene un fatto significante la presenza delle
Cariti328
.
ibV(82 L.-P. = V.) metrum: hipp
2cho (a); hipp
2cho suppl. possis (b)
a
eujmorfotevra Mnasidivka ta;" ajpavla" Gurivnnw"
a
Mnasidica è più bella della delicata Girinno...
328
Cfr. Gentili 2006, 158.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
272
b
kaivt∆ ej[ mhden[
n —u'n d∆aj[ mh; bovlle≥[
5 euj]morfo≥[tevra
b
certo (?)...
niente...
ma ora...
non volere...
5 più bella...
TEST (a) (I) Heph. 11, 5 p. 36 Consbruch kai; tetravmetra de; ajkatavlhkta diafovrw" sunevqesan: h] ga;r trisi;n ijwnikai'" mivan trocai>kh;n th;n teleutaivan ejphvgagon –
kalei'tai de; Aijolikovn, o{ti Sapfw; pollw'i aujtw'i ejcrhvsato – oi/on [a] (II)
Longin. Proll. in Heph. 3 p. 82 Consbruch tou'to ga;r a[ntikru" jIwnikovn ejstin ajpo; meivzono" o{moion tw'i [a] (III) Choerob. In Heph. 178, 24 Consbruch ajlla; kai; ijwnikovn ajpo; meivzono" para; tw'i aujtw'i [Pi. O. III 4] o{moion [de;] tw'i [a] (IV)
(Hdn. Peri; klivsew" ojnomavtwn ap.) Aldi Thesaurus Cornucopiae f. 268v
(ap. Choerob.
Ed. Hilg. vol. 2, praef. P. 65, 39ss., cf. Hilg. ad l.) = cod. Voss. Gr. 20 ap. Reitzenstein
1897, 367 oiJ de; Aijolei'"...prosqevsei tou' "s" poiou'si th;n genikhvn, oi\on hJ Sapfwv, th'" Sapfw'"...kai; dhlou'sin aiJ crhvsei"...kai; pavlin par∆aujth'/ th/' Sapfoi': [Sapph. 144], kai; pavlin:[1a]: e[stin hJ Mnai÷" au}th kai; hJ Purinw; ojnovmata kuvria...th;n de; aijtiatikh;n oiJ Aijolei'"...prosqevsei tou' "n" ejpoivoun th;n LhtwvãnÃ, wJ" kai; hJ crh'si" dhloi': [inc. auct. 11], aijtitiakw'" (-kh'" cod. Voss.) gavr ejstin ajpo; eujqeiva" th'" JHrwv. prim. rec. Steph.
1; fr. a e fr….seclusit Blomfield 1823, 302 (frr.
XXVI-XXVII) (b)POxy. 1787 fr. 34,cuius v. 5 fort. novi carminis initium est, qua re cf
initium fr. a
prim. rec. Diehl1 1923
CRIT (a) eujmorfotevra (I), (II): ajssarotevra (III): ajmorfovteron (IV)
mnasidivka (I), (II) et (III): Mnai?do" kai;(IV): Mnai'", Divka Ahrens : Mna'si, Divka Lobel 1925, 40 ajpavla" (I), (II), (III): ajplw'" (IV)
gurivnnw"(I)codd.: gurivnnw (I) H : ghri?nw" (I) C : ajrgurivnnw (I) N : gurivnw (I) ed. princ. : gurhvnw" Turnebus : gurivnnw (II) codd.(Gurinnw'" corr. Toupius 1778,
391-392), (III) RK1(sed in K
1 post –w littera erasa): gurivnnh" (III) K
2 : puri(n)nw'"
(IV) (b) 1 kavit∆ ║3 d∆a ║4 bov bovlle[o Hunt 1922, 39 inter
vv. 4 et 5 paragraphos suppleta euj]morfo≥[tevra Hunt 1922, 39 o[ vel e[
a
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
273
Il frammento è giunto interamente per tradizione indiretta. A citarlo ed a tramandarcelo
è, principalmente, Efestione: gli altri testimoni dipendono dal metricista antico. Nella
parte dell' Enchiridion (11, 5 p. 36. Consbr.) dedicata ai metra ionici Efestione osserva:
kai; tetravmetra de; ajkatavlhkta diafovrw" sunevqesan: h] ga;r trisi;n ijwnikai'" mivan trocai>kh;n th;n teleutaivan ejphvgagon – kalei'tai de; Aijolikovn, o{ti Sapfw; pollw'i aujtwi' ejcrhvsato – oi|on
eujmorfotevra Mnasidivka ta;" ajpavla" Gurivnnw" ajsarotevra" oujdavma pw Ei[rana, sevqen tuvcoisan
composero in maniera eccellente anche tetrametri acatalettici, oppure aggiungevano ai
tre ionici un trocheo finale: è chiamato Eolico, perché Saffo l'ha utilizzato molto, ad
esempio:
Mnasidica è più bella della delicata Girinno...
(che)...non avendo mai incontrato sinora una ragazza più fastidiosa di te, Irene.
Efestione, dunque, cita Saffo, precisamente due versi, per esemplificare i concetti
metrici che ha appena introdotto. La divisione dei due versi in due frammenti diversi si è
imposta tra gli editori a partire dall'edizione di Blomfield (1823, 302). Non interessa qui
affrontare i problemi metrici e la nomenclatura a cui ricorre Efestione (per i quali v.
Introduzione), ma quelli filologici ed interpretativi. Il testo del frammento varia da
testimone a testimone: Hdn. Peri; klivsew" ojnomavtwn ap. Aldi Thesaurus Cornucopiae
f. 268v
= cod. Voss. Gr. 20 tramanda il testo più eccentrico. eujmorfotevra è la lezione
sia di Efestione, sia dei Prolegomena di Longino: del resto quest'ultimo, dipendendo dal
metricista, a meno di lapsus, non può che avere lo stesso testo davanti. Choerob. In
Heph. 178.24 Consbr. presenta, invece, ajssarotevra: egli sembra aver confuso l'attacco
di due frammenti diversi, ovvero questo e quello che qui pubblichiamo come seguente,
che presenta, difatti, ajsarotevra": la confusione sarà dovuta al fatto che entrambi i
frammenti si trovano citati l'uno di seguito all'altro in Efestione. La lezione del codice
Voss. gr. 20, che riporta il Thesaurus Cornucopiae di Aldo è, invece, ajmorfovteron: le
due lezioni non potrebbero essere più distanti! ajmorfovteron, inoltre, non solo ha un
senso del tutto opposto alla lezione presente negli altri testimoni, ma rende anche il testo
incomprensibile: mentre eujmorfotevra è coordinato con Mnasidivka, ajmorfovteron, se è
maschile, è privo di ogni referente nella frase: “più deforme di Mnaide e di… Pirinno”.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
274
Per queste ragioni riteniamo che eujmorfotevra sia da accogliere pienamente.
L’aggettivo eu[morfo", come nota Cavallini (1985, 33) è attestato qui per la prima volta
nella “letteratura greca”: il termine verrà ripreso da Aeschl. Suppl. 1003 kai; parqevnwn
clidh'sin eujmovrfoi" e[pi “alle bellezze graziose delle fanciulle”; Ag. 416 eujmovrfwn
de; kolossw'n “delle belle statue”. ajpalov" è un aggettivo utilizzato nell’epos per
indicare parti del copo, specialmente di dee e di donne splendide ed avvenenti: cfr. e.g.
Il. XIX 285 aJpalh;n deirh;n “il tenero collo” (di Briseide paragonata ad Afrodite);
Hymn. Ven. 90 sthvqesi ajmf∆ajpavloisi “intorno al delicato petto” (di Afrodite).
Altrimenti l’aggettivo è utilizzato per persone molto giovani: cfr. e.g. Od. XIII 222sg.
ajndri; devma"...nevwi, ejpibwvtori mhvlwn / panapavlwi “ad un uomo di corpo giovane,
ad un pastore di greggi / delicato”. Cfr. Sapph. fr. 122 V. pai'd∆a[gan ajpavlan “ragazza
troppo delicata”; 126 V. ajpavla" ejtaãivÃra" “di una tenera compagna”. Mnasidivka è
lezione concorde di Efestione, di Longino e di Cherobosco e non vi è ragione di proporre
alcuna correzione, come ad esempio Mnai'", Divka di Ahrens o Mna'si, Divka di Lobel
(1925, 40). Per Theander (1943, 154) non vi è necessità di introdurre, accanto a Girinno
ed a (Mnasi)dika una terza ragazza. Non vi è dubbio che l'argomento di maggior peso
per accogliere il testo di Lobel sia offerto dal quarto testimone, ovvero il codice vossiano
che, al posto di Mnasidivka, presenta, inspiegabilmente, Mnai?do" kai;, collocando,
dunque, sullo stesso piano due ragazze altrimenti ignote, ovvero Mnaide e Pirinno. Un
ulteriore argomento è dato dal fatto che in Sapph. 101 V. sia presente, a quanto sembra,
il nome Mna'si": tutto ciò non può portare ad alcuna conclusione sicura: difatti, in quel
passo Mna'si" è frutto di una congettura di Wilamowitz ed inoltre, anche se
l'accettiamo, nulla vieta di pensare che Mna'si" sia un' Abkürzung per Mnasidivka:
abbiamo già accennato, del resto, all'ipotesi di Welcker (1828, 421), secondo il quale
Divka del frammento precedente non sarebbe altro che un' Abkürzung per Mnasidivka: v.
fr. prec. e ad loc. È inoltre doveroso segnalare che Divka potrebbe essere stato utilizzato,
amichevolmente, per indicare non solo Mnasidivka, ma anche la Pleistodivka di cui si
parla in un frammento ad un commentario ad un carme di Saffo alla cui comprensione
recentemente Ferrari ha dato un contributo notevole: si tratta, ovviamente, di Sapph. 213
V. Il testo del codice vossiano presenta aJplw'" invece ajpavla" che non dà senso al
passo, soprattutto in questa posizione. Gurivnnw" è la lezione di Efestione, mentre
Longino ha gurivnnw. Il primo a correggere il passo ed a comprendere che si trattava di
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
275
un nome proprio è stato Toupius (1778, 391-2), il quale si basava sulla notizia fornita da
Etym. Magn. s.u. Gurinnw;: o[noma kuvrion Lesbiva" kovrh", ei[rhtai parwnuvmw"
para; to; gurivno", o} dhloi' to;n bavtracon. Gurinnw;, wJ" e[rato", jEratwv. kai;
klevo", Klew; kai; Kleiwv. E cfr. anche Gaisford 1810, 64 n. 2 ad loc..
Il nome di questa ragazza compare, tuttavia, sebbene in una forma leggermente diversa
(Guvrinna), anche in Max. Tyr. XVIII 9 (= Sapph. 219 V.), una preziosa testimonianza a
cui abbiamo già accennato nell'introduzione.
Per Gurivnnw" negli altri frammenti di Saffo cfr. Sapph. 29h.3 V.; 90a col. III 15
(v.infra); 219. Vagliate testimonianze e paralleli, non possiamo che non accogliere la
lezione del codice vossiano che, ancora una volta, presenta un testo del tutto eccentrico
rispetto al resto della tradizione: al f. 286v del Thesaurus Cornucopiae di Aldo si legge,
infatti, purinnw'", che sembrerebbe essere un palese errore da maiuscola (P pro G), ma
che, visto il carattere eccentrico di questo testimone, è dubbio se lo si debba considerare
veramente tale. Per West (1970, 327-328), non è un caso che il nome di Girinno compaia
anche in Sapph. DV laV fr. 1 col. III 15 = 90a col. III 15 V. (v. infra): il grecista
britannico ha ipotizzato che in questo carme, alla constatazione della superiorità estetica
di Mnasidica (West, tuttavia, chiama la ragazza Dika), seguisse un rimprovero dovuto al
carattere della ragazza: purtroppo, però, non si ha a disposizione alcuna prova per
dimostrare la fondatezza di una tale ricostruzione.
b
Il motivo per cui questi due frammenti vengono considerati insieme nelle edizioni
moderne è semplice: dato il testo tradito dal papiro si è ritenuto lecito integrare la
citazione presente nella tradizione indiretta all'ultimo verso, il che equivale ad ipotizzare
una fortunata coincidenza tra i due testimoni, quello diretto (il papiro) e quello indiretto:
essa fu ipotizzata già da Hunt (1922, 39, 45) e Nicosia (1976, 45-46) la ritiene
"inevitabile": portano ad una tale conclusione sia gli argomenti metrici (si tratta dello
stesso metro), sia testuali (in entrambi i testimoni eujmorfotevra è ad inizio di verso).
Aloni (1997, 132-133) va ben oltre: "con ogni probabilità il verso 5 segnava l'inizio del
nostro carme, mentre i quattro precedenti dovevano costituire la chiusa dell'altro". Che il
fr. a costituisse il primo verso, ovvero l'inizio di una nuova ode, lo possiamo inferire,
forse, dal solo fatto che viene citato da Efestione: difficilmente avrà potuto riportare un
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
276
verso tratto dalla metà di un'ode (inutile sottolineare che il testo tradito da Efestione è in
sé concluso e dotato di senso), anzi si sarà trattato, molto probabilmente, di un attacco
piuttosto famoso.
1 Su kaiv è ben visibile l'accento. Si dovrà intendere, dunque, kaivtoi, oppure kaiv
toi, dove toi corrisponde all'attico soi, per cui cfr. Sapph. DV eV 21 = 65, 7 V. (v.
supra) e Hamm 1958, 107.
4 Per bovlle≥[ cfr. Sapph. 22.19 b]ovlloma≥[i; 16.17 bolloivman; Alc. 70.8 bovllht(ai);
81.7 ]b≥o≥l≥l≥[; 112, 11 ejbovl [leto.
igV(91 L.-P. =V.) metrum: hipp2cho
ajsarotevra" oujdavma pw Ei[rana, sevqen tuvcoisan
(che)...non avendo mai incontrato sinora una ragazza più
fastidiosa di te, Irene.
TEST (I) Heph. 11, 5 p. 36 Consbruch (codd. AHI) [1] Choerob. In Heph. 11,
p. 244 Consbruch (codd. K U) Ei\ta ejpifevrei a[llwn tinw'n paradeivgmata, levgwn kai; to; povqen suvgkeitai, ejn oi/" parafevrei tou'to to; Sapfou'" [1]. o} de; qevlei eijpei'n, toiou'tovn ejsti: blaberwtevra" oujdamw'" pouv (mou' K) pote, Eijrhvnh (eijrhvnh" codd., corr. Bergk), sou' (sou'] sevqen K) ejpitucou'sa (-ou'sa K) prim. rec. Steph.
1
CRIT ajsa- (I) codd. AH, (II): ajssa- (I) cod. I et Choerob. In Heph. p. 178, 24
Consbruch, sed v. supra. ajsarotevrasoujdam∆a. pw[rana (I) cod. A : oujdamap∆w[rana (I) cod. I : ajsarotevra s∆ oujdavm∆ajpwvrana (II) K
: oujdavmavpa eijrhvna (II) U : pw prim. cogn. Arnaud : oujdamav pw, jranna; Blomfield
1823, 302 : oujdavm∆ujpwravnia Neue 1827, 62-63: oujdam∆e[p∆w\ jravnna Hermann 1835,
124-125 : oujdamav pw, jranna Schneidewin 1838, 314 : oujdam∆ejt∆w \ jranna Ahrens
1839, 267: nom propr. Ei[ranna cogn. Bergk3, Ei[rhna Fick 1891, 208 : ou[dam ejp∆, w \
Ei[rhna, Hoffmann 1893, 152 : poi Ei[rhna Edmonds1 1922, 264, pWi[rana Lobel
1925, 42 : pw Ei[rana Voigt 1971, 100 tucoi'san (I): tucou'san (II) cod. U : tuvcoisa K, rec. Hermann 1835, 124-125, Schneidewin 1838, 314, Ahrens
1839, 267, Bergk1
1843, 616, Edmonds11922, 264 : tuvcoi" a[n Blomfield 1823, 302,
rec. Neue 1827, 62-63.
1 Il verso è tradito, nella sua interezza, da Efestione, immediatamente dopo il frammento
qui edito come precedente: dal testo di Efestione dipende, poi, quello di Cherobosco.
L'aggettivo ajshrov" trova qui una delle rarissime attestazioni in poesia: altrove è
presente in un altro frammento di Saffo, ovvero Sapph. 103 V. gav]mbron, a[saroi g ≥a;r≥
u≥jmali≥k[ “lo sposo, infatti fastidiosi i compagni”; ma cfr. anche Soph. fr. 268 R. ajsarovn.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
277
L'aggettivo, successivamente, diventa caratteristico del gergo medico. È derivato da a[sh
(eol. a[sa), per cui cfr. Sapph. 1.3; DV iV a, 4 = 68a. 4 V. (v. supra); Alc. 39a.11.
Una ragazza di nome Irene viene nominata anche in Sapph. 135 Tiv me Pandivoni", w\
Ei[rana, celivdwn “Perchè, o Irene, la figlia di Pandione, la rondine, me...”: lì siamo in
un contesto, a quanto pare, amichevole, mentre qui si tratta di un attacco giambico, ma
non possiamo sapere chi rivolga queste parole.
Per sevqen, sempre tonico e corrispondente all'attico sou' o sou, cfr. Hamm 1958, 107. Il
pronome eolico è caratterizzato dallo stesso suffisso –qen presente in avverbi o in altre
espressioni che indicano l'origine, ad esempio povqen etc. Forme pronominali di tal sorta
si riscontrano anche in Omero, ad esempio ejmevqen in Il. I 525 (al.).
tuvcoisan sembra essere una lectio difficilior rispetto al semplice nominativo tuvcoisa:
è forse ipotizzabile che si tratti di una frase dichiarativa retta da un verbum dicendi? Del
resto, come nota Aloni (1997,148-149), il participio femminile potrebbe anche essere
riferito ad una persona diversa da Saffo. Per anni si è ritenuta possibile la coincidenza tra
questo verso tradito da tradizione indiretta e quello che nell'edizione della Voigt
compare come 60.1 = Sapph. DV eV 9, per cui v. supra: il collage operato da Ferrari e da
Puglia, tuttavia, ha tolto credito ad una simile ipotesi e la sola presenza dell'accusativo,
che non si riscontra nell'altro frammento, avrebbe dovuto rendere gli studiosi più cauti di
fronte ad una simile ipotesi. E non si può, certo, risolvere il problema come fecero molti
insigni editori e studiosi dell'Ottocento (Hermann 1835, 124-125; Schneidewin 1838,
314; Ahrens 1839, 267; Bergk1
1843, 616: essi, tuttavia, non avevano all'epoca a
disposizione il POxy. 1787 e, quindi, muovevano da altre motivazioni, cioè
normalizzavano il testo), ovvero non darsi alcuna cura dell'accusativo e, quindi,
trascrivere il participio al nominativo! Gli editori novecenteschi sono stati un po' più
cauti, ma quasi mai fino al punto di negare una simile possibilità: così Lobel (1925, 42; I
App.), così Lobel-Page (1955, 73; I App.), così la Voigt (1971, 101) e così anche
Nicosia (1976, 46). Nel Novecento l'unico editore fuori dal coro è Gallavotti (1957,
112). Crediamo si possa dare una spiegazione piuttosto ragionevole: nel corso delle
poesie di Saffo e, come abbiamo visto, addirittura in questo stesso libro si hanno molti
casi di ripresa di uno stilema o di un'intera espressione già utilizzata in precedenza:
Nicosia (1976, 41-43) presenta un elenco di casi simili, cioè di passi in cui è presente
un'espressione utilizzata anche in un altra poesia o in un altro libro. Qui basti richiamare
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
278
alla memoria un caso in cui ci siamo imbattuti nel corso di questo stesso commento,
ovvero quello della ripresa dell'espressione, anche in clausula, calevpan...merivmnan,
calevpai m[erivmnai, cavlep≥[ai mevrimnai. E lo stesso si dica, centrando maggiormente
l'obiettivo, della numerosa frequenza, nel corso di questo libro, di participi femminili
sempre in clausula. Bisogna, inoltre, tenere in considerazione un fenomeno peculiare
della metrica eolica, ovvero l'isosillabismo, che costringeva il poeta in un numero
prestabilito di sillabe senza poter mai sciogliere una lunga in due brevi o viceversa:
simili costrizioni non possono che portare, ogni tanto, al riuso di un'espressione già
composta. In conclusione, la presenza qui di un tale participio non prova affatto questa
coincidenza ed una simile evenienza non potrà che indurci, in futuro, ad una maggiore
cautela nel trarre conclusioni simili.
idV(64 L.-P. = V.) metrum: hipp2cho
vel hippxcho
║ hippxcho
║ hippx-1cho
suppl. possis?
a
]lak≥[ ]
]niv.[ a]livkes≥≥si[
5 ] ]paivdwn[ ]dho≥≥n ]
] 10 ]qent[
].qevois≥[ ]n aijscr[ ] ]a moi'[
15 ]teti[
b ≥].a[ ]aivga[
].do.[ ] [
5 ...
...
...
…ai compagni
...
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
279
10 …di ragazz-
...
...
...
...
15 …gli dei
…vergogn-
...
...Musa (?)
...
TEST (a) POxy. 1787 fr. 17 [11-15], quocum fr. S. m. d — 6 a prim. ed. [1-10] coni.
Lobel 1925, 29-30 (b) fr. a Lobel 1925, 29-30 editum, quod ex infer. parte
eiusdem col. provenisse censuit Lobel 1925, 29 prim. rec. Lobel 1925, 29-30
CRIT (a) 3 fort. l≥[ ║4 livk : a]livkessi Lobel 1925, 29 :. aj]livkessi vel ujma]livkessi suppl. Voigt 1971, 82 fort. post a]livkessi finis versus, metro cogente ║12 aivs ║14 moi' Moi'[sa vel moi'[ra suppl. Voigt 1971, 82 ║15
]teti[, te suprascriptum (b) 1 vestigia hastae obliquae, quae Lobel 1925 leg. ut h
║2 a≥ivga ║3 post omicron vestigia hastae obliquae
a
Di questo frammento, purtroppo ben poco definibile, è importante sottolineare un fatto
non di poco momento: sembra essere organizzato, infatti, non in strofe distiche, ma
tristiche, con l'ultimo verso di ciascuna più breve rispetto agli altri due. Finora abbiamo
commentato, esclusivamente, frammenti in strofe distiche. Non possiamo dire con
certezza che appartenesse allo stesso libro dei precedenti, ma l'essere stato tradito dallo
stesso testimone, il POxy. 1787 sembra portare proprio ad una simile conclusione.
Questa constatazione, effettuata già dalla Voigt ben prima della sua edizione del 1971,
assume un peso ancora maggiore quando si consideri il fatto che anche altri frammenti
dello stesso papiro sembrano organizzati in strofe di tre versi. Non solo: un frammento,
con una maggiore qualità di conservazione, ma tradito da un altro testimone, ovvero il
POxy. 2290, presenta un metro simile, ma sempre organizzato in strofe tristiche e con il
terzo verso più breve: si dovrà concludere che questo libro inglobasse poesie sia in strofi
distiche che tristiche?
4 La prima sequenza di lettere con un significato preciso si trova al quarto verso: se
la suddivisione per strofi tristiche è giusta, saremmo in presenza del verso centrale,
ovvero il secondo, di una singola strofe. a]livkessi è integrato da Lobel (1925, 29), ma
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
280
come nota la Voigt in apparato anche ujma]livkessi si adatta al verso: arrivare ad una
integrazione più certa, a causa del pessimo stato di conservazione del teso, è impossibile.
Per a]livkessi o ujma]livkessi e per altri composti simili cfr. Sapph. DV iV a.5-6 = 68.5 +
70.5 V. jAn]Õdromevdan ... ajpav]lik∆ “l'attempata Andromeda”; DV kV 7 = 76.7 V. ]a–
lik[; Sapph. 30.7 soi;" ujmavlik≥[a" "i tuoi coetanei"; 103.8 gav]mbron, a[saroi g≥a;r≥
u≥jmavli≥k[ "lo sposo, infatti sfacciati i coetanei".
6 È, a quanto pare, il primo verso della strofe successiva. Il sostantivo andrà, forse,
inteso nel suo genere femminile, ovvero “di ragazze”?
12 ai[scr[: “voc. nusquam nisi hic ap. nostram” (Voigt 1971, 82). Il termine viene
integrato da Puglia e da Ferrari nella nuova ode Contro Andromeda al v. 19 ed al v. 23.
14 La Voigt (1971, 82) propose di integrare Moi'[sa oppure moi'[ra. Per Moi'[sa
Sapph. DV aV 8 k≥avla, Moi's∆, ajeivdw “cose belle, Musa, io canti”; DV gV 1 Moivsan
ij]ok[ov]lpwn kavla dw'ra, pai'de" “i bei doni (delle Muse) dal cinto purpureo,
ragazze”, per cui v. supra. Per moi'[ra, invece, cfr. Alc. 39a.10; 112.12; 120.1; 130b. 2;
206.7.
15 te è soprascritto a ti.
ieV (67 L.-P. = V.) metrum: [, hipp2cho
suppl. possis
a
qev]wn mak≥[avrwn k —ai; tou't∆ ejpike.[ daivmwn ojlof[
o—uj ma;n ejfivlhs≥≥[ 5 nu'n d∆ e[nneka[
t —o; d∆ ai[tion oujt[ oujde;n povlu[.].[ .]—ud∆ [.[
b
].oude[
]t≥auta [ ]laisim[ ]plhvoni≥[
5 ] jajmf[ ].sqeo.[ ]e≥[rw".[
degli dei beati…
e questo…
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
281
dio lament- (ingannat-?)…
non certo amavi…
ma ora a causa di…
ma la causa non…
per niente molto…
…né…
…ciò…
…tènere desiderio…
…maggiore…
…intorno…
…amore…
TEST (a) POxy. 1787 fr. 5 (b) POxy. 1787 fr. 18 fragmm. ita
collocanda esse ut fr. 18 haud magno intervallo fr. 5 subiungatur censuit Lobel 1925, 31
(a) prim. rec. Diehl1 1923, 360
(b) prim. rec. Lobel 1925. 31
CRIT omnia in app. crit. non memorata suppl. Hunt 1922, 30-33 et 36-37 (a) 1 k[
simm. : qev]wn mak[avrwn Diehl1 1923, 360 ║2 inter vv. 1 et 2 paragraphos suppleta
tou't∆ ║3 o;lo;΅[ : ojlof.[ leg. Lobel 1925, 31, L.-P. 1955, 47 et Voigt 1971, 83-
84, sed vestigia ullius litterae incertae post f papyrus habet, malim ojlof[ post
o;lo; fort. littera accentu acuto distincta : ojlof[wvio" Hunt 1922, 31 : ojlof[udn- Diehl1
1923: ojloovfrwn ci. Kalinka apud Diehl1 1923, 360 ║4 inter vv. 1 et 2
paragraphos suppleta fivl vel q[ ║5 nund∆ ║6
tod∆avit ║7 povlu[.]ev[ ut vid. ║8 ]ud∆a≥v[ leg. Hunt 1922, 32 : ]ud∆[.v vel [.– leg.
Lobel 1925, 31 : o]ujd∆ Hunt 1922, 33, rec. Diehl1 1923, 360 : s]u; d∆a≥[[ Treu 1976, 62
(b) ║3 povl]lai" Ferrari 1987, 155 e n. 2 : fort. ajpav]lai" i]m[er- (ajpav]lai" acc.) vel ajpav]lais∆i[m[er-? ║4 ]pl˙˘'hvoni≥[ : plhvoni Hunt 1922, 37, rec. Lobel 1925, 31
et Voigt 1971, 83-84: n.[ L.-P. 1955, 47 ║5 jamf ║7 ].vrws.[, fort.
]e≥[rw".[ scribendum : ]e≥[rws.[ Hunt 1922, 36-37, rec. Lobel 1925, 31 et Voigt 1971, 83-
84 : ].vrws.[ L.-P. 1955, 47
a
A questo frammento abbiamo accennato, davvero brevemente, nel commento a Sapph.
DV eV: recentemente, infatti, Franco Ferrari ed Enzo Puglia hanno tentato un collage tra
questi lacerti papiracei e tutti gli altri che qui vengono raggruppati sotto la numerazione
Sapph. DV eV e che tramandano, a quanto sembra, un’ode ad Afrodite. Il motivo per il
quale affrontiamo separatamente questo frammento è semplice: non sembra che il
tentativo di Ferrari e Puglia abbia avuto esiti positivi: per far tornare la loro ricostruzione
gli studiosi sopramenzionati sono costretti a passare sotto silenzio il primo verso di un
frammento coinvolto in quel collage, quello che la Voigt numerava come 65 V.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
282
1 qev]wn mak≥[avrwn è integrato da Diehl1 (1923, 360); per l'espressione cfr. Sapph.
44A a.8 qevwn makavrwn pavthr "padre degli dei beati“; Alc. 5.7 makavrwn qevwn;
130b.13 makavrwn qevwn. E cfr., inoltre, Alc. 129.4 ajqanavtwn makavrwn "dei beati
immortali"; 298.19 ].:t≥a m≥akavrwn; 117b.16 ] D≥ivo["] k≥ai; m[a]ka≥vrwn qevwn "di Zeus e
degli dei beati". Per questo aggettivo / sostantivo nei poeti eolici cfr. anche Alc. 42.6
pavnta" ej" gavmon mavk≥[ara" kalevssai" "chiamati a nozze tutti gli immortali"
(sost.); Sapph. 1.13 mavkaira (sost. voc.); DV iV a.6 = 68a.6 (v. supra) mavka[ir]a; 95.9
o]uj ma; ga;r mavkairan≥ [ "no, per la dea (beata)"; DV iaV 6 = 81.6 V. (v. supra)
Cavrite" mavkairaãià "beate Cariti"; Alc. 112.19 maka....[; Sapph. 15b.1 makai[r; 3.16
maka[. Per l'espressione in altre opere cfr. Il. I 339 qew'n makavrwn (al.); Sol. 4.2 W2.
makavrwn qew'n...ajqanavtwn; 13.3 W2. qew'n makavrwn; Thgn. 834 ajqanavtwn...qew'n
makavrwn; 741 makavressi qeoi'"; 759 ajqavnatoi mavkare" qeoiv (al.)
2 -e.[ (se è la lettura giusta) deve essere in sillaba lunga: Puglia apud Ferrari
(2007a, 62-63) ha proposto di leggere e di integrare ejpivkei≥[r(e): il verbo ejpikeivrw è
attestato due sole volte nell’epos omerico, in Il. XV 467 w] povpoi, h\ dh; pavgcu mavch"
ejpi; mhvdea keivrei / daivmwn hJmetevrh" “Ahimè, un dio distrugge i piani / della nostra
battaglia”; XVI 394 Pavtroklo" d∆ejpei; ou\n prwvta" favlagga" “Patroclo, dopo
aver spezzato le prime schiere”. Per le attestazioni successive cfr. Bacchyl. V 108
o[rcou" ejpevkeiren ojdovnti “recideva i filari con la zanna”; Aeschl. Pers. 921 ou}" nu'n
daivmwn ejpevkeiren “ora un demone li falcidiava”. Si noti che anche in questo
frammento, al v. 3, ricorre proprio daivmwn come in Il. XV 467 ed Aeschl. Pers. 921,
due dei passi sopracitati. Purtroppo non è possibile sapere con esattezza quale lettera
seguisse l’epsilon, perché la traccia rimasta sul testimone è poco decifrabile.
3 La traccia posta sul papiro è la seguente: o;lo;΅[; lo scriba ha posto l'accento grave
sul primo omicron e poi l'acuto sul secondo, ma si è accorto che ad essere accentata era
la sillaba ancora successiva, perciò ha cancellato l'accento acuto sul secondo omicron e
poi ha scritto, al posto dell'acuto, ancora un accento grave. L'accento grave, infatti, si
trova, nei papiri, prima di un acuto per distinguere ancor meglio la sillaba da pronunciare
accentata, ergo la parola doveva continuare con una sillaba marcata dall'accento acuto.
Per un simile intervento cfr. DV ieV b.4 (POxy. 1787 fr. 18.4; v. supra); DV iV b.3 =
POxy. 1787 fr. 19.3 (v. supra); DV kaV a, 5 = POxy. 1787 fr. 26.5 (v. infra). Varie sono
state le integrazioni proposte: ojlof[wvio" (quadrisillabo) di Hunt (1922, 31), ojlof[udn-
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
283
di Diehl (Diehl1 1923, 360) e ojloovfrwn, quest'ultima riportata nell'edizione di Diehl
(Diehl1 1923, 360), ma attribuita dallo stesso Diehl a Kalinka.
Quanto alla integrazione proposta da Kalinka, essa si deve scontrare con un problema
non da poco: tra l'omicron ed il phy successivo non c'è alcuno altro omicron e l'accento
deve cadere, necessariamente, sulla vocale o dittongo posti immediatamente dopo il phy
stesso. Poche possibilità di essere corretta ha anche ojlof[udn- proposto dal Diehl (19231,
360): l'“essere dolente, lamentoso, pietoso“ non può addirsi ad un daivmwn.
Occorrerebbe, invece, un'integrazione che comporti un'azione attiva della divinità.
L'aggettivo ojlofwvio" è attestato nell'Odissea (e.g. IV 410; IV 460; X 289; XVII 248:
nell'Iliade è del tutto assente) al neutro plurale e soprattutto nell'espressione clausolare
ojlofwvi>a eijdwv" "che conosce gli inganni, abile nell'ingannare". ojlovf[wi(a) è, infatti,
integrato da Ferrari (2007a, 62-63), ma se si deve dar credito a quel che scritto sul papiro
(ovvero, come si è detto : o;lo;΅[) Ferrari avrebbe modificato la posizione dell’accento,
tornando insomma alla posizione che l’accento aveva ante correctionem.
Tuttavia, anche una forma del verbo ojlofuvromai, come suggerito dal Diehl, potrebbe
essere una integrazione possibile, però con il significato di "avere pietà, provare
compassione“. Per un'espressione di tal sorta si può trovare un parallelo omerico, ovvero
Od. X 157 kai; tovte tiv" me qew'n ojlofuvrato mou'non ejovnta "ed allora un dio ebbe
pietà di me ch' ero solo“
Purtroppo, manca il contesto per stabilire quale sia l'integrazione corretta.
5 Per e[nneka (= att. e}neka) cfr. Alc. 5.15 e[nn]eka; 43.1 e[nnek(a); 283.14 e[n]neka;
306 i col. II 22 e[nãnÃeka; Theoc. XXVIII 13 e[nnek(a); IG XII (2) 258.8 (Lesbo, I sec.
d.C.). Il miceneo presenta solo e-ne-ka. L'epica ha sia e}neka (cfr. e.g. Il. I 110), sia
e}neken (ma solo in Od. XVII 288; XVII 310), ma soprattutto ricorre ad ei}neka,
allungando, per Lejeune (1972, 159 n. 3) e Chantraine DELG s.u., l'epsilon iniziale di un
dattilo: e[nneka, non sarebbe, dunque, altro che un ipereolismo rispetto all'omerico
ei}neka. La preposizione regge il genitivo già nel miceneo (e.g. eneka iqojo, ovvero "per
il cavallo"), ma di solito è posposta a quest'ultimo: la posposizione, tuttavia, non avviene
sempre e qui, difatti, il genitivo sembra seguire (anche se non è tradito), come già in Il. I
94.
8 Hunt (1922, 32), l'editore del papiro, leggeva [.]ud∆a≥v[. Si riscontra un palese
errore nell'edizione della Voigt (1971, 84): l'integrazione [o]ujd∆ compare già nell'editio
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
284
princeps del papiro (Hunt 1922, 33) e lo stesso Diehl, al quale la Voigt l'attribuisce, non
la considera sua. s]u; d∆a≥[[ è stato, invece, integrato dal Treu (1976, 62), senza
aggiungere alcuna precisazione nel commento. Dopo la lettera successiva, di cui resta,
forse, come unica traccia un punto in basso subito dopo l'apostrofo, il testimone presenta
una linea orizzontale sopra la lettera caduta: potrebbe trattarsi di un accento o di un
segno di vocale lunga, ma forse la seconda possibilità è da preferire, vista la scarsa
lunghezza e l'orizzontalità del tratto stesso, soprattutto in raffronto agli altri accenti posti
sul papiro, più lunghi e nettamente obliqui. Ferrari (2007a, 62-63) e Puglia (apud Ferrari
l.c.) fanno coincidere questa parte finale del verso con il v. 16 del frammento qui
presentato come eV, ovvero jAnd]romev[da, che diventerebbe, dunque o]ujd∆
jA≥[nd]romev[da, ma il testo presentato dal papiro, in qualunque modo lo si interpreti,
sembra togliere credito ad una simile possibilità: infatti, se la traccia posta sul papiro
fosse il simbolo di lunga ( ) non vi sarebbe alcuna ragione per la sua presenza, visto
che l’alpha iniziale di jA≥[nd]romev[da non può che essere lungo, dato che è seguito da
ben tre consonanti; se invece fosse un accento acuto, jA≥[nd]romev[da non potrebbe essere
comunque una integrazione valida, dato che ha l’accento in un’altra posizione.
b
Ferrari (1987, 155 e n. 2) propone di integrare povl]lai", ma il supplemento di Ferrari,
data la natura estremamente frammentaria dell'ode, non aggiunge niente alla sua
comprensione e non è la sola possibile. Inoltre, se la parola successiva fosse, ad es.,
i]m[er-, con iota lungo, si avrebbe una sequenza di tre sillabe lunghe, impossibile per il
metro. È, forse, possibile integrare ajpav]lai" i]m[er- (ajpav]lai" acc.) oppure
ajpav]lais∆i[m[er-, vel similia?
4 Su plhvoni era stato posto, precedentemente, l'accento circonflesso, ma poi è
stato cancellato e sostituito, ut uidetur, con l'acuto.
7 Per e[rw" in vece dell'atteso eolico e{[ro" cfr. Sapph. 23.1 e[rwto"; 58.26 e[rw" (v.
supra) e ad loc.
izV (72 L.-P. = V.) metrum: hipp2cho
suppl.?
]ano≥≥vr≥[
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
285
]amme≥≥[ ]npe[
]lhn[
5 ]te": t≥[ ].wnw[
]mwv[ ].[
...
...noi...
TEST POxy. 1787 fr. 28 prim. rec. Lobel 1925, 34
CRIT 1 ]am≥o≥i≥[ Hunt 1922, 36-37 : ]ano≥≥vr≥[ vel fort. evr[ Lobel 1925, 34, L.-P. 1955,
50 et Voigt 1971, 87 ║2 ]amma[ Hunt 1922, 36-37 : e[ vel o[ leg. Lobel 1925,
34, L.-P. 1955, 50 et Voigt 1971, 87 : ]amme≥[ veri simile ║5 ]t≥eev.[ Hunt 1922,
36-37 : ]te": t≥[ : Lobel 1925, 34, L.-P. 1955, 50 et Voigt 1971, 87 ║6 ]m≥o≥nw[
Hunt 1922, 36-37 : ].wnw[ Lobel 1925, 34, L.-P. 1955, 50 et Voigt 1971, 87
║7 mwv
Il frammento è, a causa della scarsa dimensione del frustolo papiraceo, ben poco
definibile.
2 Compare in questo verso l'unica parola più o meno integra (e dunque
comprensibile) dell'intero frammento, ovvero ]amme≥[: la lettura ]amme≥[ è da preferire:
dopo il my, difatti, compare un tratto uncinato simile a quello di un epsilon.
ihV (73 L.-P. = V.) metrum: ] , hipp2cho
suppl. possis
a
]n≥b.[.] .[.]u≥ ]a ]an jAfrodi[ta
aj]duvlogoi d∆ ejr[
5 ]"≥ a[lloi a]i"≥ e[coisa ].ev≥na qaas≥[s
]av≥llei ]a" ejevrsa" [
b
]w.[
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
286
]as[
]is∆ ej[
...
...Afrodite
...(amori?) dolci parole
5 …altri…
…avendo…
…sed-
…(fiorisce?)
…della rugiada
…
TEST (a) POxy. 1787 fr. 11 (b) eiusdem papyri frustulum, a Lobel 1925,
34-35 prim. editum, quod haud procul distare Lobel 1925, 34-35 licuit. (a)
prim. rec. Diehl1 1923, 362
CRIT omnia in apparatu critico non memorata suppl. Hunt 1922, 34-35 et 44 (nota ad
locum) (a) ║1 ]i≥b≥[..]r≥a≥i≥ [ Hunt 1922, 34-35 : ]i≥ b≥[..]r≥a≥i≥[ Diehl1 1923, 362 :
]n≥b.[.].[.]u≥ Lobel 1925, 35, L.-P. 1955, 51, rec. Voigt. 1971, 87-88 : ]n≥ b≥[....]u≥ Diehl2
1936, 4]49 ║3 ]an brevis syll., fort. crusostevf]an∆ Diehl1 1923, 362, sed
etiam ]a±n jAfrodiv[tan fieri posse uidit Voigt 1971, 88 ║4 d∆er[ : e[r[wte",
vel e[r[astai vel e[r[ante" Hunt 1922, 35 et 44 ║5 ].alloi : ]" a]lloi Hunt 1922,
35, rec. Diehl1 1923,362 : ]b≥avlloi, sed etiam ]s vel ]q fieri posse cens. Lobel 1925, 35,
L.-P. 1955, 51 et Voigt 1971, 87-88 ║6 ]i±"≥≥ siue o]i" uidit Diehl2
1936, 4]50
║7 ].e≥vnaqaa–s≥[ : ].e≥na qaavs≥[s Hunt 1922,35 : m]e≥vna qaavs[s ] Diehl 1923, 362
qaavssein "sedere" Hom. prim. agn. Diehl1 1923, 362 ║8 q]a≥llei
Diehl1 1923, 362
║9 kavl]- Diehl1 1923, 362 e Sapph. 96, 12sg. V. (b) ]a–
s[ vel ]av" Lobel 1925, 35, L.-P. 1955, 51 et Voigt 1971, 88 : ]a–s[ veri simile is∆e≥ A partire dall'editio princeps (Hunt 1922, 44) questo passo è stato messo in relazione
con Him. Or. 9, 4 p. 76 Colonna: a[gei (Sapfw;) kai; jAfrodivthn ejf∆a{rmaãtiÃ
Carivtwn, kai; coro;n jErwvtwn sumpaivstora "Saffo conduce sul carro delle Cariti sia
Afrodite, sia un coro degli Eroti, compagno di giochi ". L'orazione di Imerio fu letta
anche da Fozio: la frase di Imerio, infatti, è citata parola per parola (a[gei –
sumpaivstora) in Phot. Bibl. 243, 366b 26, ma nell'opera del patriarca di Costantinopoli
la frase è del tutto estrapolata dal contesto, sicchè senza il testo originale non potremmo
capire che il soggetto della frase è la poetessa eolica.
a
1 Diehl sia nella prima edizione (Diehl1 1923, 362), sia nella seconda (Diehl
2 1936,
4] 49s.) considera il primo rigo del frustolo uno scolio e non un verso dell'ode; scrive,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
287
infatti, "v. 1.6.8 in mg. scholia interisse uidentur": questa osservazione perde, tuttavia,
una buona dose di credibilità di fronte alla constatazione del fatto che alcun frustolo del
P.Oxy. 1787 presenta la minima traccia di scoli. È vero che il papiro a nostra
disposizione non è integro, ma che tra tutti i frammenti solo qui si presentino tracce di
scoli è, riteniamo, poco credibile. E tuttavia, come abbiamo visto precedentemente, il
testo sembra essere piuttosto curato, vista la presenza (probabile) di segni di richiamo e
quella, piuttosto regolare, di accenti e /o simboli prosodici. ( o ). Forse Diehl è stato
tratto in inganno dalla scarsa dimensione del beta, unica lettera leggibile in modo chiaro
del primo rigo: ciò, tuttavia, avviene anche per tutti gli altri (rari) beta presenti sulla
porzione del papiro a noi giunta. L'ipotesi del Diehl non è stata seguita da nessun altro
editore moderno, se si esclude Gallavotti (1957, 118) che, sintomaticamente, riporta il
frammento privo del primo verso.
Questo problema si combina con un altro: l'ode sembra strutturarsi, infatti, come un altro
frammento tradito dallo stesso papiro (Sapph. DV idV a = 64a V.), in strofi tristiche, il
cui terzo verso è più breve dei due precedenti. Sulla possibilità che questo libro
presentasse anche odi in strofe tristiche cfr. Introduzione; Voigt 1971, 96-97 e Gallavotti
1957, 118-119. Se si accetta questa possibilità, non può che balzare agli occhi il fatto che
il verso successivo, il v. 2, è più breve del primo, ergo il primo rigo del frustolo non può
che essere il primo verso preservato dell'ode (il secondo della strofe) e come tale andrà
considerato.
2 Questo verso, di cui rimane solo la vocale finale (]a), è nettamente più breve del
verso precedente e dei due successivi: sembra opportuno considerarlo, in base ai
ragionamenti effettuati finora, quale il terzo verso di una strofe tristica.
3 L'alfa di ]an deve essere, metri causa, breve. crusostevf]an∆ è integrato da
Diehl1 (1923, 362), per cui cfr. Sapph. 33, 1 V. ai[q∆e[gw, crusostevfan∆ jAfrovdita, /
tovnde to;n pavlon ã......Ã lacoivhn "magari io ottenessi questa sorte, Afrodite
dall'aurea corona". crusostevfan∆ richiederebbe, tuttavia, jAfrodita al vocativo,
ovvero jAfrovdita come al fr. 33: il papiro, tuttavia, non presenta alcuna traccia di
accento, nè sull'omicron, né su alcuna altra vocale: Diehl scrive direttamente jAfrovdita
adattando leggermente il testo alla sua proposta di integrazione. Per il nome della dea nei
frammenti di Saffo cfr. Sapph. 1.1; 33.1; 96.16; 102.2; 112.5; 133.2; 194; 198b; 200;
211; 221 V.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
288
4 È significativo il fatto che proprio in questa ode il nome di Afrodite, di cui parla
il passo di Imerio, compaia al v. 3, mentre la parte tradita del verso successivo si
conclude con ejr[: così si spiega e[r[wte", che è, dunque, un'integrazione di Hunt (1922,
35, 44) basata sulla testimonianza di Imerio: in alternativa l'editore propone anche
e[r[astai o e[r[ante". Per e[r[wte" invece del supposto eolico *e[roi cfr. Sapph. 23.1
e[rwto"; DV dV 4 = 58.26 V. e[rw" (v. supra) e ad loc.; DV ieV b.7 = 67b.7 V. (v. supra)
]e[≥rw"[. Diehl1 (1923, 362) scrive [Er[wte", ovvero ritiene che si tratti di una
personificazione. Per hJduvlogo" / hJdulovgo" (proparossitono nel significato di "dalle
dolci parole", parossitono in quello di "adulatore, lusingatore": cfr. LSJ s.u.) cfr. Pi. O.
VI 96 aJduvlogoi dev nin / luvrai molpaiv te ginwvskonti "la (i.e. Ortigia) conoscono
lire e canti dolci-parole"; Eur. Hec. 131sgg. oJ pokilovfrwn / kovpi" hJdulovgo"
dhmocaristh;" / Laertiavdh" "l'astuto / imbroglione, suasivo adulatore / figlio di
Laerte" (Odisseo); Timo 841, 4 hJdulovgou sofivh"; Mel. A. P. V 136 e[gcei ta'"
Peiqou'" kai; Kuvprido" JHliodwvra" / kai; pavli ta'" aujta'" aJdulovgou Cavrito"
"versa alla salute di Peithò e dell'Eliodora Cipride / e di nuovo alla salute della stessa,
Grazia dalla dolce parola"; Nicarch. A.P. VII 159.1-2 jOrfeu;" me;n kiqavrai plei'ston
gevra" ei{leto qnhtw'n, / Nevstwr de; glwvssh" hJdulovgou sofivhi "Orfeo con la cetra
ottenne onore tra gli uomini / Nestore con la saggezza di un linguaggio sudente".
hJdulovgo" ricorre come sostantivo, in prosa, in Ath. IV 165b Fruvnico" oJ
kwmwidiopoio;" ejn tw'i jEfiavlthi mnhmoneuvei tou' hJdulovgou dia; touvtwn "il poeta
comico Frinico nell’ “Efialte” ricorda il burlone con queste parole…".
5 La lezione del papiro non è certa: si legge soltanto, sotto la lacuna materiale, un
tratto obliquo che può far pensare al beta iniziale di ]b≥avlloi, oppure ad un ]s≥: del resto
Hunt (1922,35), seguito da Diehl1 (1923, 362), trascriveva proprio un sigma (]"≥ a[lloi).
Lobel (1925,35) è stato il primo a proporre ]b≥avlloi. La terza possibile lettura proposta
dalla maggior parte degli editori, ovvero ]q≥, non crediamo possa cogliere nel segno,
soprattutto se confrontata con gli altri q scritti dalla stessa mano (uno in questo stesso
frammento al v. 7): la traccia presente sul papiro è troppo obliqua e diritta. La lettura ]b≥
non è inevitabile per le stesse ragioni per le quali anche ]q≥ è poco verosimile. In
conclusione riteniamo, salvo ulteriore ed approfondita verifica delle tracce, che ]"≥ abbia
un maggior grado di verosimiglianza: sull'estremità del papiro, sopra l'inizio del tratto
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
289
obliquo, sembra esserci una linea verticale, che può essere considerata, forse, l'asta
verticale di un sigma. La lettura della lettera resta, comunque, difficile.
6 Il papiro presenta sopra lo iota il simbolo di vocale breve ( ; l'editore (Hunt
1922,35) propone di integrare un a, ma, come nota Diehl2
(1936, 4]50), anche o]i" può
essere corretto: che si tratti di un accusativo plurale eolico?
Riscontriamo anche qui (e[coisa) l'alta frequenza di un participio femminile in clausula:
v.supra.
7 Diehl1 (1923, 362) propone di integrare m]e≥vna qaavs[s ], ma prima dell'epsilon
(esso stesso ben poco leggibile) sembra esserci un punto in alto, ovvero una traccia della
lettera precedente, letta da Hunt nell'editio princeps e poi da tutti gli altri editori,
ovviamente Diehl escluso: essa può essere compatibile con l'integrazione proposta, ma
la certezza assoluta non c'è e,comunque, data la traccia non si tratterebbe più di
un'integrazione, bensì di una proposta di lettura ]m≥e≥vna qaavs[s ].
Il verbo qaavssw, riconosciuto per primo da Diehl1 (1923, 362), è tipico dell'epos, per
cui cfr. Il. IX 194b lipw;n e{do" e[nqa qavassen "dopo aver abbandonato il seggio ove
sedeva"; Il. XV 124b livpe de; qrovnon e[nqa qavasse "lasciò il trono ove sedeva"; Od.
III 335-6 oujde; e[oike / dhqa; qew'n ejndaiti; qaassevmen,ajlla; nevesqai "non conviene /
stare a lungo a sedere al banchetto dei numi, ma andarsene"; [Hom.] Hymn. Merc. 170
sgg. bevlteron h[mata pavnta met∆ajqanavtoi" ojarivzein / plouvsion,
ajfneiovn,polulhvi>on,h] kata; dw'ma / a[ntrwi ejn hjeroventi qaassevmen "meglio è
starsene in intimità ogni giorno tra gli immortali / ricco, opulento, dalle molte messi,
che starsene a casa / in un antro fumoso"; Id. 468 prw'to" gavr Dio;" uiJev,
met∆ajqanavtoisi qaavssei" "per primo, infatti, figlio di Zeus, siedi tra gli immortali". In
altri generi poetici (lirica, tragedia e commedia) si ha, invece, qa–vssw, per cui cfr. e.g.
Alc. 113.5 qavssei. Entrambi i verbi sono attestati solo al presente ed all'imperfetto e
sono derivati da qaÛakyw-, la cui esistenza è dimostrata da Hsch. s.u. qavbakon: qa'kon
h] qrovnon. Saffo, dunque, sembra essere ricorsa, anche qui, ad un lessico decisamente
epico.
8 Sul papiro si legge ]a≥llei (tra tutte le lettere l'alpha è la meno leggibile, ma
sembra la giusta lettura): Diehl1 (1923,362) propone di integrare q]a≥vllei, ma la sua
integrazione (riproposta anche nella seconda edizione: Diehl2 1936, 4[50) ha avuto poco
seguito: Lobel (1925, 35) e L.-P. (1955, 51) non la riportano neanche in apparato,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
290
mentre la Voigt (1971, 87-88), pur riportandola in apparato, non la accoglie nel testo.
Per q]a≥vllei cfr. Sapph. 2.9 tevqale; 96.12-13 teqav-/ laisi.
9 Diehl1 (1923,362) propone di integrare, sulla base di Sapph. 96.12sgg. V. aj
d∆ãejÃevrsa kavla kevcutai "e la bella rugiada si è diffusa", kavl]a" ejevrsa" [: se si
eccettuano questi due passi, il termine non è attestato altrove in Saffo o Alceo.
iqV (74 L.-P. =V.) metrum: hipp
2cho suppl.?
a b c
]wn e[ka[ ]a[ ].[
]aipovl[ ]poqo[ ]as i[drw[
]m.[ ].wvba≥[ ].uz≥≥ad.[ ]brodo[ ]i≥n[
5 ].nq[ ]f≥aim[
…
…capraio… … …
… …desiderio… …sudore…
… ros-… … …
…
…dico
d
].[.].e[
]n≥po.[ ]m≥[
…
TEST (a) POxy. 1787 fragm. novum (I), a Lobel 1925, 35 (d— 14a) prim. editum [1-3] et
POxy. 1787 fr. 16 (II) [4-6]; fragmm. coni. Lobel 1925, 35 (b) POxy. 1787
fragm. novum, a Lobel 1925, 35 (d— 14c) prim. editum (c), (d) eiusdem
papyri fragmm. nova, Oxy. Pap. XXI p. 135 prim. edita omnia fort. ex eadem
pap. parte ac Sapph. 73 esse censuit L.-P. 1955, 52 frr. (a) et (b) prim. rec. Lobel
1925, 35, fragmm. (c) et (d) edidit L.-P. 1955, 52
CRIT (a) 1 evk (I) ║2 povl (I) ║4 fort. ]brodov[pacu- vel ]brodo[- ║5 ]o≥nq[ veri simillime (b) 2 qo;[ ut vid. ║3 ]a–wv scriptum credidit Lobel 1925, 35,
L.-P. 1955, 52 : fort. ]awv Voigt 1971, 88 (c) 2 i>d ║3 a±d (d) 1 ].[ : si
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
291
una littera, n, si duae, a sive l, tum hasta horizontalis, ut vid. L.-P. 1955, 52 ante e fort k leg. L.-P. 1955, 52 2 .[ : p≥[ ut videtur
a
Il testo tradito da questo frustolo papiraceo è stato pubbicato in due momenti diversi:
mentre i vv. 4-6 compaiono già come POxy. 1787 fr. 16 nell'editio princeps di Hunt
(1922, 34-35), i primi tre furono pubbicati per la prima volta da Lobel (1925, 35). La
disposizione del frammento che qui si adotta è stata proposta da Lobel: nell'edizione del
1925 il collage tra i frustoli è dato come probabile ("inter (a) 3 et (b) 1 aut minimum aut
nullum intervallum fuisse credideris"), mentre in quella di Lobel e di Page (1955, 52)
come certo, al punto che viene pubblicato direttamente il testo risultato dal collage, poi
accettato anche dalla Voigt (1971, 88). Lobel e Page (1955, 52) ipotizzano, inoltre, che i
due frustoli (poi riuniti) derivino dalla stessa parte del papiro che ci ha restituito il
frammento precedente.
1 La Voigt (1971, 88) non riporta per questo frustolo la lettura paleografica, ma
come notano Lobel (1925, 35) e L.-P. (1955,52) sopra l'epsilon sembra esserci l'accento
acuto.
2 Sull'omicron è posto un accento acuto e parrebbe essere questa l'unica
attestazione (per altro sfuggita anche alla Voigt al momento di stilare l'Index verborum
alla fine dell'edizione) della parola aijpovlo" o di un suo derivato nei frammenti di Saffo
e di Alceo: la certezza non può, tuttavia, esservi e nulla preclude dal tentare di scrivere
]ai povl[.
3 Dopo il my vi è l'estremità del papiro, ma sopra rimane traccia della lettera
successiva: si intravede, infatti, la parte superiore di quello che sembra essere un tratto
decisamente verticale, forse uno iota: Lobel (1925, 35), il primo editore di questa parte
del frustolo, proponeva di leggere e di integrare m[o]i≥, oppure mn≥.
Da questo verso inizia la parte del frustolo pubblicata già da Hunt (1922, 35). ]brodo[ è
una lettura certa. Sul papiro non è presente alcun accento che possa esserci utile per la
comprensione. Per brovdon (← Ûrovdon; att. rJovdon) cfr. Sapph. 2.6 brovdoisi de; pai'" oj
cw'ro" / ejskivast∆ "e tutto il luogo è ombreggiato di rose"; 55.2-3 ouj ga;r pedevchi"
brovdwn / tw;n ejk Pieriva" "chè non hai parte delle rose / della Pieria"; 94.13
stefavn]oi" i[wn / kai; br[ovdwn "corone di viole e di rose"; 96.12-13 teqav- / laisi de;
brovda "sono in fiore le rose"; Alc. 115 a.22 ]b≥rod[. Vi è, però, anche la possibilità che
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
292
qui si celi non tanto il sostantivo brovdon, quanto l'aggettivo brodovpacu", usato da Saffo
in altri carmi (anche di questo stesso libro) come epiteto di Aurora o delle Cariti, per cui
cfr. Sapph. 53 brodopavcee" a[gnai Cavrite", deu'te Divo" kovrai "venerande Cariti
dalle braccia di rosa, venite qui, figlie di Zeus" e Sapph. DV gV 9 = 58.19 V.
brodovpacun Au[wn "Aurora dalle braccia di rosa".
5 Le uniche lettere certe sono nq: non è chiaro quale lettera le precedesse. Hunt
(1922, 34-35) leggeva ]e≥n≥q[. Lobel (1925, 35) e L.P.(1955, 52), con lodevole cautela,
non fornirono alcuna ipotesi di lettura. La Voigt (1971, 88) legge ]o≥nq[, ma non vi è
alcuna traccia che possa portare ad una simile conclusione: tutto quel che si riesce a
leggere è un breve tratto obliquo in alto che corre dall'estremità del frustolo verso
l'interno, dall'alto verso il basso.
6 La lettura ]f≥aim[ di L.-P. (1955, 52), accolta anche dalla Voigt (1971, 88), è
pienamente condivisibile, soprattutto perché restituisce una parola di senso compiuto,
ciò che, invece, non si può dire di ]r≥aim[ di Hunt (1922, 34-35) e di ]d≥aim[ di Lobel
(1925,35). Per ]f≥aim[ cfr. ajpufai'mi di Sapph. DV eV 15 = 65.1 V.; DV lV 17 = 88.17 V.
fai'm∆; 147 mnavsesqaiv tina faãi'Ãmi †kai; e[teron† (codd. : kai; u[steron Volger)
ajmmevwn "credo che qualcuno si ricorderà di noi in futuro".
b
2 Per ]poqo≥[ cfr. Sapph. 22.11-12 a\"≥ se dhu\te povqo" t≥. [ / ajmfipovtatai
"finchè nuovamente il desiderio intorno a te … / voli"; 48.2 h\lqe" †kai;† (codd. : eu\ d∆
Lobel 1925, 22, L.-P. 1955,38, rec. Di Benedetto 1982, 8-12 = Di Benedetto 2007, II,
808-812) ejpovhsa", e[gw dev s∆ ejmaiovman / o]n d∆ e[yuxa" e[man frevna kaiomevnan
povqwi "giungesti ed hai fatto bene: io ti desideravo, ma tu hai raffreddato il mio cuore
che ardeva di desiderio"; 94.23 ejxivh" povqo≥[n "placavi il desiderio"; 102.1-2 Gluvkha
ma'ter, ou[ toi duvnamai krevkhn to;n i[ston / povqwi davmeisa pai'do" bradivnan di∆
jAfrodivtan "dolce madre, davvero non riesco a tessere la tela, vinta dal desiderio di un
ragazzo per volere della delicata Afrodite". Sul secondo omicron, del resto anche esso
poco leggibile, sembra, tuttavia, presente l'accento grave: sul margine del frustolo si nota
un tratto obliquo che corre dal basso verso l'alto.
c
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
293
2 Per i[drw[ cfr. Sapph. 3.13 m∆i[drw" kakcevetai "su me il sudore si spande"; Inc.
auct. 12 i[drw" †ajmfovtera. Il termine in eolico è di genere femminile, secondo quanto
affermano tre testimonianze, riportate da Ahrens (1839, 118 n. 11): Epim. An. Ox. I,
208, 14ss. Cr., testimone del parallelo citato precedentemente; Epim. An. Ox. I, 208,33-
34 Cr. par∆Aijoleu'sin qhlukw'" levgetai, kai; klivnetai wJ" to; hjwv"; Schol. in Il.
XXII 2 iJdrw': ...Aijolei'", qhlukw'" aujto; levgonte". È il caso di soffermarci sulla prima
testimonianza, ovvero Epim. An. Ox. I, 208, 14ss. Cr., perchè è la più importante, in
quanto cita entrambi i paralleli precendenti:
tou'to par∆ Aijoleu'sin qhlukw'" levgetai: ajnadevcetai klivsin ajkovlouqon qhlukw'i gevnei: ajdem∆ (sic) iJdrw;" (sic) kako;" (sic) cevetai (sic) (codd. : †evkade† m∆i[drw" kakcevetai corrigendum, cfr. Sapph. 31,13) ;: o{moion tw'i hjwv":ei\ta hJ genikh; iJdrw'" ajmfovtera (sic) ajnti; tou' iJdrou'". "questo sostantivo presso gli eolici si dice al femminile: riceve la declinazione conforme
al genere femmnile: "su me il sudore si spande" [Sapph. 31.13 V.]. Come hjwv". Poi il
genitivo iJdrw'" ajmfovtera (sic) "di sudore insieme (?)" invece di iJdrou'""
Gli jEpimerismoiv citano, a quanto sembra, due passi eolici, di cui uno sicuramente di
Saffo (è un passo del Carme della gelosia, ovvero Sapph. 31.13), mentre l'altro di incerta
attribuzione. Ahrens (1839, 273) ritiene che anche i[drw" ajfovtera sia un frammento di
Saffo: non abbiamo la sicurezza assoluta, ma è probabile.
kV (76 L.-P. = V.) metrum: hipp2cho
suppl. ?
]an≥ pa≥[ te]levseie k≥[
]ivh lela[
]e qevlw[
5 ]echn[ ]h≥: e[fa.[ ]alivk[
...
...compia...
...
...voglio...
5 ...avere...
...diceva...
…coetan-
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
294
TEST POxy. fr. 12 prim. rec. Diehl1 1923, 362
CRIT 1 ]am≥p[ leg. Hunt 1922,34 : l]am≥p[ Diehl1 1923, 362 : ]am≥pe≥[ Lobel
1925,36 : ]an≥pa≥[ L.-P.1955, 54 : ]an≥ pa≥[ Voigt 1971, 89 ║2 lev ]levseien [ Hunt
1922, 34-35 : te]levseien [ Diehl1 1923, 362 : ]levseie k≥[ Lobel 1925, 36, rec. L.-
P.1955, 54 : ka]levseie Snell : te]levseie k≥[ Voigt 1971, 89 n≥[ leg. Hunt
1922, 34-35 ║3 ]i?h : ]ivh formam voc. i{hmi an coniunct. Verbi in –ivw exeuntis
censuit Voigt 1971, 89 lelav sive lela – : lelav[q leg. et suppl. Hunt 1922, 34-35,
rec. Diehl1 1923, 362 ║5 ] e[chn [ Hunt 1922, 34-35, rec. Diehl
1 1923, 362 : ]evchn[
Lobel 1925, 36 : ]echn[ L.-P. 1955, 54, Voigt 1971, 89 ║6 ]z≥∆ vel ]h≥∆ vel ]e≥i≥∆ Hunt 1922, 34-34, 44 : ]h≥: vel ]h∆ vel ]p∆ vel fort. ]e≥i∆ ut vid. Lobel 1925, 36, L.-P.
1955, 54 evfa± vel evfa– : e[fa[n Diehl1 1923, 362 ║7 ]a–livk[ :
]ajlivk[essi Hunt 1922, 34-35, rec. Diehl1 1923, 362 : ujm]alivk[essi Treu 1976, 66:
etiam –[wn fieri posse vidit Voigt 1971, 89
2 te]levseien è un'integrazione di Diehl1 (1923, 362), in parte accolta dalla Voigt
(1971, 89): difatti sembra corretta la lettura k≥[, proposta per la prima volta da Lobel
(1925, 36). Per *tevlhmi (= att. televw) cfr. Sapph. 1.26- 27 o[ssa dev moi tevlessai /
qu'mo" ijmevrrei, tevleson "tutto ciò che il mio animo brama che per me si avveri,
avveralo"; Sapph. 5.4 pavnta te]levsqhn; 9,4 tele[; 17.5 ejktelevssante"; DV eV 11 =
60.3 V. (v. supra) tev]l≥eson novhmma; 112.2 [Olbie gavmbre, soi; me;n dh; gavmo" wj"
a[rao / ejktetevlest(ai) "sposo fortunato, per te le nozze che ti auguravi / son
celebrate"; Alc. 361 aij dev k∆a[mmi Zeu'" televsh novhma "se Zeus voglia portarci a
compimento il progetto"; inc. auct. 31a.6 d∆ejteles.[ vel dev teles.[.
3 Il papiro presenta, sopra l'alpha, un tratto orizzontale di difficile interpretazione:
un accento acuto o il simbolo di vocale lunga? Hunt (1922, 34-35) leggeva lelav[ ed
integrava lelav[q, ma la sua proposta è stata accolta, tra gli editori successivi, solo da
Diehl.
4 Per (ej)qevlw cfr. Sapph. 1.17 kw[tti moi mavlista qevlw gevnesqai / mainovlai
quvmwi "e che cosa, con l'animo folle, voglio che soprattutto avvenga per me"; 1.23-24
tacevw" filhvsei / kwjuk ejqevloisa "presto amerà / anche se non vuole"; 5.3 kw[ssa
Û]o≥i≥ quvmwãià ke qevlh gevnesqai / pavnta te]levsqhn "e quanti desideri nutre nel suo
animo che avvengano, che siano tutti compiuti"; 5.9 ta;n kasig]nhvtan de; qevloi
povhsqai / e[mmoron ]tivma" (e[mmoron Wilamowitz, v. supra) "e dell'onore voglia
rendere (partecipe) la sorella"; 26.9 ] sev, qevlw[ "te, voglio"; 45 a\" qevlet∆u[mme"
"finchè voi volete"; DV eV 10 = 60.2 V. (v.supra) ]qevl∆†wntapaivsan "(che) tu voglia tra
tutte"; DV eV 14 = 60.6 V. o[]ssa tuvchn qelhvsh" "tutto ciò che tu voglia ottenere"; DV
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
295
lV 5 = 88.5 (v. infra) qe≥vloi" "vorresti"; DV lV fr. 1 col. II 10 = 90 a col. II 10 V. ]
q≥ev≥loisa [ "volendo"; 94.1 teqnavkhn d∆ajdovlw" qevlw "sinceramente vorrei esser
morta"; 94.9 aij de; mhv, ajllav s∆e[gw qevlw "e se no, io voglio farti ricordare";137.1
qevlw tiv t∆ ei[phn, ajllav me kwluvei / ai[dw" "vorrei dirti una cosa, ma mi impedisce /
il pudore". È possibile, tuttavia, anche un'altra lettura, ovvero ] ejqevlw[.
5 Hunt (1922, 34-35) e Diehl1 (1923, 362) leggono ] e[chn≥[. Lobel (1925, 36),
invece, legge ]evchn[, ma nell'edizione che ha curato insieme a Page (L.-P. 1955, 54)
assume un atteggiamento ancora più cauto, ovvero toglie l'accento sull'epsilon. Su
epsilon non è presente alcun accento e la stessa lettura dell'ultima lettera, ovvero n[,
seppure condivisa da tutti gli editori, non è certa: per queste ragioni è giusto scrivere
]echn≥[, perché potrebbe anche trattarsi di un verbo composto.
6 La prima lettera tradita dal frustolo è difficilmente leggibile: nell'editio princeps
(Hunt 1922, 34-35) si legge ]z≥∆, ma come nota lo stesso Hunt "sd would be expected,
and h or ei is perhaps admissible". La lettura di Hunt è accolta anche da Diehl1 (1923,
362), mentre per Lobel (1925,36) per L.-P.(1955, 54) "sive ]h∆ vel ]p∆ vel fort. ]e≥i∆ ut
vid.". Anche il segno posto in alto a destra rispetto alla lettera precedente è poco
decifrabile: un punto in alto, oppure un apostrofo?
Più semplice è la lettura di ciò che viene dopo, anche se sull'alpha non è chiaro se vi sia
il simbolo di vocale lunga o breve. Accanto all'alpha, in basso, si intravede un tratto
puntiforme, probabilmente l'ultima traccia rimasta della lettera successiva. Non è
possibile stabilire con certezza quale lettera vi fosse scritta, ma potrebbe trattarsi di un n≥[
o di un m≥[: la non leggibilità del segno di breve o di lunga posto sopra l'alpha è una
difficoltà in più. Sembra, dunque, qui attestato per l'unica volta l'imperfetto del verbo
eolico fai'mi (= att. fhmiv), per cui cfr. Hamm 1958, §248b.
7 Sul papiro è chiaramente leggibile ]a–livk[ e Hunt (1922, 34-35) integrava ]
ajlivk[essi, mentre Treu (1976, 66) integra ujm]alivk[essi. Per altri a\lix (att. h|lix) ed
altri composti in Saffo cfr. Sapph. 30.7 soi;" ujmavlik≥[a" "i tuoi coetanei"; Sapph. DV iV
a.5-6 = 68.5 + 70.5 V. jAn]Õdromevdan ... ajpav]lik∆ “l'attempata Andromeda”; Sapph.
DV idV a.4 = 64a.4 V. a]livkes≥≥si[; DV kV 7 = 76.7 V. ]a–lik[; 103.8 gav]mbron, a[saroi
g≥a;r≥ u≥jmavli≥k[ "lo sposo, infatti sfacciati i coetanei".
kaV (77 L.-P. = V.) metrum: ] [, hipp2cho
suppl. possis
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
296
a b c
]a[ ].[ ]a≥≥tw[
]seta[ ]mhvte≥≥[ ]ha" ]u≥mai..[ ]d≥ivaisa [ ]
.v]tecara≥≥[ ]e": ajll[ ]t≥a": 5 ]i≥di do≥i's[ 5 ]fra[
]den ajmes[ ] .[ ]o" suvg∆ aj[ ].lona[ ].dal[
…né…
…impazz- (?)…sorridendo (?)…
…ma…
…porgendo alla ragazza (?)…
TEST (a) POxy, 1787 fr. 26 (b) POxy. 1787 fr. 27 (c) fr. POxy. 1787
prim. editum a Lobel 1925, 37 ut fr. d— 17 omnia ex eadem parte provenisse
censuit Lobel 1925, 37 (a) prim. rec. Diehl1 1923, 363-364 (b) et
(c) prim. rec. Lobel 1925, 37
CRIT (a) 1 ]ai≥[ Hunt 1922, 36-37 : ]ap≥[ Lobel 1925, 37 : ]a.[ L.-P. 1955, 54 et Voigt
1971, 90 : ]a[ potius quam ]a.[ ║ 2 ]seta[ Hunt 1922, 36-37, rec. Lobel
1925, 37, L.-P. 1955, 54, Voigt 1971, 77 : ]se ta[ Diehl1 1923, 363 ║3
]u≥main≥.[ legit Hunt 1922, 36-37 : ]u≥maik≥.[ legit Lobel 1925, 37 : ]u≥mai..[ vel ]r≥mai..[ legerunt L.-P. 1955, 54 et Voigt 1971, 90 post i, litt. k, m, n legerunt Lobel
1925, 37, L.-P. 1955, 54, Voigt 1971, 90 : n veri simillime de l]u≥main≥- cog. Diehl
1 1923, 363-364 : ga;]r≥ main≥- vel alia Voigt 1971, 90 ║4 ]ev te
Hunt 1922, 36-37 : v]te Lobel 1925, 37 : .v]te L.-P. 1955, 54 ca[.]ro≥[ legit Hunt
1922, 36 : ca[i]ro≥[ Hunt 1922, 37 : cara≥[ Lobel 1925, 37, L.-P. 1955, 54 : cavra vel
(ej)ca[i]r∆ Voigt 1971, 90 ║5 ]i≥di ?doi's[, i.e. ]i≥ divdoisa[ in ]i≥di doi's[ corr. Voigt
1971, 90 : pa]i'di doi'sa vel pa]i'd∆i[doisa Treu 1976, 208 ║6 a;Ñ —me;s[
║7 suvga; : suv ga[ Hunt 1922, 37 : suvg∆aj Lobel 1925, 37, L.-P. 1955, 54, Voigt
1971, 90 ║8 ]a–≥lona[, ]a≥lon aj[ Hunt 1922, 36-37 : ]s vel fort. ]a– vel ]av Lobel
1925, 37 et L.-P. 1955, 54 : ]s≥ (fort. e[]s≥lon supplendum) vel fort. ]a– sive ]av Voigt
1971, 90 ║9 ]i≥dal[ Hunt 1922, 36-37 : ]i≥ vel ]n≥ leg. Lobel 1925, 37 e L.-P. 1955,
54 (b) 2 sive o≥[ ║3 ]d≥≥ivaisa± : mei]-? Hunt 1922, 36-37 ║4
]e≥s∆all≥[ :]es: ajll[a; Hunt 1922, 37 (c) 1 tw; ║2 ]ha±s ║3
]t≥a±s vel ]g≥a±": n]ta": Lobel 1925, 37 : ]tas: vel ga": L.-P. 1955, 55, Voigt 1971,90.
a
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
297
1 Sul frustolo si nota la sola lettera ]a[, ma tutti gli editori precedenti hanno letto in
aggiunta, evidentemente, la traccia di un'asta verticale: Hunt (1922, 36-37) trascrive ]ai≥[,
mentre Lobel (1925, 37) ]ap≥[. Nelle edizioni più recenti, ovvero L.-P. (1955, 54) e Voigt
(1971, 90), non viene proposta alcuna lettura della traccia posta dopo l'alpha. Dubitiamo
che dopo l'alpha sul testimone vi sia, effettivamente, la traccia di un'altra lettera: ergo,
occorre trascrivere ]a[.
2 Hunt (1922, 36-37), seguito da quasi tutti gli altri editori successivi, legge
]seta[: l'unica eccezione è costituita dall'edizione di Diehl1 (1923, 363), dove si sceglie
di separare le due sillabe in due parole diverse, ovvero ]se ta[.
3 Le uniche lettere chiaramente leggibili sono ].mai..[. Il primo editore (Hunt 1922,
36-37) leggeva ]u≥main≥.[ e Diehl1 (1923, 363) ipotizzò, velatamente, di integrare
l]u≥main≥.[, adducendo come passo parallelo Sapph. DV kqV b.8 = 87a.8 V. ].umain[ (v.
infra). Lobel (1925, 37), due anni dopo l'edizione di Diehl, propose una lettura diversa,
ovvero ]u≥maik≥.[, poi accolta nel testo anche dal Diehl, nella seconda edizione (Diehl2
1936, 4]51). Lobel nell'edizione successiva (L.-P. 1955, 54), per la preparazione della
quale si è avvalso della collaborazione di Denys Page, non si arrischiò a leggere la
lettera successiva allo iota; e così ha fatto anche la Voigt (1971, 90). Tutti gli editori qui
nominati hanno proposto di leggere un u immediatamente prima del limite del frustolo,
ovvero ]u≥, ma hanno altresì notato come quest'ultima non sia l'unica possibilità: " i or r
can be read in place of u" (Hunt 1922, 44), "in. siue im, siue rm" (Diehl1 1923, 363), "vel
]r" (Lobel 1925, 37; L.-P. 1955, 54; Voigt 1971, 90). La Voigt ha proposto, da ultimo, di
leggere ed integrare ga;]r≥ main≥.[. Tutto ciò che è possibile leggere sul papiro è un’ asta
verticale privata della parte superiore, ma in alto a sinistra di essa, sul margine del
frustolo, è forse presente una impercettibile traccia puntiforme: se una tale lettura è
corretta, essa è congruente con due sole lettere possibili, ovvero ]u≥ o ]r≥. Precisare
ulteriormente la lettura è difficile, ma forse alcune considerazioni possono essere fatte:
1) raramente l'u supera il bilineo inferiore (si hanno comunque eccezioni, ad es. in
POxy. 1787 fr. 11); 2) ha, generalmente, un'asta verticale più sottile e con un tratto più
preciso, anche quando essa supera il bilineo inferiore: sembrerebbe, dunque, più
probabile ]r≥ che non ]u≥, ma la sicurezza assoluta non c'è. Per main≥[ cfr. Alc. 10.6 V.
m]ainovmenon [ "folle"; 283.5 V. ejkmaivneisa.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
298
4 Hunt (1922, 36-37) trascrive ]evteca[.]ro≥[ e propone di leggere ed integrare ]ev
te ca[i]ro≥[, testo accolto anche da Diehl1(1923, 363). Il testo di Lobel (1925, 37) è,
invece, v]tecara≥[. Prima del ]t vi sarà stata, sicuramente, una lettera accentata: l'accento
è ben visibile nell'interlinea. Sotto l'accento si nota chiaramente una linea orizzontale
diritta: il primo editore pensò, come abbiamo detto, che si trattasse della parte superiore
di un epsilon, mentre Lobel nota in apparato v–]te, ovvero legge quel tratto sotto l'accento
come il simbolo di vocale lunga.
Dopo ca il papiro presenta una lacuna non molto estesa, ma comunque tale che non
possiamo sapere se sia caduta o meno una lettera tra ca e r: Hunt pensava di integrare,
come abbiamo detto, ca[i]ro≥[, ma Lobel (1925, 37) sembra non prendere in
considerazione la possibilià di una lacuna. Il dubbio torna a palesarsi nelle edizioni
Lobel-Page (1955, 54: "vel ca[.]r") e, soprattutto, Voigt (1971, 90). La Voigt è incerta
tra cavra (per cui propone il confronto con Sapph. 5.6 kai; fivlois]i Ûoi'si cavran
gevnesqai "e ci sia gioia per i suoi cari") ed (ej)ca[i]r∆. Per ca[i]r cfr. Sapph. 22.14
e[gw de; caivrw "ed io godo"; 96.5 sa'i de; mavlist∆e[caire movlpai≥ "e gioiva del tuo
canto"; 116 cai're, nuvmfa, cai're, tivmie gavmbre, povlla "sii felice, sposa e sii molto
felice, sposo onorato; 117 †caivroi" aj nuvmfa†, cairevtw d∆oj gavmbro" "che tu, o
sposa, sia felice lo sposo"; 155 povlla moi ta;n Pwluanaktivda pai'da caivrhn "e tanti
saluti da parte mia alla figlia del Polianattide"; 94.7 caivrois∆ e[rceo ka[meqen /
mevmnais∆ "va', essendo felice e di me / serbando memoria"; Alc. 306 A b.26 caivrw[;
308, 1 cai're Kullavna" oj mevdei" "salve signore di Cillene"; 401a cai're kai; pw'
tavnde "sii lieto e bevi questa…".
5 Il papiro presenta chiaramente il seguente testo: ]i≥di ?doi's[; sul secondo iota
l'accento è stato, ut uidetur, cancellato: per simili interventi del copista cfr. Sapph. DV ieV
b.4 [= POxy. 1787 fr. 18.4] (v. supra); DV iV b.3 [= POxy. 1787 fr. 19.3] (v. supra); DV
ieV a.3 [= POxy. 1787 fr. 5] (v. supra). Hunt (1922, 36-37) lesse l'accento acuto su do≥iv
(accolto anche da Diehl11923, 363) o, solamente in alternativa, un circonflesso (Hunt
1922, 45), mentre Lobel (1925, 37), giustamente e senza alcuna esitazione, un accento
circonflesso e così anche Lobel-Page e la Voigt. Hunt divideva ]i dido≥ivs[, mentre Lobel
in ]i≥di doi's[ e così anche Lobel-Page, anche se la loro scelta non era univoca ed
ottemperavano anche l'altra possibilità. Treu (1976, 67, 208) sembra in errore
nell'attribuire a Lobel-Page l'integrazione pai]di doi'sa (in realtà pa]i≥di do≥i'sa) o
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
299
pa]i≥d∆ ivvvdo≥isa: il supplemento non si riscontra in Lobel-Page (1955, 54) e dunque andrà
attribuito a Treu stesso.
6 Non si comprende bene cosa sia scritto sopra l'alpha; dal basso verso l'alto è
possibile leggere: un tratto orizzontale tagliato da uno verticale, sopra un altro tratto
orizzontale ed in alto alla destra della lettera uno obliquo che corre dal basso verso l'alto.
Diehl1 (1923, 363) e la Voigt (1971, 90) interpretano il tratto tagliato da una linea
verticale come uno spirito dolce ( j ) e gli altri due segni come un accento grave (;) ed il
simbolo di vocale lunga, ovvero a–].
7 Il papiro riporta ]ossuvga;[ e Hunt (1922, 36-37) divideva ]o" suv ga[ e leggeva il
tratto obliquo posto sopra l'alpha come il simbolo di vocale lunga, mentre Lobel,, Lobel-
Page e la Voigt come un accento grave. Diehl1(1923, 364), invece, se da un lato accoglie
la lettura di Hunt, dall'altro ipotizza che il tratto posto sull'alpha possa appartenere ad un
ipotetico t successivo: di fronte ad una simile ipotesi, è in qualche modo costretto a
modificare il testo di Hunt in ]o" suv g∆aj[: Diehl2 (1936, 4]51), pur accogliendo la
nuova lettura di Lobel, non modifica il testo già presentato nella prima edizione.
8 Hunt (1922, 36-37) legge ]a–≥lona[, mentre la Voigt (1971, 90) integra e[]s≥lon
(]s≥lona[ iam Lobel-Page 1955, 54) che è, paleograficamente, molto probabile: prima
del lambda si notano due tratti puntiformi, uno in alto e l'altro in basso, congruenti con
un ipotetico ]s≥.
9 Il curatore dell'editio princeps del papiro (Hunt 1922, 36-37) legge ]i≥dal[,
mentre gli editori successivi, escluso Diehl, ].dal[: che si tratti di uno iota è probabile,
ma non certo.
b
1 La lettera risulta illeggibile.
2 Sul papiro di legge ]mhvte≥[, ma l'ultima lettera è poco decifrabile, perché è posta
proprio sul margine: è possibile, in seconda ipotesi, che si tratti di un o[. Per ]mhvte≥[ cfr.
Sapph. 146 mhvte moi mevli mhvte melissa "a me non tocchi né il miele né l'ape"; Alc.
305 a.14-15 s≥[oi;] k≥a[moi po≥vlemo" mhvte gevnoit≥[o] "che tra te e me guerra non fosse"
(cfr. Porro 1994, 41-42, 49-50; Hamm 1954, 455-456); inc. auct. 41, 1 ]mhvt≥[.
3 ]d≥ è poco leggibile, perché in buona parte caduto in lacuna, ma è letto da tutti gli
editori. Hunt (1922, 37) integra mei]d≥ivaisa, per cui cfr. Sapph. 1.13sgg. ai\ya
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
300
d∆ejxivkonto: su; d∆, w \ mavkaira, / meidiaivsais∆ajqanavtwi proswvpwi / h[re∆ "e subito
giunsero e tu, o beata, /sorridendo nel volto immortale / mi domandasti…". Sopra
l'ultimo alpha lo scriba ha posto il simbolo di vocale breve.
Dopo l'alpha, come nota Hunt (1922, 45) sembra esserci un breve spazio bianco:
l'editore ipotizzò che con alpha terminasse il verso, ma osservando bene il papiro si nota,
proprio sul margine del frustolo, una traccia puntiforme.
4 Hunt (1922, 37) propone di integrare ajll≥[a;.
6 Sul margine inferiore del frustolo si nota una traccia puntiforme, che Hunt (1922,
36, 45) interpretò come un accento, ma come nota egli stesso "the accent is very
doubtful": una lettura più precisa è impossibile.
c
Si tratta di un frustolo papiraceo di medie dimensioni, tratto dallo stesso POxy. 1787,
pubblicato per la prima volta da Lobel (1925, 37): egli ritenne che i tre frustoli
provenissero dalla stessa parte del papiro. Questo frustolo riporta la parte finale di tre
versi, ma tra il secondo ed il terzo vi è uno spazio bianco piuttosto esteso: vi è la
possibilità, riteniamo, che anche questo frustolo rientri tra i testimoni di odi suddivise in
strofi tristiche, con il terzo verso più brevve degli altri due.
1 ]a≥ è in gran parte in lacuna e su tw;[ è presente l'accento grave.
2 Sull'alpha è presente il simbolo di vocale breve.
4 È incerta la lettura della prima lettera dopo la lacuna: può trattarsi di un ]t≥ o di
un ]g≥. Sull'alpha è presente il simbolo di vocale breve. Lobel (1925, 37) integra n]t≥a":
del resto, prima deve esserci una sillaba lunga. Dopo il sigma il copista ha scritto un
punto in alto, che andrà accolto nel testo.
kbV(78 L.-P. = V.) metrum: ] [, hipp2cho
suppl. possis
].onau[
]hn oujde[
]h" i[mer[
].ai d∆a[ma[
5 ].anqo":[ i[]meron[
]eterp[
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
301
…
…né…
…desider-…
…
5 …fiore…
…desiderio..
…diletto…
TEST POxy, 1787 fr. 10 prim. rec. Diehl1 1923, 362
CRIT ║2 ]h≥noude[ : ]hn oujde[ Hunt 1922, 34-35 : ]hn oujdev [ Diehl1 1923, 362 ║3
e[c[h" Diehl1 1923, 362 i?m -[o Hunt 1922, 35, rec. Diehl
2 1936, 4]49 : -[on
Diehl1 1923, 362 ║4 ].a–idavma[ : ]tai davma[ (dat.) Hunt 1922, 35, rec.
Diehl1 1923, 362 : ]t≥ai d∆a[ma[ Lobel 1925, 38, rec. Diehl
2 1936, 48[4 : ].ai d∆a[ma[ L.-
P. 1955, 55, Voigt 1971, 90 : t]a;i davma[rti Essler apud Diehl, Suppl. P. 37 ║5 qos: ║6 i[]meron Hunt 1922, 35
1 La prima lettera è indecifrabile: si nota un tratto obliquo dal basso verso l'alto che
corre dal margine del frustolo verso l'interno. La lettura delle altre lettere non presenta
alcuna difficoltà, ma non è possibile proporre una suddivisione delle parole che si basi
su un qualche fondamento. La divisione di parole attuata da Diehl1 (1923, 362), ovvero,
].on auj[ (in realtà nella sua edizione si legge ]on auj[, che non è corretto), può essere
probabile o corretta, ma non vi sono prove sufficienti.
3 Hunt (1922, 35) integra i[mer[o, mentre Diehl1(1923, 362) e[c]h" i[mer[on. Per
i[mer[o cfr. v. 6 i[]meron e Sapph. 95.12 katqavnhn d∆i[merov" ti" [e[cei me kai; /
lwtivnoi" drosoventa" [o[- / c≥[q]oi" i[dhn jAcer[ "e mi possiede un desiderio di morire
e di vedere le rugiadose rive, fiorite di loto, di Acher(onte)"; 96.15sgg. polla de;
zafoivtais∆ajgavna" ejpi- / mnavsqeis∆ [Atqido" ijmevrwi / levptan poi frena
k[.]r...bovrhtai "spesso lei, mentre si aggira, presa dal ricordo, morde il cuore nel
desidero di Attide delicata…"; [Sapph.] 137.3 aij d∆h \ce" e[slwn i[meron h] kavlwn "se
tu avessi desiderio di ciò che è bello e probo…".
4 La prima lettera è di difficile decifrazione: si nota esclusivamente un tratto
orizzontale che parte dal margine del frustolo. Il primo editore (Hunt 1922, 34-35)
trascriveva ]t≥ai, seguito poi da Diehl1 (1923, 362), da Lobel (1925, 38) e da Diehl
2
(1936, 4]49). Le edizioni successive, invece, ovvero Lobel-Page (1955, 55) e Voigt
(1971, 90), presentano, con una maggiore cautela, ].ai. Sicura è, invece, la presenza del
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
302
simbolo di lunga sopra ai. Il testo successivo, invece, a seconda dell'edizione, è
sottoposto ad una diversa divisione tra le parole. Hunt trascriveva le lettere seguenti
come formanti l'inizio di una parola unica, ovvero davma[, seguito dal Diehl1. Partendo da
questo testo, Essler trasse l'integrazione ]ta;i davma[rti "alla sposa". Il termine davmar
ricorre cinque volte in Omero e sempre accompagnato dal nome del marito: \Iri" d∆au \q∆
JElevnhi leukwlevnwi a[ggelo" h\lqen / eijdomevnh galovwi, jAnthnorivdao davmarti /
th;n jAnthnorivdh" ei\ce kreivwn JElikavwn / Laodivkhn, Priavmoio qugatrw'n ei\do"
ajrivsthn "Iride andò messaggera ad Elena dalle bianche braccia, / somigliante alla
cognata, la moglie dell'Antenoride / il potente Elicaone, figlio di Antenore, che
possedeva/ Laodice, la migliore d'aspetto tra le figlie di Priamo"; Od. IV 126 jAlkavndrh,
Poluvboio davmar "Alcandre, sposa di Polibo"; Od. XX 290 mnavsket∆ jOdussh'o" dh;n
oijcomevnoio davmarta "corteggiava la sposa di Odisseo da lungo tempo partito"; Od.
XXIV mnwvmeq∆ jOdussh'o" dh;n oijcomevnoio davmarta "corteggiavamo la sposa di
Odisseo da lungo tempo partito"; Hymn. Apoll. 212 kai; Leukivppoio davmarti "e con
la sposa di Leucippo". Il termine è piuttosto raro anche nella lirica; è attestato in due odi
Nemee di Pindaro: Pi. N. IV 57sg. davmarto" JIppoluvta" jAkavstou dolivai" / tevcnaisi
crhsavmeno" "dopo aver sperimentato le astuzie ingannevoli di Ippolita, sposa di
Acasto"; VII 26a xanqw'i Menevlai davmarta komivsai "riportare al biondo Menelao la
sposa". In età arcaica il termine sembra, dunque, essere attestato solo in unione a quello
del marito (chiunque egli sia), come se non avesse un significato indipendente (così
anche in Pi. N. VII 26 a, dove, però, il nome del marito è al dativo, perché retto dal
verbo komivsai).
Gernet (1937, 394) nota come, dopo Omero, davmar non sia mai attestato nel dialetto
ionico, ma questo per il grecista ed antropologo francese non è un motivo valido per
attribuire davmar ad un altro dialetto, ovvero all’eolico. Il lessico di Esichio, del resto,
fornisce la glossa dovmorti": gunhv (e cfr. anche Hdn. dovmorti": gunhv ti") e si ritiene
che dovmorti", il termine glossato, sia eolico329
. Per Gernet, dunque, il termine davmar
non può essere eolico, ma ionico e, dunque, occorre presumere che in ionico sia
scomparso. Tutto ciò sarebbe dimostrato da un terzo dialetto, quello attico, dove figura
in due testi legislativi antichi, la “legge di Dracone”citata da Demosth. XXIII 53, che
dichiara non passibile di pena (esilio) colui che uccide un altro uomo colto in flagranza
329
Così Gernet 1937, 394; Chantraine, DELG s.u. davmar.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
303
di delitto con la moglie (ejpi; davmarti), la madre, la sorella, la figlia o la concubina; la
“legge di Solone” presente in [Demosth.] XLVI 18. La “legge di Solone” è, tra i due,
quello più notevole, perché fornisce indirettamente una definzione del termine davmar: da
questo passo sembra trasparire una relazione tra lo statuto della sposa così denominata
ed una forma matrimoniale chiamata ejgguvhsi": }Hn a[n ejgguhvshi ejpi; dikaivoi"
davmarta ei\nai h] path;r h] ajdelfov" oJmopavtwr h] pavppo" oJ pro;" patrov", ejk
tauvth" ei\nai pai'da" gnhsivou" “Se il padre o il fratello che ha lo stesso potere del
padre o il nonno in linea paterna dà in matrimonio regolare una donna, i suoi figli sono
legittimi”. Per Gernet (1937, 395) l’ ejgguvh doveva essere anticamente un contratto
formale, un modo di sancire il matrimonio ben definito e valido in epoca arcaica
specialmente tra le famiglie nobili, come dimostrerebbe il racconto delle nozze di
Agariste fornito da Hdt. VI 130. In età classica, invece, si è del tutto persa la conoscenza
di questo tipo di matrimonio: ogni moglie legittima diviene, così, ejgguhthv. Allorchè
nell’Atene arcaica, con Solone, si è costituito un diritto privato, i costumi legislativi dei
singoli gruppi nobili si sono allargati all’intera città ed il tipo di matrimonio valido tra le
famiglie ateniesi prima di Solone, nella sua forma speciale, sarebbe del tutto caduto in
oblio e con esso anche il termine davmar che indicava la sposa legittima e nobile. E
quanto è avvenuto ad Atene e per il dialetto attico sarebbe, per Gernet, ipotizzabile
anche per il dialetto ionico. davmar, dunque, per lo studioso francese è un termine ionico:
in eolico si aveva dovmorti". Le parole di Gernet suonano, dunque, come una condanna
contro l'integrazione di Essler: per quanto riguarda il nostro testo, si tratta di un
argomento valido, ma non decisivo, considerate le varie espressioni omeriche o,
comunque, non proprio eoliche che si rintracciano, come abbiamo visto, nei frammenti
di Saffo.
5 Prima di a[nqo" è presente sul frustolo la traccia della lettera precedente (un
sottile, breve tratto orizzontale sul bilineo superiore), ma è impossibile stabilire quale
lettera fosse. Per a[nqo" cfr. Sapph. 2.9s. V. ejn de; leivmwn ijp≥p≥ovboto" tevqale /
†tw≥t...(.)rinnoi"† a[nqesin "e qui un prato, pascolo dei cavalli, è florido / di fiori
(primaverili)"; 94.15ss. kai; povllai" ujpaquvmida" / plevktai" ajmf∆ ajpavlai devrai /
ajnqevwn ej≥[ravtwn ] pepohmevnai" (ej≥[ravtwn ] suppl. Schubart)"ed intorno al delicato
collo molte ghirlande intrecciate, fatte di fiori (gradevoli)"; 98 a.9 s]tefavnoisin .../
aj≥nqevwn ejriqalevwn: "con corone .../ di molto floridi fiori"; 105b.2 cavmai dev te
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
304
povrfuron a[nqo"... "ed a terra il fiore purpureo..."; 122 (Sappho dicit se uidisse) a[nqe∆
ajmevrgoisan pai'd∆a[gan ajpavlan "(Saffo dice di aver visto) una fanciulla molto
delicata che coglieva fiori"; Alc. 397 V. terevna" a[nqo" ojpwvra" "di tenero autunno
un fiore"; inc. auct. 16.3 poãivÃa" tevren a[nqo" mavlakon mavteisai "cercando il
delicato, tenero fiore dell'erba".
6 Per i[]meron (suppl. Hunt 1922, 35) cfr. v. 3 i[mer[ e Sapph. 95, 12 katqavnhn
d∆i[merov" ti" [e[cei me kai; / lwtivnoi" drosoventa" [o[- / c≥[q]oi" i[dhn jAcer[ "e mi
possiede un desiderio di morire e di vedere le rugiadose rive, fiorite di loto, di
Acher(onte)"; 96.15sgg. polla de; zafoivtais∆ajgavna" ejpi- / mnavsqeis∆ [Atqido"
ijmevrwi / levptan poi frena k[.]r...bovrhtai "spesso lei, mentre si aggira, presa dal
ricordo, morde il cuore nel desidero di Atthis delicata…"; [Sapph.] 137.3 aij d∆h \ce"
e[slwn i[meron h] kavlwn "se tu avessi desiderio di ciò che è bello e probo…".
7 Il testo presente sul papiro è ]eterp[. L'unico ad aver tentato una qualche
divisione tra le parole è stato Diehl, sia nella prima (Diehl1 1923, 362), sia nella seconda
edizione (Diehl2 1936, 4]49): ]e terp[. Se consideriamo la serie di lettere come
formanti un'unica parola, è obbligo ipotizzare la presenza di un imperfetto di tevrpw. ]e
terp[ rimanda, invece, a qualche altra forma dello stesso verbo, oppure all'aggettivo
tevrpno" (= terpnov"). Per tevrpw/ tevrpno" cfr. Sapph. 160 ...tavde nu'n ejtaivrai" /
tai;" e[mai" †tevrpna† (tevrpoisa Sitzler) kavlw" ajeivsw. "ora intonerò ben questo
canto per dilettare le mie compagne"; e cfr. anche Alc. 73.9 suvn t∆u[mmi tevp[ "e con
voi dilettarmi" (cfr. 306 i col. I 25 suv]m t∆u[mmi terpe≥[sqai). Più improbabile che si
tratti di ]et∆ ejrp[: la radice eJrp- (← *serp; cfr. gr. e{rpw, lat. serpo) sembra, infatti,
diventare ojrp- in eolico, per cui cfr. Sapph. 130.2 glukuvpikron ajmavcanon o[rpeton
"dolceamara, invincibile creatura". Per ejrp[ cfr., però, anche Sapph. 141.3 [Ermai"
d∆e[lwn o[lpin qevois∆ejoinocovhse "Ermes, presa un'anfora, versò vino agli dei", dove
due testimoni hanno e[rpin al posto di o[lpin.
kgV (79 L.-P. = V.) metrum: ] [, hipp
2cho suppl. possis
]n≥m≥[ ]w≥[ ]to.[ ]t∆au\ton.[
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
305
5 ]w≥ pevlet[
]na[
...lui...
...è...
TEST POxy. 1787 fragmm. novum, a Lobel 1925, 38 prim. ed. ut S. m. d— 19
vv. 5-6: de S. 81, 6s. cog. superiora vetare mon. Lobel 1925, 38.
CRIT 3 to;.[ ║4 t∆au'
Il frustolo è stato edito per la prima volta da Lobel (1925, 38) e, dunque, è privo di una
numerazione.
5 pevlet[ e ]na[ del v. successivo sembrano essere congruenti con pevletai e
†proterhn†, ajstefanwvtoisi del fr. DV iaV 6-7 = 81.6-7 V. (v. supra), ma come
avverte già l'editore, il testo riportato dalla parte superiore del frustolo impedisce una
simile coincidenza. Per pevlet[ cfr. Sapph. 50.1s. oj me;n ga;r kavlo" o[sson i[dhn
pevletai ãkavlo"Ã / oj dev ka[gaqo" au[tika kai; kavlo" e[sãseÃtai "colui che è bello,
infatti, è bello per quanto lo si guarda, / ma colui che è anche virtuoso sarà subito anche
bello"; 94.25-26 i\ron oujd∆uj[ ]/ e[plet∆o[pp≥[oqen a[m]me" ajpevskomen "non c'era
rito…da cui fossimo assenti"; Alc. 360.3-4 V. pevni- / cro" d∆oujd∆ei \" pevlet∆e[slo"
oujde; tivmio" "non c'è un povero alcun povero illustre ed onorato"; 373 ga'" ga;r
pevletai sevo" "della terra vi è un sussulto"; Alc. 113, 6 pevlont∆ aj[.
kdV (80 L.-P. = V.) metrum: ] [ (?), hipp2cho
suppl. possis
].[ ].t≥oses.[ ]panta[
]i≥ d∆ajtevra[
5 ]loka[
].[
...tutto...
...altr-...
...ricciol-...
TEST POxy. 1787 fr. 15. prim. rec. Diehl1 1923, 363
CRIT 2 ].t≥oses.[ pap. : ]t≥oses∙.[ leg. Hunt 1922, 34 : ]to" ejs[ Hunt 1922, 35, rec.
Diehl1 1923, 363 : ].t≥oses.[ Lobel 1925, 38 pro t fort. i, u, simm. post es
litteram deletam (s, e, q, o, simm.) esse censuerunt Hunt 1922, 34, Lobel 1925, 38-39
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
306
║2 ]panta[ : ] pavnta[ Hunt 1922, 35, rec. Diehl1 1923, 363 ║4 vel ]n d supra
lineam additum tevra– ║5 p]loka[m Hunt 1922, 35
2 Dopo es si nota sul testimone una traccia di una lettera con un tratto posto sopra
dal copista: è possibile che si tratti di una lettera cancellata, come ipotizzarono Hunt (che
scrive ]t≥oses∙.[) e lo stesso Lobel. In questo stesso frustolo, del resto, vi sono anche
altri interventi da parte del copista, per cui cfr. v. 4.
3 Su panta non è presente alcun accento: Hunt (1922, 35) e Diehl1 (1923, 363)
con ben poca cautela propongono di intendere ] pavnta[, ma non vi è la certezza
assoluta..
4 La prima lettera tradita è illeggibile: si nota soltanto un breve tratto obliquo che
corre in parallelo al margine del frustolo ed a breve distanza da quest'ultimo. Prima di
ajtevra[ lo scriba (probabilmente lo stesso che ha trascritto il papiro, come pensava Hunt
1922, 44: la scrittura è simile) ha aggiunto nell'interlinea un d, cioè d∆. Per ajtevra[ (=
eJtevra) cfr. Sapph. 3.14 V. ]n ajtevrai" me[ "altre"; 113 ouj ga;r / ajtevra nu'n pavi", w\
gavmbre, teauvta "infatti oggi non esiste, o sposo, altra ragazza simile"; Alc. 346.5 V.
ãajà d∆ajtevra ta;n ajtevran kuvlix / wjqhvtw "ed una coppa spinga via l'altra coppa".
e{tero" si trova solo in Sapph. 147, ma è un passo corrotto: kai; e{teron non fornisce un
significato adatto al contesto.
5 Hunt (1922, 35) propone di integrare p]loka[m per cui cfr. Sapph. DV kqV b.5 =
87 a.5 V. ].plokam[. Il sostantivo compare una sola volta nell'Iliade (Il. XIV 176b cersi;
plokavmou" e[plexe faeinou;" "con le mani intrecciò gli splendidi riccioli") e mai
nell'Odissea, ma si conta un'attestazione negli Inni Omerici (Hymn. Vest. 3 aijei; sw'n
plokavmwn ajpoleivbetai uJgro;n e[laion "sempre dai tuoi riccioli stilla liquido olio").
Per plovkamo" nella lirica arcaica cfr. Pi. P. IV 82 oujde; koma'n plovkamoi kerqevnte"
w[icont∆ajglaoiv, / ajll∆a{pan nw'ton kataivqus- / son "una volta tagliati, non si erano
rovinati i lucenti riccioli delle chiome, ma lungo tutto il dorso risplendevano"; Pae. 52na
Sn.-M. ajn- / dhsavmenai pl[o]kavmou" "legando i riccioli"; fr. 246 a Sn.-M. (= Lesbon.
De fig. p. 44sg. R. Müller) melirrovqwn d∆e[petai plovkamoi (plovkamoi Lesbon. :
ãejpevwnà plovkoi Schroeder) "seguono riccioli (oppure, con Schroeder, intrecci di parole)
che suonano dolci come il miele"; Bacchyl. Fr. adesp. 10.9 p]lokavmoi".
keV (83 L.-P. =V.) metrum: ] [, hipp2cho
suppl. possis
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
307
].aiv.[ ]l∆au\qi me[
]nwvmeq∆oj[ ] dhu\t∆ejpit[
5 ]evnthdem≥[ ].a ga;r ejkav[ ].[.].[
…
…qui rimanere
…
…nuovamente verso…
5 …e…
…difatti…
…
TEST POxy. 1787 fr. 36. prim. rec. Diehl1 1923, 364
CRIT 1 avi 2 ]l∆au' mev[nhn ? Diehl1 1923, 364 conl. Alc. 5, 16 au\q]i
mevnhn ? ║3 ]nwvmeq∆o; ║4 dhu't∆ ║5 ]evnthdem≥≥[ : ]evn t∆ hjdev k≥≥[ Hunt 1922,
38 ║6 ]a– Hunt 1922, 38 : ].a– legendum ekav[ : fort. ejkav[st ?
2 Per au\qi mev[nhn, integrazione di Diehl1 (1923, 364) cfr. Alc. 5.16 V. au\q]i
mevnhn (suppl. Hunt). L'epressione è omerica, per cui cfr. Il. I 492 au\qi mevnwn,
poqeveske d∆aju>thvn te ptovlemon te "lì rimanendo, rimpiangeva il bellico grido e lo
scontro" (Achille in disparte dal campo acheo); III 290-291 aujta;r ejgw; kai; e[peita
machvsomai ei{neka poinh'" / au\qi mevnwn, h|ov" ke tevlo" polevmoio kiceivw "ma io
anche dopo combatterò per questo compenso / qui rimanendo, finchè io raggiunga lo
scopo della guerra" (Agamennone); VI 84 hJmei'" me;n Danaoi'si machsovmeq∆au \qi
mevnonte" "noi combatteremo contro i Danai, qui rimanendo" (parla Eleno, figlio di
Priamo); IX 412 eij mevn k∆au \qi mevnwn Trwvwn povlin ajmfimavcwmai "se combatto,
qui rimanendo, intorno alla città dei Troiani"(Achille); IX 427 Foi'nix d∆au\qi par∆a[mmi
mevnwn katakoimhqhvtw "ma Fenice, qui rimanendo, dorma presso di noi" (Achille); X
62 au\qi mevnw meta; toi'si, dedegmevno" eij" o{ ken e[lqhi" "qui io rimango con loro,
aspettando finchè tu torni" (domanda di Menelao); X 65 au\qi mevnein "resta qui"
(risposta di Agamennone); X 209 (= X 410) au\qi mevnein para; nhusi;n "restare qui
vicino alle navi"; XIII 37 o[fr∆e[mpedon au\qi mevnoien "perché qui fermi restassero in
attesa"; XXII 136s. {Ektora d∆, wJ" ejnovhsen, e{le trovmo": oujd∆a[r∆e[t∆e[tlh / au\qi
mevnein "come lo vide, un tremito colse Ettore e non più sopportò / di lì rimanere"; XXII
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
308
241 au\qi mevnein "lì rimanere"; XXIII 128 au\qi mevnonte" "lì rimanendo"; XXIII 674
au\qi menovntwn; Od. V 208 ejnqavde k∆au\qi mevnwn su;n ejmoi; tovde dw'ma fulavssoi"
"qui rimanendo con me la mia casa custodiresti" (Calipso parla ad Odisseo); VII 311ss.
ai] gavr, Zeu' te pater kai; jAqhnaivh kai; [Apollon,/ toi'o" ejw;n oi|ov" ejssi,tav te
fronevwn a{ t∆ejgwv per, / pai'dav t∆ejmh;n ejcevmen kai; ejmo;" gambro;" kalevesqai /
au\qi mevnwn "Ah se, infatti, -Zeus padre, Atena ed Apollo - / essendo tale come tu sei,
che pensi ciò che penso anche io, / la figlia mia avessi e mio genero fossi chiamato, / qui
rimanendo" (Alcinoo rivolto ad Odisseo); XIII 44 uJmei'" d∆au\qi mevnonte" "Voi,
invece, qui rimanendo…" (Odisseo, in partenza da Scheria, si rivolge ai Feaci); XV 455
oiJ d∆ejniauto;n a{panta par∆hJmi'n au \qi mevnonte" "quelli, tutto un anno intero presso
di noi qui rimanendo"; XX 220 to; de; rJivgion, au\qi mevnonta "ma più terribile, qui
rimanendo". Non si conta alcuna attestazione né in Esiodo, né negli Inni Omerici e
questa espressione è piuttosto rara anche nella produzione lirica arcaica a noi rimasta: se
si esclude questo passo e quello di Alceo sopramenzionato, essa ricorre solo in Bacchyl.
Fr. 7, 27 au\qi mevne[in. Indubbiamente, è una reminiscenza epica e non è certo la sola a
trasparire da questo frustolo.
3 Prima di ]nwvmeq∆ occorre, metri causa, una sillaba lunga, ma, in mancanza del
contesto, è impossibile proporre integrazioni valide.
4 Per dhu\t∆ cfr. Sapph. 1.15.16.18 h[re∆o[tti dhu\te pevponqa kw[tti / dhu\te
kavlhmmi / kw[tti moi mavlista qevlw gevnesqai / mainovlai quvmwi: tivna dhu\te
peivqw / ..s≥avghn ej" sa;n filovtata "mi domandasti che cosa di nuovo soffrissi e
perché / di nuovo invocavo / e che cosa più di tutto io volessi che per me si realizzasse /
nel mio animo folle: chi di nuovo devo convincermi / a ricondurre al tuo amore?"; 22.
11ss. a\" se dhu\te povqo" t≥.[ / ajmfipovtatai / ta;n kavlan "finchè di nuovo il
desiderio a te / voli intorno, / bella"; 127 Deu'ro dhu\te Moi'sai cruvsion livpoisai
"qui di nuovo venite, Muse, abbandonata l'aurea (dimora del padre?)…"; 130, 1 [Ero"
dhu\tev m∆oj lusimevlh" dovnei "Eros che scioglie le membra di nuovo mi agita"; Alc.
303 A b.14 dhu\te Pwluanaktivdan / to;n mavrgon o[ndeixai qevlw "di nuovo dei
Polianattidi / il folle voglio mostrare". L’avverbio dhu\te, come è noto, è un modulo a
cui Saffo ricorre per indicare il carattere ciclico di una certa esperienza: cfr. da ultimo
Ferrari 2007a, 96
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
309
5 Il primo editore (Hunt 1922, 38-39) proponeva di leggere ]evn t∆hjde; k[, ma il
suo testo è stato accolto solo da Diehl1 (1923, 364). Eva-Maria Voigt (1971, 93) mostra
una certa perplessità, soprattutto verso hjdev, che è attestato quasi esclusivamente
nell'epica e la cui presenza in un'ode lirica dovrebbe suonare strana, o comunque fuori
contesto. hjdev si può trovare come correlativo di hjmevn (e.g. Il. II 279; V 751; VII 302),
oppure usato da solo, come semplice congiunzione "e" (e.g. Il. I 41, 96, 251; cfr. LSJ
s.u.). In quest'ultimo caso, cioè quando sia usato da solo, può essere talvolta preceduto
dall'enclitica t(e), proprio come in questo passo di Saffo, per cui cfr. Il. I 400 }Hrh t∆hjde;
Poseidavwn kai; Palla;" jAqhvnh "Hera, Poseidone e Pallade Atena"; IX 99 skh'ptrovn
t∆hjde; qevmista" "lo scettro e le leggi"; XII 61 }Ektor t∆hjd∆a[lloi Trwvwn ajgoi;
hjd∆ejpikouvrwn "Ettore e gli altri condottieri dei Troiani e degli alleati". L'enclitica t(e)
e hjdev possono anche trovarsi separati da una parola che si frappone tra loro, così come
in Il. V 822 tou[neka nu'n aujtov" t∆ajnacavzomai hjde ; kai; a[llou" "per questo ora mi
ritiro ed anche gli altri…". Finora i passi qui riportati sono tutti epici, ma hjdev non è
attestato solo nell'epos. Già la Voigt (1971, 93) si era accorta che hjdev ricorre anche in
Alc. 34.2b D[ivo"] hjde; Lhvda" "di Zeus e di Leda" (riferito, ovviamente, ai Dioscuri,
Castore e Polluce), ma non si riscontra alcuna altra attestazione nei poeti eolici e/o nella
lirica cosiddetta monodica (Saffo, Alceo, Anacreonte e Ibico). Una attestazione si conta
per Simonide (Sim. 59.4 {Omhro" hjde; Stasivcoro") e due per Pindaro, di cui una nelle
Olimpiche: Pi. O. 43s. o{ssa t∆ejn Defoi'sin ajristeuvsate, / hjde; covrtoi" ejn
levonto" "e quante volte avete primeggiato in Delfi / e nei pascoli del leone!"; Pi. fr.
203.4 Sn.- M. povda" hjde; kefalavn "i piedi e la testa". Per la poesia elegiaca cfr.
Mimn. 1.5 W. ajndravsin hjde; gunaixivn "per gli uomini e per le donne"; Sol. 9.1 W. ejk
nefevlh" pevletai ciovno" mevno" hjde; calavzh" "dalla nube nasce la violenza di neve
e di grandine"; 13.63 W. Moi'ra dev toi qnhtoi'si kako;n fevrei hjde; kai; ejsqlovn "la
Moira porta ai mortali il male ed il bene"; 24.5a W. = Thgn. 723a (v. infra); Tyrt. 12.
27 W. to;n d∆ojlofuvrontai me;n oJmw'" nevoi hjde; gevronte" "allo stesso modo lo
piangono giovani e vecchi"; 12, 37b W. oJmw'" nevoi hjde; palaioiv "allo stesso modo
giovani ed anziani"; 19.8 W. cwri;" Pavmfuloiv te kai; JUllei'" hjd≥[e; Duma'ne"
"separati tra loro Panfili, Illei e Dimani"; Thgn. 369 mwmeu'ntai dev me polloiv, oJmw'"
kakoi; hjde; kai; ejsqloiv "e molti mi deridono, allo stesso modo poveri e potenti"; 723a
paidov" t∆hjde; gunaikov" "di un ragazzo o di una donna"; 761 fovrmigx d∆au\ fqevggoiq∆
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
310
iJero;n mevlo" hjde; kai; aujlov" "e la cetra, invece, suoni il sacro inno ed il flauto…";
1067 ajndravsin hjde; gunaixiv "per gli uomini e per le donne"; 1312 touvtois∆, oi |sper
nu'n a[rqmio" hjde; fivlo" "a costoro, per i quali ora sei amichevole e caro"; Ant. 57.2
W. (= 57.2 Wyss) povda" hjde; kavlwa" "le scotte e le gomene"; Ion 30.1 W. w}" oJ me;n
hjnorevhi te kekasmevno" hjde; kai; aijdoi' "così lui è eccellente per coraggio e pudore";
Xenoph. 2.12 W. ajndrw'n hjd∆ i{ppwn "di uomini e di cavalli"; Xenoph. VS 21 B 25 gh'
kai; u{dwr pavnt∆e[sq∆ o{sa givnontai hjde; fuvontai "terra ed acqua sono tutto quanto
nasce e cresce". Dunque, se ci basiamo su questi paralleli, la presenza di hjdev non
sembra talmente strana da dubitare di una simile lettura: hjdev risulta attestato, infatti, non
solo nell'epica, ma anche nell'elegia, nella lirica corale e, seppur più raramente, in quella
monodica. Se, dunque, accogliamo hjdev, esso farà coppia con au\qi me[ del secondo
verso: sono entrambe, infatti, espressioni proprie dell'epos, ma, come possiamo vedere,
riutilizzate anche dai poeti lirici ed elegiaci: del resto, per voler stare alle fonti, Saffo
avrebbe composto anche poesie elegiache.
6 L'alpha posto subito dopo il margine del frustolo è sormontato dal simbolo di
lunga, mentre le due sillabe successive sono brevi: in queste condizioni l'alpha finale
deve essere in sillaba lunga e quindi ejkav[st è un'integrazione probabile.
kzV (84 L.-P. = V.) metrum: ] , hipp2cho
suppl. possis
].ais[
].ikip[
]w≥n k[..].[.?]ivna[
]tonovne.[ .? ].o≥se≥[ 5 l]avbroi" ejpi; ceivm[wna" ]an jArtemi≥[ ]nabl[
…in violente tempeste…
…Artemide
TEST POxy. 1787 frr. 37 et 41, ita fort. coniungenda, ut illius v. 3, huius v. 5 aut nullo
aut minimo intervallo continetur, censuit Lobel 1925, 41 fr. 37 prim. rec. Diehl1
1923
CRIT 1 ]l≥ais[ Hunt 1922, 40-41 ║2 ]l≥ vel ]a≥ legi potest : guvn[aiki Hunt
1922, 41 : a[]liki ? Diehl2 1936, 4]53 ║4 nov s≥[≥ vel simm. ]d≥o≥ Hunt
1922, 41 pro e≥[ etiam s≥[ vel alia o[nei≥[d]o" e[i[h ? Voigt 1971, 94
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
311
║5 ]avb a[broi" vel l]avbroi" Voigt 1971, 94 chm : pro chm fort,
ceim legendum esse censuerunt Lobel 1925, 41, L.-P. 1955, 58 et Voigt 1971, 94
l]avbroi" ejpi; ceivm[wna" Di Benedetto apud Ferrari 1987, 169 n. 1.
║6 fort. ajgrotevr]an [Artemi[n? ║7 ]n ajbl[ab- Ferrari 2007a, 34 n. 6
Il frammento, così costituito (POxy. 1787 fr.37 + POxy. 1787 fr. 41), si basa su collage
proposto da Lobel (1922, 40-41). Prima dell'edizione di Lobel, il solo fr. 37 era stato
accolto nell'edizione Diehl1
(1923, 365).
1 La prima lettera tradita dal testimone è di difficile interpretazione: si nota
soltanto un breve tratto orizzontale che si estende, in basso, dal margine all'alpha e Hunt
(1922, 40) legge ]l≥ais[: non vi è la certezza, ma potrebbe essere una lettura probabile.
2 Anche in questo verso la prima lettera tradita è poco decifrabile, ma la traccia è
abbastanza simile a quella del verso precedente: Hunt (1922, 41) legge ed integra
guvn]aiki, mentre Diehl2 (1936, 4]53) a[]liki. Per guvn]aiki di Hunt cfr. Sapph. 44.14-15
pai'" o[clo" / gunaivkwn "tutta la folla / delle donne"; 44.31 guvnaike" d∆ejlevlusdon
o[sai progenevsterai "e le donne, quante erano più anziane, gridavano eleleu"; 96,
6ss. nu'n de; Luvdaisin ejmprevpetai gunaiv- / kessin w[" pot∆ajelivw / duvnto" aj
brododavktulo" ãselavnnaà "ed ora risplende tra le donne / lidie come, quando
tramontato / è il sole, la luna dalle dita di rosa"; Alc. 130 b.19 a[cw qespesiva
gunaivkwn "eco mirabile di donne"; 390 †mh;† fovno" kevcutai gunaivkwn "sangue di
donne è stato versato"; 347.4 nu'n de; guvnaike" miarwvtatai "ed ora le donne son più
lascive"; inc. auct. 35.6 gunaivkwn. Per altri a\lix (att. h|lix) ed altri composti in Saffo
cfr. Sapph. 30.7 soi;" ujmavlik≥[a" "i tuoi coetanei"; Sapph. DV iV a.5-6 = 68.5 + 70.5 V.
jAn]Õdromevdan ... ajpav]lik∆ “l'attempata Andromeda”; Sapph. DV idV a.4 = 64a.4 V.
a]livkes≥≥si[; DV kV 7 = 76.7 V. ]a–lik[; 103.8 gav]mbron, a[saroi g≥a;r≥ u≥jmavli≥k[ "lo sposo,
infatti sfacciati i coetanei".
4 Hunt (1922, 38-39) leggeva ]ton o[ne≥s≥[, testo accolto da Diehl1(1923, 365). La
Voigt (1971, 94), che parte dal collage di Lobel, propone di leggere ed integrare ]ton
o[nei≥d≥o" e[i[h: in effetti, la lettera posta dopo l'epsilon sul POxy.1787 fr. 37 può
benissimo essere uno iota, perché la traccia (un tratto uncinato) che rimane sul papiro
prima del margine è congruente con una tale lettura: cfr. e.g. lo iota di ]abroi" al verso
successivo.
5 La Voigt (1971, 93-94) propone di leggere e/o di integrare ]a[broi" o l]avbroi".
Ferrari, nelle note dell'edizione che ha curato insieme a Vincenzo Di Benedetto,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
312
attribuisce a quest'ultimo l'integrazione l]avbroi" ejpi; ceivm[wna" "in violente
tempeste"330
: "la Voigt ha suggerito la possibilità di integrare l]avbroi" e già Lobel
prendeva in considerazione la possibilità di leggere kheim invece di khēm; su questa base
è possibile l]abrois epi kheim[ōnas". Ferrari cita direttamente le parole di Di Benedetto,
ma non l'occasione in cui sono state riferite. Secondo la proposta di Di Benedetto,
l'aggettivo lavbro" sarebbe utilizzato, come avviene sempre in Omero (cfr. LSJ s.u.), per
qualificare fenomeni naturali, per cui cfr. Il. II 147-148 wJ" d∆o {te kinhvshi Zevfuro"
baqu; lhvi>on ejlqwvn / lavbro" ejpaigivzwn "così come quando Zefiro, giunto, turbi le alte
messi / precipitando violento"; Od. XV 293 toi'sin d∆ i[kmenon ou\ron i{ei glaukw'pi"
jAqhvnh / lavbron ejpaigivzonta di∆aijqevro" "per loro vento favorevole muoveva Atena
dagli occhi azzurri, / impetuoso, che si scatenava per l'etere". Per lavbroi" cfr. Alc. 72.
3 lavbrw". Per ceivm[wna" (suppl. Di Benedetto) cfr. Sapph. 22.6 ceivmwn[; Alc. 338.2
[Uei me;n oj Zeu'", ejk d∆ojravnw mevga" / ceivmwn, pepavgaisin d∆ujdavtwn rjovai "Zeus
manda la pioggia e dal cielo una grande / tempesta, sono fermi i corsi delle acque"; 208
(a), 5 ceivmwni movcqente" megavlwi mavla "assai fiaccati da una grande tempesta". In
Alc. 208 (a) non si descrive una tempesta reale, ma attraverso l'immagine allegorica del
fenomeno naturale si intende, implicitamente, la situazione politica e tutto ciò avviene
anche in altri frammenti, anche senza la presenza del sostantivo ceivmwn, ad es. Alc. 6 V.
tod∆au\te ku'ma tw; protevrw∆nevmw / steivcei, parevxei d∆a[mmi povnon povlun /
a[ntlhn, ejpei; ke na'o" e[mbai / ].ovmeq∆e[ / ]..[..]:[ / farxwvmeq∆wj" w[kista≥[ / ej"
d∆e[curon livmena drov[mwmen "quest'onda del vento di prima di nuovo / avanza e vi
procurerà molta fatica / affrontarla, poi che se entra nella nave /…/…/…/fortifichiamo il
più rapidamente possibile…/ ed a saldo porto corriamo…", ode che Eraclito stoico
(Heraclit. Quaestiones homericae 5) spiega come allegoria della tirannide di Mirsilo. E
cfr. anche Alc. 73 V. pa;n fovrti[o]n d..[ / d∆o[tti mavlistasavl[ / kai; kuvmati
plavgeis[an / o[mbrwi mavcesqai..[ fai's∆oujde;n ijmevrrh[n, ajsavmwi] / d∆e[rmati
tuptom[evnan "tutto il carico…/ ma quanto più…/ e colpita dall'onda…/con la pioggia
combattere…/ più non vuole, dice, da oculto / scoglio battuta…". Alla metafora della
tempesta si affianca, in Alceo, come possiamo vedere, quella della nave che si trova ad
330
Le edizioni di Aloni (1997, 134) e Tedeschi (2005, 50) presentano quello che sembra essere, vogliamo
sperare, un duplice errore di stampa, ovvero l]avbroi" ejpi; c[eiv]m[ona": ei è ben visibile sul papiro,
anche se poco decifrabile; e poi il testo che loro stampano, ovvero c[eiv]m[ona" invece del corretto
ceivm[wna", è ametrico, oltre che sbagliato.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
313
affrontarla. La stessa immagine allegorica, cara ad Alceo, ricorre anche nei seguenti
frammenti: 249 V., 306 (i) e forse anche 385. Per immagini di tempesta allegorica nella
poesia arcaica cfr. Archil. 105 W.2 Glau'c∆, o{ra: baqu;" ga;r h[dh kuvmasin
taravssetai / povnto", ajmfi; d∆a[kra Gurevwn ojrqo;n i}statai nevfo", / sh'ma
ceimw'no", kicavnei d∆ejx ajelptivh" fovbo" "Guarda, Glauco: dalle onde è ormai
agitato il mare profondo, / intorno alle vette di Gire dritta si staglia una nube, / segno di
tempesta, d'improvviso ci coglie la paura". È dunque possibile, ma non certo, che tutto
ciò, ovvero l'allegoria della tempesta che rimanda alla situazione politica mitilenese,
valga anche per questo frammento di Saffo. Per ceivmwn nel significato di "inverno" cfr.,
invece, Alc. 338, 5 kavbbale to;n ceivmwn∆ "sconfiggi l'inverno".
6 Saffo sembra invocare Artemide, così come avviene in un frammento qui già
discusso, ovvero l'ode sull'esilio restituita da Ferrari: la coincidenza tra i due passi dello
stesso libro potrebbe non essere banale: se la nostra ipotesi fosse dimostrata, il nome
della stessa dea (o, addirittura, una invocazione a lei diretta) ricorrerebbe in due odi dello
stesso libro dal contenuto analogo. Per la presenza di Artemide nei frammenti di Saffo
cfr. Sapph. 44 A a.4sgg. [Artemi" de; qevwn] mevgan o[rkon ajpwvmose / kefav]lan: a[i>
pavrqeno" e[ssomai / ].wn ojrevwn koruvfais∆e[pi / ]d≥e neu'son e[man cavrin: / evneu]se≥
qevwn makavrwn pavthr: / ejlafav]bolon ajgrotevran qevo≥i / ].sin ejpwnuvmion mevga: /
]ero" oujdavma pivlnatai. "Ma Artemide giurò il gran giuramento degli dei / sulla testa
(di suo padre): "sempre sarò vergine / …sulle cime dei monti/ …accorda la mia grazia. /
…annuì il padre degli dei beati. / …cacciatrice di cervi, agreste gli dei /…(le danno) il
titolo solenne. / …Eros (a lei) mai si accosta". In base a questo parallelo saffico è, forse,
possibile integrare ajgrotevr]an [Artemi[n? Cfr. Il. XXI 471 [Artemi" ajgrotevrh;
Bacchyl. Ep. 11.37 [Artemi" ajgrotevra; Ar. Thesm. 115 [Artemin ajgrotevran; Xen.
Cyn. VI 13.2 th'i jArtevmidi th'i jAgrotevrai; Nonn. XLVIII 349 [Artemi" ajgrotevrh
(al.).
7 Ferrari (2007a, 34) propone di integrare ]n ajbl[ab- "innocent-"
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
314
khV (85 L.-P. = V.) metrum: ] , hipp2cho
suppl. possis
a
b
col. I
].. [ ]pavmena≥[ o]lbon [ ]t≥∆w[st∆oj pevlh[
]akouvhn [ ]akan s≥ov[ ]a≥uvtan≥ [ . . . . . . col. II
.v]gan n[.].[ ] go≥[ c
] .[ . . . . . . ]fwna[ ] ._[ ]prosq[ ] ovd≥[ . . .
] a;_i[ ]n en≥[ ] s_[ ]x e[ . . .
…a colei che ha acquistato (?)…
…ricchissimo…sicchè il vecchio…
…ascoltare…
…lei stessa…
TEST (a) POxy. 1787 frr. 40+35+addenda (b) POxy. 1787 fr. 38
fragmm. ex eadem papyri parte proficisse cens. Lobel 1925, 41 fragm.
(a) prim.rec. Lobel 1925, 41, fragm. (b) prim.rec. Diehl1 1923 fragm.
(c) a Lobel 1925, 41 prim. editum, sed a Voigt 1971, 94 omissum
CRIT (a) 2 .;] ut videtur : compos. in –olbo" (cfr. poluvolbon Sapph. 133, 2) Voigt 1971,
94 ║3 kovu ║4 ]av≥u (b) pe]pavmena≥≥[i Hunt 1922, 39 (finis versus esset)
║2 t≥∆wstopevlh pevlh]o"? Hunt 1922, 39 ║3 s≥o≥v[
a
2 Il testo presente sul papiro è, chiaramente, .;]lbon, che sembra presupporre
l'accento acuto sulla vocale immediatamente precedente a quella con il grave. Quanto a
questa ultima, ovvero a quella che porta l'accento grave, il dubbio può essere solo tra
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
315
omicron ed iota: o]lbon rimanda, ovviamente, dato l'accento grave, ai composti di
o[lbo", mentre i]lbon a quelli, davvero più rari, di stivlbo". Non vi possono essere
dubbi sul fatto che l'aggettivo corretto sia un composto di o[lbo"; stivlbo" ha
attestazioni ben più tarde ed appartiene soprattutto al gergo medico: quindi o]lbon è,
riteniamo, un'integrazione certa: Lobel-Page (1955, 59) e Voigt (1971, 94) mostrano un
po' troppa cautela nel trascrivere .;]lbon. La Voigt ha, poi, istituito il parallelo con Sapph.
133.2 V. Yavpfoi, tiv ta;n poluvolbon jAfrodivtan "Saffo, perché Afrodite che rende
fortunato…", l'unico altro passo della poetessa eolica in cui sia attestato un composto di
o[lbo". poluvo]lbon, tuttavia, non può essere integrato qui: prima di quella con accento
acuto occorre una sillaba lunga e non breve come po. Hunt (1922, 39) integrava
a[no]lbon, per cui cfr. Archil. 88.1 W.2 jErxivh, ph'i dhu't∆a[nolbo" ajqroi?zetai
stratov"; "Erxia, dove di nuovo si riunisce il misero esercito?"; 112.3 [ aj]novlb≥o≥[i]"
ajmfau>thvsei stratov" "l'esercito grida per ogni dove agli sventurati"; Thgn. 288
†wsdetoswsaiei;† polloi; ajnolbovteroi "…molti più infelici". Possibili anche
pavno]lbon (cfr. Aeschl. Suppl. 582 di∆aijw'no" makrou' pavnolbon "per lungo tempo del
tutto fortunato"; Or. Sib. III 345 Gavza panolbivsth) e fivlo]lbon (cfr. HAn. Hymnus
Curetum 40 aJ fivlolbo" Eijrhvna "la pace amica della prosperità"), ma a[no]lbon di
Hunt trova maggiori paralleli nella poesia arcaica.
3 Per ]akouvhn (rischioso scrivere ] ajkouvhn, come fa Hunt: potrebbe trattarsi di un
verbo composto) cfr. Sapph. 31.3-4 kai; plavsion a\du fwneiv- / sa" ujpakouvei "e
vicino ti ascolta parlare dolcemente"; Alc. 129.9-12 a[[gi]t∆eu[noon / qu'mon skevqonte"
ajmmetevra" a[ra" / ajkouvsat∆ "suvvia avendo l'animo benevolo ascoltate le nostre
invocazioni"; Alc. 130(b).3-4 V. ijmevrrwn ajgovra" a[kousai / kar≥u≥[zo]mevna" w\ (
jA)gesilai?da "desiderando ascoltare che le assemblee / vengono convocate, o
Agesilaide"; 341 V. ai[ k∆ei[ph" ta; qevlhi", ãkaiv kenà ajkouvsai" tav kãenà ouj qevloi"
"se dici ciò che vuoi, potresti anche udir quel che non vorresti".
b
1 Hunt (1922, 39) integra pe]pavmena≥[i
2 pevlh[ è parola di significato incerto. Hunt (1922, 39) integra pevlh[o" ed afferma
"is possibly for pevleio" dark; cfr. pevleia". pevleio" è una parola attestata, a quanto
pare, solo da Hsch. p 1308 peleivou": Kw'oi kai; jHpeirw'tai tou;" gevronta", kai;
ta;" presbuvtida", ma cfr. anche Hsch. p 1325 pevlh[t]o": gevrwn: il significato che si
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
316
recupera da queste glosse di Esichio (la seconda potrebbe essere corrotta e si può
ipotizzare che all'origine fosse pevlho": gevrwn) è "vecchio" e non "dark", come intende
Hunt.
kqV (87 L.-P. = V.) metrum: hipp
2cho suppl. possis?
a
col. II
1a aj_l≥[
1 ejp≥[ f_[ 3 xa[
o_jp[
5 h[l≥[ t≥_[
col. I . . . . . .
]sqhn desunt nonnulla
].": . . . ] z_a[
] u≥j.[ . . . . . .
b
]amm≥[ ]i≥ka.[ ]povisai[ ]k≥lehdon≥[ 5 ].plokam[
]e≥sda≥jma[
]anqrwvp[
].umain[
]t≥e k≥ai; n≥.[
…noi…
…
…
…presagio…
5 …ricciol-…
…
…uom-…
…
...e...
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
317
c
a[
p[
s—u[
k[
5 t—.[
d
o≥u[
e;n≥[
s—ed[
pa[
e
kat[
m—hvm≥[
dwv.[
f
].in[
]hv.[
] k—a[
] tak≥[
5 ] t—a
g
m]erimna[
]g≥hn [
]a≥i≥ko≥[
]ai [
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
318
h
].o≥i plu.[ ]g≥etoc≥u≥[
]..∆av[
i
]kla≥[ ]uvs.[ ]ev≥s≥[
j
[.]dw.[
t≥o≥vlm[
k
].[ ]daqel≥[
]skevd[
l
].[ ].vran [
]. [
].ai [
5 ] [
] [
]n [
]
]
10 ]
]
]. ]
]on: ]
]
m
]rasqa.[ ]n [
] [
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
319
n
]efi≥.[ b]a≥silh≥.[ ]egad.[ ].os.[
o
.v]dh[
.v]k≥wsa[
]n:soi[ ].dhk.[
5 ]es≥i≥p≥p≥[ ].a≥l.[ ].essa[
].[.].[
p
]...[ ]za.[
] [
]udavma..[.v 5 ]oi'd.[
..v]t[
q
. . . ]i≥o[ Fr. 1
]e—≥vd[
]. kh[
].—[ . . . ]a.[ Fr. 2
] e—vs≥[
r ]tro[
].w.[ ].up.[ ]s≥ka≥[ 5 ].[
s
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
320
]s≥ki[ ]s≥on.[ .v]l≥.[ ]m≥a.[
5 ]p≥[ ]de[
].n≥[
t
].en≥[ ].eik.[ ]al≥[
u
]∙.y‚a≥±vm[
]ex≥a[
].a[
TEST (a) POxy. 1787 fr. 21, 31 ita disposita a Lobel-Page 1955, 61 in col. II ante
al[ coronis ║ (b) POxy. 1787 fr. 14 prim. rec. Diehl1 1923, 363 om. Lobel
1922 ║ (c) POxy. 1787 fr. 22 ║ (d) POxy. 1787 fr. 23 ║ (e) POxy. 1787 fr. 24 ║ (f)
POxy. 1787 fr. 25║ (g) POxy. 1787 fr. 30 ║ (h) POxy. 1787 fr. 39 ║ (i) POxy. 1787 fr.
42 ║ (j) POxy. 1787 fr. 43 ║ (k) POxy. 2166 (d) 2 prim. rec. Lobel-Page 1955,
63 om. Voigt 1971 ║(l) POxy. 2166 (d) 4 prim. rec. Lobe-Page 1955, 63
om. Voigt 1971 ║ (m) POxy. 2166 (d) 5 prim. rec. Lobel-Page 1955, 65
om. Voigt 1971 ║ (n) POxy. 2166 (d) 6 prim. rec. Lobel-Page 1955, 64
similia esse Sapph. 65, 5-7 uidit Treu 1976, 205, sed u. 4 alienum a Sapph. 65, 8
esse monuerunt Lobel-Page 1955, 64 ║ (o) POxy. 2166 (d) 7 prim. rec. Lobel-Page
1955, 64║(p) POxy. 2166 (d) 8 prim. rec. Lobel-Page 1955, 64 om. Voigt
1971║(q) POxy.2166 (d) 9 prim. rec. Lobel-Page 1955, 65 om. Voigt
1971║ (r) POxy. 2166 (d) 10 prim. rec. Lobel-Page 1955, 65 om. Voigt
1971║ (s) POxy. 2166 (d) 11 prim. rec. Lobel-Page 1955, 65 om. Voigt
1971║ (t) POxy. 2166 (d) 12 prim. rec. Lobel-Page 1955, 65 om. Voigt
1971║(u) POxy. 2166 (d) 13 prim. rec. Lobel-Page 1955, 65 om. Voigt
1971
CRIT (b) 2 ]i≥ka.[ : ]i≥kai≥[, i.e. ]i≥ kai;[ Hunt 1922, 34-35, rec. Diehl1 1923, 363 : ]i≥ka.[
Lobel-Page 1955, Voigt 1971, 95-96 ║3 poi–sai±, i.e. ]poi" ai[[ Hunt 1922, 34-35, rec.
Diehl1 1923, 363 : povisa±i Lobel-Page 1955, 61, Voigt 1971, 95-96 ║4 ]k≥lehdon≥[, i.e.
]k≥levhi don[, vel ]k≥levhi d∆ojn[? Hunt 1922, 44 : k≥lehdon≥ forma epica cog. Voigt 1971,
95-96 ║5 ]. : ]i≥, ]n≥ vel simm. leg. Lobel-Page 1955, 61, Voigt 1971, 95-96
║6]e≥sdaÑm≥a[ : ]e" d∆ ajm≥a[ Hunt 1922, 35, rec. Diehl11923, 363 : ]e≥sda≥jma[ Lobel-Page
1955,61 : ]e≥sd∆a≥jma[ Voigt 1971, 95-96 ║7 rwvp ║8 ].umain[ : ]l≥umain.[ Hunt 1922, 34-
35 : ]l≥umain[ Diehl1 1923, 363 : ].umain[ Lobel-Page 1955, 61, Voigt 1971, 95-96 : ]a≥,
]d≥, ]l≥ possis ║9 ]t≥ek≥aip≥[, i.e. ]te kai; p[ Hunt 1922, 34-35, rec. Diehl1 1923, 363
: ]t≥ek≥aip≥[ Lobel-Page 1955, 61, rec. Voigt 1971, 95-96 : ]t≥e k≥ai; n≥.[, potius quam ]t≥e
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
321
k≥ai; p≥.[ legendum ║ (f) 1 ante et supra litt. i ad sinistr. punctulum, aliud atramenti
uestigium ante i nullum ║ 2 post hv h. dextrorsum asc. initium ║ (g)1 m]erimna[
Hunt 1922, 38-39 ║3 ]..ko≥[ Hunt 1922, 38-39: ]a≥i≥ko≥[ Lobel-Page 1955, 62 ║ (h) 1
].o≥iplu.[ pap. : ].o≥i plu.[ Hunt 1922, 39 : ].o≥iplu.[ Lobel-Page 1955, 62 ║ 3 ]u≥p≥∆av[, i.e.
]ujp∆a[[ Hunt 1922, 40 : ]..∆av[ Lobel-Page 1955, 62 ║(k) 3]skevöd[ ║ (l) "inter 3 et 4
spatium solito latius, uersui tamen non sufficiens" Lobel-Page 1955, 63 ║2 ].v vel .v]. ║3]. : i, sed etiam u possis ║4 ]. : circuli partem dextram leg. Lobel-Page 1955,
63 ║(m) 1 i≥[ possis ║ (n) 1 .[ : h. dextrorsum asc. initium ║2 suppl. Lobel-Page
1955 in Verborum Sapphicorum Indice, p. 301 fort. a[ ║ (o) 4]. : uix legi potis est,
sed fort. ]a≥vi≥ legendum censuerunt Lobel-Page 1955, 64 et Voigt 1971, 95-96 .[ : h.
dextrorsum asc. initium ║ 5 Telesippae nomen hic agnoscendum esse censuit Treu
1976, 174 ║ 6 .[ : h. dextrorsum asc. initium ║7 ]. : fort. a siue l legendum
censuerunt Lobel-Page 1955, 64║(p)1 littera secunda e siue s, cuius restat tantum pedis
hamati pars extrema .[ : initium h. dextrorsum asc. ║2 .[ : h.longius infra lineam
desc. pars. inf., fort. f censuerunt Lobel-Page 1955, 64 ║3 spatium uacuum, ut uid.
║4 ma suprascriptum post dav, si litt.duae, magis solito condensae:
fort. se uel te legendum censuerunt Lobel-Page 1955, 64║ .[ : h. dextrorsum
ascendentis initium ║ (q) inter (Fr. 1) et (Fr. 2) fort. uersum nullum esse censuerunt
Lobel-Page 1955, 65║(r) 2 ]g≥ uel ]t≥ censuerunt Lobel-Page 1955, 65 m≥[, n≥[, p≥[ simm. Lobel-Page 1955, 65 ║3 ]. : punctulum crassum, fort. k uel c rami sup.
partem extremam, sed fort. uestigia litterae non esse censuerunt Lobel-Page 1955, 65
fort. r≥[ legendum censuerunt Lobel-Page 1955, 65 ║5 d siue l apicem ueri sim.
censuerunt Lobel-Page 1955, 65║(s) 2 .[: h.u. ║7 fort. ]e≥ legendum censuerunt
Lobel-Page 1955, 65║ (t)1 ]g≥, ]t≥, sim. Lobel-Page 1955, 65 ║2 ]. : h. a sin. uenientis
partem extremam leg. Lobel-Page 1955, 65 .[ : h. dextrorsum asc. initium leg.
Lobel-Page 1955, 65║ (u) 1 litteram deletam fort. t fuisse censuerunt Lobel-Page 1955,
65 etiam litt. a mutatam esse crediderunt Lobel-Page 1955,65 ║3 fort.
]n≥ Lobel-Page 1955, 65
b
1 ]amm≥[ andrà inteso o come una forma del pronome eolico a[mme" (attestato in
Sapph. 5.7; 21.12; 24a.3; 27.6; 38; 90 a, col. II 12; 90 a, col. II 15; 94.26; 121.1; 147;
Alc. 6.2; 6.25; 48.17; 69.3; 70.8; 73.11; 129.24; 179.4; 208a.3; 305a.22; 306 A b.19;
314.1; 315; 353.1; 361; 362.4; 391; inc. auct. 3), oppure dell’aggettivo possessivo eolico
a[mmo" (= hJmevtero"), per cui cfr. Sapph. DV zV 4 = 71.4 V. a[mma[i", integrato da Ferrari
(2007b, 19); Alc. 6.18 a[mmo" qu'm[o" (supplemento di Diehl 1944, 24); 66.8 aj povli"
a[mma "la nostra città"; 302c.2; 394 patevrwn a[mmwn.
2 ]i≥ kai;[ viene trascritto da Hunt (1922, 34-35), ma la traccia della quarta lettera è
troppo esigua per essere identificata correttamente: potrebbe anche non essere uno iota.
3 Tra l’omicron e lo iota di ]poisai[ è posto, nell’interlinea, un tratto non proprio
obliquo, ma si deve trattare di una accento; sull’alpha, invece, è ben visibile il simbolo di
breve.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
322
4 ]k≥lehdon≥[, proposto dalla Voigt (1971, 96), è la lettura più verosimile. La forma
klehd- è epica, ma è attestata solo due volte in Omero, sempre nell’Odissea: Od. XVIII
117 w}" a[r∆ e[fan, cai'ren de; klehdovni di'o" jOdusseuv" "così dissero; e gioì a
quell’augurio il luminoso Odisseo"; XX 120 w}" a[r∆ e[fh, cai'ren de; klehdovni di'o"
jOdusseuv" "così disse; e gioì a quell’augurio il luminoso Odisseo". La forma klhhd-,
anche essa epica, è attestata, invece, una sola volta in Omero e sempre nell’Odissea (IV
317, Telemaco si rivolge a Menelao: h[luqon ei[ tinav moi klhhdovna patro;"
ejnivspoi" “giunsi, se mai tu mi dica qualche notizia del padre”), ma di essa si conta una
attestazione anche nell’epica ellenistica (Ap. Rh. III 392 qespesivhn oi[sw klhhdovna
“diffonderò una fama meravigliosa”). Per l’uso del più diffuso klhdwvn nella lirica e
nella giambografia arcaica cfr. Sim. 11.3 eujrei'an klhdovna “vasta fama”; Hippon. fr.
28.4 W.2 au{th gavr ejsti sumforhv te kai; klhdwvn “questa è una sventura ed un
malaugurio”. La presenza di una forma epica in una poesia lirica può sembrare una
stranezza, ma si è visto che questo è ciò che accade anche altrove in Saffo.
5 Per plovkamo" cfr. Sapph. DV kdV = 80.5 V. p]loka[m, supplemento di Hunt
(1922, 35).
6 Per ajnqrwvp[ cfr. Sapph. 16.7 kavl≥l≥o≥"≥ [ajnq]r≥wvpwn “bellezza degli uomini (sc.
umana); 16.22 ajnqrwp[; 24c.7 ]anqrw[; 27.13 aj]nqrw[p (suppl. Hunt); DV kdV
a[n[qrwp]o≥"≥, supplemento di Enzo Puglia (apud Ferrari 2007a, 25-26); 129b h[
tin∆a[llon ajnqrwvpwn e[meqen fivlhsqa “o ami qualcun altro degli uomini (più) di
me”.
8 ].umain[ è chiaramente leggibile sul papiro: prima della u è possibile scorgere
l’ultimo tratto inferiore di un’asta obliqua discendente, una traccia, questa, che fin dalla
editio princeps è stata interpretata (e non senza ragione) come un lambda: il testo di
Hunt (1922, 34-35) fu accolto, seppur con una differenza quasi impercettibile (Hunt
leggeva la traccia di un’altra lettera dopo il n, ma tutti gli altri editori, giustamente, non
lo hanno seguito), anche dal Diehl1 (1923, 363), che trascrisse direttamente a testo
]l≥umain[, istituendo il confronto con Sapph. DV kaV a.3 [=77 a.3 V.] ].≥main[ (l]u≥main[
Diehl1 1923, 363), ma su tutto ciò v. supra ad loc. Anche se non certa, ]l≥umain[ di Hunt
rimane oggi la lettura più verosimile: questo verbo, tuttavia, non è mai attestato altrove
nei frammenti di Saffo e di Alceo a noi giunti.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
323
9 Per ]t≥e k≥ai; n≥.[, suddivisione non certa, ma probabile cfr. Alc. 306(14) col. II.16
povlla te kai; qama≥[; Alc. 391 o[ttine" e[sloi ujmmevwn te kai; ajmmevwn “chiunque
di voi e di noi sia valoroso”. Lobel-Page (1955, 61) e Voigt (1971, 95-96) usano, forse,
troppa cautela a scrivere ]t≥ek≥aip≥[ senza divisione tra le parole. Dopo il kai;, se
l’attestazione di questa congiunzione è confermata, sono presenti tracce di almeno due
lettere e non di una soltanto come hanno dedotto gli altri editori. La prima lettera viene
letta da tutti gli editori precedenti come un p≥, ma anche un n≥ potrebbe essere una lettura
giusta, soprattutto qualora si raffronti questa lettera con gli altri p dello stesso frustolo:
questi ultimi hanno tutti aste verticali piuttosto diritte, mentre l’asta verticale di questa
lettera non è diritta, ma obliqua e dotata di un breve ricciolo nella parte inferiore. Di
questa ultima lettera leggibile è interessante notare anche un ultimo dettaglio:
dall’estremità in alto dell’asta sembra iniziare un brevissimo tratto obliquo, che non può
certo far pensare ad un p≥, ma ad un n≥. Il confronto con il n≥ finale del verso precedente
non può che confermare la validità di una simile lettura: n≥.[ invece di p≥[. E dopo il
supposto n≥ compare, piuttosto in alto e quasi nell’interlinea, una traccia puntiforme:
dovrebbe trattarsi di un’altra lettera o di un accento, sfuggita agli altri editori, tranne che
ad Hunt, ma costui la prendeva in considerazione, a quanto pare, per il verso precedente,
ma è troppo distante dal verso precedente per essere la traccia di una littera caudata.
g
1 Per m]erimna[, integrazione di Hunt (1922, 38-39) cfr. Sapph. 1.25-26 calevpan
de; lu'son / ejk merivmnan “liberami dagli angosciosi / affanni”; 23.8 ]paivsan kev me
ta;n merivmnan “che me da tutti gli affanni”; Sapph. DV eV 8 = 86.8 V. ca≥levpai
m≥[erivmnai “per un’ansia opprimente“; Sapph. DV iV b.3 = 68 b.3 V. ]m≥oi cavlep≥[ai
mevrimnai “…a me penosi affanni”.
n
Pur nella sua esiguità, questo frammento è stato oggetto di molte discussioni dal
momento in cui Max Treu (1976, 205) si è accorto che il suo testo corrisponde quasi
completamente a quello presentato ai vv. 19-22 da Sapph. DV eV = 65.5-8 V. (in
grassetto riportiamo il testo condiviso da entrambi i testimoni):
Yavpfoi, se fivl[ kuv]kl≥a s[oiv te
20 Kuvprw b≥[a]sivl[h j sev]mna kaiv toi mevga dw≥'[ron ]i≥ kat≥evn≥[ 22 o[]ssoi" faevqwn≥[ jAevlio"
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
324
Lobel-Page, che accolgono la scoperta di Treu, hanno notato che il quarto verso risulta
diverso nei due frammenti: tuttavia il POxy. 2166 (d) 6 presenta al quarto verso ]os.[ e
Sapph. DV eV 22 ha o[]ssoi", seppur non nella stessa posizione.
Un simile fenomeno non poteva che destare l’attenzione degli studiosi, i quali si sono
interrogati sul suo perchè. Le spiegazioni che si possono dare non sono molte: (1) che
Saffo abbia riutilizzato in due poesie diverse dello stesso libro espressioni identiche o
simili; (2) che nello stesso luogo fossero stati gettati due papiri identici dello stesso
“libro quarto”, i cui frammenti si siano poi mescolati. La prima ipotesi è quella che ha
goduto più consensi: a favore di una possibile autocitazione si è espresso, ad esempio, il
Di Benedetto (1987, 44 n. 47; e cfr. anche Di Benedetto 2005, 14).
Abbiamo già visto come l’autocitazione avvenga in modo ricorrente nei frammenti a
nostra disposizione: è possibile, dunque, anche in questo caso, ipotizzare che Saffo stia
riutilizzando un’espressione che lei aveva già utilizzata in un’altra poesia dello stesso
libro IV.
2 b]a≥silh≥.[ è un’integrazione proposta nell’edizione Lobel-Page (1955, 301) non
nell’apparato di questo frammento ma nel Verborum Sapphicorum Index di fine volume.
o
5 In questo verso si ha l’unico segmento testuale di rilievo: secondo Treu (1976,
174) potrebbe celarvisi il nome di Telesippa, una delle eJtai'rai di Saffo secondo Suida
s.u. Sapfwv (S207): eJtai'rai de; aujth'" kai; fivlai gegovnasi trei'", jAtqiv",
Telesivppa, Megavra. Tuttavia, la certezza dell’attestazione del nome di costei in questo
frammento non può esserci, anche se l’integrazione sembra piuttosto probabile.
p
3 Vi è un palese spazio bianco sul papiro, ma non sembra possibile che anche
questo frammento rientri tra le odi in strofe tristiche col terzo verso più breve: il v. 6,
infatti, che in quel caso dovrebbe essre più breve dei due precedenti, sarebbe anche esso
bianco, ma così non è: non è possibile trovare una spiegazione, a meno che non si
ipotizzi che il v. 4 sia il primo verso di una nuova ode.
4 Si potrebbe pensare che questo frustolo testimoniasse Sapph. DV igV = 91 V.
ajsarotevra" oujdavma pw Ei[rana, sevqen tuvcoisan “(che)...non avendo mai incontrato
sinora una ragazza più fastidiosa di te, Irene”, ma se è valida la lettura proposta da
Lobel-Page (1955, 64), ovvero se o te dopo ]udavma, questa ipotesi non può che
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
325
cadere. La lettura del testo del papiro fornita da Edgar Lobel e Denys Page non è affatto
sicura, perché i limiti del frustolo non facilitano, certo, il compito. Comunque, se si
trattasse effettivamente di se o te, con la seconda ipotesi da preferire rispetto alla prima
a dispetto di ciò che sostengono Lobel e Page, dovrebbe essere il primo elemento di un
dittongo o dovrebbe essere seguito da due consonanti, altrimenti l’appartenenza al “libro
quarto” di Saffo o addirittura alla stessa poetessa verrebbe meno, per via della sequenza
di tre sillabe brevi, fenomeno estraneo alla metrica lesbia ed in particolare all’ipponatteo
acefalo con doppia espansione coriambica. Per il possibile o]ujdavma (non certo e per ora
non integrato da alcuno studioso) cfr. Sapph. DV igV = 91 V. ajsarotevra" oujdavma pw
Ei[rana, sevqen tuvcoisan “(che)...non avendo mai incontrato sinora una ragazza più
fastidiosa di te, Irene”; Sapph. 44 A a.11 V. ]e[ro" oujdavma pivlnatai “Eros mai si
accosta”.
lV(88 L.-P. = V.) metrum: [ ] [ ║
[ ] [ ║
[ ]
hippxcho
║ hippxcho
║ hippx-1cho
, fort. hipp2cho
║ hipp2cho
║ hippcho
suppl. possis?
a . . . ].[
]n≥ pr≥o≥..[ ]nw" pro;" povt≥[
4 ].aton cavla[
].qevloi". ouj duv[ ].avsdois∆ojlivga[
7 b ].evna fevresqa[i . . .
].fi≥a≥ tis≥...[ ejm[ ].d∆a[dion eijsor[
10 to≥u≥'[ o]i\sqa kau[ta: –
k[ lev l≥aq∆ajlloniav[ se[ ].an: ti≥rad[
13 hj[ ]a≥i≥ ti" ei[poi [–]
aj[ ].san: e[gw te gar[
filh≥[ ]m≥∆a \" ken e[nh m∆[
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
326
16 ka'l.[ ]a≥i melhvshn: – ejst.[ ]fivla fai'm∆ejcuvra ge≥v[ vnesqai .]c≥a≥[ ]ena[.]ai":ajt≥[
19 ]..d∆ojnivar≥[o]" [ . . .
]. pivkro" u[m[
].[.]ta≥.qa'd≥[ 22 ]≥.a≥ tovde d∆i[s≥[q(i)
].w[tti s∆ej.[ ]a filhvsw[
25 ]t≥w t≥i≥ lo[
]sson gar.[ ]s≥qai belevw[n
28 ]..[
. . .
...
...
...
4 ...
...vorresti: non poss- (?)...
…poco…
7 …esser portato…
…
…più dolce a vedersi…
10 …(lo) sai anche tu stessa…
…ha dimenticato…
…
13 …qualcuno direbbe…
…io infatti te…
amare…finchè vi sia in me respiro…
16 …avrò cura…
…dico di essere stata un'amica sicura…
…
19 …doloroso…
…amaro ugualmente…
22 …ma questo sappi…
…quello che (a?) te…
…amerò…
25 …
…meglio infatti…
…delle frecce…
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
327
TEST POxy. 2290 (ed. princ.: Lobel 1951a, 7-10) "fragmentum b sursum
deorsum mouere non licet; interuallum incertum nisi quatenus de metro coniectura
succedat" Lobel 1951a, 10 strophas trinorum uersuum, quorum tertius ceteris breuior,
agnovit Hamm1954, 455 (sed vide Voigt 1971, 96-97), rec. Lobel-Page 1955, 66-67
prim. rec. Lobel-Page 1955, 66-67
CRIT 1 h.v. pes ║2 ]n≥, cuius h. dext. tantum conspicua .[: litt. caudatae pars
inf. ║3 pov t≥[: h. h. pars extrema sin. ║4 ]. : h.h. cav fort.
cavla[ssai Voigt 1971, 97 ║5 ].: circuli arcus dex, fort ]o, sed a litt. q longinquum
quam exspect. censuit Lobel qe≥vloi"., e magna ex parte in lacuna qe≥loi"., ut. uid. u≥[ : tantum rami sin. cacumen fort. ouj du≥v[na leg. et suppl. (i.e. duv[naton vel simm.)? ║6]. : h.h. pars. extrema dext. summis litteris adaequata s∆ol
║7 ]. : restant tantum punctula duo, sed fort. h.u. uestigia, ]m≥ possis Lobel
1951,10 evna – ║8 i≥a≥: fort. tantum a male scr. censuerunt Lobel 1951, 10,
Lobel-Page 1955, 66-67, Voigt 1971, 96-97 ║9 ].: punctulum summis litteris
adaequatum fort. pa;]n d∆a[dion ? da–vd ║10 aujta–: ║11 ]l≥, sed
uix dispici potest : lev]l≥aq∆ Lobel 1951a, 9 iav[ : forma uoc. ijavomai censuit
Voigt 1971, 97 ║12 an:t║13 a≥vi≥ ║14 n:e [se Treu 1976, 8, 164, sed
gavr exspectandum censuit Voigt 1971, 97 : [sa;n uel [so;n Voigt 1971, 97
║15 filhvsw Voigt 1971, 97 : fivlh[n Di Benedetto ]m≥∆ evnhm∆ [aju?tma Treu 1976, 164 ║6 mg. sin. x ka'l, ut uid. hvshn: ║17 .[ : post t circoli arcus
pars media a'imecuv ║18a±i":║19 d∆o║20 suvm u[m[w" Di Benedetto
1987, 62 ║21 qa' ║22 -[q Lobel 1951, 9 : -[q(i) Voigt 1971, 97
║23 ]. : punctulum crassum summis litt. adaequ., ]k non adeo ueri sim. censuerunt
Lobel 1951, 10, Lobel-Page 1955, 66-67, Voigt1971, 96-97 wvttivs∆e eg≥[, ep≥[ : e[g≥[w Treu 1976, 8, 164 ║ 24 lhv" ║25 ]t≥ : tantum h.h., fort z possis
║26 kre]- Treu 1976, 164 ║27 ]s≥ : tantum arcus suprioris pars estrema
dext. de Dianae telis cog. Treu 1976, 164 ║28 ].–.[, ut uid.
Il testimone dell'ode, il POxy. 2290, è stato pubblicato per la prima volta da Edgar Lobel
nel 1951 (Lobel 1951, 7-10), all'interno del ventunesimo volume de "The Oxyrhynchus
papyri": il primo editore lo attribuì a Saffo, precisamente al IV libro, "on grounds of
dialect, metre and contents" e lo dotò di quelle paravgrafoi di cui era privo a causa di
guasti materiali. Prese a modello, dunque, i frammenti editi da Hunt quasi trenta anni
prima nel quindicesimo volume dei Papiri di Ossirinco, ovvero quelli del POxy. 1787:
una paravgrafo" ogni due versi, ovvero odi in strofe distiche. L'editio princeps di
Lobel fu sottoposta alla breve, ma attenta recensione di Eva-Maria Hamm (1954, 453-
456), colei che, poco meno di venti anni dopo e con il nome di Eva-Maria Voigt,
avrebbe pubblicato una nuova edizione di Saffo e che in quel periodo stava preparando
la sua Grammatik zu Sappho und Alkaios. La Hamm (1954, 455), appunto, fu la prima
ad accorgersi che la disposizione delle paravgrafoi operata da Lobel non era corretta e
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
328
che i versi 7, 10, 13 e 16 sembravano essere più brevi degli altri (offenbar kürzer als die
übrigen): si doveva trattare, dunque, non di strofe distiche, ma tristiche, con il terzo
verso più breve dei primi due. L'argomentazione non era banale e poteva portare, anche,
ad attribuire questo frammento ad un altro libro, senonchè Gallavotti notò, pur non
potendo averne la certezza, che anche alcuni frammenti del POxy. 1787 potevano essere
ricondotti ad una tale struttura. Lobel, al momento di preparare la nuova edizione di
Saffo e di Alceo, stavolta in collaborazione con Denys Page (Lobel-Page 1955, 66-67),
accolse le argomentazioni della Hamm e modificò la posizione delle paravgrafoi nel
testo critico. L'ode è, dunque, in strofe tristiche, ma la struttura metrica non è definibile
con precisione, a causa della mancanza della parte centrale di tutti i versi: i primi due di
ogni strofe dovrebbero essere ipponattei acefali con x espansioni coriambiche
(choriambisch erweitertes Hipponakteum, nella terminologia usata da Hamm 1954,
455), mentre il terzo verso un ipponatteo espanso con un coriambo in meno degli altri
due, ovvero hippxcho
║ hippxcho
║ hippx-1cho
.
4 L'ode è in parte restituibile solamente a partire dal quarto verso. La Voigt (1971,
97) propone di integrare cavla[ssai, per cui cfr. Alc. 70.10 V. calavssomen de; ta;"
qumobovrw luva" / ejmfuvlw te mavca", tavn ti" jOlumpivwn / e[nwrse, da'mon me;n eij"
ajuavta a[gwn / Fittavkwãià de; divdoi" ku'do" ejphvr[at]o≥n≥ "allentiamo la contesa che
divora l'animo, / la battaglia civile, che un Olimpio / suscitò, guidando il popolo alla
follia / e dando a Pittaco gloria amabile"; Alc. 208 A.9 cavlaisi d∆a[gkulai "si
allentano le sartie". Quel che precede aton è ben poco leggibile: si nota soltanto un'asta
verticale posta sul margine del frustolo e che è congruente con ]i≥, o ]n≥: se fosse un ]n≥ si
potrebbe integrare duv]n≥aton, dato l'infinito successivo, ovvero "possibile allentare", ma
la presenza di duvnaton è forse ipotizzabile anche per il verso successivo.
5 Per qe≥vloi" cfr. Sapph. 1.17 kw[tti moi mavlista qevlw gevnesqai / mainovlai
quvmwi "e che cosa, con l'animo folle, voglio che soprattutto avvenga per me"; 1.23-24
tacevw" filhvsei / kwjuk ejqevloisa "persto amerà / anche se non vuole"; 5.3 kw[ssa
Û]o≥i≥ quvmwãià ke qevlh gevnesqai / pavnta te]levsqhn "e quanti desideri nutre nel suo
animo che avvengano, che siano tutti compiuti"; 5.9 ta;n kasig]nhvtan de; qevloi
povhsqai / e[mmoron ]tivma" (e[mmoron Wilamowitz, v. supra) "e dell'onore voglia
rendere (partecipe) la sorella"; 26.9 ] sev, qevlw[ "te, voglio"; 45 a\" qevlet∆u[mme"
"finchè voi volete"; DV eV 10 = 60.2 V. (v.supra) ]qevl∆†wntapaivsan "(che) tu voglia tra
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
329
tutte"; DV eV 14 = 60.6 V. o[]ssa tuvchn qelhvsh" "tutto ciò che tu voglia ottenere"; DV
kV 4 = 76.4 V. qevlw[; DV laV fr. 1 col. II 10 = 90 a col. II 10 V. ] q≥ev≥loisa [ "volendo";
94.1 teqnavkhn d∆ajdovlw" qevlw "sinceramente vorrei esser morta"; 94.9 aij de; mhv,
ajllav s∆e[gw qevlw "e se no, io voglio farti ricordare"; 137.1 qevlw tiv t∆ ei[phn, ajllav
me kwluvei / ai[dw" "vorrei dirti una cosa, ma mi impedisce / il pudore". oudu≥[ del
papiro andrà probabilmente distinto in ouj du≥[ e si può integrare ouj duv≥[na-: viene subito
da pensare a ouj duvnaton gevnesqai del Carme della vecchiaia che occupa la stessa
sede metrica, senonchè questa espressione può essere integrata anche al verso
precedente. Per ouj duv≥[naton cfr., comunque, Sapph. 16.21 ].men ouj duvnaton
gevnesqai; DV gV 7 = 58.18 V. ouj duvnaton gevnesqai; Thgn. 626b tou'to ga;r ouj
dunatovn "ciò, infatti, non è possibile".
7 Probabile ]m≥evna.
9 Forse è possibile integrare pa;]n≥ d∆a[dion "tutto più dolce", espressione che
ricorre in un'altra ode di questo stesso quarto libro, ovvero in Sapph. DV hV 3 = 62.3 V.,
ma mai in alcun altro passo della "letteratura greca": potrebbe trattarsi di un'epressione
tipica.
10 Per o]i\sqa kau[ta cfr. Sapph. fr. 19.7 e]uj ga;r i[dmen (suppl. Hunt); DV eV 17
= 60.9 V. su; d∆eu\ ga;r oi\sqa; 94.8 oij~sqa gavr e l'integrazione [i[ste de;] tou'to del Di
Benedetto per il fr. DV dV 3 = 58.25 V., per cui v. supra. Saffo, dunque, si rivolge ad
un'interlocutrice femminile.
11 lev]l≥aq∆ è integrato da Lobel (1951, 9). Per Treu (1976, 164) sarebbe qui in
evidenza il tema del dimenticare (das Thema des Vergessens), a dire dello studioso
tedesco presente anche in Sapph. 75 D. [= Sapph. DV kV = 76 V.], 137 D. [= Sapph. 130
V.] [Ero" dhu\tev m∆oj lusimevlh" dovnei, / glukuvpikron ajmavcanon o[rpeton / *** /
[Atqi, soi; d∆e[meqen me;n ajphvcqeto / frontivsdhn, ejpi; d∆ jAndromevdan povthãià "di
nuovo mi agita Eros che scioglie le membra / dolceamara, invincibile creatura /***/
Attide, ti era odioso di me / darti pensiero, ma voli verso Andromeda"; 146 D. [=Sapph.
129 a V.] e[meqen d∆e[chisqa lavqan "e di me hai oblio". La sequenza di lettere ajlloniav[
è priva di senso: andrà distinta, come propone la Voigt (1971, 97) in a[llon ijav[, con ijav[
inizio di una forma verbale di ijavomai? ijavomai non è altrove attestato in Saffo ed Alceo.
14 Treu (1976, 8, 164) propone di integrare [se, retto dal fivlh≥[ del verso successivo,
ma la Voigt (1971, 97) nota che con l'enclitico [se occorrerebbe l'accento acuto sul gar
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
330
precedente: perciò l'editrice integra [sa;n o [so;n, riferendolo a qualche sostantivo
presente, ipoteticamente, al v. successivo. Per Di Benedetto (1987, 63 n. 62) quello della
Voigt è un argomento inconsistente: il comportamento degli scribi in "questioni" di tal
sorta è piuttosto variabile e non sottoposto ad alcuna norma di comportamento univoca:
gar è presente anche al v. 26 e lì non porta alcun accento, ma non sappiamo cosa
seguisse: la stessa Voigt scrive ga;r in quel caso, ma porre l'accento grave è rischioso.
Per queste ragioni Di Benedetto, condivisibilmente, accetta gavr [se di Treu.
15 La Voigt propone di integrare filh≥v[sw, ma come nota Di Benedetto (1987, 63 n.
63), si tratta di un'operazione "molto problematica": nel "Conspectus metrorum" (Voigt
1971, 19) l'editrice trascrive, per questo metro, ║ ed appare
subito chiaro, dunque, che filh≥[ vsw non può essere integrato in quella sede. Di
Benedetto propone, dunque, di integrare solamente un –[n, ovvero di intendere fivlh≥[n,
che non crea problemi metrici. Treu (1976, 164) integra [ajuvtma e propone il confronto
con Il. IX 609 (= X 89) sg. eij" o{ k∆aju>tmh; / ejn sthvqessi mevnhi kaiv moi fivla
gouvnat∆ojrwvrhi "finchè permanga respiro / nel petto ed a me le care ginocchia si
levino". Di Benedetto accetta l'integrazione di Treu: per lui ha "molta verosimiglianza".
Espressioni simili sono attestate in altre poesie di Saffo: Sapph. 9.6 V. ]..a\" a[.[, dove il
senso si ricava dalla glossa interlineare, posta sul testimone (POxy. 2289), e{w" zw'
(ewszw pap.), ma cfr. anche Sapph. 4.5 V. ]a\" ken h\ moi (]a" pap. : ]a\" Bergk4)
"finchè sia a me". Per a\" cfr. Sapph. 9.6 ]..a\" a[.[ "finchè"; 22.11-12 a\"≥ se dhu \te
povqo" t≥. [ / ajmfipovtatai "finchè nuovamente il desiderio intorno a te … / voli"; 45
a\" qevlet∆u[mme" "finchè voi volete"; Alc. 74, 6 (q)a'" e[ti t]o; xuvlon; 117b.19 a\";
118.20 a\" ijm[; cfr. Sapph. 25.3 ]nua'sep[ e Alc. 77 col.II.5 ]a'so[.
17 Per ejcuvra cfr. Alc. 6.8 ej" d∆e[curon livmena drov[mwmen "corriamo ad un porto
sicuro", dove si riferisce ad un porto. Spesso nella tradizione manoscritta ejcurov"
alterna con ojcurov": i due aggettivi hanno lo stesso significato. Per ejcurov" / ojcurov"
usato in riferimento a persone cfr. Aeschl. Pers. 76sgg. pezonovmoi" e[k te qalavssa" /
ojcuroi'" pepoiqw;" / stufevloi" ejfevtai" "su comandanti terrestri, anche per il mare /
validi avendo confidato, / crudeli"; Plu. Sol. I 6 pro;" tou;" kalou;" oujk h\n ejcuro;" oJ
Sovlwn "Solone non era forte di fronte ai belli" (i.e. "aveva un debole per i belli").
19 ojnivaro" (= ajniarov") può essere riferito sia ad uomini o animali, sia ad oggetti,
azioni o sensazioni. L'aggettivo è riferito agli uomini in Od. XVII 220 ph'i dh; tovnde
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
331
molobro;n a[gei", ajmevgarte subw'ta, / ptwco;n ajnihrovn, daitw'n ajpolumanth'ra;
"dove porti questo parassita, misero porcaio, / mendicante molesto, divoratore d'avanzi
dei pasti?"; XVII 377 ptwcoi; ajnihroiv, daitw'n ajpolumanth're" "mendicanti molesti,
divoratori d'avanzi dei pasti". Per la seconda possibilità cfr. Od. II 190 aujtw'i mevn oiJ
prw'ton ajnihrevsteron e[stai "prima di tutto per lui sarà più penoso"; Hes. fr. 75, 24 ]
d∆ajnihro;n a[eqlon; Tyrt. 10.4 W.2 th;n d∆aujtou' prolipovnta povlin kai; pivona"
a[grou" / ptwceuvein pavntwn e[st∆ajnihrovtaton "ma l'aver lasciato la propria città ed
i grassi campi / e mendicare è più di tutto penoso"; Sol. 13.15 W.2 ajnihrh; de; teleuta'i
"(rovina) penosa alla fine"; Archil. fr. 12 W.2 †kruvptomen ajnihra; Poseidavwno"
a[nakto" / dw'ra "nascondiamo del sire Poseidone penosi / doni"; Thgn. 124 eij de;
fivlou novo" ajndro;" ejni; sthvqessi lelhvqhi / yudro;" ejwvn, dovlion d∆ejn fresi;n
h\tor e[chi / tou'to qeo;" kibdhlovtaton poivhse brotoi'sin, / kai; gnw'nai pavntwn
tou't∆ajnihrovtaton "ma se si nasconde nel petto di un amico un animo / che è falso e nei
precordi ha un cuore ingannatore, / questo è ciò che di più ingannevole il dio creò per
gli uomini / e scoprirlo è più penoso di tutto". Dubbi sussistono sulla scansione della
parola: difatti in Omero si trova ajni–hr-, ma altrove (ad es. nei due passi di Tirteo e
Teognide sopra citati) si ha ajni±hr-/ ajni±a –r-: entrambe sono possibili e la condizione
estremamente frammentaria dell'ode certo non ci aiuta.La presenza di questo aggettivo fa
intravedere, dunque, qualcosa di spiacevole e questo dato sembra confermato
dall'aggettivo a cui Saffo ricorre nei verso successivo, pivkro".
20 Per pivkro" in Saffo cfr. Sapph. 15b.9 Kuv]pri ka[iv s]e pi[krot∆..]a≥n ejpeuvr[oi
"Cipride e possa trovarti più aspra…", dove è riferito a Dorica. Cfr. Alc. 42.3 ejk sevqen
pivkron "da te l'amaro…"; Alc. 303Ac.18 pivk.[. Di Benedetto (1987, 62) propone di
integrare u[m[w", per cui cfr. Sapph. DV gV 11 = 58.21 V. ajll∆au[ton u[mw" e[marye "ma
tuttavia se lo prese…"; DV iV 2 = 68 a.2 V. u[]mw" de[gen[to (v. supra); Alc. 1.14 u[mw[.
22 tovde d∆ i[s[q(i) era già stato usato da Saffo nel primo libro, per cui cfr. Sapph.
23.7 tovde d∆ i[s[qi] ta;i sa'i "e questo sappi nel tuo (cuore?)…", che è un parallelo
certo più diretto di Archil. fr. 113.9 i[sqi nu'n, tavd∆i[sqi, fornito da Tedeschi (2005, 88 n.
399) Per espressioni simili cfr. o]i\sqa kau[ta del v. 10 (v. supra) e Sapph. fr. 19.7 e]uj
ga;r i[dmen (suppl. Hunt); DV eV 17 = 60.9 V. su; d∆eu\ ga;r oi\sqa; 94.8 oij~sqa gavr e
l'integrazione [i[ste de;] tou'to del Di Benedetto per il fr. DV dV 3 = 58.25 V., per cui v.
supra: "gibt es unzählige Parallelen" (Treu 1976, 164).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
332
24 Saffo sembra assicurare che anche in futuro amerà: questa affermazione è, per Di
Benedetto (1987, 62-63) da porre sullo stesso piano di ]fivla fai'm∆ ejcuvra ge≥v[ vnesqai
"affermo di essere stata un'amica fidata" del v. 17 e, soprattutto, di e[gw te gar[ se /
fivlh≥[n ]m≥∆a \" ken e[nh m∆[ aju?tma "ed io, infatti, / (ho intenzione di)
amarti…finchè in me sia respiro" (suppl. Treu, Di Benedetto: cfr. ad loc.) dei vv. 14-15.
Tutte queste affermazioni, per Di Benedetto, si porrebbero in contrasto con la situazione
negativa che sembra possibile dedurre dai pochi lacerti dei vv. 19-22: tuttavia, abbiamo
a disposizione informazioni troppo scarse per trarre simili conclusioni.
26 Treu (1976, 164) integra krev]sson gar.[, deducendolo da Sapph. DV laV Fr. 3,
20 = 90b.20 V. ]k≥revsson ga;[r, per cui v. infra.
27 Treu (1976, 9) traduce questo passo così: "…den besser…/ (von der Artemis)
Geschossen (bezwungen) liegen…", "…infatti meglio sarebbe.../ giacere, una volta vinti
dalle frecce di Artemide", ovvero Saffo farebbe riferimento alla tradizione mitologica
che vede Artemide munita di arco e di frecce a cui ricorrere specialmente contro le
donne, per cui cfr. Il. XXI 483sgg. pw'" de; su; nu'n mevmona",kuvon ajdeev",ajntiv∆ejmei'o /
sthvsesqai; calephv toi ejgw; mevno" ajntifevresqai / toxofovrwi per ejouvshi, ejpei;
se; levonta gunaixi; / Zeu;" qh'ken, kai; e[dwken kataktavmen h{n k∆ejqevlhisqa. "come
hai potuto, cagna sfrontata, desiderare di / opporti a me? Il mio furore è duro per te da
affrontare, / pur essendo armata di arco, poiché una leonessa tra le donne / Zeus ti ha
reso ed ha concesso di uccidere quella che vuoi"; Pi. P. III 7sgg. to;n me;n eujivppou
Fleguva qugavthr / pri;n televssai matropovlwi su;n jElei- / quivi,damei'sa crusevoi"
/ tovxoisin u{p∆ jArtevmido" "la figlia di Flegia dai bei cavalli / prima di concepirlo con
l'aiuto d'Ilizia / che assiste le madri, domata dagli aurei / dardi di Artemide". Celebre il
mito di Niobe. Niobe era figlia di Tantalo e sorella di Pelope. Sposò Anfione e gli diede
un numero imprecisato di figli (sette figli e sette figlie per i mitografi, sei figli e sei figlie
per Omero, dieci figli e dieci figlie nella tradizione tragica) e comunque superiore ai due.
Niobe, così, potè vantarsi di avere più figli di Latona e quest'ultima, adiratasi, chiese ad
Apollo ed ad Artemide, i due suoi unici figli, di vendicare l'offesa: Artemide uccise le
figlie femmine, Apollo i maschi, secondo il racconto di Il. XXIV 599-618: uiJo;" me;n dhv
toi levlutai, gevron, wJ" ejkevleue", / kei'tai d∆ ejn lecevess∆: a{ma d∆ hjoi'
fainomevnhfin / o[yeai aujto;" a[gwn: nu'n de; mnhswvmeqa dovrpou. / kai; gavr t∆
hju?komo" Niovbh ejmnhvsato sivtou, / th'i per dwvdeka pai'de" ejni; megavroisin
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
333
o[lonto, / e}x me;n qugatevre", e}x d∆ uiJeve" hJbwvonte". / tou;" me;n jApovllwn pevfnen
ajp∆ ajrgurevoio bioi'o / cwovmeno" Niovbhi, ta;" d∆ [Artemi" ijocevaira, / ou{nek∆ a[ra
Lhtoi' ijsavsketo kalliparhviwi: / fh' doiw; tekevein, hJ d∆ aujth; geivnato pollouv":
/ tw; d∆ a[ra kai; doiwv per ejovnt∆ ajpo; pavnta" o[lessan. / oiJ me;n a[r∆ ejnnh'mar
kevat∆ ejn fovnwi, oujdev ti" h \en / katqavyai, laou;" de; livqou" poivhse Kronivwn: /
tou;" d∆ a[ra th'i dekavthi qavyan qeoi; Oujranivwne". hJ d∆ a[ra sivtou mnhvsat∆,
ejpei; kavme davkru cevousa. / nu'n dev pou ejn pevtrhisin ejn ou[resin oijopovloisin /
ejn Sipuvlwi, o{qi fasi; qeavwn e[mmenai eujna;" / numfavwn, ai{ t∆ ajmf∆ jAcelwvi>on
ejrrwvsanto, / e[nqa livqo" per ejou'sa qew'n ejk khvdea pevssei. "tuo figlio è liberato,
vecchio, come ordinavi, / giace sul letto: contemporaneamente l'Aurora che appare /
vedrai, conducendolo via. Ora pensiamo alla cena. / Ed infatti anche Niobe dalla bella
chioma si ricordò di mangiare, / seppure a lei morirono in casa dodici figli, / sei
femmine e sei figli nel fiore della gioventù. / Gli uni li uccise Apollo con l'arco
d'argento, / irato con Niobe, le altre Artemide saettatrice / perché Niobe si andava
paragonando a Latona dalla bella guancia: / diceva che due soli ne aveva partoriti e lei
tanti, / ma quelli, pur essendo due soli, li uccisero tutti. / Essi per nove giorni giacquero
nella strage e non c'era qualcuno / per seppellirli, ma il figlio di Crono aveva reso
pietre le genti:/ il decimo giorno li seppellirono gli dei celesti. / E lei, Niobe, poi che si
sfinì versando lacrime, si ricordò di mangiare. / Ed ora da qualche parte, tra le rocce,
tra i monti deserti, / sul Sipilo, dove dicono essere la dimora delle ninfe / divine che
danzano intorno all'Acheloo, / là, pur essendo pietra, cova i dolori inflitti a lei dagli
dei". Il mito di Niobe è raccontato da molte fonti, ma per brevità non possiamo riportare
il testo greco di tutte, ma cfr., almeno, Apoll. Bibl. III 5.6; Ael. Hist. Varia XII 36; Diod.
Sic. IV 74:
Apoll. Bibl. III 5, 6 gamei' de; Zh'qo" me;n Qhvbhn, ajf∆ h |" hJ povli" Qh'bai, jAmfivwn de; Niovbhn th;n Tantavlou, h} genna'i pai'da" me;n eJptav, Sivpulon Eujpivnuton jIsmhno;n Damasivcqona jAghvnora Faivdimon Tavntalon, qugatevra" de; ta;" i[sa", jEqodai?an (h] w{" tine" Nevairan) Kleovdoxan jAstuovchn Fqivan Pelopivan jAstukravteian jWgugivan. JHsivodo" de; devka me;n uiJou;" devka de; qugatevra", JHrovdwro" de; tevssara" me;n a[rrena" trei'" de; qhleiva", {Omhro" de; e}x me;n uiJou;" e}x de; qugatevra" fhsi; genevsqai. eu[tekno" de; ou\sa Niovbh th'" Lhtou'" eujteknotevra ei\pen uJpavrcein: Lhtw; de; ajganakthvsasa thvn te [Artemin kai; to;n jApovllwna kat∆ aujtw'n parwvxune, kai; ta;" me;n qhlei va" ejpi; th'" oijkiva" katetovxeusen [Artemi", tou;" de; a[rrena" koinh'i pavnta" ejn Kiqairw'ni jApovllwn kunhgetou'nta" ajpevkteinen. ejswvqh de; tw'n me;n ajrrevnwn jAmfivwn, tw'n de; qhleiw'n Clwri;" hJ presbutevra, h|i Nhleu;" sunwvikhse. kata; de; Televsillan ejswvqhsan jAmuvkla" kai; Melivboia, ejtoxeuvqh de; uJp∆ aujtw'n kai; jAmfivwn. aujth; de; Niovbh Qhvba" ajpolipou'sa pro;" to;n patevra Tavntalon h|ken eijj" Sivpulon, kajkei'
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
334
Dii; eujxamevnh th;n morfh;n eijj livqon metevbale, kai; cei'tai davkrua nuvktwr kai; meq∆ hJmevran tou' livqou. Zeto sposa Tebe, dalla quale la città (si chiama) Tebe. Anfione sposa Niobe, figlia di
Tantalo, che partorisce sette figli (Sibilo, Eupinito, Ismeno, Damasittone, Agenore,
Fedimo e Tantalo) e figlie in ugual numero: Etodéa (secondo alcuni Neèra), Cleodossa,
Astioche, Ftia, Pelopia, Asticrazia, Ogigia. Esiodo dice che ebbe dieci figli e dieci figlie,
Erodoro quattro maschi e tre femmine, Omero sei figli e sei figlie. Niobe, che era dalla
bella prole, disse di essere di prole più numerosa di Latona e quest'ultima, irritatasi,
incitò Artemide ed Apollo contro di loro: Artemide uccise con l'arco le femmine in casa,
Apollo uccise i maschi che erano insieme a caccia sul Citerone. Dei maschi si salvò
Anfione, delle femmine, invece, la maggiore, Cloride ed a lei andò in sposo Neleo.
Secondo Telesilla si salvarono Amicla e Melibèa ed anche Anfione fu colpito a morte
dalle frecce. E Niobe, lasciata Tebe, giunse al Sibilo, presso il padre Tantalo e lì, dopo
aver pregato Zeus, si trasformò in pietra e lacrime scorrono via dalla pietra, di notte e di
giorno.
Ael. Hist. Varia XII 36 ejoivkasin oiJ ajrcai'oi uJpe;r tou' ajriqmou' tw'n th'" Niovbh" paivdwn mh; sunavidein ajllhvloi". {Omhro" me;n e}x levgei a[rrena" kai; tosauvta" kovra", Lavso" de; di;" eJpta; levgei, JHsivodo" de; ejnneva kai; devka, eij mh; a[ra oujk eijsi;n JHsiovdou ta; e[ph, ajll∆ wJ" polla; kai; a[lla katevyeustai aujtou'. jAlkma;n devka fhsiv, Mivmnermo" ei[kosi, kai; Pivndaro" tosouvtou".
Gli antichi, a riguardo dei figli di Niobe, sembrano non concordare tra loro. Omero [Il.
XXIV 603] afferma che erano sei i maschi ed in ugual numero anche le femmine, mentre
Laso [fr. 5 P.] che erano due volte sette ed Esiodo [fr. 183 M.-W.] diciannove, a meno
che i versi epici non siano di Esiodo, ma come molti altri siano stati falsamente attribuiti
a lui. Alcmane [fr. 75 P.], invece, afferma che erano dieci, Mimnermo [fr. 19 W.2] venti
e Pindaro [fr. 52 Sn.-M.] altrettanti.
Diod. Sic. IV 74 touvtou d∆ ejgevneto Pevloy uiJo;" kai; Niovbh qugavthr: au{th d∆ ejgevnnhsen uiJou;" eJpta; kai; qugatevra" ta;" i[sa" [eujprepeivai diaferouvsa"]. ejpi; de; tw'i plhvqei tw'n tevknwn mevga fruattomevnh pleonavki" ejkauca'to kai; th'" Lhtou'" eJauth;n eujteknotevran ajpefaivneto. ei\q∆ hJ me;n Lhtw; kata; tou;" muvqou" colwsamevnh prosevtaxe tw'i me;n jApovllwni katatoxeu'sai tou;" uiJou;" th'" Niovbh", th'i d∆ jArtevmidi ta;" qugatevra". touvtwn d∆ uJpakousavntwn th'i mhtri; kai; kata; to;n aujto;n kairo;n katatoxeusavntwn ta; tevkna th'" Niovbh", sunevbh th;n proeirhmevnhn uJf∆ e{na kairo;n ojxevw" a{ma eu[teknon kai; a[teknon genevsqai.
Figlio di costui fu Pelope e Niobe la figlia; costei generò sette figli ed un numero eguale
di figlie, che si distinguevano per la bella apparenza. Poiché era molto orgogliosa per il
gran numero dei figli, spesso se ne vantava e dichiarava di essere più prolifica di Latona.
Poi Latona, adiratasi, secondo le leggende ordinò ad Apollo di colpire a colpi di freccia i
figli di Niobe ed ad Artemide le figlie. Costoro, avendo ubbidito alla madre ed avendo,
nella stessa circostanza, colpito con frecce la prole di Niobe, accadde che, in uno solo
momento, costei fosse madre dalla prole numerosa e senza figli.
E cfr. anche Soph. Ant. 822sgg.; El. 150sgg.; Eur. Phoen. 159 (et scholia ad locum);
Paus. I 21.3; II 21.9; V 11.2; XVI 4; VIII 2.5.7; Parth. Erot. 33; Ov. Met. VI 146sgg.;
Lact. Plac. Ad Statii Theb. III 191; Scholia in Plat. Tim. 22a; Tzetz. Ad Lyc. 111.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
335
Sappiamo che Eschilo aveva composto una tragedia intitolata Niobe, per cui cfr. Aeschl.
fr. 167b Radt. Per il mito di Niobe in Saffo, cfr. Sapph. 142 V. [= Ath. XIII 571d] Lavtw
kai; Niovba mavla me;n fivlai h\san e[tairai "Latona e Niobe erano care
compagne…"; 205 [= Gell. XX 7] Mira et prope adeo ridicula diuersitas fabulae apud
Graecos poetas deprenditur super numero Niobae filiorum. Nam Homerus pueros
puellasque eius bis senos dicit fuisse, Euripides bis septenos, Sappho bis nouenos,
Bacchylides et Pindarus bis denos, quidam alii scriptores tres fuisse solos dixerunt. "Si
rileva una diversità della storia sorprendente e quasi ridicola presso i poeti greci a
riguardo del numero dei figli di Niobe. Infatti Omero afferma che i figli e le figlie di lei
furono due volte sei, Euripide due volte sette, Saffo due volte nove, Bacchilide e Pindaro
due volte dieci, certi altri scrittori dissero che furono tre soli". Per Niobe nella poesia
greca arcaica non epica cfr. Bacchyl. Enc. fr. 7b.4 oujde; tlapenqh;" Niovba "né Niobe
afflitta".
laV (90 L.-P. =V.) metrum: in hipp2cho
lemmata quadrare vid. Lobel 1951b, 16
Fr.1
col. i
]e ]
10 ]iin ]n ] ].
col. ii
]c. . . . ].nti
n —[ ].esei na[ ].ontwn
5 e—n.[ ] Kuqerhva" trov-
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
336
fo"[ q]r≥e≥p≥≥t≥h v ejn a[lloi" de; qug≥[atevra (th'") jAfro]divt≥h" ei[rhke th;[n Peiqwv .[ ]h≥sefw≥neihm[ t —asallh[ ]. eJauth'" p≥r[osa-
10 govreue:u[m[ ].[.]q≥e≥loisa[..].[ ... q—ikonetr[ ]asin c[ ] a—[mmi ajgg[ ]tina[ ] daim[w]na≥q≥[ ].o≥ sun[ ] i[na h..pe.[ ]
15 leg∆o a[≥mme[ ] men[.].i>e[ ] dhe[.]p≥.s.[ ]. qelet≥e≥[ ]..fi o—n∙d‚tek[ ]tou
20 dunat[ ]e≥i≥mai∆ c—erre"[ ]kai; ka-
t∆ijdivan[ ].[ ]h≥" kai; pro;s th;[n mo]c≥qou'n[
t≥[.]"≥pro.[ ]tanu[ - 25 p —≥t≥erug.[ ].ato≥[
]o≥ fhsi;[ ].[
…
…
…
…
5 …di Citerea crea-
tura : …in altri passi,
invece, chiama Peitho figlia di Afrodite.
…
…di lei stessa dice-
10 va :…lei volendo…
…
a noi annunci-… divinità (immortale ?)…
affinchè…
15 di-…noi
volete…
…
20 (è ?) possibile…
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
337
mani…e secondo
la propria…e
alla…sofferent-…
…dalle ali
25 distese (Eroti?)…
…dice (che ?)
col. iii
[ .[ ajge-]
rwvcou[" a[gan ejcouv-] sa" gev≥ra".[
15 k —ai; Gurinn[ ta" toiauvta"≥ .[.]..[ e[-] g —w to; kavllo" ejpet.[ mevãsÃdon: tiv ga;r hjnem[ ei\nai kai; ajreth'" po≥[ ajl-]
20 la; mhvpote levgei o{ti o[ kavllei ≥ eujfhvmeisqa[
m —ooi zefuvr≥w p≥neuma[
soi; d∆an[em]o≥fovrhto[ ]n≥ondeka.[
25 ]" pai> ta'" m[ pro;"] jAndromev]d≥hn gevgra≥[ptai ] uJpo; jAnd[romevdh" ].i oujk eujn[ ]w≥arre.[
30 ]c≥htis[
…ar-
roganti…(donne) che hanno in eccesso
privilegio…
15 e Girinno….
tali (donne)…io
la bellezza…
più grande : che cosa, infatti, …
essere anche della virtù…ma
20 forse dice che…
per la bellezza onor-…
a me il soffio di Zefiro…
a te, invece, portato dal vento…
…
25 …figlia della… : contro
Andromeda è stato scritto.
…da Andromeda…
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
338
Fr. 2
].usa≥.[ ].nuna[ ].laght≥[ ]d≥iat≥[ Fr. 3
].[ ].[ ] [ ] [
5 ]o≥u≥t≥i≥.[ ]poihs≥..t.[ ]hq≥eia≥n.[
]ein:f[ ]..hb.[
10 ]slon [ ]d.[.]e≥∙m≥on‚[
]q≥w≥≥sa.[ ].wm[ ] :souan≥[
15 ]a{pax tout[ ]o≥u panta[
]prw'ton[ ].[.]oisproa[
]q≥anein[ 20 ]kr≥vesson ga[r …[5] non…[6]…fa-
…[7]…[8]…[9]…[10]…buono…[11]…[12]…[13]…[14]…[15]…una volta che quest-
…[16]…non (?) tutto…[17]…primo…[18]…[19]…morire…[20]…meglio, infatti,…
Fr. 4
]nome[.].[ ].tapu≥n≥.[
]menon:i>[ ]n≥ohmma a[ 5 ]e≥feroi.∆[ ]...[ ] .g≥≥≥[ …[4]…pensiero…[5]…portass- ( ?)…
Fr. 5 ]...[ ]ch≥ri [
]h≥ta [
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
339
]h≥sefo [ 5 ]upole≥[
].os≥th[ ]l≥i≥ga[
]wn p≥[ Fr. 6
].eil[ ].eif.[ ]..[
Fr. 7 ]ote≥los≥[
].oukai.[ ]onga[ ]ot≥..[ …[1]…fine (?)…[2]…(non? e?)..
Fr. 8
].hnar≥[ [ ] ].· ] .g.[ 5 ]n≥er[
Fr. 9
].[..].[ ]aut.[
]piap.[ ].tia≥[
Fr. 10 (a) Fr. 10 (b)
]." gar[ ].[ ]hket.[ [At]qi glu[k-
]latw".[ ]taen[ ].perisa[ ]s...[
5 ].iqum≥[ ].toth...[ ]o≥s fhsi;n a[ ]nu≥potou [ ].[
10 ]u[ ].i[ ].amenhn [ ]kai; carie≥.[
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
340
ejn tauvthi ]t≥h'i wjãiÃdh'ãià lev[gei o{ti 15 ] [Atqido"≥[
]auth"≥[ ].h b≥a≥qu≥[
].[
…[1]…come(?), infatti,… [2]…o dolce
Attide…[3]…[4]…[5]…[6]…[7]…dice…[8]…[9]…[10]…[11]…[12]…restare…[13]
…e grazios-…[14]…in questa ode dice che…[15]…di Attide…[16]…[17]…profond-
…[18]…
Fr. 11 Fr. 12
]nan :c.[ ]r≥i an≥h≥k.[ ].pl≥h≥.[ ]us≥taqei≥s≥[
].w≥.naig≥[ Fr. 13
].nr≥[ ].aigi≥[ ]n∙e‚a[ …[4] (dell’annima? della sorte?)…
]u≥ch" n≥[ 5 ]s≥i≥a" [
]i≥w≥[ Fr. 14
].[ ]taita≥[
]e≥shtoiit[ ]touti≥[
Fr. 15
]an.[ ]sth.[
Fr. 16
]dem[ ]un∆ot≥[ Fr. 17
]lh≥[ ].ra[ ]esq.[ ]tel.[
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
341
TEST POxy. 2293, editum a Lobel 1951b, 16-23 prim. rec. Lobel-Page 1955, 68-73
magna ex parte rec. Voigt 1971, 97-100 Fr. I (a) col. I, Fr. 2, Fr. 4, Fr. 5, Fr.
6, Fr. 7, Fr. 8, Fr. 9, Fr. 11-17 om. Voigt 1971, 97-100
CRIT Fr. I (a) col. ii 1 fort. ]c≥a≥[ leg. vid. Lobel 1951b, 17-18 ║2 fort. ].v legendum
vid. Lobel 1951b, 17-18, Lobel-Page 1955, 68-69, Voigt 1971, 97, 100 ║3 fort. ]c≥ legendum vid. Lobel 1951b, 17-18, Lobel-Page 1955, 68-69, Voigt 1971, 97, 100
║4 fort. ]u≥ legendum vid. Lobel 1951b, 17-18, Lobel-Page 1955, 68-69 : ]o≥, ]u≥ Voigt 1971, 98, 100 ║5 ãhoc quidem locoà interpr. Lobel-Page 1955, 68-69
║5-6 Kuqerhva" trov-/ fo" [ distinxit Lobel 1951b, 22, rec. Lobel-Page 1955, 68-
69, Voigt 1971, 98, 100 ║6 ãid està interpr. Voigt 1971, 98, 100
q]r≥e≥p≥t≥h suppl. Lobel-Page 1955, 68-69 : Sapph. (q]r≥e≥vp≥t≥a) trib. censuit Voigt
1971, 98, 100 ║7 suppl. Lobel 1951b, 22, conl. Sapph. 200 V. : rec. Lobel-Page
1955, 68-69, Voigt 1971, 98-100 ║8 inter w et .[ spatium vacuum ║9 eauth'" p≥r[osh- /govreue distinxit et suppl. Treu 1976, 12 ║ 10 e:uv fort.
u[m[w" ? ]t≥[ Voigt 1971, 98-100 ║11 inter n et c spatium vacuum
supra c tres litterae parvulae sive a[nw stigmhv et litterae duo ║2 ajgg[elivan
Treu 1976, 12 ║13 daivm[w]n ajq[avnato" Treu 1976, 12, rec. Aloni 1997,
]:, ut vid. o≥ vel r≥ Lobel 1951, 17-18, rec. Lobel-Page 1955, 68-69 : o≥, l≥ vel m≥ legit Voigt 1971, 98, 100 : tantus arcus dextr. litterae rotundae, fort. o≥, r≥ vel w≥? ║14 i post h vestigia non perspicua inter h.. et p fort. spatium vacuum? l≥[, m≥[ Lobel 1951, 17-18 : pel≥[ veri sim., fort. forma verbi pevlomai ? Sapph. trib.? ║15 g∆ fort. o deletum, i.e. ∙o‚, censuerunt Lobel-Page 1955, 68-69 et Voigt
1971, 98-100, sed vestigia non perspicua sane sunt ║16 i>e ║18 ].o≥fi vel ]r≥fi legerunt
Lobel 1951b, 17-18, Lobel-Page 1955, 68-69, Voigt 1971, 98, 100 ║19 on∙d‚, t
suprascriptum ║20 ante d fort. diple ai∆ ║22 ti>d ║25
fort. ]g≥ legendum censuit Voigt 1971, 98, 100 ║26 ]o≥ legerunt Lobel 1951, 17-18,
Lobel-Page 68-69 et Voigt 1971, 98, 100, sed vestigia non perspicua sane sunt
fort. fhsi;≥? col. iii 12s. suppl. Lobel 1951b, 22 ║15 kai; Gurinn[ Lobel-Page 1955, 68-69 ║16 post s≥ fort. a≥ legendum censuit Voigt 1971,
98, 100 ║17 epit.[, e sscr. ad i ║18 mezon pap. : meãvsÃdon Voigt 1971, 98, 100,
sed cfr. Hamm 1958, §9 on:ti ║ 19 ajl-] Lobel-Page 1955, 69
║20 pot∆e pap. : dist. et corr. Lobel-Page 1955, 68-69 ║21 inter i≥ et euj- spatium vacuum eujfhvmei" qa[ vel eujfhvmeisqa[ Lobel-Page 1955, 68-69 ║22
dist. Lobel-Page 1955, 68-69 ║23 dist. et suppl. Lobel-Page 1955, 68-69
║25 in mg. coronis, ut vid. inter s et p spatium vacuum pai> ta'" distinxi au{th (vel tau'ta) Lobel ║28 fort. ]t legit Lobel 1951b,
18, rec. Lobel-Page 1955, 68-69, Voigt 1971, 98, 100 ║Fr. 2 fort. e fr. 1 col. II
provenisse censuit Lobel 1951b, 17-18 ║Fr. 3 3-4 perdita superficies 1-4 om.
Voigt 1971, 99 ║6 post h litt. rotundae partem sx. leg. Lobel 1951, 19, Lobel-Page 1955
: s≥ legi litt. t tantum caudae pars inf.║7 litt. q tantum h.h. pars extrema
dextra post n fort. litt. t h.h. partem estrema sin. vel stigmhvn esse censuit Lobel
1951b, 19 ║8 ein:f ║9 e.g. ].l≥hb.[ Lobel 1951b, 19 ║10 e[]slon, ka\]slon
simm. Voigt 1971, 100 post n spatium vacuum ║11 ]d≥d≥[ sive ]d≥a≥[ leg. Lobel
1951b, 19 ║12 ]q≥w≥sa.–[ ║13 fort. ]r≥ vel ]s≥ leg. Lobel 1951b, 19 ║14 ].: ut. vid.
commatis punctulum inf. leg. Lobel 1951 ║15 distinxi ║16 sive fort. ]q≥ leg. Lobel
1951b, 19 distinxi a7[ ║17 prw'ton Voigt 1971, 99 ║18 ]k≥[, ]l≥[, ]c≥[
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
342
Lobel 1951b, 19 ║20 ]k≥ressonga[ leg. Lobel 1951b, 19 : ]k≥revsson ga;[r Lobel-
Page 1955, 70, rec. Voigt 1971, 99 ║Fr. 4 3 ]menon:i>[ ║5 pro .j[ fort. b[ legit
Lobel 1951b, 20 ║Fr. 5 1 ]..i≥, i.e. ].a≥i≥ vel ].l≥i≥ legitLobel 1951b, 20, sed vix dispici
potest ║6 ].os≥th potius quam ].oo≥th legendum censuit Lobel 1951b, 20 ║Fr. 6
1]m≥eil[ vel ]p≥eil[ Lobel 1951b, 20 ║2 fort. l≥[ ? Lobel 1951b, 20 ║3
vestigia vix dispici possunt ║Fr. 7 2 ]g≥oukai.[ vel ]t≥oukai.[ Lobel 1951b, 20
║4 ]ot≥..[ Lobel 1951b, 20 : fort. ]ot≥.:[? ║Fr. 8 1 ]g≥ vel ]t≥ Lobel 1951b, 20 r≥ vel u≥ ║2 abrasa superficies ║4 ante prim. litt. vestig. atramentum nullum, sed
illaesa pap., ut vid. ante g h.v. longius infra lineam desc. pars inf. ║Fr. 9 1 prima
litt. caudam longam habet, fort r≥ vel u≥ ║2 h.v. dextrorsum leviter inclinata ║Fr.
10 (a) 1 ]o≥ vel ]w≥ Lobel 1951b, 21 ]." g≥ar Voigt 1971, 99 fort. ]wJ" ga;r ?
║2 fort. e≥[ vel o≥[ Lobel 1951b, 21 ║3 ].: h.v. vestigia ║6 post h vestigia h.v.
.[ : vestigia caudae longae, u≥, r≥ ? ║7 ]o≥ vel ]w≥ legendum vidit Lobel 1951b,
21 : fort. wJ" fhsi;(n) ? distinxi ║9 magna ex parte abrasa superficies
vestigia dispici non possunt ║10 magna ex parte abrasa superficies ║11 magna
ex parte abrasa superficies h.h. pars extrema dextra litteram i sub apice scindit ║13
distinxi fort. cariven≥[t- ║14 ejn tauvthi] th≥'i wjãiÃdh'ãià lev[gei o{ti suppl.
Lobel-Page 1955, 72, rec. Voigt 1971, 100 ║15 nomen Atthidis prim. agn. Lobel-Page
1955, 72 ║17 ].: tantum vestigia ║ Fr. 10 (b) 2 [At]qi glu[k- ? Treu apud
Voigt 1971, 100 ║4 fort ]s≥e≥p≥a≥[ legendum censuit Voigt 1971, 100 ║Fr. 11
1]nan:c.[ .[ : punctulum litt. apices superimens ║2 .[ : litterae
rotundae pars superior ║Fr. 13 3 e deletum, ut. vid. ║4 t]uv≥ch"? ║5
]s≥i≥a" [ Lobel 1951b, 22, Lobel-Page 1955, 72 : ].: littera cauda longa, fort. ]u≥a"[ ?
║6 ]if≥[ Lobel 1951b, 22 : ]iw≥[ Lobel-Page 1955, 72 sup. w h.v. cuius ratio
non reddita leg. Lobel-Page 1955, 72 : fort. vestigia caudae litterae a v. 5 disc. ? ║Fr.
14 3 supra i, ut vid., litt. i inter lineas scriptum ║ Fr. 15 1 post n vestigial litt.
rotundae vel hamatae, fort s≥[ ?║Fr. 17 2 ].: u≥ sive ]r≥, ]f≥ minus veri sim. recte vidit
Lobel 1951b, 22 ║3 post q vestigia h.v. ║4 punctulum in linea leg. Lobel-Page
1955, 73
Il POxy. 2293, pubblicato da Edgar Lobel (1951b, 16-23) nel ventunesimo volume de
The Oxyrhynchus Papyri, tramanda un commentario a più carmi di Saffo. Il fatto che si
tratti di carmi della poetessa eolica è dimostrato, come nota Lobel (1951b, 16) dalla
presenza dei nomi propri Attide e Girinno e da un’intera spiegazione di un lemma,
ovvero quella che dice che altrove Saffo aveva detto che Peithò era la figlia di Afrodite,
per cui cfr. infra. Il fatto, invece, che si tratti di un commentario ad alcune odi del quarto
libro è sembrato possibile a Lobel inferirlo dalle sequenze metriche restituite dai vari
lemmi.
Fr. 1
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
343
Sotto il Fr. 1 vengono radunati, da Lobel (1951b, 17-18) e Lobel-Page (1955, 68-69) tre
colonne del commentario: la prima colonna, omessa dalla Voigt, riporta sola l’ultima
lettera di alcuni righi susseguenti e non apporta niente alla comprensione del contenuto:
di ben maggiore interesse sono, invece, le altre due colonne del frammento, sulle quali
occorrerà soffermarsi. Una breve nota di demerito va a sfavore della Voigt: quest’ultima,
infatti, inspiegabilmente, nel pubblicare il testo non vi ha apposto i segni delle coronidi e
di quest’ultime dà notizia solo nell’apparato.
col. ii
La colonna ii del Fr.1 sembra presentare un commentario a due odi di Saffo: sono
presenti due coronidi, una tra il rigo quattro ed il cinque ed una tra il ventitré ed il
ventiquattro. La prima ode cominciava, secondo gli studiosi, con un’invocazione alla
Persuasione (Peithò) che si presentava a Saffo come messaggera di Afrodite .
5-8 Il primo lemma tradito dal testimone è ] Kuqerhva" trov- / fo". Il commentatore
riporta un passo di un’ode di Saffo e spiega che, in un’altra poesia, Saffo aveva invece
sostenuto che Peithò era la figlia di Afrodite e non, come qui, trovfo", la "nutrice":
questa è l’interpretazione di Ferrari e Di Benedetto (Ferrari 1987, n. 1 ad loc.).
L’integrazione del v. 6 è di Lobel & Page (1955, 68-69), i quali confrontano le tracce
poste sul papiro (]..p≥t≥h) con un lemma di Esichio: trofoiv: ajnti; tou' qrevmmata.
Dunque, se si deve dar ragione a Lobel, qui trovfo" non significherebbe "nutrice", bensì
"nutrita" e quindi "creatura, rampollo", come del resto traduce Aloni (1997, 142-143),
mentre Ferrari (1987, 175) accoglie il significato classico "nutrice". Se l’interpretazione
di Lobel è corretta, si potrebbe ipotizzare che q]r≥e≥p≥≥t≥h v del rigo successivo glossi trovfo",
il che significa integrare qualcosa come Kuqerhva" trov- / fo"[ ajnti; tou' q]r≥e≥vp≥≥t≥h v. ejn
a[lloi" / de; qug≥[atevra (th'") jAfro]divt≥h" ei[rhke th;[n / Peiqwv.[ : ebbene, una tale
formulazione della spiegazione crea non pochi problemi, perchè ejn a[lloi" / de;
qug≥[atevra (th'") jAfro]divt≥h" ei[rhke th;[n / Peiqwv.[ è una tautologia: ha già detto che
Peithò è la figlia di Afrodite e la presenza dell’avversativa de; non avrebbe senso, perchè
non vi sarebbe alcuna opposizione. Una prima strada per comprendere il passo è negare
credibilità a q]r≥e≥p≥≥t≥h v, ma esso non può essere evitato: a parte il tau, di cui è poco
leggibile l’asta verticale, l’unica traccia presente sul papiro prima del pi è,
nell’interlinea, la parte bassa di quella che sembra essere un’asta verticale o obliqua e
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
344
che può benissimo essere interpretata come un rho: tra quest’ultima traccia e il pi vi è
una lacuna, presumibilmente di una sola lettera: ecco che q]r≥e≥p≥≥t≥h, come riconosce la
stessa Voigt (1971, 100) appare inevitabile. La Voigt propone, dunque, di considerare
q]r≥e≥p≥≥t≥h non una parte della spiegazione, ma dello stesso lemma ovvero, in altre parole,
di attribuirlo a Saffo. Se si segue l’interpretazione di Ferrari la glossa del commentatore
acquista significato: "il commentatore cita prima un passo di Saffo, da cui risulta che
Peithò è nutrice di Afrodite e poi nota che Saffo aveva espresso anche un’opinione
diversa ", riassume Ferrari (1987, n.1 ad loc.): così sembra diventare, d’improvviso,
tutto chiaro, senonchè in tal caso farebbe difficoltà q]r≥e≥p≥≥t≥h v: esso non avrebbe alcun
significato in quel passo e difatti Ferrari, nella traduzione, sembra non prenderlo proprio
in considerazione. Aloni (1997, 143 n. 2) tenta un’altra strada: pur accettando trovfo"
nel senso di "creatura, figlia", ipotizza che il commentatore si sia confuso tra i due
significati di quest’ultima parola, ovvero intendendo di nuovo "nutrice" e non
accorgendosi, dunque, della tautologia che stava scrivendo: e tuttavia, anche in questo
caso, fa difficoltà q]r≥e≥p≥≥t≥h v, perchè esso, così, non può più essere la glossa di trovfo": se
lo fosse, il commentatore non farebbe la confusione che gli si addebita. A tutto ciò si
aggiunga che la parola q]r≥e≥p≥≥t≥h sembra aver creato, in tutti gli editori, seri problemi per
quanto concerne la posizione dell’accento: Lobel-Page, che riportano la parola solo in
apparato, lo omettono del tutto, mentre la Voigt riporta a testo q]r≥e≥vp≥≥t≥h, invece
dell’atteso e regolare q]r≥e≥p≥≥t≥hv: la ragione di questo errore va, forse, individuata nel fatto
che l’editrice è incerta se attribuire la parola all’esegeta o a Saffo: se la si considera una
glossa o, comunque, una parte del commento, come a noi appare preferibile, occorrerà
scrivere q]r≥e≥p≥≥t≥hv e non q]r≥e≥vp≥≥t≥h; altrimenti, se la si attribuisce a Saffo va corretta in
q]r≥e≥vp≥≥t≥a. La Voigt fa confusione tra le due possibilità. q]r≥e≥vp≥≥t≥h è, tuttavia, accolto da
tutti gli editori. Per Kuqerhva" cfr. Sapph. DV eV 3 = 86.3 V. K≥u≥qevrh∆ e≥uj≥c≥om[ (per cui v.
supra); 140 V. :
- katqnavskei, Kuqevrh∆, a[bros∆ ―Adwni": tiv ke qei'men… - kattuvptesqe, kovrai, kai; katereivkesqe civtwna".
- Muore, Citerea, il delicato Adonis: che faremo?
- Percuotetevi il petto, fanciulle, e laceratevi la tunica.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
345
Per integrare il rigo successivo Lobel (1951b, 22) si basa, invece, su Schol. in Hes. Op.
74 [= Sapph. 200 V.] Sapfw; dev fhsi th;n Peivqwn jAfrodivth" qugatevra " Saffo,
invece, dice che Peithò è figlia di Afrodite".
8-10 Il testo presentato dal testimone dopo la lacuna dell’ottavo rigo è di difficile
interpretazione, ma è probabile, riteniamo, che si tratti di un lemma : la spiegazione della
citazione precedente sembra terminare con Peiqw;. Ed un altro argomento potrebbe
dimostrare questa ipotesi : con u[m[ del decimo rigo del commentario sembra iniziare un
nuovo lemma e vi è una paravgrafo" tra i righi otto e nove ed una tra il decimo e
l’undicesimo: il testo compreso tra il nono ed il decimo rigo viene così ad essere
separato da ciò che segue e da ciò che precede : e se nel prosieguo si ha, al rigo 10, una
citazione, ergo anche prima, tra i righi otto e nove occorre pensare ad un lemma.
10-11 La sequenza di parole presente al v. 10 da u[m[ in poi deve costituire un nuovo
lemma: lo dimostra il carattere del tutto eolico delle due uniche parole in tutto o in parte
leggibili. u[m[ e qeloisa: esse andranno, dunque, attribuite a Saffo. Dove si concludesse
il lemma è impossibile dire, mentre qualcosa di più preciso si può affermare per il
commento che segue: il rigo dodici inizia, infatti, con una parola del tutto eolica (a[mmi) e
tra i righi 11 e 12 è stata apposta una coronide: sembra dunque verosimile ritenere che la
spiegazione terminasse entro il rigo seguente. Al rigo 11, del resto, è presente un
simbolo (un c con tre circelli più o meno pieni posti sopra) che non può essere presente,
certo, in un verso poetico.
12 a[mmi ajgg[ è parte di un nuovo lemma e Treu (1976, 12) propone di integrare
ajgg[elivan, ovvero ipotizza che oggetto di questo verso fosse un annuncio proveniente
da Afrodite.
13 Treu propone di integrare, con molta verosimiglianza, daivm[w]n aj≥q[avnato",
accolto da Aloni (1997, 147-148), ma di cui la Voigt (1971, 100) non dà alcuna notizia
in apparato.
15 Dopo il ∆ vi sono due lettere di lettura incerta: la prima delle due sembra essere
un o preceduto da una linea obliqua tangente all’omicron stesso e si è ipotizzato che si
debba leggere un omicron cancellato, ma non vi può essere certezza. Ancor più
indecifrabile è la lettera che segue quest’ultima: già il Lobel (1951b, 17-19) ritiene che si
tratti di un alpha, questa conclusione si può trarre solo da ciò che segue: si dovrebbe
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
346
trattare, dunque, del pronome eolico a[mme[, ma il punto posto in alto alla destra
dell’alpha non può concordare con una simile lettura. Riteniamo credibile anche un’altra
possibilità che potrebbe dar ragione della correzione del copista e del punto in alto: la
lettera potrebbe essere non un alpha, bensì un hypsilon: il copista potrebbe aver pensato
di scrivere a[mme[, ma poi si è accorto che lì occorreva u[mme[. Del resto qelet≥e≥[, seconda
persona plurale, è presente al rigo 18.
21 cevrre" è eolico (cfr. Sapph. DV iaV 5 = 81.5; 96.29; Alc. 45.6; 58.21; 302b, a):
deve, dunque, essere parte del lemma.
24-27 Gli editori (Lobel 1951, 17; Lobel-Page 1955 68-69; Voigt 1971, 98) pongono la
paravgrafo" tra i righi 23 e 24 della colonna, ma crediamo sia più probabile per essa
un’altra collocazione. Della coronide posta in basso, a fianco del testo, è visibile solo la
parte superiore, perchè al di sotto termina il papiro: se confrontiamo questa coronide con
quella posta all’inizio del frustolo possiamo notare che la paravgrafo" è, solitamente,
collegata alla parte mediana del tratto della coronide, a media distanza tra la parte alta e
quella bassa di essa: in base a queste considerazioni, è possibile, riteniamo, abbassare la
paravgrafo" di un rigo e considerare il tratto orizzontale posto tra i righi 23 e 24 come
la parte alta di un t: ed un tau, del resto, leggono in quella posizione tutti gli editori.
Questa nuova collocazione per la paravgrafo" si adatta meglio al testo del
commentario: ]t≥anu[ - / p≥t≥erug.[ va considerato, infatti, parte del lemma, anzi del primo
lemma di una nuova ode: lo conferma la coronide posta lungo il margine. Anche la
nuova ode avrebbe per oggetto, secondo gli studiosi, un’epifania divina: Afrodite si
presenta a Saffo accompagnata dagli Eroti "dalle ali distese", secondo l’interpretazione e
la proposta di integrazione di Treu (1976, 12), accolta da Aloni (1997, 142-143).
L’aggettivo tanuptevrux (tanuvpterux in eolico) è usato solitamente in riferimento agli
uccelli od altre famiglie di volatili e compare già nell’Iliade (XII 237 oijwnoi'si
tanupteruvgessi; XIX 350 a{rpi eji>kui'a tanuptevrugi "simile al puffino dalle ali
distese, dalla voce sonora"), ma cfr. Sim. fr. 521/16.4-5 Page wjkei'a ga;r oujde;
tanupteruvgou muiva" / ou{tw" aJ metavstasi" "così veloce non è neanche il guizzo
della mosca dalle ali distese"; Alcm. 89.6 Davies = 159.6 Calame eu{dousi d∆oijwnw'n
fu'la tanupteruvgwn "dormono le stirpi degli uccelli dalle ali distese". Treu (1976,
167) attribuisce ad Edgar Lobel l’integrazione [ [Erwte", ma essa non trova alcun
riscontro nè nell’editio princeps del papiro (Lobel 1951b, 16-23) nè nell’edizione critica
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
347
che lo stesso Lobel ha curato per la OCT avvalendosi dell’aiuto di Denys Page (Lobel-
Page 1955, 68-69) e la Voigt stessa (1971, 100) dimostra, non riportandola in apparato,
di non conoscerla: e tuttavia essa può cogliere nel segno. Viste le altre attestazioni
dell’aggettivo tanuptevrux, è anche possibile, riteniamo, che esso si riferisca qui a dei
volatili veri e propri: si ricordi, a tal proposito, che nell’ode incipitaria del primo libro
(Sapph. 1, 9-12) Afrodite è accompagnata da uno stormo di passeri. Al rigo successivo
proponiamo di leggere fhsi;, un verbo che è caratteristico dell’esegesi: ciò che segue il
sigma è un tratto verticale, congruente con la lettura qui proposta. La nostra proposta è,
tuttavia, stata preceduta dal Treu (1976, 12) che traduce sagt sie: probabilmente il
commentatore sta parafrasando il lemma. La lettera precedente al phy per tutti gli editori
è un omicron, ma la sua lettura è piuttosto incerta, perchè posta sul margine della lacuna.
col. iii
Secondo l’interpretazione di Ferrari (2007a, 55s.) oggetto del carme commentato in
questo frustolo sarebbe la “diserzione di Girinno a favore, ancora una volta, di
Andromeda”, ma i dati in nostro possesso sono troppo pochi, riteniamo, per giungere ad
una simile conclusione. E l’ipotesi da cui parte Ferrari è, a ben vedere, poco solida: egli
considera l’intera colonna come un commentario ad un’unica ode, ma consultando
l’edizione di Lobel-Page (1955, 68-69) e, soprattutto, l’immagine del papiro ci si
accorge della presenza di ben due coronidi sulla stessa colonna, una che non inficia sulle
considerazioni dello studioso perché posta tra i righi 11 e 12, cioè in una posizione
innocua, ma una seconda, di cui rimane traccia evidente sul margine dei righi 22-23,
depone nettamente a sfavore della ricostruzione di Ferrari. In base ai dati presentati dal
papiro, infatti, circa verso il rigo 25 doveva essere presente il primo lemma commentato
tratto dalla terza ode e perciò l’ode “scritta contro Andromeda” doveva essere la terza e
non la seconda o (addirittura) l’unica oggetto di esegesi in questa colonna. E la frase dei
righi 25 e 26 sembra, essa stessa, deporre contro il Ferrari, ma per essa v. infra.
12-14 Le integrazioni qui accolte sono di Lobel (1951b, 22). Si tratta molto
probabilmente di una banale spiegazione di un termine raro. Lobel per integrare
l’esegesi del papiro è ricorso a molti lessici, etimologici ed opere grammaticali antiche e
bizantine, ma la Voigt in apparato ne riporta solo due. L’elenco completo fornito da
Lobel comprende i seguenti passi: Epim. An. Ox. I 29.25sgg. Cramer jAgerwvcwn: hJ me;n
sunhqeiva th;n levxin ejpi; yovgou tavssei, tou;" ga;r aujqavdei" kai; ajpaideuvtou"
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
348
ajgerwvcou" levgousi: oJ de; {Omhro" tou;" a[gan ejntivmou", para; to; a[gan ejpi; tou'
gerw'" ojcei'sqai "la lingua d’uso impiega la parola per biasimo, infatti dicono
agerōkhoi gli arroganti ed i non acculturati; Omero, invece, (indica con questo
aggettivo) coloro che ricevono troppo privilegio, (derivando il significato) dal fare
troppo affidamento sul privilegio"; Epim. An. Ox. I 44, 10sgg. Cramer jAgevrwcon:
e[ntimon, ejpi; gerw'" ojcouvmenon ktl.; Etym. Magnum <jAgevrwco">™ JRhtorikh; hJ
levxi": shmaivnei de; to;n aujqavdh, para; to; a[gan aujcei'n: h] oJ e[ntimo" kai;
ajndrei'o"", para; to; a[gan geroucei'n. jWrivwn. ktl. "il termine è retorico: significa
"arrogante", a causa del troppo vantarsi. Oppure indica l’onorato ed il coraggioso, a
causa dell’avere troppo privilegio. Orione."; Orion Etym. jAgevrwco", oJ a[gan
geroucw'n "agerōkhos: colui che possiede privilegio in eccesso"; Etym. Gud.
jAgerwvcwn:: ajlazovnwn: hJ me;n sunhvqeia th;n levxin ejpi; tou' yovgou tavssei: tou;"
ga;r aujqavdei" kai; ajpaideuvtou" ajgerwvcou" levgei. oJ de; {Omhro" tou;" a[gan
ejntivmou", ajpo; tou' a[gan ejpi; to; gevra" ojcei'sqai "agerōkhōn: „degli spacconi“:
La lingua d’uso impiega la parola per biasimo: infatti si dicono agerōkhoi gli arroganti
ed i non acculturati; Omero, invece, (indica con questo aggettivo) coloro che ricevono
troppo privilegio, (derivando il significato) dal fare troppo affidamento sul privilegio";
Apoll. Soph. Lex. Hom. s.v. ajgevrwcoi: hJ me;n kaq∆ hJma'" sunhvqeia th;n levxin ejpi;
tou' yovgou tavssei: tou;" ga;r aujqavdei" kai; ajpaideuvtou" ajgerwvcou" levgei. oJ de;
{Omhro" tou;" a[gan ejntivmou", ajpo; tou' a[gan ejpi; to; gevrw" ojcei'sqai "il nostro
uso impiega la parola per biasimo: infatti si dicono agérōkhoi gli arroganti e gli
sculturati; Omero, invece, (indica con questo aggettivo) coloro che ricevono troppo
privilegio, (derivando il significato) dal fare troppo affidamento sul privilegio"; Hsch.
s.v. <ajgevrwcoi>: oiJ a[gan e[ndoxoi kai; e[ntimoi h] uJperhvfanoi h] ajpaivdeutoi
"agérōkhoi: coloro che sono troppo illustri e ed onorati, oppure arroganti e volgari“. E
cfr. Eust. In Od. XI 285; Tzetz. Chil. IX 118 (al.). Per espressioni simili a quella
integrata dal Lobel e, presumibilmente, usata dal commentatore cfr. Eust. In Il. II 654
ajgevrwcoi de; oiJ a[gan gevra" e[conte" "agérōkhoi sono coloro che hanno privilegio
in eccesso“; Eust. In Il. III 36 o{ti ajgerwvcou" levgei tou;" Trw'a", o} taujtovn ejsti
tw'i uJperhfavnou" kai; ajxiou'nta" a[gan gevra" e[cein "chiama agerōkhoi i Troiani,
ciò che è lo stesso di essere superbi e pretendere di avere privilegio in eccesso“. Il
termine, infatti, è già attestato nell’Iliade (per la prima volta in Il. II 654: JRodivwn
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
349
ajgerwvcwn) esclusuvamente nel senso di “nobile”: “It is applied by Homer to the
Trojans, the Mysians, and once to an individual, Periklymenos, Od. 11.286” commenta
Leaf (1900, ad Il. II 654), il quale nota anche che in altri autori lo stesso aggettivo
poteva avere anche valore negativo: “overbearing”, “haughty”, “superbo”,
“arrogante”331
. Per la stessa radice cfr. Sapph. 7.4 ajg≥e≥rwcivai "per la superbia“. Per
ajgevrwco" nei poeti eolici cfr. Alc. 402 V. ajgevrwco", citato da Eust. 314, 43s. e spiegato
con i sinonimi a[kosmo" e ajlazwvn: Eustazio aggiunge, inoltre, che il termine era
attestato, con lo stesso significato, in Archiloco (fr. 154 Bgk.4 = 261 W.
2), mentre
Alcmane (fr. 122 Bgk.4 = fr. 10(b).15 PMGF) utilizzava questo aggettivo nel significato
di “degno di onore, illustre”. In Pindaro, invece, l’aggettivo è utilizzato solamente in
riferimento a cose: O. X 79 nivka" ajgerwvcou “della vittoria superba”; P. I 50 plouvtou
stefavnwm∆ajgevrwcon “superbo coronamento di ricchezza”; N. VI 34-35 ajgerwvcwn
eJrgmavtwn / e{neken “a causa delle opere superbe”. Fin qui ci siamo limitati ai dati
linguistici della parola, ma essa risulta interessante anche per un altro motivo: nel PKöln
II 60 = Sapph. S476 SLG, un frustolo papiraceo pubblicato dopo l’edizione della Voigt,
questo aggettivo viene utilizzato in riferimento ad Attide: S476 SLG aj]gevrwco" [At≥[qi":
l’integrazione è di Denys Page, ma non vi possono essere molti dubbi
Per Girinno cfr. Sapph. 29h.3 V. G]uvrinnoi; DV ibV a = 82a V. eujmorfotevra
Mnasidivka ta;" ajpavla" Gurivnnw" "Mnasidica è più bella della delicata Girinno“;
Max. Tyr. Dial. XVIII 9 p. 230ss. Hob. [= Sapph. 219 V.] o{, ti ga;r ejkeivnwi
jAlkibiavdh" kai; Carmivdh" kai; Fai'dro", tou'to th'i Lesbivai Guvrinna kai; jAtqi;"
jAnaktoriva “ciò che per lui (Socrate) erano Alcibiade. Carmide e Fedro, per la
poetessa di Lesbo erano Girinno, Attide ed Anattoria”. Ferrari (2007a, 55) ritiene che
oggetto dell’ode fosse la diserzione di Girinno a favore di Andromeda, ma la sola
presenza del nome della prima non può giustificare una simile ricostruzione; inoltre il
commentatore dice che “quest’ode è stata scritta contro Andromeda” soltanto a riguardo
del carme successivo: è, infatti, presente una coronide sul margine dei righi 22-23, ma
cfr. infra. La presenza di Girinno è, invece, certa: nell’ode qui commentata dallo
sconosciuto esegeta Saffo avrà, piuttosto, “espresso la propria disapprovazione nei
confronti di donne superbe […] tra siffatte donne è annoverata Girinno”, secondo quanto
afferma correttamente la Cavallini (1991, 111). Girinno, dunque, doveva aver suscitato
331
Cfr. Cavallini 1991, 111.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
350
qualche risentimento nella poetessa: del resto proprio in un carme di questo stesso libro
la bellezza di Girinno viene posposta a quella di una ragazza di nome Mnasidica:
eujmorfotevra Mnasidivka ta;" ajpavla" Gurivnnw" “Mnasidica è più bella della
delicata Girinno”.
16-18 L’integrazione del rigo 16 e[-] è di Lobel-Page 1955, 68-69. Ai righi 16-18 deve
esserci un altro lemma: lo stacco con quel che precede è segnato da e[-] / gw (suppl
Lobel-Page), un pronome che non è, certo, solitamente usato dagli esegeti. Secondo gli
interpreti (Treu 1976, 167; Aloni 1997, 144-145), nei righi 16-18, Saffo direbbe
qualcosa del tipo “io non ho qualcosa di più grande della bellezza”, frase a cui farebbe
seguito, nei righi immediatamente successivi, l’esegesi. Nessuno ha, tuttavia, proposto di
confrontare questo lemma con Sapph. DV dV 3sgg. õe[gw de; fivlhmmVajbrosuvnan,Õ[
] tou'to kaiv moi / to; lavõmpron e[rw" ajelivw kaiv to; kavÕlon levõlÕogce “io amo la
raffinatezza…ciò e per me / l’amore del sole ottenne in sorte splendore e bellezza”: in
entrambi i casi Saffo rivendica una certa caratteristica positiva, la bellezza e la
raffinatezza, da cui deriva anche la prima. “La critica di Saffo sarà, dunque, rivolta
contro donne troppo orgogliose del suo aspetto esteriore”332
.
Dal punto di vista metrico, il lemma crea non pochi problemi: sul papiro, infatti, il
copista ha scritto epit, ma sullo iota, o meglio leggermente alla destra di esso (dunque
alla nostra sinistra) viene soprascritto un epsilon: se assumiamo che l’ode appartenga
veramente al quarto libro, non possiamo ritenere che il lemma fosse tutto contenuto in
un solo verso: lo impediscono le tre sillabe brevi susseguenti che si verrebbero a creare.
Cavallini (1991, 113 e n. 42) ritiene che per ejpet[ si debba intendere una forma del
verbo ejpitugcavnw, ma come nota lei stessa “l’ordinamento metrico resta comunque
problematico” e la studiosa non propone alcuna soluzione: e[gw to; kavllo", piuttosto,
può formare perfettamente la parte finale di un parasclepiadeo maggiore, ovvero
dobbiamo scandire e[gw to; kavllo" ║ ejpet- : ejpet- è il testo presentato dalla Voigt
(1971, 98), da Treu (1976, 14), da Aloni (1997, 144) e da Di Benedetto-Ferrari (1987,
176): tuttavia, sia con ejpet-, sia con ejpit- (il testimone presenta, infatti, epeit[) il verso
risulterebbe ametrico, perché la seconda sillaba di un parasclepiadeo maggiore è
necessariamente lunga: la soluzione potrebbe essere quella di intendere epeit[ non come
correzione di epit[ in epet[, ma come aggiunta di una vocale, ovvero ejpeit[: del resto,
332
Così Cavallini 1991, 111.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
351
al rigo 21 il copista ha scritto kavlli≥ che, probabilmente, va corretto in kavllei≥: lo scriba
sembra aver fatto, insomma, lo stesso errore. ejpeit[ andrà inteso, quindi, o come ejpei;
t[ (per ejpeiv cfr. Sapph. 20.14; 31.17; Alc. 6.3; 72.8; 140.14; 249.8; 306 A b.20; 332.2;
347.5; inc. auct. 42.15) o, meno probabilmente, come e[peit[a, per cui cfr. Alc. 129.19;
306 A b.24: in questo modo non avremmo il verbo in quella posizione, ma si può sempre
presumere che fosse in lacuna: e se fosse al rigo precedente con la fine di verso vi
sarebbe anche fine di frase (…io la bellezza ║ poiché…).
18 La Voigt (1971, 98, 100) ha letto un punto in alto dopo il ny finale di mevzon ed
ha proposto, giustamente, di correggere il mevzon del papiro nell’eolico mevãsÃdon:
considera mevzon come ultima parola del lemma: la separazione tra il lemma e l’esegesi
sarebbe garantita proprio dal punto in alto. Treu (1976, 12), invece, sembra considerare
parte del lemma che inizia al rigo 16 tutto il rigo 18: partendo da questa ipotesi,
considera hn presente sul papiro come imperfetto del verbo “essere” e propone di
integrare, immediatamente dopo la lacuna, au[tai; traduce denn wash atte ich denn
(selbst) größeres, non prendendo in alcuna considerazione il punto in alto dopo mezon
letto dalla Voigt (ed anche da Lobel-Page 1955, 68-69). In reltà non è nemmeno certa la
distinzione di hnem[ in h\n ejm[.
18-21 Al lemma, i cui confini non possono essere stabiliti con certezza, segue l’esegesi:
per Treu (1976, 167) e per Aloni (1997, 145) questa ultima si sostanziava in due
“momenti”, ovvero ad una prima interpretazione morale (al rigo 19 compare,
significativamente, il termine ajreth'") seguiva un’altra possibile linea esegetica (ajl-] /la;
mhvpote levgei o{ti o[ "ma forse dice che… "). Quanto alla prima interpretazione, una
sua comprensione precisa dipende soprattutto dal contenuto del v. 18 e su questo, lo
abbiamo detto, la Voigt e, prima ancora, Lobel-Page, hanno assunto una posizione
diversa dal Treu: se accettiamo, come sembra probabile, il punto in alto dopo mevzon, tiv
non può più riferirsi a ciò che precede, ma anzi con esso deve iniziare una nuova frase.
Degna di nota è la menzione del termine ajrethv al rigo 19: la Cavallini (1991, 113) ha
sostenuto, in modo convincente, che tale "maggiore bellezza" di Saffo sia "strettamente
connessa con l’ajrethv": del resto un’idea del genere è sviluppata da Saffo anche nel fr.
50 V. : oj me;n ga;r kavlo" o[sson i[dhn pevletai ãkavlo"Ã, / oj de; ka[gaqo" au[tika
kai; kavlo" e[sãseÃtai "colui che è bello è bello solo per quanto tempo lo si guardi, / ma
colui che è virtuoso sarà subito anche bello": si delinea così, dal fr. 50 V. e
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
352
probabilmente anche tra le righe di questo commentario ad un’ode di Saffo, la figura del
kalo;" kajgaqov", ossia del perfetto aristocratico: Saffo, rispetto alle donne ajgevrwcoi di
cui ha parlato prima non solo è kalhv, ma anche ajgaqhv. Per il concetto cfr. Od. VIII 169-
175 a[llo" me;n ga;r t∆ ei\do" ajkidnovtero" pevlei ajnhvr, / ajlla; qeo;" morfh;n e[pesi
stevfei: oiJ dev t∆ ej" aujto;n / terpovmenoi leuvssousin, oJ d∆ ajsfalevw" ajgoreuvei, /
aijdoi' meilicivhi, meta; de;• prevpei ajgromevnoisin, / ejrcovmenon d∆ ajna; a[stu qeo;n w}"
eijsorovwsin. / a[llo" d∆ au\ ei\do" me;n ajlivgkio" ajqanavtoisin, / ajll∆ ou[ oiJ cavri"
ajmfi; peristevfetai ejpevessin “Un uomo, infatti, è più meschino d’aspetto / ma un
dio di bellezza incorona le sue parole e quelli che sono allietati / lo guardano: egli parla
sicuro / con rispetto cortese, risplende nelle adunanze, / quando gira per la città come
un dio lo contemplano. / Un altro, invece, in bellezza simile agli immortali, / ma grazia
non cinge d’intorno a lui le parole”; Plat. Charm. 154 e :
Eij th;n yuchvn, h\n d∆ ejgwv, tugcavnei eu\ pefukwv". prevpei dev pou, w\ Kritiva, toiou'ton aujto;n ei\nai th'" ge uJmetevra" o[nta oijkiva". jAll∆, e[fh, pavnu kalo;" kai; ajgaqov" ejstin kai; tau'ta. Tiv ou\n, e[fhn, oujk ajpeduvsamen aujtou' aujto; tou'to kai; ejqeasavmeqa provteron tou' ei[dou";
«Se d’anima, dissi io, si trova ad essere ben disposto per natura. Conviene
in qualche modo, o Crizia, che costui sia tale, essendo della vostra
ojikiva »
« Ma certamente, disse, è bello e virtuoso anche in questo. »
« Perchè dunque, dissi, non spogliamo di costui proprio questo aspetto e
lo ammiriamo prima della bellezza ? »
La seconda linea interpretativa, che per Aloni (1997, 145) doveva essere più "filistea",
comincerà alla fine del rigo 19 per proseguire fino alla fine del rigo 21, ma bisogna
notare che buona parte di questo spazio è utilizzato dall’esegeta soltanto per introdurre
l’interpretazione: quest’ultima, infatti, doveva iniziare solo dopo o{ti del rigo 20: la
parte rimasta della linea 21 kalli≥ eujfhvmeisqa[ doveva avere, dunque, non poca
importanza. Aloni (1997, 144-145) traduce il rigo 21 con un laconico "…tacere (?) …",
ma al medio-passivo questo verbo non assume il significato di "osservare religioso
silenzio", bensì quello di "esssere celebrato, onorato", un significato, quest’ultimo, che
si lega anche bene con quel che precede, kalli≥, che forse andrebbe corretto in kavllei ≥: il
senso dell’ultimo rigo sarà, dunque, "essere onorata per la bellezza".
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
353
22-23 Al rigo 22 comincia, molto probabilmente, un nuovo lemma: anche qui lo stacco
tra le due parti è dato da un pronome di prima persona singolare, moi. Il lemma del rigo
22 rientra perfettamente nella struttura metrica del supposto quarto libro. Per zefuvr≥w
p≥neuma[ cfr. Nicaen. fr. 6.2 Zefuvrou pneuvmasi; Hermocr. A. P. XVI 11.2 aJpalw'i
Zevfuro" pneuvmati fuvlla donei' “Zefiro con delicato soffio agita le foglie”. Il lemma
doveva continuare nel rigo successivo, ma ajn[em]ofovrhto[, con quattro sillabe brevi
susseguenti, non sembra corrispondere alla struttura metrica del supposto “libro quarto”
ed inoltre ha attestazioni rare (solo cinque volte nella “letteratura greca”, di cui ben
quattro in lessici e scoli), piuttosto tarde e mai in poesia: la prima attestazione della
parola non è in un’opera della “letteratura greca”, bensì in una della “letteratura latina”,
le Epistulae ad Atticum di Cicerone (Cic. Ep. Ad Atticum XIII 37): de gladiatoribus, de
ceteris quae scribis ajnemofovrhta, facies me cottidie certiorem “mi renderai
quotidianamente informato a riguardo dei gladiatori e delle altre cosucce che tu scrivi
che son portate dal vento”. Luc. Lex. 7, 6 ghgenh' polla;...pavnta mevntoi
ajnemofovrhta kai; uJmenovstraka “molte terraglie…tutte leggere come se portate dal
vento e sottili come una membrana” è, in pratica, l’unica attestazione in un’opera
letteraria greca. Se si escludono, per ovvie ragioni, gli scoli a Luciano, si contano solo
altre tre attestazioni, due nel lessico di Apollonio Sofista ed una in quello di Esichio. È
su Apollonio Sofista che occorre soffermarci:
<ajnemwvlia>: mavtaia, ajnemwvdh, ajpo; tou' meta; tw'n ajnevmwn molivskein, oi|on ajnemofovrhta: "ajnemwvlia gavr moi ojphvdei."
“cose inutili” : “vane, leggere come il vento, a causa dell’andare con i venti, cioè cose
portate dal vento”: “invano, infatti, mi insegue”
<metamwvnia>: mavtaia, ajpo; tou' meta; tw'n ajnevmwn ijevnai, oi|on ajnemofovrhta: ou{tw" jApivwn. oiJ de; ta; metameleiva" a[xia.
“cose vacue” : “inutili, a causa dell’andare con i venti, cioè portate dal vento”: così
(spiega) Apione, mentre altri (dicono che sono) “cose degne di rimpianto”
È innegabile che i due lemmi di Apollonio sembrano derivare da una stessa fonte: pur
con pochissime differenze, il testo è simile e d’altronde il significato delle due parole è
identico. Occorre, però, sottolineare che il secondo lemma fornisce anche il nome della
fonte: il grammatico Apione (20 a.C. – 45 d.C.), un allievo di Didimo che insegnò a
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
354
Roma ai tempi di Tiberio e di Claudio333
ed assunse posizioni fortemente anti-ebraiche:
contro di lui Giuseppe Flavio scrisse un’apologia dell’ebraismo, la Contra Apionem.
Egli è in qualche modo legato all’esegesi dei poeti eolici: il suo nome (abbreviato apiw)
lo troviamo menzionato negli scholia ad Alceo presenti sul POxy. 2295 (I sec. d.C.)334
.
ajn[em]ofovrhto[, dunque, oltre ad essere ametrico (ovviamente se si presume che si tratti
di un commentario al IV libro), non è una parola poetica, anzi fa parte del lessico
esegetico: è possibile che essa non faccia parte del lemma, ma della spiegazione o,
meglio, della parafrasi: il commentatore starebbe parafrasando le parole presenti
nell’ode di Saffo: soi si oppone, innegabilmente, a moi e, dunque, anche soi doveva
essere presente nell’ode, ma quel che segue l’avversativa non doveva essere
ajn[em]ofovrhto[, ma ajnemwvlio-, che oltre ad essere una parola di retaggio poetico, si
adatta alla struttura metrica presupposta. Per il possibile ajnemwvlio- cfr. Il. IV 355 su; de;
tau't∆ajnemwvlia bavzei" “queste che dici son parole al vento”; V 216 ajnemwvlia ga;r
moi ojphdei' “invano, infatti, mi segue”; XX 123 oiJ d∆ au\t∆ajnemwvlioi oi} to; pavro"
per / Trwsi;n ajmuvnousin povlemon kai; dhi>oth'ta “van sono coloro che già da tempo
/ difendono i Troiani dalla guerra e dalla strage”; nhpuvtie, tiv nu tovxon e[cei"
ajnemwvlion au[tw" “stolto, perché porti così quell’arco inutile?”; Od. IV 837 (= XI
464) kako;n d∆ ajnemwvlia bavzein “male è dir chiacchiere al vento”.
Lobel (1951b, 23) invitava a confrontare ajn[em]ofovrhto[ con Sapph. 37 V. ka;t e[mon
stavlugmon *** to;n d∆ejpiplavzont∆a[nemoi fevroien / kai; melevdwnai “per il mio
pianto *** chi mi giudica i venti e le preoccupazioni se lo portino via”. Il passo addotto
da Lobel è un esempio di propemptikon, cioè un carme in cui si augura del male ad un
nemico. Verso questa interpretazione sembra portare, dunque, la supposta presenza di
venti. Anche per Treu (1976, 167), che parte dal testo della Voigt, l’ode qui commentata
sarebbe un propemptikon: Saffo starebbe augurandosi fortune e, nello stesso momento,
invocando i mali ad abbattersi contro i nemici. La nostra ipotesi nega che
ajn[em]ofovrhto[ possa far riferimento a dei venti. Ed anche se la nostra ricostruzione
fosse sbagliata, l’aggettivo ajn[em]ofovrhto[ andrà difficilmente inteso letteralmente,
dato che in tutte le sue attestazioni assume sempre significato traslato: “leggero, inutile,
vano”. La presenza di venti, dunque, sembra valida solo per m—oi zefuvr≥w p≥neuma[ che,
333
Cfr. Suida A3215 Adler. 334
Per Apione ed il testo di Alceo cfr. Porro 1994, 15s.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
355
non a caso, è l’unica parte da attribuire con certezza a Saffo. E, del resto, lo stesso
Ferrari (2007a, 56) ha recentemente espresso non pochi dubbi sul fatto che si tratti
effettivamente di un propemptikon e nota come la sola presenza di venti non può essere
considerata determinante in un senso o nell’altro. Tuttavia, i dubbi di Ferrari andranno
leggermente sfumati: infatti, anche se ajn[em]ofovrhto[ fosse una glossa, l’opposizione
tra moi e soi è troppo forte per essere così velocemente messa da parte e si potrebbe
sempre pensare ad esempio ad un giro di frase del tipo: “a me il soffio di Zefiro
(porta/ha portato?)… a te, invece, inutile…”.
25-26 Sul papiro, in corrispondenza dell’inizio del rigo 23, è presente la parte alta di
una coronide ed al v. 25 sembra esserci un nuovo lemma: è dunque possibile che solo a
partire da questo rigo o dal precedente cominciasse il commento ad un’altra ode. Ferrari
(2007a, 55-56), tuttavia, considera tutta la colonna come il commento ad un’unica ode,
non prendendo in alcuna considerazione, forse sviato dal testo della Voigt, la presenza
della coronide: invece, era la nuova ode che comincia, verosimilmente, al v. 25 che
pro;"] / jAndromev]d≥hn gevgra≥[ptai “era scritta contro Andromeda”. Le integrazioni
dei righi 25-28 sono di Lobel (1951b, 23) e sono accolte da tutti gli editori: oltre quelle
accolte qui nel testo, il papirologo propone anche au{th (vel tau'ta) pro;"] “queste
parole sono state scritte contro Andromeda”. La formulazione dell’esegesi sembra avere
carattere incipitario: avrebbe poco senso, riteniamo, presentare un dato così importante
dell’ode solo quando essa era già iniziata da molti versi. E del resto la presenza della
coronide ben risponde a questa esigenza. Per Andromeda cfr. Sapph. DV iV a.4-8 = 68
a.4-8 (v. supra) nu']n≥ dei\m ejÕ[pi; o[]õnivan [ ]Õa[san ajlivtrai≥ / ejpo]r≥somevnÕ[a
su;n doj]õd≥uvn≥[aisjAn]Õdromevdan [uj]pavx[ei / ajpav]likujpa[Õ[rmujy]õimevdo[is]Õ
[Ar[temi]" aj mavka[ir]a, / aj d]o≥u≥jk≥ [aj]bavÕ[khn]õ ma;n≥ stev[r]Õe≥≥on de; trovpon
a[ijs]cuvnhtai: / ou[ti]" ga;r e[pauÕõ[s ].k[ ]Õk≥ovro≥n ouj kativsc≥ei. “ma ora
andrò ad attaccare la colpevole dei tormenti e delle ansie / [e con pe]na la beata
Artemide che governa dall'alto / condurrà sotto il carro l'attempata Andromeda, / sì che
lei si vergognerà del suo carattere non quieto, ma duro. / Nessuno, difatti, ha messo fine
[…]non trattiene la sazietà”; Sapph. DV eV 16 jAnd]romev[dan c]l≥idavnai
pivqeisa / ].ela.[ ]i. Di Andromeda, informa Ateneo (I, 21 b-c), Saffo
parla in maniera derisoria nel fr. 57, di cui riportiamo qui il v. 1 ed il v. 3, gli unici citati
dall'autore originario di Naucrati: tiv" d∆ ajgroi?wti" qevlgei novon... / oujk ejpistamevna
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
356
ta; bravke∆ e[lkhn ejpi; tw;n sfuvrwn “Chi è la rozza che ti ammalia la mente… / e non
è capace di sollevare i suoi straccetti sopra le caviglie?…. ”. Anche in Sapph. 130.3
sgg. si parla di Andromeda: ―Atqi, soi; d∆e[meqen me;n ajphvcqeto / frontivsdhn, ejpi; d∆
jAndromevdan povthãiÓMa tu, o Attide, ti sei stancata di pensarmi / e voli verso
Andromeda”. Così come pure in Sapph. 133.1 in senso sarcastico ed ironico: ―Ecei
me;n jAndromevda kavlan ajmoivban... “Andromeda ha una bella ricompensa…”. Il nome
di Andromeda è stato integrato da Denys Page in Sapph. fr. 213 A k V. ]n≥..and≥.[ /
jAndro]mevdan[.
Fr. 3
10 Per e[]slon (= ejsqlovn), ka\]slon (suppl Voigt 1971, 99-10) cfr. Sapph. 3.3 V.
k]avlwn ka[slwn “de- belli e nobili”; Sapph. 19.4 ] e[coisan e[sl[; 20.4 t]uvcai su;n
e[slai “con sorte fausta”; Sapph. 137.3 aij d∆h\ce" e[slwn i[meron h] kavlwn “se tu
avessi desiderio di ciò che è bello ed onorevole”; 141.6 ajravsanto de; pavmpan e[sla
gavmbrwi “augurarono allo sposo in ogni modo fortune”; 213 A b.10 e[slo"≥[.
15 ]a{pax tout[ (fort. ]a{pax tou't[o) così distinto si trova per la prima volta
nell’edizione di Eva-Maria Voigt (1971, 99) ed è presumibile che faccia parte
dell’esegesi del commentatore e non del lemma: l’espressione, infatti, trova paralleli
molto più tardi e non è mai utilizzata in poesia.
16 La distinzione delle parole qui proposta (]ouj panta[) non si trova altrove. Si
tratta certamente di una parte dell’esegesi: dopo l’a sul papiro è stato tracciato dallo
scriba un simbolo a forma di 7 ed esso si trova anche nel POxy. 2292, un altro
commentario ad un’ode di Saffo [= 213 V.], per il cui testo e la restituzione cfr. Voigt
1971, 160; Ferrari 2007b, 22-29.
19 A prima vista ]q≥anein[ non sembra essere parte del lemma (altrimenti avrebbe
scritto ]q≥avnhn[, ma potrebbe permanere qualche dubbio nel caso si considerino le parole
del Lobel (1951b, 16): egli sostiene, infatti, che il copista sembra aver atticizzato alcune
parole dei lemmi, sicchè, non essendo altrimenti possibile dividere con assoluta certezza
i lemmi dall’esegesi, non può che esserci il sospetto di aver perso qualcosa delle parole
della poetessa eolica.
20 Per ]k≥r≥evsson ga;[r, espressione poetica, cfr. Sapph. DV lV 26 = 88.26 V.
krev]sson ga;r.[, dove è stato integrato dal Treu proprio sulla base di questo lemma del
commentario. Saffo, dunque, sembra sostenere che “è meglio…” di qualcos’altro. Sorge
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
357
il sospetto che ]q≥anein[ del verso precedente avesse in un modo od in un altro a che fare
con questa affermazione: per il tema del preferire la morte a qualcos’altro cfr. Sapph. DV
lV 26 = 88.26 V. dove ricorre, come abbiamo visto, krev]sson ga;r.[ e Treu interpreta il
passo così: “è meglio giacere trafitti dalle frecce di Artemide che…”. E cfr. anche
Sapph. 94.1 teqnavkhn d∆ajdovlw" qevlw “sinceramente vorrei esser morta” (dove si può
con buone ragioni accogliere l’attribuzione della frase a Saffo) e, forse, anche Sapph.
95.8-13, in cui (lo abbiamo detto) la morte viene sublimata attraverso immagini
gratificanti e viene preferita ad uno stato esistenziale turbato e pieno d'angosce
(e[pt≥[akon oujdavmw" et a[ga[n a[saisin suppl. Di Benedetto 1982a, 18):
eij~pon: wj~ devspot∆, e[pt≥[akon oujdavmw" o]uj ma; ga;r mavkairan≥ [
o]ujde;n a[dom∆ e[parq∆ a[ga[n a[saisin katqavnhn d ji[merov" ti" [e[cei me kaiv
lwtivnoi" drosoventa" [o[- c[q]oi" i[dhn jAcer[
io dissi: "o signore, (non ho proprio paura)…
No, per la dea…
Non mi piace affatto essere (troppo) agitata (dalle ansie)…
Mi possiede il desiderio di morire e
di vedere le rugiadose rive dell'Acher(onte)
fiorite di loto…"
Per ]k≥r≥evsson gav[r cfr. anche Il. I 80 kreivsswn ga;r basileu;" o}te cwvsetai ajndri;
cevrhi> “più potente è, infatti, un re quando si adira con un uomo inferiore”; Pi. P. I 85
krevsswn ga;r oijktirmou' fqovno" “l’invidia è meglio della compassione”.
Fr. 4
4 Per ]n≥ohmma cfr. Sapph. 12.4 ]n≥o≥hm≥[; 41 tai;" kavlais∆u[mmin ãto;Ã novhmma
tw\mon / ouj diavmeipton “per voi belle il mio pensiero non potrà cambiare”; 51 oujk
oi\d∆o[tti qevw: duvo moi ta; nohvmata “non so cosa fare: due sono per me i pensieri”;
DVeV 11 = 60.3 V. (v. supra) tev]l≥eson novhmma “porta a compimento l’ intento”; Alc.
361 V. aij dev k∆a[mmi Zeu'" televsh novhma “e se Zeus ci compierà il progetto”; oujdev
ti munavmeno" a[lloi to; novhma “né stornando altrove il pensiero”; 61.11-13
no≥vhmm≥a...n[ov]hm[m∆ “pensiero…pensiero”; 292.1 ]n≥ohmm[; inc. auct. 31a.2 ]e≥mon
nov[h]mm∆ “il mio pensiero”.
Fr. 10 (a)
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
358
1 La lettera posta immediatamente dopo la fine della lacuna è poco leggibile, ma
dovrebbe trattarsi di un segno rotondo, un o oppure un w, come già nota Lobel (1951b,
21). Forse è possibile leggere ]wJ" ga;r[, espressione attestata sia in poesia, sia in prosa,
per cui è impossibile, in queste condizioni, dire se si tratti del lemma o dell’esegesi.
L’espressione è attestata anche in Sapph. 31.7 wj" ga;r ãe["Ã s∆ i[dw “infatti, come
volgo a te lo sguardo”.
12 ].amenhn [ dovrebbe trattarsi di un infinito eolico di mevnw o di un suo composto
e si tratta, a quanto pare, della prima e per ora unica attestazione di questo verbo in
Saffo.
13 Per ]kai; carie≥.[ cfr. Il. VIII 203-4 (= IX 598-599) dw'r∆... / polla; te kai;
cariventa “doni… / molti e graditi”; Il. XXII 510-511 ei}mat∆ / leptav te kai;
cariventa “vesti… / sottili e graziose”; Od. V 230-231 (= X 544) fa'ro".../ lepto;n kai;
cariven “manto… / leggero e grazioso”; X 222-223 oi|a qeavwn / leptav te kai;
cariventa kai; ajglaa; e[rga pevlontai “come le opere delle deee / che sono sottili,
graziose e splendenti”; Alcm. 27.3 Davies = 84.3 Calame ejpi; d∆ i{meron / u{mnwi kai;
cariventa tivqh corovn “desiderio / concedi al canto e gradevole danza”; Archil. fr.
9.10 eij keivnou kefalh;n kai; cariventa mevlea [ / {Hfaisto" kaqaroi'sin ejn
ei{masin ajmfeponhvqh “se intorno alla sua testa ed alle membra graziose / Efesto, in
candide vesti, si fosse affaticato”. Per l’aggettivo cfr. Sapph. 2.2 cavrien me;n a[lso"
“gradevole bosco”; Sapph. DV eV 10 = 68a.10 V. (v. supra) ka;[t] carivent∆.../…covron
(suppl. et interpr. Ferrari, v. supra) “in un grazioso / spazio di danza”; Sapph. 108 w\
kavla, w\ carivessa kovra “o bella, o incantevole ragazza”; Sapph. 112.3 soi; cavrien
me;n ei\do" “hai un viso grazioso”; inc. auct. 39.2 c]aries.[; Alc. 368.1 V. kevlomaiv
tina to;n cariventa Mevnwna kavlessai “prego qualcuno di chiamare il grazioso
Menone”.
14 L’integrazione è di Lobel (1951b, 23). Si tratta, evidentemente, di un tipo di
formulazione usuale alle opere esegetiche, soprattutto quelle che abbiano per oggetto i
lirici arcaici: non è, dunque, un caso se essa trova paralleli, anche se meno diretti, negli
scholia all’unico poeta lirico arcaico le cui poesie ci siano giunte per tradizione
medievale: cfr. e.g. Schol. in Pi. O. VII metr. 5 tauvthn th;n wjidh;n; Schol. in Pi. N. IV
21c. tauvthi th'i wjidh'i; Schol. in Pi. I. 5.inscr a.1 tauvthn th;n wjidh;n. La frase iniziale
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
359
dell’esegesi sembra, inoltre, avere carattere incipitario: se, dunque, l’integrazione di
Lobel è giusta, ai righi 12-13 potrebbero celarsi le prime parole di una nuova ode.
15 [Atqido" è un’interpretazione di Lobel-Page (1955, 72). Per Attide cfr. Sapph.
8.3 [At[qi (suppl. Lobel); 49.1 hjravman me;n e[gw sevqen, [Atqi, pavlai potav “io ero
innamorata di te, Attide, tanto tempo fa”; 96.15-17 povlla de; zafoivtais∆ajgavna" ejpi-
/ mnavsqeis∆ [Atqido" ijmevrwi / levptan poi frevna k[.]...bovrhtai: “molte volte
aggirandosi, punta dal ricordo, consuma il suo cuore debole nel desiderio di Attide
delicata…”; 130.3-4 [Atqi, soi; d∆e[meqen me;n ajphvcqeto / frontivsdhn, ejpi; d∆
jAndromevdan povthãià “Attide, per te era odioso di me / darti pensiero e voli verso
Andromeda”. Il nome di Attide è tramandato anche dal retore Massimo di Tiro: Max.
Tyr. Dial. XVIII 9 p. 230ss. Hob. [= Sapph. 219 V.] o{, ti ga;r ejkeivnwi jAlkibiavdh"
kai; Carmivdh" kai; Fai'dro", tou'to th'i Lesbivai Guvrinna kai; jAtqi;" jAnaktoriva
“ciò che per lui (Socrate) erano Alcibiade. Carmide e Fedro, per la poetessa di Lesbo
erano Girinno, Attide ed Anattoria”. E cfr. anche Suida s. u. Sapfwv: […] eJtai'rai d∆•
aujth'" kai; fivlai gegovnasi trei'", jAtqiv", Telesivppa, Megavra “le sue compagne
ed amiche sono state tre: Attide, Telesippa e Megara”. Per Attide in questo stesso
commentario cfr. Fr. 10 (b).2 e ad loc.
Fr. 10 (b)
2 [At]qi glu[k- è un’integrazione che la Voigt (1971, 100) attribuisce a Max Treu.
Per Attide cfr. Fr. 10(a).15 e ad loc. Per gluvku" cfr. Sapph. DV qV 3 = 63.3 V. (v.
supra) gluvku" q≥[ev]o" “dolce dio”; 102.1 gluvkha ma'ter “dolce madre”. Possibile,
dunque, [At]qi gluv[kh(a).
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
360
Bibliografia
AHRENS 1839 H. L. Ahrens, De graecae linguae dialectis, I, De
dialectis aeolicis et pseudaeolicis, Gottingae 1839
AHRENS 1839b H. L. Ahrens, Conjecturen zu Alcaeus, Sappho,
Corinna, Alcman an Professor Schneidewin, «RhM» 6
(1839), pp. 226-239
AHRENS 1843 H. L. Ahrens, De graecae linguae dialectis, II, De
dialecto dorica, Gottingae 1843
ALLEN-SIKES 1904 Th. W. Allen - E. E. Sikes, The Homeric Hymns,
edited, with preface, apparatus criticus, notes, and
appendices., London 1904 (www.perseus.tufts.edu/cgi-
bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0029&qu
ery=id%3D%2330 ).
ALONI 1997 Saffo, Frammenti, a cura di A. Aloni, Firenze 1997
ASHERI 1988 Erodoto, Le Storie. Libro I. La Lidia e la Persia, a cura
di D.Asheri, Traduzione di V. Antelami, Milano 1988
(20016)
AUSTIN 2007 C. Austin, Nuit Chaudes à Lesbos: buvon avec Alcée,
aimon avec Sappho, in BASTIANINI – CASANOVA,
Atti, pp. 115-126
BARTOL 1997 K. Bartol, Saffo e Dika (Sapph. 81 V.), «QUCC» 56
(1997), p. 75-80.
BASTIANINI – CASANOVA, Atti del IX Convegno Internazionale di Papirologia "I
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
361
Atti Papiri di Saffo e di Alceo" (Firenze 8-9 giugno 2006),
a cura di G. Bastianini e A. Casanova, Firenze 2007
BELOCH, GG J. Beloch, Griechische Geschichte, Strassburg 1893
BERGK1 1843 Poetae Lyrici Graeci, rec. Th. Bergk, Lipsiae 1843
BERGK2 1853 Poetae Lyrici Graeci, rec. Th. Bergk, Lipsiae 1853
BERNSDORFF 2005 H. Bernsdorff, Offene Gedichtschlusse, «ZPE» 153
(2005), p. 1-6.
BETTARINI 2005 L. Bettarini, Note linguistiche alla nuova Saffo, «ZPE»
154 (2005), p.33-39.
BLASS 1874 F. Blass, Zu den griechischen Lyrikern, «RhM» 29
(1874), pp. 149-158
BLOMFIELD 1823 C. J. Blomfield, Sapphonis Alcaeique fragmenta, ed. C.
J. Blomfield ap. Museum Criticum or Cambridge
Classical Researches - vol. I, p. 1-31 (1813) et 421-444
(1814); iterum ap. Poetae Minores Graeci, ed. Th.
Gaisford, vol. III, Lipsiae 1823, pp. 289-314 (da cui
cito).
BLUMENTHAL 1940 A. von Blumenthal, Beobachtungen zu griechischen
Texten II, «Hermes» 75 (1940), pp. 124- 128.
BOURRIOT 1976 F. Bourriot, Recherches sur la nature du genos. Etude
d'Histoire Sociale Athenienne – Periodes Archaique et
Classique, Paris 1976
BOWRA 1961 C. M. Bowra, Greek lyric poetry. From Alcman to
Simonides, Oxford 1961
BRADEEN 1963 D. W. Bradeen, The Fifth-Century Archon List, «Hesperia»
vol. XXXII, n. 2, April-June 1963, pp. 187-208.
BURZACCHINI 1991 G. Burzacchini, recensione de D. Pieraccioni, Manara
Valgimigli-Giorgio Pasquali. Storia di un’amicizia. 1912-
1952 («Studi Valgimigliani» a c. di P. Pellegrino, 5),
Milazzo (Spes) 1989, 96 pp. 15 ill., «Eikasmos» II (1991),
pp. 393-396.
BURZACCHINI 1995 G. Burzacchini, Lirica arcaica (I). Elegia e giambo. Melica
monodica e corale (dalle origini al VI sec. a. C.), in
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
362
Senectus. La vecchiaia nel mondo classico, a cura di U.
Mattioli, Bologna 1995
BURZACCHINI 2007 G. Burzacchini, Saffo frr.1,2,58 V. tra documentazione
papiracea e tradizione indiretta, in BASTIANINI –
CASANOVA, Atti, pp. 83-114
CAMPBELL 1982 D. A. Campbell, Greek Lyric. I. Sappho and Alcaeus,
Cambridge / Mass. – London 1982
CANFORA 2005 L. Canfora 2005, Saffo, la seconda ode alla divina
Afrodite, «Corriere della Sera» 3 settembre 2005, p. 39.
CASAUBONUS 1600 I. Casauboni, Animadversionum in Athenaei
Deipnosophistas (1600), Lugduni 1612
CAVALLINI 1986 E. Cavallini, Presenza di Saffo e Alceo nella poesia
greca fino ad Aristofane, Ferrara 1986
CAVALLINI 1991 E. Cavallini, Due poetesse greche, in F. De Martino (a
cura di), Rose di Pieria, Bari 1991, pp. 97-135
CHANTRAINE, DELG P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue
grecque. Histoire des mots, Paris 1999
CHANTRAINE, Morph. P. Chantraine, Morphologie historique du grec, Paris
19612
COPPOLA 2005a G. Coppola, Makareus tra Eoli e Pelasgi, in Mele-
Napolitano-Visconti 2005, pp.73-93
COPPOLA 2005b G. Coppola, Mirsilo di Metimna e la storia di Lesbo, in
Mele-Napolitano-Visconti 2005, pp. 153-175
DANIELEWICZ 2006 J. Danielewicz, Bacchylides fr. 20a, 12 S.-M. and
Sappho, P. Köln fr. I-II, 12, «ZPE» 155 (2006), pp. 19-
21.
DE SANCTIS, [Atqi"
G. De Sanctis, ATQIS, Storia della repubblica ateniese
dalle origini alla età di Pericle, Torino 1912 (19111)
DE SANCTIS, SG G. De Sanctis, Storia dei Greci dalle origini alla fine
del secolo V, Firenze 1940 (19391)
DETIENNE-VERNANT 2005 M. Detienne – J.-P. Vernant, Le astuzie
dell’intelligenza, Roma-Bari 20052
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
363
DEVELIN 1989 R. Develin, Athenian Officials. 684-321 BC,
Cambridge 1989 (2003)
DI BENEDETTO 1955 V. Di Benedetto, Pittaco e Alceo, PP 41 (1955), pp.
97-118; poi nuovamente in Id., Il richiamo del testo.
Contributi di Filologia e letteratura, II, Pisa 2007, pp.
771-789.
DI BENEDETTO 1965 Euripidis, Orestes, a cura di V. Di Benedetto, Firenze
1965
DI BENEDETTO 1978 V. Di Benedetto, L'idelogia del potere e la tragedia
greca. Ricerche su Eschilo, Torino 1978
DI BENEDETTO 1982a V. Di Benedetto, Contributi al testo di Saffo, «RFIC»
110 (1982), pp. 5-21.
DI BENEDETTO 1982b V. Di Benedetto, Sulla biografia di Saffo, «SCO»
XXXII (1982), pp. 217-230.
DI BENEDETTO 1983 Di Benedetto, Osservazioni intorno a *aus- e *aieri,
«Glotta» LXI (1983).
DI BENEDETTO 1985 V. Di Benedetto, Il tema della vecchiaia ed il fr. 58 di
Saffo, «QUCC» 48 (1985), pp. 145-163.
DI BENEDETTO 1987 V. Di Benedetto, Introduzione in Saffo, Poesie,
Introduzione di V. Di Benedetto – Traduzione e note di
F. Ferrari, Milano 1987, pp. 5-78.
DI BENEDETTO 2004a V. Di Benedetto, L'ultimo pianto di Saffo, «La Stampa» 25
agosto 2004, p. 21.
DI BENEDETTO 2004b V. Di Benedetto, Osservazioni sul nuovo papiro di Saffo,
«ZPE», 149 (2004), pp. 5-6.
DI BENEDETTO 2005 V. Di Benedetto, La nuova Saffo e dintorni, «ZPE»,151
(2005), pp.7-20.
DI BENEDETTO 2006 V. Di Benedetto, Il tetrastico di Saffo e tre postille, «ZPE»,
155 (2006), pp. 5-18.
DI BENEDETTO 2007 V. Di Benedetto, Il richiamo del testo. Contributi di
Filologia e letteratura, I-IV, ETS, Pisa 2007
DI DONATO 2005a R. Di Donato, Lingua, cultura e civiltà: il problema
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
364
storico dell'identità eolica, in Mele-Napolitano-
Visconti 2005, p. 9-13
DI DONATO 2005b R. Di Donato, Formazioni sociali minori a Mitilene:
l'evidenza della poesia eolica, in Mele-Napolitano-
Visconti, pp. 95-101
DI DONATO 2006 R. Di Donato, Aristeuein. Premesse antropologiche ad
Omero, Pisa 2006
DIEHL 1917 Supplementum Lyricum, ed. E. Diehl, Bonn 19173
DIEHL1
1923 Anthologia lyrica graeca, edidit E. Diehl, 1, Lipsiae
19231
DIEHL2 1936 Anthologia lyrica graeca, edidit E. Diehl, 1, Lipsiae
19362
DIEHL 1944 E. Diehl, Lyrici graeci redivivi, «RhM» 92 (1944), pp.
1-26.
DIKAIOMATA 1913 Dikaiomata, Auszuge aus Alexandrinischen Gesetzen
und Verordnungen in einem Papyrus des
Philologischen Seminars der Universitat Halle (Pap.
Hal. 1), mit einem Anhang weiterer Papyri derselben
Sammlung, Hrsg. von der Graeca Halensis, Berolini
1913
DINDORF 1827 Athenaeus, ex recensione G. Dindorfii, vol. III, Lipsiae
1827
EDMONDS1 1922 J. M. Edmonds, Lyra Graeca, London – New York
1922
EDMONDS 1927 J. M. Edmonds, Some New Fragments of Sappho,
Alcaeus and Anacreon, «PCPhS» 136/38 (1927), pp. 13ss.
EDMUNDS 2006 L. Edmunds, The new Sappho: e[fanto, «ZPE» 156
(2006), pp. 23-26.
EVANS 1985 J. A. S. Evans, Candaules, whom the Greeks name
Myrsilus…, «GRBS» XXVI (1985), pp. 229-233.
FASSINO-PRAUSCELLO 2001 M. Fassino – L. Prauscello, Memoria ritmica e
memoria poetica: Saffo e Alceo in Teocrito Idilli 28-30
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
365
tra ajrcaiologiva metrica e innovazione alessandrina,
«MD» 46 (2001), pp. 9-37.
FERRARI 1987 v. DI BENEDETTO 1987
FERRARI 2003 F. Ferrari, Il pubblico di Saffo, «SIFC» s. IV vol. I
(2003), pp. 42-89.
FERRARI 2005 F. Ferrari, Contro Andromeda: recupero di un'ode di
Saffo,«MD», 55 (2005), pp. 13-30.
FERRARI 2007a F. Ferrari, Una mitra per Kleis. Saffo e il suo pubblico,
Giardini, Pisa 2007.
FERRARI 2007b F. Ferrari, "Hai fatto la tua scelta": due storie di
diserzione attraverso i papiri di Saffo, in BASTIANINI
– CASANOVA, Atti 2007, pp. 17-29
F-G. 1806 F-G.,censura Athenaei NaucratitaeDeipnosophistarum
libri XV, ex optimis codicibus nunc prim. collatis
emendavit ac supplevit, nova latina versione et
animadversionibus cum Is. Casauboni aliorumque tum
suis illustravit commodisque indicibus instruxit
Iohannes Schweighäuser cet., Tom. I (1801)-V (1805),
Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, III jahrgang,
band IV, 247 (18 october 1806) – 251 (23 october
1806), pp. 121-156.
FICK 1891 A. Fick, Die sprachform der lesbischen lyrik, «Beiträge
zur kunde der indogermanischen sprachen», 17 (1891), pp.
177-213
FIORILLO 1803 R. Fiorillo, Observationes criticae in Athenaeum, I,
Gottingae 1803
FRAENKEL 1942 E. Fraenkel, An epodic Poem of Hipponax, «CQ» 36
(1942), pp. 54-56 (poi in Id., Kleine Beiträge zur
klassischen Philologie, I, Roma 1964).
FRAENKEL, Horace E. Fraenkel, Horace, Oxford 1957
FRÄNKEL 1928 H. Fränkel, censura editionum E. Lobel (Sapfou'"
mevlh, 1925 et jAlkaivou mevlh, 1927) ap. «GGA» 1928,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
366
pp. 258-278.
FRÄNKEL 1962 H. Fränkel, Dichtung und Philosophie des frühen
Griechentums, München 1962 (19934)
FUNGHI–MESSERI
SAVORELLI 1992
M. S. Funghi – G. Messeri Savorelli, Lo “scriba di
Pindaro” e le biblioteche di Ossirinco, «SCO», 42
(1992), pp. 43-62.
FUSTEL 1878 N.-D. Fustel De Coulanges, La citè antique, Paris
18787 (1864
1)
GAISFORD 1810 Hephaestionis Alexandrini Enchiridion…curante
Thoma Gaisford, Oxonii 1810
GALLAVOTTI 1948 C. Gallavotti, Storia di Lesbo nel VII-VI secolo a.C..
Alceo di Mitilene, Bari 1948
GALL(AVOTTI). C. Gallavotti, Saffo e Alceo. Testimonianze e
frammenti, Collana di Studi Greci, X e XV, Napoli
19562 e 1957
2
GENTILI 2006 B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Milano
20064 (1984
1)
GERNET 1937 L. Gernet, Notes de Lexicologie juridique, Annuaire de
l'Inst.de Philologie et d'Hist. or. et. slaves, t. V,
Mélanges Emile Boisacq, Bruxelles 1937, pp. 391-398.
GERNET 1968 L. Gernet, Anthropologie de la Grèce antique, Paris
1968
GERNET 1997 L. Gernet, La famiglia nella Grecia antica, a cura di R.
Donato, Roma 1997
GLOTZ 1904 G. Glotz, La solidarité del la famille dans le droit criminel
en Grèce, Paris 1904
GRANDOLINI 2000 S. Grandolini, Forme rituali e coscienza religiosa nel tiaso
di Saffo, in M. Cannatà Fera – S. Grandolini (a cura di),
Poesia e religione in Grecia. Studi in onore di G. Aurelio
Privitera, Perugia 2000, pp. 353-365
GRONEWALD-DANIEL 2004a M. Gronewald - R. W. Daniel, Ein neuer Sappho-Papyrus,
«ZPE»,147 (2004), pp. 1-8.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
367
GRONEWALD-DANIEL 2004b M. Gronewald - R. W. Daniel, Nachtrag zum neuen Sappho-
Papyrus, «ZPE»,149 (2004), pp. 1-4.
GRONEWALD-DANIEL 2005 M. Gronewald - R. W. Daniel, Lyrischer Text (Sappho-
Papyrus), «ZPE», 154 (2005), p.7-12.
GROTE 1849 G. Grote, History of Greece, vol. III, London 18492
GUSMANI 1964 R. Gusmani, Lydisches Wörterbuch, Heidelberg 1964
HAMM 1954 E. - M. Hamm, censura "The Oxyrhynchus Papyri, Part
XXI", «Gnomon» 26 (1954), pp.453-456
HAMM 1958 E.- M. Hamm, Grammatik zu Sappho und Alkaios,
Akademie Verlag, Berlin 1958
HARDIE 2005 A. Hardie, Sappho, the Muses and the Life after Death,
«ZPE», 155 (2005), pp. 13-32.
HERMANN 1835 G. Hermann, Über Homer und die Fragmente der
Sappho, «Wiener Jahrbüchern» LIV(1831); poi in G.
Hermann, Opuscula, VI. Pars I, Leipzig 1835
HODOT 1990 R. Hodot, Le dialecte éolien d’Asie. La langue des
inscription. VIIe s. a. C. - IV
e s. p. C., Paris 1990
HOFFMANN 1893 O. Hoffmann, Die griechischen Dialekte, II Band –
Der nord-achäische Dialekt, Göttingen 1893
HUMBERT, Synt. J. Humbert, Syntaxe grecque, Paris 1972
HUMPHREYS 1978 S. C. Humphreys, Anthropology and the Greeks, London
1978
HUMPHREYS 1983 S. C. Humphreys, The family, women and death.
Comparative studies, London 1983
HUNT 1922 B. P. Grenfell – A. S. Hunt, New classical fragments: POxy.
1787-Sappho, Book IV in Id., The Oxyrhynchus Papyri, XV,
1922, pp. 26-46.
JANKO 2005 R. Janko, Sappho Revisited, «Times Literary
Supplement» 23&30/12/2005, pp. 19-20.
JOHNSON 2004 W. A. Johnson, Bookrolls and scribes in Oxyrhynchus,
Toronto 2004.
KAIBEL 1890 Athenaeus, Dipnosophistae, recensuit G. Kaibel, vol.
III, Stutgardiae 1890 (editio stereotypa 1992)
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
368
KOEN 1766 Gregorius, Corinthi Metropolita, De Dialectis, e
Codicibus MSS. emendavit & notis illustravit G. Koen,
Lugduni Batavorum 1766
KURKE 1992 L. Kurke, The politics of aJbrosuvnh in Archaic Greece,
«CA» 22 (1992), pp. 92-120.
LANATA 1966 G. Lanata, Sul linguaggio amoroso di Saffo, «QUCC»
2 (1966), pp. 63-79
LA PENNA 1972 A. La Penna, Sunt qui Sappho malint. Note sulla
suvgkrisi" di Saffo e Alceo nell’antichità, «Maia» n.s.
XXIV (1972), pp. 208-215.
LAPINI 2007 W. Lapini, Elementi biografici di Pittaco nei frammenti
alcaici, in BASTIANINI – CASANOVA, Atti 2007,
pp. 167-175
LARDINOIS 2006 A. Lardinois, A New Sappho Papyrus (P. Köln 21351):
Key to the Old Fragments,137th
Annual Meeting of the
American Philol. Association, Montreal, PQ, Canada,
January5-8,2006: http://www.apaclassics.org/
AnnualMeeting/06mtg/06meeting.html
LATTE 1949 K. Latte, Zur Textkritik Theokrits, «NAWG» 1949, p.
232 (n. 1)
LEAF 1900 W. Leaf, The Iliad, edited, with apparatus criticus,
prolegomena, notes, and appendices, London 1900
(Amsterdam 1971). (http://www.perseus.tufts.edu/cgi-
bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0056)
LEJEUNE, Phon. M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du
grec ancien, Paris 1972
LIBERMAN 1999 Alcée, Fragments, Texte établi, traduit et annoté par G.
Liberman, Paris 1999 (20022).
LIBERMAN 2007 G. Liberman, L'édition alexandrine de Sappho, in
BASTIANINI – CASANOVA, Atti, pp. 41-65.
LIVREA 2007 E. Livrea, La vecchiaia su papiro: Saffo Simonide
Callimaco Cercida, in BASTIANINI – CASANOVA,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
369
Atti, pp. 67-81
L(OBEL).-P(AGE). 1955 E. Lobel – D. L. Page, Poetarum Lesbiorum
Fragmenta, Oxonii 1955.
LOBEL 1925 E. Lobel, Sapfou'" Mevlh. The fragments of the lyrical
Poems of Sappho, Oxonii 1925.
LOBEL 1927 E. Lobel, jAlkaivou mevlh, The fragments of the lyrical
poems of Alcaeus, Oxonii 1927
LOBEL 1941 E. Lobel, POxy. 2166: Supplement to 1231, 1233,
1234, 1360, 1787, 1789, 2081 (c,d) in Id., The
Oxyrhynchus Papyri, XVIII, pp. 38-46.
LOBEL 1951a E. Lobel, POxy. 2290: Sappho, Book IV? in The
Oxyrhynchus Papyri, XXI (1951), pp. 7-10.
LOBEL 1951b E. Lobel, POxy. 2293: Commentary on Sappho (Book
IV?) in The Oxyrhynchus Papyri, XXI (1951), pp. 16-
23.
LOMBARDO 1983 M. Lombardo, Habrosyne e habrá nel mondo greco
arcaico, in Forme di contatto e processi di
trasformazione nelle società antiche, Atti del convegno
di Cortona (24-30 maggio 1981), Pisa-Roma 1983, pp.
1077-1103.
LUNDON 2007 J. Lundon, Il nuovo testo lirico nel nuovo papiro di
Saffo, in BASTIANINI-CASANOVA, Atti, pp. 149-
166
LUPPE 2004 W. Luppe, Ueberlegungen zur Gedicht-Anordnung im
neuen Sappho-papyrus, «ZPE», 149 (2004), pp. 7-9.
MAAS 1922 P. Maas, Ährenlese, «Sokrates» 10 (1922), pp. 179-180
MAGNANI 2005 D. Magnani, Note alla nuova Saffo, «Eikasmos» XVI
(2005), pp. 41-49.
MAZZARINO 1943 S. Mazzarino, Per la storia di Lesbo del VIo secolo
a.C., «Athenaeum» n.s. XXI (1943), pp. 38-78.
MAZZARINO 2007 S. Mazzarino, Fra Oriente ed Occidente. Ricerche di
storia greca arcaica, Torino 2007
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
370
MARTINELLI 1995 M. C. Martinelli, Gli strumenti del poeta. Elementi di
metrica greca, Bologna 1995.
MARZULLO 1994 B. Marzullo, Sapph. fr. 58, 25s. V., «Philologus» 138
(1994), pp. 189-193.
MELE 2005 A. Mele, Aiolos e gli Aiolidai: tradizioni anatoliche e
metropolitane, in Mele-Napolitano-Visconti, pp. 15-24
MELE-NAPOLITANO-
VISCONTI 2005
Eoli ed Eolide tra madrepatria e colonie, a cura di A.
Mele, M. L. Napolitano, A. Visconti, Napoli 2005
MEYER 1954 E. Meyer, Geschichte des Altertums, Basel 19543
(18931)
MORGAN 1970 L. H. Morgan, La società antica. Le linee del progresso
umano dallo stato selvaggio alla civiltà, Milano 1970
NAUCK 1848 Aristophanis Byzantii grammatici alexandrini
fragmenta collegit et disposuit Augustus Nauck, Halis
(Halle) 1848.
NEUE 1827 D. Chr. Fr. Neue, Sapphonis Mytilenaeae Fragmenta,
Berolini 1827
NICOLOSI 2005 A. Nicolosi, Nuove scoperte. Recuperi di lirica greca
arcaica da papiri, «A&R» L, ff. 2-3 (2005), pp. 80-94.
NICOSIA 1976 S. Nicosia, Tradizione testuale diretta ed indiretta dei
poeti di Lesbo, Roma 1976
NISBET-HUBBARD 1970 R. G. M. Nisbet – M. Hubbard, A commentary on
Horace, Odes, Book I, Oxford 1970
PAGE 1955 D. L. Page, An Introduction to the Study of Ancient
Lesbian Poetry, Oxonii 1955.
PEDLEY 1974 J. Pedley, Carians in Sardis, «JHS» XCIV (1974), pp. 96-
99
PERROTTA 1935 G. Perrotta, Saffo e Pindaro, Bari 1935
PIPPIN BURNETT 1983 A. Pippin Burnett, Three archaic poets. Archilochus,
Alcaeus, Sappho, London 1983
PORRO 1994 A. Porro, Vetera alcaica. L'esegesi di Alceo dagli
alessandrini all'età imperiale, Milano 1994.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
371
PORRO 1996 Alceo, Frammenti, a cura di A. Porro. Prefazione di G.
Tarditi, Firenze 1996
PORRO 2006 A. Porro, Libri e lettori antichi di Alceo, in
BASTIANINI – CASANOVA, Atti, pp. 177-189.
PUELMA-ANGIÒ 2005 M. Puelma - F. Angiò, Sappho und Poseidippos.
Nachtrag zum Sonnenuhr-Epigramm 52 A.-B. des
Mailänder Papyrus, «ZPE» 152 (2005), pp. 13-15.
PUGLIESE-CARRATELLI
2001
G. Pugliese Carratelli (a cura di), Le lamine d'oro
orfiche. Istruzione per il viaggio ultramondano degli
iniziati greci, Milano 20012
REITZENSTEIN 1897 R. Reitzenstein, Geschichte der griechischen
Eymologica. Ein Beitrag zur Geschichte der Philologie
in Alexandrian und Byzanz, Leipzig 1897
RÖSLER 1980 W. Rösler, Dichter und Gruppe, München 1980
ROUSSEL 1976 D. Roussel, Tribu et cité, Paris 1976
SCHADEWALDT 1936 W. Schadewaldt, Zu Sappho, «Hermes» 71 (1936), pp.
363-373
SCHADEWALDT 1950 W. Schadewaldt, Sappho, Welt und Dichtung, Potsdam
1950
SCHNEIDEWIN 1838 Delectus poesis Graecorum elegiacae, iambicae,
melicae, edidit F. G. Schneidewin, Gottingae 1838
SCHWEIGHÄUSER, Anim. Animadversiones in Athenaei Deipnosophistas, post I.
Casaubonum conscripsit I. Schweighäuser, VIII,
Argentorati 1805.
SEIDLER 1829 H. Seidler, Über einige Fragmente der Sappho und des
Alcäus, «RhM» 3 (1829), pp. 153
SITZLER 1898 J. Sitzler, Bericht über die griechischen Lyriker (mit
Ausnahme Pindars), Bukoliker, die Anthologia
Palatina und die Epigrammensammlungen für 1891-
1894, «Jahresbericht über die Fortschritte der
classischen Altertumwissenschaft» 92 Bd. – 25 Jahrg.
(1898), pp. 1-204.
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
372
STIEBITZ 1926 F. Stiebitz, Zu Sappho 65 Diehl, «Philol. Wochenschr.»
45/46 (1926), coll. 1259-1262.
TEDESCHI 2005 G. Tedeschi (a cura di), Saffo, Biografia ed antologia
di versi, Trieste 2005.(http://termit.sslmit.univ.trieste.it/
crevatin/documenti/saffo.pdf)
THEANDER 1943 C. Theander, Lesbiaca, «Eranos» XLI (1943), pp. 139-
168.
TOUPIUS 1778 Dionysii Longini quae supersunt graece et latine,
recensuit…J. Toupius, Oxonii 1778
TREU 1968 M. Treu, Von Homer zur Lyrik, München 19682
TREU 1976 Sappho.Griechisch und deutsch hrsg. von M. TREU,
München 1976.
V(OIGT). 1971 Sapphus et Alcaeus. Fragmenta, edidit E.-M. Voigt,
Amsterdam 1971.
WELCKER 1828 F. G. Welcker, censura editionis C. F. Neue Sapphonis
Mytilenaeae Fragmenta, «Jahrbücher für Philologie
und Pädagogik (Jahnii Analecta)» 6 (1828), pp. 389-
433.
WEST 1966 M. L. West, Hesiod. Theogony, Clarendon Press,
Oxford 1966
WEST 1970 M. L. West, Burning Sappho, «Maia» n.s., XXII
(1970), pp. 307-330.
WEST 1971 M. L. West, Iambi et Elegi Graeci Ante Alexandrum
Cantati, I, Oxonii 1971
WEST 2005 M. L. West, The new Sappho, «ZPE»,151 (2005), pp.1-
9.
WILAMOWITZ 1913 U. von Wilamowitz-Moellendorff, Sappho und
Simonides, untersuchungen über griechische Lyriker,
Berlin 1913
WILAMOWITZ 1931-1932 U. von Wilamowitz-Moellendorff, Der Glaube der
Hellenen, I-II, Berlin 1931-32
WILLIAMSON 1995 M. Williamson, Sappho's Immortal Daughters,
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
373
Cambridge, Mass.-London 1995
Indice degli antroponimi, dei toponimi, degli
idronimi e di altri dati notevoli
A
abrosyna; 171 Acaia; 47; 48 Acasto; 302 Acheronte; 158; 189; 214; 215; 229; 301; 304; 357 Achille; 53; 131; 167; 170; 212; 233; 248; 307 Achilleio; 61 Actéa; 14 Ade; 125; 133; 134; 147; 215; 216; 217; 218; 219;
246; 265 Adonis; 195; 344 Adramyttium; 9; 93 Adrasto; 35 Aeria; 199 Afidna; 14 Afidne; 14 Afrodite; 103; 142; 167; 175; 191; 192; 194; 195; 196;
197; 198; 199; 200; 201; 202; 210; 211; 212; 213;
261; 266; 270; 274; 286; 287; 292; 336; 342; 343; 345; 346
Agamede città dell'isola di Lesbo; 50 figlia di Macare; 50
Agamennone; 25; 55; 58; 143; 212; 233; 307 Agenore; 247
figlio di Anfione e di Niobe; 334 Agesia; 41 agesicoreo; 111 Agesidamo; 252 Agiadi; 13 Agrigento; 79; 249 Aiace
Filaide; 43 Aioliká; 55 aJbrosuvnh; 177 akrasia; 75 akratisma; 75 Alcandre; 302
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
374
alceidi; 78 Alceidi; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 71 Alceo; 5; 8; 11; 12; 13; 48; 55; 60; 61; 62; 63; 64; 65;
66; 67; 68; 70; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 81; 96; 100; 111; 112; 116; 117; 133; 134; 155; 156; 157; 175; 177; 182; 186; 197; 219; 222; 223; 224; 226; 235; 257; 265; 290; 291; 308; 309; 312; 322; 328; 329; 354; 370
Alcesti; 174 tragedia di Euripide; 174
Alcibiade; 94; 95; 232; 349; 359 Alcinoo; 135; 308 Alcione; 48 Alcmane; 86; 88; 111; 117; 156; 157; 334; 349 Alcmena; 160 Alcmeone; 42 Alcmeonide; 43; 46 Alcmeonidi; 13; 31; 41; 42; 43; 44; 46 Ali el Gamman; 117; 118 Aliatte; 9; 68; 91; 92; 93 Alicarnasso; 8; 49; 101 Amasi; 10; 91 Amicla; 334 Anacreonte; 100; 134; 252; 309 Anattoria; 5; 94; 349; 359 Anchite; 142 Andro
isola; 5 Andromaca; 214 Andromeda; 12; 81; 94; 95; 98; 99; 178; 189; 191;
203; 204; 205; 211; 216; 217; 241; 249; 252; 253; 280; 295; 311; 329; 337; 347; 349; 355; 359
Androzione; 50 Anfinomo; 35 Anfione; 332; 334 Anfissa; 48
figlia di Macareo; 48 Anfitrite; 56; 57 Antenore; 302 Antìclea; 131 Anticlide Ateniese; 57; 58 Antimaco; 24 Antimaco di Colofone; 163 Antimenida; 60; 64; 68 Antioche; 38 Antioco
padre di Tisameno; 41 Antissa
altro nome dell'isola di Lesbo; 53 cttà dell'isola di Lesbo; 50 figlia di Macare; 50
Aoni; 14 Apaturie; 25 Apione; 353; 354 Apollo; 14; 22; 37; 40; 41; 48; 77; 148; 152; 153; 196;
308; 332; 334 Apollodoro; 32; 62 Apollonio Sofista; 353 Arcadi; 49 Arcadia; 49; 54
Archeanassa; 77 Archeanatte; 61; 77 Archeanattide; 76; 77 Archeanattidi; 13; 44; 77 Archelao; 54; 55; 58 Archestratide
arconte ateniese; 69 Archiloco; 88; 100; 197; 349 Areopago; 53 Ares; 35; 160; 167; 213; 254; 258 Argadei; 14; 15 Argiride; 244 Argivi; 156; 209 Argo; 47; 193 Aristagora; 55 Aristarco di Samotracia; 100; 101; 113; 119 Aristeo; 140; 143 Aristocle; 7 Aristodemo; 161 Aristofane; 185 Aristofane di Bisanzio; 100; 101; 113 aristoi; 29 Aristomene
arconte ateniese; 68; 69 Aristotele; 16; 17; 18; 21; 46; 62; 80; 144 Armonia; 255; 256 Arsace; 166 Artemide; 35; 159; 194; 196; 205; 236; 241; 251; 310;
313; 332; 334; 355; 357 Ascalona; 64; 198; 199 Asclepiade; 72 asclepiadeo “minore”; 104 asc le pi ad eo mag g ior e ; 104; 110 asfoldeo; 234 Asia; 49; 64; 88; 157; 170; 177; 214 Asio; 89 Assiri; 170; 199 associazione cultuale; 126; 127; 128 Astafi; 240 Asteropéo; 35 Astiage; 68 Asticrazia
figlia di Anfione e di Niobe; 334 Astioche
figlia di Anfione e di Niobe; 334 Atena; 15; 20; 196; 264; 308; 309; 312 Atena Polias; 20 Atenaide; 14 Atene; 7; 8; 12; 13; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 27; 33;
41; 42; 43; 44; 46; 53; 60; 66; 67; 69; 90; 97; 303 Ateneo; 10; 41; 58; 81; 82; 96; 98; 99; 114; 163; 172;
176; 178; 180; 186; 204; 260; 262; 263; 266; 268; 269; 270; 355
Ateniesi; 9; 12; 15; 60; 61; 62; 69 Atride; 58; 233 Atridi; 63 Attica; 14; 17; 30 Attide; 5; 94; 95; 103; 205; 222; 232; 257; 301; 329;
340; 349; 359 tribù; 14
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
375
Attine; 48 Auge; 49 Aurora; 140; 149; 159; 161; 163; 164; 167; 168; 169;
236; 292; 333 Autoctono; 14
B
Babilonesi; 64 Bacchiadi; 13 Bacchilide; 335 barbari; 26; 226 Beata
città; 49 Beoti; 14 Beozia; 49 Biante; 91 Bisanzio; 100 Bosforo; 61 braccia di rosa
epiteto di Aurora; 104; 140; 149; 161; 292 Braurone; 14 Brese
località dell'isola di Lesbo. Vedi Brise breue; 108; 109 Brise
località di Lesbo, detta anche Brese; 50 Briséo
Dioniso; 50 Brytidai; 23 Buselidi; 24; 31 Butadi; 24; 30 Bute; 20; 24 Buzigi; 41
C
Cadmo; 152; 256 Calipso; 308 Callino; 88 Calliope; 102; 139; 141; 146; 147; 256 Camone; 5 Candalo; 48 Candaule; 81; 83; 84 Canone; 12 Carasso; 5; 6; 10; 11; 135 Cari; 14 Caria; 9; 10; 93 Cario
Zeus; 44 Cariti; 104; 194; 212; 239; 259; 266; 268; 270; 271;
282; 286; 292 Carme della vecchiaia; 119; 159; 329 Carmide; 94; 349; 359 Cartaginesi; 72 Castore; 35; 97; 132; 197; 253; 254; 255; 309 Castore Ilacide; 35 Catalogo delle donne; 48 catalogo delle Oceanine; 146 Caucaso; 160
Cecrope; 14 Cecropia; 14 Cecropide; 14 Cefalo; 167 Cefisia; 14 cefisie
acque; 194 Celti; 72 Cercafo; 48 Cercila; 5; 6 Cerinto; 39 Cesio Basso; 104 Cetó; 38 Cherobosco; 274; 276 Cheronea; 28 Chimera; 35 Chio; 52 Ciassarre; 68 cicala; 151; 154; 169; 179 Cicerone; 8; 102; 353 Cicladi; 49 Ciclo
epico; 258 Cidrolao; 52 Cillene; 49; 298 Cimone; 41 Cinira; 199 Cinzia
amante di Properzio; 160 Cipride; 192; 195; 197; 242; 288; 331 Ciprioti; 198 Cipro; 189; 194; 197; 198; 199; 210; 211 Cipselidi; 13; 39 Cipselo; 40; 43; 62 Circe; 73; 132 Citera; 195; 198; 199 Citerea; 188; 195; 336; 344 Citero; 14 Citerone; 334 civitas; 22 clan; 13; 18; 19; 33; 34; 36; 39; 40; 41; 44; 45 Claudio; 51; 354 cleanattide; 59; 66; 78 Cleanattide; 63; 70; 84; 86; 247 Cleanattidi; 7; 13; 44; 59; 62; 63; 64; 65; 66; 69; 76;
81; 84; 86 Clearco di Soli; 70; 172; 184; 186 Cleide
figlia di Saffo; 5; 215; 229; 231 madre di Saffo; 5
Cleodossa figlia di Anfione e di Niobe; 334
Cleomaco di Magnesia; 110 Clinia
padre di Alcibiade; 232 Clio; 102; 138; 146 Clistene; 15; 16; 30; 43; 46 Clitemestra; 53; 253 Clitiade; 41 Cloride; 334
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
376
Cnido; 197 collage; 192; 253; 256; 277; 291; 311 Colofone; 5; 87; 163; 176 Colonia; 119 colonizzazione pentilide; 56 Comete; 55 Commedia dantesca; 132 confini della terra; 166; 168 confini della Terra; 140; 149 coppa del Sole; 164 coriambo; 104; 112; 191; 328 Corinto; 13; 40; 62 coronide; 121 coronidi; 173; 343; 347 Costantinopoli; 286 Costituzione degli Ateniesi; 16; 17; 45; 46 Cranaide; 14 Cranao; 14 Creonte; 205; 245 Creso; 9; 11; 12; 43; 91; 92; 93 Creta; 35; 49; 195 Creusa; 14 Criaso; 49 Crinaco; 47; 48 Crizia; 352
arconte ateniese; 7 Cronide; 87; 168; 171; 175; 176; 189; 211; 212; 231 Crono; 148; 333 Ctesifonte; 45 curia; 22; 25
D
Damasia arconte ateniese; 69 figlio di Pentilo; 54
Damasittone figlio di Anfione e di Niobe; 334
Danai; 307 Dania; 160 Deceleia; 14 Deione; 167 Delfi; 43; 309 delfino; 56; 57 Deliasti; 40 Delio
Apollo; 40 Delo; 148; 167 Demarchi; 17 Demetra; 147; 216 Demiurghi; 33 demo; 17; 23; 30; 33 Demostene; 23; 32; 45 depas; 163 Deucalione; 47 Diacria; 14 Diade; 14 Didimo; 20; 353 Dika; 259; 260; 262; 263; 268; 269; 270; 274; 275 dikē; 27; 63
diluvio epoca di Deucalione; 47
Dimani; 15; 309 dimetro ionico a maiore acataletto; 110 Diocle; 35 Diodoro Siculo; 46; 47; 48; 49; 51; 52 Diogene Laerzio; 8; 9; 13; 60; 67; 68; 69; 76; 79; 80;
92 Diomeda; 167 Diomede; 35 Dionigi d'Alicarnasso; 49 Dioniso; 50; 51; 135; 255 Dioscuri; 97; 132; 197; 253; 255; 309 diphron; 165 dita di rosa
epiteto di Aurora; 161; 311 Dorica; 6; 10; 11; 331 Dracone; 20; 27; 302 Draconte; 59; 65; 79; 80 dynasteîai; 65
E
E(e)rigio; 5 E(u)rigio; 5; 6 Eaco; 43; 133; 217 Echela
figlio di Pentilo; 54; 55; 58 Ecrito; 5 edizione alessandrina di Saffo; 101 Eèta; 73 Efeso; 89; 97 Efestia; 14 Efestione; 100; 103; 104; 105; 108; 109; 110; 114;
273; 275; 276 Efesto; 163; 197; 358 Ege; 157 Egeo; 199 Egesistrato; 8; 11 Egicorei; 14; 15 egida; 15; 193 Egina; 43 egioco
epiteto di Zeus; 188; 193 Egisto; 53; 54 Egitto; 6; 10; 67 Elena; 73; 97; 193; 236; 253; 254; 302 Eleno
figlio di Priamo; 307 Elettrione; 48 Eleusi; 14 Eliadi
dramma di Eschilo; 164 Eliano; 51 Elicaone; 302 Elide; 32; 52 Elio; 48 Eliodora; 288 Elladio; 145 Ellanico; 48; 55; 169
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
377
Elleni; 41 Ellesponto; 49 Emazione
figlio di Aurora e di Titono; 167 Enalo; 56; 57; 58 endecasillabo falecio; 104 en n ea de ; 102 Eoli; 55 eolide; 48; 56 Eolide; 54; 55; 160 Eolo; 48; 52 Eos; 159; 163; 166; 167; 170; 177 Epacria; 14 Epimenide; 70 Epitalami; 102; 106 Epithalamia; 105 Eracle; 81; 135; 164; 195; 249; 254; 255 Eraclea
poema di Pisandro; 164 Eraclidi; 54
dramma di Eschilo; 164 Eraclito; 89 Eraclito Stoico; 312 Eratò; 102; 146 Ereso; 5; 6; 50; 70
figlia di Macare; 50 Eretteo; 14 Erides; 38 Erigone; 53; 54 Eritea; 164 Eritre; 77 Erittonio; 14 Ermione; 53; 100 Erodoro; 334 Erodoto; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 18; 41; 42; 43; 44; 61;
81; 83; 84; 91; 93; 102; 193 Eros; 140; 161; 185; 231; 251; 308; 313; 325; 329 Eroti; 286; 337; 346 Eschilo; 24; 133; 164; 197; 335 Eschine; 45 Esichio; 78; 302; 316; 343; 353 esimnete; 62; 69; 75; 81; 91; 92; 93 esimnetia; 7; 27; 62; 65; 66; 69; 70; 91 Esiodo; 37; 38; 47; 48; 88; 102; 116; 146; 167; 181;
193; 234; 254; 258; 264; 265; 308; 334 Esperidi; 163 Estiotide; 49 Età oscure; 13; 21; 26; 31 Etarco; 5 Eteobutadi; 13; 16; 20; 24; 30 Etiopi; 163; 167; 212 Etiopia; 167 Etneo
Zeus; 146 Etodéa
figlia di Anfione e di Niobe; 334 Etone; 39; 244 Ettore; 132; 201; 214; 223; 231; 307; 309 Eubea; 39; 49; 157 Eubulide; 24; 32
Euforione di Calcide; 20 Eumeno; 5 Eumolpidi; 16; 24; 45 Euneides; 30 Eunica; 5 Eupatridi; 15; 27; 33 Eupinito
figlio di Anfione e di Niobe; 334 Eupoli; 44 Euridice; 140; 141 Euripide; 126; 174; 177; 234; 335 Euripontidi; 13 Euristeo; 35 Eurota
fiume; 255 Eusebio; 6; 7; 8; 11; 12 Eustazio; 182; 349 Euterpe; 102; 146 Eutidemo; 80 Evadne; 41 eythynai; 45
F
Faone; 175; 177 fatria; 21 Feaci; 308 Febo; 142 Fedimo
figlio di Anfione e di Niobe; 334 Fedro; 94; 349; 359 Femio; 226 Fenarete
madre di Socrate; 232 Fenice; 261; 307 Fenici; 198; 199; 240 Fetonte; 48; 167 Filaidi; 41; 43; 44 Fileo; 43 Filippo; 28 Filocoro; 14; 33 Fitalidi; 24 Fitalo; 24 Flegia; 332 Flegra
piana di; 160 floruit; 10; 11; 68 Focide; 49 Foloe; 49 Forbante; 52 Fortunaziano; 104 Fozio; 145; 286 fratria; 16; 17; 21; 22; 24; 25; 28; 33; 35 fratriarca; 25 Frinico; 288 Frinone; 9; 11; 12; 60; 61; 69; 77 Ftia
figlia di Anfione e di Niobe; 334 Fusco; 160
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
378
G
Geleonti; 14; 15 Gelone; 79 geneá; 42; 43 gennētai; 16; 17; 23; 32 genos; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 55; 218; 237; 244; 255
gens; 14; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 45 gente; 28 Gheomori; 33 Gire; 313 Girinna; 94 Girinno; 94; 108; 166; 271; 273; 274; 275; 337; 342;
347; 349; 359 Giuba
terra di; 160 Giuseppe Flavio; 354 Giustizia; 207; 208 Glauco; 35; 38; 313 gliconeo; 103; 104; 105; 110 Gongila; 5; 137 Gorgia; 94 Gorgò; 12; 94; 95; 97; 99; 178 Gorgòne; 193 Gra
figlio di Echela; 54; 55; 57; 58 Graus
altro nome di Gra; 55 Greci; 15; 81; 83; 194; 260; 263 Grecia; 13; 22; 26; 27; 28; 30; 34; 42; 49; 55; 88; 90 Grinea; 74 guerra di Troia; 53; 54
H
habrosyne; 67; 87; 88; 90; 176; 177 Hattusa; 84 Hattusilis I
re ittita; 84 Helios; 164; 167; 202 Hera; 35; 89; 236; 309 Hermes; 81; 82 Hesychides; 30 Hipponion; 217 hopla; 15 Hyrras; 70; 71; 72; 73; 75; 91; 97; 99; 187
I
Iade antica regione greca, poi chiamata"Acaia"; 47
Iamidi; 41; 44 Iamo; 41 Iase; 56 Iberi; 72 Ibico; 309 Idaspe; 160 Ierone; 79; 138
Iliade; 34; 48; 53; 132; 181; 182; 193; 195; 234; 236; 247; 249; 267; 283; 306; 346; 348
Ilio; 36; 135; 156; 249 Ilizia; 184; 332
epiteto di Artemide; 251 Illei; 15; 309 Ilo; 167; 170 Imera
altro nome della città di Issa; 50 Imerio; 270; 286 institutum; 18; 19; 20; 21; 22; 34; 37; 38 Ione; 14; 15; 22; 94; 95; 97 Iperione; 163; 167 Iperionide; 164 Ippia; 8; 46 Ippolita; 302 Ipponatte; 81; 82; 89; 90; 120 ipponattei acefali; 112; 119; 120; 328 Ippote; 52 Irene; 108; 273; 276; 277; 324 Iride; 147; 302 Irra; 62; 64; 65; 77 Irradio; 69 Irrieo; 48 Isagora; 43; 44; 46 Iseo; 24; 32 Ismeno; 255
figlio di Anfione e di Niobe; 334 Issa
altro nome dell'isola di Lesbo; 53 città dell'isola di Lesbo; 50 figlia di Macare; 50 nome dell'isola di Lesbo; 47
Itaca; 35; 37
K
Kaiko; 69 kandaulos; 82 kandaylēs; 82 kandylos; 82 Kathetos; 20 Ker; 234 Kerykes; 16; 20; 30; 40; 41; 44; 45 Kikis; 60 kôm; 117; 118 Krokonides; 30 Kypselos
arconte ateniese; 7
L
Lacedemoni; 41 Laconico
Golfo; 195 Laerte; 37; 288 Lalage; 160 Laodice; 302 Laomedonte; 169 Lapite; 49; 52
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
379
Larico; 5; 6 Laso; 334 Latona; 74; 148; 332; 334; 335 Leda; 140; 160; 254; 255; 309 Lelanto; 39 Leofanto; 221 Lesbiaká; 53; 56 Lesbii; 52 Lesbo; 6; 7; 8; 13; 27; 30; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52;
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 64; 65; 70; 77; 81; 86; 94; 99; 128; 158; 160; 181; 283; 349; 359; 370 eroe eponimo dell’isola; 51
Leucade; 32; 234 Leucippe; 167; 169 Leucippo; 52; 302 Lexicon Patmense; 16 Licambe; 222 Licaone; 49 Licia; 47; 267 Licomidi; 13; 24 Lidi; 9; 43; 67; 68; 81; 82; 84; 87; 88; 91; 93; 167; 176;
206 Lidia; 9; 12; 30; 60; 62; 66; 81; 86; 90; 91; 92 lineare B; 34 lirica arcaica; 40 lirici arcaici; 11; 39; 99; 178; 246; 358 Lisia; 20 Locri; 32 Locride; 48 Longino; 273 Lossia; 245 Lotta; 193 Luciano; 353
M
Macare; 47; 48; 49; 50; 51; 52 Macareo
altro nome di Macare; 48; 49 sacerdote di Dioniso; 51
Macaria città; 49
Macaro; 48 Magnesia; 110 Malèa
Capo; 195 Mani; 160 Marcello; 166 Marco Aurelio; 104 Marmor Parium; 6; 7; 12; 64; 67 Massimo di Tiro; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 215; 359 Medea; 146 Medi; 68 Medioevo ellenico; 21; 26 Mediterranea; 14 Mediterraneo
nome di uno scoglio; 57 Megacle; 7; 59
Alcmeonide; 43 Megara; 5; 241; 243; 257; 359
Megiste; 252 Melancro; 7; 12; 59; 60; 62; 69; 70 Melanippo; 8 Melia; 255 Melibea; 49 Melibèa; 334 Melitone; 20 Melpomene; 102; 115; 136; 146; 271 Memnone
figlio di Aurora e di Titono; 167 Menelao; 35; 177; 302; 307; 322 meonia; 82 Metimna
città dell'isola di Lesbo; 50; 52; 58 figlia di Macare; 50; 52
Mica; 220; 224 Micco; 221 miceneo; 26; 162; 283 Micerino; 6; 10 Mileto; 5 Milziade; 41; 43 Mimnermo; 163; 169; 334 Mini; 194 Minosse; 35 Mirsilo; 7; 12; 56; 58; 62; 63; 64; 65; 75; 76; 78; 81;
83; 84; 312 Mirsilo di Lesbo; 53; 56 Misi; 24; 54; 55 misteri; 40 Mitilene; 6; 7; 8; 10; 12; 44; 50; 52; 59; 60; 61; 62; 64;
66; 67; 69; 70; 71; 77; 84; 90; 95; 160; 176; 187 figlia di Macare; 52
Mitilenese; 65; 69; 70; 86; 91 Mitilenesi; 6; 8; 12; 60; 61; 62; 65; 71 mitra; 67; 85; 86; 91 mivasma; 27 Mnaide; 273 Mnasidica; 108; 271; 273; 275; 349 Mnasidika; 274 Mnemone; 63 Mnemosyne; 218; 219 Moira; 309 moisopolos; 126 mola; 70; 160 Moralia; 56 Moros; 234 Morte; 234 Murshilis I; 84 Musa; 115; 123; 125; 136; 137; 141; 146; 148; 152;
215; 224; 254; 256; 279; 280 Muse; 102; 125; 126; 127; 128; 129; 134; 136; 137;
146; 147; 148; 152; 153; 154; 159; 174; 212; 221; 254; 270; 280; 308
N
Nabuchadrezzar; 64 Nabuchodonosor II; 64 Naiadi; 141 Naubolide; 38
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
380
naucrari; 17 naucraria; 17; 21 Naucrati; 10; 204; 355 Neandro; 52 Neèra
altro nome di Etodéa, figlia di Anfione e di Niobe; 334
Nekyia; 132 Neleo; 334 Nemesi; 142; 189; 208 Neobule; 240 Neottolemo; 131 Nereide; 212 Nereidi; 57; 58 Nicerato; 232 Nicia; 232 Nicostrata; 217 Ninfe; 193; 266 Niobe; 159; 332; 334; 335
mito di; 333 Notte; 234
figli della; 234 nozze
di Cadmo e di Armonia; 256 di Ettore e di Andromaca; 214
O
Oceano; 49; 163; 164; 168; 234 Ochimo; 48 Odissea; 34; 35; 132; 135; 181; 193; 195; 234; 236;
246; 247; 249; 283; 306; 322 Odisseo; 35; 37; 131; 156; 207; 224; 267; 288; 302;
308; 322 Ogigia
figlia di Anfione e di Niobe; 334 oikia; 7; 43; 45; 46; 58; 59; 66; 77; 79; 81; 126; 224;
352 oikiē; 42; 43; 44 oikos; 33; 42; 43 Oleno; 47; 48 Olimpio
epiteto di Zeus; 212; 236; 251; 254; 328 Olimpo; 35; 49; 146; 212; 226 Omero; 37; 62; 88; 158; 161; 167; 181; 184; 193; 209;
231; 238; 245; 247; 249; 258; 277; 302; 312; 322; 331; 332; 334; 335; 348
Oneiros; 233; 237; 238 Opere ed i giorni; 37 Opleti; 14; 15 Orazio; 64; 133; 134; 136; 263 Orcomeno; 194 Ore
opera di Teolito; 164 Oreste; 53; 54; 55; 58; 97 Orfeo; 141; 288 Orgheônas; 24 Oriente; 90 Orione; 144; 145; 348
gigante; 167
Orsinome; 52 Ortigia; 288 Ossa; 49 Ossirinco; 116; 117; 118; 119; 120; 141; 327 Ovidio; 214
P
P. Berol. 9722; 105 P. Harris II 194; 118 P. Mil. Vogliano II 71; 118 P.Berol. 9780; 118 P.Oxy. Hels. 36; 118 Pafo; 197; 198; 199 Palestina; 199 Pallade; 195; 264; 309 Pamphyloi; 15 Pan; 127; 226 Panfili; 15; 309 Panormo
località di Cipro?; 197 Papiro di Colonia; 151
P.Köln 21351+21376; 119; 131; 137; 154; 158; 166; 170; 172; 175
Paralia; 14 parasclepiadei maggiori; 111; 112; 114; 118 parasclepiadeo maggiore; 110; 174; 195; 200; 214;
350 parasclepiadeo minore; 115 parásitoi; 40 Paride; 226 Partenio del Louvre; 111 patrai; 35 Patroclo; 131 Patrōus
Apollo; 22 Pausania; 48; 55
figlio di Anchite; 142 Peithò; 288; 342; 343 Pelasgi; 25; 46; 47; 49 Pelasgia
altro nome della città di Issa; 50 nome dell'isola di Lesbo; 47
Pelope; 50; 197; 255; 332; 334 Pelopia
figlia di Anfione e di Niobe; 334 Peloponneso; 50; 54; 86; 195 Penelope; 35; 37; 231; 234 pe n tam et r i eo l ic i ; 103; 111 Pentilide; 59; 63; 65; 70; 79; 81; 96 Pentilidi; 7; 13; 44; 53; 56; 58; 59; 65; 66; 69; 71; 80;
96; 220; 222; 224 Pentilo; 53; 54; 55; 59; 65; 79; 80; 97 pergamena di Berlino; 105 Periandro; 9; 61; 62 Pericle; 41 Perifante; 49; 52 Perse; 38 Persefone; 147 Persiani; 72; 118
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
381
Petelia; 217 Phorcy; 38 phylobasileus; 25 Phylobasileus; 22 Pindaro; 41; 42; 43; 100; 116; 117; 118; 128; 194;
245; 254; 256; 302; 309; 334; 335; 349 Pirinno; 273 Pirra
località dell'isola di Lesbo; 64 località di Lesbo; 50
Pisandro; 55 poeta epico; 164
Pisistratide; 11 Pisistratidi; 8; 11; 13; 28; 31; 46 Pisistrato; 8; 43 Pittaco; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 27; 30; 48; 57; 59; 60;
61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 72; 73; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 86; 90; 91; 92; 93; 97; 99; 160; 187; 224; 328
Pizia; 43; 55 PKöln 21351+21376; 99; 111; 116; 119; 150; 159;
175; 179 PKöln II 60; 349 Placia; 167 Platea; 41 Platone; 31; 95; 97; 152 Pleistodica; 77 Plutarco; 8; 9; 12; 13; 53; 56; 58; 66; 70; 75; 80; 91;
216 Polianattide; 73; 74; 75; 94; 95; 97; 298 Polianattidi; 13; 44; 96; 308 Polibio; 144 Polibo; 302 Polieno; 13 Polinnia; 102 Polipaide; 39; 207 polipo
norma del; 224 polis; 14; 18; 25; 31; 50; 53; 85; 247; 333 Polluce; 97; 132; 197; 253; 254; 255; 309 Pompeo; 166 populus; 22 Poseidone; 35; 48; 57; 58; 143; 167; 201; 309; 331 Posidippo; 141 Posidonia; 14 POxy. 1231; 103; 107 POxy. 1787; 8; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114;
115; 116; 119; 120; 139; 144; 148; 149; 150; 154; 172; 178; 182; 189; 191; 192; 211; 220; 233; 238; 242; 259; 260; 262; 272; 277; 279; 281; 282; 285; 286; 290; 291; 296; 297; 298; 300; 305; 307; 310; 311; 314; 320; 327
POxy. 2176; 120 POxy. 2290; 112; 113; 114; 120; 279; 327 POxy. 2293; 114; 120; 341; 342 POxy. 2295; 354 POxy. 2442; 117 POxy. X 1231; 103 Praxiergides; 30 Priamel; 173; 174; 175; 177; 185
Priamo; 48; 131; 167; 169; 302; 307 Priene; 91 Prodico; 94 propemptikon; 354 Proserpina; 133 Protagora; 94 Proteo; 140 Pylōnos; 38
R
Radamanto; 217 repertum; 118; 189 riforma clistenica; 15; 24; 28; 30; 45 Ritorni; 58 Rode; 48 Rodi; 48; 52 Rodo; 48 Rodopi; 6; 10; 11 Roio; 169 Roma; 25; 52; 354; 370
S
sabeo; 198 Sadiatte; 83 Saffo; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 48; 50; 55; 60; 64; 67; 68;
69; 70; 77; 81; 86; 88; 90; 91; 94; 95; 97; 98; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 108; 111; 112; 113; 114; 116; 118; 119; 120; 123; 125; 126; 128; 133; 134; 135; 137; 138; 140; 141; 142; 143; 145; 147;
150;머151; 153; 155; 156; 157; 158; 159; 161;
162; 163; 166; 170; 174; 175; 177; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 189; 190; 191; 194; 195; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 204; 210; 211; 212; 214; 215; 216; 217; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 228; 229; 231; 232; 235; 236; 247; 248; 249; 251; 253; 255; 256; 258; 260; 263; 264; 265; 267; 268; 269; 270; 271; 273; 275; 276; 277; 286; 289; 290; 291; 292; 293; 295; 303; 304; 308; 309; 311; 313; 315; 322; 324; 325; 327; 329; 330; 331; 332; 335; 342; 343; 345; 346; 349; 350; 351; 354; 355; 356; 358; 361; 368; 369
Salamina; 5; 62 Samo; 10; 52 Samotracia; 100 Santippe; 80 Sardi; 10; 43; 81; 82; 85; 86; 87; 90; 91; 92; 93 Sarpedonte; 223 Scamandro; 169
fiume; 47 Scamandronimo; 5; 10 Scheria; 308 Sciti; 72; 198 scriba di Pindaro; 118 Selene; 167 Semo; 5 Semonide di Amorgo; 89 Senilità; 119 Senofane; 88; 89; 176
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
382
Serapione Apolloniano; 118 Sette Sapienti; 60; 61; 68; 69; 92; 93 Sfetto; 14 Sibilo
figlio di Anfione e di Niobe; 334 località; 334
Sicano; 249 Sicilia; 6; 7 sidērophoreîn; 16 Sigeo; 8; 11; 12; 60; 61; 62; 64; 69; 77 Silloge teognidea; 39; 78 Simone; 5; 7 Simonide; 309 Siracusa; 7; 8; 41; 67; 79; 138 Siria; 167; 198 Sirti; 160 Sisifo Eolide; 52; 159 Smerdi; 59; 80 Sminteo; 56; 57 societas; 22 Socrate; 80; 81; 94; 95; 97; 221; 232; 349; 359 Sofronisco
padre di Socrate; 232 Sogni
figli della Terra; 234 popolo dei; 234 stirpe dei; 234
Sogno; 233; 235 Sole; 49; 163; 164; 167; 186; 189; 213; 234 Solone; 8; 12; 27; 30; 66; 67; 90; 253; 303; 330 Sonno; 234 Sopatro Sofista; 105 Sparta; 13; 55; 86; 161; 255 Sparti
stirpe degli; 255 Stesicoro; 5; 162 stirpe eraclide; 81 Storie; 18; 41 Strabone; 8; 13; 53; 55; 58; 61; 64; 65; 67 Strimno; 170 strofe distiche; 105; 111; 112; 114; 120; 279; 327 strofe tristiche; 104; 112; 113; 114; 279; 287; 324;
328 st ro f i sa f f i ch e ; 103 Strozza-cani
Hermes; 81; 82 subscriptio; 103 Suida; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 60; 68; 69; 101; 243; 257;
324; 354; 359
T
Talete; 70 Talia; 102; 146 Tamira; 199 Tantalo; 177; 332; 334
figlio di Anfione e di Niobe; 334 Tebe; 10; 32; 39; 93; 126; 244; 255; 334
città della Troade; 9 Teia; 167
Telamone; 20 Telefo; 56 Telemaco; 35; 37; 145; 161; 231; 322 Telesilla; 334 Telesippa; 5; 257; 324; 359 Tenage; 48 Tenedo; 55; 62 Teoclimeno; 37 Teodoro; 20 Teofrasto; 24; 143 Teognide; 40; 331 Teogonia; 37; 138; 195; 265 Teolito; 164 Terenziano Mauro; 104 Terone; 79 Terra; 234 Terrore; 193 Tersicore; 102; 146 Tessaglia; 52 Tetide; 212 Tetrapoli; 14 Tetrastico di Saffo; 172 Teutrania; 56 The Tithonos poem; 119 Theia; 186 themis; 27; 31; 126; 138; 159; 220 Tiberio; 354 Tifone; 147 Tindareo; 53; 97 Tindaridi; 97; 241; 254 Tiro; 95; 359 Tirteo; 88; 331 Tisameno; 41; 53; 55 Tisandro; 43; 46 Titani; 167 Titanomachia; 164 Titonia; 164 Titono; 140; 149; 159; 164; 166; 167; 168; 169; 170;
175; 177 Torico; 14 Traci; 72 Tracia; 54; 197 Trasimaco; 94 tribù; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 25; 28; 31; 33 tribù "ioniche"; 16 tribù doriche; 15 tribù ioniche; 15; 17 tribunus; 25 trimetro ionico; 108 Triopa; 47; 48; 52 Triope; 48 trittia; 16; 17; 21; 32; 33 trittie; 17; 33 Trittolemo; 217 Troade; 9; 53; 61; 93 Troia; 55; 61; 77; 131; 164; 167 Troiani; 55; 170; 184; 307; 309; 348; 354 Troo; 73 Tullio Laurea; 102
Luca Benelli Il «Quarto Libro» delle Odi di Saffo
383
U
ultimo dei Misi proverbio; 55
Urania; 102; 146; 198; 199
V
vecchiaia; 8; 119; 125; 138; 148; 149; 155; 158; 159; 168; 169; 170; 172; 176; 177; 223; 245
Venere; 197; 198 Vergogna; 208 Verre; 8 vicinato; 26 Violenza; 193
X
Xanto; 10; 46; 47; 49 fiume; 47
Z
zamqic agg. etrusco
"aureo"; 47 Zefiro; 312; 337; 353; 355 Zeto; 334 Zeus; 35; 36; 39; 44; 47; 48; 68; 73; 74; 104; 128; 132;
138; 141; 146; 147; 153; 159; 163; 168; 175; 185; 188; 189; 193; 195; 201; 206; 208; 209; 211; 212; 215; 217; 233; 236; 238; 246; 251; 254; 255; 271; 282; 289; 292; 294; 308; 309; 312; 332; 334; 357
zophodorpidas; 75