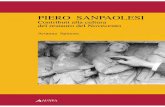Donne, economia ed istituzioni tra Otto e Novecento. Fonti e questioni
Interpretare un gesto: maschi esibizionisti tra Otto e Novecento
Transcript of Interpretare un gesto: maschi esibizionisti tra Otto e Novecento
Genesis, iX / 2, 2010
domenico Rizzo
interpretare un gesto: maschi esibizionisti tra otto e novecento
1. Molti uomini finiscono in tribunale, tra Otto e Novecento, per aver mostrato in pubblico i propri genitali. i fascicoli processuali che li riguardano sono scarni, perché i giudizi vengono celebrati per direttissi-ma, secondo il rito abbreviato seguito per i reati minori. le tracce sono numerose: diverse decine di casi all’anno soltanto a Roma, la città che ho preso in esame.1 e il gesto compiuto è sempre lo stesso: esibire le parti intime con l’intenzione di esibirle. vediamone alcuni esempi.
al garzone di un macellaio che orina sulla ruota del proprio carro, una guardia municipale contesta la contravvenzione; il giovane si volta verso la guardia esibendo «il membro virile».2
Un uomo di 64 anni, ubriaco, viene arrestato nel maggio 1885 mentre «se ne [sta] colle spalle al muro, e col membro fuori dei calzoni, additandolo al pubblico, e se la [ride] dell’atto da lui fatto».3
nei pressi di un cantiere, quello dell’ospedale Policlinico in co-struzione nel 1900, un uomo di 26 anni si mostra più volte alla moglie di un ingegnere addetto ai lavori.4
al culmine di una lite tra vicini di casa, in un vicolo del centro storico, Giovanni, un operaio di 39 anni, «si [cala] i calzoni e, facen-do vedere il suo membro virile dalla finestra, [dice] alla [dirimpettaia]: “Questo ti basta?”».5
1. il campione di fonti si basa su uno spoglio degli atti del tribunale civile e penale di Roma, per anni campione, tra il 1875 e il 1910.
2. archivio di stato di Roma, tribunale civile e Penale [asR, tcP], Processi [Pr], b. 3.098, fasc. 6.822; ivi, sentenze [s], v. 5.497, s. 10 febbraio 1875.
3. asR, tcP, Pr, b. 4.270, fasc. 32.703; ivi, s, vol. 5.591, s. 11 maggio 1885.4. asR, tcP, s, vol. 93, s. 13 giugno 1900.5. asR, tcP, s, vol. 264, s. 10 luglio 1910.
Ricerche194
Infine – ma l’elenco potrebbe continuare – rivolto alle finestre di un convento di orsoline, un «vaccaro» abruzzese di 37 anni, «[è] stato visto più volte da quelle suore nell’atto di dimenarsi il pene».6
le pagine che seguono saranno dedicate all’analisi di questi gesti, a partire da un’ipotesi: che essi possano funzionare da «indizi rivela-tori» rispetto ai significati e agli usi pubblici del corpo maschile nel quadro di una città di fine Ottocento. I gesti, in altri termini, saranno trattati come quegli «scarti», quei «dati marginali», quei «particolari considerati di solito senza importanza, o addirittura triviali», ai quali applicare il metodo indiziario.7
si tratta di una ipotesi che merita una breve spiegazione. essa ha senso, infatti, a una condizione: superare l’idea che un’identità (in que-sto caso) maschile esista – e quindi sia indagabile – come un costrutto culturale autonomo e astratto.
Un gesto può costituire un punto di osservazione fecondo soltanto se pensiamo al genere – in quanto significato del corpo sessuato – come ad una dimensione performativa; se ammettiamo che il significato non è un a priori ma si costruisce e si ricostruisce, in un dato contesto, nel quadro delle performance e delle interazioni sociali in cui si esprime; ma anche nell’intreccio con altre variabili sociali. nella sua continua produzione e riproduzione, il genere muta, partecipando allo stesso tempo del mutamento storico e culturale complessivo.
Gli esempi riportati richiamano evidentemente una pluralità di cir-costanze e di soggetti. in comune tutti i gesti hanno però un tratto fon-damentale: non si tratta di semplici movimenti corporei ma di azioni sociali, dotate di un significato per il soggetto che le compie e che un significato assumono per chi ne è destinatario.
Interpretare queste situazioni significa chiedersi di volta in volta: “cosa sta facendo” il soggetto che mostra i genitali? Qual è il signifi-cato del suo gesto? Quali sono le sue intenzioni? o anche, nei termini mutuabili dall’analisi delle “azioni linguistiche”,8 con quale forza illo-cutoria il gesto viene eseguito?
esiste un codice culturale dell’oscenità, con una sua tradizione e una sua riconoscibilità. nei casi citati, come vedremo, questo codice
6. asR, tcP, s, vol. 170, s. 28 aprile 1905.7. il riferimento è al saggio di carlo Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in
idem, Miti, emblemi spie. Morfologia e storia, torino, einaudi, 1986, pp. 158-209.8. cfr. l’ormai classico John langshaw austin, Come fare cose con le parole, Genova-
Milano, Marietti, 1987 (ed. or. 1962). suggestive indicazioni di applicabilità alla ricerca storica in Quentin skinner, Dell’interpretazione, Bologna, il Mulino, 2001.
Rizzo, Interpretare un gesto 195
Genesis, iX / 2, 2010
rappresenta un livello di significato condiviso dagli attori sociali. Ma, a qualificare le situazioni, è la forza intenzionale che i soggetti mettono nel gesto; l’adozione dell’oscenità come linguaggio espressivo a fini specifici e del tutto contestuali.
nell’intreccio dinamico tra intenzioni degli attori e reazioni che su-scita, il gesto dell’esibizione costituisce un prisma, utile a riconoscere i significati diversi che “essere” un corpo sessuato può assumere nelle relazioni sia con l’altro sia con il proprio sesso.
2. le tracce giudiziarie sulle quali possiamo lavorare sono il pro-dotto di una congiuntura storica, i cui tratti caratteristici sono almeno due: una particolare normazione dello spazio pubblico – sotto il profilo del “pudore” ma non soltanto – e le modalità della sua sorveglianza.
il “pudore pubblico” come bene da tutelare è una creazione squi-sitamente ottocentesca.9 la norma penale che ne sanziona l’oltraggio – ricalcata sul modello francese del codice di napoleone – vieta, nella sostanza, qualsiasi comportamento sessuale in luoghi pubblici; e preve-de una procedura d’ufficio.
la posta in gioco è percepita altissima: «se si permettessero atti offensivi al pudore in luogo pubblico – spiega un giurista di fine secolo – la società ritornerebbe ad uno stato primitivo, non soltanto selvaggio ma animalesco».10
il pudore, come sentimento acquisito, si esprime nella «tendenza diretta a nascondere tutto quello che più o meno si riferisce alla vita sessuale».11 nella cultura ottocentesca, il pudore è inscritto saldamen-te nella parabola sia dell’evoluzione della specie sia del progresso di civiltà. e questo sarà vero a tal punto da precludere anche agli studi demo-etno-antropologici che si vanno svolgendo, in italia come negli altri Paesi europei, la possibilità di indagare apertamente sui costumi sessuali «popolari».12
Ma il sesso non è che una preoccupazione tra tante rispetto ai com-portamenti che vanno espunti dalla sfera pubblica. l’immagine che lo
9. cfr. domenico Rizzo, Gli spazi della morale. Buon costume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale, Roma, Biblink, 2004, in part. il cap. 5: Spazi e civiltà liberale, pp. 157-179.
10. Giovanni Formica, Oltraggio al pudore, in Enciclopedia giuridica italiana, 1905, sub vocem, p. 259.
11. Giuseppe Fanciulli, L’individuo nei suoi rapporti sociali: studi di psicologia, torino, F.lli Bocca, 1905, p. 129.
12. si veda luigi Maria lombardi satriani, Strategie di silenzio e volontà di parola, all’url://http://www.irsap-agrigentum.it/pitre_letteratura_erotica.htm [ultimo accesso: 20 giugno 2011].
Ricerche196
spazio pubblico deve assumere e la trasformazione necessaria dei co-stumi di vita della popolazione trova una espressione significativa nei Regolamenti di polizia municipale.
a Roma, ad esempio, negli anni che seguono l’annessione al Re-gno d’italia, non si tratta soltanto di avere una «capitale tranquilla»,13 di prevenire disordini attraverso un controllo capillare dello spazio urba-no; aspetti questi che la storiografia ha più spesso sottolineato. Si tratta anche – e nella stessa misura – di avere una «capitale civile»: i liberali romani si presentano come portatori di un progresso che comporta la modificazione di costumi e di stili di vita della popolazione.
il Regolamento di polizia municipale traccia per questo una mol-teplicità di confini tra ciò che va tenuto celato e ciò che può essere mo-strato, sottraendo alla vista tutto ciò che attiene alla nudità della materia organica. viene così vietato a maniscalchi e veterinari di esercitare la propria professione in vista del pubblico (art. 79); ai macellai di mo-strarsi «con vestimenta e attrezzi sudici o intrisi di sangue» (art. 81) e di esporre fuori delle botteghe le bestie macellate, le interiora «e tutti quegli oggetti che possono offendere il pubblico decoro» (art. 82); è vietato «pettinarsi o pettinare sul suolo pubblico» (art. 88) e tosare ani-mali domestici (art. 89); non si può «soddisfare alle naturali occorrenze fuori de’ cessi e degli orinatoi pubblici» (art. 92); «in generale è proibito esporre in luoghi pubblici nudità, piaghe e deformità ributtanti» (art. 93); «i conduttori delle vetture pubbliche o di piazza, dei carri, e di qualunque veicolo, dovranno tenere costantemente un contegno deco-roso e decente. le grida, le parole sconce, gli alterchi e i modi inurbani, saranno considerati e puniti quali contravvenzioni» (art. 95).14
nei decenni che seguono l’Unità d’italia ci troviamo quindi in una congiuntura nella quale, a livello normativo, trova definizione una mol-teplicità di ambiti “privati”, ciascuno frutto dell’espulsione dallo spazio pubblico di un’attività materiale; ambiti privati diversi per ciascuna ca-tegoria della popolazione e per ciascun contesto urbano.
Questo progetto liberale di civilizzazione si traduce in una forte pressione sullo spazio pubblico, esercitata dalle diverse forze di polizia incaricate della sua sorveglianza.
13. Per tutti alberto caracciolo, Roma capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello Stato liberale, Roma, editori Riuniti, 19934, che focalizza l’attenzione sull’esigenza della tranquillità sociale.
14. si tratta di norme contenute nel titolo v del Regolamento, che contiene le Disposizioni relative al decoro pubblico, alla decenza pubblica, alla quiete pubblica e all’ordine pubblico.
Rizzo, Interpretare un gesto 197
Genesis, iX / 2, 2010
se singoli gesti, compiuti all’incirca un secolo fa, hanno lasciato traccia scritta, è perché hanno ricevuto una prima attribuzione di signi-ficato in un contesto segnato dai processi ai quali ho appena accennato. Un apparato normativo e istituzionale li ha selezionati per noi, insieme a molti altri comportamenti considerati lesivi del pudore pubblico. ve-diamone brevemente alcuni, per contestualizzare i gesti maschili di cui ci occuperemo più in dettaglio.
3. Una nutrita tipologia di casi riguarda le coppie di amanti, sorpre-se – per lo più notte tempo – in luoghi remoti della città: appena fuori l’antica cinta delle mura vaticane o fuori porta san Giovanni; all’orto botanico o sotto gli archi del colosseo; o ancora nei vicoli di trastevere e del rione Monti. Uomini e donne dei ceti popolari, a volte adulteri ma-turi, altre volte giovani che si discolpano menzionando una promessa di matrimonio; indizio, quest’ultimo, di un sapere legale che li avrebbe forse salvati davanti a un tribunale ecclesiastico e che risulta invece inutile rispetto all’oltraggio al pudore pubblico.
È determinante la presenza delle forze dell’ordine, che attraver-sano sistematicamente, in base a turni e percorsi prestabiliti, strade e piazze della città. sorprendono gli amanti a volte per caso, ad esempio nei portoni del centro storico. Ma li vanno anche a scovare nei luo-ghi appartati dove si aspettano di trovarli; luoghi di confine, quali una grotta fuori porta o un anfratto nell’antica cinta muraria; o anche una «località remota» dell’orto botanico dove – spiega un giudice – «dei male intenzionati si recano spesso di proposito».15 i casi di questo ge-nere sono particolarmente numerosi nei primi anni del novecento, in corrispondenza di una campagna politica per la moralità che si traduce nei fatti in una maggiore sorveglianza degli spazi pubblici.16
Uomini e donne che cedono invece al desiderio dove capita – che si tratti di una panchina di piazza navona,17 di una strada del rione Monti,18 di un teatro19 o della piazza di san Giovanni in laterano20 – si espon-gono al rischio di reazioni ostili tra i presenti, i quali reclamano a gran
15. asR, tcP, s, vol. 178, s. 5 settembre 1905; casi del tutto analoghi in asR, tcP, s, vol. 171, s. 6 maggio 1905; ivi, vol. 172, s. 25 maggio 1905 e s. 3 agosto 1905.
16. Cfr. Bruno P.F. Wanrooij, Storia del pudore. La questione sessuale in Italia, 1860-1940, venezia, Marsilio, 1990.
17. asR, tcP, s, vol. 94, s. 12 luglio 1900.18. asR, tcP, Pr, b. 4.334, fasc. 34181; ivi, s, vol. 5597, s. 18 novembre 1885. 19. asR, tcP, s, vol. 93, 23 giugno 1900.20. asR, tcP, s, vol. 96, s. 6 settembre 1900; un intervento scandalizzato di altri cittadini
anche in vol. 5597, s. 18 novembre 1885.
Ricerche198
voce l’intervento delle guardie. su queste reazioni, purtroppo, le fonti sono troppo avare di informazioni per permetterci di coglierne meglio il significato; ma, in ogni caso, confermano che ci troviamo in un contesto a proposito del quale sarà corretto parlare di “oscenità”. Quanto meno rispetto alla definizione che di un simile contesto danno gli antropologi, e cioè di una cultura nella quale sia presente una censura su determinati atti, che si espliciti in una normativa, scritta o non scritta.21
in altri termini, la scelta da parte delle coppie di luoghi appartati, insieme alla reazione nei confronti delle più incaute, e all’intervento sanzionatorio delle forze di polizia, si presentano come altrettanti indi-zi, tra loro coerenti, di una cultura condivisa che censura le espressioni pubbliche della sessualità. È in questo contesto che scoprire i genitali è un gesto consapevolmente e volutamente osceno. ed è un gesto che ha lasciato tracce esclusivamente maschili.22 con il prossimo paragrafo inizieremo allora a delinearne il fenomeno.
4. via dei cappellari, a Roma, è una strada stretta e densamente abitata del centro storico. ai diversi piani delle case che si fronteggiano sui due lati, pochi metri separano in linea d’aria finestre dirimpettaie. Abitudini, odori, voci e rumori quotidiani possono dar luogo a conflitti, anche molto aspri, nei rapporti di vicinato.23 l’aggressione verbale è la regola e, come suggeriscono ricerche anche su periodi e contesti diver-si, il campo semantico dell’insulto è spesso sessuale. Quello che accade però in via dei cappellari, nell’aprile del 1910, presenta particolari mo-tivi di interesse ai fini del nostro tema.
Giovanni, un operaio romano di 39 anni, racconta: «siccome la mia bambina Jole cantava gli stornelli, adele, che abita incontro a casa mia, si offese per tali canti».24
21. alfonso M. di nola, Oscenità e riso, in Antropologia religiosa, Firenze, vallecchi, 1974, pp. 15-90; cfr. in particolare pp. 74-78.
22. le donne arrestate con un uomo sono praticamente le sole che incontriamo nei casi di oltraggio al pudore. le rare eccezioni si riferiscono a situazioni di estrema marginalità sociale: donne senza fissa dimora, in età avanzata e stato di ubriachezza, sulle quali cfr. Rizzo, Gli spazi della morale, pp. 200-202.
23. Sui conflitti di vicinato tra Sette e Ottocento cfr. James R. Farr, Crimine nel vicinato: ingiurie, matrimonio e onore nella Digione del XVI e XVII secolo, in «Quaderni storici», 3 (1987), pp. 839-854; arlette Farge, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités a Paris au XVIIIe siècle, Paris, hachette, 1986; david Garrioch, Neighbourhood and Community in Paris (1740-1790), cambridge, cambridge University Press, 1986.
24. asR, tcP, s, vol. 264, s. 16 luglio 1910.
Rizzo, Interpretare un gesto 199
Genesis, iX / 2, 2010
Gli “stornelli” sono un genere di canzonetta molto popolare a Roma ai primi del secolo, lanciati da Pietro capanna (noto come “sor capanna”) e ripresi poi da ettore Petrolini. si tratta di brevi e salaci strofe che nascono come forma di satira politica e di costume, ma le cui più celebri appartengono a un filone sessual-goliardico, giocato pesan-temente sull’oscenità delle situazioni descritte.25
È verosimile che la bambina canti proprio uno stornello audace e questo susciti una reazione nella vicina. la quale forse è offesa nel pudore ma, più probabilmente, le rimprovera di essere una bambina “maliziosa”, una categoria che si affaccia spesso nelle testimonianze dei vicini di casa, magari quando si tratta di attestare la credibilità o meno di un’accusa di molestia sessuale.
A questo punto interviene Giovanni, che prende le difese della fi-glia insultando la vicina che l’ha criticata e, da finestra a finestra, grida: «Brutta mignotta! Bocchinara! dai il comodo di casa tua per la prosti-tuzione delle minorenni…». che è come dire: non ti riconosco i titoli per distribuire patenti di moralità.
adele rilancia urlandogli «Magnaccia! Magnafregna!»; insulti convenzionali che in questo contesto, però, assumono un significato non per forza generico. sembra dirgli infatti: sei un uomo che si disin-teressa della moralità delle donne della sua famiglia, che anzi ci mangia sopra; e per questo puoi permettere che tua figlia canti gli stornelli.
allo scambio di insulti assiste un pubblico, composto di almeno due donne e tre uomini, che in tribunale deporranno come testimoni. la lite di vicinato assume inevitabilmente i tratti di una performance pubblica.
E all’apice del conflitto, quando la reciproca delegittimazione è massi-ma, Giovanni – raccontano le vicine – «si cala i calzoni, e, facendo vedere il suo membro virile dalla finestra, dice all’Adele: “Questo ti basta?”».
«Qualche testimone – ricapitola il giudice nella sentenza – disse che [Giovanni] doveva essere quella sera o ubriaco o matto. osserva il collegio che l’imputato non era né ubriaco né matto, poiché nel suo interrogatorio spiega la causale di quelle ingiurie». Una conclusione ineccepibile: non possiamo spiegare il gesto in termini di irrazionalità o
25. Pietro capanna, Gli stornelli, Roma, istituto editoriale, 1930. Molte le analogie con le «canzoni oscene popolari» raccolte ai primi del secolo da Raffaele corso, La vita sessuale nelle credenze, pratiche e tradizioni popolari italiane, ed. it. a cura di Giovanni Battista Bronzini, Firen-ze, olshki 2001. corso, allievo di Giuseppe Pitrè, aveva pubblicato il volume nel 1914 in tedesco, come vol. vii della collana “anthropophyteia. Jahrbücher für folkloristische erhebungen und For-schungen zur entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral”, dir. da Friedrich s. Krauss.
Ricerche200
di coscienza attenuata; si tratta evidentemente di un atto aggressivo del tutto consapevole. come interpretarlo?
5. Una proposta suggestiva viene dall’antropologia e, in particola-re, da un saggio del 1974 di alfonso Maria di nola, Oscenità e riso.
l’esibizione genitale, maschile o femminile, scrive di nola, «esprime uno stato di natura, per il ritorno alla nudità e al prelimine degli usi di coprirsi, ma lo esprime anche per la qualità istintuale della forza significata nel sesso. Per quanto riguarda la violazione, rituale o non-rituale del tabù, ci si trova in presenza di un tipico meccanismo di cancellazione dell’impianto culturale in momenti in cui lo stesso im-pianto è in crisi». si tratterebbe di «una tipica dialettica di momentanea regressione alla condizione preculturale, ma soltanto per rifondare la sicurezza di cultura messa in crisi».26
Mi sembra che questa impostazione aiuti a capire meglio la vicen-da di via dei cappellari. l’esibizione di Giovanni interviene ad azzerare qualsiasi convenzione morale all’interno di una crisi molto “seria”, che ha incrinato il delicato equilibrio tra competenze morali della famiglia e permeabilità di ciascuno al giudizio e all’intervento del vicinato. Gli insulti appartengono ancora alla fase di crisi; il gesto di calarsi i calzoni – leggendolo in chiave antropologica – spariglia invece le carte, facen-do tabula rasa di ragioni e torti reciproci.
il gesto osceno, per di più, rivolto a una donna, assume una conno-tazione di genere ulteriore. non a caso troviamo traccia di uomini che, accusati di aver compiuto gesti osceni, si difendono dicendo di essersi rivolti soltanto a una prostituta.
Un carrettiere della campagna romana, ad esempio, attraversa la città con «un grosso membro virile di creta» attaccato al proprio carro, «coperto da un panno, che ad ogni momento toglieva».27 di un ogget-to che tradizionalmente ha funzioni apotropaiche, l’uomo ha fatto un uso improprio, rivolgendone l’aggressività verso altre persone. alcuni cittadini reclamano infatti, rivolgendosi alle guardie municipali che lo arrestano. e l’uomo si discolpa dichiarando che «per ischerzo [sic] e soltanto ad una prostituta, [lo] fece vedere».
26. di nola, Oscenità e riso, p. 89 passim. oscenità ed esibizione dei genitali sono oggetti di studio “classici” per l’antropologia storica delle società antiche e moderne. Mi limito a questo riferimento bibliografico per la sua specifica pertinenza rispetto alle interazioni sociali che mi interessa analizzare.
27. asR, tcP, s, vol. 177, s. 18 agosto 1905.
Rizzo, Interpretare un gesto 201
Genesis, iX / 2, 2010
Questo modo di difendersi suggerisce che il gesto assume signifi-cato non semplicemente in rapporto alle proprie intenzioni ma anche a seconda del soggetto al quale viene rivolto. con una prostituta se ne potrebbe ridere e non ci sarebbe ingiuria; con una donna onesta invece sarebbe ben più grave. così ragiona anche un giovanissimo accusato di molestie nei confronti delle ragazze che passano in strada e che dice: «avendo visto passare una prostituta avevo fatto semplicemente l’atto di toccarmi le mutande».28 e il gesto nei confronti di adele è contestua-le al fatto di apostrofarla come prostituta, e si accompagna alla frase: «ti basta questo?».
la crisi viene qui superata in modi molto distanti dal contesto ana-lizzato da di nola. egli lavorava, infatti, su narrazioni sacrali, di origini e datazioni diverse, che presentavano tra loro forti analogie descrittive e mitico-ideologiche; e il tratto fondamentale comune a tali narrazioni era il riso. Provocato dall’esibizione oscena, il riso di chi era destinatario del gesto segnava il superamento della crisi.
in una lite di vicinato, invece, le cose vanno molto diversamente. la soluzione di adele consiste nel rivolgersi all’apparato pubblico della giustizia, secondo un uso tradizionale della querela a fini dimostrativi e riparatori del proprio status.29 la donna querela Giovanni per diffamazio-ne e ingiurie. la prima accusa sarà giudicata inconsistente; per la seconda saranno concesse le attenuanti; il grosso della pena – applicando la norma sull’oltraggio al pudore pubblico – sarà così la conseguenza proprio del gesto che – sul terreno simbolico – avrebbe dovuto azzerare il conflitto.
la vicenda che abbiamo appena visto è eccezionale. si tratta infatti dell’unico caso – rispetto a un campione di fonti molto ampio – in cui il gesto dell’esibizione dei genitali compare nel contesto di una lite priva-ta. sono invece molto più frequenti i casi, dei quali ora ci occuperemo, nei quali il destinatario del gesto è un altro uomo e che, soprattutto, indossa una divisa.
6. in un pomeriggio di dicembre del 1874 arcangelo – un uomo romano di ventisei anni, garzone di un macellaio – orina sulla ruota di un carro che utilizza per il trasporto della carne, a poca distanza da altri carrettieri. Gli si avvicina una Guardia municipale e gli contesta una
28. asR, tcP, s, vol. 259, s. 10 marzo 1910.29. Per alcuni esempi cfr. domenico Rizzo, Forestieri nelle pratiche di giustizia: opportuni-
tà e rischi (Roma, XVIII-XIX secc.), in L’Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea, a cura di angiolina arru e Franco Ramella, Roma, donzelli, 2003, pp. 133-159.
Ricerche202
contravvenzione: ha violato l’art. 92 del Regolamento di polizia urbana, che vieta i bisogni corporali sul suolo pubblico.
arcangelo, per tutta risposta, si volta verso la Guardia e «scuote in atto di disprezzo il membro virile». la discussione si fa animata e una dozzina di carrettieri si avvicina per sostenere arcangelo; si passa in breve alle vie di fatto e la Guardia è messa in difficoltà. Il giovane viene arrestato, grazie all’intervento di un poliziotto, e condannato a cinque mesi di carcere per «ribellione» e «oltraggio al buon costume».30
come nella vicenda di via dei cappellari, il gesto osceno si colloca all’interno di una “crisi”, i cui tratti peculiari sono però ben altri.
anzitutto, l’esibizione si manifesta come reazione al rimprovero, alla restrizione e, addirittura, alla sanzione pecuniaria di un comporta-mento non consentito in un luogo pubblico. Un comportamento che è agli occhi del giovane del tutto inscritto nella sua sfera “privata” e che, per la guardia invece, si configura come contravvenzione alle regole.
il tentativo dei corpi di polizia di applicare le norme che regolano lo spazio pubblico e, in modo particolare, il minuzioso Regolamento di polizia municipale, provoca una grande conflittualità. Nei decenni successivi all’unificazione italiana, ribellioni, violenze e oltraggi contro i rappresentanti delle forze dell’ordine – poliziotti e guardie municipali, ma anche carabinieri e guardie daziarie – costituiscono un fenomeno dalle dimensioni imponenti. E, nella gran parte di questi conflitti, affio-ra una componente di genere molto forte, a partire dal fatto che ne sono protagonisti soltanto i maschi.31
la “crisi” più generale nella quale si inscrive l’episodio di arcan-gelo riguarda la percezione di ciò che è lecito fare nello spazio pubbli-co. in questo senso possiamo considerare emblematico un caso che si verifica cinque anni dopo, nel marzo del 1880.
Un facchino romano di 23 anni, aureliano, sta orinando in stra-da quando due guardie municipali gli contestano la contravvenzione all’art. 92.32 aureliano risponde: «se non te ne vai te la do io la contrav-venzione, va via brutto beccamorto che sei». nel frattempo i suoi amici, una decina, si fanno attorno alle guardie e le insultano pesantemente. Una di esse corre a chiamare rinforzi; l’altra intima ad aureliano di seguirlo in caserma ma il giovane risponde: «se non te ne vai ti do un
30. asR, tcP, Pr, b. 3.098, fasc. 6.822; ivi, s, v. 5.497, s. 10 febbraio 1875.31. Per alcune considerazioni più generali sul fenomeno rinvio a domenico Rizzo, Liberal
Decorum and Men in Conflict, Rome, 1871-90, in «Journal of Modern italian studies», 10 (2005), pp. 281-296.
32. asR, Pr, b. 3.674, fasc. 19.322.
Rizzo, Interpretare un gesto 203
Genesis, iX / 2, 2010
sacco di sganassoni, facendo un atto minaccioso con la mano destra». all’arrivo delle altre guardie, aureliano fugge e ripara in un’osteria, dove viene scovato in un armadio della cucina e arrestato, «in mezzo a un diluvio di selciate».
l’atto di minaccia è un topos del conflitto tra maschi, soprattutto nel crescendo di un’interazione conflittuale (gli Statuti comunali, ad esempio, comprendevano il gesto tra le ingiurie);33 si tratta di un gesto fortemente ritualizzato, soprattutto nella variante del «fare atto» di met-ter mano al coltello.34 così anche un giovane facchino, invitato «a non spandere acqua fuori dall’orinatoio» lo chiama «porco» e gli dice «me la pagherai», facendo «atto di cavare un’arma dalla tasca».35
È un’esibizione di forza e di coraggio, una affermazione di dispo-nibilità allo scontro fisico quando si avverte una minaccia alla propria libertà. la posta in gioco, come si è visto, è un tentativo di ingegneria urbana in un certo senso antropologica, ispirata a una gerarchia delle rilevanze al cui vertice è posta la definizione rigida dei confini tra pri-vato e pubblico.
7. azzerare le regole e regredire alla condizione preculturale, in que-sto contesto, significa non riconoscere l’autorità dell’istituzione e portare il conflitto sul terreno dello scontro personale. E poiché l’istituzione s’in-carna in un corpo maschile, il conflitto diventa una sfida tra maschi.
l’oggetto del contendere è il reciproco riconoscimento dei sogget-ti: della libertà degli uni e dell’autorità degli altri. il genere attraversa questi conflitti, nella misura in cui la messa in discussione sia della li-bertà sia dell’autorità viene vissuta dalle parti come un oltraggio all’in-terno di un «gioco di faccia».36
Un vetturino, ad esempio, tale Giovanni del Bigio, romano, di 33 anni, il 12 novembre del 1885 sta entrando in città per il ponte di Ripet-ta. le guardie daziarie gli intimano di fermarsi per ispezionare il carro. Lui si rifiuta. Le guardie insistono. Giovanni si rivolge a una di esse in
33. ad esempio, degli statuti romani del 1360 cfr. il tit. Xl (De ponentibus manum ad coltellum); per altre manifestazioni aggressive, soprattutto lesive della mascolinità altrui, sono interessanti i tit. Xliii (De facientibus aliquem cadere in terris) e liii (De percutientibus manu vacua). camillo Re, Statuti della città di Roma per cura dell’Accademia di conferenze storico-giuridiche, Roma, tip. della Pace, 1880.
34. sulla cultura del coltello Giancarlo Baronti, Coltelli d’Italia. Rituali di violenza e tradi-zioni produttive nel mondo popolare, Padova, Muzzio, 1986.
35. asR, PU, s, reg. 8, 2 gennaio 1872.36. il riferimento è a erving Goffman, Il rituale dell’interazione, Bologna, il Mulino, 1988,
in particolare cap. i.
Ricerche204
questi termini: «levati la divisa e vieni fuori porta, vigliacco te e chi t’ha dato la divisa».37
le parole di Giovanni sintetizzano il doppio piano sul quale il conflitto si gioca. Il primo attiene all’identità e al conflitto tra maschi («levati la divisa… vigliacco»): nella sua ottica, la divisa s’interpone simbolicamente tra loro, impedendo uno scontro alla pari e, per que-sto, la guardia è vigliacca perché vi si nasconde dietro. La qualifica di pubblico ufficiale è una maschera protettiva alla quale l’altro, in quanto uomo, dovrebbe rinunciare. il secondo piano, quello del «chi t’ha dato la divisa», dell’istituzione e della norma da rispettare, è volutamente ignorato, spostando tutta l’attenzione sul piano personale.
il “fuori porta” al quale la guardia è invitata in quanto uomo, senza divisa, è uno spazio non urbano, selvatico, non normato dalle leggi del-la città, nel quale la partita possa giocarsi al di fuori dei ruoli sociali38. È l’immaginazione di questa possibilità, a mio parere, il dato più inte-ressante in questa come in altre vicende. con essa il progetto liberale di “civilizzazione” deve fare i conti per affermarsi nello spazio pubblico. in tanto tale progetto ha possibilità di guadagnare terreno in quanto il piano personale cede progressivamente, nelle interazioni quotidiane, al piano della norma e dell’istituzione che la divisa incarna. diventare “civili” significa – e non solo nel quadro liberale – riconoscere istintiva-mente i ruoli sociali per averli interiorizzati; in questo caso, si trattereb-be di mettere da parte il genere dell’interlocutore – che rende possibile una parità – a favore dell’identità stabilmente conferita dalla divisa.
e invece la fantasia di uno scambio di ruoli si affaccia in molti casi. a volte assumendo una coloritura politica: «che te possino ammazzatte, che belle leggi, finirà, finirà, venirà [sic] il momento che comanderemo noi antri, brutti bojaccia».39 Ma più spesso il riferimento è a uno scam-bio di ruoli “personali”: un vetturino di 19 anni, dichiarato in contrav-venzione non oppone resistenza e, mentre la Guardia si allontana, dice: «Bisognerebbe fare la guardia una volta per uno, così ti farei la bojeria che fai a me».40
L’oscenità maschile assume significato in questo quadro, utilizza-ta soprattutto da uomini appartenenti ai ceti popolari. si tratta di una
37. asR, PU, s, reg. 182, 27 gennaio 1885.38. Sulla molteplicità di significati, anche simbolici, delle porte della città nel lungo periodo
cfr. La città e le mura, a cura di cesare de seta e Jacques le Goff, Roma-Bari, laterza, 1989.39. asR, PU, s, reg. 52, 17 luglio 1875.40. asR, PU, s, reg. 193, 10 luglio 1885.
Rizzo, Interpretare un gesto 205
Genesis, iX / 2, 2010
risorsa offensiva simbolica, che presta però il fianco a un’imputazione ulteriore, come nel caso di arcangelo e in molti altri.
Non è l’oltraggio al pudore pubblico che dà quindi luogo al conflit-to ma è più spesso vero l’inverso. ad esempio, nel novembre del 1890, quando un poliziotto interviene nel mezzo di una lite violenta in strada tra un uomo e una donna, l’uomo, un bracciante di 44 anni, dice alla guardia: «che sei venuto a fare? che fai osservare, la legge del c…?» e – si legge nella sentenza che lo condanna a 3 mesi di carcere – «non contento di ciò trasse anche fuori il membro virile».41
nel giudicare questi casi, i magistrati mostrano un certo equilibrio nelle loro valutazioni e, non di rado, assolvono per inesistenza di reato gli imputati di oltraggio a pubblico ufficiale. Anche nel caso di Gio-vanni, pur riconoscendolo colpevole, ritengono ad esempio che, «per le speciali circostanze del fatto, la pena […] deve determinarsi nel suo minimo», in sei giorni di carcere.
il minimo della pena è la regola. a volte non si ritiene neanche provata l’accusa delle Guardie;42 altre volte si concedono le attenuanti non solo per i buoni precedenti, ma anche per «l’irritazione d’animo in cui si trovava» o perché «mancava l’animo di ingiuriare».43 e quando il sentimento di offesa è fondato sull’idea di uno scambio dei ruoli, il giudice si mostra particolarmente clemente.44 si direbbe che i magistrati prendano atto di una «recita» difficile da entrambe le parti e scelgano di ignorare la connotazione in ultima istanza politica di tali conflitti.
8. i gesti osceni rivolti alle forze dell’ordine, come quello dell’uomo che lo indirizza alla vicina di casa, assumono un significato che è condi-viso da chi li compie e da chi ne è destinatario, ma anche dai giudici che sono chiamati a valutarne le intenzioni. e i giuristi si muovono anch’essi su un terreno familiare quando si tratta di riconoscere nell’oscenità l’in-tenzione di ingiuriare qualcuno.45
41. asR, tP, s, v. 5.657, 10 dicembre 1890.42. asR, PU, s, reg. 8, 9 gennaio 1872.43. asR, PU, s, reg. 52, 17 luglio 1875 e, ivi, 12 luglio 1875.44. nel caso del «bisognerebbe fare la guardia una volta per uno», si legge nella sentenza
che «queste parole, sia per il loro contenuto, il quale più che un’ingiuria costituisce una sgarba-tezza, sia per l’animo con cui furono pronunciate, diretto piuttosto ad esprimere il dolore della incorsa contravvenzione, che a ferire l’onore e la rispettabilità del pubblico agente cui furono rivolte, e dettate piuttosto da ignoranza che dal mal animo, non si ravvisano contenere i caratteri dell’oltraggio», per cui si dichiara il non luogo a procedere per inesistenza di reato. asR, PU, s, reg. 193, 10 luglio 1885.
45. si veda ad esempio il dibattito scaturito da una sentenza della cassazione di Roma nel 1890, in Formica, Oltraggio al pudore, pp. 279-280.
Ricerche206
si tratta di gesti aggressivi e offensivi, compiuti in risposta a quella che viene percepita come un’invasione della propria sfera di libertà per-sonale. Gesti che appartengono del resto a un repertorio tradizionale.
Raccogliendone un piccolo campionario ai primi del novecento, Raffaele corso citava le osservazioni di alessandro dumas sulla zona di napoli, «dove i lazzaroni sono soliti abbassarsi i pantaloni di fronte al vesuvio, per schernirsi del vulcano e scongiurare gli eventuali danni derivanti dalla lava e dalla pioggia di sabbia in caso di eruzione». e ancora dumas narrava un episodio delle gesta di Masaniello: «fece fer-mare la banda, come per rendere omaggio al viceré; dopo ognuno, con un unico movimento, fece cadere il suo pantalone e mostrò al viceré e alla corte ciò che il lazzarone scopre di fronte al vesuvio!».46
Spiegando il significato contestuale e relativo dell’oscenità, Di nola sottolineava come alcuni termini e alcuni gesti siano oggetto di tabù a seconda dei destinatari: non soggetti a censura in alcuni rapporti sociali, lo sono invece in altri, soprattutto al cospetto di un’autorità.47 Nel caso di Masaniello, come nei conflitti tra maschi dei ceti popolari e forze dell’ordine che abbiamo visto, questa notazione si direbbe trovare una piena conferma.
il ventaglio di situazioni che le fonti restituiscono è però molto più ampio. E spesso diventa difficile rispondere alla domanda: “cosa stanno facendo?”.
i testimoni di via dei cappellari che vorrebbero aiutare Giovanni dicono: «doveva essere o matto o ubriaco». sanno evidentemente che non essere nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali vale come attenuante; e tentano di spiegare il gesto con la sua irrazionalità. nel caso specifico – come abbiamo visto – la spiegazione non funziona per-ché ai giudici è molto chiaro “cosa stava facendo” l’imputato. in altri casi, invece, l’ubriachezza fornisce una ragione sufficiente a riconosce-re un’attenuante e non indagare oltre; tanto più che ai giudici interessa soprattutto accertare che un oltraggio al pudore pubblico sia avvenuto.
È il caso di sebastiano che, «colle spalle al muro, e col membro fuori dei calzoni, additandolo al pubblico, se la rideva dell’atto da lui fatto».48 È anche il caso di angelo, che «esibiva il membro virile rivolto verso la gente numerosa che passeggiava nel giorno di festa».49 e di
46. corso, La vita sessuale, p. 169. il testo di dumas al quale fa riferimento è la raccolta di articoli pubblicati a napoli nel 1863 con il titolo Da Napoli a Roma.
47. di nola, Oscenità e riso, p. 74.48. asR, tcP, Pr, b. 4.270, fasc. 32.703; ivi, s, vol. 5.591, s. 11 maggio 1885.49. asR, tcP, s, vol. 175, s. 10 luglio 1905.
Rizzo, Interpretare un gesto 207
Genesis, iX / 2, 2010
molti altri ai quali, in circostanze analoghe, la pena inflitta è di pochi giorni di carcere.
Un’aria di famiglia accomuna poi queste ad altre storie di ubriachi. domenico, ad esempio, un uomo di 35 anni, che lavora come guardiano nel quartiere in costruzione ai Prati di castello, alle quattro del pome-riggio se ne va gridando per i vicoli attorno al Pantheon: «chi mi fa rizzare il c… ci do una lira».50
Qui non c’è una “crisi sociale” a scatenare l’oscenità: la sospensio-ne delle norme culturali è piuttosto un effetto individuale dell’alcool. Ma la direzione nella quale spinge l’ubriachezza non è in se stessa priva di significato. I tre uomini citati si direbbero accomunati – almeno in quell’istante – da una personale utopia, dall’immaginazione cioè di un mondo nel quale esista una disponibilità diffusa ad appagare i loro desi-deri; uno “stato di natura” nel quale sia sufficiente mostrare il membro per ottenere favori; un mondo-postribolo, nel quale basti una lira per avere soddisfazione.
se i tre ubriachi “stanno facendo” qualcosa, è il gioco del mondo alla rovescia. impersonano il “re di carnevale”, al quale ogni osceni-tà è lecita. non a caso sebastiano «se la ride», rivolgendo a tutti un gesto che è più frequente rivolgere alle prostitute; e domenico offre una lira, un compenso che le fonti giudiziarie coeve attestano infinite volte, soprattutto nei confronti di bambini e bambine. Un carnevale, però, evidentemente del tutto personale, privo di qualsiasi ritualità e legittimazione sociale.
9. seguendo le guardie attraverso la città, incrociamo una serie ul-teriore di comportamenti e usi del corpo che hanno lasciato traccia do-cumentaria proprio in virtù della presenza delle forze dell’ordine.
lo spettro delle situazioni è ampio, e ci porta ineluttabilmente sul terreno scivoloso dell’esibizione come pratica sessuale. si tratta di circostanze, infatti, nelle quali il gesto ha una connotazione in tal senso molto esplicita. le fonti permettono di riconoscerne almeno tre distinte tipologie.
la prima riguarda forme di approccio estremamente dirette e aggres-sive, da parte di uomini giovani, tra i 18 e i 35 anni al massimo, nei con-fronti di ragazze – e talvolta di ragazzi – anche loro giovani, all’incirca coetanei. il contesto è la strada, nell’ambito di quelle che l’antropologia
50. asR, tcP, Pr, b. 4.291, fasc. 33.148; ivi, s, vol. 5.593, s. 6 luglio 1885.
Ricerche208
urbana definisce «relazioni di traffico», forme cioè di incontro tra estra-nei.51 vediamone alcuni esempi.
luigi segue Maria per la strada, dicendole: «che bel culo che hai! Potessi fare una scopata con te» e – racconta la donna – «ad un certo pun-to finisce con l’estrarre l’asta».52 Mentre Gaetano guadagna l’attenzione di virginia abbassandosi i calzoni e dicendo: «ti mangeresti un pezzo di questo qua?».53
l’unico ubriaco è achille, che «pedinando alcune ragazze se ne [va] col membro fuori dai calzoni».54 Gli altri due sono invece sobri, e sobrio è anche domenico, un venditore di giornali di 33 anni; proprio il suo comportamento – protratto nei giorni – ci fornisce qualche elemento per interpretare le dinamiche anche degli altri casi.
Per due settimane, ogni pomeriggio, alcune diciottenni s’imbattono in lui rientrando a casa. l’uomo fa, nel tempo, almeno tre cose diverse. la prima: «mette le mani sulle parti pudende» e dice loro: «vedete, lo vendo per poco». la seconda: offre loro dei soldi «purché si facciano baciare le parti genitali». la terza: si sbottona i calzoni e «le invita a gran voce».55 tra le tre espressioni c’è una continuità, ma ogni passaggio è a sé stante. in un primo tempo, infatti, scherza rovesciando le parti, attri-buendo alle ragazze un tale desiderio di lui da essere disposte a pagarlo; e intende quindi rassicurarle: si offre a costo zero. domenico si muove qui nell’orizzonte semantico degli stornelli e, più in generale, dei canti osce-ni popolari, nei quali il contenuto è spesso giocato sullo svelamento del desiderio femminile.56 Un desiderio immaginato anzi come insaziabile e irrefrenabile (e in questo fonte di ansietà in diversi contesti culturali).
le ragazze lo accusano di «parole rozze e oscene». Forse sono gli agenti di polizia a verbalizzare così, traducendo termini diversi. Ma, in ogni caso, è fondamentale la distinzione che viene introdotta: l’oscenità potrebbe di per sé anche divertire, sedurre, avvicinare e creare confiden-za; potrebbe perfino presentarsi come audacia, brillantezza o sicurezza di sé; la rozzezza invece – congiunta all’oscenità – allontana, provoca repulsione e offende.
51. Per la discussione di un’ampia letteratura su questo tema cfr. Ulf hannerz, Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 220-226.
52. asR, tcP, s, vol. 178, s. 29 settembre 1905. il corsivo è mio.53. asR, tcP, s, vol. 93, s. 12 giugno 1900.54. asR, tcP, Pr, b. 4.263, fasc. 32.550; ivi, s, vol. 5.590, s. 24 aprile 1885.55. asR, tcP, s, vol. 183, s. 29 dicembre 1905.56. cfr. la raccolta di corso, La vita sessuale, pp. 205-281.
Rizzo, Interpretare un gesto 209
Genesis, iX / 2, 2010
ad aver lasciato tracce giudiziarie sono così gli uomini rozzi, quelli che non padroneggiano bene il codice dell’osceno, che non sanno render-lo elemento di complicità, che non sanno scherzare con le donne che vo-gliono attrarre; e talvolta non vogliono neanche attrarle, accontentandosi di passivizzarle verbalmente.
Quando domenico, infatti, passa alla seconda fase del suo approccio e offre lui dei soldi, sta di nuovo scherzando ma ha già perso, ed è del tutto verosimile che lo sappia. il suo approccio è senza alcuna speranza. ed è a questo punto che si abbassa i calzoni, quando tutto è già perduto, quando il rifiuto nei suoi confronti è conclamato.
se il gesto azzera qualcosa, infrangendo il tabù della nudità, sono qui le regole del corteggiamento tra i sessi, della gestione quotidiana dell’in-contro tra uomini e donne, del gioco delle parti di cui il linguaggio osceno potrebbe ancora partecipare se non si presentasse così rozzamente. dalla crisi innescata dall’impossibilità dell’incontro domenico – ma anche lu-igi e Gaetano – escono con un gesto fortemente aggressivo, che azzera le regole e conduce simbolicamente ancora una volta “fuori porta”. e non a caso – dopo aver subito parole e motteggi per giorni – è davanti all’esibi-zione che le ragazze invocano l’intervento di una guardia che si trova nei paraggi. «Furono costrette a fuggire», spiega la sentenza che condanna domenico a tre mesi di carcere.
10. Una seconda tipologia di esibizione assume anch’essa connotati sessuali ma all’interno di un quadro relazionale del tutto diverso. anzi-tutto a causa dell’età delle vittime, che sono bambini e bambine tra i sette e i dodici anni, adescati da uomini di tutte le età. il più giovane di essi di cui ho trovato traccia ha infatti 19 anni, il più anziano 82.
tra otto e novecento i tribunali si occupano molto spesso di bam-bini. Un celebre medico legale scriveva, ad esempio, a fine secolo: «nella mia ormai lunga carriera di perito giudiziario, ben rare volte sono stato adibito da’ magistrati per esaminare persone oltre i 10, 12, 15 anni, dolentisi per patito oltraggio al pudore e per violento stupro; la massa de’ miei casi (e davvero ne ho veduti molti in circa trent’anni) si compone quasi per intiero di fanciulle e di ragazzi in bassa età e in umile condizione sociale».57
57. Giuseppe Ziino, Stupro e attentati contro il pudore e il buon costume, in Digesto Italia-no, XXii2, torino, 1895, pp. 897-1004, p. 908; analoghe considerazioni aveva già fatto in Clinica forense, napoli, 1886, p. 48. Una certa enfasi sul tema si trova nel francese Les attentat aux mœurs di ambroise tardieu (Parigi 1857; Grenoble 1995, a cura di Georges vigarello, alla quale andranno riferite citazioni successive), tradotto in italia come Delitti di libidine: oltraggi pubblici al pudore,
Ricerche210
a Roma, in particolare, la metà dei reati sessuali giudicati riguarda vittime meno che dodicenni. nella grande maggioranza dei casi si tratta di uomini che conoscono già i bambini e non hanno bisogno di adescarli in strada: sono parenti o vicini di casa, portieri dello stabile in cui abita la famiglia, bottegai o artigiani. al riparo da sguardi indiscreti, toccano e si fanno toccare dalle vittime, che in alcuni casi tentano anche di pe-netrare. vengono colti sul fatto da un altro adulto o accusati in seguito dagli stessi bambini.58
tra le numerosissime molestie di questo genere e le poche vicende di esibizione la differenza principale sta nel fatto che, per i bambini, co-storo sono degli estranei. la dinamica dei fatti suggerisce in ogni caso una certa contiguità tra i due fenomeni. ad esempio Giuseppe, un uomo di 62 anni, si rivolge in strada ad anita, una bambina di 7. e, secondo la sentenza, «estratto il proprio membro, prese a dimenarlo con una mano in atto osceno; e così facendo la invitò ad avvicinarsi, promettendo di compensarla poi con due soldi. la bambina, invece, vedendo poco lun-gi la Guardia Municipale […] corse verso di essa raccontandole quanto le era avvenuto».59
l’esibizione come preliminare per stabilire un contatto sessuale però, ai fini del nostro tema, è meno interessante di un’altra possibile dinamica della quale le fonti danno conto in pari misura. e cioè l’esi-bizione “fine a se stessa”. Poiché ha rilevanza penale, infatti, accertare se l’imputato abbia accompagnato il gesto con inviti espliciti, parole o promesse di qualsivoglia genere, i giudici lo domandano e – nelle pur stringate sentenze – riferiscono le risposte dei bambini. siamo quindi in grado di distinguere tra le due situazioni.
i fatti sono in sé alquanto banali. così, ad esempio, nel 1885 un uomo di 30 anni si scopre, sotto il colonnato di san Pietro, davanti a una dodicenne che sta andando dal padre, dipendente vaticano.60 Qualche anno dopo, nello stesso posto, un cinquantenne fa lo stesso davanti a
stupri ed attentati al pudore, pederastia e sodomia: studio medico-legale (Roma 1898); l’opera di tardieu in ogni caso costituisce – ben prima della sua traduzione – un riferimento centrale per la medicina legale italiana in materia di reati sessuali. si veda anche Storie di violenze sui bambini. Testi di A. Tardieu e E.C. Bourdin (1860-1882), a cura di Giuliana Kantzà, Pisa, ets, 1986.
58. sull’insieme dei casi rinvio al mio Gli spazi della morale, cap. 2, pp. 67-91. Un quadro analogo emerge a Parigi a partire dalla seconda metà del Xviii secolo, sul quale cfr. Georges vi-garello, Storia della violenza sessuale (XVI-XX secolo), venezia, Marsilio, 2001, pp. 91-92.
59. asR, tcP, s, vol. 175, s. 3 luglio 1905; identiche le dinamiche in: ivi, vol. 165, s. 6 febbraio 1905; ivi, vol. 178, s. 27 settembre 1905; ivi, vol. 183, s. 18 dicembre 1905.
60. asR, tcP, Pr, b. 4.248, fasc. 32.170; ivi, s, vol. 5.587, s. 27 gennaio 1885.