intellectuels et modernité
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of intellectuels et modernité
IL DIFFICILE INGRESSO DEGLI INTELLETTUALI EUROPEI NELLA mODERNITà DOPO IL 1905
Christophe Charle
Gli intellettuali europei avevano dato molta importanza all’entrata nel XX secolo, in ragione del fascino per le cifre rotonde (inizio del XX secolo dell’Era cristiana) e soprattut-to della credenza rimasta intatta nell’opinione progressista, sul carattere cumulativo ed illimitato del progresso umano. I profeti della decadenza, attivi fin dagli anni Ottanta del secolo precedente, e i nemici della modernità, virulenti fin dagli anni Novanta, si sono sempre fatti sentire. Tuttavia, il campo della modernità sembrava aver ricevuto aiuti inattesi e vari, atti a rinnovare il tradizionale discorso sul progresso:– una serie d’innovazioni tecniche rea lizzatesi tra il 1890
e il 1900, rilanciarono l’immagine delle sorti progressive dell’umanità, proprio quando il discorso sul progresso vi-vacchiava su marchingegni ormai datati: alla ferrovia, sim-bolo dell’abolizione dello spazio e del tempo, si sommava-no l’automobile e l’aereo che aprivano nuovi orizzonti di libertà come pure il telefono o il cablaggio transoceanico1.
– la conquista degli ultimi spazi sconosciuti del mondo e quelli più inospitali è illustrata da mostre polari o amazzo-niche2.
Traduzione dal francese di J. Errante rivista da F. Chiarotto.1 vedi l’entusiasmo suscitato dall’attraversamento della manica da parte di Blériot, che fornì ispirazione per le rappresentazioni pittoriche di Delaunay su questi temi; cfr. C. Studeny, L’invention de la vitesse France XVIIe-XXe siècle, Gallimard, Paris 1995.2 Cfr. A. Enders, Positivisme et mythe de la frontière dans l’expediçao cientifica Roosevelt-
ultima.indd 281 26-10-2010 13:59:09
282 christophe charle
– la lunga depressione che alimentò il pessimismo di fine se-colo, è sostituita dall’espansione economica della “Belle épo-que” e dall’ascesa di nuove economie extra-europee (Stati-Uniti, Giappone); queste rimettono in discussione l’egemo-nia europea e pongono dubbi sull’avvenire dell’Europa nel mondo globalizzato, dove le differenze si accentuano.
– gli scienziati esplorano, con l’ausilio della radioattività, ma-terie sconosciute dalle sorprendenti proprietà (scoperta delle proprietà radioattive del radio da parte di Pierre e ma-rie Curie e H. Becquerel nel 1898) o ancora l’uso di raggi X (1895) per esaminare il corpo umano.
– la nascita del cinema, dopo il 1895, fa entrare il mondo nell’immenso campo sconosciuto del virtuale e della vera illusione3.Questi pochi fatti e avvenimenti, raggiungono il grande
pubblico perché trovano spazio sulla stampa e sono commen-tati dai principali intellettuali.
Se vogliamo soffermarci ora su altre tipologie di modernità più avanguardiste, o sulle quali gli apprezzamenti dei contem-poranei possano divergere in base ai gusti o agli orientamenti politici, il decennio precedente alla guerra è ugualmente ricco di rotture spettacolari. Queste, tuttavia, non possono essere in-terpretate semplicemente tramite una griglia presa in prestito all’antico pensiero progressista del XIX secolo. Infatti, dopo il 1905, sorgono movimenti pittorici, musicali o teatrali che vogliono andare oltre le innovazioni della prima modernità: il fauvismo, cubismo, futurismo e astrattismo (Kandinskij, Kupka ecc…); nella pittura, i balletti russi e la prima scuola di vienna; nella musica e coreografia, le nuove sperimentazioni teatrali (E. Gordon Craig, A. Appia, v. meyerhold, C. Stanilavsij)4.
Rondon au Mato Grosso et en Amazonie 1913-1914, «Revue d’histoire d’outremer», t. 85, 1998, pp. 83-104 (disponibile in rete: http://nuevomundo.revues.org/do-cument607.html).3 Pour une histoire cinématographique de la France, dossier coordinato da C. Gauthier, P. Ory, D. vezyroglou, «Revue d’histoire moderne et contemporaine» n°51-4, ottobre/dicembre 2004; R. Bellour, La naissance du cinéma, in L. Brion-Guerry, L’Année 1913. Les formes esthétiques de l’œuvre d’art à la veille de la première guerre mon-diale, Klincksieck, Paris 1971, pp. 885- 921.4 J.F. Dusigne, Le Théâtre d’art: aventure européenne du XXe siècle, Ed. théâtrales, Paris 1997; per un bilancio delle tendenze musicale, cfr. m. Guiomar, Prémices, attentes et sacres. Les jeux et les conflits des tendances musicales et l’humanisme européen, in L. Brion-
ultima.indd 282 26-10-2010 13:59:09
il difficile ingresso degli intellettuali europei 283
Alla prima modernità degli anni 1860-80, che rimetteva in causa gli accademismi figurativi, il romanticismo musicale e il teatro borghese, succede una nuova modernità, più radicale ancora. Questa si libera dalla rappresentazione pittorica tradi-zionale (cubismo, movimento verso l’astrazione), dai canoni musicali vecchi di tre secoli (le prime opere atonali sono data-te 1908-1911), dal rapporto tra corpo umano e spazio scenico convenzionale nella danza (Isadora Duncan, balletti russi, Sa-gra della Primavera,1913)5. Il nuovo teatro rivendica anche un capovolgimento della scena, della scenografia, delle luci, del rapporto con gli spettatori6.
In modo più discreto, è anche il momento dell’esplorazio-ne dell’inconscio da parte di Freud, il quale abbandona i pro-cedimenti medici positivisti per l’interpretazione delle parole del paziente7. Alcuni scrittori ancora sconosciuti elaborano segretamente nuove forme di romanzo: da Proust con A la recherche du temps perdu (Du côté de chez Swann, è datato 1913), ai romanzi inediti di Kafka, ai primi scritti di Joyce. La contami-nazione della letteratura con la scienza porta alla fantascienza o all’utopia, con numerosi romanzi anticipatori a forte carica emotiva: citiamo Time machine (1895), The invisible man (1897), The War of the worlds (1898), The first men in the moon (1901) di H.G. Wells, gli ultimi Evangiles di zola, Travail (1901) e Vérité (1903), i romanzi sulle guerre future8, i films di méliès che aggiungono il potere dell’immagine ai romanzi di Jules verne (Le premier voyage dans la lune, 1902).
Guerry (dir.), L’Année 1913 cit., t. 1, pp. 395-488; D. Jameux, Le goût musical dans un centre de haute tradition. Vienne 1913, ibid., pp. 489-512 e E. Hurard, Aperçu sur le goût musical à Paris en 1913, ibid., pp. 513-26; J. F. Fulcher, French cultural politics and music, from the Dreyfus Affair to the great war, Oxford U.P., New York - Oxford 1999. 5 G. Prudhommeau, La chorégraphie de 1909 à 1914, in L. Brion-Guerry, L’Année 1913 cit., pp. 823-53.6 A. villiers, La recherche d’un nouvel espace théâtral en 1913, in ivi, pp. 769-87 e D. Bablet, “La plastique scénique” ibid., pp. 789-815; Opera and Society in Italy and France from Monteverdi to Bourdien, Cambridge, Cambridge U.P. 2007.7 L’interprétation des rêves conclusa il 4 novembre 1899 ma volontariamente postda-tata al 1900 per ottenere l’effetto simbolico della cifra tonda della nuova era (E. Roudinesco, “Freud” in Célébrations nationales, 2000). Negli anni successivi, Freud allarga il metodo all’interpretazione delle opere (Delirio e sogni nella Gradiva di W. Jensen, Un ricordo d’infanzia di Leonardo Da Vinci).8 Cfr. The great war with Germany, 1890-1914. Fictions and fantasies of the war-to-come, a cura di I. F. Clarke, Liverpool U.P., Liverpool 1997.
ultima.indd 283 26-10-2010 13:59:09
284 christophe charle
Si possono analizzare questi elementi rapidamente abboz-zati, interrogandosi su tre trasformazioni specifiche di questi anni della seconda modernità:1) quale è il grado di internazionalizzazione della vita intellet-
tuale, facilitata dalla circolazione degli intellettuali e delle produzioni intellettuali grazie all’accelerazione delle proce-dure di trasmissione o alla mobilità crescente delle élites?
2) vi è una modificazione dell’auto-percezione delle identità nazionali e della gerarchia dei Paesi dominanti nella nuova congiuntura mondializzata nella quale l’Europa percepisce confusamente nuove e minacciose potenze?
3) come è percepita la guerra, sempre più presente nell’at-tualità internazionale: guerra dei Boeri (1899-1902), guer-ra russo-giapponese (1904-1905), crisi marocchina, guerre balcaniche, in questo dibattito intellettuale internazionale?
1. Internazionalizzazione della vita intellettuale?
Una delle maggiori manifestazioni della modernità, agli occhi degli europei, era l’apertura culturale su uno spazio sempre più internazionale, europeo ma sempre più mondiale. L’unificazione culturale è molto più profonda per i circoli bor-ghesi o d’avanguardia che seguono la stessa attualità letteraria o artistica tramite le riviste e la stampa, le quali – per certe lin-gue internazionali – hanno abbonati in tutte le capitali.
Così Stefan zweig, nel suo Le monde d’hier, souvenirs d’un Européen, sottolinea come la giovane generazione borghese au-striaca fosse al corrente delle ultime tendenze a Parigi quasi istantaneamente, grazie alle riviste:
In un buon caffè di vienna, si trovavano non soltanto tutti i gior-nali viennesi ma anche quelli di tutto l’Impero tedesco, quelli francesi, inglesi, italiani ed americani oltre alle principali rivi-ste d’arte e di letteratura del mondo intero, Le Mercure de France come la Neue Rundschau, lo Studio e il Burlington Magazine. Così sapevamo di prima mano tutto quello che succedeva nel mondo; eravamo informati di tutti i libri che erano pubblicati, di tutte le rappresentazioni in qualunque luogo avvenissero, e potevamo confrontare le critiche di tutti i giornali; probabilmente, nulla ha contribuito tanto alla mobilità intellettuale ed all’orientamento internazionale dell’Austriaco quanto questa facilità che aveva a
ultima.indd 284 26-10-2010 13:59:09
il difficile ingresso degli intellettuali europei 285
reperire così completamente, al caffè, gli avvenimenti mondiali e poterne discutere con un gruppo di amici.9
Questo discorso nostalgico è in parte edulcorato dal tempo; il testo è, infatti, stato scritto da zweig nel corso della Seconda guerra mondiale, nel momento in cui questa Europa intellet-tuale i dea le lasciava spazio al caos e al furore della barbarie na-zista. Un’analisi più obiettiva, fondata su indicatori bibliografi-ci o culturali, permette di stabilire un bilancio più oggettivo.
Circulazioni letterarie
Se si considera, ad esempio, la presenza della letteratura straniera nelle grandi riviste culturali francesi, si costata un certo divario in base al tipo di riviste. Une rivista relativamente vicina all’avanguardia come il «mercure de France», pubblica numerosi resoconti sulle opere straniere ma fornisce ai suoi lettori un numero modesto (44) di traduzioni di opere ori-ginali e continua a dare la precedenza all’Inghilterra, paese con il quale la Francia ha tradizionalmente mantenuto le più intense relazioni intellettuali, e che risulta maggioritario per le traduzioni e dominante per i resoconti.
Le due grandi riviste che raggiungono il grande pubblico erudito («Revue de Paris» e «Revue des Deux mondes»), sono ancora meno aperte al settore straniero, e danno la priorità alla letteratura inglese; ma al secondo posto troviamo l’Italia per l’una e la Germania per l’altra. vista dalla Francia, l’Europa let-teraria dell’inizio del XX secolo rimane dunque l’Europa illu-minista delle vecchie nazioni letterarie, dopo il breve interesse per le letterature del Nord o russe degli anni 1880-’90. Eppure il dibattito letterario degli anni antecedenti, in Germania, In-ghilterra o Francia, si è focalizzato soprattutto sulle letterature russe o scandinave (Tolstoj, Dostoevskij, Gorki, teatro di Ibsen e in seguito Strindberg)10. Per la letteratura russa, l’importanza
9 S. zweig, Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, ried. Belfond, Paris 1982, p. 62 (ed. orig. Die Welte Von Gestern. Erinnerungen eines Europäers, Fisher, Stockholm 1941).10 Cfr. C. Charle, Paris fin de siècle, Le Seuil, Paris 1998, cap. 6 e B. Wilfert, Paris, la France et le reste…Importations littéraires et nationalisme culturel en France, 1885-1930. Tesi dell’Università di Parigi-I, sotto la direzione di C. Charle, 2003.
ultima.indd 285 26-10-2010 13:59:09
286 christophe charle
del movimento di traduzioni negli anni Ottanta dell’ottocen-to (dovuto alla presenza di numerosi russofoni in Francia do-po l’afflusso di studenti russi a Parigi), può spiegare che una
Tab. 1: La presenza delle letterature europee nel «mercure de Fran-ce» (1897-1904)
Letteratura Traduzioni Resoconti n % n %tedesca 2 4,5 153 13,1inglese 24 54,5 370 31,9spagnola 1 + 2 * 182 15,6italiana 1 97 8,3olandese 5 ** 74 6,3polacca 0 39 3,3portoghese (e brasiliana) 0 84 7,2rumena 0 1 scandinave 3 45 3,8russe 6 51 4,4ceca 0 64 5,5Totale 44 - 1.160 -
Tab. 2: Articoli sulle letterature straniere e traduzioni in la «Revue de Paris» e la «Revue des Deux mondes».
Letteratura Revue de Paris Revue des Deux Mondes n % n %tedesca 10 10,8 35 29,4inglese 27 29,3 40 33,6spagnola 3 3,2 3 2,5italiana 25 27,1 20 16,8olandese 6 6,5 1 0,8polacca 0 - - -portoghese 0 - - -rumena 0 - 2 1,6scandinave 6 - 6 5,0russe 15 16,3 12 10,0ceca 0 - - -Totale 92 119
(Fonte: Table décennale 1894-1903 e Table analytique des articles 1901-1911)
ultima.indd 286 26-10-2010 13:59:09
il difficile ingresso degli intellettuali europei 287
cronaca delle opere originali o delle pre-pubblicazioni in una rivista d’avanguardia come il «mercure de France» sia meno necessaria. Per quanto riguarda le opere scandinave, sono state messe in scena al “Théâtre libre” o al “Théâtre de l’Oeuvre” e un autore come Strindberg si traduce autonomamente per conquistare la Francia. L’Italia è presente soprattutto con Ga-briele D’Annunzio e matilde Serao le cui opere sono pubblicate in anteprima nella «Revue des Deux mondes» o nella «Revue de Paris», più diffuse rispetto al «mercure de France»11. Anche in questo caso, l’assidua presenza di scrittori e attori italiani a Parigi e l’importanza degli adattamenti diretti delle opere per via della vicinanza linguistica, rendono l’intermediazione di una cronaca delle opere in lingua originale meno decisiva12.
Queste differenze dimostrano che anche le riviste d’avan-guardia prediligono le aree più vicine, suscettibili di dare agli editori francesi proposte di traduzioni più commercializzabi-li. La casa editrice annessa al «mercure de France» pubbli-ca – non a caso – nelle stesse aree geografiche, appoggiandosi così alla diffusione precedente della fama degli autori operata a carico della rivista13.
Al contrario, la focalizzazione del dibattito letterario sul più esotico segnala che esistono ora due tipi di reti letterarie tra la Francia e l’Europa: quelle che fanno capo agli scambi tradizio-nali, avviati nel XvIII secolo, prese in carico dalle riviste gene-riche e le case editrici commerciali; e quelle che dipendono da relazioni più militanti esteticamente o politicamente, prese in carico dagli stessi autori in funzione dei dibattiti letterari fran-co-francesi dove si tratta di naturalizzare gli scrittori stranieri per rinforzare la loro posizione e non semplicemente per fare prosperare correnti commerciali (soprattutto romanzesche) stabilite da tempo.
La moda di Nietz sche, promossa dall’avanguardia lettera-ria in Francia come in Italia, contro l’establishment filosofico e persino nel suo paese di origine, la Germania, illustra questo
11 La «Revue de Paris» ha tradotto sette opere di D’Annunzio tra il 1894 e il 1903.12 Cfr. R. Lelièvre, Le théâtre dramatique italien en France 1855-1940, Colin, Paris 1959.13 vedi Le Mercure de France cent un ans d’édition, catalogo dell’esposizione della BNF, 1995, p. 141, sotto la direzione di m.F. Quignard.
ultima.indd 287 26-10-2010 13:59:09
288 christophe charle
fenomeno, come hanno dimostrato Christopher E. Forth e Louis Pinto14.
Si potrebbe obiettare che si tratta di una particolarità tutta francese, quella di tenere molto allo statuto privilegiato della letteratura nella stampa in Francia e alla secolare intensità del dibattito tra generazioni e scuole come modi d’accesso alla no-torietà. Di fatto, per la prima volta nella storia letteraria d’altri Paesi, sono comparse battaglie letterarie in Inghilterra, in Eu-ropa Centrale, in Italia, in Russia, in Ungheria, in Spagna, dove i principi d’opposizione propri del campo francese si possono ritrovare più o meno identici, a volte con le stesse etichette o con etichette analoghe e dove le reti create con la Francia sot-to forma simbolica, effettiva o politica poggiano su legami con le correnti francesi per omologia di posizione15. Quest’epoca vede anche un fiorire di riviste letterarie, artistiche, culturali e politiche, dove si ritrovano le stesse rubriche da un paese all’al-tro, e che contribuiscono alla circolazione dell’informazione tra intellettuali giacché questi non possono più stare dietro ad una produzione europea pletorica16.
Se esaminiamo la circolazione della cultura allargata, rap-presentata dal teatro, ritroviamo la stessa stabilità. Il teatro francese continua (come nel XvIII secolo o nella prima me-tà del XIX secolo) ad esportare verso l’Inghilterra, la Germa-nia, l’Italia e la Russia, e persino gli Stati Uniti, ma la parte di opere straniere su ogni scena nazionale ha piuttosto tendenza a ridursi o ad essere rappresentata esclusivamente su scene d’avanguardia in rottura con le logiche commerciali dominan-ti, che lasciano circolare esclusivamente i generi prediletti dal pubblico come l’operetta, la commedie musicale o altri generi leggeri. Così a Londra, la parte di opere francesi nell’insie-
14 C. E. Forth, Zarathustra in Paris. The Nietz sche vogue in France 1891-1918, De Kalb, Northern Illinois U.P., 2001; L. Pinto, Les neveux de Zarathoustra, Seuil, Paris 1995.15 Polémiques et dialogues, les échanges culturels entre la France et l’Italie de 1880 à 1918, a cura di m. Colin, Centre de Publications de l’Université de Caen, Caen 1988; F. Livi, Le ‘Saut vital’. Le monde littéraire italien à Paris 1900-1914, in Le Paris des étran-gers, a cura di A. Kaspi e A. marès, Imprimerie nationale, Paris 1989, pp. 312-27; A. Hennegan, Personalities and principles. Aspects of literature and life in Fin-de-Siècle England, in (ed.), Fin de siècle and its Legacy, a cura di m. Teich e R. Porter, Cam-bridge U. P., Cambridge, 1990, pp. 170-215.16 Cfr. gli esempi di queste riviste analizzati nel tomo 2 di L’Année 1913.
ultima.indd 288 26-10-2010 13:59:09
il difficile ingresso degli intellettuali europei 289
me della produzione, si riduce dal 13,5 % negli anni 1890-92; al 6,2 % negli anni 1910-1217. La Francia, principale nazione esportatrice di opere teatrali, non è aperta ai teatri stranieri, eccezione fatta per casi particolari come il “Théâtre libre”, il “Théâtre Antoine”, il “Théâtre de l’Oeuvre”, il “Théâtre des Champs-Elysées” o per le stagioni speciali del “Châtelet”, che accolgono i balletti russi o delle compagnie italiane. Solamen-te le nazioni dominate subiscono l’influenza delle opere pro-venienti da fuori, non avendo una produzione locale sufficien-te. La quota di opere francesi sulle scene di vienna rimane stabile e attorno al 15-16% dal 189018. Sulle scene tedesche, in compenso, la parte del teatro straniero si è ridotta dal 18 % del totale al 10 % tra il 1881-’82 e il 1911-’1219.
Se esaminiamo la sfera artistica e musicale, dove la lingua e il successo di massa svolgono un ruolo minore rispetto al campo letterario o teatrale, l’internazionalizzazione appare più marcata. L’Opéra de Paris, a lungo chiusa alle produzioni straniere, dopo il 1871, ricupera il ritardo e mette in scene numerose opere provenienti dall’estero (Italia, Germania e Russia)20. In compenso, anche le opere francesi sono ampia-mente interpretate sulle scene di altri Paesi d’Europa: dieci compositori francesi dell’época, sono regolarmente messi in scena in Europa e in America21.
Avanguardie
La Francia, e in particolare Parigi, funge da calamita per i giovani artisti e ciò in modo molto più ecumenico che per le discipline accademiche: le nazionalità più presenti nella Ecole
17 Dati personali contabilizzati a partire di J.P. Wearing, The London stage 1890-1899. A calendar of plays and players, The Scarecrow Press metuchen, Londra 1976; The London stage 1900-1909. A Calendar of Plays and Players, ivi, 1981, 2 voll.; The London stage 1910-19. A Calendar of plays and players, ivi, 1982, 2 voll. 18 Tratto da conteggi personali a partire dal Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien.19 Statistiche stabilite a partire da Almanach der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger, 1883; P. voigt’s musikalien-verlag, Kassel-Leipzig 1894, 1903, 1913.20 F. Patureau, Le Palais Garnier dans la société parisienne: 1875-1914, mardaga, Liè-ge 1991.21 C. Charle, L’Opéra en France 1870-1900 entre nationalisme et importations étrangères essai de bilan, a cura di J. Fulcher, v. Johnson, T. Ertman, Opera and society, France and Italy XVI-XXth centuries, Cambridge U.P., Cambridge 2006.
ultima.indd 289 26-10-2010 13:59:09
290 christophe charle
des Beaux-Arts sono, ad esempio, quelle inglesi e americane. Questa dominazione instauratasi a partire dalla fine del Se-condo Impero, in seguito alla fama della pittura accademica francese, poi del Salone e successivamente, del mercato d’arte parigino, prosegue anche oltre quello che Cynthia e Harrison White hanno definito il “sistema mercantile critico” a spese delle istituzioni ufficiali22. Le avanguardie artistiche dell’inizio del XX secolo coinvolgono anche numerosi pittori stranieri ve-nuti a tentare fortuna a Parigi23. È in questi ambienti cosmopo-liti che riescono a farsi conoscere, a volte anche fuori dalla “vil-le Lumière”, una parte delle avanguardie più radicali, come gli spagnoli Picasso, Juan Gris, Picabia per il cubismo, Sonia Terk futura sposa Delaunay, e Chagall, di origine russa, gli italiani modigliani (presente a Parigi fin dal 1906) e Soffici (a Parigi dal 1900 al 1907), il ceco Kupka, il rumeno Brancusi a Parigi nel 1904, il bulgaro Pascin, giunto l’anno successivo, ecc.
Lo stesso eclettismo nazionale esiste per l’avanguardia astrat-tista promossa dai russi emigrati in Germania nella regione di monaco con il gruppo del Blaue Reiter con Kandinski e di Franz marc24. L’apertura internazionale non è limitata alla sola avanguardia: il “Salon d’Automne”, nel 1912 accoglie, infatti, un 44,1% di stranieri, con in testa gli artisti russi (10 %), poi americani (8,4 %), tedeschi (4,4%), svizzeri (4,3%) e inglesi (4,1%). Il “Salon de la Société nationale des Beaux-Arts” riceve una quota leggermente inferiore di opere provenienti dall’este-ro (35,5%), come pure la “Société des artistes français” (21,1%) ma l’internazionalizzazione è nettamente superiore a quella del-le università o della vita letteraria25. A queste grandi mostre so-no da sommare ancora una moltitudine di mostre minori nelle quali i mercanti d’arte presentano gli artisti stranieri nelle varie capitali, fenomeno che va aumentando dopo il 190526.
22 C. White e H. White, La carrière des peintres au XIXe siècle: du système académique au marché des impressionnistes, Flammarion, Paris 1991.23 Cfr. B. Prunel-Joyeux, «Nul n’est prophète en son pays…» ou la logique avant-gardiste. L’internationalisation de la peinture des avant-gardes parisiennes 1855-1914, 3 voll., diretto da C. Charle, Université de Paris-I, 2005, t. 1, pp. 109-10.24 B. Prunel-Joyeux, tesi cit., t. 2, p. 609 e sgg.; J.Y. Bosseur, L’Almanach du “Blaue Reiter”, in L. Brion Guerry, L’année 1913 cit, t. 2, pp. 959-66.25 Annuaire statistique de la ville de Paris, 1913, masson, Paris 1915, pp. 476-80.26 B. Prunel-Joyeux, tesi cit., vol. 3, pp. 887-90.
ultima.indd 290 26-10-2010 13:59:09
il difficile ingresso degli intellettuali europei 291
Università invisibili
Paradossalmente, questi processi di apertura più lenti ad affermarsi nella cultura in senso lato, si sviluppano in modo decisamente più netto nella sfera universitaria e nella cultura scientifica d’élite. Lo si può dimostrare con lo studio dei flussi studenteschi in Europa. Karady ha, infatti, messo in evidenza la nuova peregrinatio academica che va affermandosi in Europa dopo il 1880, periodo che ho definito «della costruzione di un’università invisibile», con un rinnovo di flussi di studen-ti tra Est e Ovest dell’Europa. Questa mobilità è importante rispetto al numero totale di studenti dell’epoca, anche se si riferisce ad effettivi molto inferiori rispetto a quelli odierni; nel 1890, Karady recensisce 8.800 studenti stranieri nei prin-cipali Paesi dell’Europa Occidentale (Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Svizzera), e quasi tre volte di più nel 1910: 23.500. Per dare un ordine di grandezza, basti pensare che vi erano appena 26.000 studenti in Gran Bretagna nel 1910. Questi studenti migranti si distribuiscono in modo molto variabile nei diversi Paesi ospiti e sono concentrati in tre Paesi dell’Europa continentale: nel 1910, il 31 % studiano in Austria, il 24 % in Francia e il 19 % in Germania. L’area di lingua tedesca ha il sopravvento se si sommano Austria e Ger-mania, ma la Francia è in testa dopo la guerra del 1914-’18, visto che nel 1930, si concentra il 60 % degli studenti stranie-ri in Europa27. Da dove vengono questi studenti? Nel 1910, i due terzi sono originari della Russia e dell’Europa Centrale e Orientale. Nonostante la nascita di numerose università in quella parte dell’Europa, quelle occidentali continuano a svol-gere un ruolo di conclusione degli studi o d’iniziazione alla ricerca e alla cultura generale per gli studenti più ambiziosi o per quelli che sono discriminati (ebrei) nel loro paese di origi-ne. Intellettuali di alto livello ed élites di queste nuove nazioni si formano così in Europa Occidentale.
Questa migrazione costituisce, quindi, uno dei canali di pas-saggio della modernità per l’Europa meno sviluppata giacché,
27 v. Karady, Student mobility and western Universities. Patterns of unequal exchange in the European academic market, 1880-1939, in Transnational intellectual networks, a cura di C. Charle, J. Schriewer, P. Wagner, Campus, Frankfurt 2004, pp. 361-99, in particolare i dipinti alle pp. 371, 369, 373.
ultima.indd 291 26-10-2010 13:59:09
292 christophe charle
di ritorno a casa, questi laureati si fanno carico della moderniz-zazione del loro paese. Conoscendo le lingue dominanti, essi possono fare da intermediari tra la cultura europea e la cultura del loro paese. Gli studenti stranieri hanno tendenza a con-centrarsi nelle capitali dei paesi ospiti e ad approfittare, così, della centralizzazione delle risorse culturali, politiche e scien-tifiche anche se, contropartita negativa, la forte visibilità degli studenti stranieri in alcuni quartieri suscita, in alcuni periodi, reazioni violente e xenofobe. Esistono anche specializzazioni disciplinari: la sfera francofona attira di più gli studenti e le studentesse maggiormente volti alle lettere, la sfera di lingua tedesca quelli o quelle iscritti(e) nei settori tecnici e medici il ché a lungo termine, ha contribuito al mantenimento delle immagini nazionali dei due paesi: nazione letteraria/versus nazione scientifica e tecnica.
La concorrenza nell’egemonia intellettuale, per il tramite della creazione di reti di scambi universitari, si può riscontra-re nelle reti delle università di Parigi e Berlino. Benché mol-to poco aperto verso il mondo esterno, eccezione fatta per strutture importanti come il “Collège de France” o l’“Ecole des langues orientales”, il corpo docente universitario parigi-no – in particolare quello della Sorbonne –, raccoglie la sfida dell’egemonia tedesca negli anni 1890-1914, con delle mis-sioni in campo, l’avvio di scambi istituzionalizzati con gli Stati Uniti ad esempio o altri Paesi alleati, l’abitudine di spostarsi all’estero una volta ottenuta la cattedra per congressi, inse-gnamento all’estero, creazione di istituzioni… Il recupero è facilitato dalla costituzione di istituti di ricerca e formazione superiore all’estero, localizzati prioritariamente nei Paesi me-diterranei, specificità francese che verrà ripresa da altri paesi europei: dall’“Ecole française d’Athènes”, fondata nel 1846 ma che riprende slancio nel 1872 e l’“Ecole de Rome”, fondata nel 1873-74, all’“Institut de St Petersbourg”, fondato alla vigilia della guerra nel 1911, les “Ecoles supérieures d’Alger” (1879), l’“Institut d’archéologie du Caire” (1881), l’“Ecole française d’Extrême-Orient” (1898), l’“Institut français de Florence” (1908), l’“Institut des hautes études hispaniques” (1909)28.
28 C. valenti, L’École française d’Athènes 1846-1981, Université de Provence, sotto la direzione di G. Chastagnaret, 1999; L’histoire et l’œuvre de l’École française de Rome,
ultima.indd 292 26-10-2010 13:59:10
il difficile ingresso degli intellettuali europei 293
A sua volta, la Germania creerà istituzioni simili che rag-giungeranno il loro massimo sviluppo prima della guerra del 1914: ad Atene, Firenze e a Roma. L’Italia è presente in Egit-to29, l’Inghilterra a Roma.
Le stesse rivalità e la stessa egemonia della capitale france-se, in quanto all’organizzazione di congressi internazionali, si sviluppano sulla scia dei fenomeni iniziati negli ultimi due de-cenni del secolo. I primi anni del Novecento, segnano un’acce-lerazione sullo sfondo di tensioni internazionali: Claude Tapia ha così potuto censire 1.413 congressi tra il 1815 e il 1899, ma più del doppio nel periodo 1900-’14: esattamente 2.44530. Nel decennio 1890-’99, si passa da una media annua di 66 congres-si, a 135 per il decennio successivo e 230 tra il 1910 e il 191331. Si tratta dunque di una crescita esponenziale. Tuttavia, questa internazionalizzazione della vita scientifica rimane molto pola-rizzata in alcuni grandi centri. Tra il 1900 e il 1913, Parigi ha visto 404 riunioni, Londra appena 129, contro le 151 di Bru-xelles; le altre capitali europee si attestano molto indietro: 58 a vienna, 49 a Roma, mentre Berlino, madrid, San Pietroburgo non figurano neanche nel palmarès delle otto principali città di congressi. Parigi appare quindi sempre come il centro per eccellenza degli scambi internazionale, nonostante l’indebo-limento economico della Francia rispetto alle altre potenze europee. Nel 1900, ad esempio, per l’Exposition universelle, la più frequentata e cosmopolita del secolo, Parigi aveva accolto 203 congressi sui 232 dell’anno32. La dialettica, internazionaliz-zazione della scienza/centralizzazione a favore di alcune parti
De Boccard, Paris 1931; 1881-1909. L’Institut français d’archéologie orientale du Caire, Impr. de l’Institut français, Le Caire 1909; P. Singaravélou, L’École française d’Extrê-me-Orient ou l’institution des marges (1898-1956). Essai d’histoire sociale et politique de la science coloniale, L’Harmattan, Paris 1999; J. m. Delaunay, Des palais en Espagne. L’Ecole des hautes études hispaniques et la Casa de Velázquez au cœur des relations franco-espagnoles du XXè siècle (1898-1979), Casa de velàzquez, madrid 1994; I. Renard, L’Institut français de Florence (1900-1920), Ecole française de Rome, Rome 2001.29 Cfr. E. Gady, Le pharaon, l’égyptologue et le diplomate. Les égyptologues français en Egypte, du voyage de Champollion à la crise de Suez (1828-1956), tesi Université de Paris Iv, sotto la direzione di J. Frémeaux, 2005.30 C. Tapia, Colloques et société, Publications de la Sorbonne, Paris 1980, p. 41.31 Ibid., p. 46 d’après UAI, Les congrès internationaux de 1681 à 1899, Bruxelles, 1960 et de 1900 à 1919, Bruxelles 1964, p. 4.32 Ibid, p. 47.
ultima.indd 293 26-10-2010 13:59:10
294 christophe charle
dell’Europa, e il mantenimento di rivalità nazionali in ognuno di questi incontri, è sottolineata da tutti gli autori: la scelta delle lingue, il tempo a disposizione, la partecipazione più o meno importante in base ai luoghi, la dominazione intellet-tuale specifica di questo o quel paese in funzione dell’ambito, dell’alleanza tra piccole e grandi nazioni; tutto è materia di concordia o frizione, anche se la retorica dell’universalismo e dell’intesa tra scienziati è abbondantemente masticata con i toast iniziali e finali33. François Simiand, giovane sociologo e allora discepolo de Durkheim, ci vede uno degli strumenti di conoscenza reciproca nei settori emergenti quando le vie di pubblicazione sono ancora insufficienti per una corretta circo-lazione dei risultati scientifici:
I lavori in seduta sia generale e sia di settore, non sono tutto in un congresso; spesso non ne sono neanche l’aspetto principale. Sono piuttosto le conversazioni individuali, le conoscenze fatte in quelle occasioni, gli incontri tra persone già legate dalle loro ricerche o preoccupazioni comuni a costituire un gran vantaggio, forse il maggiore di un congresso.34
Certo è che la tragica fine di questo movimento d’inter-nazionalizzazione della vita intellettuale, ha tendenza a farci sottostimare la real tà e la modernità dello stesso. La guerra degli scienziati e scrittori che seguì lo scoppio dello scontro bellico mondiale, le violenze verbali scambiate, fin dall’estate 1914 tra vecchi colleghi, che si scrivevano o incontravano fino a pochi mesi prima, hanno occultato questo internazionalismo intellettuale in pieno sviluppo35. Per completarne l’approccio oggettivistico, dobbiamo quindi tentare di misurare gli effetti di questi scambi sulla percezione del mondo da parte degli in-tellettuali, con l’ausilio dell’immagine nazionale reciproca che essi hanno elaborato nel corso del decennio in questione.
33 Cfr. A. Rasmussen, L’internationale scientifique (1890-1914), tesi, EHESS, 1995.34 Cit. da A. Rasmussen, Sciences et sociabilités; un “tout petit monde” au tournant du siècle, «Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine», n. 3-4, 1997, pp. 49-57.35 m. Hanna, The mobilization of intellect. French scholars and writers during the great war, Harvard U.P., Cambridge 1996; C. Prochasson, A. Rasmussen, Au nom de la patrie. Les intellectuels et la première guerre mondiale, La Découverte, Paris 1996.
ultima.indd 294 26-10-2010 13:59:10
il difficile ingresso degli intellettuali europei 295
2. Modificazione della gerarchia delle potenze europee nel discorso sulla modernità
Superiorità degli anglosassoni?
Il passaggio dal XIX al XX secolo è stato segnato da una controversia internazionale sulla posizione e l’avvenire delle diverse zone dell’Europa36; la contesa prese avvio da un best-seller internazionale del sociologo leplaysiano Edmond Demo-lins, che esprimeva la sua tesi già a partire dal titolo della sua opera: A quoi tient la supériorité des Anglo-saxons?37. Le idee soste-nute non erano particolarmente originali, nemmeno in Fran-cia, dove una corrente anglofila esisteva fin dal XvIII secolo, ripresa da Guizot, poi Taine. ma la novità era nell’argomenta-zione: non era più la libertà inglese, la superiorità industriale, l’intraprendenza e lo spirito d’avventura che si ritenevano re-sponsabili della superiorità anglosassone, ma le strutture fami-liari, quelle educative e persino le qualità della “razza”. Queste idee si erano radicalizzate tra gli eugenisti o i social-darwiniani spesso tedeschi ed americani. Essi opponevano i popoli del Nord, votati alla dominazione del mondo, come dimostrava l’estensione dei loro imperi coloniali, ai popoli del Sud votati alla decadenza, come confermavano la disfatta spagnola con-tro gli Stati Uniti del 1898 e il fallimento italiano ad Adua, in Etiopia, nel 1896.
Gli intellettuali francesi non furono gli unici ad appassio-narsi a questo dibattito, riacceso lo stesso anno dalla rivalità coloniale franco-inglese su Fachoda38. Alcuni autori italiani e spagnoli misero in discussione o rifiutarono questa immagine
36 Cfr. C. Charle, Pour une histoire sociale comparée des débats intellectuels internatio-naux, l’exemple de la crise fin de siècle, in Internationalisierung, Internationalisation, Semantik und Bildungssysteme in vergleichender Perspektive, a cura di m. Caruso e H.E. Tenorth, Peter Lang, Frankfurt/m 2002, pp. 167-84. Per una vista d’insieme di questa rappresentazione degli europei, cfr. H. Kaelble, Europäer über Europa: die Entstehung des europäischen Selbstverständnisses im 19. und 20. Jahrhundert, Fran-kfurt/main, Campus, New York 2001.37 E. Demolins, A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons?, Didot, Paris 1897 (ed., Anthropos, Paris 1998).38 C. Prochasson, Une crise anglaise de la pensée française; les intellectuels français face à l’Angleterre au temps de Fachoda et de la guerre des Boers, «Cahiers du Centre de re-cherches historiques», n. 31, avril 2003, pp. 79-92.
ultima.indd 295 26-10-2010 13:59:10
296 christophe charle
positiva dei popoli del Nord, proponendo altre spiegazioni rispetto a quelle di Demolins (tirando in ballo, ad esempio, il tradizionalismo cattolico quale fattore di rifiuto del progres-so). Anche in Francia, la questione divise persino gli intellet-tuali che conoscevano più approfonditamente l’Inghilterra, i quali proposero una visione nettamente più critica, fondata sulle loro inchieste e soprattutto sull’evoluzione degli eventi dopo la guerra dei Boeri e la rivalità anglo-tedesca.
Nonostante il successo di pubblico e anche pedagogico39, Demolins segnò la fine di un’epoca più che l’inizio di un’altra. Due serie di motivi spiegano il cambiamento della percezione dell’Inghilterra agli occhi degli intellettuali francesi. Da un lato, la guerra dei Boeri (1899-1902), la nascita degli imperia-lismi, il ravvicinamento franco-inglese (in seguito all’Entente cordiale nel 1904), la spinta femminista, operaia e laburista, manifestano agli occhi dell’opinione pubblica l’ampiezza dei cambiamenti rispetto alla vecchia immagine del Paese; d’altro lato, le fragilità sociali interne dell’antica potenza del XIX se-colo. I luoghi comuni triti e ritriti, riproposti a partire da Taine sulla stabilità del Regno Unito, la dominazione aristocratica, la sottomissione delle classi popolari e l’invincibilità dell’Impero, sono in parte smentiti dagli eventi riportati dalla stampa. Co-me rilevato da Elie Halévy, il bilancio della guerra dei Boeri è stato molto pesante per la popolazione inglese: «Più di trenta mila inglesi erano morti; si era dovuto mantenere lì più di tre-centomila uomini; il budget del 1902 raggiunse i ottanta milio-ni di libbre, quattro miliardi e mezzo [di franchi]»40.
Inizio del dibattito sul “declino inglese”
Anche la società inglese, alla stregua delle altre nazioni eu-ropee, appare sempre più divisa: come la Francia, è minacciata dagli scioperi, dalle agitazioni sociali, dai pericoli esterni (que-stione irlandese) ed interni (campagna a favore del voto alle donne)41.
39 A lui si deve la fondazione dell’Ecole des Roches in Normandia, dove sono messi in pratica i principi educativi delle public schools rinnovate.40 E. Halévy, L’Angleterre et son empire, Pages libres, Paris 1905, p. 115.41 Cfr. R. Savary, La détérioration physique du peuple anglais (A propos d’une enquête récente), in Annales des sciences politiques, 1905, pp. 578-91. Nonostante le stati-
ultima.indd 296 26-10-2010 13:59:10
il difficile ingresso degli intellettuali europei 297
Il secondo fattore di evoluzione delle percezioni del vici-no, è legato alla presenza di un gruppo di specialisti, per lo più universitari, che hanno trascorso lunghi periodi di studio Oltre-manica e non rapidi viaggi come i saggisti antecedenti. Su posizioni politiche più a sinistra, essi ricercano nel “model-lo inglese”, rimedi che vadano oltre il salvataggio e la riforma di una classe dirigente o di una borghesia francese in cerca di legittimità. In risposta, gli anglofili liberali, si vedono costretti a modificare i loro discorsi per poter rispondere ai loro con-correnti ma anche per prendere le distanze dagli eccessi del razzismo anti-latino di Demolins.
Questo cambiamento è riscontrabile già nel 1901, in Études anglaises di André Chevrillon, nipote di Taine. Con un richia-mo alla guerra del Transvaal, Chevrillon prova a spiegare ai suoi lettori francesi perché il nazionalismo è stato tanto forte Oltre manica. mentre l’opinione francese è stata in maggio-ranza favorevole ai Boeri, senza pronunciarsi sulla sostanza, Chevrillon cerca di dare una spiegazione psicologica al gingoï-smo britannico. Con un procedimento iconoclasta, egli tenta di giustificare il complesso di superiorità inglese con una tra-sposizione del modo con il quale i francesi stessi, a volte, giusti-ficano il loro dovere di civilizzazione42:
Ogni popolo pone degli assiomi di quel genere, dando digni-tà di principio generale alle sue tendenze particolari, e, proprio perché asseconda le sue tendenze, si proclama il primo di tutti i popoli. In Francia, abbiamo formule analoghe: la sovranità della Ragione, i diritti astratti dell’Uomo, l’uguaglianza sociale di tutti i cittadini. Da parecchio tempo ormai, gli Inglesi hanno proiettato nell’assoluto della morale, i comandamenti dei loro istinti orga-nizzatori e almeno una parte del loro I dea le ha rispecchiato il loro attaccamento e senso della real tà concreta”.43
stiche allarmanti tratte da diverse inchieste sociali inglesi, l’autore riafferma ottimisticamente il suo credo anglofilo liberale. Per un’analisi inglese: J. E. Barker, The Economic decay of Great Britain, «Contemporary Review», n. 79, 1901, pp. 781-812.42 “L’opinion anglaise et la guerre du Transvaal”, datato 18 febbraio 1900, Etudes anglaises, Hachette, Paris 1901, p. 276-77. 43 Ibid. p. 298.
ultima.indd 297 26-10-2010 13:59:10
298 christophe charle
l’Inghilterra
pensa di essere il popolo capo, la guida del progresso umano, il principale costruttore o meglio, inventore della civilizzazione mo-derna, il missionario di questa civilizzazione. In India, in Egitto, in Sudafrica, predica questa civilizzazione; ovunque essa porga la sua mano, gli uomini vi guadagnano in indipendenza, sicurezza e prosperità materiale. mentre ogni paese capitato sotto altre mani, le appare perso o compromesso in quanto a civilizzazione. È per l’umanità che lavora: ecco quale è il sua funzione e da questa de-rivano i suoi speciali diritti.44
Questa difesa minimalista tradotta con il lessico politico fran-cese permise di evitare di pronunciarsi sulla sostanza (la bontà o meno della causa inglese nei confronti dei Boeri) e di urta-re l’opinione pubblica dominante francese. In compenso, fece passare l’i dea che il nazionalismo inglese con la sua forza e la quasi totale assenza di contestazione interna (mentre in Fran-cia, i nazionalisti antidreyfusardi e gli “intellettuali” dreyfusardi si scontravano da due anni), potesse essere ad esempio ad una Francia profondamente divisa dagli strascichi del caso Dreyfus.
La prima opera che smonta la vulgata liberale e, a mag-gior ragione, gli schieramenti socio-darwiniani di Demolins, è prodotta da Elie Halévy. È il risultato della richiesta di un piccolo editore militante e di dreyfusardi socializzanti, Pages libres45. Al termine di un intervento volontariamente oggetti-vo sulla politica estera britannica nel corso del XIX secolo, l’autore trae conclusioni moderate ma critiche, tanto nei con-fronti dei detrattori pro-Boeri degli inglesi, quanto nei con-fronti dei sostenitori liberali. Contro i primi che demonizzano Albione, Halévy mette in luce i conflitti di interessi che divi-dono i partiti e le élites britanniche; la via non percorribile dell’imperialismo brutale per cui le difficoltà della guerra dei Boeri hanno mostrato i limiti e l’uguale impercorribilità del
44 Ibid. p. 302.45 La rivista «Pages libres» (3.000 abbonati nel 1906, con un pubblico di insegnan-ti e sindacalisti), è gestita da intellettuali dreyfusardi socialisteggianti; il fratello di Elie, Daniel, ne prefiggeva un’azione educativa. Pubblicava inoltre una colle-zione di opere di divulgazione centrate sulla storia e la politica estera (cfr. S. Lau-rent, Daniel Halévy. Du libéralisme au traditionalisme, Grasset, Paris 2001, pp. 150-51 e E. Halévy, Correspondance, De Fallois, Paris 1996, p. 306).
ultima.indd 298 26-10-2010 13:59:10
il difficile ingresso degli intellettuali europei 299
liberalismo anti-imperialista quale Hobson lo sottolineava nel-la sua celebre opera Imperialism, a study46. Egli nega il declino prossimo dell’Inghilterra e del suo impero già preannunciato dai suoi avversari, ma sottolinea l’identica vanità del complesso di superiorità che le tesi di Demolins pretendevano dimostra-re scientificamente o che Chevrillon giustificava intellettual-mente. Come gli altri, l’Impero britannico doveva adattarsi al nuovo corso internazionale e trattare con i suoi antichi e troppo numerosi avversari ciò che aveva portato l’anno prece-dente al ravvicinamento con la Francia. Elie Halévy propone anche una diagnosi sociale che contraddice le teorie di Demo-lins. L’espansione esterna, l’émigrazione oltre mare, il gusto delle conquiste, lungi dall’essere espressione della superiorità britannica rischiano, tanto quanto l’introversione francese, di aprire un’era di degenerazione per l’Inghilterra:
Gli Inglesi tentano con lo sviluppo del loro impero e, di conse-guenza, dell’imperialismo, di diventare una nazione composta non più d’industriali, commercianti ed operai ma di capitalisti ed amministratori, non più di uomini che lavorano ma di uomini che prelevano, per vivere, una parte del lavoro altrui. E non è, forse, proprio a causa di quest’ozio al quale l’esercizio stesso del comando li condanna che le razze superiori degenerano e, a lun-go andare, permettono un giorno alle razze inferiori di liberarsi dalla prolungata soggezione?47
Halévy riprende qui lo schema e persino la terminologia di Demolins, ma per invertirne le conclusioni, ispirandosi in parte alle tesi di Hobson. ma dopo questo passaggio nel quale sembra essere stato contaminato dall’ideologia dominante, si riprende rapidamente e termina con una conclusione netta-mente equidistante; secondo lui, né la superiorità del popolo inglese né la sua decadenza sono naturali o ineluttabili. Filo-sofo nutritosi sia col pensiero inglese e sia con quello tedesco, Halévy riveste i panni dello storico e ricusa gli schemi naturali-sti e darwiniani dei suoi predecessori: sono le lotte delle nazio-ni e la concorrenza degli imperi nonché le capacità di adatta-
46 Nisbet, Londra, 1902, 3a ed., Allen & Unwin, London 1938.47 E. Halévy, L’Angleterre et son empire cit., p. 122.
ultima.indd 299 26-10-2010 13:59:10
300 christophe charle
mento dei popoli, che decidono dell’avvenire dell’Inghilterra come di quello delle altre potenze. E termina con una profezia («il ventesimo secolo sarà il secolo degli imperi»48) sufficiente-mente vaga da riconciliare le tesi a confronto.
Quattro anni più tardi, un altro allievo della Scuola Nor-male Superiore, Paul mantoux, sottoscrive ancora più netta-mente quest’approccio sociale ed anticonformista rispetto alla vulgata liberale antecedente. Secondo lui, la nuova Inghilterra non incarna più né il miracolo della conservazione sostenuto da Taine, né il genio dell’adattamento sostenuto da Boutmy. Ancor meno, essa gli appare come frutto infallibile della se-lezione delle razze, come ipotizzato da Demolins. È dipinta, invece, come un laboratorio di riforme, un focolaio di con-flitti e di contraddizioni e, forse, più profondamente agitata della stessa Francia contemporanea. È in ogni caso l’esempio di tentativi multipli di adattamento, il modello – questa volta sì – del cambiamento di cui la Francia dovrebbe trarre esempi di progresso49.
Dedicati alla guerra dei Boeri e al gingoismo, i primi due capitoli vi vedono patologie analoghe al nazionalismo del caso Dreyfus e non quel patriottismo positivo elogiato da Chevril-lon nel brano sopraccitato. È una specie di “delirium tremens” basato sul disprezzo delle altre nazioni che troviamo in tutta Europa. Rinforzato da teorie razziali pseudo-scientifiche che «hanno dato una sembianza filosofica e moderna ai pregiudizi più primitivi, assurdi e feroci». Quasi sempre vincente e non soggetto al servizio militare, il popolo inglese coltiva un’im-magine positiva falsata della guerra, a differenza delle nazioni continentali che hanno sofferto collettivamente50.
Pertanto, mantoux trae, dal confronto dei diversi nazionali-smi analizzati, insegnamenti validi per gli altri paesi d’Europa:
48 Ibid., p. 123.49 Come scritto nella pref. da G. monod: «Gli Inglesi hanno un’imposta sul red-dito da un secolo senza aver mai creduto che era l’inizio della spoliazione dei capitalisti. Hanno tentato una serie di prove di socialismo municipale, di cui mantoux ci descrive il principale rea lizzato proprio a Londra, senza con ciò cre-dere che il collettivismo fosse alle porte» (A travers l’Angleterre contemporaine, Al-can, Paris 1909, p. IX).50 P. mantoux, A travers l’Angleterre contemporaine cit., pp. 21, 26, 32.
ultima.indd 300 26-10-2010 13:59:10
il difficile ingresso degli intellettuali europei 301
malgrado alcuni sintomi preoccupanti, l’Inghilterra del 1895 era sana. Ancora oggi51, essa è un grande corpo robusto ma divorato da una febbre pericolosa della quale non vuole guarire. Se queste riflessioni fossero valide solamente per l’Inghilterra, sarebbero già, comunque, un invito a diffidare di noi stessi. Purtroppo, pos-sono essere applicate ad altri Paesi e al nostro in primo luogo. I nostri vicini hanno una trave nell’occhio ma siamo sicuri di avere solamente una pagliuzza?52
Questa visione critica della politica estera è ampiamente controbilanciata dagli ultimi quattro capitoli, nei quali si elo-giano i tentativi di riforme sociali a livello municipale (il socia-lismo municipale di Londra del1890-1900), le riforme scolasti-che e la pressione operaia crescente; questa sfocia nell’emer-gere di una nuova forza in Parlamento, il partito laburista, che riesce a vincere la politica conservatrice o le leggi anti-operaie votate all’inizio del secolo. Facendo l’elogio del riformismo operaio e del nuovo liberalismo che rompe con il lassismo del XIX secolo, mantoux abbozza un contro-modello di democra-zia sociale che sogna come progetto del socialismo francese, allora in preda a profondi dissensi tra moderati e rivoluzionari, tra partito socialista e CGT. Questi ultimi capitoli denunciano anche gli stereotipi antecedenti:
L’individualismo britannico è stato ampiamente analizzato. Le persone che hanno pensato bene di inventare, a loro uso e consu-mo, un’Inghilterra teorica, ne hanno parlato molto appropriata-mente. Le Unions sono state spesso citate come uno dei migliori esempi della fiducia nel libero associazionismo e della ripugnan-za per l’intervento statale che contraddistinguono l’Anglosassone i dea le. Tuttavia, l’individualismo assoluto – che non è quello dei Trade-Unions – suppone, nel nostro Stato societario, alcune ga-ranzie di libertà, istituite dalla legge53.
51 Nel 1902 (nota di mantoux). 52 Ibid., p. 53. 53 Ibid., pp. 225-26.
ultima.indd 301 26-10-2010 13:59:10
302 christophe charle
3. Quale senso per la storia? guerre inevitabili o guerre impossibili?
Desiderio di guerra
La confutazione delle immagini positive dei popoli anglo-sassoni da parte degli intellettuali francesi simpatizzanti di si-nistra, si inserisce in un dibattito più ampio a livello europeo, che si sviluppa anche nel Novecento: quello del senso della storia “recente”. La visione social-darwiniana, imperialista o nazionalista che sia, che prende sempre più piede non sol-tanto in Inghilterra, ma anche in Germania e in Italia, come pure in Austria-Ungheria e in Russia nonostante gli sforzi del-la socialdemocrazia e degli intellettuali pacifisti, si radica in un nuovo fatalismo della guerra inevitabile e persino in una paradossale valorizzazione della guerra da parte di alcuni in-tellettuali. mentre la visione progressista del XIX secolo (vedi victor Hugo), prevedeva la fine delle guerre e gli Stati-Uniti d’Europa, un numero crescente d’intellettuali è preso da una frenesia guerriera, e non si tratta esclusivamente di intellet-tuali conservatori. Il manifesto del Futurismo, pubblicato da marinetti il 20 febbraio 1909 su «Le Figaro», fa l’apologia della guerra alla stregua della velocità e della macchina e la assimila dunque alla modernità e al futuro54. Lungi dall’essere origi-nali con la diffusione di queste idee, i futuristi sono sempli-ci echi di una moltitudine di scritti letterari e politici italiani pubblicati a partire dal 1900: quelli di Papini, D’Annunzio, Prezzolini, Corradini, morasso, ecc.55 Tutti si aspettano dalla guerra, la rinascita del Paese, impantanato in lotte politiche intestine e nell’impotenza dello Stato a costruire la nazione, e un freno alla spinta democratica e socialista, se non addirittura una specie di sacrificio rigeneratore che metterà termine alla decadenza italiana.
Questa visione utopistica di una guerra rigeneratrice che si sostituisce alle utopie del secolo precedente, non è esclusivo appannaggio degli intellettuali italiani nazionalisti, anche se la loro retorica è senza dubbi più aspra. E riescono ad adoperar-
54 Cfr. A. D’Orsi, I chierici alla guerra. La seduzione bellica sugli intellettuali da Adua a Baghdad, Bollati Boringhieri, Torino 2005, p. 18; F. Roche-Pézard, L’aventure futu-riste 1909-1916, Ecole Française de Rome, Roma 1983.55 A. D’Orsi, I chierici alla guerra cit., pp. 78-104.
ultima.indd 302 26-10-2010 13:59:10
il difficile ingresso degli intellettuali europei 303
si per mobilizzare l’opinione pubblica nel 1911, in occasione della presa di Tripoli, che provoca in loro una frenesia analo-ga a quella suscitata dodici anni prima dalla guerra dei Boeri nell’opinione pubblica inglese56. La vittoria del Giappone sulla Russia nel 1905 serve anch’essa come argomento per dimostra-re che un popolo entrato di recente a far parte della civilizza-zione moderna, può avere la meglio su una grande potenza, sempre che vi sia unità morale e senso del sacrificio.
Analoghe tematiche si ritrovano nel mondo intellettuale tedesco, dove si va diffondendo sia nella massa, tramite le le-ghe pangermaniche o militariste e la stampa, e sia nelle riviste minori d’avanguardia, una visione rigeneratrice di una guerra vista come liberazione da un mondo materialista e borghese. Questo spiega come certe frange dell’avanguardia espressio-nista, e persino alcuni settori di destra della socialdemocrazia, abbiano potuto condividere le stesse idee selezionatrici e raz-ziste (contro gli Slavi o i popoli latini decadenti), tacciando come guerra inevitabile e come legge di specie, quella del po-polo tedesco contro le razze imbastardite. La voga di Nietz sche nelle avanguardie, i cui testi danno credito a questa legge di lotta, e la diffusione ad alta tiratura di trattati d’orientamen-to più politico come quelli di Riezler (Die Erforderlichkeit des Unmöglichen)57, Bernhardi (Unsere Zukunft, 1912), Hasse (Die Zukunft des deutschen Volkstums, 1907) o ancora di Class (Wenn ich der Kaiser wär, 1912), ne sono altrettanti segnali58. Doveroso ricordare che la Lega pangermanica che appoggia queste tesi recluta abbondantemente nel Bildungsbürgertum e negli am-bienti intellettuali protestanti e urbani, vale a dire strati del cuore della modernità59.
Nemmeno i settori intellettuali maggiormente a contatto con il mondo internazionale, come gli universitari, sono esenti
56 G. Cianferotti, Giuristi e mondo accademico di fronte all’impresa di Tripoli, Giuffrè, milano 1984.57 münchen 1913.58 Su tutto questo, cfr. T. Lindemann, Les doctrines darwiniennes et la guerre de 1914, Economica, Paris 2001, p. 125; cfr. anche m. Korinmann, Quand l’Allemagne pen-sait le monde, Fayard, Paris 1990. 59 m. Korinmann, Deutschland über alles. Le pangermanisme 1890-1945, Fayard, Paris 1999 et R. Chickering, We men who feel most german. A cultural study of the Pan-German league 1886-1914, Allen & Unwin, London 1984.
ultima.indd 303 26-10-2010 13:59:10
304 christophe charle
da riflessi sciovinisti, come ho dimostrato nello studio sulla partecipazione ai vari congressi internazionali nei quali ogni gruppo nazionale vuole essere dominante, a meno che non si astenga dall’intervenire, quando il congresso si svolge sul terri-torio del principale “avversario”60.
Tutti questi piccoli conflitti, come pure queste guerre sim-boliche, alimentano un clima di ostilità e sospetto; motivo per il quale, nonostante l’internazionalizzazione della vita intel-lettuale, il disarmo intellettuale non è all’ordine del giorno della nuova modernità, come non lo è il disarmo tra le nazio-ni. La strumentalizzazione del premio Nobel ad opera delle correnti nazionaliste delle grandi potenze, mentre il suo fon-datore voleva metterlo al servizio del progresso e della pace, è un’ulteriore manifestazione di questo paradosso che precede il 191461.
Le lotte letterarie, le classificazioni estetiche, rimangono profondamente connotate anche dal lessico nazionale, persi-no nei gruppi che si dichiarano d’avanguardia, come rilevato da Blaise Wilfert e Béatrice Prunel-Joyeux nelle loro tesi. In un mondo intellettuale in cui la circolazione e la concorrenza au-mentano, la demarcazione delle identità e delle frontiere – sia-no pure immaginarie –, è un riflesso logico. Tutti i fenomeni di dominazione culturale sono rivisti con la lente della visione politica prevalente dell’imperialismo, della minaccia straniera contro l’identità nazionale, anche nelle nazioni europee prin-cipali: in Francia contro la scienza tedesca, in Germania contro l’arte moderna di origine francese acquistato dai collezionisti locali (spesso ebrei) a spese dei pittori tedeschi62, in Italia con-tro il teatro francese giudicato invadente sulle scene italiane, ecc…. Il clima di rivalità, più forte grazie all’incremento delle circolazioni e in particolar modo negli ambienti più inclini alla modernità, più che calmare, prepara un clima bellicista. Que-ste tensioni spiegano l’incapacità della maggior parte degli in-tellettuali a resistere alla retorica sui lati positivi della guerra e
60 C. Charle, La République des universitaires (1870-1940), Fayard, Paris 1994, pp. 384-93.61 E. Crawford, La fondation des prix Nobel scientifiques 1901-1915, Belin, Paris 1988, pp. 104-12.62 P. Paret, The Berlin secession: modernism and its enemies in imperial Germany, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1980.
ultima.indd 304 26-10-2010 13:59:10
il difficile ingresso degli intellettuali europei 305
ciò ben prima dell’avvio delle ostilità. In un mondo intellettua-le e artistico ogni giorno più concorrenziale, e con il trionfo dei meccanismi del mercato in letteratura come nella pittura o le arti sceniche, con le rivalità nazionali nei congressi e le com-petizioni scientifiche, la retorica della guerra passa facilmente dal registro simbolico a quello nazionale e politico.
Guerra impensabile
Eppure, proprio mentre si facevano questi discorsi, le guerre rea li di quegli anni avrebbero dovuto avvertire questi uomini supposti illuminati sul vero aspetto di una guerra generalizzata che alcuni incoscienti si auspicavano senza tema: la gravità delle perdite britanniche nonostante lo squilibrato rapporto di forza con i Boeri (richiamata nel testo citato sopra di Halévy), gli ef-fetti devastanti delle nuove armi e la durata dell’assedio di Port Arthur nella guerra russo-giapponese63, l’effetto domino e le ripercussioni incontrollabili delle guerre balcaniche, tutto ciò preannunciava gli arresti, le riprese e i massacri di una guerra allargata preparata dalle molteplici crisi precedenti il 1914.
Di fatto, nonostante le notizie pubblicate sulle nuove guer-re, gli esperti rafforzano le loro scelte aprioristiche anziché rimetterle in discussione Secondo loro, la guerra futura sarà innanzitutto una guerra per la quale il morale farà la diffe-renza tra eserciti ugualmente dotati materialmente. Questa conclusione rinvigorisce l’entusiasmo degli intellettuali che si vedono assegnare la missione essenziale di forgiare o tenere alto il morale della popolazione. Ecco perché pochi intellet-tuali hanno ignorato o solo intuito il dramma che si preparava. E quando lo hanno fatto, non sono stati capiti né ascoltati o ancora sono stati trattati da Cassandre, sognatori o peggio da traditori e vigliacchi. Tutto si svolge come se la sbornia retorica dominante della guerra vista come futuro positivo, impedisse ogni percezione, a partire dalle nuove real tà verificabili nei conflitti in corso, di quello che sarebbe successo su larga sca-la. L’opera più famosa sull’argomento, The Great illusion, del
63 Cfr., su questo, O. Cosson, Expériences de guerre et anticipation à la veille de la Pre-mière guerre mondiale. Les milieux militaires franco-britanniques et les conflits extérieurs, «Revue d’histoire moderne et contemporaine», 50-3, 2003, pp. 127-47.
ultima.indd 305 26-10-2010 13:59:10
306 christophe charle
pacifista inglese Norman Angell, è come la dimostrazione al contrario di questo accecamento volontario64. Per dissuadere i suoi contemporanei dal cedere alle sirene dell’ineluttabilità della guerra, Angell vuole dimostrare che questa è una grande illusione perché, nelle attuali condizioni delle società moder-ne, una guerra generale paralizzerebbe completamente tutti i belligeranti, vista l’internazionalizzazione della vita economi-ca, la fragilità delle società industriali sempre più interdipen-denti e l’impossibilità di fermare la vita economica contempo-ranea per via degli scambi commerciali. I suoi costi sarebbero stati incomparabilmente superiori ai supposti guadagni che porterebbe al vincitore, visto che i comportamenti di rapina coloniale non sono più possibili nell’Europa contemporanea. E questi argomenti, che possono sembrarci sensati, poggia-vano, nel suo trattato, sulle guerre anteriori e hanno trovato riscontro, da quello che sappiamo, nelle conseguenze della guerra del 1914 sulla vita economica e sociale. Essi hanno su-scitato più di trecento articoli di commento critico solamente in Inghilterra65.
Neppure tutto questo successo serve a convincere i bellicisti a tornare alla ragione, né ad aprire gli occhi all’opinione pub-blica più colta, né alla maggior parte degli intellettuali, sulla nuova real tà della guerra. La guerra è considerata inevitabile in considerazione della natura umana (o della “razza” superio-re) e della modernità (sia essa simbolica o manifestazione della potenza nazionale), dal momento in cui la nazione è diventata la religione dominante in Europa tra il 1860 e il 1890. Preten-dere di dimostrare che una nuova guerra e la modernità eco-nomica sono diventate incompatibili, è quindi inammissibile per i contemporanei del 1910. Persino gli intellettuali sociali-sti, che discutono a lungo e rifiutano la crescente pericolosità, sono divisi sull’avvenire e sulla strategia da adottare di fronte alla guerra. Sono stretti tra il loro internazionalismo di princi-pio e le condizioni specifiche assegnate alle strutture politiche
64 N. Angell, The great illusion: a study of the relation of military power in nations to their economic and social advantage, 3a ediz., Heinemann, London 1912. Con una tiratu-ra di oltre un milione di esemplari, l’opera è stata tradotta in 25 lingue (m. Cea-del, “Sir (Ralph) Norman Angell”, Oxford DNB versione internet).65 N. Angell, The great illusion cit., pp. 303-304.
ultima.indd 306 26-10-2010 13:59:10
il difficile ingresso degli intellettuali europei 307
nazionali nelle quali ogni partito della Seconda Internazionale deve affermare la propria esistenza in una situazione di rap-porti di forza molto disuguale. I socialisti in grado di opporsi alla guerra grazie alla loro organizzazione e al peso politico (in particolare, l’SPD tedesco), rischiano di essere considerati la “quinta colonna” degli Imperi nei quali il movimento socialista troppo debole non potrà arrestare la macchina militare; è la situazione squilibrata che oppone, ad esempio, la Germania e la Russia.
La celebre opera di Jaurès, L’Armée nouvelle (1910), che vuo-le rispondere alla deriva militarista e bellicista che attraversa la Francia con il progetto di allungamento del servizio militare fino a tre anni in risposta alla pressione tedesca, offre analisi premonitrici66. Nuocciono tuttavia alla causa di Jaurès due suoi preconcetti:– la sua proposta di un esercito di cittadini alla Svizzera allo
scopo di liberare la nazione dal militarismo da caserma, imitato secondo lui dalla Prussia – ma che non ha senso in una visione repubblicana e democratica dell’esercito – è poco convincente con l’avvento della guerra industriale;
– il suo ottimismo sulla capacità di bloccare la spirale ascen-dente di pericoli con un’opzione nazionale isolata in un’Europa affollata di monarchie e Imperi, appare trop-po volontaristico: impossibile sperare che gli altri seguano l’esempio, anche se fosse messo in pratica, a meno che non si creda ad una rivoluzione politica europea prossima come prolungamento degli eventi russi del 1905.
Conclusioni
Questo quadro incompleto della modernità vista o vissuta dagli intellettuali europei prima del 1914 è, come il decennio, contraddittorio. Non “bello”, come i sopravvissuti al massacro lo hanno falsamente qualificato, ma confuso ed incerto: in rot-tura con la rappresentazione della real tà come la sua pittura moderna, in rottura con l’armonia come la sua musica d’avan-
66 J. Jaurès, L’Armée nouvelle, nuova ediz. Presentata da J. N. Jeanneney, Imprimerie nationale, Paris 1992; cfr. anche il mio studio più dettagliato: La question de l’État de Jaurès à Léon Blum, atti del colloquio Jaurès e lo Stato, in Jean Jaurès cahiers trimes-triels, n. 150, luglio-ottobre 1998, pp. 44-57.
ultima.indd 307 26-10-2010 13:59:10
308 christophe charle
guardia, scuotendo le certezze del senso comune come la fisica di Einstein, la filosofia di Bergson67 o la psicanalisi di Freud, mobile e aperto sul mondo come i suoi studenti ed artisti ma anche in preda a crisi di xenofobia e nazionalismo, freddoloso e aggressivo come i suoi giornalisti, artisti e scrittori più famosi. La maggior parte degli innovatori sono stati accolti o percepiti male dai loro contemporanei, niente di diverso insomma dalla prima modernità. Alcuni intravedono la fine dei vecchi para-digmi progressista e liberale, le crepe di una socialdemocrazia travagliata dal revisionismo e contestata alla sinistra radicale. Se da un lato, l’Europa si apre come mai agli scambi culturali e scientifici, le sue grandi potenze preparano contemporanea-mente le condizioni dell’apocalisse chiudendosi in una visione falsamente determinista della guerra e della potenza imperia-le. ma, come abbiamo visto, la maggioranza degli intellettuali sono conquistati da questa visione. Nessun altro discorso intel-lettuale, al di fuori di quello dominante della modernità della guerra e dei suoi aspetti potenzialmente positivi per uscire dal-le difficoltà delle diverse nazioni, viene, di fatto, recepito; que-sto faciliterà, a crisi dichiarata, l’accettazione più o meno ras-segnata – anche da parte degli oppositori di un tempo – della mobilizzazione generale dell’estate 191468.
67 La fama internazionale di Bergson appare nel corso del congresso internazio-nale di filosofia di Bologna nel 1911 dove presenta la sua comunicazione sull’in-tuizione filosofica (E. Souriau, 1913. La conjoncture, in L. Brion-Guerry, L’Année 1913 cit., p. 22).68 Pochissimi dei membri delle avanguardie, nonostante fossero stati respinti dalla società pre-bellica, hanno rifiutato il loro concorso alla mobilizzazione; tra i pochi: Einstein, Picasso, Romain Rolland.
ultima.indd 308 26-10-2010 13:59:10





























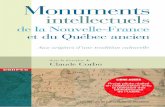








![[tapuscrit original] Femme et langue. Sexe et langage (1982)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6336af56e8daaa60da100428/tapuscrit-original-femme-et-langue-sexe-et-langage-1982.jpg)










