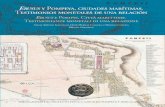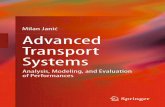Impianti di Panificazione a Pompei - Thomas Milan
Transcript of Impianti di Panificazione a Pompei - Thomas Milan
~ 1 ~
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
CORSO DI LAUREA IN
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
TESI DI LAUREA
IMPIANTI DI PANIFICAZIONE A POMPEI
RELATRICE:
PROF.SSA ANNAPAOLA ZACCARIA
LAUREANDO:
THOMAS MILAN
MATR. N.810554
ANNO ACCADEMICO 2008/2009
~ 2 ~
INDICE
Introduzione.........................................................................................p. 4
1. Aspetti generali della panificazione..........................................p. 5
1.1 Varietà del pane romano............................................................p. 8
2. Nascita dell'industria della panificazione................................p. 9
3. Fasi della panificazione e caratteristiche
e strutture dei pistrina......................................................................p. 10
3.1 Le macine.................................................................................p. 11
3.2 Le macchine impastatrici........................................................p. 12
3.3 I forni e gli ambienti associati................................................p. 12
4. Catalogo........................................................................................p. 15
4.1 Premessa...................................................................................p. 15
I,3,1.............................................................................................p. 16
I,3,27...........................................................................................p. 18
I,4,12-17 e I,4,13-14....................................................................p. 20
I,12,1-2........................................................................................p. 22
V,1,14-16.....................................................................................p. 25
V,3,8............................................................................................p. 27
V,4,1-2.........................................................................................p. 29
VI,2,6...........................................................................................p. 31
VI,3,1-4.27-28.............................................................................p. 33
VI,5,15.........................................................................................p. 36
VI,6,4-5.......................................................................................p. 38
VI,6,17-21...................................................................................p. 40
VI,11,8-10...................................................................................p. 42
VI,14,29-33.................................................................................p. 44
VI,14,34.......................................................................................p. 46
~ 3 ~
VII,1,36-37..................................................................................p. 48
VII,1,46-47..................................................................................p. 50
VII,2,3.........................................................................................p. 52
VII,2,22.......................................................................................p. 55
VII,12,1-2.37...............................................................................p. 57
VII,12,7.......................................................................................p. 59
VII,12,11.....................................................................................p. 60
VII,12,13.....................................................................................p. 62
VII,14,9.......................................................................................p. 64
VII,16,6.9....................................................................................p. 65
VIII,4,26-29.................................................................................p. 66
VIII,6,1.8-10................................................................................p. 68
IX,1,3.33......................................................................................p. 70
IX,3,10-12...................................................................................p. 73
IX,3,19-20...................................................................................p. 75
IX,5,4...........................................................................................p. 77
IX,12,6-8.....................................................................................p. 79
5. Considerazioni di carattere generale..................................p. 82
5.1 Pistrina e pistrina dulciaria...................................................p. 82
5.1.1 Macine..............................................................................p. 82
5.1.2 Botteghe o punti di vendita.........................................p. 83
5.1.3 Forni.................................................................................p. 84
5.1.4 Laboratori.......................................................................p. 84
5.1.5 Depositi e magazzini.....................................................p. 85
5.2 Distribuzione nel quadro urbano............................................p. 85
5.3 Sviluppo cronologico..............................................................p. 87
Bibliografia.........................................................................................p. 88
Apparato iconografico.....................................................................p. 90
~ 4 ~
Introduzione
Questo ricerca è stata effettuata al fine di produrre un catalogo specifico e aggiornato dei panifici
di Pompei, a seguito del quale fosse possibile poi affrontare le problematiche economiche,
tecniche e sociali relative al processo di panificazione e alla sua presenza e diffusione nel quadro
urbano e in un arco cronologico.
Il primo capitolo contiene informazioni riguardanti gli aspetti generali del processo di
panificazione e il suo sviluppo nella civiltà romana, con particolare attenzione ad alcuni dei
principali tipi di pane di cui troviamo riferimenti nelle fonti latine. Nel capitolo successivo viene
analizzato il processo attraverso il quale la produzione del pane inizia a configurarsi non più come
una produzione di tipo domestico, ma come un'attività industriale, con la nascita e la diffusione dei
primi impianti per la panificazione.
Notizie e descrizioni delle varie fasi del processo di panificazione e delle principali strutture che
caratterizzano i pistrina, sono presenti nel capitolo 3, con paragrafi riguardanti in modo specifico
le macine, le macchine impastatrici e i forni.
Il capitolo 4 comprende il Catalogo dei pistrina pompeiani; composto di 32 schede, una per
impianto, esso si configura come la parte centrale della tesi, in cui vengono descritti caso per caso
gli impianti per la panificazione a tutt'oggi identificabili nella città.
Nell'ultimo capitolo vengono elaborati i dati forniti dalla schedatura dei pistrina, evidenziando le
principali differenze tra pistrina e pistrina dulciaria con particolare attenzione verso la
disposizione delle strutture quali macine, botteghe, forni, laboratori, magazzini all'interno dei vari
impianti. Vengono infine effettuate delle considerazioni relative alla distribuzione dei pistrina nel
quadro urbano e allo sviluppo di questa distribuzione in una arco cronologico.
Metodo di lavoro
Nello studio dei pistrina pompeiani, una preliminare ricerca bibliografica mi ha consentito di
accertare l'esatta ubicazione dei panifici nella città; la più recente monografia dedicata
all'argomento è il volume di B.J. Mayeske1, contenente una prima catalogazione con dati sui
singoli pistrina e sulla situazione della panificazione nella città. Le informazioni sono state
confrontate e integrate con lo studio di La Torre2
e l'Indirizzario di Pompei3 presenti nel volume
Pompei. L'informatica al servizio di una città antica, dove tuttavia i dati si limitano ad un elenco
1 MAYESKE 1972
2 LA TORRE 1988, pp. 75-102
3 Pompei Informatica , pp. 103-184
~ 5 ~
di complessi classificati come pistrina.
Infine, confrontando i dati ricavati con le ricerche di L. Eschebach4 è stato possibile ottenere un
quadro generale della distribuzione degli impianti nel quadro urbano, completato con le
informazioni fornite dalle schede degli edifici e dalle piante contenute nei volumi della serie
Pompei. Pitture e Mosaici5. Ho proceduto quindi alla schedatura dei vari pistrina, descrivendo le
strutture di ogni impianto, fornendo datazioni (ove presenti informazioni a riguardo) e definendo
una tipologia di vendita. Successivamente, elaborando i dati ottenuti dalla schedatura, ho riportato
gli aspetti generali in un quadro più specifico e urbano, effettuando considerazioni relative le
caratteristiche distintive tra panifici e pistrina dulciaria, la distribuzione degli impianti nel
territorio e il loro sviluppo cronologico.
Per quanto riguarda gli studi sul processo di panificazione e la diffusione di questa nel mondo
romano, mi sono avvalso delle pubblicazioni di Dosi e Schnell6 e del volume curato da Longo e
Scarpi7, contenenti la descrizione di alcuni dei tipi più comuni di pane e dolci. Per le varie fasi
della panificazione e per le strutture caratteristiche dei panifici, con riferimenti particolari al caso
di Pompei, ci si è basati sulle informazioni fornite da R. Etienne nel suo La vie quotidienne a
Pompéi8, che dà precise descrizioni delle macine, delle macchine impastatrici e dei forni dei
panettieri. Ad integrazione di questi aspetti sono stati utilizzati anche il volume di August Mau9, in
cui si fa riferimento ai fornai di Pompei, e l'articolo dedicato alle macine di Buffone, Lorenzoni,
Pallara e Zanettin nel X numero della Rivista di Studi Pompeiani10
.
1. Aspetti generali della panificazione
Il pane è il risultato della domesticazione e della coltivazione del grano ed è stato uno dei maggiori
sostegni energetici delle popolazioni del pianeta, evolvendosi in maniera parallela allo sviluppo
delle civiltà.11
Le prime graminacee conosciute dall'uomo, in età Neolitica, sono state l'orzo e il
miglio e quasi certamente è dall'orzo che è stato ottenuto il primo tipo di “pane”, anche se questa
pianta ha il grosso limite di non poter lievitare perchè troppo povera di glutine. I più antichi tipi di
pane erano quasi sicuramente azimi, cioè non lievitati ed è verosimile che il processo di
4 ESCHEBACH 1993
5 PPM, I-X
6 DOSI-SCHNELL 1986
7 LONGO-SCARPI 1993
8 ETIENNE 1966
9 MAU 1982
10 BUFFONE 1999, pp. 117-130
11 CERLETTI 1993, p. 123
~ 6 ~
lievitazione naturale o fermentazione sia stato scoperto casualmente lasciando l'impasto di acqua e
farina in ambiente privo di luce.12
Nell'antichità il pane era un alimento di base, presente in varie forme e composizioni e destinato
alle diverse classi sociali, benché nei primissimi tempi fosse riservato unicamente ai privilegiati.
Ecateo di Mileto nel 500 a.C. chiama gli Egiziani “popolo mangiatore di pane”, ma sappiamo
sappiamo che questo alimento era già conosciuto e diffuso anche nel II millennio a.C., in cui,
secondo il linguaggio omerico, “mangiatori di pane “13
era sinonimo di “uomini”, portatori di
civiltà14
. Anche per i Greci il pane era quindi un alimento di base della dieta quotidiana e
sembrerebbero essere addirittura settanta i tipi di pane che erano capaci di produrre, tra cui la
maza di orzo impastato (una focaccia molto diffusa di cui parla anche il poeta Archiloco15
), e il
pane a pagnotte di frumento che secondo le prescrizioni di Solone doveva essere consumato solo
nei giorni di festa16
.
Uguale se non maggiore importanza ebbe il pane nella civiltà romana, dove costituiva la base
dell'alimentazione soprattutto per le classi meno abbienti come dimostrato dall'espressione
popolare panem et circenses17
, in cui venivano riassunte le aspirazioni della plebe romana più
povera, vivente per lo più della carità pubblica.
Come conferma Plinio il Vecchio18
, per molti secoli i romani vissero di polta, una densa zuppa di
cereali in cui si metteva di tutto, dai grani di cereali selvatici, alle leguminose e perfino pezzi di
carne, se disponibili, ed è probabile che la prima focaccia sia stata un fondo di polta essiccata e
arrostita. Il nome di questa focaccia, detta far, all'origine designava soltanto il primo frumento
adoperato per fare il pane, cioè la varietà detta oggi farro o spelta, ma finì poi per indicare non
solo il grano in generale ma anche la farina da esso ricavata19
, la polta, la focaccia (farreatio o
confarreatio) usata nelle cerimonie sacre come libagioni e matrimoni20
. Con il termine far si
definiva persino il pastone per ingrassare il pollame o lo stesso ripieno usato per guarnire i piatti di
carne21
.
Il farro, che per oltre tre secoli ebbe una notevole importanza nella storia economica romana22
, era
caratterizzato da grani piccoli e duri, molto difficili da liberare dalla pula, per cui era
12 BOSELLO 1993, pp. 175-176
13 HOMER. Od. 6.8
14 MONTANARI 1993, p. 27
15 ARCHIL. 2 West.
16 Citato da DOSI-SCHNELL 1986, pp. 49 e 52
17 JUV. 10.81 “nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se continet atque duas tantum res anxius
optat, panem et circenses.”
18 PLIN. Nat. 18.83 “Pultem autem, non pane, vixisse longo tempore Romanos manifestum”
19 PLIN. Nat. 18.88 “Farinam a farre dictam nomine ipso apparet”
20 PLIN. Nat. 18.10 “Quin et in sacris nihil religiosius confarreationis vinculo erat, novaeque nuptae farreum
praeferebant”
21 DOSI-SCHNELL 1986, p. 52
22 PLIN. Nat. 18.62 “Populum Romanum farre tantum e frumentum CCC annis usum Verrius tradit.”
~ 7 ~
indispensabile, per conservarli ed evitare la fermentazione, un'operazione di tostatura, a seguito
della quale venivano triturati in un mortaio per produrre la farina; proprio da questa attività di
molitura, i servi che la eseguivano venivano detti pistores, da pinsere far, termine che poi andò a
indicare il mestiere del panettiere e del pasticcere23
.
Considerato di scarsa qualità e generalmente diffuso solo tra schiavi e soldati era il bollito d'orzo,
mentre molto più era la focaccia d'orzo impastato, affine alla maza del mondo greco, che i romani
spesso farcivano con formaggio, olive, uova, funghi o altro. Con l'orzo veniva preparata anche un
tipo di polenta, diffusa probabilmente solo nella Gallia Cisalpina, come si evince da una citazione
di Plinio il Vecchio24
.
La qualità della polta e delle focacce migliorò sensibilmente con l'introduzione verso la fine del V
sec. a.C. di grani di qualità superiore provenienti dalla Sicilia e dall'Africa, più facilmente
separabili dalla pula tramite trebbiatura, che permisero di incrementare la produzione e rendere i
pani e le focacce più morbide e meno acide. A migliorare la qualità del pane contribuì lo sviluppo
tecnologico che introdusse la mola, seguita successivamente dal mulino a braccia e infine da
quello azionato da un asino o da un cavallo,come attestato dalla documentazione archeologica
pompeiana (vedi per es. gli scheletri di equidi ritrovati del pistrinum di Giulio Polibio in IX, 12, 6-
8), che producevano migliori qualità di farina e semola anche grazie a perfezionamenti nella
tecnica della setacciatura.
Caratteristica principale del pane romano era la durezza, dovuta soprattutto all'utilizzo di farine di
scarsa qualità che assorbivano meno acqua e alla insufficiente quantità di lievito (prodotto
lasciando fermentare un po' di pasta nel mosto d'uva), per altro scadente, che inacidiva per
impossibilità di conservarlo. Solo con la conquista della Grecia nel II sec. a.C., venne introdotta a
Roma la tecnica della fermentazione, che fino a quel momento era pressoché sconosciuta25
.
É noto infatti che Catone il Vecchio, di stampo conservatore, non approvò mai l'introduzione a
Roma del pane propriamente detto, considerandolo un fattore di decadenza dei costumi e
predicando un ritorno agli antichi costumi e quindi alla polta e alla focaccia. Nel De Agri Coltura
infatti, tutte le ricette per la fabbricazione del pane che tramanda, riguardano focacce prive di
lievito26
La mancanza di lievito era in alcuni tipi di pane obbligatoria, ad esempio per quelli destinati ai riti
e alle offerte; al flamine era addirittura vietato di toccare del pane lievitato27
.
23 DOSI-SCHNELL 1986, p.52
24 PLIN. Nat. 18.84 e 72
25 BOSELLO 1993, p. 177
26 CATO. Agr. 74-87
27 GEL. 10.15.19 “Farinam fermento inbutam adtingere ei fas non est”
~ 8 ~
1.1 Varietà del pane romano
Molte erano le varietà di pane prodotte nel mondo romano28
, soprattutto in età imperiale, quando
le tecniche di panificazione raggiunsero un elevato grado di produttività; alcuni tipi di pane, come
il pane del Picenum, erano ancora più duri del normale a causa della presenza nell'impasto di
aggiunte di argilla proveniente da una zona tra Napoli e Pozzuoli, consumate intinte nel vino
oppure in minestre e salse.
Prodotto con una farina superiore, detta siliga o simila, era il pane siligineus29
, mentre a seconda
della tecnica di setacciatura della farina, si poteva ottenere il panis cibarius30
, secundarius31
,
plebeius32
.
Simile a gallette o biscotti, di lunga conservazione, era il panis militaris33
, destinato ai soldati in
guerra, il panis buccelatus e il panis nauticus34
, destinato invece ai marinai; il panis autopyrus35
era una specie di pane integrale, mentre il panis furfureus36
veniva dato ai cani.
Più morbido, ma meno diffuso era il panis parthicus o aquaticus37
, caratterizzato da un maggior
assorbimento d'acqua.
Di lusso era il pane artolaganus38
, preparato con miele, vino, latte, olio, frutti canditi e pepe,
mentre pani speciali, confezionati con simili ingredienti e dotati quindi di un elevato apporto
calorico, venivano consumati durante i digiuni rituali39
.
Nelle aree più povere, soprattutto nelle campagne, erano invece diffuse specie rustiche di pane
mescolato a cereali di bassa qualità o a fave e lenticchie, oppure frutti come ghiande e castagne.
A causa della scarsa capacità di conservazione del lievito, i pani assumevano spesso un odore
acido che veniva eliminato al momento della cottura ripassando la crosta con rosso d'uovo o
spezie come semi di papavero40
.
Diverse erano le tecniche di cottura del pane, a seconda delle quali si poteva ottenere il panis
28 DOSI-SCHNELL 1986, p. 54
29 CAEL.AUR. Acut. 2.110
30 PLIN. Nat. 18.87
31 PLIN. Nat. 18.90
32 SEN. Ep. 119.3
33 PLIN. Nat. 18.67
34 PLIN. Nat. 22.138
35 PLIN. Nat. 22.138
36 PHAED. 4.18.84
37 PLIN. Nat. 18.105 “..non pridem etiam e Parthis invecto quem aquaticum vocant, quoniam aqua trahitur ad
tenuem et spongiosam inanitatem, alii Parthicum.”
38 PLIN. Nat. 18.105
39 DOSI-SCHNELL 1986, p. 55
40 DOSI-SCHNELL 1986, p. 55
~ 9 ~
furnaceus41
, cotto in forno e il panis artopticus42
, cotto sotto una campana domestica; più simili a
una galletta o focaccia erano invece il panis subcinericus o focacius43
, cotto sotto la cenere, e il
panis clibanicius44
, cotto in teglie di terracotta o metallo45
.
La forma principale in cui veniva prodotto e cotto il pane erano pagnotte rotonde, leggermente
schiacciate, con quattro o otto incisioni a croce sul dorso che permettevano di spezzare più
facilmente il pane in spicchi (vedi fig. 1) 46
; la pagnotta con quattro incisioni era detta panis
quadratus, e ogni spicchio era chiamato quadra47
. Molto diffuso era anche il pane a forma
allungata, ma molteplici erano gli stampi con cui il pane poteva essere prodotto, come si apprende
da Marziale, che, in uno dei suoi epigrammi, rimprovera l'amico Lupo di viziare la propria amante
con pani dalle forme oscene48
.
2. Nascita dell'industria della panificazione
La produzione del pane rimase per molto tempo relegata nell'ambito domestico, ma con l'evolversi
delle tecniche di fabbricazione, della qualità della farina e soprattutto della domanda del prodotto,
l'attività di panetteria prima svolta dalle massaie, passò nelle mani di cuochi e artigiani
specializzati. Nelle grandi dimore la produzione del pane continuò in alcuni casi a svolgersi in
ambito domestico,era anzi segno di grande prestigio per le famiglie benestanti avere al proprio
servizio dei pistores privati, mentre nelle città iniziarono a sorgere panifici e panetterie forniti
anche di attrezzature per la macinazione del grano e di grandi forni dotati di un livello produttivo
molto elevato, capace di rispondere alla crescente richiesta di prodotto.
L'installazione di questi primi impianti di panificazione viene collocata nei primi decenni del II
sec. a.C., come risulta da una notizia di Plinio49
che farebbe risalire al 171 a.C., anno d'inizio della
guerra contro Perseo, la nascita dell'industria della panetteria. La professione, inizialmente poco
considerata e svolta soprattutto da liberti o cittadini di umile condizioni (spesso Greci immigrati),
ottenne successivamente privilegi ed immunità, con la costituzione del collegium pistorum. I
panettieri o pistores potevano ottenere un aiuto statale nell'acquisto delle strutture o manodopera
41 PLIN. Nat. 18.88
42 PLIN. Nat. 18.105
43 ISID. Orig. 20.2.15
44 PLIN. Nat. 18.105
45 SEN. Ep. 90.22, in cui parla della tesi del filosofo Posidonio, secondo il quale la nascita della panificazione
sarebbe da attribuire ad un filoso, il Saggio, che avrebbe inventato il pane imitando il processo naturale attraverso
cui il grano viene digerito e assimilato dal corpo umano.
46 CANTARELLA-JACOBELLI 2003, p. 35
47 HOR. Ep. 2.1.123
48 MART. 9.2.3 “Illa siligineis pinguescit adultera cunnis, conuiuam pascit nigra farina tuum;”
49 PLIN. Nat. 18.107-108 “Pistores Romae non fuere ad Persicum usque bellum annis ab urbe condita super
DLXXX.”
~ 10 ~
necessarie (schiavi, asini, attrezzature) e ottenere addirittura la cittadinanza romana se lavoravano
per tre anni almeno 100 moggi di frumento al giorno, cioè circa 8 ettolitri, corrispondenti a oltre
600 kg secondo il peso del grano siciliano ed alessandrino50
.
Lo sviluppo di questa professione andò di pari passo con la grande trasformazione urbana di Roma
in età repubblicana, con la costruzione di strutture portuali e magazzini per la conservazione in
grandi quantità delle derrate alimentari, soprattutto cereali. In età imperiale la produzione del pane
si incrementò ulteriormente, grazie al miglioramento delle tecniche di macinazione (l'introduzione
del mulino ad acqua per es.), ma soprattutto grazie ad un aumento costante della richiesta di
prodotto.
Nei rapporti con lo Stato era inserita anche la possibilità di stipulare accordi per fornire la città di
pane pubblico, detto panis gradilis, di qualità tuttavia non buona poiché prodotto in parte con
farine avariate. Veniva prodotto inoltre il panis fiscalis, distribuito alle classi povere a prezzo fisso.
In concomitanza con la nascita della professione di fornaio, si diffuse nel mondo romano anche
l'attività dei pistores dulciarii, i fornai pasticceri, specializzati nella produzioni dei dolci.
I dolci erano di vario tipo:creme, focacce, pultes prodotte con vari ingredienti.
Molto diffuse e apprezzate erano le liba51
,focacce rituali prodotte dai pistores libarii, specie di
pani preparati con formaggio, farina di grano, uovo, cotti lentamente sotto a una tegola con delle
foglie d'alloro. Usata soprattutto in riti sacrificali era la placenta52
, fatta con farina, avena,
formaggio e miele.
3. Fasi della panificazione e caratteristiche e strutture dei pistrina
A Roma gli impianti legati all'attività della panificazione erano identificabili da una serie di
particolari strutture e spazi presenti generalmente in tutti i pistrina; i panifici pompeiani non erano
diversi dagli impianti della capitale e condividevano dunque le medesime caratteristiche, pur con
le ovvie differenze riscontrabili nei singoli edifici.
Elemento principale che consente l'identificazione di un pistrinum in un edificio è la presenza di
un grande forno e in molti casi, anche se non sempre, di macine per la molitura del grano. Con la
nascita dell'industria della panificazione infatti, l'attività del panettiere andò a comprendere non
solo la produzione degli impasti e la loro cottura, ma anche la produzione propria della farina
attraverso l'utilizzo di macine.
In ogni panificio sono solitamente identificabili un reparto per la riduzione del grano a farina, una
50 AMPOLO 1993, p. 242
51 CATO. Agr. 75
52 CATO. Agr. 76
~ 11 ~
zona per la produzione dell'impasto e la sua lievitazione,a volte fornita di macchina impastatrice,
un'area con uno o più forni per la cottura dei pani e in molti casi un punto d'esposizione o bottega
per la vendita al dettaglio. A questi spazi si aggiungono frequentemente lo stabulum, un'area per il
ricovero degli animali che azionano le macine e aree di deposito o magazzini. Alcuni pistrina sono
inoltre forniti di quartieri abitativi o impiantati in abitazioni parzialmente convertite in stabilimenti
di produzione.
3.1 Le macine
Non sono stati rinvenuti mulini ad acqua nell'area pompeiana, dove le macine si presentano, con
piccole variazioni, tutte dello stesso tipo, attivate da schiavi o ad azione animale.
Le macine pompeiane ricavate da roccia lavica, più specificamente trachiandasite basaltica, e
prodotte parte nella zona di Orvieto, parte nella cava di Castello di Cisterna e probabilmente anche
in altri affioramenti dell'area vesuviana, come quello dell'Anfiteatro di Pompei53
, erano costituite
di più elementi (vedi fig. 2) 54
: una parte fissa, campaniforme, detta meta55
, inserita in uno zoccolo
in muratura, sul quale veniva posizionato un catino di metallo per la raccolta della farina; una
scanalatura profonda56
alcuni centimetri veniva scavata in cima alla meta, per permettere
l'alloggiamento di un asse lignea, su cui veniva fissato un perno in ferro, attorno al quale avveniva
la rotazione della macina. Per quanto riguarda le dimensioni, le metae pompeiane solitamente
misuravano in media sessanta centimetri in altezza e circa ottanta centimetri di diametro nel punto
più largo57
.
L'elemento mobile, detto catillus,più fragile della meta e meno conservatosi, era a forma di doppio
tronco di cono, con la parte superiore utilizzata come imbuto per versare il grano nella macina e la
parte inferiore per la macinazione vera e propria. Le dimensioni del catillus consistevano
mediamente in circa settantatre centimetri di diametro nel punto più largo e trentasei nel punto più
stretto, con un'altezza pari anch'essa a circa settantatre centimetri58
. Un sistema di assi lignee
veniva fissato attraverso delle cavità a entrambi i lati del catillus e inserito nel perno fissato alla
meta; per evitare che l'attrito tra meta e catillus fosse troppo elevato,e di conseguenza aumentasse
ancor di più lo sforzo fisico necessario alla rotazione, quest'ultimo veniva mantenuto leggermente
53 BUFFONE 1999, p.121
54 AVVISATI 2007, p. 176
55 ETIENNE 1966, p. 156
56 MAU 1982, p.389
57 MORITZ 1958, p. 75. Dimensioni medie di una macina “normale” pompeiana, in questo caso Moritz prende come
esempio una delle macine presenti in VI,2,6.
58 Vedi nota 57.
~ 12 ~
sollevato dalla meta. La rotazione era infine impressa da schiavi (nelle macine di dimensioni
minori e caratterizzate da una minore produttività) oppure da asini o cavalli collegati al sistema di
travi nel tipo di macina più frequente a Pompei e indicata anche col nome di mola asinaria.
La scelta della roccia lavica per la costruzione delle macine era legata alla durezza e alla porosità
di questo tipo di roccia che riduceva al minimo la possibilità di contaminare la farina con
particelle litiche, per questo di roccia basaltica veniva ricoperta anche l'area attorno alle macine,
con lastre simili a quelle delle strade, per evitare che il continuo passaggio degli asini o cavalli
potesse creare solchi o avvallamenti nella pavimentazione.
3.2 Le macchine impastatrici
Una volta macinato il grano e ottenuta la farina,a quest'ultima venivano aggiunti acqua, lievito e
sale; il tutto veniva poi mescolato per ottenere l'impasto necessario alla produzione dei pani e per
questa operazione veniva spesso utilizzata una macchina impastatrice.
Costituita anch'essa di materiale lavico, consisteva in un bacile sul cui fondo era inserita in una
scanalatura e fissata ad un perno in ferro un'asse lignea verticale, alla quale erano poi aggiunti due
o tre bracci di legno orizzontali (vedi fig. 3)59
. Altri due denti lignei venivano inseriti
orizzontalmente nelle pareti del bacile, disposti in modo da non interferire con la rotazione dei
denti attaccati all'asse verticale. Dopo aver versato nel macchinario la farina e gli altri elementi per
produrre la pasta, a braccia o con l'aiuto di un asino o un cavallo, l'asse centrale veniva fatta
ruotare fino a che l'impasto non era pronto60
; esso veniva poi diviso in pagnotte di varie forme e
dimensioni ( a Pompei tuttavia era frequente la pagnotta rotonda a spicchi) e lasciato in un
ambiente caldo e umido a lievitare (per questo spesso l'impasto veniva fatto lievitare in un locale
adiacente al forno in cui si provvedeva alla creazione di un clima caldo-umido attraverso
un'apertura comunicante con la camera di cottura).
3.3 I forni e gli ambienti associati
Completata la lievitazione delle pagnotte, esse venivano poi cotte nel forno.
I forni più semplici erano composti unicamente da una camera di cottura con soffitto a volta, la cui
calotta era visibile dall'esterno (per questo erano detti forni “ad alveare”) e veniva talvolta
59 ETIENNE 1966, pp. 157-158
60 MAU 1982, p. 392
~ 13 ~
ricoperta di un sottile strato di sabbia per mantener meglio il calore.
La temperatura necessaria alla cottura del pane si otteneva bruciando legname o carbone;
successivamente si provvedeva a rimuovere dalla camera di cottura le braci e i pezzi di legno
rimasti e si puliva il piano di infornata con una scopa fornita di uno straccio bagnato per eliminare
la fuliggine. A questo punto si infornavano le pagnotte con pale in legno o ferro (rutabula) e poi si
chiudeva la bocca del forno con uno sportello in ferro provvisto di impugnature. Un camino,posto
davanti o dietro alla struttura ad alveare, permetteva la fuoriuscita del fumo e la circolazione del
calore.
A Pompei era tuttavia più diffuso un tipo di forno più complesso e di dimensioni maggiori61
(vedi
fig. 4 ). Il piano di cottura (a) era composto di mattoni ben uniti e cementati a calce, sotto ai quali,
per evitare perdite di calore, si disponeva un letto si sabbia spesso più di 10 cm, il tutto posato su
di un basamento in muratura (b).
La camera di cottura era sormontata da una volta (c), poggiante su di un piccolo muro (d), ed era
accessibile tramite la bocca (e). Al di sopra della camera di cottura, un vano (j), detto camera o
vano per il fumo, anch'esso a volta e connesso tramite delle aperture (k ed h) al camino (i), era
utilizzato per aumentare la tenuta termica del forno tramite una migliore circolazione del fumo. In
(h) era l'apertura principale del forno, attraverso la quale venivano passati i pani all'interni della
camera di cottura.
Questi forni di grandi dimensioni erano frequentemente forniti di aperture laterali nella camera di
cottura, con piani d'appoggio62
che connettevano queste ultime ad altrettante aperture presenti nei
muri dei locali adiacenti al forno, in cui solitamente erano situati il laboratorio per la preparazione
dei pani e il deposito dei pani cotti; in questo modo il furnacator, l'addetto alla cottura dei pani,
poteva ricevere da un lato le pagnotte crude dalla stanza dell'impasto, cuocerle, rimuoverle, e
riporle dall'altro lato nel deposito senza mai spostarsi dalla sua postazione di fronte al forno.
A livello del pavimento era spesso presente una cavità (l), utilizzata come deposito per le ceneri o,
se di grandi dimensioni, più probabilmente come ripostiglio per il combustibile. Nei pressi delle
bocche dei forni erano inoltre situati dei recipienti (m) in pietra o terracotta utilizzati come acquai;
l'acqua veniva infatti usata sia per inumidire le pagnotte che per pulire la superficie di cottura del
forno o raffreddare gli strumenti incandescenti.
Nei pistrina dulciaria erano usati comunemente dei forni più piccoli, in laterizi, con una camera di
cottura fornita di un'apertura ad arco, ed un vano inferiore, con una piccola apertura rettangolare
posta a lato, in cui veniva fatto bruciare il fuoco; da qui il calore riscaldava la camera di cottura
soprastante e il fuoco poteva essere mantenuto acceso anche durante il processo di cottura.
61 ETIENNE 1966, p. 158
62 MAYESKE 1972, pp. 23-24
~ 14 ~
In tutti i forni il fuoco veniva alimentato con pezzi di legname, cocula, sterpaglie secche, cremia
oppure con la scorza della pianta del lino.
L'intera operazione legata alla preparazione del forno e alla cottura del pane era un'attività che
richiedeva tempo ed attenzione e non certo priva di rischi.
Come ai giorni nostri, l'attività del panettiere si svolgeva di notte e durava parecchie ore, poiché il
pane doveva essere pronto all'alba;la produzione inoltre doveva essere piuttosto rumorosa, se
Marziale in uno dei suoi epigrammi si lamenta di non riuscire a dormire la notte a causa dei
fornai63
.
L'intera operazione di panificazione trova un preciso e dettagliato riscontro iconografico nel fregio
della tomba del fornaio Marco Virgilio Eurisace64
, datata nella seconda metà del I sec. a.C.65
e
situata nella zona di Porta Maggiore a Roma nel punto in cui l'antica Via Labicana intersecava Via
Prenestina. Il fregio raffigura i momenti essenziali della panificazione: la prima scena si legge a
partire dal lato meridionale del fregio (vedi fig. 5), da destra verso sinistra, e rappresenta il primo
passo dell'attività del panettiere, cioè l'acquisto del grano e la sua consegna al fornaio
“appaltatore” da parte dei funzionari di stato66
; successivamente è raffigurata la fase della
molitura, con due macine trainate da equidi mentre uno dei due garzoni raccoglie la farina
depositata nel basamento67
. La fase successiva è la setacciatura della farina, per eliminarne le
impurità, compiuta da due schiavi disposti l'uno di fronte all'altro con due grossi setacci. Nel lato
settentrionale del fregio (vedi fig. 6), sempre da destra a sinistra, sono rappresentate le operazioni
conclusive della panificazione68
; la lavorazione della pasta nell'impastatrice, di dimensioni
notevoli e azionata da un cavallo, la fabbricazione dei pani, per opera di otto garzoni che lavorano
su due lunghe tavole, e infine la cottura in un forno dalla semplice struttura a cupola, nella cui
apertura il furnacator sta infornando il pane con una lunghissima pala.
L'ultima parte del fregio, ovvero il lato settentrionale (vedi fig. 7), il più corto, si legge questa
volta da sinistra a destra e raffigura le operazioni successive alla cottura dei pani, durante le quali
i prodotti vengono pesati su delle grandi bilance e riposti in delle ceste e in canestri portati in
spalla dai garzoni, pronti per essere consegnati e smerciati nei punti di vendita69
.
63 MART. 12.57.4 “ Negant uitam ludi magistri mane,nocte pistores, aerariorum marculi die toto.”
64 MAYESKE 1972, p.14
65 EAA, VI, p. 882
66 CIANCIO ROSSETTO 1973, p.45
67 CIANCIO ROSSETTO 1973, p.42
68 CIANCIO ROSSETTO 1973, p.43
69 CIANCIO ROSSETTO 1973, p.44
~ 15 ~
4. CATALOGO
4.1 Premessa
Il seguente catalogo è composto di trentadue schede, ciascuna scheda riguardante un pistrinum o
pistrinum dulciarium di Pompei. Le schede sono ordinate in base all'indirizzo dell'impianto,
partendo dalla Regio I fino alla Regio IX. Ogni scheda contiene una piccola pianta dell'edificio in
esame del quale viene indicata la funzione d'uso (pistrinum/pistrinum dulciarium, etc) e descritte
le principali strutture e caratteristiche, quali macine, forno, etc. Di seguito viene definita la
tipologia di vendita dello stabilimento, se al dettaglio o all'ingrosso e infine, ove sono state
reperite informazioni in proposito, viene attribuita una datazione all'impianto.
~ 16 ~
I,3,1
Pistrinum dulciarium
Impianto produttivo con forno.
Impianto e Strutture
L'edificio, situato nell'angolo meridionale dell'insula con asse NE-SO, è composto da un primo
ambiente quadrangolare (a), accessibile dall'ingresso lungo Via Stabiana, di cui è ipotizzabile un
utilizzo come bottega per la vendita dei prodotti finiti. Un secondo vano, (b), posto lungo la parete
meridionale dell'edificio,doveva servire come deposito o magazzino. L'ambiente (a) era connesso a
N con la zona cottura (d), fornita di un forno di medie dimensioni con bocca in pietra lavica;
basamenti in muratura, probabilmente sostenenti tavoli da lavoro, sono ancora visibili in
corrispondenza dell'apertura del forno e su entrambe le pareti dell'ambiente prospiciente ad esso. Il
locale (c), situato alla destra del forno,doveva servire come laboratorio per la produzione degli
impasti. L'intero impianto era fornito un di un piano superiore, accessibile da una scalinata lignea
posta a sinistra dell'ingresso, e utilizzato come abitazione.
Analogie/Confronti
L'impianto presenta analogie con altri pistrina di piccole dimensioni, in particolare quelli in
VI,6,4.5 e VII,12,1.2.36, in cui si riscontra l'assenza di macine e la sola presenza del forno per la
cottura.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum dulciarium con bottega per la vendita al dettaglio.
~ 17 ~
Osservazioni
La definizione dell'impianto come pistrinum dulciarium viene data da La Torre e da Eschebach, ma
non da Mayeske che non ne specifica la destinazione d'uso.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p. 25 e p. 495
MAYESKE 1972, pp. 82-83
LA TORRE 1988, p. 97
Pompei Informatica, p. 105
PPM, I, pianta.
~ 18 ~
I,3,27
Pistrinum
Panificio completo di forno e macine. Privo di bottega.
Impianto e Strutture
L'impianto è situato lungo il vicolo orientale dell'insula, con orientamento NE-SO, è costituito da
un ambiente principale, di forma rettangolare allungata, che si sviluppa dall'ingresso verso O e tre
ambienti ad esso perpendicolari sul lato S dell'edificio.
A destra dell'ingresso, un piccolo vano usato come magazzino (a) presenta una tompagnatura nella
parete prospiciente al vicolo, forse un'originaria apertura che permetteva l'accesso diretto alla
stanza; Le quattro macine in pietra lavica, di cui sono visibili le basi in muratura e i pochi resti di
metae e catilli, erano collocate lungo il muro N dell'ambiente (b), accessibile dall'androne (1)
d'ingresso. Nella parte S dell'edificio, in corrispondenza con una vasca in muratura per la raccolta
dell'acqua, si apriva il laboratorio (d) dove, come attestano i resti di una macchina impastatrice qui
ritrovata, avveniva la preparazione e la lievitazione dell'impasto su tavoli di legno. Ad O era il forno
in laterizi, con bocca in pietra lavica e camera di cottura fornita di vano anteriore per il fumo. A
sinistra, il piccolo locale (e), affiancato dalla latrina, era utilizzato come magazzino o come
laboratorio secondario.
All'estremità occidentale dell'impianto, l' ambiente (h), con tanto di abbeveratoio in pietra,doveva
costituire lo stabulum per il ricovero delle bestie che azionavano le macine; a S di esso, un piccolo
vano (g) era usato come dispensa o magazzino.
Non è presente la bottega per la vendita al dettaglio.
Datazione: ?
~ 19 ~
Tipologia
Pistrinum destinato alla vendita all'ingrosso o tramite venditori ambulanti.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p. 25 e p. 495
LA TORRE 1988, p. 97
MAYESKE 1972, pp. 83-84
Pompei Informatica, p. 106
PPM ,I, pianta.
~ 20 ~
I,4,12-17 e I,4,13-14
Complesso di Pistrina con botteghe e taberna di D.Junius Proculus.
Panificio, pasticceria e botteghe con forni e macine.
Impianto e Strutture
Il grande impianto, situato all'angolo occidentale dell'insula, si affaccia a N su Via dell'Abbondanza
e ad O su Via Stabiana. Costituito da due pistrina, quattro botteghe e una taberna, la proprietà
dell'intero complesso viene attribuita a D. Junius Proculus. Su Via Stabiana si affacciano la bottega
al civico 12, il piccolo pistrinum dulciarium al n.13 con ampio ingresso, fornito di forno ma privo
di macine, la bottega al n.14 e il primo dei due ingressi della taberna al n.15. Lungo Via
dell'Abbondanza è invece disposto il secondo ingresso alla taberna n.16 e quello della bottega al
n.17.
Elemento principale che conferma l'appartenenza di questi ambienti ad un singolo complesso sono i
numerosi vani d'accesso che collegano tra loro tutti gli spazi dell'impianto. Il pistrinum vero e
proprio è collocato nella parte interna del complesso, a cui si accedeva principalmente tramite la
bottega (a) al n.12. Nell'ambiente principale (b), di grandi dimensioni, era situata l'area dedicata alla
molitura, con le cinque macine circondate da una pavimentazione in lastre di basalto e la zona di
cottura, con il forno (c) disposto lungo la parete meridionale dell'edificio. A SO del forno un
ambiente di modeste dimensioni (d), fornito di una vasca per il lavaggio del grano, doveva servire
come laboratorio per la produzione dei pani, funzione analoga a quella attribuibile al vano (e) posto
a destra del forno.
La funzione di stalla per gli animali che azionavano le macine è attribuibile al locale (f), nei pressi
del quale, all'angolo NE di (b), sono visibili i resti di una scalinata d'accesso al piano superiore,
dove erano presumibilmente collocati gli ambienti abitativi.
~ 21 ~
Il vano (h), connesso al panificio e aperto a N verso la bottega al n.17, dove furono rinvenuti due
catilli, doveva servire come piccolo disimpegno o deposito per la bottega.
Il pistrinum dulciarium al civico n.13, era fornito soltanto di un piccolo forno posto nell'ambiente
(a) e di un laboratorio (b) situato alla sua sinistra; la bottega al n.14 era utilizzata invece per la
vendita al dettaglio.
I due pistrina erano inoltre serviti anche dalla bottega al n.17, verso la quale si aprivano.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum e pistrinum dulciarium con botteghe per la vendita al dettaglio.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p. 29 e p. 495
LA TORRE 1988, p. 97
MAYESKE 1972, pp. 84-86
Pompei Informatica, pp. 106-108
PPM, I, pianta.
~ 22 ~
I,12,1-2
Pistrinum di Sotericus
Abitazione con annesso impianto produttivo privo di bottega (?). Provvisto di forno e macine.
Impianto e Strutture
L'installazione del complesso,situato all'angolo NO dell'insula, risale probabilmente al periodo
successivo al terremoto del 62 d.C. con il restauro e il riadattamento di due vecchie abitazioni di
forma rettangolare allungata delle quali rimane ben visibile la planimetria nella suddivisione interna
degli ambienti del pistrinum.
L'impianto di questa zona dell'insula è di origine sannitica, dato confermato dal muro della facciata
secondaria che conserva perfettamente l'opus africanum originario, con catene verticali di calcare e
pietre laviche disposte secondo lo schema dell'opus incertum. Gli unici due ingressi accessibili nel
79 d.C. Si aprono entrambi su Via dell'Abbondanza, su di un marciapiede in cocciopesto e
conducono ad un vano d'accesso fornito di panche per i clienti. Sia la zona di abitazione che il
quartiere di laboratorio erano forniti di un piano superiore, come testimoniano il grande maenianum
in opus craticium sporgente ad E sulla strada al livello della facciata principale e una particolare
finestra quadrifora che si apre in corrispondenza alla zona di abitazione. In quasi tutti gli ambienti
sono presenti tracce di restauri , dove la struttura in opus incertum di calcare e pietra lavica mostra
integrazioni con laterizio di reimpiego. In corrispondenza dell'ambiente ove sono situate le macine,
sul fronte strada due vani d'accesso risultano tompagnati così come altri due grandi vani sulla
facciata secondaria all'altezza del triclinio e del viridarium.
La zona d'abitazione è costituita di un atrio (3), un triclinio (6) con ancora presente l'incasso per il
letto, due cubicula (4) e (8), e una grande area giardino (7) dove si sono conservate due colonne in
~ 23 ~
laterizio, rivestite di stucco con registro inferiore rosso e superiore bianco, con capitelli dorici in
pietra lavica tenera rivestiti da stucchi bianchi di buon fattura, elementi che fanno pensare ad una
certa cura dei particolari, benché in una casa modesta. In un angolo del viridarium è presente una
bocca di pozzo in pietra lavica.
Nel pistrinum, l'area dedicata alla molitura occupa l'intera lunghezza della casa ed è collegata al
quartiere di abitazione; l'ambiente destinato alle macine (17), collocato a N e prospiciente Via
dell'Abbondanza, presenta nella parte limitrofa al marciapiede una pavimentazione a grandi basoli
irregolari in pietra lavica per sostenere il continuo attrito della rotazione delle macine probabilmente
azionate da animali da soma quali asini o buoi. Una delle macine presenta ancora la guaina in
lamina di bronzo, destinata a raccogliere il grano macinato.
L'area adibita alla cottura (9), separata dalla zona mulino, presenta un forno di grandi dimensioni
con bocca in pietra lavica e la grata di chiusura in ferro, comunicante direttamente con la zona del
panificium vero e proprio (12), destinato alla produzione dell'impasto e alla sua lievitazione, dove si
conservano ,sulle pareti, tracce di mensole e scaffalature per riporre i vari prodotti necessari. La
costruzione,in questo ambiente, di un muro di fondo ad andamento semicircolare ritaglia un piccolo
spazio di uso incerto; altre aree (10),(11),(13) della zona panificio possono essere state usate come
magazzini, dormitori o stalle per gli eventuali animali.
Vista l'assenza di una zona bottega e la grandezza dell'area laboratorio che occupa circa la metà
della superficie dell'edificio sono da escludere una vendita al dettaglio e una produzione di solo
ambito domestico, mentre appare plausibile, anche se non certo, classificare questo pistrinum come
specializzato nella vendita all'ingrosso.
Per quanto è testimoniato, la casa presenta una decorazione pittorica appartenente al IV stile
pompeiano. Tracce esigue attestano la presenza di un semplice larario dipinto, di cui rimane la
figura di un serpente.
Datazione
In base alle tecniche edilizie l'impianto viene datato originariamente all'età sannitica (IV-III a.C.),
con restauri e rimaneggiamenti dopo il terremoto del 62 d.C., a seguito del quale l'abitazione viene
riadattata per ospitare al suo interno le strutture del pistrinum.
Tipologia
Pistrinum per la vendita all'ingrosso o tramite venditori ambulanti (?).
La Torre indica la presenza di un punto di vendita al dettaglio, che però non trova riscontro nel resto
della bibliografia.
~ 24 ~
Osservazioni
Fino a metà degli anni '50 la numerazione di questo edificio rimase un problema pressoché irrisolto;
Della Corte indicava l'edificio come III,2,2 mentre per il Maiuri l'indirizzo corretto era II,2,3.
Successivamente si ritornò definitivamente alla numerazione di scavo, I,12,1-2 , condivisa anche da
Mayeske, Eschebach e La Torre.
Bibliografia
DELLA CORTE 1965, p. 348
ESCHEBACH 1993, p.62 e p. 495
LA TORRE 1988, p. 97
MAIURI 1953, p. 83
MAYESKE 1972, pp. 86-88
Pompei Informatica, p.111
PPM, II, pp. 684-685 e pianta.
~ 25 ~
V,1,14-16
Pistrinum dulciarium
laboratorio di pasticceria con botteghe, fornito di due forni per la cottura ma privo di macine.
Impianto e Strutture
L'edificio, prospiciente a Via del Vesuvio e inserito nel lotto più settentrionale dell'insula V 1, fu
edificato tra il III e il II sec. a.C. come testimoniano le murature in opera a telaio di calcare del
Sarno e residui di decorazione di I stile. Da semplice abitazione, venne trasformato in laboratorio di
pistor dulciarius nell'ultima fase di vita di Pompei (probabilmente a seguito del terremoto del 62
d.C. analogamente a ciò che avvenne per altri edifici) e comprendeva anche i due ambienti (i) e (h)
ai civici 14 e 16, posti ai lati delle fauces di ingresso, usati con funzione di botteghe come
testimoniano le profonde scanalature su entrambi i gradoni d'accesso dove si innestavano le tavole
delle saracinesche di chiusura. Sebbene si conservi sostanzialmente intatto l'aspetto di abitazione,
furono apportate alcune modifiche dovute alla nuova destinazione d'uso, soprattutto nella parte
posteriore dell'edificio, dove nell'originario viridarium, furono impiantati due forni.
Attraverso il piccolo corridoio di ingresso (a) si accedeva all'atrio (b) dove l'impluvium con bordo di
tufo modanato databile al II sec a.C. e il pavimento in lavapesta con crocette di tessere bianche e
nere testimoniano la più antica fase costruttiva dell'edificio. Addossata al muro meridionale
dell'atrio, una vasca rialzata per la raccolta dell'acqua o forse per il lavaggio del grano. Gli ambienti
(c) e (d), posti sul lato settentrionale dell'edificio, mantennero probabilmente le precedenti funzioni
di soggiorno. In essi sono presenti tracce di decorazione di IV stile pompeiano: (c) presenta un
fondo bianco con vignette di amorini e nella parte più alta della parete conservava un piano
sporgente di stucco, residuo della più antica decorazione di I stile; l'ala (d) era a fondo nero con
quadretti di animali nei pannelli centrali e medaglioni con busti di giovanetti e vignette con figure
~ 26 ~
volanti in quelli laterali, pitture di cui tuttavia non rimane traccia. Proprio nell'ala furono ritrovate
numerose forme da pasticceria e utensili per la lavorazione delle paste, elementi che unitamente alla
presenza dei due forni attesterebbero la destinazione di laboratorio di pistor dulciarius per l'edificio.
Su di entrambi i lati del tablino (e), dove una tavola poggiava su due sostegni in muratura,adiacenti
i forni, erano situati altri due cubicoli, (g) a N con pareti decorate in IV stile poi ridipinte in
semplice “bianco con strisce rosse” e (f) a S ricoperto di intonaco grezzo. Dell'antico peristilio il
braccio O venne occupato dai due forni, mentre rimane il braccio S sul quale si apriva un ambiente
di servizio (i) con latrina e primi gradini di una scala probabilmente conducente ad un piano
superiore.
Del viridarium rimase solo una piccola parte (h) all'angolo NE dell'edificio, circondata da un pluteo
continuo, con canaletta di raccolta dell'acqua piovana che si triplica inspiegabilmente sul lato S.
La presenza di due forni di modeste dimensioni indica un livello di produzione piuttosto elevato;
l'assenza di macine presuppone l'utilizzo di farina acquistata da altri produttori.
Datazione
Le murature in opera a telaio di calcare del Sarno e residui di decorazione in I stile datano
l'impianto originario al III-II a.C. ,con successivi rimaneggiamenti e modifiche nella destinazione
d'uso probabilmente posteriori al terremoto del 62 d.C.
Tipologia
Pistrinum dulciarium; in origine fornito di botteghe aperte sulla strada, poi chiuse. Nell'ultimo
periodo di vita, forse destinato alla vendita all'ingrosso.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p. 125 e p. 495
LA TORRE 1988, p. 97
MAYESKE 1972, pp. 88-89
Pompei Informatica, p.122
PPM ,III, pp. 536-537 e pianta.
~ 27 ~
V,3,8
Pistrinum
Impianto produttivo ricavato da precedente casa ad atrio, comprende un forno e tre grandi macine.
Privo di bottega.
Impianto e Strutture
L'edificio è situato all'angolo SE dell'insula, prospiciente a Via di Nola e presenta un
raddoppiamento della facciata contigua al civico n.7 con la costruzione di un secondo muro privo
di rivestimento, a piccoli blocchi di calcare disposti in filari regolari e delimitati da grandi lastroni
dello stesso materiale che ha chiuso l'alta finestra sulla strada della parete in opus incertum già
esistente. L'impianto originario, risalente all'età sannitica, conservava resti di decorazione di I stile
nell'atrio tuscanico (11), nel tablino (10) e nel più settentrionale (5) dei tre piccoli cubicoli coperti a
finta volta e sormontati da un secondo piano, che prendevano luce tramite alte finestre strombate,
successivamente modificate nei due cubicoli più a S, (3) e (4).
In un momento successivo, probabilmente a seguito del terremoto del 62 d.C., vista l'analogia con
altre simili trasformazioni d'uso, l'abitazione è stata convertita in pistrinum con l'installazione di un
forno e di tre macine nell'ambiente.
Il forno con facciata ad acro, collocato nell'angolo SE dell'atrio, di fronte al cubiculum (3), presenta
in aggiunta alla camera di cottura anche un a vano per il fumo, che migliorava la cottura delle
pagnotte e il mantenimento del calore.
Nell'atrio vennero installate tre grandi macine in lava, poggianti su pavimento in lastre di basalto,
delle quali si conservano tuttora gli zoccoli in muratura e parte di meta e catillus della macina
situata a NE. Con la trasformazione in panificio anche l'impluvium viene modificato e riadattato in
vasca a due scomparti probabilmente con funzione di acquaio per il lavaggio del grano. L'ampio
ambiente (2) adiacente al forno era invece usato come magazzino o stalla per le bestie necessarie ad
attivare le macine.
~ 28 ~
Altri ambienti (14) e (6) nella parte settentrionale dell'atrio costituivano magazzini o zone di
servizio; le ampie aree scoperte (7) e (9) nella parte posteriore dell'edificio derivano certamente
dalla planimetria precedente alla trasformazione subita nell'ultima fase edilizia, quando la
ripartizione degli spazi doveva essere ben diversa e connessa ai civici n.7-10 con diverso
proprietario (vedi il vano tompagnato sulla parete N dell'ampia area scoperta che conduceva al
civico n.9).
Datazione
Da resti di decorazione in I stile si data l'impianto originario in età sannitica, II a.C., quando era in
uso come abitazione;secondo lo scavatore, per analogie con altre simili trasformazioni, venne
convertito in pistrinum dopo il 62 d.C.
Tipologia
Pistrinum privo di bottega, destinato alla vendita all'ingrosso o tramite venditori ambulanti.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.138 e p. 495
LA TORRE 1988, p. 97
MAYESKE 1972, pp. 89-90
Pompei Informatica, p.124
PPM, III, pp. 915-916 e pianta.
~ 29 ~
V,4,1-2
Casa con pistrinum e bottega
abitazione con annesso impianto produttivo costituito di un forno e tre macine e piccola zona
bottega.
Impianto e Strutture
L'edificio, situato all'angolo SO dell'insula, si affaccia con gli ingressi su Via di Nola. Di pianta
rettangolare allungata, l'edificio potrebbe essere nato come semplice abitazione, nella quale solo
successivamente venne impiantato un laboratorio di panetteria.
Entrando nel complesso, ai lati delle fauces (A) sono disposti sei ambienti, tre per ogni lato,
probabilmente con funzioni di stabula o magazzini, fatta eccezione per il primo ambiente (N) ad E
dell'entrata, il quale, provvisto di un proprio accesso al civico n.2, si affaccia direttamente su Via di
Nola ed era probabilmente usato come bottega.
Ad E dell'atrio (I), privo di impluvium, una stanza tricliniare (H) conserva ancora gli incassi per il
letto sulla parete S.
Il laboratorio vero e proprio (K) è situato nel retro dell'abitazione, in quello che doveva essere
precedentemente il viridarium, e presenta un forno, collocato nell'angolo NO dell'ambiente, e tre
macine disposte parallele lungo la parete opposta e circondate da un pavimento in lastre di basalto.
A N, un grande vano con due accessi (P), fornito di un'apertura che lo collegava direttamente alla
camera di cottura del forno era utilizzato per la preparazione e la lievitazione dell'impasto. Sostegni
per tavoli da lavoro sono presenti nella parete a S del forno.
In corrispondenza di quello che un tempo era il tablino (M), un piccolo vano con gradini in
muratura conduceva ad un piano superiore.
Datazione: ?
~ 30 ~
Tipologia
Pistrinum e abitazione con bottega per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
Durante i primi scavi dell'edificio alla fine dell'800 vennero alla luce numerosi oggetti, tra cui
lucerne decorate, una figurina raffigurante un Sileno nudo e barbuto, piedistalli di lucerne, vasi,
piatti, casseruole, amuleti osceni, monete, cinque anfore e una briglia per gli asini che azionavano le
macine. Presso le fauces d'ingresso venne ritrovata inoltre una statuetta in terracotta raffigurante una
Minerva armata.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p. 140 e p. 495
LA TORRE 1988, p. 97
MAYESKE 1972, pp. 91-93
Pompei Informatica, p.124
PPM, III, p.1047 e pianta.
VI,2,6
~ 31 ~
Pistrinum di A.Cossius Libanus
Piccolo impianto produttivo fornito di forno e tre macine. Privo di bottega.
Impianto e strutture
Originariamente parte del complesso definito “Casa di Sallustio”o “Casa di A.Cossius Libanus” (in
uso come hospitium nell'ultima parte di vita della città),all'estremità meridionale dell'insula, il
pistrinum venne impiantato tra la fine del I sec. a.C. E gli inizi del I sec. d.C. in coincidenza con
una trasformazione d'uso del complesso, in cui la parte occidentale del braccio N del giardino che
circondava la casa e le due botteghe più settentrionali, sul fronte strada, furono trasformate in
panificio con macine e forno.
L'ingresso del laboratorio, che si affaccia su Via Consolare, all'incrocio con il Vicolo di Narciso,
introduce direttamente alla zona mulino (6), con le tre macine in pietra lavica ben conservate, e al
forno (7) con camera di cottura e vano per il fumo e un'apertura sul lato S che trasmette il calore al
piccolo ambiente dove avveniva la preparazione e la lievitazione dell'impasto.
A SE dell'ingresso al pistrinum, un vano (9) di modeste dimensioni con i resti di una vasca (?) in
pietra era forse utilizzata come stalla.
A S del forno, una scala conduceva ad un piano superiore.
Datazione
Impianto originario realizzato nel II a.C, come testimonia la struttura molto regolare inserita entro
compatti muri perimetrali, successivamente modificato e in parte trasformato in pistrinum,
probabilmente tra fine I a.C. e I d.C.
~ 32 ~
Tipologia
Pistrinum per la vendita all'ingrosso o tramite venditori ambulanti.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.157
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp. 93-95
Pompei Informatica, p.128
PPM, IV, pp. 87-88 e pianta.
VI,3,1-4.27-28
~ 33 ~
“Casa del Forno”
Abitazione convertita in pistrinum/ pistrinum dulciarium; Impianto produttivo completo di
forno,macine e botteghe (?).
Impianto e Strutture
L'edificio, situato all'estremità settentrionale dell'insula, si affaccia ad O su Via Consolare e ad E sul
Vicolo di Modesto. Originariamente abitazione di III-II sec. a.C., nell'ultima parte di vita della città
venne trasformata per meglio servire alle esigenze del panificio impiantato nella sua parte orientale,
al posto dell'originario viridarium. La planimetria originaria fu sostanzialmente conservata, ma
mutarono le funzioni d'uso dei vari ambienti.
Ai civici n.1 e 4 vennero aperte due botteghe (non associabili con certezza all'attività del panificio),
come testimoniano i solchi sul gradone d'accesso in cui si innestavano le saracinesche lignee,
mentre all'ingresso n.2 delle scale (2) conducevano al piano superiore.
Dalle fauces d'ingresso (1) si accedeva al grande atrio tuscanico (8) con impluvium di tufo di
Nocera, agli angoli del quale furono innalzati quattro pilastri in laterizi per sostenere il solarium,
costruito al posto del compluvium, e accessibile tramite la scala aggiunta nell'angolo SO
dell'ambiente. I cubicoli (7), (12), (13) lungo il lato meridionale dell'atrio vennero convertiti in
apoteche o locali di attesa per clienti, come ipotizzato dalla presenza di sostegni per sedili. Funzione
residenziale dovevano avere gli ambienti (10) e (11) lungo il lato settentrionale dell'atrium.
Il tablino (14), allineato con il vestibolo (1) e sopraelevato rispetto all'atrio, venne accorciato e
convertito in una sorta di vestibolo del pistrinum, mentre le fauces adiacenti ad esso vennero
eliminate.
L'area panificio/pasticceria, fornita di doppio ingresso indipendente, ai n. 27-28, venne installata
nella zona del precedente giardino , con il forno (17) provvisto di vano per il fumo, con facciata ad
arco in mattoni e un secondo arco nella parte superiore (probabilmente con funzione puramente
estetica), collocato tra due ambienti lungo la parete meridionale;di seguito erano presenti un oecus
(19) ad O (decorato in III stile e pavimentato a mosaico alla fine del I sec. a.C. quando aveva ancora
~ 34 ~
funzione residenziale) e un locale (18) ad E per la preparazione e la lavorazione dell'impasto e il
deposito del pane cotto.
Le macine furono collocate al centro del viridarium (15), su pavimentazione in pietra lavica e una
vasca in muratura fu addossata alla parete del tablino interna al pistrinum. Una latrina (20) e la
stalla (16) per le bestie che azionavano le macine furono realizzate sul lato N.
I pochissimi resti di decorazione pittorica visibili risalgono all'ultima fase costruttiva della casa e
confermano il carattere commerciale dell'edificio in quanto semplici schemi di pannelli delineati in
rosso su sfondo bianco.
Dopo il terremoto del 62 d.C. vennero eseguiti alcuni interventi di restauro sulle murature, come
indicano gli stipiti in laterizi, la facciata, i pilastri nell'atrio, il forno e le catene di irrobustimento
delle pareti.
Analogie/confronti
Il forno di questo impianto si collega per la forma al forno presente in VI,6,17-21, caratterizzato
dallo stesso tipo di facciata ad arco ripetuto.
Datazione
L'impianto ha origine nel III-II sec a.C. come abitazione, nella quale dopo il 62 d.C. viene installato
uno stabilimento per la produzione di pane/dolci.
Tipologia
Pistrinum/pistrinum dulciarium con botteghe (?) per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
L'impianto viene indicato da La Torre come pistrinum dulciarium,mentre Eschebach attribuisce
all'edificio entrambe le funzioni di panificio e pasticceria; Mayeske utilizza invece la sola
definizione di panificio. E' possibile dunque che lo stabilimento abbia assolto a entrambe le
funzioni, poiché se considerato unicamente come pistrinum dulciarium, risulterebbe un impianto
anomalo, soprattutto vista la presenza delle macine, solitamente assenti nelle pasticcerie.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.162 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAIURI 1942, pp.164-165
MAU 1982, pp.388-392
MAYESKE 1972, pp.95-97
~ 36 ~
Pistrinum dulciarium
Impianto produttivo di pasticceria fornito di due macine, forno e bottega.
Impianto e Strutture
L'edificio, con ingresso sulla facciata meridionale dell'insula, in origine doveva far parte di un unico
impianto abitativo con la domus al civico n.14, vista l'anomala disposizione degli ambienti.
Il primo locale (1) a cui si accede dall'ingresso contiene nella sua parte orientale la zona mulino con
due macine su pavimentazione in pietra lavica, di cui oggi rimangono solo i segni circolari tra le
lastre basaltiche; all'angolo NO un piccolo ambiente aperto (8) doveva fungere da bottega di vendita
al dettaglio, disposizione insolita in quanto non si affaccia direttamente sulla strada come avviene in
altri impianti del genere. Adiacente alla bottega, un secondo ambiente (7) di simili dimensioni
doveva servire come camera da letto del panettiere. A NE della zona mulino un lungo corridoio (2)
conduceva alla zona di preparazione e cottura dei prodotti (3), con un forno (9) di medie dimensioni
con bocca e piano d'appoggio esterno in pietra lavica, una macchina impastatrice e un ambiente
fornito di sostegni per tavoli da lavoro (4).
All'estremità settentrionale del corridoio d'accesso alla zona cottura, nel vano (5), sono visibili i
resti di un acquaio e di un piccolo dolio inserito in una base in muratura.
Datazione:?
Tipologia
Pistrinum dulciarium con bottega per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
~ 37 ~
Mayeske riferisce che nel 1971 non erano visibili macine nell'edificio, probabilmente a causa del
disastroso stato di conservazione dell'impianto.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.172 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp.97-98
Pompei Informatica, p.129
PPM,IV, pianta.
VI,6,4-5
~ 38 ~
Pistrinum dulciarium
Piccolo impianto produttivo fornito di forno. Provvisto di bottega (?).
Impianto e Strutture
L'edificio, situato all'angolo SE dell'insula, e accessibile tramite due ingressi, al civico n.14 lungo
Via delle Terme e al civico n.15 lungo Vicolo della Fullonica, doveva essere in qualche modo
connesso all'abitazione VI,6,6 ad esso adiacente, con la quale forse comunicava tramite un'apertura
sulla parete N, successivamente murata.
Di piccole dimensioni, l'impianto era fornito di un forno (2), oggi non più visibile, situato lungo la
parete orientale dell'edificio,nei pressi dell'ingresso al n.15, con bocca in pietra lavica e camera di
cottura in laterizi.
All'estremità settentrionale, un piccolo ambiente (4) ad O doveva servire come locale di
lavoro,analogamente a (3), o deposito dei prodotti.
É possibile che la vendita dei prodotti avvenisse nell'ambiente (1), in quanto fornito di due ampi
ingressi aperti sulla strada.
Analogie/Confronti
L'impianto presenta caratteristiche comuni al pistrinum dulciarium presente in I,3,1, con il qule
condivide la ristrettezza degli spazi e la sola presenza del forno per la cottura dei dolci come
struttura identificativa della destinazione d'uso dell'edificio.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum dulciarium con bottega per la vendita al dettaglio (?).
~ 39 ~
Osservazioni
In Eschebach la proprietà dell'edificio viene attribuita a P. Cipio, ma nessun altro riferimento a tale
personaggio è presente nel resto della bibliografia.
La Torre e Pompei Informatica descrivono l'edificio come semplice pistrinum, ma viste le sue
ridotte dimensioni e l'assenza di macine è più attendibile la definizione di pistrinum dulciarium data
da Mayeske e da Eschebach.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.174 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, p.98
Pompei Informatica, p.130
PPM, IV, pianta.
VI,6,17-21
~ 40 ~
Pistrinum dei Christiani
Panificio con forno,tre macine e bottega.
Impianto e Strutture
L'edificio,situato all'estremità sudoccidentale dell'insula, è accessibile tramite un ingresso principale
al civico n.17, che introduce in un ambiente a pianta quadrangolare (1) con due vani sul lato E, dei
quali il più meridionale (3) è connesso direttamente alla bottega (4) con ingressi ai n.20 e 21.
Il laboratorio (3), provvisto di una macchina impastatrice, era collocato all'estremità NO
dell'impianto, comunicante con l'ambiente dedicato alla macinazione e fornito di tre molae in pietra
lavica (1) nell'angolo SE; esse erano disposte su pavimentazione in lastre basaltiche, presso le quali,
un acquaio in muratura è addossato alla parete orientale.
Il forno in laterizi (2) con facciata ad arco ripetuto (un'arcata principale che coincide con l'apertura e
un secondo arco superiore con funzione puramente estetica), installato a N della zona mulino,
presentava nella parte superiore della facciata una placca rettangolare in terracotta, con una
rappresentazione fallica in bassorilievo e la frase “hic habitat felicitas” incisa ai margini superiore e
inferiore, ora conservata al Museo Archeologico di Napoli. Questo tipo di iscrizione, spesso
presente negli ingressi delle abitazioni, doveva probabilmente la sua insolita posizione al senso
dell'umorismo del fornaio.
Sostegni per tavoli da lavoro, disposti lungo la parete all'angolo NO del laboratorio, erano usati per
la produzione dell'impasto e la sua lievitazione.
Gli ingressi ai civici n.18 e 19 conducevano a scalinate d'accesso ad un piano superiore.
Analogie/confronti
L'impianto presenta similitudini con il pistrinum VI,3,1-4.27-28, con il quale condivide la
medesima tipologia di forno caratterizzato da una facciata ad arco ripetuto.
~ 41 ~
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum con bottega per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
La denominazione di pistrinum dei Christiani deriva da un frammento di bassorilievo raffigurante
una croce, ritrovato sulla parete esterna della bottega.
Nella pianta dell'edificio, ricavata dal PPM, il pistrinum sembrerebbe composto di due unità per
altro non comunicanti, in cui gli ambienti di ciascuna unità sono stati numerati in modo
indipendente; ciò ha comportato la ripetizione dei numeri da 1 a 3 con conseguente confusione nella
comprensione della suddivisione degli spazi. Evidentemente il tutto è dovuto ad un errore nella
creazione della pianta, ancor più esplicito se si osserva come l'unità più settentrionale dell'impianto
risulti priva di qualsiasi accesso, cosa alquanto improbabile.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.176 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp.99-102
Pompei Informatica, p.130
PPM, V, pianta
VI,11,8-10
~ 42 ~
Casa del Labirinto
Grande domus a doppio atrio e peristilio con pistrinum domestico.
Impianto e Strutture
La casa occupa quasi 2000 metriquadri della metà meridionale dell'insula VI,11 e figura tra le più
grandi domus preromane della città.
L'edificio fu costruito intorno alla fine del II sec. a.C. o poco dopo, inglobando alcuni stabili
preesistenti; Agli inizi del I sec. a.C. vennero effettuati ampliamenti e riallestimenti che
aumentarono lo sfarzo dell'abitazione, tra cui la costruzione di un piano superiore per le stanze
private nella parte anteriore della casa a O e a S dell'atrio tuscanico (3) e il nuovo peristilio
impostato nella zona del precedente hortus che aveva tuttavia dimensioni più ridotte, ampliato a
spese di almeno due case adiacenti a N, acquistate per l'occasione. Successivi restauri vennero
eseguiti intorno agli anni 70/60 a.C. probabilmente anche a seguito dei numerosi danni subiti
durante l'assedio sillano di Pompei nell'89 a.C. Il terremoto del 62 d.C. provocò notevoli danni nel
settore meridionale della domus, che resero necessari nuovi restauri e furono occasione per ulteriori
modifiche degli ambienti.
Tra le trasformazioni che la casa subì dopo il 62 d.C.,è compresa l'installazione di un panificio
privato ,situato nella parte occidentale della domus. Al pistrinum si accedeva tramite un lungo
corridoio (15) situato a N dell'atrio (3), che conduceva al cortile (16) in cui erano collocate le
quattro grandi macine, tre delle quali conservatesi nelle loro basi in muratura, mentre la quarta è
andata perduta, ma desumibile da una lacuna nella pavimentazione in basalto.
Il grande forno in laterizi (55), del tipo con vano per il fumo, è situato a N, adiacente ad un vano
(19) usato sicuramente come laboratorio, vista la presenza di una macchina impastatrice. Nella parte
S del panificio, una scala (59) conduceva al piano superiore sovrastante il bagno e l'accesso
~ 43 ~
all'ambiente (20) che nel periodo successivo al terremoto venne soppresso a favore di un nuovo
forno.
Datazione
Impianto originario del tardo II sec. a.C. con successive modifiche e restauri nel I sec a.C. e nel I
sec. d.C.. Panificio impiantato solo dopo il terremoto del 62 d.C.
Tipologia
Pistrinum domestico.
Osservazioni
La casa VI,11,8, in origine utilizzata dall'amministratore della Casa del Labirinto, divenne
successivamente l'abitazione del fornaio, un tale Eutychus, il cui signaculum fu ritrovato nel
peristilio vicino alla sua salma.
La Torre considera il pistrinum come appartenente alla Casa di Hermes, connessa alla Casa del
Labirinto.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.199 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp.103-104
PESANDO-GUIDOBALDI 2006, pp.189-191
Pompei Informatica, p.134
PPM, V, pp.1-68 e pianta.
VI,14,29-33
~ 44 ~
Pistrinum
Pistrinum fornito di forno e macine connesso alla Casa di Laocoonte e ad una taberna.
Impianto e strutture
Di impianto risalente all'età repubblicana, come attestano l'impluvium in cocciopesto dell'atrio
tuscanico (a) e resti di decorazione in I stile presenti in alcuni ambienti della casa,l'abitazione è per
la maggior parte decorata in tardo III stile di età imperiale e proprio intorno alla metà del I sec. d.C.
subisce le maggiori trasformazioni. Collocato all'angolo NE dell'insula,il complesso subisce una
serie di mutamenti probabilmente a seguito del famoso terremoto del 62 d.C., quando viene a
distinguersi in più nuclei comunicanti tra loro: la Taberna Lusoria Aleariorum con accesso al n.28
affacciata su Via di Stabia, la Casa di Laocoonte con ingresso al n.30, la stalla al n.31 e il panificio
ai n.32-33.
Il pistrinum, affacciato sul vicolo che costeggia il lato N dell'insula,è fornito di tre macine in pietra
lavica disposte in (p) ad E dell'ingresso e circondate dalla consueta pavimentazione in lastre
basaltiche che contraddistingue la zona mulino di tutti i panifici; il forno (r) in opera laterizia, del
tipo con camera per il fumo, è situato a S dell'area dedicata alla molitura e presenta a S, (m), e ad E,
(n), due ambienti probabilmente usati come laboratori. Il piccolissimo vano (s), ad O del forno, per
la ristrettezza degli spazi non rende chiara la sua funzione, analogamente all'ambiente (h), con
ingresso al n.32, di destinazione d'uso incerta, probabilmente una stalla per gli asini che azionavano
le macine.
Tramite il corridoio (o) si poteva passare direttamente dal panificio all'abitazione.
~ 45 ~
Datazione
Impianto originario risalente all'età repubblicana,come risulta dall'impluvio rivestito di cocciopesto
situato al centro dell'atrio tuscanico, e da resti di decorazione in I stile, con successivi mutamenti
nella seconda metà del I sec. d.C. (dopo 62 d.C.), confermati da residui di pitture in III stile.
Tipologia
Pistrinum destinato alla vendita all'ingrosso (?) o tramite venditori ambulanti.
Osservazioni
In Pompei Informatica e in Eschebach la Casa del Laocoonte ed il pistrinum ad essa connesso
vengono indicati come proprietà di Manius Salarius Crocus.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, pp.214-215 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp.104-106
Pompei Informatica, pp.136-138
PPM, V, p.341 e pianta.
VI,14,34
~ 46 ~
Casa con pistrinum
Casa ad atrio tuscanico con impianto produttivo provvisto di forno e macine.
Impianto e strutture
L'edificio, situato sul lato N dell'insula, si divide in due aree con due diverse funzioni: La parte
occidentale,corrisponde alla zona residenziale, con atrio tuscanico (2) con impluvium di tufo, due
cubicoli (a) e (b) a entrambi i lati delle fauces (1) e un triclinio (c) all'estremità SO dell'abitazione.
La zona orientale coincide invece con il panificio. Privo di bottega, comprendeva le macine a N
(f),gli ambienti di lavoro (l) ed (i) con macchina impastatrice a S, il forno (h) del tipo con camera
per il fumo, l'annessa latrina (g) e la stalla (k) per le bestie che azionavano le macine, situata ad E
delle molae e accessibile, in origine, anche dalla strada. Di fronte al forno (h), sopra i resti di un
supporto in mattoni era dipinto un larario raffigurante due serpenti in rilievo di stucco su sfondo
rosso.
É possibile che il panificio occupasse ,almeno in parte, una zona in precedenza residenziale,
essendo ancora riconoscibile la posizione originaria dell'ala E, grazie al ritrovamento dei resti di
pavimentazione in cocciopesto con ornato delineato in tessere bianche, simile a quello del tablino
(d). L'intero impianto doveva avere in precedenza dimensioni maggiori e un aspetto più “nobile”,
come risulta da colonne murate ancora visibili nella parete S del tablino e sulla parete O dell'atrio.
Le soglie marmoree nel vestibolo, nei cubicoli e nell'atrio, in corrispondenza dell'entrata al panificio
presentavano decorazioni di età imperiale, probabilmente in fase di rifacimento come risulta
dall'intonaco grezzo che le rivestiva al momento dell'eruzione del 79 d.C.. All'epoca dell'eruzione il
panificio doveva aver smesso la sua funzione o funzionare comunque solo in parte, vista l'assenza
di macine al momento dello scavo.
Analogie/confronti
~ 47 ~
Sebbene in uno spazio più ridotto, la disposizione degli ambienti di questo edificio, soprattutto per
quanto riguarda la collocazione delle strutture per la panificazione, ricorda fortemente il pistrinum
di Sotericus I,12,1.2.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum per la vendita all'ingrosso.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.215 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp.106-107
Pompei Informatica, p.138
PPM, V, p.363 e pianta.
VII,1,36-37
~ 48 ~
Pistrinum di Modesto
Casa ad atrio comprendente un panificio con forno, macine e bottega.
Impianto e Strutture
L'edificio, situato nella parte settentrionale dell'insula VII,1 che segna la zona di raccordo tra
l'impianto cittadino primitivo e la zona di espansione di età sannitica, si apriva con entrambi gli
ingressi, quello principale al n.36 e quello della bottega al n.37, su Via degli Augustali, una delle
zone di maggior movimento pedonale.
Dalle fauces d'ingresso, si accedeva all'atrium nel cui centro, al posto del consueto impluvium, fu
installata una vasca ad alti bordi per il lavaggio del grano e la raccolta dell'acqua, resa possibile da
un complesso sistema di adduzione attraverso canalette di piombo e terracotta,una delle quali
proseguiva verso la parte retrostante dell'edificio, terminando in un dolio collocato nella zona delle
macine e del forno.
A destra del vestibolo,fornita di una piccola finestra verso la strada, è situata la stalla per gli animali
che azionavano le macine (d); a sinistra, la bottega (1) con ingresso al n.37, (dove era presente un
larario dipinto raffigurante la dea Vesta, protettrice dei pistores), suddivisa in due ambienti e
comunicante con l'atrio, e in sequenza,verso S, il cubicolo (g) forse destinato agli operai, il triclinio
(h) e il magazzino (i). Dalla parte opposta dell'atrio, un altro cubicolo (e) e la cucina (f) con i
sostegni in muratura per le tavole su cui impastare e preparare il pane. L'ampio ambiente (k)
probabilmente serviva per la preparazione e il deposito dei pani.
Il forno e le macine si trovavano nella parte meridionale della casa, queste ultime in (l), su
pavimentazione in basoli. Il forno (m), tra i meglio conservati di Pompei, di grandi dimensioni, con
apertura ad arco in mattoni e appartenente alla tipologia con vano per il fumo, era situato lungo la
parete orientale dell'edificio, affiancato a S da (l) e a N da una scala posta accanto ad (i) che portava
al piano superiore probabilmente adibito a terrazza per far asciugare il grano.
Le strutture murarie dell'edificio, per la maggior parte in opus incertum, presentano rifacimenti in
opera laterizia e vittata mista di laterizi e tufo, soprattutto nel restauro e consolidamento di cantonali
~ 49 ~
e stipiti, probabilmente necessari dopo i danni del terremoto del 62 d.C.
Sugli stipiti rivolti verso la strada, all'altezza dell'ingresso 36, quattro placche, due per stipite,
presentano decorazioni particolari; due placche con contorno a forma di tempietto, decorate
all'interno con simboli di fertilità (una figura Priapica nella lastra di sinistra e un fallo orizzontale in
quella di destra), e più in basso una lastra quadrangolare, sullo stipite sinistro, decorata con elementi
circolari a spicchi (dei pani?) e sullo stipite destro una placca rettangolare con decorazione a tessere
quadrate oblique policrome.
Datazione
Impianto originario di datazione incerta, con restauri dopo 62 d.C.
Tipologia
Pistrinum con bottega per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
Al momento dello scavo, alcune macine erano costituite dalle sole metae, forse perché in procinto
di essere completate da nuovi catilli, o per essere utilizzate solo in caso di necessità.
La notte prima della catastrofe del 79 d.C., l'ultima infornata era stata di 81 pagnotte, carbonizzate
poi dal calore dei gas espulsi dal Vesuvio, e ritrovate intatte all'interno del forno ancora chiuso dallo
sportello di ferro.
Mayeske ricorda come nei pressi dell'entrata all'edificio comparisse un'iscrizione elettorale a favore
di un certo MODESTUM, identificato come Lucius Modestus e proprietario dell'impianto;
Eschebach conferma l'attribuzione del pistrinum a Modesto ma aggiunge anche il nome di Q.
Granius Verus.
Bibliografia
CIPROTTI 1962, p.115
ESCHEBACH 1993, p.249 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAIURI 1942, pp.167-168
MAIURI 1983, pp.26-29, in cui viene immaginata l'ultima notte di lavoro del panettiere Modesto.
MAYESKE 1972, pp.107-110
Pompei Informatica, p.144
PPM, VI, pp.365-366 e pianta.
VII, 1,46-47
~ 50 ~
Casa di Sirico
Domus con atrium tuscanico e peristilio fornita di cucina con panificium privato (forno e macine).
Impianto e Strutture
La casa, conosciuta precedentemente anche come Casa dei Principi di Russia prende il nome da un
sigillo rinvenuto nel tablino (6) con inciso il nome SIRICI. Un'iscrizione elettorale che raccomanda
un P. Vedius trovata nelle vicinanze della casa e l'esistenza di un P. Vedius Siricus candidato alla
carica di duoviro quinquennale hanno fatto attribuire alla domus il nome del personaggio.
Il complesso è formato da due nuclei distinti,l'uno aperto su Via di Stabia al n.25 e l'altro,
probabilmente il principale, su Vico del Lupanare al n.47.
Un secondo ingresso, al n.46, dava accesso,tramite un vano (16) d'uso non ben definito e uno stretto
corridoio (15) ad un'ampia zona di servizio contenente una cucina (12) di notevoli dimensioni
fornita inoltre di un piccolo panificio (14), con forno e macine, impiantate su pavimentazioni in
basoli tipica delle aree mulino dei panifici. Il locale (13) adiacente al forno doveva servire per la
lievitazione degli impasti e la preparazione dei pani, forse in ambiente termicamente controllato
tramite un'apertura nella parete della camera di cottura del forno, come attestato in altri panifici.
Questa disposizione degli ambienti doveva tuttavia differire dall'impianto originario, che subì una
serie di modifiche, come un 'ampliamento dell'esedra (10) che andò ad occupare un'area
precedentemente parte della cucina (12) sulla quale era installata una macina.
Altra modifica all'impianto originario dell'edificio è l'unificazione dei due nuclei abitativi che
comunicano tramite uno stretto passaggio aperto sui peristili (19) e (31), uniti in un unico
complesso in momento sconosciuto, ma probabilmente non prima dell'età tardo-repubblicana.
Datazione
~ 51 ~
Impianto originario di IV sec a.C., modificato dalla costruzione delle Terme Stabiane, con vari e
successivi interventi in età tardo-repubblicana e imperiale.
Tipologia
Pistrinum domestico.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.246
Pompei Informatica, p.144
PPM, VI, pp.228-229 e pianta.
VII,2,3
~ 52 ~
Pistrinum di Terentius Neo
Casa ad atrio con impianto produttivo di panetteria. Incerta la presenza di un punto di vendita.
Impianto e Strutture
L'edificio, situato all'angolo SE dell'insula, è parte di un complesso costituito dal primitivo nucleo
del panificio, accessibile dal civico 3, cui fu aggiunta ,nell'ultimo periodo di vita della città, la
vicina abitazione del civico 6 resa intercomunicante tramite l'abbattimento di un muro che in
origine divideva il corridoio (m) in due ambienti.
L'ingresso al panificio avveniva tramite delle ampie fauces (a) che conducevano all'atrio (d) fornito
di un piccolo cavedio, formato da pilastri angolari e due colonne per lato, in mattoni, inglobati in
muretti, e affiancato nell'angolo SE da una vasca in muratura per la raccolta dell'acqua piovana.
Resti di scalini, addossati alla parete E, dovevano condurre ad un piano superiore di cui non è
rimasta però alcuna traccia.
Gli ambienti a S e N del cavedio, (f), (g), (h), (k), (l),con funzione abitativa, erano forse destinati
agli schiavi, anche se con un diverso uso precedente, vista la presenza di soglie marmoree.
Il vano (e) venne classificato come cucina, data la presenza di un basso tramezzo che divideva la
stanza dalla latrina sul quale era stato graffito più volte e con errori “ Secundus hic cacat”.
Il ritrovamento di ossa animali al momento della scavo nel vano (i), così come l'assenza di
pavimentazione e segni di incasso sulle pareti di una mangiatoia lignea, attestano l'uso dell'ambiente
come stalla per gli animali che azionavano le macine.
Gli ambienti (n), (o), e (p), gli ultimi due derivati da un ampliamento verso O a discapito
dell'abitazione 51, costituivano la zona del panificio vero e proprio; in (o) erano collocate le 5
macine in pietra lavica, una delle quali aveva la base ricoperta da una lamina di piombo, forse per
facilitare la raccolta del grano macinato, e acquai in muratura su pavimentazione in basoli. Nel
locale del forno,del tipo con vano per il fumo e apertura ad arco, un'immagine dipinta di Vesta
seduta, oramai del tutto scomparsa, aveva funzione protettiva per l'intero edificio.
In (n) muretti di sostegno per tavoli, recipienti per l'acqua, un dolio interrato per metà, un'anfora
~ 53 ~
murata in un poggiolo, incassi per le mensole su cui venivano appoggiati i pani e il varco di
comunicazione diretta con il forno confermano la destinazione d'uso dell'ambiente come laboratorio
per la preparazione del pane.
L'ampio ambiente (p) era invece usato come magazzino per la conservazione delle scorte.
Particolare interessante, nell'ambiente ad O, adiacente al forno, era presente un' ulteriore forno in
laterizi, appartenente alla domus del civico 51 utilizzata probabilmente per la produzione domestica
del pane.
Pochi resti di decorazione pittorica rimangono sulle colonne del peristilio; nell'ultimo periodo le
pareti furono rivestite in semplice intonaco o cocciopesto.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum per la vendita all'ingrosso (?)
Osservazioni
La primitiva identificazione dell'edificio, attribuiva al proprietario il nome di Proculus (sostenitore
di Frontone) del quale si era letto il nome nell'iscrizione elettorale “Procule Frontoni tuo officium
commoda” a sinistra dell'ingresso del panificio, tuttavia PPM tende a preferire T.Terentius Neo il cui
nome compare nell'atrio dell'abitazione contigua,dove si è ben conservato un ritratto del panettiere e
della moglie, ora al Museo Archeologica di Napoli.
E' stata effettuata l'ipotesi che i due fossero fratelli, costruita sull'induzione che l'iscrizione
“Studiosus et Pistor” letta nella vicina casa di M. Lucretius in IX,3,5, si riferisca ad essi,
indicandone la condizione sociale invece dei nomi.
Pompei Informatica attribuisce la proprietà a M. Terentius Proculus, mentre in Eschebach viene
dato come padrone T. Terentius Proculus.
Data l'assenza di botteghe per la vendita al dettaglio, è stata avanzata in PPM l'ipotesi che essa si
svolgesse nel panificio IX,3,10-12 appartenente ad un Proculus.
La Torre, Mayeske ed Eschebach confermano invece la presenza di punti di vendita, situati in
VII,2,1.2.4.5.7, ma non danno per certa una correlazione tra questi ed il pistrinum.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.254 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAIURI 1942, pp.168-170
~ 55 ~
Pistrinum/pistrinum dulciarium (?) di Popidio Prisco
impianto produttivo con forno e macine connesso ad abitazione con atrio e peristilio.
Impianto e Strutture
Il panificio o pasticceria (?), collocato all'angolo NO dell'insula, era accessibile dall'ingresso al
civico n.22, lungo Vicolo Storto e, attraverso una porta all'estremità orientale dell'edificio, era
connesso con l'abitazione al n.20 su Vicolo del Panettiere,denominata Casa di N. Popidius Priscus.
Entrando nell'edificio,sono visibili le quattro grandi macine in pietra lavica poste nel cortile
lastricato in basoli e il forno (a) adiacente al deposito (d), comunicante con il laboratorio
(e),provvisto di una macchina impastatrice e utilizzato per la preparazione del pane. Il forno,
caratterizzato nella facciata da un grande arco in mattoni che raggiunge il pavimento, era fornito di
un ampio spazio di lavoro lungo l'apertura della camera di cottura e di un passaggio connesso al
deposito (d) utile per spostare i pani direttamente dal forno al magazzino.
Nel piccolo atrio ad E si trovava la vasca per il lavaggio delle granaglie e sotto il portico orientale la
scala conducente ad una terrazza sulla quale venivano fate asciugare le stesse. In questo ambiente
erano inoltre situate la latrina (f) e la porta verso la casa di Popidio Prisco. Non è definito l'uso al
quale era adibita la cella (b).
L'impianto era privo di una bottega per la vendita al dettaglio e lo smercio doveva avvenire
all'ingrosso o grazie ad una schiera di venditori ambulanti.
L'edificio subì varie trasformazioni dall'impianto originario, soprattutto per quanto riguarda le
aperture verso il Vicolo del Panettiere, poi parzialmente chiuse per ottenere delle ampie finestre nei
laboratori e nella cella (b), inizialmente fornita di apertura lungo il Vicolo Storto.
Le pareti dell'edificio presentavano semplici rivestimenti in intonaco rustico o cocciopesto.
Datazione: ?
~ 56 ~
Tipologia
Pistrinum/ pistrinum dulciarium (?) per la vendita all'ingrosso o tramite venditori ambulanti.
Osservazioni
Eschebach attribuisce l'edificio a M. Fabius Lalus, definendolo inoltre come pistrinum dulciarium;
gli stessi dati sono presenti anche in Pompei Informatica, dove tuttavia viene ricordata anche
l'attribuzione a N. Popidius Priscus. Diversamente, PPM, Mayeske e Cantarella considerano
l'impianto uno stabilimento per la panificazione, senza riferimenti alla produzione di dolci.
In base alle dimensioni del forno e alla presenza delle macine è tuttavia molto più plausibile che
uno stabilimento con queste caratteristiche fosse destinato alla panificazione e non alla produzione
di dolci, ma è comunque doveroso riportare entrambe le ipotesi.
Bibliografia
CANTARELLA-JACOBELLI 2003, p.104
COARELLI 2002, pp.138-140
ESCHEBACH 1993, p.259 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp. 114-115
Pompei Informatica, p.145
PPM, VI, p.659 e pianta.
VII,12,1-2.37
~ 57 ~
Pistrinum di Donatus
Impianto produttivo con forno e bottega.
Impianto e Strutture
L'edificio, situato all'angolo NO dell'insula, definita “Insula dei pistores”, è provvisto di due
accessi, al n.1 su Via degli Augustali e al n.37 su Vicolo di Eumachia, e di un'apertura interna che
comunica con la bottega al n.2. La proprietà dell'edificio viene attribuita a un certo Donatus, a causa
di un'iscrizione sulla parete esterna della bottega “Donatus rog(at)”.
Nell'impianto sono visibili unicamente i resti di un forno in laterizi del tipo con vano per il fumo,
posto all'estremità meridionale del panificio, addossato alla parete O.
In una fase precedente a quella documentata nel 79 d.C., il panificio era connesso all'abitazione al
n.3 e alla bottega al n. 4 tramite una porta aperta nel vestibolo della domus, quest'ultima in
connessione anche con l'ambiente contenente il forno dell'edificio n.7 tramite un largo passaggio
nella parete di fondo dei vani orientali dell'abitazione.
Datazione: ?
Tipologia
pistrinum con bottega per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
Mayeske definisce l'edificio come pistrinum dulciarium, dato non confermato dal resto della
bibliografia.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.325 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
~ 59 ~
VII,12,7
Pistrinum dulciarium
Piccolo impianto produttivo con bottega.
Impianto e Strutture
L'edificio,con ampio ingresso al n.7 lungo Via degli Augustali, presenta nella sua parte anteriore la
bottega (a) con triclinio retrostante (b). Il forno (f) preceduto da un podio in muratura, in un'area
scoperta nella parte posteriore dell'impianto, è l'unica struttura che permette di definire l'edificio
come pistrinum, assieme ad una piccola vasca per la raccolta dell'acqua. L'ambiente (d) doveva
fungere da laboratorio mentre la funzione d'uso dei vani (c) ed (e) non è definita.
Tramite una larga apertura nella parete O dell'area scoperta, successivamente tompagnata, era
possibile accedere alla domus al n.3.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum dulciarium con bottega per la vendita al dettaglio.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.326 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, p.121
Pompei Informatica, p.157
PPM, VII, p.484 e pianta.
~ 60 ~
VII,12,11
Pistrinum
Panificio con forno e bottega.
Impianto e Strutture
L'ingresso che da Via degli Augustali introduce all'edificio, conduce alla bottega (a) dalla quale
partiva la scala per l'abitazione al piano superiore. Dalla bottega si poteva accedere al magazzino
(b) in cui erano conservati i prodotti per la vendita e da qui al vano (k), anch'esso un piccolo
deposito, aperto verso parte posteriore della casa. Il corridoio (c) conduceva all'area di lavoro,
separata dalla zona di vendita tramite una porta, dove in origine erano installate delle macine,
successivamente rimosse prima ancora della distruzione della città.
Un piccolo vano disposto presso l'uscita posteriore di (k) era forse utilizzato come stalla, ma tale
funzione non è certa, viste anche le ridotte dimensioni dell'ambiente.
Il forno in laterizi, del tipo con camera per il fumo e grande apertura ad arco, è situato nella parte
retrostante dell'edificio, in un'area scoperta. L'ambiente (g) era usato probabilmente come deposito
dei pani cotti o come laboratorio.
Analogie/Confronti
L'edificio presenta analogie nella disposizione degli ambienti con il pistrinum VII,12,13; la zona
bottega presenta similitudini con tutte le botteghe di quest'insula che si affacciano su Via degli
Augustali.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum con bottega per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
~ 61 ~
Mayeske definisce l'edificio come pistrinum dulciarium, tuttavia nessun'altra indicazione di questo
tipo è presente nel resto della bibliografia.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.327 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp.122-123
Pompei Informatica, p.157
PPM, VII, p.488 e pianta.
VII,12,13
~ 62 ~
Pistrinum di Sabinus
Impianto produttivo con forno e bottega.
Impianto e Strutture
L'edificio, con ingresso lungo Via degli Augustali, presenta nella parte anteriore della bottega la
stessa struttura di quelle vicine che si aprono su questa via, costituita da un primo ambiente (a)
dotato di ampia apertura verso la strada,tipica delle botteghe,con grandi stipiti in blocchi di tufo
messi in opera a secco e di un triclinio (b) di piccole dimensioni e destinato probabilmente ai
clienti.
Ad E del triclinio uno stretto corridoio,con sostegni per tavoli di legno, conduceva agli ambienti
nella parte posteriore dell'edificio,scoperta, dove era collocato il forno con struttura ad alveare,
addossato all'angolo SE dell'edificio; l'ambiente (e) a destra del forno era probabilmente usato per la
preparazione dei pani. Non è attestata la presenza di molae per la macinazione del grano.
Nell'angolo NE dell'ambiente (d), una semicolonna in laterizi adiacente alla parete, conteneva
all'interno una tubatura in terracotta, di funzione non ben definita.
L'attribuzione di questo impianto a Sabinus deriva dalla presenza dell'iscrizione “Sabinus cupit”
sulla parete sinistra dell'ingresso.
Analogie/Confronti
L'edificio presenta analogie nella disposizione degli ambienti con il pistrinum VII,12,11; la zona
bottega presenta similitudini con tutte le botteghe di quest'insula che si affacciano su Via degli
Augustali.
Datazione: ?
Tipologia
~ 63 ~
Pistrinum con bottega per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
Mayeske definisce l'impianto come pistrinum dulciarium; il resto della bibliografia risulta tuttavia
concorde nel classificare tale edificio come stabilimento per la produzione del pane e non di dolci.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.328 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp. 123-124
Pompei Informatica, p. 157
PPM, VII, p.494 e pianta.
~ 64 ~
VII,14,9
Casa con pistrinum domestico
Abitazione ad atrio tuscanico e peristilio con piccolo panificio incorporato.
Impianto e strutture
La casa, con ingresso al n.9 lungo Via dell'Abbondanza, deriva nella sua forma definitiva
dall'ampliamento verso E di un originario nucleo edilizio organizzato attorno all'atrio (2) con i
cubicoli ai lati. Una delle trasformazioni che subì la casa coinvolse il piccolo pistrinum posto
all'estremità NO dell'edificio, negli ambienti (20) e (21), ora non più visibile poiché sostituito
totalmente o per la maggior parte dall'inserimento degli ambienti termali (18) e (19) in cui per altro
erano in corso dei lavori al momento dell'eruzione che distrusse la città.
Del panificio non rimangono che il catillus di una macina, davanti ad una vasca addossata all'arco
di scarico in laterizi del calidarium (19) e la bocca del forno in blocchi di lava.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum domestico.
Bibliografia:
PPM, VII, pp.686-697 e pianta.
~ 65 ~
VII,16,6.9
Pistrinum
Piccolo impianto produttivo con forno e macine. Privo di bottega (?).
Impianto e Strutture
L'edificio è situato nella parte SE dell'insula, con doppio ingresso al n.6 lungo Via Marina, a poca
distanza da Porta Marina, e al n. 9 lungo il vicolo settentrionale.
L'impianto, di piccole dimensioni, è fornito di due macine poste su pavimentazione in basoli
nell'ambiente (1) accessibile dall'ingresso n.6, e di un forno in laterizi (2) con la bocca rivolta ad E
verso l'ingresso n.9. Il vano (3) era forse usato come laboratorio o come deposito. Non è certo se
l'ambiente (1) aperto sulla strada al n. 9 potesse avere funzione di bottega, anche se la ristrettezza
dello spazio che separa questo vano dal forno (2), sembrerebbe escludere l'ipotesi.
É da ricordare che l'ambiente 6 non viene menzionato nella bibliografia come appartenente al
pistrinum, ma a seguito di una personale indagine in loco è risultata evidente la connessione.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum per la vendita all'ingrosso (?).
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.347 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
Pompei Informatica, p.160
PPM, VI, pianta.
~ 66 ~
VIII,4,26-29
Pistrinum e abitazione di Felix
Panificio con annessa abitazione a peristilio e botteghe.
Impianto e Strutture
L'edificio occupa l'angolo SE dell'insula e si compone di due nuclei distinti, il panificio, con
ingresso al n.27 lungo Via Stabiana, e il settore abitativo con ingresso al n.29 che si affaccia su Via
del tempio di Iside.
L'impianto originario dell'edificio risale al II sec a.C., come indicano le murature in opera a telaio
con l'utilizzo di blocchi di calcare del Sarno e i capitelli cubici di tufo di Nocera, rimasti inseriti
nella facciata.
L'attribuzione dell'edificio a Felix deriva dalla presenza dell'iscrizione “Felix rog(at)” sulla parete
esterna, a sinistra dell'ingresso al n.27. Ai lati di quest'ultimo si trovavano la stalla (a) e la bottega
(r) accessibile anche dalla strada e comunicante attraverso due aperture con il panificio (b) dove
erano situate le tre macine in lava su basi in muratura e il forno del tipo con vano per il fumo e
grande facciata ad arco che raggiunge il pavimento. La camera di cottura era fornita esternamente di
un piano d'appoggio e al di sopra dell'apertura del forno era collocata una raffigurazione fallica.
Verso (b) si aprivano gli ambienti (d) ed (e), probabilmente usati come magazzini, e collegati alla
bottega (p) accessibile dalla strada al n.28.Il locale (c) adiacente al forno doveva servire come
laboratorio per la produzione e la lievitazione dell'impasto. L'ambiente (f) fungeva da androne per la
zona abitativa, a cui si accedeva tramite il vestibolo (g), ai lati del quale si aprivano i cubicoli (h) ed
(i). Il peristilio (k) dava accesso al viridarium (l) con triclinio (m), cella penaria (n) e l'uscita (o)
corrispondente al n.29 di fronte al Tempio di Iside.
~ 67 ~
Analogie/Confronti
Il forno di questo impianto presenta analogie con quello installato nel pistrinum di Popidio Prisco al
VII,2,22; entrambi sono del tipo con camera per il fumo,caratterizzati da una facciata ad ampio arco
che raggiunge il pavimento e piano d'appoggio in corrispondenza della camera di cottura, connessa
al laboratorio di preparazione dei pani tramite un'apertura laterale.
Datazione
Impianto abitativo originario di II sec a.C., come testimoniano le murature in opera a telaio di
calcare del Sarno, nel quale, in un periodo non identificato, venne installato un panificio.
Tipologia
Pistrinum e abitazione con botteghe per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
Sulla parete esterna, accanto all'ingresso n.29 era dipinto il programma elettorale per l'edile Cn.
Helvius Sabinus, sostenuto da tutti gli Isiaci.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.375 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp.124-125
Pompei Informatica, p.164
PPM, VIII, p.528 e pianta.
~ 68 ~
VIII,6,1.8-10
Pistrinum con abitazione di P. Emilius Gallicus
Casa ad atrio e peristilio trasformata in panificio.
Impianto e Strutture
L'edificio occupa la parte occidentale dell'insula e conserva l'impianto regolare di una casa ad atrio
e peristilio, modificata per ospitare nella parte meridionale uno stabilimento di panificazione.
L'attribuzione dell'impianto a P. Emilius Gallicus deriva dal ritrovamento, nell'area settenrionale
dell'abitazione, di un frammento in bronzo rettangolare con inciso “P. AEMILI.GALLICI.”.
Il panificio si pare a S sul Vicolo dei Teatri con l'ingresso n.1 e ad O con il civico 10 sul Vicolo dei
Dodici Dei. Dal vestibolo (1) si accede all'atrio (a) dove furono impiantate le quattro grandi macine
in lava su basi in muratura, sostituendo il pavimento con un selciato e lastre di basalto attorno alle
macine. Lungo le pareti N e O dell'ambiente, tavoli da lavoro erano poggiati su sostegni o infissi nel
muro come testimoniano i fori di alloggiamento. Il forno, del tipo con camera per il fumo e grande
facciata ad arco, era addossato alla parete orientale, seguito verso N da (e) in cui erano collocate
altre due macine con grossi mortai in pietra con i bolli di C. Petronius Saturninus.
In (f), accessibile anche dalla strada al n.10, si trovava la scala per il piano superiore e una latrina;
l'uso di questo ambiente,come pure di (c), non è specificato, ma di certo legato all'attività del
panificio, forse come magazzino. La vendita del pane doveva invece avvenire in (b), dove erano
presenti scansie alle pareti.
La cucina (g) era fornita di un bancone di focolare sulla parete S e di un fusorium nell'angolo NO.
L'ambiente (k),che nell'impianto originario corrispondeva al tablino, conduceva alla zona
residenziale, organizzata intorno al peristilio (h) e accessibile dalla strada attraverso l'ingresso n.9
sul Vicolo dei Dodici Dei. La parte centrale del peristilio non era adibita a viridarium, ma
pavimentata in cocciopesto con un tappeto di lastre di marmo e fungeva da atrio sul quale si
aprivano i triclini (p) ed (r) , i cubicoli (m), (n), (s) e (t); gli ambienti sul lato N si trovavano ad una
~ 69 ~
quota leggermente più alta del peristilio ed erano probabilmente in rifacimento vista l'assenza di
decorazione dipinta. I locali (i) ed (o) erano forse usati come apoteche, mentre in (l) era una scala
per accedere al piano superiore.
Dal civico 8 si accedeva a degli ambienti sotterranei usati come cantina o granaio, accessibili anche
da una scala all'angolo NO dell'edificio; su questi sotterranei erano sprofondati gli ambienti (q)
dell'angolo NE dell'edificio, di uso non definito.
E' possibile che i sotterranei attingessero luce attraverso la casa e ciò farebbe presupporre una stretta
relazione di proprietà tra i due complessi.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum con bottega per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
A destra dell'ingresso al n.9, sulla parte superiore di un pilastro rivestito di marmi, era presente un
larario dipinto.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.386 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, p.126
Pompei Informatica, p.167
PPM, VIII, p.664-665 e pianta.
IX,1,3.33
~ 70 ~
Pistrinum
Impianto produttivo con forno, macine e bottega.
Impianto e Strutture
L'edificio, situato all'angolo O dell'insula, presenta due ingressi, il principale, al n.3 si affaccia su
Via di Stabia e conduce alla zona di vendita; l'ingresso secondario, al n.33 si affaccia invece sul
Vicolo di Balbo e permette l'accesso diretto alla zona panificio.
Dall'ingresso al n.3 si accede all'ambiente (a), con bancone di vendita in opera cementizia
prospiciente la strada. All'interno di esso,addossati alla parete meridionale ed incapsulati in una
fodera in muratura, sporgono tre grandi dolia, dei quali solo due si sono conservati interamente.
Una parete in legno doveva separare questo ambiente da quello successivo, come sembra attestare
un frammento si soglia in pietra lavica, in cui compare il foro quadrato per il cardine, nell'angolo S.
Il locale (b) doveva servire come horreum per la conservazione dei cereali e a tale uso erano adibiti
i cinque dolia sporgenti da una soprafodera in muratura lungo la parete S, al di sopra dei quali 6 fori
rettangolari, disposti in due file, a regolari distanze, dovevano contenere i sostegni per due grandi
mensole lignee. Il pozzo (c), posto all'angolo NO di (b), costruito in blocchetti tufacei e pietre
calcaree, doveva servire sia il locale di vendita che il retrostante laboratorio di panificazione.
La presenza di un piano superiore, forse con funzione abitativa, è attestata dalla scala (d), ad E del
pozzo, formata da due gradini in pietra ai quali era fissata una gradinata lignea.
A N del magazzino (b), il locale (e), con un bancone quadrato in muratura nell'angolo SE e un altro
banco rettangolare con le medesime caratteristiche sulla parete O, doveva servire come ambiente-
cucina con piano di cottura e piano di lavoro, funzione ancor meglio spiegabile con la vicina riserva
d'acqua del pozzo (c).La parete O, di confine all'ambiente (b) della bottega al n.2, presenta un'ampia
finestra circolare tompagnata, segno che in una fase anteriore questa era un'area a cielo aperto,
~ 71 ~
mentre una grande apertura nel muro orientale permetteva l'accesso diretto al vano (g).
Il pistrinum vero e proprio era situato ad E del magazzino, nell'ambiente (f) di grandi dimensioni,
che si prolungava poi in un corridoio in diretta comunicazione con il forno (k); il locale era
caratterizzato dalla presenza di tre macine in pietra lavica su pavimentazione in basoli, di cui solo
due hanno conservato la base circolare in muratura; sul lato settentrionale, presso l'ingresso al
laboratorio (g), si apriva un pozzo quadrangolare interamente intonacato, con accanto una bocca di
cisterna di forma circolare in pietra lavica. Che (g) fosse utilizzato come laboratorio per la
confezione dei pani è confermato dalla presenza di un lungo bancone in muratura che correva lungo
le pareti E e S e dal rinvenimento di una madia lignea con resti di farina carbonizzata; il locale, oltre
all'ingresso S, comunicante con la zona mulino, si apriva anche ad O verso la cucina (e) e ad E
verso il forno (k); quest'ultimo è caratterizzato da un'ampia facciata ad arco che raggiunge il
pavimento, bocca rettangolare in pietra lavica ed un insolito ampio vano sottostante la camera di
cottura, probabilmente usato per il deposito del combustibile.
Nel locale (k), oltre al forno, sono visibili sulla parete O, presso l'accesso al laboratorio (g), due
podii circolari in opera incerta su cui poggiano due vaschette in cotto con la funzione di lacus,
contenevano cioè l'acqua per raffreddare il rutabulum (pala in ferro) quando si era scaldata troppo o
per bagnarvi la scopa di saggina per spazzare il forno. A N, oltre al corridoio connesso all'ingresso
al n.33, un pilastro in blocchi calcarei divideva quest'ultimo da un parallelo ingresso più piccolo che
dava nella latrina. Affinché il fornaio non restasse allo scoperto durante il lavoro, fu costruita
davanti al forno una volta su due pilastrini in muratura, che formavano il prolungamento delle pareti
laterali della camera di cottura, alla cui sinistra un secondo muro parallelo formava il caminus con
copertura di tegole in alto, verso cui veniva convogliato il fumo.
Immediatamente alla destra del forno, l'ambiente (l) era probabilmente usato come secondo
ambiente di servizio per la panificazione, dove un finestrino rettangolare all'altezza della mensola
del forno, consentiva il passaggio dei pani dal laboratorio di confezione alla camera di cottura.
In (h), a S del forno, era invece situato lo stabulum, la stalla per il ricovero di uno o più quadrupedi
per il funzionamento delle macine del pistrinum (f), con un dolio nell'angolo SE, forse con funzione
di abbeveratoio per gli animali.
L'impianto, risalente al II sec. a.C. o ad epoca anteriore, come suggeriscono i pilastri in opera
quadrata, l'opera a telaio per le tramezzature interne degli ambienti più importanti e le tracce di
pavimenti in lavapesta, doveva, al momento della prima urbanizzazione interna dell'insula,
costituire un unico complesso, unitamente agli impianti 1 e 2 e alla piccola casa ad atrio al n.32, di
cui uno degli ingressi principali era quello sito al n.33. Si ignorano tuttavia quanti e quali siano stati
i mutamenti avvenuti tra questo periodo e l'eruzione dl 62 d.C., a seguito della quale i vari restauri
furono volti soltanto ad una rifunzionalizzazione degli ambienti dell'impianto, con poca o nulla
attenzione alla decorazione parietale.
~ 72 ~
Datazione
Impianto di II sec. a.C. o precedente con successive modifiche in periodi non definiti. Ultimi
restauri, post 62 d.C.
Tipologia
Pistrinum con bottega per la vendita al dettaglio.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.397 e p.495
GALLO 2001, pp.10-16 e 37-39.
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp.127-129
PPM, VIII, pianta.
IX,3,10-12
~ 73 ~
Panificio e taberna di T. Terentius Proculus
Pistrinum con taberna annessa.
Impianto e Strutture
L'edificio è situato all'angolo SO dell'insula ed è composto dalla taberna con ingressi ai n.ri 10 e 11,
il primo lungo Via di Stabia, il secondo su Via degli Augustali, e il panificio accessibile dal civico
12. L'impianto viene attribuito ai Terentii, in questo caso a T.Terentius Proculus, e lo si ritiene
collegato al panificio VII,2,3 situato dalla parte opposta di Via di Stabia e appartente a Terentius
Neo, tesi che deriva dalla presenza dell'iscrizione “Popidium aed(ilem) Proculus rog(at)” sulla
parete esterna tra gli ingressi 11 e 12.
La taberna, fornita di un bancone di vendita e di quattro grandi dolia infissi per terra, era collegata
al deposito (b), un tempo dotato di accesso alla strada. Un'apertura nella parete E della taberna
connetteva quest'ultima con il panificio, dotato di quattro grandi macine su basi in muratura e un
forno in laterizi.
Nella parete S del pistrinum, ai lati di una nicchia di larario, erano dipinte le dee Iside-Fortuna e
Luna o Semele sotto la cui protezione era posto l'edificio. Il forno, con vano per il fumo, grande
facciata ad arco che raggiungeva il pavimento e piano d'appoggio presso la bocca in pietra lavica,
era affiancato a N dal laboratorio (g), con i sostegni per le tavole da lavoro e le vasche per l'acqua e
ad O dalla stalla (e). Ad E di quest'ultima, un piccolo vano (f) era adibito a cucina.
Nella parte settentrionale dell'edificio si trovava il triclinio (k) con due ampie finestre verso il
viridarium (i).
Resti di decorazione di III stile, con semplice zoccolo rosso e ampie superfici bianche concluse da
una cornice in stucco sono visibili nel triclinio, mentre gli ambienti di lavoro presentano un
rivestimento in intonaco grezzo.
Sul pilastro di sostegno della tettoia davanti al forno, era presente un secondo larario dipinto,
raffigurante il Genius familiaris con patera e cornucopia davanti all'altare con le offerte su di una
~ 74 ~
faccia, e una figura femminile con cornucopia, al timone di una nave avanzante a vele spiegate
sull'altra.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum con taberna attrezzata anche per la vendita al dettaglio dei pani.
Osservazioni
Fino al 1920 l'impianto era attribuito a Paquius Proculus, successivamente convertito in T.Terentius
Proculus; entrambi i nomi vengono riportati dalla bibliografia, con l'eccezione di Mayeske che non
ne fa alcun cenno.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.415 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp.130-131
Pompei Informatica, p.172
PPM, IX, pp.316-317 e pianta.
IX,3,19-20
~ 75 ~
Casa e panificio/pasticceria di Papirius Sabinus
Panificio e panetteria con abitazione al piano superiore.
Impianto e Strutture
La casa, situata all'angolo orientale dell'insula, è attribuita a Papirius Sabinus per la presenza sulla
scala di accesso al piano superiore del graffito “Hic domus Papiriu Sabinum”, anche se
probabilmente i gestori e i lavoranti furono altri, forse identificabili tra coloro che hanno lasciato i
loro nomi nei messaggi elettorali presenti sulla facciata S, a destra e a sinistra dell'ingresso al civico
19, tra i quali si ricordano Pyramus,Olympionica,Calvus,Statia,Petronia.
L'edificio si compone di due nuclei principali, comunicanti tra loro: la bottega/taberna con ingresso
al n.19 e il pistrinum/pistrinum dulciarium accessibile dal civico 20.
L'abitazione si distribuiva prevalentemente al piano superiore, in quanto gli ambienti di
intrattenimento al piano terra, strettamente connessi, sia nella dislocazione che nella decorazione,
all'attività svolta nella panetteria, sono stati classificati come ambienti adibiti alla ristorazione e
aperti al pubblico della bottega, meglio identificabile quindi come taberna. Quest'ultima si apre
sulla strada con l'ambiente (a), adibito alla vendita, fornito di un poggiolo per un mortaio e scala
d'accesso al piano superiore, sotto la quale era collocata una dispensa con scansie al muro. Da qui si
accedeva al triclinio (b), con piccole finestre che fornivano luce naturale e decorato con pannelli di
vignette di figure femminili volanti. Ad O di (a) erano presenti un secondo triclinio (c) e lo oecus
(e) aperto con finestre verso il cortile con le macine del pistrinum vero e proprio e verso (c).
Accedendo al panificio dall'ingresso 20, il primo locale in cui si entrava era l'ambiente (a) con le 4
macine in pietra lavica e il pavimento in basoli e sostegni per tavoli da lavoro sulle pareti O e S,
comunicante con (f) forse usato come deposito.
Il forno (b), con vano per il fumo e facciata ad arco, era affiancato ad E dalla stalla (c) e ad O dal
laboratorio per la panificazione (d), connesso comunicante con la cella (e) fornita di due vasche
foderate in piombo nelle quali si conservava l'acqua. (g) era la cella del panettiere, cui seguivano
~ 76 ~
due cortiletti scoperti (h) e (k) utilizzati per il lavaggio del grano, seguiti dal viridarium (i) sul quale
si apriva una seconda cella (l) con la scala per il piano superiore, sulla cui parete era infisso un disco
di marmo raffigurante una maschera tragica con funzione apotropaica.
Dal sottoscala fuoriusciva il getto di una fontana che cadeva in un mortaio di marmo e poi in un
canale collegato con una cisterna o una conduttura si scarico sotterranee.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum con bottega per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
Il complesso presenta decorazioni pittoriche interessanti; nell'oecus (e) è inserito in un contesto di
III stile un quadro con la rara rappresentazione di Cerere, Demetra e Trittolemo, mentre nel
viridarium un larario dipinto raffigura il Sarno.
Mayeske non menziona la funzione di panetteria per l'impianto, presente invece sia in Eschebach
che in Pompei Informatica; concorda però con Pompei Informatica nel ricordare che l'edificio viene
in alcuni casi attribuito a T.Genialis, oltre ai nomi già citati.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.418 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp.131-134
Pompei Informatica, p.172
PPM, IX, pp.348-349 e pianta.
~ 77 ~
IX,5,4
Pistrinum
Impianto produttivo con forno, macine e bottega.
Impianto e Strutture
L'edificio, a pianta di forma rettangolare molto allungata, è situato nella parte occidentale
dell'insula, con ingresso al n.4 su Via di Nola, e si sviluppa in profondità con una serie di ambienti
comunicanti.
Il primo ambiente cui si accede dalla strada è la bottega (a), dove avveniva la vendita dei pani e
probabilmente anche della farina; dalla bottega si passa alla zona mulino (b) con le quattro grandi
macine in pietra lavica circondate da pavimentazione in lastre di basalto. Al momento dello scavo
tuttavia, una sola delle macine è stata rinvenuta intera e al suo posto e poteva quindi essere
funzionante al momento dell'eruzione del Vesuvio, elemento che potrebbe far pensare ad un calo
nella richiesta di prodotto, cosa che però appare improbabile visto lo sviluppo che l'attività di
panificazione ebbe nell'ultimo periodo di vita della città, soprattutto dopo il terremoto del 62 d.C.
(c) doveva essere utilizzato come deposito del grano mentre in (d) era il laboratorio, connesso
direttamente alla camera di cottura del forno tramite una piccola apertura; da notare in (d) la
presenza di un pozzo o di una bocca di cisterna in pietra lavica di forma circolare.
Dalla zona con le macine, uno stretto corridoio conduceva ad (e), di uso non ben definito, con un
dolio infisso in una base in muratura nell'angolo NO. Da qui si accedeva al forno (f) in laterizi,con
bocca quadrata formata da tre blocchi di lava, di fronte al quale stava una vaschetta usata come
acquaio.
In (g) era probabilmente un altro locale di lavoro, l'ambiente (h) poteva servire come stabulum per
gli animali che azionavano le macine, oppure come cortile per far asciugare le granaglie.
Il complesso era dotato di un secondo piano, del quale sono stati rinvenuti i frammenti di
pavimentazione in cocciopesto, conservatisi insieme ai crolli delle volte sui quali poggiavano.
L'edificio presenta paramenti in opera cementizia con rivestimenti in opus incertum, che permettono
~ 78 ~
di datare l'impianto al II-I sec. a.C..
Datazione
Impianto originario di II-I a.C.
Tipologia
Pistrinum con bottega per la vendita al dettaglio.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.422 e p.495
LA TORRE 1988, p.97
MAYESKE 1972, pp.134-136
Pompei Informatica, p.174
PPM, IX, p.400 e pianta.
~ 79 ~
IX,12,6-8
Pistrinum (di C. Julius Polybius?)
Impianto produttivo con forno,macine e
bottega.
Impianto e Strutture
L'edificio è situato all'angolo SE dell'insula,
ancora oggi solo parzialmente scavata, e si
affaccia direttamente su Via
dell'Abbondanza. L'ingresso principale della
casa è quello al n.6, dal quale si penetrava in
un vestibolo quadrangolare (a), fornito di
una scala lignea conducente al piano
superiore, di cui è ben visibile il segno
dell'intonaco sulla parete E, e di un andito posto sulla stessa parete che connetteva al vano
successivo (b), decorato con pitture in IV stile e con alcuni disegnini graffiti. Ad E di (b), con esso
non comunicante, era la bottega (d), aperta su Via dell'Abbondanza con l'ingresso n.7, e fornita di
un retrobottega (e) con finestra sulla parete meridionale e di un piano superiore a cui si accedeva
tramite una scala collocata lungo la parete E di (d). Procedendo verso N dal vestibolo (a), si
accedeva all'ambiente centrale dell'impianto, il locale (f) con il forno e le macine, che fungeva da
atrio, raccordando tra loro i vari ambienti dell'edificio.
Il forno in laterizi, di grandi dimensioni, era inserito in una struttura in opera incerta, con dei
rifacimenti in laterizio puro lungo una marcata fenditura nello spigolo NE, causata da un evento
tellurico, forse il terremoto del 62 d.C.. Oltre alla camera di cottura, un avancorpo forniva una sorta
di camera di tiraggio per il fumo, dinanzi all'imboccatura a sistema trilitico in pietra lavica con
piano d'appoggio posto in comunicazione a S con un'apertura nel vano (g), una vasta sala
rettangolare adibita a laboratorio di panificazione con banconi lignei su sostegni in muratura.
L'ambiente prendeva luce da un'ampia finestra posta sulla parete meridionale, mentre sul versante
settentrionale era fornita di un ampio soppalco ligneo (pergula). La sala era decorata sulla parete
orientale da un quadretto dipinto raffigurante Venere nuda intenta a sollevarsi e raccogliersi i capelli
dietro la nuca con la mano destra, mentre un erote, in basso a destra, le tiene sollevato lo specchio
nel quale si mira; sulla parete O era presente un altro quadretto, ora non più leggibile.
~ 80 ~
Sulla parete N, la già citata apertura,si collegava mediante un piano in pendenza in lastroni di
terracotta alla bocca del forno, utilizzata evidentemente per il passaggio dei pani che dovevano
essere infornati e non per quelli già cotti e ritratti dal forno, come indica la pendenza a scendere tra
finestrella e bocca del forno.
Nella parte O di (g) furono ritrovati inoltre gli scheletri di due equidi,probabilmente impiegati per la
rotazione delle macine, qui rifugiatisi al momento dell'eruzione e rimasti schiacciati dai travi delle
strutture superiori precipitati.
In (f), oltre al forno, furono rinvenute quattro macine per il grano, delle quali solo una recava il
catillus inserito al di sopra della meta, mentre altri due catilli risultarono impiegati dinanzi al forno
come contenitori per l'impasto della calce, utilizzata nei lavori di ristrutturazione che si stava
evidentemente effettuando al momento dell'eruzione.
Da (f) si poteva accedere ad E al vano (c), di uso non ben definito, e al giardinetto pensile (h),
impostato ad una quota di circa due metri superiore al piano di Via dell'Abbondanza, con canalette a
quote sfalsate per la raccolta delle acque e un'edicoletta con decorazione in IV stile ben conservata
nell'angolo SO. Sulla parete O, uno strato di intonaco rilevato rispetto a quello della restante parete,
presenta un dipinto con scena di apoteosi di Ercole al cospetto degli dei consentes, sovrastante due
serpenti agathodemoni, numi benefici. Sotto al dipinto stava un'arula in pietra e terracotta, con
segni di annerimento nel punto del muro in corrispondenza del piano sacrificale. Sulla stessa parete
era visibile il disegno preparatorio della scena del Genio familiare sacrificante tra due Lari e dei
serpenti sacri, in fase di preparazione al momento dello scavo.
Lungo il versante settentrionale dell'ambiente (f) erano accessibili altri ambienti;ad O la stalla (i),
(di destinazione diversa, in origine, data la presenza di resti di decorazione pittorica) dove sono stati
rinvenuti cospicui resti di foraggio carbonizzato lungo la parete N presso la quale era situata una
mangiatoia lignea, e una fossa per lo scorrimento dei liquami nell'angolo SE.
Il piccolo disimpegno (l),fornito di un focolare nell'angolo SO oltre che di una scala e accessibile da
(f), si raccordava ad E con il triclinio (m), a N con il cubicolo (n) e ad O con (o), forse anch'esso un
cubicolo.
Il triclinio (m) era decorato con scene di banchetto in III stile finale che al momento dell'eruzione
era in piena ristrutturazione e stava per essere integralmente rifatta; è valida l'ipotesi secondo la
quale quest'ambiente sarebbe stato adibito anche ad uso di locale di ristorazione per i clienti del
panificio.
Il cubicolo (n) presentava una decorazione a fondo bianco in un IV stile molto lineare, similmente
al cubicolo (o) anch'esso decorato in IV stile.
Comunicante attraverso uno stretto passaggio con il giardinetto (h), dove un muretto correva tutto
lungo il lato N, era la stalla (p), accessibile anche dal vicolo ad E dell'edificio dall'ingresso n.8; da
qui tramite una scala si accedeva al piano superiore connesso al vano al di sopra di (e) e quindi alla
~ 81 ~
bottega al n.7. Nella stalla compaiono i segni dell'abbeveratoio un tempo presente, ma eliminato già
prima dell'eruzione, e della mangiatoia, che contenevano l'acqua e il foraggio per gli equidi, di cui
sono stati qui rinvenuti i cinque scheletri perfettamente conservati, morti anch'essi al momento
dell'eruzione; salirebbe perciò a sette il numero totale degli animali appartenenti all'edificio, un
numero davvero notevole per la sola attività di molitura, soprattutto vista la ristrettezza dello spazio
contenente le macine, che avrebbe reso estremamente difficile l'azione contemporanea anche di soli
quattro animali. E' perciò ipotizzabile che la produzione fosse talmente sostenuta da richiedere un
alternarsi degli animali alle macine oppure che solo alcune delle bestie fossero utilizzate per la
molitura, mentre altre servissero per trasportare in gerle il pane nel contado.
Non ci sono ancora elementi validi che attestino definitivamente la proprietà dell'edificio, che viene
tuttavia associato all'abitazione di Giulio Polibio la cui casa è proprio ad E del panificio, separata da
esso soltanto da un vicolo, e che viene citato in alcune iscrizioni come “studiosus et pistor”
(CIL,iv,875) che “panem bonum fert” (CIL,iv,429 = ILS,6412) e come candidato sostenuto da
pistores.
Datazione: ?
Tipologia
Pistrinum con bottega per la vendita al dettaglio.
Osservazioni
I numerosi lavori di restauro, riscontrabili nell'abitazione al momento dell'eruzione, fanno ipotizzare
che al terremoto del 62 d.C., che provocò ingenti danni in tutta la città, siano succeduti altri eventi
sismici,sebbene di minor intensità, che renderebbero più plausibile l'insistente e contemporanea
presenza di ristrutturazioni un po' dovunque a Pompei,che a distanza di 17 anni dal 62 d.C.
,risulterebbero altrimenti non semplici da giustificare.
Bibliografia
ESCHEBACH 1993, p.448
PESANDO-GUIDOBALDI 2006, pp.241-242
VARONE 1989, pp.231-238.
~ 82 ~
5. Considerazioni di carattere generale
Come è possibile evincere dal catalogo dei singoli edifici, a Pompei sono attestati 32 stabilimenti70
,
tra pistrina e pistrina dulciaria, un numero attualmente non definitivo, ma che potrebbe accrescere
con nuove campagne di scavo e indagini esplorative.
Gli impianti erano per la maggior parte forniti di macine, stalla, magazzino e laboratorio e in molti
casi di un punto di vendita al dettaglio; da ciò si desume la completezza e l'autosufficienza di molti
dei pistrina pompeiani, nei quali si svolgevano tutte le operazioni, dalla macinazione del grano alla
vendita del prodotto finito. I proprietari e/o i gestori di questi impianti dovevano quindi disporre di
strutture, mezzi e manodopera tali da richiedere una notevole possibilità economica e organizzativa
che garantisse il completamento di tutte le fasi lavorative.71
5.1 Pistrina e Pistrina dulciaria
Una primo dato importante si ricava analizzando il tipo di alimento prodotto nei pistrina, se pane o
dolci; dei 32 stabilimenti analizzati, 21 sono panifici (65,6%), 5 sono pistrina dulciaria (15,6%) e 3
impianti si dedicavano alla produzione di entrambi i prodotti (9,4%). 3 pistrina (VI,11,8-10/
VII,1,46-47/ VII,14,9) erano invece collocati all'interno di grandi dimore e svolgevano una funzione
legata per lo più all'ambito domestico, con una produzione che generalmente non usciva dai confini
della domus (9,4%).
Con l'eccezione degli impianti misti pistrina/pistrina dulciaria, emerge inoltre come i pistrina per il
pane fossero nella maggior parte dei casi stabilimenti di maggiori dimensioni, per la quasi totalità
dei casi forniti di macine (in pochi casi rinvenute complete di metae e catilli), a differenza dei forni
per dolci, generalmente più piccoli e privi di molae.
5.1.1 Macine
Dei 27 panifici totali, compresi quelli domestici e gli impianti di doppia produzione, solo 4 (14,8%)
risultano sprovvisti di macine (3, e quindi l'11,1%, se si considera che in VII,12,11 furono rimosse
solo nell'ultima fase di vita del panificio) e dovevano quindi acquistare la farina già preparata. Per
quanto riguarda invece i pistrina dulciaria, escludendo gli impianti di doppia produzione, solo
VI,5,15 era fornito di un'area per la riduzione del grano a farina. É interessante notare come dei 24
impianti totali forniti di una zona per la molitura, undici di essi (45,8%) siano collocati in
70 Nelle bibliografie il numero di pistrina varia dai 30 ai 34 stabilimenti; tuttavia alcuni degli impianti citati non
possono essere definiti con certezza dei pistrina in quanto privi di qualsiasi struttura che li identifichi.
71 LA TORRE,1988, p.84
~ 83 ~
precedenti abitazioni, nell'atrium o più comunemente nel viridarium. Ciò era strettamente collegato
alla disponibilità spaziale, chiaramente maggiore nelle domus.
Il numero di macine presenti in un pistrinum era legato alla quantità di farina necessaria per la
produzione, alla domanda di prodotto e ovviamente alla disponibilità economica del fornaio;
generalmente ritroviamo nei pistrina pompeiani tre o quattro macine, con situazioni in cui il numero
si abbassa a due, come in VI,5,15 e VII,6,6.9, o raggiunge le cinque unità (I,4,12-17 e VII,2,3). Non
tutte le macine venivano azionate contemporaneamente, anche perché ciò avrebbe richiesto un
numero di asini o cavalli eccessivo e probabilmente fuori dalla portata economica dei panettieri; è
più plausibile che le macine in funzione fossero circa la metà di quelle disponibili e venissero
attivate tutte solo in casi di grande necessità.
La presenza di equidi utili alla macinazione, comportava la necessità di uno spazio all'interno dei
pistrina in cui disporre la stalla per il ricovero di questi animali.
Osservando i dati emersi dal catalogo, si nota come su 24 pistrina provvisti di macine, in 16 di essi
(66,7 %) sia riconoscibile uno stabulum, mentre in 3 (12,5%) non è possibile determinarlo con
certezza. Nei 5 pistrina in cui non è stata identificata una stalla (20,8%), è comunque possibile che
uno spazio simile fosse ugualmente presente, in quanto tali ambienti non sono identificabili per la
presenza di strutture particolari, se non in alcuni casi per il rinvenimento di abbeveratoi in pietra o
resti di mangiatoie lignee, elementi non sempre reperibili.
Per quanto concerne la disposizione di questi locali all'interno della planimetria dei singoli pistrina,
appare evidente come gli stabula venissero collocati generalmente o in prossimità delle aree
contenenti le macine, come avviene in 10 (62,5%) dei 16 pistrina con stalla, oppure in locali
prossimi agli ingressi dei panifici (4 su 16, ovvero il 25%); Uniche due eccezioni sono il pistrinum
di Giulio Polibio IX,12,6-8 , in cui la stalla è posizionata in un locale esterno, accessibile da un
vicolo laterale, e IX,5,4 dove essa è collocata sul fondo dell'edificio e lontano dalle macine e
dall'ingresso.
5.1.2 Botteghe o punti di vendita
Elemento tra i più esplicativi nella struttura dei pistrina pompeiani è certamente la bottega o punto
di vendita; essa è generalmente di facile riconoscimento, in quanto caratterizzata nella maggior
parte dei casi da una lunga apertura sulla strada, spesso corrispondente all'ampiezza del negozio
stesso, con una soglia in travertino pietra lavica solcata da una lunga scanalatura centrale per
l'alloggiamento di una serranda lignea72
. Dall'analisi dei pistrina emerge come il punto di vendita
sia un ulteriore elemento di distinzione tra panifici e pasticcerie;14 su 27 (51,8%) pistrina per il
pane hanno una bottega annessa, circa la metà degli impianti, mentre per quanto riguarda i pistrina
72 CANTARELLA-JACOBELLI 2003 p.34
~ 84 ~
dulciaria, tre su cinque (60%) ne sono provvisti, e in due casi (40%) non ne è accertata la presenza
(VI,3,1-4.27.28 e VI,6,4-5).
Negli impianti privi di bottega lo smercio doveva avvenire all'ingrosso, o tramite venditori
ambulanti, che si appostavano con banchetti lungo le strade della città; è inoltre accertato che la
vendita del pane avveniva anche attraverso delle botteghe prive di forno, non connesse a panifici, di
cui le uniche due attualmente identificate nell'area urbana erano situate in VII,7,8 e VIII,4,14.
É interessante notare come gli impianti sprovvisti di macine siano invece in tutti i casi forniti di
punto di vendita.
5.1.3 I Forni
Come già riferito nel paragrafo riguardante le strutture dei pistrina, i forni pompeiani si presentano
sostanzialmente nel modello più complesso, costituito di una camera di cottura racchiusa all'interno
di un'ulteriore intercapedine, o camera per il fumo, per trattenere in maniera più efficace il calore e
aumentare il tiraggio. Tale tipologia di forno è diffusa in 28 dei pistrina dei Pompei (87,5%), con
ovvie variazioni per quanto riguarda le dimensioni e l'aspetto esteriore, mentre solo in quattro
stabilimenti, ovvero il 12,5%, (tre pistrina dulciaria :I,3,1/V,1,14-16/VI,6,4-5 ed il pistrinum
VII,12,13) sono presenti forni ad alveare del tipo più semplice, senza vano per il fumo.
5.1.4 Laboratori
In ogni pistrinum (con nessuna eccezione rispetto ai pistrina dulciaria) è stata rilevata la presenza
di uno o più locali usati per la produzione dell'impasto, la lievitazione e la suddivisione in pani: tali
ambienti, indicati come laboratori, erano caratterizzati unicamente dalla presenza di tavoli da lavoro
e in quattro casi, di una macchina impastatrice, che doveva tuttavia essere uno strumento molto più
diffuso di quanto non attestino i ritrovamenti archeologici (attualmente visibile solo in
I,3,27/VI,5,15/VI,6,17-21/VII,2,22).
Osservando i singoli panifici, si nota come nella totalità dei casi i laboratori fossero disposti in
prossimità del forno, con il quale erano spesso connessi attraverso delle aperture nelle pareti che
oltre a permettere il passaggio dei pani, creavano un ambiente caldo-umido necessario alla
lievitazione. Ad eccezione dei pistrina più piccoli, dove l'esiguità dello spazio rendeva la cosa
impossibile, solitamente nei panifici di medie e grandi dimensioni le stanze per la lavorazione dei
pani erano due, una utilizzata per la produzione della pasta e la seconda destinata alla lievitazione o
allo stazionamento dei pani in attesa di cottura.
~ 85 ~
5.1.5 Depositi e magazzini
Osservando i vari impianti risulta evidente come in ognuno di essi sia presente almeno un locale il
cui utilizzo doveva in qualche modo essere legato allo storaggio e al deposito del grano (horreum),
della farina e del prodotto finito. Essendo tuttavia uno spazio la cui funzione d'uso non richiedeva
strutture particolari, con l'eccezione di tavoli o mensole, non ci sono elementi, se si escludono gli
eventuali resti organici rinvenibili grazie alle indagini archeologiche, che permettono di individuare
chiaramente un deposito all'interno di un pistrinum.
Solitamente si identificano come depositi quegli ambienti che non sono attribuili ad altri precisi
utilizzi; nei pistrina di Pompei essi si presentano come locali di varie dimensioni, collocati in zone
diverse all'interno di ogni stabilimento, in alcuni casi in prossimità dell'area di macinazione.
Non si rilevano elementi di distinzione tra pistrina e pistrina dulciaria in relazione alla disposizione
o alla funzione dei magazzini; è certo, invece, che il deposito del grano avvenisse solo negli
stabilimenti provvisti di macine, in quanto gli impianti privi di strutture per la molitura dovevano
rifornirsi di farina già macinata.
In alcuni stabilimenti il deposito o uno di essi era situato a lato del forno, e comunicava con la
camera di cottura attraverso un'apertura nella parete del forno; in questo caso il fornaio poteva
spostare il pane cotto direttamente dall'interno del forno al deposito senza cambiare postazione,
velocizzando così il procedimento.
5.2 Distribuzione e collocazione nel quadro urbano
Se si rivolge l'attenzione alla distribuzione dei pistrina pompeiani sul territorio, si può notare come
essi si presentino collocati nel quadro urbano in maniera piuttosto omogenea, con stabilimenti
sparsi in quasi tutta la parte scavata della città. Ovviamente l'incompletezza degli scavi non
permette certo di avere dei dati assoluti, ma appare chiaro come la concentrazione degli impianti
aumenti man mano che da Porta Marina ci si sposta verso est, dove il pistrinum più orientale a
tutt'oggi noto è il panificio di C.Julius Polybius, ancora in fase di scavo.
Si nota un attestarsi dei forni in prevalenza lungo Via di Stabia, il principale asse viario N-S della
città, con una maggiore densità di panifici nelle insulae 1, 2 e 12 della Regio VII, subito ad est del
Macellum, mentre le aree più povere di attestazioni sono le insulae occidentali delle Regiones VII e
VIII, zone ad alto tasso residenziale e tutta la parte orientale della città.. Si deve tener conto
comunque che la vendita del pane non si limitava alle botteghe e alle rivendite fisse, ma poteva fare
affidamento su una schiera di venditori ambulanti che contribuivano a rendere reperibile il prodotto
in tutte le aree della città.
Risulta evidente dunque che la maggior parte dei pistrina si colloca lungo i percorsi di maggior
~ 86 ~
percorrenza, attraverso i quali, dalle aree a nord, il grano veniva portato in città73
negli unici due
horrea conosciuti e situati in VII, 7, 29 presso il Foro Civile e VII,15,2 sotto la Casa del Marinaio
nel Vicolo dei Soprastanti. Ciò non meraviglia in quanto la reperibilità delle materie prime, in
questo caso il grano, era un fattore di estrema importanza, sul quale si basava la possibilità o meno
di svolgere l'attività della panificazione.
I pistrina sprovvisti di macine, che dunque non provvedevano alla macinazione della propria farina,
appaiono concentrati nell'area centrale della città, soprattutto nella Regio VII,insula 12 (area per
definizione legata alla panificazione, in quanto denominata insula dei pistores) e in Via degli
Augustali, una delle vie maggiormente trafficate, sulla quale si affacciano ben sette impianti.
Essendo tutti questi pistrina forniti di un punto vendita, è logico che essi si dislocassero nelle aree a
più alta frequentazione, in cui aumentavano le possibilità di vendita.
Al contrario, sono gli stabilimenti privi di botteghe per la vendita al dettaglio quelli disposti più
lontano dalle vie principali, in modo così da facilitare l'affluire del grano senza congestionare delle
strade già fortemente trafficate. In queste zone più marginali e quindi dotate di maggiori spazi si
collocano anche gran parte dei pistrina dotati di macine.
Altro dato significativo relativo alla distribuzione dei pistrina riguarda l'approvvigionamento idrico.
L'acqua era fondamentale nella panificazione, necessaria innanzitutto al lavaggio del grano per
eliminare le impurità, ma soprattutto per la miscelazione della farina e la creazione della pasta;
l'acqua veniva raccolta in vasche o dolia, nei pressi dei forni dove serviva per il raffreddamento
della pala del furnacator e per la pulizia del piano di cottura e nei laboratori dove avveniva la
produzione degli impasti. Molte vasche si trovavano a cielo aperto per poter raccogliere e sfruttare
la pioggia, spesso risultanti dalla trasformazione degli impluvia, soprattutto nei pistrina installati in
precedenti case ad atrio con impluvium, ma in alcuni impianti troviamo resti di canalette in
terracotta che attestano la presenza saltuaria di sistemi idraulici privati anche nei pistrina; in
alternativa gli impianti potevano usufruire delle numerose fontane pubbliche sparse per la città.
Il fatto che molti dei pistrina fossero collocati nelle insulae ai lati di Via di Stabia indica
chiaramente una connessione con l'acqua. Questa via ricalca infatti un avvallamento naturale che
divide in due il costone lavico sul quale sorge Pompei e che costituì il confine naturale del primo
insediamento; l'avvallamento congiunge inoltre il punto più alto del pianoro, a Porta Vesuvio, e
quello più basso, a Porta di Stabia, costituendo un asse privilegiato per lo scorrimento delle acque74
.
L'acquedotto augusteo del Serino aveva infatti proprio fuori Porta Vesuvio il castellum tripartitore
da cui partivano le condotte principali che alimentavano case, fontane, edifici pubblici ed entravano
in città lungo Via dei Vettii e Via di Stabia.
73 LAURENCE 1996, pp.55-57
74 LA TORRE 1988, p.83
~ 87 ~
5.3 Lo sviluppo cronologico
Diversamente dall'analisi della distribuzione sul quadro urbano, la tematica dello sviluppo
cronologico dei pistrina pompeiani ci pone di fronte al serio problema della mancanza di
informazioni a riguardo.
Nelle varie bibliografie infatti, non è stato possibile ricavare dati certi relativi alla datazione di ogni
pistrinum, anzi si può osservare come solo nove edifici dei 32 analizzati (28,12%) presentino dati
riguardanti il momento della edificazione e della realizzazione dell'impianto.
Benché sia plausibile datare il primo manifestarsi di un'industria della panificazione nella città alla
tarda età sannitica, cioè al II sec a.C., come in tutto il resto del mondo romano, è difficile poter
definire come si sia evoluto lo scenario urbano.
Gli unici impianti che vengono datati a tale periodo sono i pistrina IX,1,3.33 e IX,5,4, entrambi
collocati tra il II e il I secolo a.C.; tra il I a.C. e il I d.C. è datata l'installazione del panificio VI,2,6,
il più occidentale della città.
Indiscutibili cambiamenti avvengono certamente nel I secolo d.C., a seguito del terremoto del 62
che causò ingenti danni per molti edifici. Tra le strutture più danneggiate era anche l'acquedotto, che
sulla Via di Stabia venne sostituito da condotte provvisorie; successivamente vennero costruite ex
novo le Terme Centrali, espropriando l'intera insula IX,4. Dopo il terremoto un gran numero di
impianti industriali si stabilirono lungo la via per godere dell'apparato idrico, tra cui molitssime
fullonicae che si installarono in vecchie case di abitazione restaurate ad hoc.
Stesso processo avvenne probabilmente per moltissimi pistrina; sono dodici gli impianti che
vennero installati in abitazioni rimaneggiate, sette delle quali collocate lungo l'asse di Via Stabiana.
Tuttavia di questi dodici forni, solo cinque vengono datati al post terremoto, ma non è inverosimile
ritenere che anche gli altri sette possano essersi stabiliti nel medesimo periodo.
Future indagini e ricerche, coadiuvate da nuovi scavi archeologici, potrebbero fornire ulteriori
informazioni che permettano di costruire un quadro più preciso e svelare nuovi aspetti della
panificazione a Pompei.
~ 88 ~
BIBLIOGRAFIA
AMPOLO 1993 = AMPOLO C., Pane antico: mulini, panettieri e città, in Nel nome del
Pane, LONGO O. - SCARPI P. (a cura di), Bolzano 1993, pp. 229-243.
AVVISATI 2007 = AVIISATI C., Pompei: mestieri e botteghe 2000 anni fa, Roma 2007.
BOSELLO 1993 = BOSELLO O., Il Pane: dalla mitologia alla clinica, in Nel nome del
Pane, LONGO O. - SCARPI P. (a cura di), Bolzano 1993, pp. 175-180.
BUFFONE 1999 = BUFFONE L. - LORENZONI S. - PALLARA M. - ZANETTIN E., Le
macine rotatorie in rocce vulcaniche di Pompei, in Rivista di studi pompeiani, X, 1999, pp.
117-130.
CANTARELLA-JACOBELLI 2003 = CANTARELLA E. - JACOBELLI L., Un giorno a
Pompei, Napoli 2003.
CERLETTI 1993 = CERLETTI P., Il Pane: una bio-storia ricca di bio-chimica, in Nel
nome del Pane, LONGO O. - SCARPI P. (a cura di), Bolzano 1993, pp. 123-132.
CIANCIO ROSSETTO 1973 = CIANCIO ROSSETTO P., Il sepolcro del fornaio Marco
Virgilio Eurisace a Porta Maggiore, Roma 1973.
CIPROTTI 1962 = CIPROTTI P., Pompei, Roma 1962.
COARELLI 2002, COARELLI F., Pompei, la vita ritrovata, Udine 2002.
DELLA CORTE 1965 = DELA CORTE M., Case ed abitanti di Pompei, Napoli 1965.
DOSI-SCHNELL 1986 = DOSI A. - SCHNELL F., La abitudini alimentari dei Romani,
Roma 1986.
EAA = AA.VV., Enciclopedia dell'Arte Antica classica e orientale, I-XVII, 1958-1997.
ESCHEBACH 1993 = ESCHEBACH L., Gebäudeverzeichnis und Stadtplan der antike
Stadt Pompeji, Köln 1993.
ETIENNE 1966 = ETIENNE R., La vie quotidienne a Pompéi, Paris 1966.
GALLO 2001 = GALLO A., Pompei.L'insula I della Regio IX, settore occidentale, Roma
2001.
LA TORRE 1988 = LA TORRE G. F., Gli impianti commerciali ed artigianali nel tessuto
urbano di Pompei, in AA.VV., Pompei. L'informatica al servizio di una città antica, Roma
1988, pp. 73-102.
~ 89 ~
LAURENCE 1996 = LAURENCE R., Roman Pompeii: space and society, London, New
York 1996.
LONGO-SCARPI 1993 = LONGO O. - SCARPI P. (a cura di), Nel nome del Pane, Bolzano
1993.
MAIURI 1942 = MAIURI A., L'ultima fase edilizia di Pompei, Roma 1942.
MAIURI 1953 = MAIURI A., Roman painting, Genova 1953.
MAIURI 1983 = MAIURI A., Pompei ed Ercolano fra case ed abitanti, Firenze 1983.
MAYESKE 1972 = MAYESKE B. J., Bakeries, bakers and bread at Pompeii: a study in
social and economic history, Diss.Un. Maryland, Michigan 1972.
MAU 1982 = MAU A., Pompeii its life and art, New York 1982.
MORITZ 1958 = MORITZ L.A., Grain-mills and Flour in classical antiquity, Oxford 1958.
MONTANARI 1993 = MONTANARI M., La cultura del Pane, fra Meditteraneo e
Mitteleuropa, in Nel nome del Pane, LONGO O. - SCARPI P., (a cura di), Bolzano, 1993
pp. 27-34.
PESANDO-GUIDOBALDI 2006 = PESANDO F. - GUIDOBALDI M. P., Pompei Oplontis
Ercolano Stabiae, Roma, Bari 2006.
Pompei Informatica = AA.VV.,Pompei. L'informatica al servizio di una città antica, Roma
1988.
PPM = AA.VV., Pompei: Pitture e Mosaici, I-IX, 1990-1999.
VARONE 1989 = VARONE A., Attività della soprintendenza, in Rivista di studi pompeiani,
III, 1989, pp. 231-238.
~ 90 ~
Apparato Iconografico75
75 Ove non indicato altrimenti, le immagini provengono dal sito web www. pompeiiinpictures.com.
~ 91 ~
Fig. 1 Uno degli 81 pani carbonizzati ritrovati all'interno del forno nel panificio di Modesto
VII,1,36-37. Si noti la forma circolare e la suddivisione in otto spicchi.
Fig. 2 Schema rappresentativo di una macina. Da MORITZ 1958, p.75, fig.8
~ 92 ~
Fig. 3 Disegno di macchina impastatrice. Da ETIENNE 1966, p.157, fig.10.
Fig. 4 Disegno di forno. Da ETIENNE 1966, p.159, fig.11.
~ 93 ~
Fig. 5 Fregio meridionale del sepolcro di M.Virgilio Eurisace. Da CIANCIO ROSSETTO1973,
tavola XXVI, 1.
Fig. 6 Fregio occidentale del sepolcro di M.Virgilio Eurisace. Da CIANCIO ROSSETTO 1973,
tavola XXVI, 2.
Fig. 7 Fregio settentrionale del sepolcro di M.Virgilio Eurisace. Da CIANCIO ROSSETTO 1973,
tavola XXVII, 1.
~ 96 ~
Fig. 11 I,3,27 Macchina impastatrice nell'angolo nord-est del laboratorio (d).
Fig. 12 I,3,27 Resti del forno.
~ 97 ~
Fig. 13 I,3,27 Muro ovest del laboratorio (d). E' visibile l'apertura che metteva in
comunicazione questo ambiente con la camera di cottura del forno.
I,4,12-17 e I,4,13-14 Complesso di pistrina di D. Junius Proculus
Fig. 14 I,4,13 Ambiente (a) con forno.
~ 99 ~
Fig. 17 I,4,12-17 Veduta parziale dell'ambiente (b) con il forno e resti di macine.
I,12,1-2 Pistrinum di Sotericus
Fig. 18 I,12,1-2 Macine nell'ambiente (17).
~ 100 ~
Fig. 19 Forno.
Fig. 20 I,12,1-2 Sostegni per tavoli da lavoro nel laboratorio (12). Sono visibili gli incassi
per le scaffalature sulla parete di sinistra.
~ 102 ~
Fig. 22 V,1,14-16 Atrium con impluvium, di cui è visibile il bordo modanato.
Fig. 23 V,1,14-16 Vasca per la raccolta dell'acqua nell'atrio.
~ 104 ~
V,3,8
Fig. 26 V,3,8 Atrio con impluvium e macine.
Fig. 27 V,3,8 Atrio con impluvium e macine, dietro alle quali si nota l'ingresso al tablino.
~ 106 ~
Fig. 30 V,3,8 Tablino. Resti di decorazione pavimentale.
Fig. 31 V,3,8 Pavimentazione in lastre basaltiche attorno alle macine.
~ 107 ~
V,4,1-2
Fig. 32 V,4,1-2 Macine lungo la parete orientale dell'ambiente (k).
Fig. 33 V,4,1-2 Forno.
~ 108 ~
Fig. 34 V,4,1-2 Laboratorio (P) a nord del forno.
Fig. 35 V,4,1-2 Apertura nel muro sud del laboratorio (P) in prossimità del forno.
Permetteva il passaggio dei pani direttamente dal laboratorio alla camera di cottura.
~ 109 ~
VI,2,6 Pistrinum di A. Cossius Libanus
Fig. 36 VI,2,6 Veduta d'insieme dell'ambiente (6) contenente le macine e il forno (7).
Fig. 37 VI,2,6 Forno.
~ 110 ~
Fig. 38 VI,2,6 Apertura sul lato destro del forno, comunicante con il piccolo
laboratorio.
Fig. 39 VI,2,6 Resti di una vaschetta per l'acqua presso il forno.
~ 111 ~
VI,3,1-4.27-28 Casa del Forno
Fig. 40 VI,3,1-4.27-28 Atrium tuscanico con impluvium (8).
Fig. 41 VI,3,1-4.27-28 Tablino (14).
~ 112 ~
Fig. 42 VI,3,1-4.27-28 Veduta da nord dell'ambiente (15) contenente le macine e il forno (17).
Fig. 42 VI,3,1-4.27-28 Macine su pavimento in basoli.
~ 113 ~
Fig. 43 VI,3,1-4.27-28 Forno (17).
Fig. 44 VI,3,1-4.27-28 Vasca ad alti bordi per la raccolta dell'acqua lungo la parete
sud dell'ambiente (15).
VI,5,15
~ 114 ~
Fig. 45 VI,5,15 Ambiente (8), probabilmente utilizzato come bottega.
Fig. 46 VI,5,15 Ambiente (1) un tempo contenente due macine, di cui sono visibili
le lacune circolari nella pavimentazione in basoli. I catilli che si possono osservare in questa foto
sono stati aggiunti successivamente agli scavi.
~ 115 ~
Fig. 47 VI,5,15 Ambiente (7), identificato come la camera da letto del fornaio.
Fig. 48 VI,5,15 Ambiente (3) utilizzato come locale di preparazione e cottura. Sono
visibili i resti di una macchina impastatrice ed il forno (9).
VI,6,4-5
~ 116 ~
Fig. 49 VI,6,4-5 Ambiente (1). Sono visibili i resti del forno (2).
Fig. 50 VI,6,4-5 Ambiente (3), forse usato come locale di lavoro.
VI,6,17-21 Pistrinum dei Christiani
~ 118 ~
Fig. 53 VI,6,17-21 Forno.
Fig. 54 VI,6,17-21 Placca rettangolare in terracotta raffigurante un elemento fallico con incisa la
frase “hic habitat felicitas”, in origine collocata nell'alloggiamento rettangolare presente sulla
facciata superiore del forno. Conservata al Museo Archeologico di Napoli.
~ 119 ~
VI,11,8-10 Casa del Labirinto
Fig. 55 VI,11,8-10 Corridoio (15) oltre il quale è visibile l'ambiente (16) contenente le macine e
il forno.
Fig. 56 VI,11,8-10 Ambiente (16). In primo piano sono due delle tre macine conservatesi.
Sul fondo è visibile il forno (55).
~ 120 ~
Fig. 57 VI,11,8-10 Forno e recipiente circolare per la raccolta dell'acqua.
Fig. 58 VI,11,8-10 Macchina impastatrice situata nel laboratorio (19).
~ 121 ~
VI,14,29-33
Fig. 59 VI,14,29-33 Ambiente (p) visto dall'ingresso 33. Si notano il forno (r) e una delle tre
macine.
Fig. 60 VI,14,29-33 Macine su pavimentazione in lastre basaltiche.
~ 122 ~
Fig. 61 VI,14,29-33 Forno (r).
Fig. 62 VI,14,29-33 Stalla (g) aperta sulla strada tramite l'ingresso 31.
VI,14,34
~ 123 ~
Fig. 63 VI,14,34 Veduta d'insieme della parte meridionale dell'atrio. Sulla sinistra si
nota l'accesso al laboratorio (l) con i resti di una macchina impastatrice, protetta da un gazebo a
causa del pessimo stato di conservazione.
Fig. 65 VI,14,34 Resti di macchina impastatrice in (l).
~ 124 ~
Fig. 66 VI,14,34 Ambiente (f). Sono visibili i resti dei basamenti in muratura di
quattro macine, che erano tuttavia già assenti al momento dell'eruzione nel 79 d.C. Sul fondo si nota
l'accesso alla stalla (k).
Fig. 67 VI,14,34 Forno (h) e dolio per l'acqua incassato nel terreno.
VII,1,36-37 Pistrinum di Modesto
~ 125 ~
Fig. 68 VII,1,36-37 Placchette decorative con rappresentazione fallica collocate a sinistra
dell'ingresso al pistrinum.
Fig. 69 VII,1,36-37 Placchette decorative raffiguranti una figura Priapica (in alto) e tre serie di
elementi circolari a spicchi (in basso), identificati come dei pani.
~ 126 ~
Fig. 70 VII,1,36-37 Atrio. Vasca ad alti bordi per la raccolta dell'acqua e il lavaggio del grano.
Ricavata dal precedente impluvium.
Fig. 71 VII,1, 36-37 Resti di macine nell'ambiente (l).
~ 127 ~
Fig. 72 VII,1,36-37 Forno. Al momento dello scavo la camera di cottura venne trovata
ancora chiusa dallo sportello in ferro e al suo interno furono ritrovati 81 pani carbonizzati
perfettamente conservatisi.
~ 128 ~
VII,2,3 Pistrinum di Terentius Neo
Fig. 73 VII,2,3 Peristilio (b). In basso a sinistra è riconoscibile una vasca in muratura per la
raccolta dell'acqua.
Fig. 74 VII,2,3 Ambiente (o). Sono visibili i resti di quattro macine in lava ed il forno.
~ 129 ~
Fig. 75 VII,2,3 Forno.
Fig. 76 Ritratto del panettiere Terentius Neo e della moglie trovato nell'abitazione
VII,2,6, alla quale viene associato il panificio VII,2,3. Ora conservato al Museo Archeologico di
Napoli.
~ 130 ~
VII,2,22 Pistrinum di Popidio Prisco
Fig. 77 VII,2,22 Ambiente d'ingresso contenente quattro grandi macine in pietra lavica ed
un forno.
Fig. 78 VII,2,22 Veduta principale del vano (b), di uso non definito e del forno (a).
~ 131 ~
Fig. 79 VII,2,22 Parte posteriore dell'impianto. In primo piano una macina, dietro la quale si
possono vedere i resti di una vasca per il lavaggio delle granaglie.
Fig. 80 VII,2,22 Resti di una macchina impastatrice, situata nel laboratorio (e).
~ 132 ~
VII,12,1-2.37 Pistrinum di Donatus
Fig. 81 VII,12,1-2.37 Ambiente (1) accessibile dall'ingresso 2. Utilizzato come bottega per la
vendita al dettaglio.
Fig. 82 VII,12,1-2.37 Ambiente principale, accessibile dagli ingressi 1 e 37. Sul fondo si
possono vedere i resti di un forno.
~ 134 ~
Fig. 84 VII,12,7 Ambiente (a) utilizzato come bottega. Sul fondo si nota l'accesso al
triclinio (b) e il corridoio conducente alla parte posteriore dell'impianto.
Fig. 85 VII,12,7 Forno. Situato nell'angolo sud-est dell'impianto.
VII,12,11
~ 135 ~
Fig. 86 VII,12,11 Bottega (a). Sul fondo sono visibili il magazzino (b), a sinistra, ed il
corridoio (c), a destra, conducente alla zona di lavoro situata nella parte posteriore dell'edificio.
Fig. 87 VII,12,11 Ambiente (d). In primo piano si nota il locale (g), usato come deposito o
laboratorio, e sul fondo la grande facciata ad arco del forno.
~ 137 ~
Fig. 89 VII,12,13 Bottega (a). Sul fondo si nota il triclinio (b), a sinistra, ed il corridoio
d'accesso alla parte retrostante dell'impianto, a destra.
Fig. 90 VII,12,13 Sostegni per tavoli da lavoro lungo la parete ovest del corridoio d'accesso
alla parte posteriore dell'edificio.
~ 138 ~
Fig. 91 VII,12,13 Resti del forno per la cottura dei pani, situato nell'angolo sud-est
dell'impianto. É ben visibile la struttura a cupola della camera di cottura.
Fig. 92 VII,12,13 Semicolonna in laterizi situata all'angolo nord-est dell'ambiente (d) e
contenente al suo interno una tubatura in terracotta, il cui uso non è tuttavia definito.
~ 139 ~
VII,14,9
Fig. 93 VII,14,9 Ambiente (21). In esso era collocato il pistrinum domestico, poi eliminato.
Rimangono visibili una parte del basamento di una macina, nell'angolo nord-est, inglobata
all'interno del muro e la bocca del forno nei pressi dell'ambiente (20).
Fig. 94 VII,14,9 Primo piano della bocca del forno. Si notino le piccole dimensioni
dell'apertura.
VII,16,6.9
~ 140 ~
Fig. 95 VII,16,6.9 Resti di macine nell'ambiente (1) accessibile dall'ingresso 6.
Fig. 96 VII,16,6.9 Ambienti (1), (2) e (3) accessibili dall'ingresso 9. Del forno, collocato in
(2), non rimangono tracce.
VIII,4,26-29 Pistrinum di Felix
~ 141 ~
Fig. 97 VIII,4,26-29 Veduta dalle fauces (q) dell'atrio (b), contenente le macine ed il forno.
Fig. 98 VIII,4,26-29 Forno.
VIII,6,1.8-10 Pistrinum di P. Emilius Gallicus
~ 142 ~
Fig. 99 VIII,6,1.8-10 Veduta da est dei resti delle macine nell'atrio (a).
Fig. 100 VIII, 6,1.8-10 Veduta da ovest dei resti delle macine nell'atrio (a) e del forno (d).
~ 144 ~
Fig. 102 IX,1,3.33 Ingresso al civico 3, con bancone di vendita.
Fig. 103 IX,1,3.33 Macine lungo il muro meridionale.
~ 145 ~
Fig. 104 IX,1,3.33 Veduta da nord-ovest dell'area di fronte al forno. In primo piano si nota un
dolio inserito in un basamento in muratura, chiaramente utilizzato per la raccolta dell'acqua.
Fig. 105 IX,1,3.33 Forno.
IX,3,10-12 Pistrinum di T.Terentius Proculus
~ 146 ~
Fig. 106 IX,3,10-12 Ambiente (a) usato come taberna e bottega. In primo piano sono visibili i
resti di un bancone di vendita.
Fig. 107 IX,3,10-12 Veduta del panificium dall'ingresso 12. In primo piano il basamento in
muratura di una macina; sul fondo è visibile invece il forno.
~ 147 ~
Fig. 108 IX,3,10-12 Estremità orientale dell'impianto. A destra del forno sono presenti tre
basamenti in muratura di macine, circondati da pavimentazione in lastre basaltiche.
Fig. 109 IX,3,10-12 Forno.
~ 148 ~
IX,3,19-20 Pistrinum di Papirius Sabinus
Fig. 110 IX,3,19-20 Macine nell'ambiente (a).
Fig. 111 IX,3,19-20 Resti del forno (b).
IX,5,4
~ 150 ~
Fig. 114 IX,5,4 Pozzo o bocca di cisterna in pietra lavica nel laboratorio (d). Sulla parete di
fondo, si nota un'apertura, a destra, che connetteva il locale al forno.
Fig. 115 IX,5,4 Forno (f).
IX,12,6-8 Pistrinum di C. Julius Polybius
~ 151 ~
Fig. 116 IX,12,6-8 Ambiente (f) con forno e macine. Visto da nord.
Fig. 117 IX,12,6-8 Ambiente (f) con forno e macine. Visto da sud.
~ 152 ~
Fig. 118 IX,12,6-8 Macine all'angolo nord-ovest dell'ambiente (f).
Fig. 119 IX,12,6-8 Forno.
~ 153 ~
Fig. 120 IX,12,6-8 Apertura sul lato sud del forno in connessione con il laboratorio (g).
Fig. 121 IX,12,6-8 Stalla (p). Veduta da sud-est. Sul pavimento sono visibili gli scheletri dei
cinque equidi morti in questo ambiente al momento dell'eruzione del 79 d.C.
Da VARONE 1989, p. 235.
~ 154 ~
Fig. 122 IX,12,6-8 Stalla (p). Pianta dei ritrovamenti effettuati nell'ambiente. Da VARONE
1989, p.234
~ 155 ~
Fig. 123 Carta di distribuzione dei panifici e delle pasticcerie. (aggiornata da LA TORRE 1988,
p. 85, fig.4)
~ 156 ~
Fig. 124 Carta di distribuzione dei pistrina senza macine. (aggiornata da LA TORRE 1988, p.85,
fig. 4)
~ 157 ~
Fig. 125 Carta di distribuizione dei pistrina forniti di bottega o punto di vendita. (aggiornata da
LA TORRE 1988, p.85, fig.4.
~ 158 ~
Fig. 126 Carta di distribuzione dei pistrina installatisi in precedenti abitazioni. (aggiornata da LA
TORRE 1988, p.85, fig. 4)