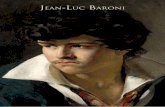Il volto affabile delle parole. Le collaborazioni di Angelo Barile a «Persona», in Letteratura e...
Transcript of Il volto affabile delle parole. Le collaborazioni di Angelo Barile a «Persona», in Letteratura e...
PAOLO SENNA
IL VOLTO AFFABILE DELLE PAROLE.
LE COLLABORAZIONI DI ANGELO BARILE A «PERSONA»
Indici mobili dei nostri sentimenti e
costumi, talora dei nostri vizi mentali,
ombre sensibili delle nostre avversioni o
antipatie, le parole ci raccontano nella loro
vicenda una storia sincera dell’uomo.
ANGELO BARILE, Fortuna delle parole
«La scelta è caduta sul termine “persona” perché, nonostante i
difetti di pedanteria, ovvietà, gusto teologizzante che gli sono stati
imputati, ci sembra suggellare con esattezza i valori che ci stanno più a
cuore e custodire l’immagine a cui vorremmo essere fedeli: l’uomo, cioè,
sottratto alla duplice tentazione, in lui sempre presente, di elevarsi a
categoria con la sua singolarità contrapposta orgogliosamente agli “altri”; e
di confondersi irrazionalmente nelle categorie che lo superano, quasi a
ritrovare in esse gli aiuti e le ispirazioni che non riesce a desumere dalla
propria solitudine: l’individuo autosufficiente e l’uomo-massa»1. Con
queste parole si apriva nel marzo del 1960 il primo fascicolo di «Persona»,
incastonate all’interno di un ampio articolo editoriale che, come sarà poi
consuetudine, appariva non firmato, ma dietro al quale dobbiamo
riconoscere la mente e la penna di Marcello Camilucci e la tessitura di
quell’attivissimo catalizzatore di cultura che fu Adriano Grande. La rivista,
diretta dagli stessi Grande e Camilucci, ospiterà nel corso della sua storia
un numero consistente di contributi, recensioni, cronache e scritti creativi
in prosa e in verso. Di chiara e fondante ispirazione cattolica, «Persona»
non si limitò alla sola letteratura, ma si aprì all’intero campo delle
esperienze artistiche: cinema, musica, arti figurative, teatro, nella
1 Si veda Intenzioni, «Persona», Roma, I, n° 1, 16 marzo 1960, pp. 1-2, qui a p. 1. «So che a
Roma Marcello Camilucci e Adriano Grande pensano a fondare una rivista, anzi un
semplice foglio prevalentemente, ma non esclusivamente, letterario. Se uscirà, te ne terrò
avvertito; e potrai, volendo, collaborarvi» (lettera di Barile ad Antonio Pinghelli del 5
novembre 1957 in BRUNO ROMBI, Angelo Barile, l’ospite discreto, Savona, Sabatelli, 1988,
p. 85). La rivista ebbe cadenza inizialmente quindicinale, poi mensile ed infine uscì con
fascicoli monografici. Essa espresse in modo chiaro il proprio indirizzo, tant’è che è anche
stata giudicata «di spiccato orientamento cattolico-intransigente e di gusto letterario un poco
stantio»; tuttavia tra i collaboratori si segnalano personalità attive non solo nell’ambito
cattolico, ma più largamente presenti nel panorama culturale italiano. Oltre a Camilucci e
Grande si trovano, per citare qualche nome: Evandro Agazzi, Renato Bertacchini, Carlo
Betocchi, Vittore Branca, Giovanni Cristini, Gina Lagorio, Igor Man, Ettore Serra, oltre,
chiaramente, ad Angelo Barile. Il comitato redazionale era composto da Carlo Alianello,
Angelo Barile, Carlo Betocchi, Francesco Grisi, Raffaello Prati, Bonaventura Tecchi,
Adriana Zarri. Per la citazione, si veda ADRIANO GRANDE, Avventure, a cura di PAOLO
ZUBLENA, Genova, De Ferrari, 1997, p. 30.
2
ossequiosa fedeltà al sottotitolo che, apparso dal 1963, recitava Mensile di
Letteratura, Arte e Costume.2 Nel programma della rivista è evidente
l’intenzione di porsi come baluardo contro la mercificazione dell’arte e i
suoi «sottoprodotti» espressi in nome di un’ostentazione di libertà
produttiva e ispirativa, optando per una soluzione non pretestuosamente
censoria, ma critica, nell’intento di restaurare la qualità profonda della
persona: la dignità dell’uomo che si basa sui «valori» e sul senso del
«divino».
Angelo Barile venne chiamato a collaborare al periodico in modo
attivo. Nonostante l’età ormai provetta (era nato nel 1888)3, fece parte del
2 Sulle pagine del periodico infatti si trovano gemme iconografiche con riproduzioni di
opere di grandi artisti, come Campigli, Carrà, De Chirico, De Pisis, Manzù, Picasso, accanto
alle quali hanno spazio gli inconfondibili schizzi di Eugenio Dragutescu che, fin dal primo
numero, ritraggono i protagonisti della vita culturale di cui via via si tratta. Grande ebbe
inoltre la carica di direttore responsabile di «Persona» fino alla morte sopraggiunta nel
febbraio del 1972. Su Eugenio Dragutescu, pittore appartenenete al Gruppo dei Romanisti
spentosi nel 1993, si possono vedere EUGENIO DRAGUTESCU, Le prime giornate italiane di
un romeno divenuto romano, «Strenna dei Romanisti», Roma, XLII, 1981, pp. 169-172, e il
ricordo apparso in occasione della morte, ivi, LIV, 1993, pp. 447-448. 3 Angelo Barile nacque ad Albisola Marina il 12 giugno 1888. Frequentò il liceo-ginnasio
«Gabriello Chiabrera» di Savona, dove conobbe Camillo Sbarbaro. Intraprese gli studi
giuridici all’Università di Genova e frequentò i corsi di Lettere a Torino. In questi anni si
legò all’ambiente modernista e strinse amicizia con Padre Semeria, docente a Genova, dalla
cui personalità trasse elementi che rimasero al fondo della sua produzione poetica e del
quale curò una raccolta di lettere. Lavorò per tutta la vita nella fabbrica familiare di
ceramiche, la Casa dell’Arte di Albisola Capo, la cui réclame si può vedere ancora oggi,
ospitata nelle pagine pubblicitarie in chiusura a «Circoli». Partecipò in qualità di ufficiale di
fanteria alla Grande guerra, dalla quale riportò due ferite. Conclusa la stagione bellica, gli
anni Venti e Trenta lo videro impegnato in collaborazioni a riviste letterarie, quali
«Solaria», «Circoli» (di cui è fondatore con Adriano Grande), «L’Italia letteraria»,
«Maestrale» e «Frontespizio». Negli anni seguenti, firmò contributi anche su «Il Gallo»,
«La Fiera letteraria», «Letteratura», «Il Fuoco», «Liguria» e «Persona». Durante il secondo
conflitto mondiale venne imprigionato in quanto partecipante al C.L.N., e si salvò dalla
fucilazione in modo davvero fortunoso, grazie all’impegno del fratello Giulio, che riuscì a
ottenere la sua scarcerazione prima che i tedeschi decidessero di condannare alcuni
prigionieri. Aderì in giovinezza per breve tempo alla prima Democrazia Cristiana di
Romolo Murri e si iscrisse nuovamente al partito nel 1943. Nel dopoguerra svolse
un’importante attività di amministratore pubblico, come consigliere comunale e provinciale,
senza tralasciare i suoi più intimi interessi letterari, ma rifiutò la candidatura al Senato,
preferendo occuparsi della famiglia. Si sposò nel 1950 con Pina Garaventa. Le sue raccolte
di poesie sono: Primasera (1933), Quasi sereno (1957, che ottenne il Premio Cittadella) e il
volume delle Poesie, apparso nel 1965 per i tipi di Scheiwiller, che vinse il Premio Fiuggi.
Si spense il 20 maggio 1967 ad Albisola Capo.
Per la collaborazione al periodico si ricordi la nota di MARCELLO CAMILUCCI, nel Ritratto a
più voci di Angelo Barile. Tavola rotonda a cura di BRUNO ROMBI, in Omaggio ad Angelo
Barile, Atti del convegno di studi, «Resine», Savona, n° 42, 1989, p. 58: «Quanto alle
caratteristiche della collaborazione di Angelo Barile a “Persona”, essa conservò per tutta la
durata il carattere della più assoluta libertà e spontaneità. Egli stesso si dichiarò schivo a
conferirle una periodicità rigorosa e sapeva che ogni scelta dipendeva da lui, considerata
l’omogeneità della visione (spirituale e letteraria) che ci contraddistingueva. Data la sua
3
comitato redazionale e, sebbene la sua produzione per la rivista non sia
stata copiosa, agì, come aveva già fatto molti anni prima per l’esperienza di
«Circoli», da illuminante punto di riferimento, capace come fu di tessere
rapporti personali e di incoraggiare con i suoi consigli molti scrittori e
poeti: i suoi carteggi, le sue introduzioni o recensioni alle prime opere dei
giovani costituivano parte fondamentale della sua attività letteraria, che
può essere considerata al di là di ogni equivoco chiaramente educativa,
poiché tesa ad indicare, da poeta e da lettore di versi e non da critico in
senso restrittivamente tecnico, le vie da seguire, i sentieri da percorrere per
giungere all’espressione della poesia, che egli considerava, prima di ogni
cosa, una «voce di gioia». Si ricordino, infatti, i legami stretti in quegli
anni con Giovanni Cristini, Adriano Sansa, Silvio Riolfo, Enrico Bonino,
collaboratori tutti di «Persona»: per Sansa e Riolfo stilò una nota prefatoria
alle loro sillogi poetiche uscite per la casa Sabatelli di Savona4. Una
peculiare discrezione, Angelo Barile non fu mai un collaboratore da arginare ma, anzi, da
sollecitare. Quando non condivideva la stima su una persona o un’opera, la rendeva palese
con estrema naturalezza senza fare mai motivo di polemica. Ciò cui risultava costantemente
più interessato era il coglimento del nesso fra l’opera e l’autore e la sua anima naturaliter
christiana e provava profonda gioia ogni volta che poteva cogliere motivi di affinità e
ragioni di consenso in terreni diversi». 4 Si vedano gli interventi La “Colombera” di Rilofo e Vigilia, apparsi su «Persona», Roma,
rispettivamente VII, n° 2, febbraio 1966, pp. 19-20 e VIII, ni 7-8-9, luglio-agosto-settembre
1967, p. 16 (fascicolo dedicato a Barile) e pubblicati in calce a questo saggio. Un articolo
che rende merito alla capacità di ascolto di Barile – e che insieme ne propone un ritratto
squisitamente umano – è SILVIO RIOLFO, Aveva dietro di sé molti giovani («Persona»,
Roma, VIII, ni 7-8-9, luglio-agosto-settembre 1967, p. 26): «Possedeva una qualità che è la
luce dell’anima, ma spesso è inosservata dalla egoistica disinvoltura dei più: la simpatia
verso gli altri, appena ne immaginava una rispondenza. […] Sempre pronto a scusare una
dimenticanza, ad alleviare un giudizio un po’ troppo severo, senza però rinunciare alla
schiettezza, e persino alla perentorietà. Soprattutto con i giovani, verso i quali riusciva
spontaneamente a cancellare le differenze di abitudini e di idee. […] Il suo amore fedele alla
vita toccava il senso degli anni lontani, di una giovinezza viva e pensosa. Era proprio così;
viveva di gioventù e in tutti riaccendeva quel lume. Perché credeva che la letteratura è
sempre giovane, che le parole dette nella giovinezza dello spirito sono le più vere. Questa
era la sua fede mai oscurata. Ecco perché, pur vivendo in provincia, era forse uno degli
scrittori che aveva dietro di sé il maggior numero di giovani». Si ricordino le parole
dell’intevista rilasciata da Domenico Astengo nel vol. ROMBI, Angelo Barile, l’ospite
discreto, cit., a p. 19: «Fu Angelo Barile a presentarmi come poeta sulle pagine della “Fiera
letteraria” e poi a scrivere l’introduzione al mio Vigilia di festa. Frequentando Barile, mi
resi conto di che cosa significhi per un giovane avere vicino un maestro che consigli senza
“dare lezioni”, facendo prevalere, sempre, le ragioni dell’affetto, dell’assoluto dono di sé».
Si vedano anche i riferimenti sparsi negli epistolari SALVATORE QUASIMODO, Carteggi con
Angelo Barile, Adriano Grande, Angiolo Silvio Novaro. 1930-1941, a cura di GIOVANNA
MUSOLINO, prefazione di GILBERTO FINZI, Milano, Archinto, 1999 e EUGENIO MONTALE,
Giorni di libeccio. Lettere ad Angelo Barile, a cura di DOMENICO ASTENGO e GIAMPIERO
COSTA, Milano, Archinto, 2002. La casa editrice Sabatelli dal 1968 avrebbe anche potuto
dare i propri tipi alla rivista: si veda al proposito la testimonianza di Enrico Bonino in
ROMBI, Angelo Barile, l’ospite discreto, cit., pp. 27-29, qui a p. 28: «Si ragionava sul
proposito (l’idea era stata di Adriano Grande) di trasferire la rivista “Persona” in Liguria, a
4
tensione dialogante (quasi una propria vocazione) di cui fu espressione
negli anni della giovinezza l’amicizia, insieme letteraria ed umana, con
Camillo Sbarbaro5. La scoperta della poesia dell’«estroso fanciullo»
avvenne – com’è noto – sui banchi di liceo, sui foglietti stropicciati che
raccoglievano la compiacenza e incontravano il gusto dei compagni di
classe e del professore, Adelchi Baratono, il cui magistero si svolse nel
segno di una apertura intellettuale che non rimase priva di frutto nella
matura capacità di accostamento ai testi degli allievi6. «Giudice segreto»,
secondo la felice espressione di Bo7, fu guida anche per un italianista
d’eccezione qual è Vittore Branca:
A me, futuro coltivatore quasi esclusivamente della narrativa – dal Boccaccio al
Nievo e poi al De Marchi e al realismo meditativo – proprio Angelo Barile svelava
e interpretava e imponeva le voci nuove della nostra lirica. Erano le più
significative voci della nostra civiltà, al di là di orge retoriche nazionalistiche e di
cedimenti narrativi. E mi guidava anche nelle mie adolescenziali esperienze – o
Savona, presso gli Editori Sabatelli, affidandone la redazione a noi “giovani”. Grande era
stanco, quel lavoro lo affaticava oltre misura. Avvertiva l’approssimarsi del “capolinea” e di
conseguenza anche la fine della “sua” rivista della quale aveva condiviso con Camilucci la
direzione e che già rappresentò nel non ricco panorama delle riviste letterarie nazionali una
bandiera isolata ma serenamente e strenuamente coraggiosa. A Barile l’iniziativa andava a
genio. Ma non era responsabilità da poco». Sulla capacità di Barile di dare l’indirizzo di
«Circoli» si vedano STEFANO VERDINO, L’evoluzione di «Circoli», «La rassegna della
letteratura italiana», Firenze, XCII, ni 2-3, maggio-dicembre 1988, pp. 373-97; EDOARDO
VILLA, «Circoli» o di una condizione poetica, in La poesia di Angelo Barile, Atti del
Convegno di studi (Albisola, 14-15 maggio 1977), Genova, Resine – Quaderni liguri di
cultura, 1978, pp. 105-37. 5 Si ricordi la memoria di CARLO BO, in ROMBI, Angelo Barile, l’ospite discreto, cit., alle
pp. 25-26: «Senza tema di esagerazione si può dire che se non ci fosse stato Barile Sbarbaro
non avrebbe potuto essere quel poeta che è diventato, perché Barile lo assisteva, lo
confortava, ne comprendeva gli umori, le ritrosie». Una testimonianza di prima mano è in
ANGELO BARILE, Confidenziale, «Persona», Roma, VIII, n° 11, novembre 1967, pp. 3-4.
Sull’argomento si vedano inoltre anche i seguenti volumi e contributi: CAMILLO SBARBARO,
Cartoline in franchigia, Firenze, Vallecchi, 1966; ANGELO BARILE e CAMILLO SBARBARO,
La trama delle lucciole. Lettere 1919-1937, a cura di DOMENICO ASTENGO e FRANCO
CONTORBIA, Genova, San Marco dei Giustiniani, 1979; EUGENIO MONTALE, Ad Angelo
Barile con fedele amicizia, a cura di GIOVANNI FARRIS, Savona, Sabatelli, 1982; Cose di
ginnasio e di liceo, a cura di GIOVANNI FARRIS, Savona, Sabatelli, 1986; LUCIA
RODOCANACHI, Amici poeti degli anni Trenta, in La poesia di Angelo Barile, cit., pp. 54-56. 6 Fu Barile a scegliere il titolo della raccolta Resine (1911) e a presentarlo con una
recensione; e poi ancora ad assaggiare i testi di Pianissimo, segnati dal sentimento della
perdita del padre e a creare un ponte per la pubblicazione con il gruppo della «Voce»
(1914), grazie all’intervento di Giuseppe Agnino. Su Adelchi Baratono si veda il fascicolo a
lui dedicato dal periodico «La Riviera Ligure», Genova, VIII, ni 24-25, settembre 1997-
aprile 1998, e la bibliografia citata. 7 CARLO BO, Un giudice segreto, «Persona», Roma, VIII, ni 7-8-9, luglio-agosto-settembre
1967, p. 3, testo precedentemente apparso su «L’Europeo» nel giugno del 1967.
5
meglio inesperienze – poetiche (per fortuna tutte e solo manoscritte e presto
distrutte): erano librate sulle ali specialmente di Sbarbaro.8
Le collaborazioni di Barile a «Persona» costituiscono uno specchio
dell’attività dell’autore e restituiscono un’immagine viva e organica della
figura del poeta, mostrando i diversi generi della sua produzione scrittoria:
sono presenti infatti la poesia, la prosa creativa e quella critica9. Non deve
invece stupire la loro esiguità in termini strettamente quantitativi: Barile
scriveva per necessità, preferendo distillare anziché profondere, per
obbedire «a un fatto del tutto insolito e raro, un dono dell’intima
trasparenza»10
. Alla base della propria esperienza letteraria si poneva una
ferma consapevolezza della moralità della letteratura (e più strettamente
della poesia): sostanza etica non limitata esclusivamente alla scelta dei
contenuti da veicolare, ma intesa nel senso più ampio di un profondo e
maturo rispetto che investe lo scrittore e in ultima analisi l’uomo. La
produzione bariliana infatti non tende all’ispirazione ma attende in qualche
modo di esserne visitata. Si tratta di un sentimento quasi religioso: «Come
nella vita religiosa, la più vicina alla nostra il riposo è raccomandato per il
bene dell’anima […], così per arrivare alla poesia quel che più giova è la
pausa, il vivo silenzio»11
; questo sentire si coagula nella necessità
dell’attesa («Il meglio è dunque […] di lasciar maturare le nespole»)12
, che
non sconfina nel regno vuoto dell’accidia ma anzi, riprendendo la
tradizionale concezione dell’attività letteraria come otium, rende possibile
lo sbocciare della poesia come un «fiore di gioia»13
e ne risolve l’equilibrio
tensivo in «lievità fantastica e pienezza di vita, grazia di distacco e senso e
impregnatura di reale»14
. Poesia e, più in generale, scrittura non sono
8 VITTORE BRANCA, Appuntamenti per la vita, «Il Sole 24 ore», Milano, 28 novembre 1999,
p. 32. Si ricordi che fu proprio Barile a presentare Branca a Montale (vd. ID., Tre
“occasioni” da rivivere con Montale, ivi, 6 ottobre 1996, p. 23). 9 Le collaborazioni bariliane sono state suddivise in tre gruppi a seconda del genere cui
appartengono. Tuttavia il carattere libero e ibrido di alcuni testi potrebbe rendere discutibile
l’appartenenza all’una o all’altra etichetta. La rubricatura si intenda quindi come meramente
indicativa per agevolare l’esposizione del presente lavoro nei prossimi paragrafi. 10 Vd. ANGELO BARILE, Postilla, in ID., Poesie, introduzione di DOMENICO ASTENGO,
Milano, Scheiwiller, 1986, pp. 148-50, cit., a p. 150 e SILVIO RIOLFO MARENGO, Angelo
Barile. Dal suo minimondo ogni cosa era eterna, «Il sole 24 ore», Milano, 29 marzo 1987,
p. 17. «Poeta assai parsimonioso» lo disse Montale in una sua recensione scritta per il
«Corriere della sera» ma non pubblicata in quella sede (si veda EUGENIO MONTALE, Barile,
in La poesia di Angelo Barile, cit., pp. 7-8, a p. 7). 11 ANGELO BARILE, Risonanze (1931-1934), a cura di SIMONA MORANDO, Milano,
Scheiwiller, 1997, p. 29. Discute il rapporto fantasia-accidia MARZIANO GUGLIELMINETTI,
Le varianti di “Primasera” e il leopardismo di Barile, in La poesia di Angelo Barile, cit.,
pp. 138-51, a p. 141. 12 BARILE, Risonanze, cit., p. 30. 13 Ivi, p. 37. 14 Ivi, p. 34.
6
artificio ma ricerca di naturalezza e, per usare un termine caro al poeta di
Albisola, consistenza15
.
1. Poesie
Negli anni ’60 Barile, dopo l’edizione di Quasi sereno nel 1957, attendeva
alla sistemazione delle sue liriche, sfociata nell’edizione milanese del 1965
delle Poesie, attraverso un continuato e instancabile processo di rilettura e
revisione, teso a cogliere l’essenza autentica della propria arte. Nella
concezione dell’autore, la vera poesia affiora dalle corde più intime che
solo raramente l’uomo è in grado di esprimere, per un dono di grazia.
Questa visione – s’è detto – profondamente etica dell’agire e del fare
poetico si concretizza nella costruzione di un sistema ove ogni parola, ogni
suono e – da essi veicolato – ogni contenuto abbia un posto specifico e
definito.
Barile pubblica su «Persona» quattro poesie, fra gli ultimi risultati
di un’opera continua, che appariranno con qualche modifica (di cui si darà
specifico rilievo) nel volume che raccoglie tutte le sue liriche. Nonostante
l’esiguo numero, i testi appaiono rappresentativi delle linee portanti della
poetica dell’autore. Mario Razetti, in un contributo al convegno del 1977,
delineò il percorso della poesia bariliana e ne mostrò lo sviluppo,
sottolineando da una parte l’inesausto labor limae operato sui testi
pregressi e dall’altra, per quelli cronologicamente a noi più vicini,
l’opzione per la chiarezza comunicativa e la scelta di non celare le
occasioni ispirative16
: la vena religiosa appare dunque aperta e dichiarata in
modo ancor più esplicito rispetto alle precedenti liriche ed anzi ne viene a
costituire il carattere fondante17
. Delle quattro poesie, due (A tarda sera e
15 Si veda Poesia consistente, ivi, pp. 27-8. 16 MARIO RAZETTI, «L’attardata / creatura dei margini», in La poesia di Angelo Barile, cit.,
pp. 81-104. La maggior parte degli interventi critici sulla figura di Barile riguardano la sua
poesia. Si vedano, oltre al contributo di Razetti, almeno: GIORGIO CAPRONI, “Un’urgenza
affettuosa mi preme”, «La Fiera letteraria», Roma, XXXII, n° 11, 17 marzo 1957, p. 3;
VALERIO VOLPINI, Esperienza e umiltà, «La Fiera letteraria», Roma, XXXII, n° 46, 17
novembre 1957, pp. 4; ID., Una poesia senza tempo, «La Fiera letteraria», Roma, XL, n° 46,
28 novembre 1965, pp. 7-8; GIORGIO BARBERI SQUAROTTI, Stile ed esperienza religiosa, in
La poesia di Angelo Barile, cit., pp. 66-80; ROMBI, Angelo Barile, l’ospite discreto, cit., pp.
59-76; il citato fascicolo di «Persona» dedicato a Barile (specialmente i saggi di Carlo
Betocchi, Ettore Serra, Nazareno Fabbretti, Domenico Astengo, Francesco Bruno e
Giovanni Cristini); Omaggio ad Angelo Barile, cit. (i saggi di Giorgio Barberi Squarotti,
Alberto Frattini, Francesco De Nicola). 17 Si leggano i seguenti passaggi di un’intervista rilasciata dal poeta: «Le mie simpatie e
preferenze sono per una poesia umana, e modernamente viva, ma non cifrata, non ingrata,
anzi di modi aperti e di valori cordiali: una poesia quant’è possibile chiara, ma la cui
chiarezza non pregiudichi, come spesso avviene, l’intensità lirica, che è virtù necessaria al
canto. Intensità e chiarezza non vanno sempre d’accordo, la loro unione è un’unione
difficile, perché l’intensità ha un moto verticale e la chiarezza tende agli andamenti piani,
discorsivi, orizzontali. Però quando le due qualità si sposano allora la poesia è una
benedizione di Dio»; «Adesso questa voce religiosa mi si è fatta, con gli anni, più distinta e
7
Navi alla fonda) appaiono in maniera diretta legate ai temi della morte e
del colloquio con i defunti, particolarmente cari a Barile come attestano
altre numerose prove innestate su questi argomenti (Un morto viene, A filo
di cielo, A mio padre, Corona di morti, Sei tu mio cielo, A sole breve).
Posta in posizione finale alla raccolta Poesie, A tarda sera costituisce un
esito estremamente significativo. La lirica è formata da tre strofe più un
distico conclusivo, con un impianto versale tradizionale18
. L’adozione di
suoni liquidi e soprattutto nasali, specialmente nella prima parte, tende a
conferire un tono meditativo, coerente con il giungere della tarda sera19
.
Proprio in questa che è l’ora del raccoglimento e del sonno, che una
metafora antica e vulgata dice simile alla morte, il poeta «prega pace» e
chiama per nome le anime dei trapassati nei quali «ripalpita» ancora la vita
(«sensibili»). Il cuore del poeta però è maggiormente commosso per coloro
«che ieri appena spezzavano il pane / con noi sotto la lampada», stanno
«ancora fermi» al di là della «porta non richiusa» e lo invitano a seguirlo.
Anche in Navi alla fonda, ove l’immediatezza icastica del paesaggio è
sostenuta dalla tessitura fonica (si veda esemplarmente l’accumulo di
toniche chiuse e di consonanti liquide: «Posano calme nella notte estiva /
sul cupo illune velluto dell’acque»), il poeta nell’immagine di alcune navi
ferme nel porto «di fronte al mio balcone»20
coglie i «cenni» e i «richiami»
dell’«altra riva»; questa visione è poi trasfigurata in allegoria:21
sfruttando
vorrei dire più vivamente sensibile, più direttamente partecipe del messaggio cristiano. Così
il pensiero – non astratto – della morte, ma propriamente il pensiero dei Morti, dei nostri
Morti, della loro spirituale presenza, del durevole vincolo che abbiamo con loro, del non
interrotto colloquio ch’essi continuano con noi – quello che la Chiesa chiama Comunione
dei Santi – è uno dei motivi più cari alla mia poesia. È per es. mia Madre che prega per i
suoi Morti, e un’anima viene, una sera, chissà da quali lontananze, a invocare il suo
requiem… (Un morto viene). Vedi anche Corona dei Morti». Vd. ANGELO BARILE,
Confessione, in GINA LAGORIO, Angelo Barile e la poesia dell’intima trasparenza, Capua,
Centro d’arte e di cultura “L’Airone”, 1973, pp. 20-21. 18 Si tratta di endecasillabi (15; 9 a maiore e 6 a minore), settenari (10) e due quinari. 19 Si noti la stessa memoria serale di un defunto nei versi «Un morto viene furtivo, una sera,
/ a te che preghi, / a distanze di cenere, raccolto / in un lampo del tuo ricordo» (Un morto
viene, in Poesie, cit., p. 106). Sul tema dei morti nella poesia bariliana si veda GIORGIO
CAVALLINI, Barile e il colloquio con i morti, in ID., Strutture tendenze esempi della poesia
italiana del Novecento, Roma, Bulzoni, 1988, pp. 123-35. 20 È lo stesso balcone-soglia di Pupille (Poesie, cit., p. 64), ove un moribondo «Sente giunta
la notte ai suoi balconi / e intorno vuole accesa d’occhi vivi / una corona». 21 Sulla questione si veda il precoce intervento di RAFFAELLO RAMAT, “Primasera”,
«L’Italia letteraria», Roma, XII, n° 15, 14 aprile 1934, p. 8: «Una simile posizione religiosa
di fronte alla propria poesia, in cui con la forza delle cose fatali domina il sentimento della
sincerità assoluta – nessuna ironia, nessun giuoco, nessuna cosciente deformazione – e che,
d’altra parte, appunto perché è poesia deve essere confessione ed altro, verità ed altro; una
simile posizione può portare ad indugiare in un modo allegorizzante. Dunque, si badi,
l’allegoria in Primasera, ove c’è non è letteratura, giuoco ingegnoso e tanto meno mezzo per
giungere a fini pedagogici, o sterile amore per il vago dell’oscurità; ma – cosa
profondamente seria – è una forma di pudore».
8
la dinamica degli opposti (notte-luce, mare-isola, realtà terrestre-realtà
ultraterrena), la notte lascerà il posto a «isole chiare» circonfuse di luce, in
un viaggio che conduce «oltre i sensi». L’esperienza umana non è una
waste land dove l’uomo constata drammaticamente l’abbandono e la
tragedia del non senso. È invece una «riva» che prima o poi dovrà essere
lasciata per raggiungere spiagge «altre», che ne costituiscono il
completamento e la pienezza (l’«altra riva / a cui naviga l’anima»)22
. La
realtà e il mondo «altro» non formano due entità separate: il poeta infatti
non li scinde e la «porta» rimane «non richiusa»; anzi, questi versi, ma più
ampiamente tutta la poesia bariliana (e in special modo quella dell’ultimo
periodo), sembrano indicare come l’intero arco dell’esperienza umana –
amore, gioia, dolore – non sia mai condotto in solitudine: è la scoperta
della valenza “orizzontale” della fede, che infatti «cammina leggera al mio
fianco / non vista, e non fa parola, / a tempo giusto riannoda / il filo
spezzato del canto»23
. Il cammino umano si svolge nel segno di quella
comunione fra gli uomini che Barile esprime come esperita coralità e che
ricorda per intensità emotiva e poetica gli accenti danteschi e i movimenti
delle anime del Purgatorio. E forse in quel “sorriso lontano”, risposta a
un’evocazione («chiamo per nome i miei morti») che non è solo
memorativa ma è certezza della viva presenza dei defunti, si può
esemplarmente misurare la distanza da altri esiti della poesia italiana: corre
alla mente lo “sbigottimento” del padre nell’abbandonare le rive dove è
cresciuto e il timore che la memoria di lui nei suoi figli svanisca in Voce
giunta con le folaghe di Montale24
. La realtà messa in scena da Barile è
dunque “visitata” dal cielo, come documentano del resto le altre due poesie
(I chierichetti della “Stella Maris” e Il canto smarrito): nella comune
quotidianità la vita del cristiano è scandita da attimi che la riconducono al
piano divino e la investono di luce «altra». È stato notato come proprio in
questi momenti la poesia bariliana giunga «al confine tra la terra e il cielo»,
sfiorando il misticismo25
: poesia e religiosità vanno di comune accordo in
Barile ed anzi la poesia può essere espressione e canto dell’anima solo in
22 Sulla presenza simbolica della «riva» si ricordino i versi «Dal lavacro del sonno / ti
risvegliavi, eri sull’altra riva» (Risveglio sull’altra riva, in Poesie, cit., p. 23) e «Ora canti
sull’altra riva» (Lamento per la figlia del pescatore, ivi, p. 103). 23 A sole breve, ivi, p. 123. 24 «L’altro sbigottisce e teme che / la larva di memoria in cui si scalda / ai suoi figli si
spenga al nuovo balzo» (EUGENIO MONTALE, Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 19841, p.
259), mentre nella bariliana A mio padre è il riconoscimento di una fraternità a essere
espresso: «Torna / con quel tuo accento, sale / dal mio profondo trafitta preghiera, / ora che
da una sponda / che s’abbandona al tuo cielo ti parlo / non come parla più un figlio. Son
prono / anch’io al limine: un uomo / grave di nembo: eguale / come un fratello al suo padre
canuto» (vd. Poesie, cit., p. 120). 25 ROMBI, Angelo Barile, l’ospite discreto, cit., p. 71. Vd. sulla questione recentemente
GIANDOMENICO MUCCI S.I., Mistica. Ossia l’interpretazione arbitraria di una parola, «La
civiltà cattolica», Roma, anno 154, vol. III, quad. 3674, 19 luglio 2003, pp. 130-7.
9
quanto il sentimento poetico della vita si fonda sul sentimento religioso
dell’esistenza.
2. Prose creative
In quegli anni, Barile era intento a recuperare alcuni suoi scritti di prosa
pubblicati al tempo di «Circoli» nella rubrica delle Risonanze. L’idea, che
giaceva nella mente del poeta già da tempo26
, si concretizza quando, nel
1966, Grande lo stimolò a raccogliere i suoi antichi interventi nel primo
volume dei «Quaderni di “Persona”»27
. È bene riproporre integralmente la
Noterella editoriale di Adriano Grande alla prima edizione delle
Risonanze:
Siamo lieti di poter iniziare questi Quaderni di «Persona» con un libro che non ha
proprio nulla dell’inamidata gravità né del linguaggio da specialisti cui a volte si
appoggiano, per ottenere considerazione, gli scritti di letteratura. Qualcuno può
osservare che, in realtà, questo non è un volume di studi, ma semplicemente una
raccolta di massime e di osservazioni marginali, la quale non può certo vantare
pretese storicistiche. Giusto, ma solo in parte; giacché, per quanto propriamente
riguarda la storia, riteniamo che il colore di un’epoca letteraria, la nostra, del
convulso Novecento non ancora concluso, e taluni aspetti del suo costume, più che
in certi poderosi tomi di critici professionisti e sistematizzanti siano ritratti in
queste sàpide e garbate noterelle e considerazioni.
Nel suo tranquillo angolo di provincia, lontano dallo sforzato impegno di coloro
che sono immersi nel soffio temporalesco del commercio letterario, Angelo Barile
– che è soprattutto poeta di sicura, elegiaca e filtratissima vena – è andato man
mano scrivendo questi suoi pensieri e ammonimenti dal 1931 al 1934 per la rivista
genovese «Circoli» alla quale venivano a dare anche un tono autocritico che
meglio inquadrava, appuntandone i difetti di clima e di gusto, gli stessi tentativi
d’arte poetica che la rivista divulgava28
.
26 Alberto Frattini segnala il testo di una lettera di Barile del 25 agosto 1957, seguente alla
recensione da lui prodotta per il volume Quasi sereno, apparsa sul «Messaggero» del 17
giugno: «Io vorrei, se Dio mi dà grazia, riunire in volume alcune mie prose (ricordi,
moralità letterarie, ritratti ecc.); ma nulla ancora di definito e di concreto». Si veda ALBERTO
FRATTINI, Osservazioni sulla prosa di Angelo Barile, in La poesia di Angelo Barile, cit., p.
179. E anche l’intervista di Cibotto a Barile (apparsa col titolo Barile e il cenacolo ligure
sulla «Fiera letteraria», Roma, XL, n° 46, 28 novembre 1965, alle pp. 7-8, cit. alla p. 8):
«Non è esatto che dopo le mie note apparse su “Circoli” io non abbia scritto altre prose. Ma
le più sono uscite qua e là, saltuariamente e non hanno avuto rilievo. Alcuni miei amici
vogliono ora farne una scelta. Sono in genere prose morali, o critiche, o evocative. Non c’è
invece nessun racconto. Non ha mai neppure tentato di scriverne, sentendomi negato, fin da
quando ero giovane, alla forma narrativa». 27 ANGELO BARILE, Risonanze (1931-1934), Roma, Società Edizioni Nuove, 1966 (Quaderni
di «Persona», 1). Della stessa collana fecero parte, nel tempo, Fra lacrime e preghiere di
Girolamo Comi, Adriano Grande, pittore candido di Barile, Carlo Belli e Camilucci, Saluto
ai paesi di Raffaello Prati, Tardi di Renato Pollitzer, Meraviglia di Giuseppina Sperandeo
Cosco. 28 Lo stesso Barile nell’intervista citata apparsa su «La Fiera letteraria», a proposito delle
sue prose apparse su «Circoli», disse: «Qual è stata la mia partecipazione a “Circoli”?
10
1931-1934: anni che alla nostra attuale isteria possono sembrare già lontanissimi,
d’un mondo irripetibile. Ma lo strano di queste note è invece la loro frequente
rispondenza a stati d’animo, vizi, abitudini e storture del costume letterario
d’oggidì, i quali son forse perenni, fatalmente connaturati al medesimo esercizio
delle lettere e alle sue presunzioni. Quel che ci preme, però, soprattutto mettere in
rilievo, oltre al filo, implicito, d’un umanesimo e d’una eticità che lega l’una
all’altra le annotazioni di Angelo Barile, è il garbo e la signorilità del suo ognora
icastico discorso: una civiltà di modi e di sentimento che si va perdendo e dalla
quale tutti avrebbero qualcosa da guadagnare, sforzandosi di salvarla in sé e negli
altri29
.
Il volume presentato si mostra con tutti i caratteri della distinzione.
In primo luogo, nel senso che esso è strutturalmente lontano dall’essere
uno studio sistematico sulla letteratura italiana contemporanea: non ha
dunque pretese di completezza o esaustività; inoltre, Grande sottolinea
come il fatto che tali prose siano state prodotte in un clima culturale e in un
contesto diverso da quello coevo, e ad esso primariamente siano state
riferite, non costituisca un valore limitante: piuttosto, l’aver individuato
alcuni elementi negativi nell’esercizio delle lettere, funge da mònito per
quei vizi, e vezzi, che fanno parte della natura di chi fa letteratura. Proprio
il fatto di non obbedire a canoni critici precostituiti, quindi, sembra essere
per Grande un vaglio d’eccezione, tale da garantire una validità universale
all’opera di Barile. Infine, un ultimo elemento della particolarità di questa
opera è il tono civile e, per usare un termine caro a Barile, “affabile” della
sua prosa, lontano dalla perentorietà con cui sono solite svolgersi le
schermaglie letterarie.
Per approntare la nuova edizione, Barile attese con lunga lena al
testo delle sue prose, già apparse su «Circoli» e sul «Gallo». Simona
Morando afferma come il lavoro del poeta fosse rivolto non solo alla forma
dei singoli testi, ma soprattutto alla quantità degli scritti da pubblicare,
optando per una drastica selezione di indirizzo decontestualizzante,
scartando quegli esiti che erano percepiti con troppa attinenza all’ambiente
culturale degli anni Trenta30
.
I due testi apparsi su «Persona» col titolo di Minuterie e di
Risonanze (rispettivamente il 1° aprile e il 16 settembre 1960) continuano
l’abitudine bariliana di redigere brevi pensieri incisivi e stimolanti la
Chiamato a far parte del primo Comitato di redazione, vi collaborai attivamente con non
poche poesie riunite poi in Primasera (1937). Ed erano miei, benché non firmati, quasi tutti
i corsivi, le cosiddette Risonanze che davano un certo sapore, un certo sorriso a ogni nostro
fascicolo. Pensieri sulla poesia note di costume letterario, spunti polemici, divertimenti,
ironie: con l’intenzione, sempre più scoperta, di far valere in pieno ermetismo le ragioni di
una vigilata chiarezza e di un’apertura, una gioia di canto fra le tante voci desolate» (cit. da
p. 7). 29 Vd. BARILE, Risonanze, cit., pp. 103-4. 30 SIMONA MORANDO, In nome della poesia, ivi, pp. 105-38, a p. 131.
11
riflessione sui costumi letterari italiani in modo critico e puntuale. Nel
primo, Barile prende le mosse da un assunto generale e da frasi autorevoli e
perciò agevolmente condivisibili. Il procedimento seguito, al di là della
scansione editoriale dei paragrafi (sempre presente e comunque funzionale
a creare una pausa di silenzio per la meditazione), tende ad uno
svolgimento lineare del pensiero dell’autore. Avendo guadagnato sulla
scorta di Pascal e Leopardi il pensiero sulla fragilità e la piccolezza
dell’uomo, Barile sposta il fuoco sulla doverosa integrazione di libertà e
necessità, per poi guidare l’attenzione del lettore sulla questione dei
quotidiani, sfruttando un passaggio di Joubert31
. Da qui l’interesse
dell’autore si dirige alla deprecabile abitudine dei giornali di esaltare
apparentemente la nobiltà dell’uomo e il rispetto della persona
(riassumendo in tal modo le premesse teoriche inizialmente esposte), ma
nella pratica di sfornare «notizie orripilanti» senza mai segnalare un «fatto
gentile». Le Risonanze apparse nel numero di settembre invece lamentano
la pioggia di carta stampata che viene donata a qualsiasi poeta affermato e
specialmente al critico per lo più con l’invito di recensione. Esse si
dirigono contro l’eccessiva quantità della produzione in versi che in modo
preoccupante spuntano come «funghi» nelle nostre Lettere. Lo scritto si
accomuna per i temi trattati a molte delle Risonanze apparse in volume32
e
documenta l’interesse di Barile per la produzione e la circolazione dei testi,
ossia per quella che oggi chiameremmo sociologia della letteratura.
Questi due testi, di numero contenuto ma perfettamente
sovrapponibili agli altri usciti in volume, sono esemplari dello stile delle
Risonanze. Si tratta di una prosa compassata che alterna argomentazioni ed
espressioni gnomiche. La preferenza accordata al nesso coordinante
(specialmente le congiunzioni e e ma) e la presenza di elementi ripetuti
(«pure… pure»; «una pagina, almeno una pagina»; «forse una scoperta;
forse, chissà, un’amicizia»; «l’omaggio, l’unico omaggio») producono un
andamento ritmato che anima la scrittura assieme alla ricorrenza di
sostantivi alterati («raccoltine, libriccini di versi»; «chiacchiericci») e di
metafore e similitudini: la «libertà e responsabilità» sono come «il canto e
l’accompagnamento della pagina musicale»; la «notizia orripilante» e le
«stupidaggini» dei giornali diventano «l’amaro caffè […] inzuccherato
oltre misura»; gli «atti di spontanea bontà o di consapevole coraggio […]
rinnovano e profumano l’aria come la luce del mattino nella stanza che sa
di sonno e di fantasmi»; versi che sono come «funghi» di un «sottobosco»
letterario; in un caso la figura retorica è anche protratta: «gli omaggi che
31 Autore citato anche ivi p. 18 e che che sembra essere particolarmente gradito al gruppo di
«Persona»: lo ritroviamo per esempio nella rubrica Controluce (I, n° 9, 16 luglio 1960, p. 4)
firmata da Cam[ilucci] e nell’anonimo estensore dello riquadro Spartivento (I, n° 8, 1°
luglio 1960, p. 10). 32 Si vedano Troppi versi (BARILE, Risonanze, cit., pp. 22-4), Amori segreti (ivi, pp. 25-6),
Poesia a getto continuo (ivi, pp. 29-30), Troppa gente in cortile (ivi, pp. 63-5).
12
piovono addosso» si mutano drammaticamente in un «diluvio di versi». Il
lessico è sempre sorvegliato e l’aggettivazione precisa («riferimento
compiaciuto, indugiante»). Su tutto aleggia un tono garbato che colora di
sottile ironia l’aneddoto narrato aprendo la mente alla riflessione. Barile
non rinuncia a esprimere giudizi netti («la disgrazia di essere critico»; «il
mondo della noia»; le recensioni di poesia come «chiacchiericci a
mezz’aria») senza però mai scadere nella polemica o nel grottesco, anzi
quasi lasciandoli en passant, pronti affinché il lettore li possa cogliere.
Accostabile alla scrittura delle Risonanze è la prosa Peccato
d’omissione, non tanto per la struttura formale, quanto per l’intento
comune di presentare una riflessione di indirizzo morale. Il testo nasce
dalla lettura della memoria profusa sulla figura scomparsa di Vieri
Nannetti, scrittore convertito, da Mario Gozzini, esponente della rivista
fiorentina cattolica «L’Ultima», che esprime il proprio rammarico per non
aver saputo «aprirsi con lui a una fraternità vera». Barile legge nella
confessata diffidenza di Gozzini ad apprezzare appieno un parvenu della
fede la tendenza più latamente cattolica alle contrapposizioni e alle antitesi,
mirando a preferire («quando per timidità, quando per povertà di cuore») i
propri simili, trascurando «l’intimità di ognuno, la sua propria favilla di
luce».
Gentile miracolo narra la vicenda dell’immagine quattrocentesca
della Madonna delle Grazie che, durante i lavori di costruzione della
cattedrale savonese all’inizio del Seicento, si staccò autonomamente dalla
colonna sulla quale venne dipinta, che sarebbe stata demolita. Il testo,
accolto postumamente nell’antologia Al paese dei vasai, è importante per
saggiare il tema che parte della critica ha definito come mistico. Il tempo e
lo spazio sono infatti visitati dal divino: «costruire una cattedrale con le
nostre mani, lavorare lo spazio a gloria di Dio», «il miracolo accadde
nell’ora del mezzodì, che è un’ora sacra», fino a concludersi con l’aforisma
finale con il quale l’autore manifesta il desiderio della «dolce Madonna che
ha voluto restare con noi». Un passaggio è poi rilevante e rappresenta la
chiave interpretativa dello scritto:
Quanta parte della nostra storia, e la più cara, è iscritta nelle vecchie pietre delle
nostre cattedrali e ascende su per le loro cupole o in vetta ai loro pinnacoli. Di
fronte a quei muri anche i palazzi gentilizi perdono di alterezza e le case dei poveri
consolano alla loro ombra le proprie pene e fatiche.
La coralità degli uomini sorta dal senso di un’appartenenza comune a un
progetto che non è solo umano porta “consolazione”. Il cielo cala sulla
terra e proprio per questo motivo la «fatica» dell’uomo è «convertita in
letizia». Inoltre, la prosa che si declina nel senso di una chiarezza
comunicativa non è priva di elementi retorici: tessere abbastanza tipiche
del parlato («anonimo sboccio dal cuore di un popolo», «il fiore della sua
13
arte», «ride il cielo di marzo»), si accompagnano a strutture più ricercate:
«Tanto è lo stupore che non li lascia parlare, poi trabocca in letizia di
abbracciamenti e preghiere e straripa nell’esultazione di tutto il popolo
accorso»33
. Il lessico è sempre seletto e sono le coppie sostantivo-aggettivo
e verbo-avverbio ad essere usate in modo sorvegliato ed efficace: «rilevarsi
animosamente», «gentile miracolo», «involontaria poesia», «ingegno
meravigliosamente testardo», «membra docili e lievi». All’apparenza
essenziale tanto da sembrare quasi semplice, Gentile miracolo si rivela
essere un testo assai significativo, non solo per l’adozione di alcuni tratti
stilistici che qui vengono attivati, ma anche per i rilievi contenutistici che si
situano alla base della poetica bariliana.
3. Prose critiche
Sotto questa etichetta sono stati catalogati quegli scritti – presentazioni,
memorie, letture – di stampo non creativo che fanno riferimento a
esponenti della letteratura, e in un caso dell’arte, italiana, con l’intento di
fornire elementi di natura critica. Si è preferito suddividerli in base ai
soggetti trattati.
a) Saba. La lettura bariliana della poesia dello scrittore triestino
costituisce un capitolo di indubbio valore nell’ermeneutica e nella fortuna
sabiana34
. All’origine del sodalizio sta un’antologia degli scritti del poeta
aparsa su «Circoli» nel numero di marzo-aprile del 1933, cui venne
premessa un’introduzione di Barile dal titolo Lo sguardo di Saba: essa si
inseriva nel contesto di un percorso rivalutativo della poesia sabiana
organizzato a cavallo degli anni Trenta in maniera esemplare prima da
«Solaria» e in seguito dalla rivista ligure35
. In quel testo veniva rilevata la
caratteristica sensibilità dello sguardo sabiano, capace di cogliere le «care
cose» con «stupefazione e candore». Auspice questo scritto l’amicizia fra i
due poeti sboccia cordiale e Come ho conosciuto Umberto Saba è uno
33 Il corsivo è di chi scrive. 34 Forse mai considerato col giusto peso dalla critica se non dallo stesso Saba. Si veda
UMBERTO SABA, Storia e cronistoria del “Canzoniere”, in ID., Tutte le prose, Milano,
Mondadori, 2001 (I Meridiani), p. 240. Sugli interventi bariliani tace anche FRANCESCO
MUZZIOLI, Saba e la sua “fortuna”, in Il punto su Saba, atti del Convegno internazionale
(Trieste, 25-27 marzo 1984), Trieste, Lint, 1985, pp. 83-8. 35 ANGELO BARILE, Lo sguardo di Saba, «Circoli», Genova, III, n° 2, marzo-aprile 1933, pp.
4-14. Il fascicolo ospitò la raccolta di una ventina di poesie di Saba cui egli stesso appose il
titolo di Piccola antologia. Per l’interesse solariano si veda: Omaggio a Saba, «Solaria»,
Firenze, III, n° 5, maggio 1928. Barile scrisse negli anni altri contributi sulla poesia di Saba:
Un poeta e un libro, «Il Lavoro», Genova, 3 gennaio 1934; Letizia di Saba, «Circoli»,
Roma,V, n° 3, maggio 1935, pp. 359-66; Saba, poeta triestino, in ID., Incontri con gli
amici, Savona, Sabatelli, 1979, pp. 85-94; Il gioco del calcio nella poesia sabiana, «Il
Giornale d’Italia», Roma, 11 marzo 1965; Una poesia natalizia di Umberto Saba, «Il
Letimbro», Savona, 23 dicembre 1966, poi in «Persona», VIII, ni 1-2, gennaio-febbraio
1967, p. 25, che qui viene pubblicato. Si veda infine l’epistolario Saba-Barile edito nel
volume La poesia di Angelo Barile, cit., pp. 212-45.
14
scritto di natura memoriale che documenta l’incontro milanese nel giugno
del 1933 fortemente voluto da Saba e i successivi rapporti epistolari nei
quali si prolungava il dialogo sulla poesia: Barile sottolinea l’interesse
dell’autore del Canzoniere per le sue poesie e l’acutezza di «penetrante
lettore di poesia». Una poesia natalizia di Umberto Saba invece commenta
il raro sonetto giovanile Nella notte di Natale. La lettura di Barile è tesa a
contestualizzare questo esito, significativo ancorché acerbo (scritto appena
a 17 anni), all’interno della produzione sabiana, sottolineando la capacità di
ricondurre a unità le «care voci discordi» insite nel suo sangue, nelle «due
vite» donate dai «parenti», quella cristiana e quella ebraica. L’elemento che
Barile dimostra di apprezzare maggiormente è il «modo» con cui Saba
parla della poesia e che costituisce il riflesso del modo di incarnarsi sulla
pagina della lirica sabiana: «semplice e sincero» come di chi non ama le
parole, ma le «adopera» come «segni di una scrittura del cuore»36
.
b) D’Annunzio. Apparso su «Letteratura» nel marzo del 1939 e
poi riproposto su «Persona» nel fascicolo dedicato integralmente al poeta
abruzzese37
, Come ho letto D’Annunzio esprime fin dalle prime battute non
solo l’impossibilità per Barile di aderire ma anche la difficoltà di
apprezzare pienamente la poesia del Vate38
. La denunciata «mancanza di
riposo» contrasta vivamente con la concezione – cui si è fatto cenno –
“religiosa” che il poeta di Albisola perseguiva, che anzi esige silenzio e
attesa39
. Barile riconosce «con quello della parola, il dono di luce che egli
ci ha fatto», ma contrappone la necessità della ricerca dell’«ombra amica al
cuore dell’uomo», quasi un rifugio sub tegmine fagi, contro il luminescente
fulgore del mezzogiorno dannunziano. Ancora: il prodotto poetico di
D’Annunzio «passa subito in canto» e si arresta alla superficie poiché
«incapace di eliminazione» – mentre Barile ha sempre agito nell’indirizzo
della forza comunicativa delle parole, ritornando più volte sui medesimi
testi. La mancanza di «quella seconda navigazione platonica che avevo
sentito, calmo, nei grandi poeti» impone che la poesia dannunziana si limiti
a una voracità istintiva, impedendogli di raggiungere «l’intima
trasparenza». L’autore passa in rassegna in seguito alcuni momenti della
poesia di D’Annunzio dove «l’attenuarsi della sua ferinità» lascia
trasparire esiti armonici e a Barile particolarmente graditi, tanto da
riconoscerglisi quasi prossimo. La consapevolezza della presenza attiva ed
36 BARILE, Letizia di Saba, cit., p. 360. 37 «Persona», Roma, IV, n° 12, dicembre 1963. L’articolo di Barile apre il fascicolo. 38 ANGELO BARILE, Come ho letto D’Annunzio, in Omaggio a D’Annunzio a cura di
GIUSEPPE DE ROBERTIS e ENRICO FALQUI, pp. 90-2, fascicolo fuori serie di «Letteratura» del
marzo 1939, che riporta le risposte al questionario proposto dalla redazione della rivista su
D’Annunzio. Per il rapporto con la poesia di D’Annunzio si può vedere CLAUDIO
MARCHIORI, Angelo Barile: due giudizi su D’Annunzio, in Omaggio ad Angelo Barile, cit.,
pp. 119-23. 39 BARILE, Risonanze, cit., p. 29.
15
operante del Vate nella lirica italiana porta ogni autore che lo segue a
rapportarsi inevitabilmente a lui:
La liberazione dal suo dominio fu nelle nostre lettere una specie di passaggio del
Mar Rosso. Si apersero le acque e più di una generazione vi andò sommersa: gli
altri, quelli decisi a guadagnare la libertà, non si salvarono da D’Annunzio se non
fuggendo e approdando a queste magre argille della nostra poesia, dove si erra e
cammina verso la terra promessa senza nessun Mosè che ci guidi, ma solo la spinta
del cuore e forse il profumo della ginestra.
Al di là del richiamo alla ginestra, appare rilevante il riferimento al cuore:
Barile conosceva il «pensiero di Leopardi ove è detto dell’influsso del
cuore nella poesia come di un soavissimo olio che le infonde pastosità e
morbidezza»40
; forse con l’intento di additare significativamente in
conclusione del proprio intervento alla densità pensosa unita alla
leggerezza espressiva del poeta recanatese come al saldo porto cui tornare
per divincolarsi dalle turbinose acque dannunziane.
c) Sbarbaro. Pubblicato nuovamente a cura della redazione della
rivista in occasione della morte del poeta di Resine, seguita a pochi mesi a
quella di Barile, Confidenziale è un omaggio che quest’ultimo stilò per la
ristampa di Pianissimo, presso Neri Pozza, nel 195441
. Barile ripercorre gli
albori dell’amicizia con Sbarbaro, le mutue letture dei testi poetici e
fornisce alcuni tratti della biografia del poeta di Spotorno. Alcuni elementi
devono essere rimarcati: innanzitutto la fedeltà di Sbarbaro alla poesia («ha
ubbidito alla sua vocazione di poeta come all’unica legge»), che lo ha
portato a svincolarsi totalmente dal mondo e dai commerci letterari; in
secondo luogo, l’individuazione del nucleo ispirativo di Pianissimo nella
figura del padre. Infine, Barile avverte come, nonostante Sarbaro l’abbia
rinnegato in più modi, si possa leggere «il segno […] della tua carità», che
nasce come fiore dalle macerie.
d) Altri testi. La messa di don Clemente è un ricordo del breve
incontro avuto con Rebora già malato a Stresa nell’ottobre del 1954. Barile
40 ANGELO BARILE, Poesia affabile, «Circoli», Genova, II, novembre-dicembre 1932, n° 6,
pp. 94-9, a p. 95. Sul tema del cuore in Leopardi si può consultare il volume di MICHELE
DELL’AQUILA, Le fondazioni del cuore. Studi su Leopardi, Fasano, Schena, 1999. Per la
presenza di Leopardi in Barile si veda GUGLIELMINETTI, Le varianti di “Primasera” e il
leopardismo di Barile, cit., pp. 138-51. Barile inoltre cita spesso Leopardi sia nelle
Risonanze – tanto in quelle raccolte in volume quanto in quelle pubblicate esclusivamente
su rivista – che negli altri scritti di stampo critico. La ripresa di Leopardi è però una
consapevolezza comune e radicata in molti degli intellettuali del tempo. Si vedano a titolo
esemplare alcuni interventi di Vittorini: Scarico di coscienza, «L’Italia letteraria», Roma, V,
n° 41, 13 ottobre 1929, p. 1 (ora in ID., Letteratura, arte, società. Articoli e interventi 1926-
1937, Torino, Einaudi, 1997, pp. 121-26); Arsenio, «Circoli», Genova, I, novembre-
dicembre 1931, pp. 79-101 (Ivi, pp. 366-86). 41 ANGELO BARILE, Confidenziale, «La Fiera letteraria», Roma, XXXIX, n° 46, 13
novembre 1955, p. 4.
16
sottolinea come poesia e umanità in lui «scaturiscano insieme», e la figura
del sacerdote Rebora diventa esemplare di quella vita che unifica preghiera
e poesia come espressione dell’amore divino e insieme pienamente umano.
Specchio dell’anima, la pittura di Berzoini presenta la pittura
dell’artista come «bisogno ingenuo, e commovente di poesia», il cui colore
è «d’anima e d’innocenza». Anche in questo testo appare la vena aforistica
che tende a riassumere in modo sintetico un concetto ritenuto rilevante
dall’autore: così in quel «anche il sonno lavora» è possibile riconoscere
non solo un contenuto già presente in altri luoghi, ma anche stilisticamente
la capacità suntiva che racchiude la riflessione. Il pensiero viene enunciato,
ma Barile lo pulisce e lo scrosta dalla catena del ragionamento che lo ha
ispirato, in modo da produrre incisività e chiarezza, semmai accostando
un’aggiunta esegetica espressa con vena icastica e spesso sostenuta da
metafore e similutudini. Si vorrebbero segnalare taluni esempi:
Anche il sonno lavora, e un principio attivo di arte o di poesia, chi lo ha dentro di
sé, gli germoglia inavvertito come il seme nella zolla (Specchio dell’anima, la
pittura di Berzoini).
Gentile miracolo. Così discreto, così silenzioso che ci prende incantevolmente il
cuore (Gentile miracolo).
Vero è che i poeti crescono anche all’asciutto, come ogni giorno si vede. Nel
nostro sottobosco i funghi nascono fitti anche quando non piove (Risonanze).
Un vortice, se posso dire, orizzontale: una di quelle raffiche che passano sul mare
e non si fa in tempo a seguirle, a vedere dove muoiono e come riprendono, vere
figure dell’inquietudine (Come ho letto D’Annunzio).
Fatica senza fatica. L’impegno, lo scrupolo che [Sbarbaro] vi mette è solo
eguagliato dal piacere che prova e che partecipa vivamente ai suoi allievi
(Confidenziale).
Musica in te sciolta, li assumi nel cielo della tua anima […]. Allineati nella tua
libreria, ne leggi talora per costola il nome, il titolo e l’anno: è un epitaffio: guarda
che vita breve, che monca esistenza (Lettura di poesia)42
.
La poesia non soffre attributi. Se è nuova, è al modo delle foglie di primavera che
non si può immaginare freschezza più antica – e diversa (Minuterie)43
.
Questa tendenza sintetica e, abbiamo detto, aforistica è parte costitutiva e
sempre attiva dello stile bariliano, in modo speciale presente nelle
42 BARILE, Risonanze, cit., p. 11. Le citazioni precedenti sono tratte dai brani pubblicati su
«Persona», presentati in calce a questo articolo. 43 Ivi, p. 51.
17
Risonanze. Anche quando l’autore esprime e sviluppa il proprio pensiero in
modo esteso, non rinuncia a darne un conto suntivo con un giro brevissimo
di parole.
“La Colombera” di Riolfo e“Vigilia” sono le prefazioni delle
edizioni delle poesie rispettivamente di Silvio Riolfo e di Adriano Sansa.
Questi testi documentano l’attenzione di Barile nel seguire i giovani poeti,
attività che egli svolgeva non come «un critico», ma come «un vecchio
poeta che scambia l’abbraccio di rito, e di cuore, con un fratello novizio».
Proprio in queste brevi parole stanno molte delle linee portanti della
poetica dello scrittore di Albisola: la poesia come esperienza pienamente
umana e quasi religiosa (qui palesata dalla similitudine); la rinuncia
all’appellativo ingombrante di critico letterario per guadagnare invece
l’«affabilità» dell’abbraccio fraterno; la consapevolezza di come
l’esperienza poetica, al pari di quella umana, sia condotta coralmente e non
in solitudine.
Ti esorto a coltivare più la prosa che la poesia, giacché è sempre meglio
essere un ottimo prosatore che un mediocre poeta. Potresti però venire un
critico sì letterario che artistico di vaglia; giacché per la critica sei nato
quasi apposta44
.
Con queste parole Carlo M. Invrea, docente al Seminario Vescovile di
Savona dove il giovane Barile frequentò il ginnasio, aveva forse
precocemente compreso la promettente capacità di accostamento ai testi
del suo allievo. L’intelligenza critica di Barile appariva già evidente, al di
là dei futuri validi esiti poetici che Invrea non poteva immaginare, sfociati
in Primasera, Quasi sereno, A sole breve: titoli ariosi che sembrano
denunciare un tempo breve, in divenire, e insieme un limite. Forse a
ricordare che la poesia, come la vita, non è un plenum: qui, in queste
plaghe di creta e di mondiglia, è solo parziale.
44 Lettera di Carlo M. Invrea a Barile del 15 maggio 1904 (ANGELO BARILE, Quaderno
primo, a cura di Giovanni Farris, Savona, Sabatelli, 1984, p. 7). Invrea in breve tempo
parve parzialmente mutare opinione sulle doti poetiche dell’allievo, ma consigliò sempre la
necessità di coltivare l’esercizio critico: «La tua trilogia mi ha fatto mutare in certo qual
modo opinione, giacché mi è ora nata la speranza che oltre che buon prosatore e critico
possa tu divenire anche buon poeta, mi rimane però sempre la convinzione che tu riesca
meglio nel campo della prosa e della critica che non in quello della poesia. […] Sì, te lo
ripeto, hai pensieri splendidi, ma la tua poesia non mi piace. […] A parer mio tu dovresti
dedicarti più alla prosa che alla poesia»; «Insomma questa volta non c’è male e sono ora
convinto che nella poesia come nella critica puoi farti onore» (lettere di Invrea a Barile
ripettivamente del 22 maggio e del 2 luglio 1904, ivi, pp. 7-9).
18
Si pubblicano i contributi di Angelo Barile apparsi su «Persona» dal 1960 a
1971. Si mantengono le peculiarità grafiche dell’originale; quando ci si
discosti, appare indicato in nota. Gli interventi editoriali sono minimi: sono
stati corretti i refusi ed è stata normalizzata l’accentazione, sia per le parole
italiane che per quelle straniere. Tra parentesi quadre sono aggiunte le
integrazioni. Tre testi sono firmati «Figulo»: questo è il nom de plume col
quale Barile – proprietario di un’azienda familiare di ceramiche («la Casa
dell’Arte» di Albisola) – siglava alcuni interventi fin dai tempi di
«Circoli»45
.
1. «Persona», Roma, I, n° 2, 1 aprile 1960, p. 4
Minuterie46
Che la grandezza dell’uomo sia avvalorata dalla coscienza e dal sentimento ch’egli
ha della sua fragilità e piccolezza è pensiero comune ad alcuni dei maggiori
scrittori. Almeno in partenza, lo troviamo eguale in Pascal e in Leopardi. Dice
Pascal: «L’homme est si grand que sa grandeur paraît même en ce qu’il connait
misérable»47
. E non diversamente il Leopardi: «Niuna cosa maggiormente
dimostra la grandezza e la potenza dell’umano intelletto, né l’altezza e la nobiltà
dell’uomo, che il poter dell’uomo di conoscere e interamente comprendere e
fortemente sentire la sua piccolezza»48
. Coincidenze come queste certificano al
massimo la verità di un pensiero.
Libertà e responsabilità sono come il canto e l’accompagnamento in una pagina
musicale: devono armoniosamente integrarsi.
Ha scritto Joubert che quasi sempre l’opinione del giornale è un’opinione da un
soldo49
. Può essere vero; ma moltiplicato per il numero dei lettori e dei giorni
quello spregevole soldo acquista un valore pauroso.
45 In una Risonanza l’autore stesso sovrappone il lavoro del ceramista e il mestiere del
poeta. Vd. Piccola allegoria del figulo, in BARILE, Risonanze, cit., pp. 101-2. 46 Testo non presente nell’edizione delle Risonanze. 47 BLAISE PASCAL, Pensées, introduction et notes par CHARLES-MARC DES GRANGES, Paris,
Éditions Garnier Frères, 1964, Article sixième, VI, 397, p. 171. 48 GIACOMO LEOPARDI, Zibaldone, Milano, Mondadori, 1997 (I Meridiani), 3171, 12 agosto
1823, vol. 2, p. 1983. 49 Non mi è stato possibile rintracciare il passo preciso cui fa riferimento Barile, nonostante
le diverse edizioni, in lingua e in traduzione, consultate. Joubert nei suoi Carnets si riferisce
in talune occasioni allo stile e alla scrittura dei journaux. Se ne ripropongono alcuni assaggi:
«Journaux. “D’un divertissement on fait une fatigue.” Se lisent vite; ne doivent contenir que
des pensées qui ne puissent pas arrêter l’esprit du lecteur. Un journaliste, pour être bon, ne
doit pas être trop supérieur au public, mais un primus inter pares»; «Personne ne peut aussi
bien faire un journal qu’un homme d’esprit qui n’est pas capable de faire mieux»;
«Merchands de bruits, et qui les vendent: journalistes, nouvellistes, etc.». Vd. JOSEPH
JOUBERT, Pensées et lettres, présentés par RAYMOND DUMAY, Paris, Bernard Grasset, 1954,
p. 235.
19
Apri un giornale qualunque e vicino all’articolo che forse esalta la nobiltà
dell’uomo e predica il rispetto della persona ti prende gli occhi la notizia
orripilante, più spaventosa di quella di ieri, ma non più orrenda di quella che vi
leggerai domani. Però fa coraggio e va avanti, che subito dopo ti aspetta,
affiancato al fattaccio, il riferimento compiaciuto, indugiante, delle mezze
sudicerie e delle stupidaggini intere in cui si avvoltola il mondo della noia. È
l’amaro caffè che il giornale ti porge ogni mattina, però te lo serve inzuccherato
oltre misura: accanto alla cronaca nera la cronaca fatua, la quale non è meno triste
dell’altra e le fa da concime.
Possibile che non vi sia mai da rilevare un fatto generoso, gentile? Da cogliere uno
di quegli atti di spontanea bontà o di consapevole coraggio, a volte bellissimi, che
rinnovano e profumano l’aria come la luce del mattino nella stanza che sa di sonno
e di fantasmi? È vero che la schietta virtù sta nascosta; ma perché non tentare
almeno un principio di cronaca bianca? O vogliamo, codesti atti che confortano la
nostra speranza, riservarli soltanto per il premio della notte di Natale?
Il Figulo
2. «Persona», Roma, I, n° 9, 16 luglio 1960, p. 3
Peccato d’omissione
Gli amici fiorentini de «L’Ultima» han dedicato un recente quaderno della loro
rivista alla memoria di Vieri Nannetti, del quale hanno illuminato con gentile pietà
e penetrante finezza la singolare figura. Tra le varie testimonianze rese all’uomo e
al poeta una ci è sembrata particolarmente accorata: la «confessione» con cui
Mario Gozzini esprime il suo pungente rammarico di non aver saputo, in una
vicinanza durata negli anni, aprirsi con lui a una fraternità vera50
.
«Troppa diversità di partenza, mi sembrava, tra le sue esperienze letterarie, il suo
giuoco intelligente e divertito, e la ricerca nostra, che, sia pure in forme diverse e
magari confuse, era sempre stata fin dagli inizi consapevolmente religiosa». Ed
ecco invece, anche se tardivo, il giusto riconoscimento di una profonda sostanziale
convergenza, di un medesimo itinerario religioso, nel quale, anzi, Nannetti col suo
passo spedito di poeta ha avanzato i suoi compagni di viaggio. «Partito – scrive
Gozzini – dalle Giubbe Rosse, della letteratura-divertimento, era approdato a
quelle sponde dove la poesia si fa contatto diretto con un Assoluto che ha le
sembianze non più vaghe, non più astratte, del Dio Persona… venuto sulla nostra
strada medesima, era andato ben più avanti di noi».
È una confessione che fa onore al poeta morto e all’amico che lo rimemora per un
bisogno d’ammenda. E come ogni confessione sincera essa ha un suo dolore di
pentimento, e in quel dolore trova una luce, più larga, che rischiara il cammino
anche degli altri. Dice Gozzini: «Le omissioni: in fondo, ecco il nostro peccato
50 MARIO GOZZINI, Confessione necessaria, «L’Ultima», Firenze, XIV, vol. IX, n° 92-93,
pp. 171-74. Il fascicolo è interamente dedicato a Vieri Nannetti.
20
quotidiano, la trama segreta della nostra vita». Parole di verità, che toccano una
zona d’ombra della nostra coscienza e vi scoprono un vuoto, un difetto, che si
riflette nel nostro costume quanto è più nascosto e inconfessato a noi stessi.
Difetto di attenzione e fiducia, difetto di avvicinamento umano, dunque di amore
verso i fratelli. I quali tante volte noi consideriamo lontani, o diversi, sol perché
«in partenza» sono fuori della nostra cittadella in cui ci teniamo se non proprio
chiusi, per lo più con l’animo degli isolati – o degli assediati. Perché questo? Per
quello spirito di famiglia, per quel gusto per le affinità elettive che se vale per le
élites, non può certo valere per l’anima cristiana? Non crediamo che la ragione sia
questa. Né quel distacco avviene sempre per una vera necessità di difesa, per la
giusta preoccupazione di non confondere e contaminare le acque.
Quando per es. Gozzini, in quella sua confessione, rivendica il carattere in qualche
modo sacro della poesia e la posizione presa dagli Ultimi (ma non soltanto dagli
Ultimi) contro una certa letteratura-divertimento «troppo frettolosamente e
baldanzosamente imbarcatasi a parlare di Dio, cedendo alle suggestioni della moda
più che a un’intima necessità e vocazione di fondo», quando ricorda queste cose
santissime, chi potrebbe e vorrebbe mai contraddirlo? C’è da credere che i primi a
consentire, a batter le mani saranno stati di certo, già in quel periodo, i poeti e
scrittori seri anche dell’altra sponda, anche delle Giubbe Rosse (ammesso il
riferimento alle Giubbe Rosse solo per comodità di discorso, per amor fiorentino
di contrasto, ché diversamente non sarebbe accettabile tanto è indiscriminato e
generico). Ma detto questo vorremmo anche aggiungere, con tutta la stima che
abbiamo di un uomo e di uno scrittore come Gozzini, che quello stacco così netto,
così scavato, tra le sponde, può colpire – ferire – un’anima semplicemente ma
genuinamente cristiana: finisce, cioè coll’apparire esso stesso un peccato
d’omissione, e questa volta più esteso, a catena, non più soltanto verso un amico.
Per grazia di Dio è sempre avvenuto e avverrà sempre che «l’uomo si avvia per
una strada e frequentemente torna per un’altra». Vorremmo proprio aspettare che
sia lui a mettersi al nostro fianco, a inserirsi con noi in una esatta dimensione
cattolica? E se provassimo a muovergli incontro?
A parte lo spunto fiorentino, troppe esperienze anche recenti ci dicono che
all’origine dei nostri peccati di omissione sta soprattutto una mancanza di coraggio
e di amore. «Ama e fa quel che vuoi»51
. Invece si direbbe che noi cattolici più che
alle distinzioni – necessarie – siamo portati alle contrapposizioni, alle antitesi, le
quali esprimono un po’ sempre uno stato ancora grezzo dell’animo; e tuttavia ne
usiamo più del bisogno, quando per timidità, quando per povertà di cuore. Per cui
avviene talvolta che dalle contrapposizioni dalle idee siamo indotti quasi
inavvertitamente a contrapporre anche gli uomini, a giudicarli in blocco, a
trascurare l’intima verità di ognuno, la sua propria favilla di luce. Nessuna
confusione di principi, ma neanche questo allontanamento e distacco dagli altri.
Ad aver più fiducia, a mescolarci più che non facciamo alla gente diversa da noi, a
sentirci non su una sponda ma nel vivo della corrente, ci ha tutto da guadagnare il
nostro bisogno di carità.
Figulo
51 S. AGOSTINO, Commento alla Prima lettera di Giovanni, Omelia 7, 8 (vd. ed. Roma, Città
nuova, 1970, p. 183).
21
3. «Persona», Roma, I, n° 9, 16 luglio 1960, p. 4
Gentile miracolo52
Il miracolo di Nostra Signora della Colonna è così bello che va raccontato.
Siamo a Savona all’alba del Seicento, quando la città comincia a rilevarsi
animosamente dalle rovine e dai lutti della guerra con Genova: mozzate le torri, il
porto interrato e, sull’acropoli del Priamar, abbattuta persino l’antichissima
Cattedrale intitolata all’Assunta. Ora un’altra ne sta sorgendo, non più sulla rocca
marina ma nel cuore vivo della città, e le prima luce del secolo ne illumina già le
alte strutture.
Costruire una cattedrale con le nostre mani lavorare lo spazio a gloria di Dio…
Viene in mente l’umile scalpellino che canta allegro sul suo mazzuolo e al
forestiero che si meraviglia di quella sua fatica convertita in letizia risponde con
due parole: costruisco la Cattedrale.
Prima che una grande opera è sempre un mirabile fatto, questo anonimo sboccio
dal cuore di un popolo. Altare di Dio e Cattedra del Vescovo; ma è anche il
massimo decoro della Città, il fiore della sua arte e il fastigio della sua potenza.
Quanta parte della nostra storia, e la più cara, è iscritta nelle vecchie pietre delle
nostre cattedrali e ascende su per le loro cupole o in vetta ai loro pinnacoli. Di
fronte a quei muri anche i palazzi gentilizi perdono di alterezza e le case dei poveri
consolano alla loro ombra le proprie pene e fatiche.
Ma veniamo a Savona. Venerata sotto vari titoli (la Misericordia, l’Assunta…),
nella Cattedrale savonese, la Vergine lo è anche per questa sua Immagine antica
che “si spiccò e calò da sé giù per la colonna”. Gentile miracolo. Così discreto,
così silenzioso che ci prende incantevolmente il cuore. A leggere le grezze parole
che testimoniano il fatto è impossibile non sentirne la verità, la vivezza e
l’involontaria poesia.
Il miracolo accade nell’ora del mezzodì, che è un’ora sacra. Forse l’Angelus è già
suonato, e nell’immenso cantiere, frammezzo alle opere interrotte e alle
impalcature giganti su cui ride il cielo di marzo, son rimasti cinque uomini, sei col
curato della cattedrale che vi fa il suo solito giro: un fabbro, un fornaio, un cassaro,
una mastro muratore, un cimatore di panni: gente tutta di popolo, artigiani che han
la vista buona e la parola sincera. Qualcuno forse di essi, non addetto ai lavori, ha
profittato dell’ora per venire a darvi un’occhiata e misurarne, come ogni tanto fa,
l’andamento. In tre, in quattro fan crocchio e commentano crucciati il recente
responso dell’architetto della fabbrica, Battista Sormano, il quale, dopo aver
saggiato a lungo l’intonaco con le nocche e “con la picchetta”, ha pronunciato non
potersi levare intiera l’immagine della Madonna delle Grazie dall’antica colonna
in cui è incorporata e che andrà demolita.
Se ne angustiano i nostri uomini, e come non sanno rassegnarsi a tanta perdita,
obiettano e si arrovellano con quell’ingegno meravigliosamente testardo ch’è dei
bravi artigiani. E continuando a discutere eccoli già avviati alla colonna per quivi
52 Il testo è apparso in ANGELO BARILE, Al paese dei vasai. Santi, artisti, scrittori, paesi di
Liguria, Savona, Sabatelli, 1970, pp. 47-8.
22
ragionarne de visu, quando un grido alto e improvviso del curato Lamberti ve li fa
correre a precipizio, giusto il tempo per vedere e sostenere la santa Immagine “che
cala giuso pian piano”. Tanto è lo stupore che non li lascia parlare, poi trabocca in
letizia di abbracciamenti e preghiere e straripa nell’esultazione di tutto il popolo
accorso.
Se gentile è il miracolo, non è meno gentile l’immagine di questa mite Madonna
quattrocentesca che regge appena e sembra porgerci il Bimbo: tutta pura nel
giovanissimo viso allargato dalla mestizia degli occhi, il capo un poco inclinato
sotto il peso a lei troppo grave della corona, le membra docili e lievi quasi linee
figurative dell’anima. È la dolce Madonna che ha voluto restare con noi.
Angelo Barile
4. «Persona», Roma, I, ni 11-12, 16 settembre 1960, p. 22
Risonanze53
Per poco nome che uno abbia nel campo cintato della poesia (e non diciamo se è
un critico), non si contano gli omaggi che gli piovono addosso. Fossero omaggi di
vive e gustose primizie! Ma è carta stampata: raccoltine, libriccini di versi, ognuno
con la brava sua dedica. Può persino capitare che l’omaggio sia doppio: che la
plaquette gli rechi, per farglielo conoscere meglio, anche la fotografia dell’autore;
che in questo caso sarà piuttosto un’autrice, magari avvenente e invitante più dei
suoi versi.
* * *
A dire la verità non ci vorrebbe molta fatica a scorrere questi libretti, chi sapesse
vincere l’uggia che gli mettono in corpo. Ma sono mai tanti che, a volerli soltanto
«passare», nonché il tempo e l’allegria uno ci lascerebbe la vista. Perciò chi li
riceve, non avendo l’animo di avviarli senz’altro al loro destino, o forse
nell’illusoria speranza di affrontarli in un momento di deciso coraggio, li colloca
vergini – e impregiudicati – in un angolo dello scaffale, sul quale, anche se così
striminziti, fanno tutti insieme un peso eccellente.
* * *
Pure… Pure, nell’atto stesso di metterli in disparte, un pensiero punge come uno
spillo. In tanto folto ci sarà bene una luce. Una pagina, almeno una pagina
onestamente bella, in tutto quel cumulo di carta stampata ci sarà di sicuro. Forse
una scoperta; forse, chissà, un’amicizia… Allora sopravviene il timore di non
porgere la mano a chi offre timidamente la sua, di passare vicino a un’anima senza
vederla: che è sempre un peccato di trascuranza e di disamore. Una punta di
rammarico lo accompagna anche quando ha già dimenticato il nome dell’autore e
il titolo del libro; e questo rammarico è ancora l’omaggio, l’unico omaggio che in
53 Non pubblicato in BARILE, Risonanze, cit.
23
tanto diluvio di versi il mancato lettore può rendere al «poeta ignoto» fra i mille
che scrivono versi.
* * *
Naturalmente l’omaggio che ricevi sottintende un invito: che tu ti pronunci. Ve lo
leggi in trasparenza come una preghiera non detta; ma qualche volta l’invito è
dichiarato, e perentorio. «Per recensione». L’autore o l’editore, o tutt’e due
insieme, ti chiedono la contropartita. Oh gli incauti. A chi non ha la disgrazia di
essere critico di professione basta per lo più una richiesta siffatta per fargli cadere
il libro dalle mani nello stesso momento in cui l’apre.
* * *
A parte i saggi critici che vogliono tempo e attenzione, le solite recensioni di
poesia – questi chiacchiericci a mezz’aria – bisognerebbe davvero abolirle, come
han già fatto, del resto, i grandi giornali, che un tempo avevano le lor cronache
regolari di poesia, i loro ragguagli di Parnaso, e ora delle raccolte di versi neanche
dànno notizia tra i «libri ricevuti». Come si potrebbe disapprovarli? Il silenzio in
questo caso è una difesa, e può forse indirizzare chi scrive, se ha vocazione e
ingegno, a fatiche più meritorie.
* * *
Vero è che i poeti crescono anche all’asciutto, come ogni giorno si vede. Nel
nostro sottobosco i funghi nascono fitti anche quando non piove. Ricusati dal
mercato, non c’è altro modo di smaltirli che di mandarli in omaggio. Chi ne vuole?
* * *
A Bino Rebellato Editore in Padova e ai suoi poeti:
Claudite iam rivos, pueri, sat prata bibere.54
Figulo
5. «Persona», Roma, III, ni 1-2, 31 gennaio 1962, p. 7
A tarda sera55
A tarda sera quando
54 VIRGILIO, Bucoliche, III, 111 (edizione a cura di MARINA CAVALLI, Milano, Mondadori,
1990, p. 32: la lezione vulgata dà biberunt, probabilmente BIBĒRE nel testo che conosceva
Barile). 55 BARILE, Poesie, cit., pp. 146-7. La lezione delle liriche apparsa su «Persona» (“Pers”) è
stata collazionata con l’edizione milanese delle Poesie, cit. (“P”). Si dà notizia delle
varianti, quando esse occorrano, nelle note ai singoli testi.
24
prego pace ai miei morti,
ad una ad una vi chiamo per nome,
mie sensibili anime. In un lampo
a ciascun nome mi risponde il viso
desiderato,
e il sangue vi ripalpita vi segna
i suoi segreti.
Odono il mio sussurro anche gli anziani
che in grembo alla memoria
già posano quieti
e forse ancora anelano in cammino
per i valichi estremi al loro Cielo.
Un poco, andando, si volgono e alcuno
lontanamente sorride…
Ma questi,
al mio cuore più mesti,
che ieri appena spezzavano il pane
con noi sotto la lampada e nell’ombra
son passati tenendosi per mano,
lo sguardo al focolare:
questi quando la sera
chiamo per nome i miei morti, li vedo
ancora fermi, ancora
trepidi e tesi di là dalla porta
non richiusa, che geme.
Ecco mi fate cenno, anime care,
d’incamminarci insieme.
Angelo Barile
6. «Persona», Roma, III, ni 11-12, 30 giugno 1962, p. 10
I chierichetti della Stella maris56
I miei poveri occhi si ravvivano
se vi passa un’immagine giuliva
di fanciullezza.57
Vi sostano un poco
oggi ch’è festa, alla Messa cantata
nella mia chiesa,
i chierichetti della Stella Maris
56 BARILE, Poesie, cit., pp. 134-5. 57 di fanciullezza. / Vi] Pers di fanciullezza. Vi] P
25
rossovestiti: spiccano
più degli angeli d’oro
che li guardan dai corni dell’Altare58
.
Angeli anch’essi, ma sbozzati appena,
i tratti un po’ composti un po’ vaganti…
Le loro voci, i gesti,
m’aprono in petto pensieri ridenti.
E in cima – come un fiore –
il loro atto più amabile: quando
poco avanti la Mensa
l’uno dà all’altro la Pace.
L’abbraccio
di fratello a fratello
scende per i gradini dell’Altare59
,
dal celebrante giunge sino a loro,
e il più piccolo s’alza
leggero in punta di piedi, le mani
gracili tese come ali d’uccello,
il viso serio; ma tra i cigli guizza
ilare lampo…
Restatemi ancora,
cari fanciulli vestiti di fiamma
oh restatemi ancora
fermi in quest’atto – e beati.
Lì sopra
dagli azzurri marini del suo trono
la Madonna sorride
quasi giovane mamma innamorata
dei suoi bambini.
Angelo Barile
7. «Persona», Roma, IV, n° 12, dicembre 1963, pp. 3-4
Come ho letto D’Annunzio60
Quell’ardore di D’Annunzio, quel suo destino d’insonnia mi colpì ancora giovane,
non come un segno di privilegio, anzi piuttosto come un castigo. Sentivo che la
sua mancanza di riposo, che pareva dettata da un principio eroico, era incapacità,
assenza originaria di pace. Come poteva la poesia ricusare il raccoglimento, il
silenzio? Più tardi mi capitò di leggere che è proprio questo il rimprovero che Dio
58 dell’Altare] Pers dell’altare] P 59 dell’Altare] Pers dell’altare] P 60 Testo già apparso sul numero fuori serie di «Letteratura», marzo 1939, pp. 90-92. Poi
anche in BARILE, Incontri con gli amici, cit., pp. 51-5.
26
per bocca di un profeta fa al suo popolo: «Voi avete detto: Io non riposerò». Era la
stessa parola che D’Annunzio aveva scelta per sé e chiusa fra i lauri. «Per non
dormire». Più che superba, mi pareva carica di tristezza.
Mi indirizzavo alla poesia col verso del Petrarca alla Vergine: «O refrigerio al
cieco ardor che avvampa». Cercavo, secondo il mio bisogno e il mio gusto,
l’ombra amica al cuore dell’uomo, cara agli antichi anche prima di Cristo: senso e
struggimento dell’ora, senso del nostro passaggio. E D’Annunzio mi ricacciava nel
sole di mezzodì. Poi, anche la sua attenzione, il suo sguardo, cosa stupenda,
diveniva a tratti spaventoso come l’occhio della sua Sibilla:
L’occhio tuo fisso non sogna
né pensa, ma vede
come nessun altro mai vide.
Non lacrima né sorride:
vede meravigliosamente.
Altre volte, e più spesso, la sua attenzione era piena di fulgore, era lampo
dell’istinto, attività dell’essere rapito alla finestra dei sensi; e fu uno dei segni
maggiori della sua potenza; con quello della parola, il dono di luce ch’egli ci ha
fatto. Però quello sguardo come rimaneva crudele. Privo delle ombreggiature e
clemenze che cercava il mio bisogno di carità. (Quando poi nel Notturno e nella
Contemplazione della morte ci diede a suo modo anche queste – penso al poeta
chino sulla stanchezza di Renata, al suo sguardo presso al letto di Adolfo Bremond
–, anche in me la sorpresa fu maggiore della gioia, un po’ la impedì, non la lasciò
sorgere intatta). Via via mi pareva di toccare con mano come quella sua attenzione,
così mirabile nella sua prima movenza, e capace in ciascun momento di una resa
perfetta, riuscisse poi all’esito opposto: a disintegrare il mondo e disperdervi
l’anima. Diramava a una varietà infinita di cose, anzi le catturava tutte, con
un’avidità che aveva, come fu detto della sua cultura, un che di utilitario. Incapace
di eliminazione, le rapiva nel suo istinto lirico «vorace» come il suo senso: un
senso più grande esso stesso, che riuniva in sé gli altri cinque. E tutto si accendeva
sulla pagina, passava subito in canto. Il mio orecchio, il mio cuore cercavano
invano il segno di quel secondo viaggio, di quella seconda navigazione platonica
che avevo sentito, calmo remo, nei grandi poeti. Nel Petrarca, in Leopardi: e a
momenti, aiutando forse l’affetto, in qualcuna delle stesse voci del mio tempo:
voci povere, avare ma che tornavano in qualche modo a essere spiccate dalle soste
e maturazione dell’anima.
Così, a sviarmi da D’Annunzio, era sempre in fondo quella sua foga e mancanza di
riposo. «Innamoratamente congiunta» alla sua vita, anche la sua poesia mi dava
alla fine la sensazione e sofferenza di un vortice: un vortice, se posso dire,
orizzontale: una di quelle raffiche che passano sul mare e non si fa in tempo a
seguirle, a vedere dove muoiono e come riprendono, vere figure dell’inquietudine.
Scrutatore accorto di se stesso e nelle cose maggiori sincero (ma talora si pensa
non gli siano rimaste estranee certe indicazioni e scoperte della critica e se ne sia
valso «a chiarezza di sé»[)], D’Annunzio vide poi bene che cosa gli era negato: il
raggiungimento dell’intima trasparenza, il premio classico della vera armonia e
quello cristiano della pace. Era l’ultima fronda: la più diffice e pura – e non poteva
toccarla. «Non pace ma ansietà; non fermezza ma ebrezza; non silenzio ma
27
clamore… Si pecca per troppo ardore anche incontro alla morte. Non si può dire
che vi sia silenzio in quello spirito che il levame lirico solleva e infervora di
continuo. È necessaria una certa nudità interiore, l’assenza delle immagini e delle
melodie perché l’anima imiti quella trasparenza dell’alba dove il giorno e la notte
si confondono».
Ecco la poesia additata dal poeta stesso come un impedimento allo spirito. Che
poesia è questa? E in che punto siamo della perdizione romantica? Quando egli
dice di sé: «Sopraffatto dall’abbondanza della vita…», io mi sento ferito da questa
parola – ma l’ultimo D’Annunzio è pieno di questi ferimenti – perché so che non
intende soltanto la molteplicità e ricchezza, né il fasto o la gloria della sua vita, ma
la densità e cupidigia dell’intero suo sangue, intende la violenza anche lirica del
suo polso. Oh non è vero che Apollo abbia sempre l’ultima parola: in D’Annunzio
è sopraffatto da Dioniso.
E tuttavia, dove quella violenza cede e l’onda si attenua, i sereni arcipelaghi della
sua poesia! Sono tregue del sangue, armonie. Ad esse mi accosto con animo
aperto, so che non contraddicono al mio sentimento e spesso m’incantano.
La tregua sulla spiaggia pisana, in grembo alla natura e all’estate, dura meno del
libro… Come si trovano momenti alcionici disseminati ovunque in D’Annunzio,
così non è tutto alcionico il libro di Alcyone. Vi son troppe pagine (non i soli
Ditirambi) nate sotto l’influsso ancora irruente di Maia. Volentieri le addebito alla
Laus trasferendo invece da questa all’ideale libro di Alcyone quei gruppi di strofe
che respirano la stessa freschezza. Non sono molti, e forse li sappiamo ancora a
memoria: Le Armonie, Ver Blandum, Felicità… e se poi devo indicare in Alcyone
le mie preferenze, per me vado a scegliere dove si sente un po’ meno il rombo
della luce e la folle cicala. A qualche distanza, ma della stessa famiglia di
Undulna, e Versilia, del Fanciullo e dell’Oleandro e delle altre che han quella
purezza, vorrei mettere alcuni Madrigali dell’Estate. Tra le cose più umili e lievi
di D’Annunzio: quasi le sue myricae; un po’ asciutte, concise, di aria tutta toscana.
Implorazione, La sabbia del Tempo, L’Orma, Il vento scrive…
Su la docile sabbia il vento scrive
con la penna dell’ala, e in sua favella
parlano i segni per le bianche rive.
Mi danno il senso, che a me piace, della felicità già pericolante, quasi prossima a
sfarsi – Estate, estate mia, non declinare –, e il primo appena avvertito presagio
dell’ombra.
Ma anche Alcyone ora mi parla già meno come, a un certo punto della vita, la
perfezione che ha poco fondo. Mi attrae l’altra sua tregua, la tregua meditativa
incominciata nella Landa, interrotta, riaperta nel Notturno e in qualche sua pagina
casta. È la tregua, o l’attenuazione, della sua ferinità. L’estate alcionia era caduta
«con non so che dolcigna afa [di] morte». Ora viene a visitarlo se non proprio il
pensiero della morte, l’orrore della «laida vecchiezza» e delle «charogne infecte».
L’eclisse solare di cui discorre la Contemplazione. La luce non sfolgora più come
prima, vi è qualche indulgenza, un principio di cordialità, a volte persino di
tenerezza, forse è intorno a questo D’Annunzio, a questa sua immagine dolorosa,
che può sorgere un’alta pietà, un sentimento di comprensione e di vicinanza. Non
28
per nulla proprio queste sono le pagine che più delle altre sue – anche più dello
stesso Alcyone – noi abbiamo cercato dopo la sua scomparsa non soltanto fisica.
Si è detto che tutti gli dobbiamo qualche cosa. Il dono del suo canto è quello della
fontana a cui tutti possono bere, un sorso di più o un sorso di meno. Ma la sua
costanza, la sua osservanza dell’arte la sua intelligenza e intimità delle parole,
quella sua facoltà di farle nascere e gioire a fiore dei sensi, di farcene apprendere
non la proprietà soltanto, né solamente il numero, ma la virtù, la potenza il primo
sgorgo e sorriso, questo è bene il regalo che egli ci ha fatto. Alleggerita dal tempo,
filtrata dalle altrui esperienze, la linfa verbale di D’Annunzio circolò per anni,
ormai segreta, in tanti autori anche lontani da lui. E non restò inoperante nemmeno
quando eran già scomparsi dalla nostra pagina i segni e i vizi della sua prepotenza.
Se a volte vi apparivano ancora, ognuno si affrettava a scancellarli, ma sotto
l’inchiostro riaffioravano tenaci, tanto la sua impronta era dura a morire…
Però mi par giusto coloro che hanno aiutato il tempo a svincolarci da lui. La
liberazione dal suo dominio fu nelle nostre lettere una specie di passaggio del Mar
Rosso. Si apersero le acque e più di una generazione vi andò sommersa: gli altri,
quelli decisi a guadagnare la libertà, non si salvarono da D’Annunzio se non
fuggendo e approdando a queste magre argille della nostra poesia, dove si erra e
cammina verso la terra promessa senza nessun Mosè che ci guidi, ma solo la spinta
del cuore e forse il profumo della ginestra.
Angelo Barile
8. «Persona», Roma, V, ni 8-11, agosto – novembre 1964, p. 3
Navi alla fonda61
Di fronte al mio balcone
navi alla fonda62
posano calme nella notte estiva
sul cupo illune velluto dell’acque63
.
Isole chiare, arcipelago d’oro…
A un braccio dalla riva
luci quasi lontane, luci nude
a segno degli scafi
che scoprirà pudicamente l’alba.
In quest’alto silenzio in questa pace
oltre i sensi m’irraggiano pensieri,
quasi cenni, richiami
dell’altra riva
a cui naviga l’anima – e ne trema64
61 BARILE, Poesie, cit., p. 142. 62 Di fronte al mio balcone / navi alla fonda] Pers Navi alla fonda] P 63 dell’acque] Pers delle acque] P 64 l’anima – e ne trema] Pers l’anima e ne trema] P
29
più s’avvicina.
Domani alla banchina
un nero peso una nera fatica
traboccherà dalla stiva.
(agosto 1963)
Angelo Barile
9. «Persona», Roma, VI, n° 4, aprile 1965, p. 19
Il canto smarrito65
Ora che la ginestra
intenerisce anche le scabre
rupi sul nostro mare,
ora vengono i giorni
grandi, d’argento: li66
apre
a prim’estate
questo favillìo67
di campane
che c’invita domani
ai canti del Corpus Domini.
Domani andremo pei68
campi
a far bracciate di rami
a riempir d’oro canestre,69
paveseremo le finestre,
rallegreremo di frasche
le vecchie vie dove le case
si tengono strette abbracciate
in una fuga d’archi – e laggiù
palpita un riso di mare.
Forse domani le anziane
donne apprenderanno alle spose
in processione con loro
la laude che non cantano più
da tanto tempo; e questo
era il suo giorno.70
Saliva
all’allegrezza della fede
65 BARILE, Poesie, cit., pp. 136-7. 66 d’argento: li] Pers d’argento. Li] P 67 favillìo] Pers favellìo] P 68 pei campi] Pers per i campi] P 69 canestre,] Pers canestre;] P 70 tempo; e questo / era il suo giorno] Pers tempo: e questi / erano i giorni] P
30
un coro d’anime in festa.
Oh, ritorna, ravvivaci71
ancora,
nostra laude disimparata,
canto di gioia smarrito
nella penosa memoria
irta di sterpi… Domani
forse domani t’udremo
ritremare sgorgare vivo
quando passa Gesù.
(dal volume Poesie d’imminente pubblicazione nelle Edizioni Scheiwiller)
Angelo Barile
10. «Persona», Roma, VII, n° 1, gennaio 1966, pp. 18-19
Specchio dell’anima, la pittura di Berzoini
Di Berzoini ho in casa due quadri che ormai non parlano soltanto allo sguardo.
Dalla parete ove sono appesi, le loro immagini mi son passate nel cuore; come non
accade sempre anche di una buona pittura se non viene incontro a un’intima
simpatia. Son due quadri forse minori, e tuttavia espressivi per il loro stesso
contrasto. Un viluppo di foglie e di poche stanche peonie in un vaso verdazzurro
leggero, vicino al quale è posata distrattamente non so che carta da giuoco. I colori
son tenui, di una soavità che li stempra. Ma l’altro quadro, di paese, è tutto vivo e
vibrato, a tocchi rapidi, a pennellate volanti: un’esplosione, un’esultanza di
giovane verde intorno a una casa biancorosa che ne è illuminata come in un assalto
di luce.
Due momenti pittorici, ma anche, essenzialmente, due inclinazioni che si alternano
nell’anima e nell’arte di Berzoini. Dalla malinconia del suo fondo sale e balena,
come è proprio dei malinconici, una vivacità festosa che nella gioia del colore fa
cantare il quadro. Accensioni improvvise, e di contro una sfumata, vaporante
mestizia. È uno degli aspetti singolari di questa pittura. La quale è tutta spontanea,
di getto, ma non per questo è pittura di superficie, di mera impressione. Figura o
paesaggio, le cose che gli son care – Venezia e le Langhe, o la facciata di certe
chiese, o un cespo di fiori di campo – Berzoini le ritrae sì in quel momento, in
quella luce istantanea, però chi può dire se le immagini amate non gli han
soggiornato nei ripostigli del cuore? Anche il sonno lavora, e un principio attivo di
arte o di poesia, chi lo ha dentro di sé, gli germoglia inavvertito come il seme di
sotto alla zolla.
Negato, vorrei dire organicamente, alle norme di qualunque scuola come alla
mediazioni (o alle trappole) della cultura, Berzoini esprime nella sua arte un
bisogno ingenuo, e commovente, di poesia. Nei suoi quadri c’è sempre un colore
71 Oh, ritorna, ravvivaci] Pers Oh, ravvivaci] P
31
che non esiste sulla tavolozza: quel colore d’anima, e d’innocenza, che unifica gli
altri e veramente li avviva.
Guglielmo Bozzano ha scritto – e scritto bene – che Berzoini rimane un isolato,
«in una seconda luce austera e discreta». Però io direi che è la luce sua propria: se
non dell’artista, propria almeno dell’uomo.
Quando incontro Berzoini con quella sua figura di uomo antico, che pare tolta a un
vecchio affresco illanguidito dal tempo – il volto pallido e scabro, l’andatura
dinoccolata, e in fondo all’abbandono delle braccia quelle sue mani famose,
assolutamente spropositate, – a vederlo in mezzo alla gente così disarmato e un po’
sperso, mi vien da pensare al fanciullo che è in lui: non visto; ma ogni tanto gli
traluce in una frase smozzicata o in un principio di sorriso che si smarrisce nella
serietà del suo volto.
L’uomo e il fanciullo si accompagnano per via (ma preferiscono andare pei campi)
e forse non si scambiano che rade parole. Ma nell’atto stesso in cui gli occhi
vergini e vivi colgono il fiore delle cose che amano, il vecchio pittore lo riceve e
trapianta nel suo recinto e lo fa poi risorgere in una luce cordiale che non lo lascia
avvizzire.
Se Berzoini avesse mai da scegliersi un motto, gli suggerirei il verso di Saba:
I miei occhi mi bastano e il mio cuore.72
Angelo Barile
11. «Persona», Roma, VII, n° 2, febbraio 1966, pp. 19-20
La Colombera di Riolfo È uscito presso Sabatelli Editore, Savona, in una collana diretta da Federico Marzot, il
volumetto di versi La Colombera di Silvio Riolfo, illustrato con bei disegni di artisti liguri.
Pubblichiamo con piacere la prefazione che vi ha premesso Angelo Barile73.
Non è solo per amicizia che saluto con gioia questo primo mannello di versi che
tra gli altri suoi inediti Riolfo ci offre. Accanto agli artisti – fra i più cari della
nostra Liguria – che in segno di simpatia hanno arricchito dei loro disegni questa
bella plaquette nitidamente stampata da Sabatelli, forse non disdice che in limine
trovi posto una mia parola. Non quella di un critico, ma la parola di un vecchio
poeta che scambia l’abbraccio di rito (e di cuore) con un confratello novizio.
Conosco e seguo con attenzione Silvio Riolfo sin da quando era studente di liceo,
agli Scolopi, e già rivelava in quelle sue primissime prove una seria vocazione alla
poesia. Mi sia permesso di dire che da allora ho sempre guardato a lui con una
fiduciosa speranza che non è andata delusa.
Se posso valermi di una sua stessa immagine, vorrei assomigliare la poesia di
Riolfo a quel primo fiotto di colombi «che nel vento rompeva alla sua casa»: alla
casa antica e deserta della sua gente, lassù a Castelvecchio di Rocca Barbena. Il
suo canto trepido e chiaro vola anch’esso in un vento affettuoso di ricordi: vola
72 UMBERTO SABA, La solitudine, in ID., Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1988 (I
Meridiani), p. 143. 73 Nota della redazione di «Persona». Vd. SIVIO RIOLFO, La Colombera, Savona, Sabatelli,
1966.
32
incontro a quel puro paese dell’adolescenza che è rimasto il suo spirituale paese. È
lì che il poeta ritrova le care anime, i cari volti scomparsi; ripercorre le sue bianche
strade di ragazzo; v’incontra i vecchi curvi e rotti dalla fatica o le allegre
scorribande dei compagni alla vendemmie d’ottobre… Risale, per la festa d’ogni
anno, al Santuario e vi rivede sua madre giovane che prega, riascolta la meraviglia
del suo canto «che da solo ferma i monelli». O risaluta le balenanti fanciulle
rimaste illese nella sua memoria: quella che beve inginocchiata alla fontana e
l’altra – incantevole – che nel magazzino della frutta acerba, tra scrosci
temporaleschi, sente già il sussulto della corriera che sotto la pioggia la ricondurrà
a casa…
Un mondo fresco, innocente, rigato di rimpianti, pervaso di mestizia, ma sentito ed
espresso con una pungente vivezza di riferimenti concreti, di richiami alle cose,
che ricreano davvero quell’ambiente, quel tempo, e gli dànno risalto e carattere.
Sono tanti e così propri, così precisi, quei richiami a una realtà fisica tutta
impregnata di anima che l’elegia o l’idillio del fondo poetico di Riolfo non
divengono mai abbandono, languore, sterilità di lamento, anzi ne avvivano la virtù
lirica.
Dirà forse qualcuno che in questa poesia di un giovanissimo c’è, nondimeno,
ancora troppa malinconia, troppa tristezza? A chi volesse fargliene rimprovero si
potrebbe rispondere con una parola di Benedetto Croce: «Che un velo di mestizia
pare che avvolga la Bellezza, e non è velo, ma il volto stesso della Bellezza»74
. Un
certo colore di malinconia è misteriosamente inseparabile dalle più felici
manifestazioni dell’arte e della poesia.
A differenza degli altri poeti liguri che traggono, benché in modo diverso,
ispirazione quasi soltanto dal mare, Silvio Riolfo non è propriamente un poeta
marino. La sua Liguria è un’altra, quella ignorata e bellissima del nostro entroterra,
chiusa nella limpida cerchia dei monti. Non già che il mare sia estraneo alla sua
poesia, anch’egli ne sente il richiamo potente, «il canto lento e feroce» (Marea, Il
fragile corallo del ricordo, Ulisse). Ma è un mare, quello di Riolfo, sentito, vorrei
dire, in contrappunto. Il suo cuore rimane lassù, affacciato dall’alto balcone di
Castelvecchio sulla sua terra arida e magra «ricca solo di pietre e di torrenti / dal
greto asciutto…»
Nome che più che al lido riconosco
a quei monti sereni dove nacqui,
ai quali tornerò coi morti antichi
che mi fecero figlio del tuo cielo.
Mite e casta poesia, felicemente evocativa, sensibilmente fedele alle memorie, alle
figure, alle costumanze di un tempo – e tuttavia di un gusto tutto moderno per la
nettezza del disegno, l’incisività delle immagini, la vigilata armonia della voce.
Riolfo crede ancora nei valori fonici usati con sobrietà e discrezione. Oggi non
sono molti i poeti giovani rimasti come lui totalmente immuni dal detestabile
contagio dei mezzi-versi, dei quasi-versi che da ogni parte tediosamente dilagano.
Il suo verso è per lo più l’endecasillabo, che è il naturale respiro della poesia
74 BENEDETTO CROCE, La poesia, Bari, Laterza, 1936, p. 12.
33
italiana. Quando e dove se ne discosta è per dare alla sua voce rapidità di tono e
non so che nervosa movenza.
Moderna ma non malata di novità, la sua poesia è chiara d’intime luci e di modi
espressivi, essenzialmente serena (o rasserenata) per equilibrio e misura. Rari i
momenti di turbata armonia. Come quando «una sera d’inverno ch’era il treno /
fermo in stazione sotto un’aspra pioggia» il poeta soffre improvvisamente l’urto
delle cose avverse e sentendosi a un tratto svuotato di pensieri, fermato per sempre
in un buio d’inerzia, conosce e prova in se stesso «la trafittura orribile che fissa / la
farfalla alla pagina…». Uno smarrimento, un principio di angoscia, che per
l’efficacia con cui viene espresso si comunica in qualche modo anche a noi.
Allora, se è così, andremo a rileggerci per sollevarci il cuore La canzonetta della
mela piccola, una poesia che sta a sé, diversa da tutte le altre della raccolta. In tono
discorsivo un vero e proprio racconto. Umile racconto, umili versi, ma intessuti di
amabile grazia. Il ricordo della nonna, del bimbo e della Messa mattutina nella
chiesa del paese rivive e s’innesta con commozione nell’episodio ilare e giocoso
della mela piccola nella cappella del collegio. Forse per la prima volta il cuore
della «matricola sperduta» è ferito, e gliene viene un pianto che ha colore d’aurora.
Così Riolfo conduce anche noi, con mano leggera, ai perduti paradisi
dell’innocenza.
Angelo Barile
12. «Persona», Roma, VIII, ni 1-2, gennaio - febbraio 1967, p. 24
Come ho conosciuto Umberto Saba75
Nel numero di marzo-aprile 1933 di «Circoli» comparve una singolare antologia:
non più che una ventina di poesie che Saba aveva trascelte dalle sue varie raccolte,
quasi per darci di ogni suo periodo poetico il motivo dominante. Alla «piccola
antologia», come egli l’aveva intitolata, la rivista volle premettere un mio scritto:
Lo sguardo di Saba, nel quale io cercavo di scrutare una delle sue virtù liriche più
affascinanti: quel suo modo incantato di aprire gli occhi sul mondo e di acquisirne
taluni aspetti ingenui e vivi incorporandoli intatti al proprio fondo meditativo76
.
Per le cose che diceva, quel mio studio, che non era soltanto una testimonianza
affettuosa, piacque a Saba più di quanto io potessi pensare e mi valse la sua
amicizia. «Cerchi di fare in modo che ci possiamo conoscere» – mi scrisse dopo
lette quelle mie pagine77
. Non occorre dire come quel suo invito, che mi ripeté di lì
a poco, veniva incontro al mio desiderio. Fu così che nel giugno di quell’anno ci
conoscemmo a Milano. Avvisato che vi era di passaggio, mi precipitai a
raggiungerlo, con quella impazienza un po’ timorosa che ci prende la prima volta
che ci avviciniamo di persona a un artista, un poeta lungamente amato. Ma ogni
titubanza scomparve tanto la sua accoglienza fu aperta, cordiale; e la nostra
75 Vd. BARILE, Incontri con gli amici, cit., pp. 100-3. 76 BARILE, Lo sguardo di Saba, cit. 77 Si veda l’epistolario Saba-Barile in La poesia di Angelo Barile, cit., p. 217 (lettera dell’11
maggio 1933).
34
conversazione trovò subito il suo tono giusto e spontaneo, quasi di naturale
confidenza.
Nel ringraziarmi poi da Trieste di essere andato da lui a Milano, Saba si
rammaricava che io l’avessi trovato «in un periodo piuttosto depresso»78
. Ma in
verità io non ebbi quell’impressione, anzi il poeta mi era parso inaspettatamente
sereno, né credo lo fosse per ragioni di cortesia. L’altro Saba – quello doloroso,
inquieto, costantemente travagliato in se stesso – dovevo poi conscerlo qualche
anno più tardi, quando fui per alcuni giorni a Trieste, e già incombeva il pensiero
della guerra che veniva ad accrescere il suo intimo tormento e la sua amarezza. Ma
quella sera, a Milano, non appariva turbato. Si cenò insieme (c’era anche
Linuccia), e usciti a fare due passi noi due ci ancorammo a un caffè all’aperto,
indugiando in uno di quei colloqui che in realtà non hanno mai termine.
Naturalmente era lui che guidava il discorso e io lo seguivo con un’attenzione che
non si fermava alle parole.
Se ora risalgo così indietro nel tempo a quel mio primo incontro con Saba mi resta
soprattutto il ricordo del modo con cui mi parlò di poesia. Un modo vivo, chiaro,
diretto, senza mai astrattezze, con pochi e pronti giudizi che riflettevano nel
discorso le luci e le ombre, le simpatie e le ripulse del suo essere profondo. E se
una poesia rispondeva al suo intimo gusto avveniva anche che ne citasse dei versi
a memoria. Rammento con che animazione e trasporto mi recitò quella sera
L’acero antico di Jessenin. Mi pare di sentirlo:
Ho lasciato la mia casa di fanciullo
ho lasciato la Russia celeste.
Come tre stelle riscaldan le betulle
il cuore di mia madre mesta.
Poi, su mia preghiera, mi disse una delle sue ultime poesie di quel tempo: Ceneri.
A distanza di tanti anni, se mi capita di rileggerla, è come se riudissi ancora la sua
voce viva, quella voce cantilenosa, lagnosa, invariabilmente monotona, che a me
piaceva perché la sentivo connaturata al suo canto, gemito vero della sua intima
pena. Impossibile dimenticarla tanto gli veniva su de profundis.
Volle anche, a un certo punto, che io gli dicessi qualcosa di mio, e facendomi
coraggio gli dissi Tu che non canti, un sonetto d’amore di strettissima forma,
chiuso nel giro corto dei suoi settenari. Mi pregò di ridirglielo; e andava fra sé
ripetendo due versi che gli restarono a lungo nella memoria: Lacrima che s’indora
/ nel verso che la beve… Non so se mi è lecito aggiungere che da Trieste mi chiese
quella mia lirichetta («Desidero leggerla in pace e farla leggere a qualche
amico»)79
, e quando mi scrisse non fu soltanto per dirmi che gli piaceva ma per
segnarmi i punti, anche minimi, che gli parevano deboli. Desideroso di farla
migliore, mi suggerì persino le possibili (o impossibili) varianti…
Dopo di allora Saba divenne per qualche anno il mio primo lettore – il più
desiderato, il più ambito. Mi sollecitava ogni tanto a mandargli le mie nuove (e
poche) poesie, che leggeva attentissimo, e il giudizio che me ne dava non era mai
78 Ivi, p. 220 (lettera del 10 giugno 1933). 79 Ibidem.
35
vago, anzi preciso e aderente alla pagina80
. Così attraverso le sue lettere Saba
proseguiva con me il discorso che avevamo cominciato quella lontana sera a
Milano; e il modo era ancora lo stesso: semplice e sincero, senza elucubrazioni,
senza giri di parole, animato da una partecipazione attiva che mi dava ogni volta il
senso vivo della sua straordinaria virtù non pure di poeta ma di libero e penetrante
lettore di poesia.
Angelo Barile
13. «Persona», Roma, VIII, ni 1-2, gennaio - febbraio 1967, p. 25
Una poesia natalizia di Umberto Saba81
Pochi anni prima della morte Umberto Saba accettò d’incidere, con quella voce un
po’ cantilenosa che gli era caratteristica, un piccolo disco «Cetra» con otto poesie
dei diversi periodi della sua vita: dell’adolescenza, della giovinezza, della maturità
e della vecchiaia. Fra le altre un sonetto: Nella notte di Natale, scritto a 17 anni e
pubblicato una sola volta, nell’edizione ormai introvabile del primo Canzoniere
limitata a poche centinaia di copie; onde quel sonetto poteva e può ritenersi
pressoché inedito e certamente ignoto ai più dei lettori. Eccolo qui riportato:
Nella notte di Natale
Io scrivo nella mia dolce stanzetta
d’una candela al tenue chiarore
ed una forza indomita d’amore
muove la stanca mano che si affretta.
Come debole e dolce il suon dell’ore!
Forse il bene invocato oggi m’aspetta.
Una serenità quasi perfetta
calma i battiti ardenti del mio cuore.
Notte fredda e stellata di Natale
sai tu dirmi la fonte onde zampilla
improvvisa la mia speranza buona?
È forse il sogno di Gesù che brilla
all’anima, che pensa sé immortale,
del giovane che ama e che perdona?
È una poesia candida, ingenua, formalmente intessuta di quelle facili rime che
Saba amava e dei modi espressivi più semplici, usuali; la quale denuncia subito, a
80 Si veda, per esempio, ivi, pp. 221, 230, 239, 245. 81 Testo già pubblicato su «Il Letimbro», Savona, 23 dicembre 1966, poi confluito in
BARILE, Incontri con gli amici, cit., pp. 98-100.
36
prima lettura l’età giovanissima dell’autore. Ma non per questo è meno
interessante per il motivo che la ispira, per i sentimenti che esprime, e per il
significato che assume nella biografia – e nello spirito – del poeta triestino. Sotto
questo riguardo quel sonetto merita rilievo, almeno per chi conosca la particolare
complessità della vita e dell’anima di Saba.
Nato di padre cristiano e di madre ebrea, ma allevato nella famiglia materna (il
padre aveva abbandonato la moglie e il figlio ancora bambino e se ne era andato
ramingo per il mondo), Umberto Saba ha sempre avuto un’estrema, pungente
coscienza di questa duplicità del suo sangue, ha sempre sentito questo coesistere in
sé di due anime come una discordia che andava composta. Ora l’una ora l’altra
delle due anime ispira e guida il suo canto; ma la vera anima genitrice della sua
dote e qualità di poeta è quella che gli viene dal padre cristiano come egli
apertamente riconosce in un sonetto della sua Autobiografia.
Mio padre è stato per me «l’assassino»
fino ai vent’anni che l’ho conosciuto.
Allora ho visto ch’egli era un bambino
e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto.
È «l’altra metà» di Saba, l’anima nuova e leggera, capace di sfuggire «come un
pallone» di mano alla tristezza, a quella millenaria desolazione del sangue sulla
quale, a mio avviso, la critica ha troppo insistito a scapito della capacità di
consolazione e di gioia, di comunione e d’amore che certamente era in lui.
Trasferite in canto, le anime di Saba divengono le due voci – la serena e l’ansiosa
– che senza fine si rincorrono e si contrappongono nella sua opera: le «care voci
discordi» che il poeta concilia in un sentimento di volta in volta più puro, in un
accordo grado a grado più alto.
Come i parenti mi han dato due vite,
e di fonderle in una io ne fui capace,
in pace
vi componete negli estremi accordi,
voci invano discordi.
Ancora nessun segno di quel sofferto dissidio nel sonetto natalizio del poeta
diciassettenne; ma vi è già il preannuncio di quella voce serena e suasiva, fiduciosa
e ottimista che diverrà poi una delle due voci dialoganti delle sua poesia. E non per
il diretto richiamo a Gesù, ma per i pensieri di «speranza buona» che la Santa
Notte suscita nell’anima «del giovane che ama e che perdona», onde egli gusta
quell’agognata serenità («Una serenità quasi perfetta…») verso la quale Saba
guarderà poi sempre, nell’ulteriore sviluppo della sua opera, come al premio più
ambito e più raro.
Forse non è senza significato che il poeta, ormai vecchio, quasi al termine della
vita, abbia voluto farci conoscere quei versi, d’ispirazione chiaramente cristiana,
della sua remota adolescenza. Anche per questo, senza volerne estendere ed
accrescere la portata, mi è parso giusto additarli ai buoni amici della poesia.
Angelo Barile
37
14. «Persona», Roma, VIII, ni 7-8-9, luglio – agosto – settembre 1967, p. 16
Vigilia Questa prefazione al volumetto di versi Vigilia di Adriano Sansa è uno degli ultimi scritti,
forse l’ultimo, di Angelo Barile.82
Prima che all’autore io vorrei, se è permesso, fare i miei complimenti agli editori
di questo volumetto di versi. Non solo per la chiara eleganza della veste alla quale
accrescono pregio e attraenza i vividi disegni di quel suasivo pittore-poeta che è
Guglielmo Bozzano. Non solo per questo, ma per la sostanziale validità della
scelta. Quando i Sabatelli un anno fa diedero avvio con La Colombera di Silvio
Riolfo a questa loro collana che riservata ai giovani s’intitola appunto «Opera
prima», c’era da chiedersi come avrebbero potuto poi proseguirla senza venir
meno troppo palesemente a quel felicissimo inizio. Il libro di Riolfo poneva già un
limite, segnava un’esigenza di serietà e valore cui non sarebbe stato facile in
qualche modo adeguarsi. Ecco ora invece la breve raccolta di un altro giovane che
prende degnamente posto in questa collana necessariamente rara e severa.
Nato a Pola di famiglia istriana, ma ligure ormai di elezione e di vita, Adriano
Sansa è uno di quei giovani (per fortuna ce n’è ancora) i quali si muovono in un
clima d’intelligenza umana e di nobiltà morale: radicati nella loro fede religiosa,
attenti alle cose dello spirito, sensibili ai richiami di una coltura che non
contraddice le ragioni del cuore. A questa disposizione naturale Sansa aggiunge
non so che vivezza e singolarità del carattere, una certa autonomia di giudizio e di
gusto che lo distingue tra gli stessi suoi coetanei. Pure scrivendo versi non è un
letterato; e anche per questo son lieto di porgere al suo libretto il mio benvenuto.
Lo faccio tanto più volentieri in quanto queste poesie le ho viste, posso dire,
nascere sotto i miei occhi, quando il giovane amico me le faceva leggere su quei
fogli volanti ancora freschi d’inchiostro… E ogni volta mi pareva che venissero
via via a comporsi nella coerente unità di un diario: nell’intimo, poetico diario dei
suoi affetti familiari, dei suoi pensieri d’amore, e di certi trasalimenti, di certi
sussulti della sua sensibilità e partecipazione umana. Vi sentivo, cioè, prima e più
ancora che un interesse estetico, un valore di vita, un valore di anima, la
confessione genuina di un giovane che scopre e illumina a se stesso il suo mondo
interiore.
Perché, a essere schietto, nei versi di Sansa raramente trovavo particolari pregi
espressivi: non il rigore della parola, né l’individualità di un accento, né la
sommessa persuasione di un canto. Il suo discorso poetico è per lo più corrente,
tenuto su toni bassi, conversativi, come del resto è nel gusto di quasi tutti coloro
che oggi scrivono versi. E tuttavia nelle sue poesie trovavo, a compenso, altre
qualità, altre doti capaci di dare luce e rilievo alla pagina: la novità
dell’ispirazione, l’originalità dei motivi e quella ricca vena inventiva che si direbbe
connaturata al suo ingegno tanto gli è propria. C’è qualche volta in lui un moto
impreparato, uno scatto che sorprende il lettore e che piace.
82 Nota della redazione di «Persona». Vd. ADRIANO SANSA, Vigilia, Savona, Sabatelli, 1967.
38
Se la fantasia è l’apparizione improvvisa e spontanea di un pensiero o di un
sentimento e rivela per ciò stesso una nascosta energia, è veramente sotto il suo
segno che il giovane Sansa ha posto la sua poetica. Ma non è, si badi, una fantasia
di aspetti e figurazioni esterne; al contrario essa è volta a chiarire quei moti e
baleni che talora sommuovono il misterioso fondo dell’animo.
Vogliamo dar qualche esempio? Nella penombra dell’ospedale, una sera estiva di
pioggia, accanto al suo vicino di letto che aspetta di morire, il poeta invoca per lui
dal Signore una tenerezza d’erba e di puri lavacri, così che «il poveretto / si senta
scivolare lungo il prato, / disperdere nei rivi d’acqua fresca / sotto gli abeti, e a
sera si raccolga / in un angolo quieto al cimitero» (Il mio vicino).
Un’altra volta, mentre finge tra la gente di aspettare anche lui la corriera, appena
rimasto solo scavalca lì «presso il muretto dell’aiuola e / a piene mani come
quando andava / in giro coi compagni a rubar mele, / afferra fiori a ciuffi e fugge
via» (Ladro).
Sia detto di passaggio: avviene anche, qualche volta, che l’estrosa impennata
sconfini, per eccesso, nella bizzarria; così in Tre di notte, allorché bussa alla porta
dell’arciprete per chiedere le chiavi della chiesa: vuol suonare «il vecchio organo
addormentato» e dare a tutti l’annuncio che nella valle è tornata l’estate, sì che tutti
accorrano e cantino gioiosamente insieme.
Le più belle poesie qui raccolte – tutte rapide e brevi – sono poesie d’amore: di un
amore al suo sboccio: limpido, fresco e gentile, che ha le trepidazioni e le
iridescenze delle cose di primavera. È stato detto che la poesia viene messa
accanto all’amore quasi sorella e con l’amore congiunta e fusa in un’unica
creatura, ma solitamente la poesia d’amore o è ancora accensione di sensi o è già
rimpianto nostalgico. Né l’uno né l’altro di questi due estremi momenti nei versi di
Sansa. Il suo amore è giovane, è vivo, e sono giovani e vive le stesse fugaci
malinconie che talora lo screziano appena. Vi si esprime, anzi, una certa
animazione e allegria. Così quando, a sera, lasciato il suo amore, il poeta si sente
solo e immalinconito «alla squallida mensa in trattoria», poco gli basta a vincere
quel suo gentile sconforto: «Ma appena mi rallegrano i colori / del canestro di
frutta, prendo in mano / l’arancia più vivace e nella scorza / furtivamente incido il
caro nome» (L’Arancia).
A differenza di tanti, di troppi giovani che quando «fanno poesia» si ammantano di
una cupa e quasi irrimediabile tristezza, Adriano Sansa ricusa quell’abito e rifugge
dalla desolazione – o dalla moda – dell’angoscia. Non è piccolo merito, se è vero
ciò che scrive il Leopardi che la poesia consiste essenzialmente in un impeto e
deve accrescere e rinfrescare la nostra vitalità83
.
Ma io non vorrei, prima di chiudere quest’esile libro, additare soltanto la delicata
trama dei versi d’amore del giovane Sansa. Altri ve ne sono, ricchi di palpito, che
forse segnano i suoi veri momenti di grazia. Il buon lettore di poesia cerchi le
pagine che s’intitolano Istria – Voi due, soli – Il figlio. Pagine propriamente
liriche, le quali sono anch’esse una testimonianza d’amore: alla propria terra
perduta, alla famiglia lontana, alla virtù rinnovatrice della preghiera, chi le ha
83 LEOPARDI, Zibaldone, cit., 4356, vol. 2, p. 2926: «Che può avere a che fare colla poesia
un lavoro che domanda più e più anni di esecuzione. La poesia sta essenzialmente in un
impeto […]. I lavori di poesia vogliono per natura esser corti».
39
scritte ha forse toccato con semplicità e immediatezza il difficile, misterioso
approdo della poesia.
Angelo Barile
15. «Persona», Roma, VIII, ni 11, novembre 1967, pp. 3-4
Confidenziale84
Studente di liceo con Sbarbaro, furono le sue poesie che mi avvicinarono a lui nel
gruppo dei condiscepoli che poi si fecero editori di Resine. Fu la nostra scoperta:
una cosa di primavera. Il compagno forse più inosservato, certo il più silenzioso e
il più schivo, fu subito al centro della nostra attenzione. Un’ingenua compiacenza
come se le sue poesie fossero in qualche modo anche nostre accresceva ogni volta
il nostro stupore e trasporto. Chiuse nel loro giusto vestito di rime, passavano
ammirate in mezzo a noi, più adulte di noi, e da un banco all’altro andavano a
sfiorare la cattedra. Dalla cattedra assentiva, incoraggiava discreto Adelchi
Baratono, giovane e amico dei giovani, ornato, elegante, che in luogo della poca o
nessuna filosofia che ci andava insegnando, forse ci apriva a un certo gusto
dell’arte. Il libretto uscì più tardi e ci parve anche per la veste una meraviglia. Ma
la mia recensione a puntate, che Sbarbaro ha ricordata, fu naturalmente severa, con
caute lodi alternate a riserve: un modo giovanile di darmi importanza e non
toglierne al libro85
. Vedo ancora sulla copertina di Resine (fui io a volere quel
titolo) il pino nel vento piangere dalle sue ferite: immagine forse non impropria a
quella che doveva poi essere la vera poesia di Sbarbaro. Quando venne Pianissimo
e seguirono i primi Trucioli, credo di essere stato il lettore «di assaggio», l’amico a
portata di mano al quale l’autore passa la pagina ancora fresca d’inchiostro per
leggergli in viso la prima impressione.
Cose remote, che valgono solo per me; e farei meglio a lasciarle. Un’amicizia che
ha l’età della nostra teme il pericolo dei ricordi: dei ricordi che a un certo punto
fan ressa e prendono il posto dei pensieri. Vorrei che non fosse ancora il momento.
Ma forse ci salva il sentimento che abbiamo della nostra diversità che l’amicizia
non ci ha mai nascosta. Così se parlo di Sbarbaro e della sua vita è come se
parlassi – in contrappunto – anche a me stesso; che è un modo onesto di essere
amici.
Da alcuni anni Sbarbaro si è ritirato con la sorella, nella casetta dei suoi vecchi a
Spotorno, in quella parte, su in alto, dove il paese si fa povero e, stretto alla terra,
dimentica il mare: uno dei «pezzi» ancora illesi e più schietti della nostra adorabile
Liguria. «Forse un giorno, sorella, noi potremo / ritirarci sui monti, in una casa /
dove passare il resto della vita». In quella povertà e quiete temo che Sbarbaro ora
84 Testo precedentemente apparso su «La Fiera letteraria», Roma, XXXIX, n° 46, 13
novembre 1955, p. 4, poi in «Il giornale d’Italia», Roma, 5-6 luglio 1965, infine col titolo
Testimonianza per Camillo Sbarbaro, in BARILE, Incontri con gli amici, cit., pp. 126-9. 85 Vd. ANGELO BARILE, Resine di Camillo Sbarbaro, «Il Cittadino», Savona, XLII, 152, 11
luglio 1911, p. 2; 153, 12 luglio 1911, pp. 2-3; 154, 13 luglio, 1911, pp. 2-3. Anche con una
nota di DOMENICO ASTENGO, «Resine», Savona, n° 7, ottobre-dicembre 1973, pp. 79-86.
40
guardi alla vita con l’animo di chi se ne sente già fuori. Ma la ringrazia di quanto
gli ha dato. Con lui che l’invocava smarrito, disperato di esserne escluso, la vita è
poi stata amica, poco gli ha fatto mancare. «Giovinezza tardi venuta, come mi
piaci!». Infatti a un certo punto, perduto un po’ del suo torbido, la vita di Sbarbaro
si addolcì in una stagione serena, che sembrò quasi ridente: aperta agli incontri,
alle accoglienze sincere, alle colorate vacanze; ma specialmente viva di attente
amicizie. Sbarbaro sa il numero e il pregio di questi doni. E il più caro di tutti,
quello che a lui era sempre parso vietato. «Ma c’è un paese dove non potrò andar
mai. Interrogo quelli che vi furono col mio più ansioso silenzio». Con mano
leggera la vita ve lo ha accompagnato.
Forse il poeta integro e puro restava ancor là, sulle soglie deserte che la vita aveva
ormai oltrepassato. Ma se la poesia è il dono di Dio che non va messo in questo
conto, va detto che Sbarbaro alla poesia è rimasto sempre fedele, ha ubbidito alla
sua vocazione di poeta come all’unica legge: senza sbandamenti, senza
contaminazioni di piccoli commerci letterari. In questo, egli che è l’uomo più
svincolato del mondo, è stato di un’esemplare osservanza, di un’intransigenza così
vigorosa da parere crudele. «A nulla ancorato» – e legatissimo al suo interno
comando.
Anche di questo è grato alla vita: di aver potuto fare, non importa a che prezzo, ciò
che gli è proprio e più spontaneo, il lavoro scelto a se stesso come il più vicino al
suo gusto ed ingegno: il traduttore, l’insegnante, il botanico, il giramondo, o che
altro. Soltanto due cose confessa di aver fatto forzatamente: il servizio militare (ma
nella prima guerra portò onestamente il suo zaino) e la vita d’ufficio quando fu per
qualche tempo impiegato: il giorno che la ditta si trasferì da Genova a Roma
Sbarbaro non accettò di seguirla e fu per lui, nel vero senso della parola, un giorno
di festa. Ma straordinario il modo in cui già prima aveva preso un altro congedo, si
era autolicenziato dalla scuola. Andato, o mandato, giovanissimo a Firenze per
concorrere a non so quale borsa di studio, la mattina che s’incammina all’esame,
Sbarbaro incontra per la sua strada un allegro corteo con musica in testa, e lui
dietro, smemorato, preso nella corrente… Non gli restò che di venirsene a casa
libero come un uccello.
Alla scuola, quando poi vi tornò per insegnare seriamente ciò che aveva
seriamente imparato da sé, a tu per tu con i testi: senz’altro titolo che la
conoscenza e l’amore per la materia. Sbarbaro si è aiutato a vivere traducendo e
dando lezioni di latino e di greco. Non so il lavoro di traduttore, ma quello delle
lezioni non è propriamente un lavoro, tanto lo fa di suo genio. Fatica senza fatica.
L’impegno, lo scrupolo che vi mette è solo eguagliato dal piacere che prova e che
partecipa vivamente ai suoi allievi. Non ho mai assistito a una lezione di Sbarbaro
e non so come avviene questo mezzo miracolo d’incantare i ragazzi insegnando
grammatica. Ma certo vi ha parte quella umana intelligenza e bontà che pure nella
sua poesia è così inconfessata.
Ristampato Pianissimo, ora Sbarbaro ha già licenziato le sue Rimanenze e tra poco
metterà fuori anche gli ultimi Spiccioli (sempre quei titoli)86
. Siamo dunque al
86 CAMILLO SBARBARO, Pianissimo, Venezia, Neri Pozza, 1954; ID., Rimanenze, Milano,
All’Insegna del Pesce d’Oro, 1955; Spiccioli è il titolo col quale vennero pubblicati singoli
scritti su «La Chimera», «La Fiera letteraria», «Botteghe Oscure», «Officina»,
«Letteratura», e in seguito non adottato per la loro pubblicazione collettiva. Si veda CARLA
41
congedo. Il poeta si accomiata con brevi parole, con brevi saluti, poiché il discorso
importante è già fatto da tempo.
Caro Camillo, chi ha sempre posto Pianissimo in cima alla tua poesia ha visto con
soddisfazione riaffermata da altri quella sua preferenza che a lui veniva forse dal
cuore. Ma gli è piaciuto più di tutto che in quelle due pagine premesse alla
ristampa tu abbia rilevato così nettamente il centro ispirativo del tuo poema,
isolandone il motivo dominante – la parola è tua – nel pensiero della morte di tuo
padre. «Padre che muori tutti i giorni un poco…». L’interpretazione autentica che
ce ne hai dato mi dice qualche cosa della tua anima vera, convalida l’essenziale
innocenza e purità di quel canto. (Per questo, Camillo, quando tuo padre morì, hai
potuto – e forse fui il solo a vederti in quell’attimo – mettere nascostamente sotto il
suo capo, nella bara, il manoscritto ancora ignoto di Pianissimo; e perdonami se
non so trattenere il ricordo)87
.
In premio, la ristampa ti ha ora portato alcune testimonianze di un’estrema
attenzione e aderenza; e la più perspicace ti pone tra i precursori della moderna
poesia dell’angoscia, nel panorama della maggiore lirica del nostro tempo.
Nessuno è più lieto del tuo vecchio amico di questi e simili giudizi che allargano di
tanto il significato della tua opera. Ma con altro animo egli scruta le pagine che
dopo tanti anni non ha ancora finito di leggere: per trovarvi – negato da te in tanti
modi, contraddetto da tante tue parole crudeli – il segno, che non vi manca, della
tua carità.
È il fiore che spunta tra le pietre della tua solitudine, nascosto nella tristezza delle
tue macìe. So dove trovarlo.
Anche per questo mi è caro che il tuo commiato dalla poesia sia quella tua lagrima
per Benedetta.
Angelo Barile
16. «Persona», Roma, XII, ni 1-2, gennaio - febbraio 1971, p. 24
ANGELERI e GIAMPIERO COSTA, Bibliografia degli scritti di Camillo Sbarbaro,
presentazione di DANTE ISELLA, Milano, All’Insegna del pesce d’Oro, 1986, pp. 239-47. 87 La porzione di testo fra parentesi, presente nella versione pubblicata sulla «Fiera
letteraria», venne espunta quando apparì sul «Giornale d’Italia» e fu in seguito ripresa per la
pubblicazione su «Persona», i cui redattori con tutta probabilità trascrivono il testo dalla
redazione della medesima «Fiera letteraria».
42
La messa di don Clemente88
Di Clemente Rebora ho un ricordo che vale molto per me, ma che forse può dire
qualcosa anche ad altri. Un ricordo non del poeta, ma dell’uomo, anzi del
sacerdote all’altare.
Dopo la sua morte, avvenuta il giorno dei Santi del ’57, chi ha parlato di lui, non
meno che al poeta ha guardato all’uomo, tanto la sua umanità e la sua poesia
scaturiscono insieme. Lo aveva già sentito appassionatamente Boine all’apparire
dei Frammenti lirici al tempo della «Voce» («…qui c’è una fonte viva; qui c’è
un’anima e un uomo…»89
); e tanti altri dopo di lui. Ma la vita di Rebora, uscendo
dal mondo, impoverendosi al mondo, si è poi arricchita della luce di Dio: in umiltà
vera, in ardore di silenzio e di sacrificio. Approdato alla fede a quarantaquattro
anni, entrato novizio nell’Istituto rosminiano della Carità a quarantasei, a
cinquantuno sacerdote per obbedienza ai superiori. Sono i dati grezzi, e parziali, di
una biografia che ci è stata illuminata di una luce di santità dalle ultime liriche
religiose che Vann[i] Scheiwiller riuscì a strappare amorosamente a Rebora sul suo
letto d’infermità. Il libro che le vide raccolte con altre minori uscì pochi giorni
prima della sua morte e non si poté aprire senza un tremito di commozione. È il
grido di un’anima nell’ultimo terreno colloquio con Dio.
«La misericordiosa bontà di Gesù Cristo mi tiene ancor sempre sacerdote attivo:
non potendo più celebrare il Sacrificio dell’Altare, mi fa celebrare il sacrificio
della Croce»90
. È il primo di alcuni pensieri premessi ai Canti dell’infermità. La
data è del novembre 1955. Quando io ebbi la fortuna di conoscere Rebora – in un
incontro del tutto impreveduto ma che penso non casuale, anzi provvidenziale –
don Clemente poteva ancora celebrare, e fu l’ultimo tempo, prima della lunga
agonia che pare non lo lasciasse morire («Il mio pregare è divenuto una
invocazione muta, interna, di ogni momento»91
) e quell’altra forma di accesa
preghiera ch’era per lui la poesia («Far poesia è diventato per me, più che mai,
modo concreto di amar Dio e i fratelli»)92
.
Ero di passaggio a Stresa nell’ottobre del ’54 e non pensavo per nulla a Rebora,
che credevo al Calvario di Domodossola o in un’altra casa dell’Istituto. Pensavo a
Rosmini. E una mattina, un po’ tardi, mi avviai al Collegio, su in alto, per
88 Testo più volte pubblicato e modificato: «Il gallo», Genova, 25 dicembre 1957, «Il
giornale d’Italia», Roma, 2-3 marzo 1964 e, successivamente, in BARILE, Incontri con gli
amici, cit., 171-3, con il titolo La messa di don Clemente Rebora; infine in ANGELO BARILE
e MARGHERITA MARCHIONE, Ricordo di Rebora, Vicenza, La locusta, 1989. «Mi ha
addolorato la morte di Clemente Rebora, anche se si sapeva da tempo che agonizzava e
soffriva di “non poter morire”. Mi pare di averti raccontato, quando tu sei stato qui, come
l’ho conosciuto, qualche anno fa, a Stresa, nel collegio rosminiano; nel modo più
impreveduto: mentre diceva Messa nella chiesetta dove è sepolto Rosmini. Era un santo. La
sua vita era una cosa sola con la sua poesia, e valeva anche di più» (lettera a Antonio
Pinghelli da Albisola del 5 novembre 1957, in ROMBI, Angelo Barile, l’ospite discreto, cit.,
p. 85). 89 GIOVANNI BOINE, Plausi e botte, a cura di MARIO NOVARO, Modena, Guanda, 19393, pp.
78-86, a p. 79. 90 CLEMENTE REBORA, Le poesie (1913-1957), a cura di GIANNI MUSSINI e VANNI
SCHEIWILLER, Milano, Garzanti, 1988, p. 259. 91 Ibidem. 92 Ibidem.
43
rivederne dopo tanti anni la tomba. Mi accompagnava un vecchio amico estraneo
al mondo delle lettere. Un inserviente ci guidò per anditi e stanze della Chiesa del
SS. Crocifisso. Vi entrammo dalla parte dell’altare. All’altare celebrava un vecchio
prete assistito da un giovane. Non c’era nessun altro a quell’ora, e la chiesa pareva
più vasta e più nuda. La Messa era appena al principio e ci fermammo a sentirla
nella prima fila dei banchi.
Il sacerdote celebrava lento, con assorto fervore, con intensa partecipazione,
pronunciando bene le parole che in quel silenzio, in quella pace, meglio che chiare
giungevano vive, animate. Ma nell’inginocchiarsi, nel passare da un lato all’altro
dell’altare piegava un po’ da una parte, i suoi movimenti erano visibilmente
impediti[: si sarebbe detto che avesse ai fianchi il cilizio]93
. E quando si voltava
verso noi anche il suo viso – un viso nobile, illuminato dagli occhi – era di
sofferente. Al Domine non sum dignus io sentii distintamente i tre colpi risuonare
sul suo petto.
Finita la Messa, e tornato il ragazzo presso l’altare, mi avvicinai per chiedergli
della tomba di Rosmini e non potei trattenermi dal dirgli: ma quel povero
sacerdote è malato. Mi rispose che soffriva da circa un anno per una paresi; poi
quasi esitando, con timida grazia: «Eppure quel Padre è stato un poeta dei più noti
d’Italia». Non aggiunse il nome e non era ormai necessario. Mi precipitai a cercare
don Clemente, a baciargli la mano, mentre era ancora in preghiera dietro l’altare.
Usciti di chiesa non so bene che cosa gli dissi: credo soltanto che ero venuto lì per
Rosmini. Egli ne fu contento, s’illuminò di un sorriso nel volto emaciato, prese a
parlarmi del suo santo Fondatore e delle onoranze centenarie che proprio allora si
stavano preparando. Non ci dicemmo forse altro. E non mi venne neppure il
pensiero di toccare altri argomenti. Impossibile, assolutamente impossibile dopo
quella Messa.
Fu ancora così quando da casa gli scrissi e lui mi rispose soltanto come sacerdote.
Fino alle ultime scarne parole di benedizione, dettate, ma non più vergate da don
Clemente: «Stresa, 15 ottobre ’56. Grazie per le intime e tanto affettuose parole: le
serbo anche se dal letto della mia infermità, sfinito. Assai ti benedico, don
Clemente Maria Rebora».
La sua benedizione è molto più che un ricordo: viva, nel cuore, da quel giorno che
levò la mano a benedirmi, nella chiesa deserta, il vecchio sacerdote ancora a me
ignoto.
Angelo Barile
93 La porzione testuale indicata tra parentesi quadrate appare in BARILE, Incontri con gli
amici, cit., p. 173.
44
AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO
In questo spazio si è tentato di recuperare gli scritti di e su Barile apparsi
nell’ultima quindicina d’anni, tenendo anche conto delle più o meno distese
trattazioni comparse in antologie o in storie della letteratura. Per i contributi
anteriori al 1989, eccezione fatta per le integrazioni, si vedano i circostanziati
regesti editi in Bibliografia degli scritti su Angelo Barile, a cura di PINO BOERO e
STEFANIA SILVESTRI, in La poesia di Angelo Barile, Atti del Convegno di studi
(Albisola, 14-15 maggio 1977), Genova, «Resine», 1978, pp. 249-58 e in BRUNO
ROMBI, Angelo Barile, l’ospite discreto, Savona, Sabatelli, 1989, pp. 105-10,
nonché la Notizia bio-bibliografica in ANGELO BARILE, Risonanze (1931-1934), a
cura di SIMONA MORANDO, Milano, Scheiwiller, 1997, alle pp. 143-47. Le
pubblicazioni sono date in sequenza cronologica. Per le opere apparse nello stesso
anno si è seguito l’ordine alfabetico.
1988
1. DOMENICO ASTENGO, Angelo Barile prima della poesia, «Il ragguaglio librario»,
Milano, LV, n° 7-8, luglio-agosto 1988, pp. 248-49.
2. ANGELO BARILE, Leggere poesia, con una nota di GIOVANNI FARRIS, «Sabazia»,
Savona, 1988, n° 5, pp. 23-25
3. AURELIO BENEVENTO, Saggi su Barile, Napoli, Loffredo, 1988
4. ENRICO BONINO, Come conobbi Angelo Barile, «Il ragguaglio librario», cit., pp.
252-53.
5. GIORGIO CAVALLINI, Strutture tendenze esempi della poesia italiana del
Novecento, Roma, Bulzoni, 1988 (il capitolo Barile e il colloquio con i morti, pp.
123-55)
6. “…Il poeta Angelo Barile…” [interviste a CARLO BO e GINA LAGORIO], a cura di
BRUNO ROMBI, «Il ragguaglio librario», cit., pp. 254-55.
7. La letteratura ligure, vol. 2: Il Novecento, parte II, Genova, Costa & Nolan, 1988,
pp. 319-23 e 356-65.
8. FAUSTO MONTANARI, Angelo Barile, «Il ragguaglio librario», cit., pp. 244-45.
9. BRUNO ROMBI, L’amico Angelo Barile attraverso due documenti epistolari, «Il
ragguaglio librario», Milano, LV, n° 9, pp. 295-96.
10. UMBERTO SILVA, Barile, tra vita e poesia, «Il Lavoro», Genova, 2 novembre 1988
11. STEFANO VERDINO, Un lettore generoso con l’opera altrui, ibid.
1989
12. ANGELO BARILE e MARGHERITA MARCHIONE, Ricordo di Rebora, Vicenza, La
locusta, 1989.
13. ANGELO BARILE, Ritagli di giornale, a cura di GIOVANNI FARRIS, Savona,
Sabatelli, 1989
14. ENRICO BONINO, Ricordando Angelo Barile a cento anni dalla nascita, «Liguria»,
Genova, LVI, 1989, n° 3, pp. 7-9
15. FRANCESCO DE NICOLA, Un Barile di poesia, «Il Lavoro», Genova, 6 ottobre 1989
16. Omaggio ad Angelo Barile, Atti del Convegno di studi, «Resine», Savona, n° 42,
1989 (contiene i saggi: GIORGIO BARBERI SQUAROTTI, Angelo Barile e la poesia
italiana del ’900. Stile ed esperienza religiosa; ALBERTO FRATTINI, Angelo Barile:
una voce ligure inconfondibile nella poesia italiana del nostro secolo; GIOVANNI
45
FARRIS, Ideali e formazione civile in Angelo Barile; GIUSEPPE AMASIO, Angelo
Barile uomo e amministratore; CARLO RUSSO, Impegno civile di Angelo Barile;
ENRICO BONINO, Per Angelo Barile; Ritratto a più voci, condotto da BRUNO
ROMBI; FRANCESCO DE NICOLA, L’itinerario poetico di Angelo Barile; DOMENICO
ASTENGO, Gli artisti di «Circoli»; MARCELLO CAMILUCCI, Angelo Barile o
dell’amicizia; EDOARDO VILLA, Angelo Barile, linee di una poesia; GIORGIO
CAVALLINI, Barile, il poeta che parla con le “anime care” dei defunti; LUIGI
PEIRONE, Alla ricerca dell’essenzialità lirica tra le varianti di Barile; CLAUDIO
MARCHIORI, Angelo Barile: due giudizi su D’Annunzio; FRANCESCO DE NICOLA,
“Primavera a Nervi”, poesia inedita di Angelo Barile)
17. BRUNO ROMBI, Angelo Barile, l’ospite discreto, Savona, Sabatelli, 1989 (con
testimonianze di: Minnie Alzona, Domenico Astengo, Emanuele Barile, Carlo Bo,
Enrico Bonino, Giovanni Cristini, Vico Faggi, Giovanni Farris, Gina Lagorio,
Antonio Pinghelli, Silvio Riolfo Marengo, Aldo G.B. Rossi, Adriano Sansa)
18. BRUNO ROMBI, Poesia come confessione, «Renovatio», Genova, XXIV, 1989, n°
1, pp. 161-73
1990
19. ANGELO BARILE, Il genio di due popoli in guerra. Alcune lettere dal fronte,
Savona, Sabatelli, 1990
1991
20. ELIO ANDRIUOLI, Il sentimento cristiano della vita in Angelo Barile, «Cristallo.
Rassegna di varia umanità», Bolzano, XXXIII, n° 1, 1991, pp. 83-8.
21. «Io sono un trovatore» [una lettera di Montale a Barile], con una nota di
DOMENICO ASTENGO, «La Repubblica», Roma, 11 settembre 1991, pp. 30-1.
1992
22. DOMENCO ASTENGO, Il giudice segreto: Angelo Barile amico e lettore di poeti, in
Archivi degli scrittori. Le carte di alcuni autori del Novecento. Indagini e
proposte, Treviso, Premio Comisso, 1992, pp. 121-30
23. FRANCESCO DE NICOLA, Angelo Barile: il dono della poesia, in Dal best seller
all’oblio. Scrittori liguri nella letteratura italiana, Genova, Marietti, 1992, pp.
105-19
24. BRUNO ROMBI, Il mare Mediterraneo nella letteratura europea, «Journal of
maltese studies», Malta, ni 21-22, 1991-1992, pp. 20-69
1993
25. ANGELO BARILE, «Circoli» anno primo, Savona, Sabatelli, 1993
1994
26. ANGELO BARILE, Agli eroi della guerra 1914-1918 (Discorsi). Ai sacerdoti defunti
della mia parrocchia, Savona, Sabatelli, 1994
27. ANGELO BARILE, La ragnatela delle parole. Epistolario Zingara-Barile, a cura di
GIOVANNI FARRIS, Savona, Sabatelli, 1994
28. SILVIO GUARNIERI, La linea ligustica, in Studi in onore di Antonio Piromalli, a
cura di TONI IERMANO e TOMMASO SCAPPATICCI, 3 voll., Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 1994, vol. 2, pp. 319-35
46
29. «Nel sole breve». Il carteggio Angelo Barile – Anita Pittoni (1962-1967),
«Resine», Savona, n° 60, 1994, pp. 3-8
1995
30. DOMENICO ASTENGO, Lettera di Natale: Camillo Sbarbaro, «Leggere», Milano, n°
76, 1995, pp. 4-6 [Una lettera di Sbarbaro a Barile]
31. GIORGIO CAVALLINI, Barile e le «anime care» dei defunti, in ID., Parole d’autore.
Usi stilistici da Boccaccio a oggi, Roma, Bulzoni, 1995, pp. 331-34
1996
32. DOMENICO ASTENGO, «In un’istantanea ingiallita»: gli amici Barile, Grande,
Sbarbaro, in La Liguria di Montale, a cura di FRANCO CONTORBIA e LUIGI
SURDICH, Savona, Sabatelli, 1996, pp. 159-68
33. Una dolcezza inquieta. L’universo poetico di Eugenio Montale [13 lettere e
cartoline di Montale a Barile e una lettera di Sergio Solmi a Barile], Catalogo della
mostra a cura di GIUSEPPE MARCENARO e PIERO BORAGINA, Milano, Electa, 1986,
pp. 67-74
1997
34. ANGELO BARILE, Risonanze (1931-1934), a cura di SIMONA MORANDO, Milano,
Scheiwiller, 1997
35. GIUDITTA CAPELLA, Angelo Barile: poesia del margine, «Resine», Savona, ni, 73-
74, 1997, pp. 53-65 [fascicolo dedicato a Barile, Sbarbaro e Grande]
36. LUIGI FENGA, Quella che danza fuori musica e sola, ivi, pp. 67-80
37. SIMONA MORANDO, In nome della poesia, in BARILE, Risonanze, cit., pp. 105-38
38. UMBERTO SABA, Lettere a Sandro Penna, a cura di ROBERTO DEIDIER, Milano,
Archinto, 1997 [alcune lettere dal carteggio Barile-Saba, pp. 47-51]
1998
39. SIMONA MORANDO, Il mondo senza sirene. I poeti liguri del primo Novecento di
fronte a D’Annunzio, in Terre, città e paesi nella vita e nell’arte di Gabriele
D’Annunzio, vol. V: Sogni di terre lontane: dall’ “Adria velivolo” al “Benaco
marino”, Pescara, Ediart, 1998, pp. 164-91
1999
40. SALVATORE QUASIMODO, Carteggi con Angelo Barile, Adriano Grande, Angiolo
Silvio Novaro. 1930-1941, a cura di GIOVANNA MUSOLINO, prefazione di
GILBERTO FINZI, Milano, Archinto, 1999
2001
41. ROSALBA CURRÒ, Incontri e sodalizi in terra ligure: Barile, Quasimodo e Natoli,
«Resine», Savona, n° 90, 2001, pp. 30-38
2002
42. VICO FAGGI, Da Montale a Barile, «Resine», Savona, n° 91, 2002, pp. 79-80
43. EUGENIO MONTALE, Giorni di libeccio. Lettere ad Angelo Barile, a cura di
DOMENICO ASTENGO e GIAMPIERO COSTA, Milano, Archinto, 2002























































![Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334f93ea1ced1126c0a92f1/il-tesoro-dei-pirati-la-fotografia-a-inchiostro-fra-rotocalchi-e-riviste-fotografiche.jpg)