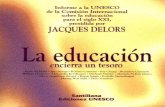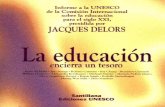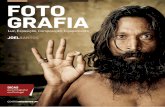Appunti in tema di valutazione: criteri per le riviste nell'ambito delle scienze giuridiche
Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959...
Transcript of Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959...
117
Il tesoro dei pirati. La fotografa a inchiostrofra rotocalchi e riviste fotografche, 1947-1959Tiziana Serena
1. Prologo
Nel 1949 Mario De Biasi, ancora fotoamatore, realizza la fotografa Pavia in cui vediamo un’edicola occasionale allestita con una cariola entro un riparo di assi di legno, dove una anziana signora in abiti poveri ci appare come anacronistica in relazione a quella modernità delle copertine fotografche dei rotocalchi pati-nati. “Oggi”, “La settimana Incom”, “Radio corriere” e “Bolero”, appesi ai fli con le mollette del bucato, appaiono collocati in un ambiente che appare cul-turalmente arretrato e che non riconosciamo come urbano, nonostante il titolo della fotografa. Quattro anni dopo, in un anno che segna una tappa importante per la periodizzazione della storia della fotografa, per il passaggio al professio-nismo di Paolo Monti e De Biasi e il riconoscimento di una nuova generazio-ne di fotograf, Roberto Morini, un altro fotoamatore, pubblica a inchiostro l’immagine fotografca Curiosità sulla rivista di settore “Fotografa”: davanti al chiosco di un’edicola, ora collocata in un chiaro ambiente urbano, un bambi-no è intento a osservare le sfavillanti copertine colorate della stampa illustrata: all’altezza del suo sguardo “Avventura” e “Oggi”, mentre in alto intravediamo “Il Borghese”, “Tempo”, “La Scienza illustrata” e “Bolero”.
Queste due opere raccontano dei molteplici intrecci fra le fotografe ar-gentiche e le immagini fotografche stampate a inchiostro, intese come quella possibilità di una “conoscenza per immagini” di cui aveva scritto Paolo Mon-ti, capaci di incidere sul destino della Fotografa italiana. Il periodo è quello in cui la stampa illustrata, sulla scia delle trainanti esperienze straniere, sembra aver fatto breccia in una popolazione ancora fortemente analfabeta, ma in grado di leggere le immagini; e in cui – contemporaneamente – i fotograf italiani riescono con grande fermento a rinnovare il proprio linguaggio, grazie ai modelli della fotografa estera: americani se traghettati dalla stampa illustra-ta;1 europei in relazione alla diffusione delle riviste fotografche.
in: "Arte moltiplicata. L'immagine del '900 italiano nello specchio dei rotocalchi",a cura di B. Cinelli, F. Fergonzi, M.G. Messina, A. Negri, Milano, Bruno Mondadori,2013. ISBN 9788861598577
Arte moltiplicata
118
2. Il tesoro dei pirati
La fotografa straniera nel primo dopoguerra rappresenta per i fotograf ita-liani un vero e proprio mito in grado di nutrire vari immaginari. Basti pensare alla vicenda di Alfa Castaldi, allievo di Roberto Longhi, che riesce a procu-rarsi un baule di fotografe dell’agenzia Magnum al quale avrebbe attinto a piene mani, come fosse un vero e proprio tesoro dei pirati, la scuola milanese di fotografa degli anni cinquanta, di Carlo Bavagnoli e di quelli che ruotava-no attorno al Bar Jamaica e alla rivista “Cinema nuovo”.2 Oppure alle parole dell’avvocato Giuseppe Cavalli che, nel 1953, nel passare il testimone alla generazione dei giovani fotograf, defnì l’innovazione di Fulvio Roiter in rela-zione alla sua capacità di essere aggiornato alla produzione fotografca coeva.
1. Roberto Morini, Curiosità, in “Fotografa”, a. VI, n. 1, 1953, p. 16, fotografa inserita nell’articolo La mostra di Roberto Morini al C.F.M.
Il tesoro dei pirati
119
Cavalli ha 49 anni e ha visto due guerre mondiali, Roiter solo una, e ha 22 anni di meno: si è avvicinato alla fotografa negli anni della ricostruzione della società, dello smantellamento della cultura fascista, e dell’entrata in Italia di suggestioni fgurative che provenivano dalla cultura estera avversata dal regi-me. Della fotografa straniera conosceva a memoria le immagini a inchiostro e, quando scattava una fotografa, guardava la realtà attraverso il fltro di quella cultura visiva che faceva di lui una sorta di “fotoalmanacco” vivente.3
Se si escludono le poche mostre di rilievo della fotografa italiana, di solito accompagnate da magri cataloghi, e le occasioni circoscritte – dapprima solo alle città di Milano e di Venezia, poi ad alcuni centri minori – di vedere dal vivo le opere della fotografa europea e internazionale,4 fno alla prima metà degli anni cinquanta, il principale canale di trasmissione e circolazione della cultu-ra fotografca è ravvisabile nella stampa a inchiostro:5 quello dei rotocalchi che propongono i grandi fotoreporter stranieri,6 e quello della produzione periodica specializzata, fra foto annuari nazionali7e riviste fotografche italiane e straniere.8
2. Paolo Monti, Cubismo, in “Il Progresso Fotografco”,a. VX, n. 2, 1953, p. 55, fotografa inserita come tavola fuori testo.
Arte moltiplicata
120
Per quanto riguarda quest’ultimo ambito si i tratta di un serbatoio d’im-magini particolare, sempre in tensione fra produzione bassa e alta, fra con-trollo tecnico e sapienza compositiva, frammiste a istanze documentaristiche ed espressive. Per chiarire alcuni aspetti di questa cultura visiva possiamo utilizzare i modi ordinari con i quali la fotografa viene denotata dal testo; ad esempio, l’opera Cubismo (1953) di Paolo Monti, con il suo titolo intriso di evocazioni artistiche, nella didascalia evidenzia la negoziazione fra le ambi-zioni artistiche e la comunicazione rivolta al mondo dei fotoamatori voluta della redazione di “Progresso Fotografco”: “Cubismo/App. 6x6 cm, Obietti-vo Tessar 3,5 / Filtro Arancio – Diaframma 8 – 1/50 / Pellicola IlFord HP3”.9 Mentre la cultura dei fotoamatori si attarda su questi modi di concepire la fotografa ancorata al sapere tecnico, nei rotocalchi vengono pubblicate im-magini dei fotograf professionisti d’agenzia, secondo ancora poco indagati modi di circolazione e trasformazione dei servizi fotografci, ma pochi sono quelli che dichiarano gli autori delle fotografe e, pertanto, l’appartenenza culturale delle immagini.
Bisognerà aspettare il decennio successivo per una stabilizzazione del-le pratiche; nel nostro decennio – invece – gli sguardi incrociati portati da quell’incredibile numero di fotograf, amatori, fotograf d’agenzia e professio-nisti, convergono sui molteplici materiali della fotografa a inchiostro, la cui storia resta ancora frammentata in numerose culture e pratiche fotografche.
3. Sguardi incrociati
Accanto a questo tema delle immagini fotografche a inchiostro, fonti e agenti in un “sistema integrato”, così come le ha defnite Giovanni Fio-rentino, che le colloca al centro di una “serie interminabile di scambi e di rimediazioni”,10 per tentare di restituire il period eye, la presenza massiccia della fotografa nei rotocalchi non può essere separata dall’analisi delle fotografe nelle riviste di settore, in cui si discute di arte fotografca e di te-matiche specifche, le quali sono tangenti alle necessità di consumo d’im-magini fotografche nella società, desiderosa di documenti visivi in grado di mostrare i volti dei politici e dei regnanti, delle soubrette e dell’uomo comune colpito dai fatti della cronaca nera, ma anche della realtà quoti-diana del Bel, e sconosciuto, Paese.
Giuseppe Turroni, nell’introduzione del suo noto volume divulgativo Gui-da alla critica fotografca (1962), pubblicato a poca distanza dai primi bilanci del decennio,11 esordisce proprio constatando che: “Viviamo nell’epoca del rotocalco”;12 epoca di cui Armando Silvestri, già nel 1947, nelle pagine di “Ferrania”13 avvertiva gli inizi nel passaggio dai comics alle “storie a fumetti fotografate”, con quelle immagini di bassa qualità. Sostanzialmente il loro sviluppo, assieme a quello dell’industria e della società, ha determinato la
Il tesoro dei pirati
121
fsionomia di un periodo storico che – come ribadiva Turroni nel medaglione dedicato a “ultimo degli artisti”, Giuseppe Cavalli –14 “vuole soltanto il docu-mento e dimentica tutto il resto”.15
La questione del documento fotografco poneva pertanto la fotografa al centro di pratiche e consumi diversi: dal successo del fotoromanzo,16 ai rotocalchi, passando anche per le fotografe delle scene dei flm, le quali venivano spesso ospitate nelle riviste di fotografa in una sezione separata. Così era stata concepita l’impaginazione di “Ferrania” in due parti dedicate alla fotografa e al cinema (con articoli e fotografe); modalità alla quale non era estranea la rivista diretta da Aldo Lini, “Diorama”. Le fotografe di sce-na e fotogrammi del cinema, se comparate alla produzione specifcatamente fotografca ospitata nella prima sezione, dimostravano il loro moderno ca-rattere tanto dirompente quanto convincente nei tagli e nelle luci, così come nelle scelte dei soggetti di gusto (neo)realista.17 Il cinema però non sembra realmente dialogare molto con la fotografa nelle pagine di questi periodici, e nonostante la lezione di Leo Longanesi, con la famosa rubrica “L’occhio di vetro”, e gli interessi incrociati di Turroni, bisognerà attendere segni più tardivi e in linea con le situazioni europee.18 Nel 1956, per la prima volta un foto annuario accoglie una sezione sulle fotografe di cinema, con testo di Mario Milani che accompagna le fotografe stampate con chiare didascalie relative al flm, al regista e agli attori, ma nessuna informazione relativa al fotografo che le ha realizzate.19
Alla fotografa – si potrebbe allora sostenere – è allora richiesto un altro compito, quasi di carattere interstiziale e che, ancor prima che essa sappia conquistarsi una posizione in seno alla società, con rifessioni sulle ragioni dell’arte e del ‘documento’ nel reportage non solo d’esprit, ma anche effettiva-mente engagé (sebbene con tutte le sue occasioni effettivamente mancante),20 è accolto dallo sviluppo dei sistemi economici del cinema e dei rotocalchi.
Il rotocalco affonda le proprie radici culturali negli anni trenta e nel dia-logo con la fotografa che struttura il layout della doppia pagina e informa le notizie, facendo appello a quel lettore medio defnito da Raffaele Berti un “lettore-spettatore”,21 il quale accede alle notizie perché guarda le immagini fotografche. Non a caso, sono numerosi i direttori delle testate che ribadisco-no il peso decisivo assegnato alla fotografa del determinare la fsionomia della rivista. Nei loro editoriali d’apertura, per “Epoca” (1950), Alberto Monda-dori dichiara di voler instaurare con il lettore un dialogo anche “di carattere visivo”;22 tre anni dopo Salviato Cappelli, per “Le Ore. Documentario Setti-manale di Attualità Fotografca”, dichiara che si tratta di “una pubblicazione da leggere, sì, ma da vedere”.23 E la stessa impostazione si ritrovava in altre esperienze editoriali maturate dall’esperienza di “Omnibus” di Leo Longane-si:24 “gli articoli si guardano le fotografe si leggono”25 era il motto del diretto-re Arrigo Benedetti de “L’Europeo”(1945-);26 parole che del resto erano del tutto simili a quelle di Ennio Flaiano de “Il Mondo” (1949-).27
Arte moltiplicata
122
La formula del consumo d’immagini da leggere conquista un’ampia fetta di mercato e il decennio è caratterizzato da una vasta produzione di roto-calchi, registrando un’impennata nel giro di pochi e cruciali anni, che pos-siamo prendere come confronto anche le periodizzazioni della produzione fotografca: nel 1950, i periodici “Domenica del Corriere”, “Oggi”, “Epoca”, “Tempo”, “L’Europeo”, “Il Mondo” vendono complessivamente 1.665.000 copie (a una popolazione non analfabeta stimata ottimisticamente di circa 20.000.000 persone),28 che raggiungono le 2.710.000 copie, nel 1957,29 regi-strando un incremento del 38,6%.
4. La vetrina delle riviste di fotografa30
Uno studio sulla fotografa condotto dall’osservatorio privilegiato delle ri-viste di settore, circa una decina, per il periodo che va dal 1947 al 1959, restituisce una idea della cultura fotografca del paese sbilanciata e ancora, necessariamente, provvisoria. Quasi tutte le riviste di settore sono pubbli-cate al nord e Milano anche in questo settore conferma una centralità da un punto di vista editoriale, con le pubblicazioni di “Ferrania”, “Fotografa”, “Fotorivista”, “Il progresso fotografco” e, dal 1957, l’edizione italiana di “Popular Photography”.
Milano era stata una piazza interessante anche per l’attività espositiva con mostre di spicco, organizzate dal Circolo Fotografco Milanese (CFM) e dall’UF,31 e la rivista “Fotografa” era diventata la vetrina degli autori pre-sentati nelle mostre, ma anche dei contatti con l’estero promossi da Pietro Donzelli e dal suo gruppo. Fra il 1953 e il 1956, su “Fotografa” vengono pubblicate 157 fotografe che appartengono a 110 fotograf stranieri, ai qua-li solitamente viene riservata la pagina fuori testo e stampata al vivo, solu-zione grafca che permette la migliore visualizzazione della fotografa e ne sottolinea l’importanza, svincolandola dal testo. La lista degli stranieri che pubblicano il maggior numero di fotografe conferma il gusto eclettico della rivista: Shankerlal Davay, Wilhelm Schack, i quali propongono anche una trattazione teorica della fotografa, seguiti dalle immagini di Toni Schnei-ders che conquistano tre volte la copertina, Tomas D.W. Friedmann, Marcel Natkin e Agnès Varda.32 In seguito, il ruolo di Milano è stato affancato, e per certi versi sostituito, da Venezia, a partire dal 1955, con le mostre scam-bio del Circolo La Gondola, di cui le riviste recano le tracce.33
Acquistate e lette in tutti i circoli fotografci dove si discute animatamente di fotografa e di ottica, di soggetti e di scelte stilistiche legate alle tecniche di stam-pa e ai loro formati, le riviste costituiscono il canale privilegiato di circolazione dei modelli fotografci, anche qualora legati agli eventi espositivi di cui esse sono l’eco. Eccezionale, ma esemplifcativo del rapporto editoria-mostra-periodico, è il caso della Mostra della Fotografa Italiana (1953), tenuta alla Galleria della
Il tesoro dei pirati
123
Vigna Nuova a Firenze per cura di Giuseppe Cavalli come un primo bilancio della fotogra-fa nazionale:34 pur se accompagnata da un piccolo catalogo, si dif-fonde con “Il Progresso Fotografco” che pub-blica 59 delle 60 opere esposte. Tramite l’im-paginazione e l’enfasi attribuita all’immagine, attraverso le dimensioni relative alla pagina e alla posizione nel layout, la stampa a inchiostro poteva aggiungere o to-gliere valori e signifcati alle stampe fotografche argentiche originali.
Possiamo immagi-nare che a partire da-gli scaffali dei circoli abbia avuto inizio un confronto fra le im-magini fotografche, prima che arrivassero esposte come concreti
oggetti, di bella factura come esigeva la cultura fotografca dell’epoca or-ganizzata attorno ai circoli. Al novero consueto: La Bussola di Milano, La Gondola di Venezia, Il Circolo Fotografco Milanese, L’Unione Fotogra-fca, Il Misa di Senigallia e Il Gruppo friulano per la nuova fotografa di Spilimbergo. Ma accanto a questi, il Foto annuario, del 1956, registrava una più articolata geografa. Le associazioni fotografche: Italiana di Tori-no, Olivetti di Ivrea, Pratese, e i circoli fotografci Bolognese, Bresciano, Milanese, assieme al Foto Club Monza e alla Società Fotografca Subal-pina di Torino fondarono, nel dicembre del 1948, la FIAF, sulla scia di altre iniziative che nello stesso anno avevano visto la I Mostra nazionale di fotografa del dopoguerra organizzata a Torino dalla Subalpina e la fon-dazione di “Fotografa”, quella di “Ferrania”, l’anno prima, e la ripresa delle pubblicazioni di “Progresso Fotografco”, “Rivista Fotografca Ita-liana”, “Corriere fotografco” e “Fotorivista”. Al 1956 le associazioni sul
3. Vittorio Villani, Ambulanti, in “Progresso fotografco”, a. VX, 1953, n. 6, copertina (la fotografa era stata esposta alla Mostra della fotografa italiana).
Arte moltiplicata
124
territorio aderenti alla FIAF erano una cinquantina, e raccoglievano fra le proprie fla quelli che defnendosi come “fotoartisti di valore”, mettevano il luce le loro ambizioni estetiche.35
Sono quei fotograf che partecipano alle numerosissime esposizioni na-zionali e internazionali e che, nelle pagine delle riviste italiane, riescono a pubblicare poche immagini nel corso della loro carriera di dilettanti. Una prima indagine su questi materiali ‘bassi’ della fotografa stabilisce che nelle sette principali riviste italiane di fotografa, fra il 1953 e il 1955,36 i fotograf che pubblicano fra una e cinque fotografe, rappresentando il 75% degli autori; di essi la storiografa ne nomina solo il 9,1%, e dell’intera rosa degli autori di fotografe pubblicate ne conosce solo il 17%.37 Di loro sappiamo, oltre ora ai nomi, solo che sono cresciuti all’ombra del circolo fotografco e si sono nutriti di immagini a inchiostro.
5. Intersezioni
I punti di contatto fra il mondo eterogeneo degli irregolari e quello profes-sionisti sono diffcili da determinare, e la sola lista delle fotografe pubbli-cate forse non è suffciente a spiegare gli intrecci e le contaminazioni delle rispettive pratiche.
Fra il 1953 e il 1956, De Biasi, appena passato al professionismo come primo fotoreporter interno a una redazione italiana, compare in cima alla classifca dei fotograf che pubblicano più immagini nelle riviste specializzate di fotografa, seguito da un primo gruppo pressoché compatto: Bruno Stefani, Fulvio Roiter, Mario Bonzuan, Giulio Parmiani, Toni Del Tin, che chiude con gli infaticabili fratelli Pedrotti; a cui segue un altro gruppo costituito da Gual-berto Davolio Marani, Paolo Monti, Federico Vender e Luxardo.
Un dato questo che, mettendo in evidenza il fatto che De Biasi pub-blica il triplo delle fotografe del caposcuola del tono-alto e lirico della fotografa italiana, Giuseppe Cavalli, suggerisce una prospettiva diversa sul ruolo delle immagini a inchiostro come agenti di cultura visiva, in re-lazione al peso fnora assegnato ai testi scritti. Inoltre, ribalta l’accento storiografco posto sulla capacità ricettiva delle riviste di settore che, fra istanze colte e divulgative, premiano De Biasi come autore-artista. Guido Bezzola, direttore di “Ferrania”, non poté che apprezzare il suo riconosci-mento nel mondo del giornalismo come professionista, compiaciuto evi-dentemente del fatto che non fosse un fotografo d’agenzia, ma uno istruito alla buona fotografa.38
Le agenzie fotografche operavano soprattutto per i rotocalchi e non rappresentavano completamente il mondo del professionismo. Con questo settore, fra i possibili punti d’intersezione, un caso di studio può essere rap-presentato dalle fotografe pubblicitarie realizzate per i foto concorsi aperti
Il tesoro dei pirati
125
ai professionisti e agli amatori. Ad esempio, “Rivista Fotografca Italiana”, si fa promotrice di due concorsi importanti: il concorso Paglieri, del quale per la cipria vinse il premio Cavalli, nel 1953, con l’opera Come una carezza, in cui il tradizionale ricorso all’high key faceva buon gioco alla comunica-zione visiva, di qualità tattile; e il celebre concorso Motta-Ferrania, subor-dinato all’uso di una pellicola Ferrania-color, preferibilmente stampata nel “terribile” formato uniformato 30x40 cm, che era stata una dichiarazione programmatica di poetica per la titolazione del gruppo francese Le Club 30x40 di André Thévenet, che assieme alla lezione di Edward Weston, ave-va presto affascinato anche gli italiani. In quello stesso anno, nella catego-ria professionisti vince l’abile Luxardo, mentre il premio assegnato ai non professionisti spetta a Stefano Robino, frequentatore degli studi dei pittori Sartorio e Spazzapan, di cui l’opera premiata sale agli onori anche del foto annuario, come per indicare che la via dell’industria con le sue possibilità di riconoscimento internazionale, garantito dalla circolazione fra i circoli fotografci dei foto annuari, rientra nelle ambizioni degli irregolari.39
Il professionismo costituisce l’anelito di più generazioni di fotoamatori che nell’Italia del secondo dopoguerra cercano di battere nuove strade per
4. Giuseppe Cavalli, Come una carezza, 1° premio Concorso fotografco-pubblicitario Paglieri, in “Rivista Fotografca Italiana”, a. XVII, n. 1, 1953, p. 1, fotografa inserita come tavola fuori testo.
5. 5° Gara Fotografca Motta-Ferrania. 1° premio ex-aequo. Categoria dilettanti. Stefano Robino – Torino, in “Rivista Fotografca Italiana”, a. XVIV, 1955, n. 4, p. 3.
Arte moltiplicata
126
un aggiornamento della fotografa, a contatto con quella straniera, e confron-tandosi con il ruolo assunto dalla fotografa nella società, con la sua crescente domanda di documenti visivi che richiedono un corpo a corpo diverso con il tempo presente. Istanza negletta in Italia alla generazione precedente che si dedicò a una fotografa colta, “lontana dalla storia” per necessità e come unica “salvezza possibile”,40 e alla quale risponde in primis, e non senza contraddi-zioni, la fotografa per il mondo dei rotocalchi d’evasione popolare e quelli d’evasione colta. Quest’ultimo settore è rimasto escluso in questa prima inda-gine, tuttavia le riviste illustrate rivolte a un pubblico selezionato e fnanziate dalle società industriali, sulle quali già Turroni aveva indicato una possibile strada di ricerca per la fotografa, come “Pirelli” e “Civiltà delle macchine” di Leonardo Sinisgalli, offrono un indiscutibile terreno di verifca per compara-re lo sviluppo della produzione fotografca.
6. Il colophon e lo straniero
Nel 1955, Guido Pellegrini, cri-tico di fotografa della vecchia scuola, poteva sostenere, e a ra-gione, che il mondo dei rotocal-chi italiani era condizionato da un’inguaribile esteroflia che fa-ceva preferire i fotoreporter stra-nieri ai fotograf italiani, i quali – proprio in quegli stessi anni – potevano cominciare a fare i pri-mi bilanci di un primo periodo di rinnovamento informato alle poetiche straniere.41
“Epoca” ne era l’artefce mag-giore, e bastava guardare il suo primo colophon per rendersene conto. Dopo che Arnoldo Mon-dadori aveva potuto acquistare, grazie ad ampi piani di fnan-ziamento nel quadro degli aiuti Marshall e dall’European Reco-very Program, una potente mac-china rotocalcografca americana, la Cottrel,42 nel primo numero, come direttore opera una scelta ardita che promette un uso e un 6. Colophon “Epoca” 1950, n. 1.
Il tesoro dei pirati
127
riconoscimento della fotografa molto più avvertito sui modelli internazionali di quanto seppe poi forse mantenere, inserendo i fotograf e le agenzie foto-grafche straniere, distinguendo i vari ruoli dei fotograf impiegati: “Inviati speciali”, “Il laboratorio fotografco”, “I servizi fotografci” e, infne la cate-goria dei “Foto-reporters”, in cui sono contemplati solo autori stranieri: per un totale di una cinquantina di nomi.
Ma anche solo attenendosi al tamburello inserito sotto il sommario, che riporta l’effettiva pubblicazione nel numero del rotocalco, i nomi dei fotograf e delle agenzie fotografche restano numerosi. Schierati come un piccolo esercito, in ordine di comparsa annunciano l’ideologia della rivista: John Philips, Helen Fischer, Paul M. Pletzsch, Lionel Stein, Farabola, Pu-blifoto, Foto Mondo, Luigi Comencini, Ettore A. Naldoni, Robert Capa, Tass, Leonard McCombe, Steicker, Henry Cartier-Bresson, Ernst Haas, Giacomo Bellini, Angelo Pennoni, Angelo P. Bellin, Ernest Plinkas, Lam-berti Sorrentino, Ralph Crane, Roger Wood, Franck Corutis, George H. Cord, Interfoto, Signal Corps Photo, Offcial U.S.A. Photo, George Cord, Illustrated, Black Stars Publishing Company Inc., Magnum Photos inc., Pix Inc., Keystone Press Agency Ltd, International News Photo.
Inoltre, a inaugurare la breve stagione della controversa e coraggiosa direzione di Alberto (1950-51), c’è un articolo dedicato al nome tutelare
7. David Linton, Childbirth without fear / Maternità senza paura, copertina rispettivamente: “Life”, 30 gennaio 1950; “Epoca”, 4 novembre 1950.
Arte moltiplicata
128
del fotogiornalismo internazionale, Henri Cartier-Bresson. Inserito nella rubrica Epoca presenta,43 con un testo del critico d’arte Lincoln Kirstein, autore del riconoscimento del genio artistico ‘documentario’ di Walker Evans.44 Nelle stesse pagine del primo numero ci sono altri quattro servizi fotografci a frma di Robert Capa e Lamberti Sorrentino, assieme a servizi composti con fotografe di vari autori italiani e stranieri. Sempre nello stesso numero, sin dalla copertina fotografca, il noto photo-essay di John Philips, Liliana ragazza italiana, sebbene realizzato con la collaborazione di Ettore Naldoni, sanciva il passaggio simbolico di testimone fra “Life” ed “Epoca” tramite uno dei fotograf più pagati in Italia. Un passaggio ravvisabile anche nell’impiego delle stesse copertine e servizi (testo e im-magini) fra le due riviste; ad esempio, nel caso del servizio con fotografe di David Linton proposto in “Life” nel 20 gennaio 1950, e in “Epoca” nel 4 novembre dello stesso anno con lo stesso titolo tradotto: Maternità senza paura.
Il riconoscimento autoriale dei fotograf stranieri si concretizzava con la vetrina offerta dalla copertina e con l’ampiezza dedicata ai photo essays che raggiungevano una decina di pagine, in cui molte fotografe erano stampate al vivo. Per un numero complessivo di circa 200 immagini fo-tografche pubblicate in ogni numero settimanale, la fotografa si dichia-rava al centro delle politiche redazionale del primo periodo della rivista, corrispondente alla direzione di Alberto. Politica che trovava riverbero in quella sezione posta sotto il sommario che funziona da vera e propria agenda delle intenzioni programmatiche del periodico, la cui formula era in gran parte mutuata dalla precedente esperienza di direzione di “Tem-po” (1939-43), la prima aperta alle intemperie internazionali, proprio gra-zie all’impiego della fotografa.45 Nel suo sommario, per la prima volta in Italia, veniva chiaramente enfatizzato il ruolo sovrano delle agenzie foto-grafche e delle riviste americane, soprattutto “Life” con il suo contratto con la Black Star, e la concorrente “Look”, a loro volta debitrici delle pre-cedenti esperienze editoriali europee, fra le quali “Signal”, “Arbeiter Illu-strierte Zeitung”, “Photo Match” e “Vu”. Riviste, che assieme a “Stern” e “Picture Post”, presto cominciarono a circolare in Italia fra i fotograf del dopoguerra.46
Ma è il colophon fotografco ad essere considerato il manifesto della po-litica redazionale perseguita da Alberto, tanto che addirittura scompare, assieme al nome di Munari, seguendo presto il destino del direttore, il quale esce di scena frmando il suo ultimo editoriale nel 17 febbraio del 1951, per lasciare i riferimenti ai crediti fotografci alla pagina del sommario, così come era del resto abbastanza in uso, seppure con usi difformi, presso “Le Ore”, la rivista che secondo Monti aveva più appreso la lezione di “Life, e “Tempo Nuovo” di Arturo Tofanelli, legata ai servizi fotografci concessi in esclusiva da “Look”.
Il tesoro dei pirati
129
7. Costruire la narrazione: la sequenza fotografca
“Tempo” e il suo rapporto innovativo con il testo fotografco, come antesigna-no delle esperienze degli anni cinquanta per l’importanza dei primi fototesti di Lamberti Sorrentino e Federico Patellani, ma anche per il lavoro di art-director di Bruno Munari, la cui esperienza di sperimentazione a contato con le arti visive d’oltralpe, legate al Bauhaus, e la sua partecipazione a “Campo grafco”, “La rivista illustrata del popolo d’Italia” o “La Lettura” e, non ulti-mo “Domus”, fra 1943 e 1944, nel cui annuario Patellani aveva pubblicato il celeberrimo testo Giornalista nuova formula,47 aveva condizionato certe sen-sibilità per la fotografa, anche sul piano della costruzione della narrazione.
In relazione a questa ricordiamo le famose Fotocronache, pubblicate pro-prio per Domus nel 1944,48 e l’episodio del (foto)racconto esplicitamente dada pubblicato su “Oggi”, in cui l’impaginazione sostanzialmente simme-trica delle sette immagini fotografche, realizzate da A.T. Novelli, gioca come una boutade umoristica proprio sul ruolo ambiguo del documento fotografco e sulle capacità di rivelazione del fotografo di una realtà che resta incompren-sibile: quel corpo che appare in varie pose, in quella distesa provocatoriamen-te è scoperto fno ai glutei, e strizza l’occhio al lettore apparendo tanto reale fn tanto che non se ne colgono le disgiunte parti di manichino.49
8. Bruno Munari, Racconto dadà. Lungo nella notte il fschio del treno, in “Oggi”, 1946, n. 47, pp. 8-9; fotografe A.T.A. Novelli.
Arte moltiplicata
130
“Tempo” è la rivista che stabilizza il photo-es-say: realizzato da un auto-re, è una miscela di scrit-tura e fotografe, defnito in Italia con varie deno-minazioni che ne indica-no la funzione narrativa: “fototesto”, “fotoraccon-to”, “fotocronaca”, “fo-toinchiesta”, “fotosequen-za” e “fotoservizio”.
L’esigenza di narrare comunque faceva parte della cultura fgurativa rinnovata sul fronte del realismo, e di quella fo-tografa a cui era chiesto un rapporto specifco con il tempo presente. Basti pensare alle rifes-sioni sulla narratività del-la singola immagine e la relazione con la sequenza fotografca proposte da Cartier-Bresson nel suo famoso Images à la sau-vette (1952).
8. Costruire la narrazione: le parole, il taglio e le dimensioni50
Proprio l’esigenza di costruire partiture narrative ha portato le redazioni ad adattare le fotografe alle esigenze editoriali. Il taglio sulle fotografe non opera solo sui bordi per focalizzare sulla narratività interna dell’im-magine, ma recide il riconoscimento autoriale, quindi il livello professio-nale del fotografo. Il taglio enfatizza il signifcato formale e contenutistico della fotografa, diventa l’azione in cui l’editing si fa indizio dell’uso socia-le a cui la fotografa è destinata: della sua prima ricezione e della trasfor-mazione che subirà.
L’atteggiamento era diffuso anche nelle riviste di settore, magari dettato da esigenze immediate; un caso fra i tanti, è quello del Ragazzo del Sud, dell’emergente fotografo Piergiorgio Branzi, pubblicata in “Fotografa”,
9. Piergiorgio Branzi, Il ragazzo del Sud, in “Diorama”, a. V, n. 3, 1955, p. 9, fotografa inserita nell’articolo Breve proflo della fotografa italiana d’oggi.
Il tesoro dei pirati
131
nel 1953: la larghezza dell’immagine è adatta-ta a quella del trafletto dell’articolo, ma il ta-glio modifca la fotogra-fa sottraendo lo spazio bianco del muro attra-verso il quale l’autore ha costruito un ritmo com-positivo particolare pau-sato fra pieni e vuoti.51 La celebre immagine di Franco Pinna, La lamen-tatrice di Pisticci (1952), si offre come caso di studio particolare sulla “biografa sociale” del-la fotografa per l’alto numero di tagli operati dai diversi usi editoriali (e teorici), verifcati in una ampia cronologia e in diversi ambiti di pub-blicazione.52
Nel settore dei roto-calchi la narratività delle immagini era poi struttu-rata dalle parole, inserite dalle agenzie di stampa e/o fotografche, le quali vendevano notizie illustrate con fotografe e/o fotografe illustrate da ampie didascalie: a partire dalle brevi note incollate sul verso della fotografa le reda-zioni potevano adattare i contenuti del testo e dell’immagine al loro pubblico, intervenendo nell’uno con modifche e integrazioni e nell’altra tramite i tagli.
Una prima indagine relativa ai dati delle fotografe dell’archivio della rivi-sta “Il Mondo” di Mario Pannunzio, degli anni in cui l’autore delle fotografe rimaneva anonimo, ovvero antecedenti il 1959, e le immagini fotomeccaniche stampate sulla rivista, sembrerebbe indicare che la strada di un’analisi degli oggetti fotografci condotta a partire dal loro verso, ricco di segni editoriali di taglio e dimensionamento, timbri ad inchiostro di agenzie fotografche e di stampa che raccontano dei loro rapporti commerciali e della circolazione delle immagini, ma soprattutto di didascalie d’agenzia confezionate e prêt-à-porter, potrebbe portare a riconsiderare il ruolo degli operatori.
Mario Pannunzio, con Ennio Flaiano,53 è stato l’inventore di una libera e talvolta dissacratoria associazione fra testo e fotografa, poiché la fotogra-
10. Mario Carrieri, Copertina, in “Epoca”, a. II, n. 59, 24 novembre 1951, fotografa del servizio Si risveglia Rovigo nel deserto d’acqua.
Arte moltiplicata
132
fa che sceglieva con un gusto collezionistico non era in relazione a un pre-sunto evento narrato nel testo, e veniva impaginata secondo quel modo che è stato defnito ‘allusivo’. E l’ambiguità della fotografa, ai suoi occhi, tro-va forse riverbero nel numero di fotografe pubblicate nel 1953 (anno in cui compare un articolo dedicato esplicitamente al reportage, pur se in chiave ironica)54 che contengono riferimenti metafotografci, con l’inserimento nel frame dell’immagine di persone nell’atto di fotografare.55 Tuttavia, una prima indagine sulla relazione delle immagini non attribuite conservate nell’archi-vio, metterebbe in luce anche un altro aspetto che ci suggerisce di valuta-re Pannunzio e Flaiano non solo come inventori di un uso particolare della fotografa nella pagina stampata, ma anche come (ri)scrittori di didascalie e trasformatori d’immagini. Il rischio del resto era avvertito nell’avvertenza in alcune fotografe distribuite dalla Magnum, che per difendere l’autorialità dei propri fotograf doveva impedire la trasformazione delle loro fotografe, e che ben chiarisce alcuni possibili rapporti genealogici: “Photos must not be alte-red by trimming” e “can be reproduced only with the accompanying caption or text strictly in the spirit of its caption”.56
Non sappiamo se il mitico baule di Castaldi avesse stampe argentiche o fo-tografe a inchiostro, ma sulla scia dei modelli fotografci e della cultura f-gurativa delle riviste, incontriamo sempre a Milano e negli stessi anni Mario Carrieri, che salirà alla ribalta per il suo fototesto Milano, Italia,57 fglio di Raffaele Carrieri, critico d’arte infaticabile che scrisse per numerosi rotocalchi italiani dal periodo fra le due guerre, Mario lavora nell’archivio fotografco di “Epoca”, ma anche realizza fotografe nello stesso periodo in cui Mario De Biasi, nel febbraio del 1953, viene assunto. Quando De Biasi arriva ad “Epo-ca” deve guadagnarsi con fatica il posto delle prime pagine e delle fotografe stampate al vivo, solitamente destinate alle frme degli stranieri. I suoi esordi furono legati alla pubblicazione di immagini di piccolo-medio formato nelle pagine interne, che hanno come contenuto reportage di cronaca o di costu-me.58 Dopo qualche anno, il peso delle sue immagini nel contesto della pagina comincia a farsi decisivo, e ovviamente ebbe un peso determinante il servizio fotografco sulla rivoluzione di Budapest, del novembre 1956, recepito anche da due riviste di fotografa in tempi diversi.59
Nello stesso periodo di queste vicende, sempre nelle pagine di “Epoca”, ora alla direzione Enzo Biagi (nel 1952 come redattore capo, poi direttore fra 1955-60), altri fotograf italiani,60 soprattutto Paolo Costa, Massimo Mauri, Ivo Meldolesi,61 Ettore Augusto Naldoni e Alfredo Panicucci, si fanno nume-ricamente più presenti esplicitamente negli articoli, come responsabili di fo-totesti, formula che a partire dal 1954 viene con maggiore frequenza utilizzata nei tamburi di copertina, in linea con la produzione industriale del neoreali-smo in fotografa, e anche i pesi delle loro immagini, in termini di grandezza relativa a quella della pagina, aumentano.
Il tesoro dei pirati
133
9. Dall’Italia si vede l’America
“Epoca” si ricorderà per aveva offerto delle prove a quel “mito americano” traghettato attraverso le fotografe e i photo-essays, nei quali si ravvisava l’eco della forza cultura fotografca americana degli anni trenta legata alle vicende della Farm Security Administration (FSA), il cui potere immaginativo e an-tiretorico era stato alla base di numerose suggestioni letterarie e fgurative.62
Suggestioni che andavano dalla prima recensione dell’opera di Walker Evans scritta da Giulia Veronesi63 nello stesso anno in cui “Tempo” ospitava fotografe americane (1939), alla celebre avventura editoriale di Americana di Elio Vittorini (1941), con quell’ampia sezione fotografca disposta secondo una impaginazione a griglia, che prefgurava una narratività sottesa, fno alla proposta dello scrittore vicentino Guido Piovene con il suo volume De Ame-rica (1953),64 frutto di un lungo viaggio on the road negli U.S.A., corredato da fotografe d’illustri stranieri. L’esperienza abbastanza marginale al mondo della fotografa di uno come Piovene, che pure più avanti utilizzò ancora la fotografa collaborando con De Biasi per “Epoca”, può raccontare quanto i rotocalchi potessero funzionare da serbatoio di forme e modelli fotografci per un pubblico vario: del resto non sorprende fra le fotografe che accom-pagnano il testo, la presenza di Henri Cartier-Bresson forse anche per il suo passaggio su “Epoca”, per la quale Piovene stesso scriveva.
Ma l’America non è vista dall’Italia solamente attraverso la fnestra aperta dalla cultura fotografca che arriva sui rotocalchi e, in seguito, sulle pagine delle riviste, di cui “Popular Photography” edizione italiana non è che l’esem-pio più noto, è – a un certo punto – anche un luogo concreto, una meta mo-derna dove si recano i fotograf a scoprire un altro senso della loro fotografa, a contatto con quel paesaggio urbano e con la sua tradizione fgurativa nella fotografa americana, di cui era certamente giunto l’eco del rinnovamento tra-mite le fotografe di Paul Strand e di William Klein. Così l’irregolare Giulia Niccolai, il cui reportage su Harlem, del 1954 quando aveva 19 anni,65 suscita l’entusiasmo di Turroni, nel famoso testo del 1959, che lo reputa accostabile alle famosissime fotografe newyorkesi dello stesso De Biasi.
10. Intersezioni mancate
Nel 1954 a Milano, fu tenuta una mostra sulle fotografe pubblicate negli ul-timi dieci anni dalla rivista “Life” di Henri Robinson Luce, fotografato da De Biasi in quell’anno,66 il quale, già direttore di “Time” e “Fortune”, era anche marito della scrittrice e direttrice di “Vanity Fair”, Clare Boothe, nominata l’anno prima dal presidente Eseinhower ambasciatrice americana in Italia.
La mostra milanese è forse legata alle morti di Robert Capa e di Werner Bischof,67 inviato per “Life” a Lima, che contribuirono ad accrescere la fama
Arte moltiplicata
134
dei fotograf come eroi della società contempo-ranea dell’informazione. Nel 1958, Alfredo Camisa sottolineava quello che gli appariva essere una lapa-lissiana considerazione: “i grandi nomi della foto-grafa internazionale sono, nella quasi totalità, dei fotoreporters”.68 Tuttavia, se ci atteniamo alla stam-pa illustrata dobbiamo notare che l’articolo com-memorativo su Capa, che riprende quello di John Mecklin, per “Life”,69 non era stato il frutto del rico-noscimento al grande fo-tografo operato dalla cul-tura fotografca nostrana, per la quale solamente il “Il Corriere Fotografco”, che mostra una certa at-tenzione ai fotograf stra-nieri da Bischof a Brassäi, pubblica un breve reso-conto per immagini della sua attività.70 E il ricordo di Bischof era solo breve
trafletto nella rubrica voluta da Cesare Zavattini, Italia domanda, a frma del poeta Alfonso Gatto.
La notizia della mostra dei fotograf di “Life” passò quindi quasi inos-servata nella stampa specializzata di fotografa. Del resto era successo anche la prima mostra italiana di Cartier-Bresson, che era stata realizzata da uno storico dell’arte, Carlo Ludovico Ragghianti (nel 1952) e non da un addetto ai lavori della fotografa, non aveva accolto che poche distratte recensio-ni sulla stampa di settore,71 mentre era stato il mondo del fotogiornalismo a dare risalto all’iniziativa con il lungo testo di Oriana Fallaci, poco più che ventenne, su “Epoca”.72 Il mondo dei fotoamatori, con l’eccezione di Piergiorgio Branzi, e l’accoglienza avuta dai Fotograf Associati a Roma, si accorse un po’ più tardi di Cartier-Bresson, forse in coincidenza con la per-sonale a Milano, del 1956, organizzata da Remo Teccani e Lamberto Vitali,
11. Meglio di un racconto questa istantanea di George Silk descrive la sgomenta nostalgia d’una recluta in viaggio per il fronte, in s.a. [Gatto A.?], Qualche cosa della nostra vita, in “Epoca”, 1954, a. V, n. 193, 13 giugno, p. 22.
Il tesoro dei pirati
135
per poi eleggerlo come simbolo di una certa fotografa ridotta alla formula del “momento decisivo”.
Nello stesso anno della mostra milanese di Cartier-Bresson, per la fotogra-fa italiana si apre un vetrina internazionale e prestigiosa: la rivista “Camera”, diretta da Romeo Martinez pubblica un fascicolo speciale, Italia. Non è la pri-ma uscita sulla stampa estera e già negli anni precedenti gli esponenti dell’éco-le de Venise, per via delle mostre scambio, avevano trovato spazio sulle riviste d’ambito francese “Photo Monde”, “Photorama” e su “Photo-Cinema”. Ma ci interessa sottolineare che sulle pagine di “Camera”, compare il noto testo militante di Zannier che congeda la “vecchia generazione” dei formalisti (so-prattutto Cavalli e i seguaci dei precetti crociani) a favore dei “giovani” Roi-ter, Ferri, Bevilacqua, De Biasi, Ferroni, Del Tin capaci di trovare, grazie ai i riferimenti imprescindibili alla cultura fotografca straniera: “il trait d’union della fotografa pura [americana] e del foto-reportage [internazionale]”.73
Mentre la cultura fotografca italiana ignorava nel 1954 la mostra dei fo-tograf di “Life” a Milano, per poi concedere, nel 1957, alla I Mostra biennale di fotografa internazionale di Venezia una sezione all’agenzia Magnum,74 e organizzare l’anno successivo una mostra personale di Bischof alla Permanen-te di Milano,75 negli anni in cui Cartier-Bresson si conquistava una notorietà in Italia, una rivista parigina come “Photo-Cinema” sostanzialmente non si pronunciava sul maestro francese, eppure a Daniel Masclet, a cui il periodico va messo in relazione, vanno riconosciuti molti meriti di connessione e pro-mozione della fotografa internazionale, anche quando aveva aperto le porte agli scambi con gli italiani e fatto conoscere Weston.
Nel giro di pochi anni pochi anni, la cultura fotografca collegata alle im-magini a inchiostro mostrava tutti i segni dell’incipiente cambiamento delle culture di produzione di riferimento e le intersezioni mancate si fanno ora sentire: amatori pressoché sconosciuti, indipendenti, irregolari e professioni-sti potevano ora ambire a un ruolo più chiaro e ambizioso della fotografa e delle riviste come sedi del dibattito.
11. “Conoscete questa foto?”
Mentre la cultura fotografca rifetteva sul proprio ruolo, sulle pagine sulle riviste e in occasione della Rassegna della fotografa di Sesto San Giovanni, anche il relazione al consumo di documenti fotografci richiesti dai rotocal-chi, questi proseguivano per una stagione di sviluppo, strizzando l’occhio alla fotografa, ormai entrata defnitivamente a fare parte coscientemente dell’immaginario comune.
Un articolo illustrato a colori e ammiccante su “L’Europeo” si interro-gava su La differenza fra una fotografa e un quadro, proponendo un gio-co comparativo da settimana enigmistica.76 A partire dal maggio 1958, su
Arte moltiplicata
136
“Epoca”, il concorso Zeiss Ikon esclusivo per la rivista, proponeva un gioco attribuzionistico Riconoscete questa foto? in cui era stato estratto un parti-colare di una fotografa pubblicata nello stesso numero ritagliato e ingran-dito. Il concorso era affancato da una rubrica che a rotazione ospitava le testimonianze dei grandi fotograf (e alcuni registi) che elargivano consigli tecnico-stilistici; furono chiamati a testimoniare nell’ordine: Cartier-Bres-son, Cornel Lucas, Patellani e, infne, De Biasi.77
La galleria dei fotograf era in sintonia con le presentazioni fatte da altre riviste nel corso degli ultimi anni, alle quali si era aggiunto il modello bio-grafco di stile americano, importato dalla rivista “Popular photography”, e improntato sul cliché del fotografo come enfant prodige al quale il destino mette casualmente fra le mani, in giovane età, una macchina fotografca: vero e proprio tòpos letterario dal quale si dipana il mito del fotografo come do-minatore di meccaniche e ottiche, e dell’alchimia dei bagni di sviluppo e di fssaggio, affancato dalla presentazione delle sue fotografe tanto autoevidenti nei contenuti, quanto esplicite nel fornire i dati della loro esecuzione tecnica e, ovviamente, stampate e diffuse a inchiostro.
12. Epoca presenta il grande Concorso Zeiss Ikon/Dieci consigli di Mario De Biasi/Riconoscete questa foto?, in “Epoca”, 1958, n. 404, 29 giugno, pp. 70-71.
Il tesoro dei pirati
137
Note
1 Per un inquadramento generale, cfr. il sempre valido Ajello N., Il settimanale d’attualità, in Castronovo V., Tranfaglia N. (a c. di), Storia della stampa italiana, vol. V: La stampa italiana del neocapitalismo, Laterza, Bari, 1976, pp. 175-249; Lucas U., Bizzicari M. (a c. di), L’informazione negata, il fotogiornalismo in Italia 1945-1980, Dedalo Libri, Bari, 1981; La bella addormentata: morfologia e struttura del settimanale italiano, catalogo della mostra (Parma, 1972) Università di Parma – Ist. Di Storia dell’arte, Parma, 1972; la raccolta di scritti di Schwarz A., La fotografa tra comunicazione e mistifcazione, Priuli & Verlucca, Ivrea, 1980; Zannier I. (a c. di), Il dopoguerra dei fotograf, catalogo della mostra (Bologna, 1981), Grafs, Bologna, 1981; Il mondo dei fotograf, catalogo della mostra (Roma, 1990), Comune-AFT, Prato, 1990. Recentemente il tema è stato rivisitato da vari studi: Morello P, La fotografa in Italia, 1945-1975, Contrasto, Roma, 2010, pp. 121- 209; M.A. Pelizzari, Photography and Italy, Reaktion Book, London, 2011, pp. 102-126 (poi in ed. it.); Russo A., Storia culturale della fotografa italiana, dal Neorealismo al Postmoderno, Einaudi, Torino, 2011, pp. 48-94; D’Autilia G., Storia della fotografa in Italia dal 1839 ad oggi, Einaudi, Torino, 2013, pp. 243-313. Per fotografa a inchiostro intendiamo un’immagine fotografca stampata con tecniche fotomeccaniche e fototipiche, da contrapporsi all’opera fotografca ai sali al bromuro d’argento.
2 L’episodio è cit. in Pellegrini E., “Ogni foto deve valere mille parole”, in Lucas U., Bizzicari M. (a c. di), L’informazione negata, il fotogiornalismo in Italia 1945-1980, cit, pp. 5-21, p. 12; sull’ambiente culturale milanese cfr. Cadioli A., L’editoria tra impegno e rotocalco, in Petrillo G., Scalpelli A. (a c. di), Milano anni cinquanta, Franco Angeli, Milano, 1986, pp. 685-697.
3 Cavalli G., Giovani alla ribalta: Fulvio Roiter, in “Il Progresso Fotografco”, 7, luglio 1953, pp. 294-295, cit. da Clara Brandani nell’articolo in questo volume, nn. 24-25.
4 [Monti P., Introduzione], in Mostra della fotografa italiana. Organizzata dal circolo fotografco La Gondola, Venezia 1952. Le mostre avevano preso simbolicamente piede a Milano per opera del Circolo Fotografco Milanese (CFM) nel 1949; a cui era seguita l’importante Mostra della fotografa europea alla Pinacoteca di Brera nella primavera del 1951, a cura dell’Unione fotografca. Associazione internazionale manifestazioni fotografche (UF), che organizzò in 15 mesi, fra il 1949 e il 1950, ben 17 mostre (cit. in Morello P., La fotografa in Italia, 1945-1975, cit., p. 60). A partire dagli anni 1952-55 le mostre scambio a Venezia, organizzate dal Circolo La Bussola gettano le basi per le Mostre internazionali biennali di fotografa che iniziarono nel 1957 e si conclusero nel 1963 (Manfroi M., Circolo “La Gondola”: una microstoria, in I. Zannier, Fotografa a Venezia nel Dopoguerra: da Ferruccio Leiss al Circolo “La Gondola”, Alinari/Craf, Firenze, 2005, p. 21).
5 Fra questi, per quanto si tratti di un’eccezione, è da annoverare anche il voluminoso libro di Mollino C., Il messaggio della camera oscura, Chiantore, Torino, 1949.
6 La più importante fu la rivista “Il tempo” (1939-1943) che ospitava fotografe d’agenzia americane; seguita soprattutto da “Epoca”. Cfr. Donno A., La cultura americana nelle riviste italiane del dopoguerra. Tempo presente, 1956-1968, Lecce, Milella, 1978; Pellegrini E., “Ogni foto deve valere mille parole”, in Lucas U., Bizzicari M. (a c. di), L’informazione negata, il fotogiornalismo in Italia 1945-1980, cit, p. 12 cita il fatto che i fotograf “divoravano” letteralmente le collezioni di “Life” e “Look”. Cfr. anche Cellinese A., Le riviste fotografche “Life”, “Look” e l’importazione
Arte moltiplicata
138
di uno stile americano, in Scarpelli E., Schnapp J.T. (a c. di), Italiamerica. L’editoria, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori – Il Saggiatore, Milano, 2008, pp. 125-155.
7 Negli anni cinquanta in Italia vengono pubblicati, dall’editore Görlich di Milano, tre foto annuari che presentano una selezione delle fotografe ritenute più importanti nel panorama nazionale anche se prodotte da autori non necessariamente italiani e che, salvo poco eccezioni, sono tutte state pubblicate nelle riviste fotografche: Circolo Fotografco Milanese (a c. di), Foto annuario italiano 1953-54 (1953); Croci E. (a. c. di), Foto annuario italiano 1955-56 (1955); Croci E. (a. c. di), Foto annuario italiano 1958 (1958).
8 Al testo di generale inquadramento storico delle riviste di fotografa di Italo Zannier (Leggere la fotografa: le riviste specializzate in Italia, 1863-1990, La Nuova Italia Scientifca, Roma, 1993) non sono seguiti studi specifci.
9 Monti P., Cubismo, in “Progresso Fotografco”, 1953, n. 2, p. 55 (tavola fuori testo).10 Fiorentino G., Il mosaico delle immagini. Gli anni cinquanta ai bordi del consumo, in Anania
F. (a c. di), Consumi e mass media, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 11-51.11 Monti P., Otto anni di fotografa italiana, in Oliva G. (a c. di), Fotografa italiana, Tip.
Fantoni, Venezia, 1955, ora in Colombo C. (a c. di), Lo sguardo critico: cultura e fotografa in Italia, 1943-1968, Agorà editrice Torino, 2003, pp. 101-103; Camisa A., Su alcune tendenze della fotografa italiana d’oggi, in Foto annuario italiano (1958), cit., ora in Idem, pp. 105-108; e l’importante volume di Turroni G., Nuova fotografa italiana, Schwarz editore (collana Enciclopedia di cultura moderna), Milano, 1959.
12 “Viviamo nell’epoca del rotocalco; la cultura dell’uomo medio, di tutti i giorni, si forma attraverso la lettura delle riviste a grande tiratura. Il nostro occhio di conseguenza, ha trovato un’altra dimensione fgurativa, oltre quella offerta tradizionalmente dalla pittura: «la fotografa – come avvertiva Ennio Flaiano – adesso si fa leggere, più che guardare»”, in Turroni G., Prefazione (1962), al suo Guida alla critica fotografca, Il Castello, Milano (3 ed.), 1980, p. 5.
13 Silvestri A., La fotografa nell’illustrazione di periodici, in “Ferrania”, n. 7 (luglio) 1947, pp. 3-4.
14 Ibidem.15 Turroni G., Giuseppe Cavalli: La pallina, 1949, nel suo Guida alla critica fotografca, cit., p. 52.16 Abruzzese A., Fotoromanzo, in Asor Rosa A. (a c. di), Letteratura italiana, Storia e geografa,
vol. III: L’età contemporanea. Letteratura di massa, Einaudi, Torino, 1989, in part. p. 416; Bravo A., Il fotoromanzo, Il Mulino, Bologna, 2003.
17 Sulla periodizzazione della fotografa neorealista, in linea con le osservazioni di Asor Rosa (La democrazia, in Storia d’Italia. Dall’Unità ad oggi, Vol. IV, T. II, Einaudi, Torino, 1975) e quelle di Ajello relativamente all’industrializzazione del rotocalco, cfr. la rifessione proposta da Russo A., Storia culturale della fotografa in Italia, cit., in part. pp. 3-10.
18 Sui rapporti fra fotografa e cinema, soprattutto in relazione ai piani narrativi, cfr. Taramelli E., Viaggio nell’Italia del neorealismo. La fotografa fra letteratura e cinema, SEI, Torino, 1995.
19 Milani M., Immagini del neorealismo cinematografco, in Croci E. (a. c. di), Foto annuario italiano 1955-56 (1955), pp. 211-13.
20 Questo è il tema centrale del catalogo di Lucas U., Bizzicari M. (a c. di), L’informazione negata, il fotogiornalismo in Italia 1945-1980, cit.
21 De Berti R., Il nuovo periodico. Rotocalchi fra fotogiornalismo, cronaca e costume, in De Berti R., Piazzoni I. (a c. di), Forme e modelli del rotocalco italiano tra fascismo e guerra, Cisalpino, Milano 2009 [Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofa, Quaderni di Acme, 115], p. 13.
22 Mondadori A., Editoriale, in “Epoca”, a. I, n. 1, 14 ottobre 1950, p. 11.23 Cit. in Fiorentino G. Il mosaico delle immagini. Gli anni cinquanta ai bordi del consumo,
cit., p. 24.24 Granata I., Tra politica e attualità. L’“Omnibus” di Leo Longanesi (aprile 1937-gennaio
1939), in De Berti R., Piazzoni I. (a c. di), Forme e modelli del rotocalco italiano tra fascismo e guerra, cit., pp. 123-211.
Il tesoro dei pirati
139
25 Proti D., Testimoni della nostra storia, in “L’Europeo”, n. speciale Testimoni del nostro tempo. I fotograf premiati dal World Press Photo, 3 (2010), p. 5.
26 Cfr. Gelsomini E., L’Italia allo specchio. L’Europeo di Arrigo Benedetti, Franco Angeli, Milano, 2011.
27 Turroni G., Prefazione (1962), p. 5.28 Il dato proviene dal censimento del 4 novembre 1951 che registra 47.515.537 persone: il
47,7% di questa popolazione può essere defnita attiva (fra i 14 e i 65 anni), ma complessivamente il tasso di analfabetismo è del 12,9%. Se applichiamo questo dato alla popolazione attiva, generalizzando quindi e senza tenere conto dei dati economici e di quelli relativi alle popolazioni urbane, otteniamo una cifra sovrastimata di circa 20.000.000 di persone capaci di leggere e consumare immagini.
29 Sulla scorta dei dati forniti da Ajello, Il settimanale d’attualità, cit., ripresentati da Fiorentino G., Il mosaico delle immagini, cit.
30 Questo testo coglie i frutti di un’intersezione fra ricerca e didattica della Storia della fotografa all’ateneo forentino, in parallelo al PRIN, fra l’AA.AA. 2010/11-2011/2012, nel corso di due seminari di analisi delle fotografe a inchiostro nelle riviste specializzate, pubblicate fra il 1947 e il 1959, con alcuni approfondimenti sui rotocalchi, che hanno portato alla schedatura di circa 6.000 immagini fotomeccaniche (IFM), e alla mappatura di oltre 1.500 nomi di fotograf, nonché degli eventi espositivi nazionali e internazionali citati nelle riviste fotografche. Il lavoro è in corso di completamento ed è previsto di darne conto in un bilancio fnale di prossima pubblicazione.
31 [Donzelli P., Redazionale], in “Fotografa”, a. III, n. 6, 1950, p. 5 in cui si spiegano le ragioni della separazione da CFM per organizzare iniziative espositive e di scambio con la fotografa straniera.
32 Marrucco A., La presenza di immagini straniere nella rivista “Fotografa” [1953-1956], relazione dattiloscritta al Seminario di Storia della fotografa, docente T. Serena, Università degli Studi di Firenze, A.A. 2010-11.
33 Ad esempio: Bolognini G., La prima mostra scambio di fotografa a Venezia: Club Photographique de Paris e Circolo Fotografco la Gondola, in “Fotografa”, a. VIII, n. 1 gennaio-febbraio 1955, pp. 34-36; D. Masclet, Les grands clubs etrangers: la Gondola de Venice, in “Photo-Cinéma”, a. XXXV, n. 646, agosto 1955, pp. 162-164. Cr. anche Manfroi M., Circolo “La Gondola”: una microstoria, cit., p. 21; Bertolini F. (a c. di), Paolo Monti. Scritti scelti 1953-1983, ISSF, Palermo, 2004, pp. 43-45.
34 Cavalli G., Incontro fra amici, in “Il Progresso Fotografco”, n. 1, gennaio 1953, p. 11; Monti P., La mostra della fotografa italiana 1953 a Firenze, in “Ferrania”, 1953, a. VII, n. 8, ora in Valtorta R. (a c. di), Paolo Monti scritti e appunti sulla fotografa, Lupetti, Milano, 2008, pp. 48-52.
35 Fioravanti R., Cenni storici, in Croci E. (a. c. di), Foto annuario italiano 1955-56, cit., pp. 000.
36 Abbiamo preso come campione un prelievo cronologico importante ai fni della periodizzazione, 1953-55, schedando sistematicamente le IFM nelle sette principali riviste: “Diorama: bimensile d’arte foto cinematografca e fgurativa”; “Ferrania. Rivista mensile di fotografa, cinematografa e arti fgurative”; “Fotografa: periodico del circolo fotografco milanese”;; “Fotorivista: foto e cinema nella tecnica, nell’arte, nell’industria”; “Il Corriere Fotografco”; “Il Progresso Fotografco”; “Rivista Fotografca Italiana: periodico mensile illustrato”. Ne fornisce un resoconto Brandani C., Aggiornatissimi sempre… Modelli e circolazione nelle riviste fotografche italiane: 1953-1955, Tesi di Laurea, rel. T. Serena, Università degli Studi di Firenze, A.A. 2010-11.
37 Cfr. l’analisi approfondita della Brandani presentata in questo stesso volume.38 Bezzola G., Mario De Biasi, in “Ferrania”, 1953, a. VII, n. 12, pp. 2-9.39 Circolo Fotografco Milanese (a c. di), Foto annuario italiano 1953-54, cit., p. 261 alla
categoria Dilettanti.40 Turroni G., Nuova fotografa italiana, cit., p. 12.
Arte moltiplicata
140
41 Pellegrini era un fotografo, fra i fondatori del CFM nel 1930, si dedicava anche alla critica con una rubrica su “Ferrania” dagli inizi, e altri interventi in varie riviste, fra questi si segnalano quelli pubblicati nella “Rivista Fotografca Italiana”.
42 Informazioni ricavate da una serie di articoli senza autore comparsi nel “Notiziario Culturale. Comitato per la divulgazione del piano Marshall, Uffcio tecnico”: Macchine per 316 milioni di Lire all’editore Mondadori, 1949, a. I, n. 2, 1 marzo, p. 2; Per l’editoria e la carta, 1950, a. II, n. 1, 1 gennaio, p. 3; Per l’editoria, 1950, a. II n. 10, 16 maggio, p. 2; cit. in Giacomini C., “Epoca”: prospettive, illusioni, condizionamenti agli esordi di un rotocalco fotografco, Tesi di laurea, rel. T. Serena, Università degli studi di Firenze, A.A. 2010-11, p. 24, n. 22.
43 Epoca presenta Henri Cartier-Bresson, in “Epoca”, a. I, n. 1, 1950, pp. 32-37.44 Kirstein L., Henri Cartier-Bresson: Documentary Humanist, in The Photographs of Henry
Cartier-Bresson, Museum of Modern Art, New York, 1947, pp. 7-11. Oltre a Kirstein per il catalogo aveva scritto un testo anche Beaumont Newhall.
45 Magnanini C., “Chi ha “Tempo” non aspetti “Life”. Un fotogiornale negli anni della guerra (1939-1943), in De Berti R., Piazzoni I. (a c. di), Forme e modelli del rotocalco italiano tra fascismo e guerra, cit., pp. 305-341; l’intervento riprende il titolo dell’articolo di Bruno Munari (Chi ha tempo non aspetti Life, in Patellani F., Documenti e notizie raccolti in trent’anni di viaggi nel Sud, Milano, Editphoto, 1977).
46 Zannier I., Il dopoguerra dei fotograf, cit., p. 000.47 Sono anni determinanti per la cultura fotografca con la pubblicazione del famoso
Annuario Domus, Prima rassegna dell’attività fotografca italiana, per cura di Ermanno Scopinich (cfr. Paoli S., L’annuario di Domus del 1943, in T. Serena (a. c. di), Per Paolo Costantini. Indagine sulle raccolte fotografche, Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa, 1999, pp. 99-128; ma anche per i numerosi punti di contatto fra i quali ricordiamo il passaggio di W. Klein.
48 “anche le fotografe sono da leggere, proprio a volte da legger e rileggere nei loro piccoli misteri: e il libro serve anche a questo, che insegna proprio, facendo così entrare nei segreti del mestiere, a leggere anche le immagini, non davvero immagini mute”, in R.G., Munari con la macchina fotografca, in “Domus”, n. 201, 1944, settembre (ora in <http://www.munart.org/doc/bruno-munari-domus-n-201-1944.pdf>).
49 Munari B., Racconto dadà. Lungo nella notte il fschio del treno, in “Oggi”, 1946, n. 47, pp. 8-9.50 Mi permetto di rimandare a due miei studi su queste tematiche d’ambito teorico: Le
parole dell’archivio fotografco, in “Rivista di Estetica”, 2 (2012) vol. 50 (num. mon. A partire da Documentalità, a c. di Casetta E. Kobai P, Mosca I.,) pp. 163-178; La profondità della superfcie. Una prospettiva epistemologica per ‘cose’ come fotografe e archivi fotografci, in “Ricerche di Storia dell’Arte”, 2012, vol. 106 (num. mon. Archivi fotografci. Spazi del sapere, luoghi della ricerca, a cura di Caraffa C., Serena T.), pp. 53-69.
51 Branzi P., Il ragazzo di Sicilia, in “Diorama”, a. V, n. 3, 1955, p. 9.52 Binazzi M., Il lavoro di Franco Pinna in Lucania (1952 e 1956). Biografa sociale degli
oggetti fotografci, Tesi di Laurea, rel. T. Serena, Università degli Studi di Firenze, A.A. 2011/12, scheda n. 3.
53 Dragara E., Ennio Flaiano e gli esordi, in De Berti R., Piazzoni I. (a c. di), Forme e modelli del rotocalco italiano tra fascismo e guerra, cit., pp. 499-523; Quaglieni P.F., Mario Pannunzio da Longanesi al “Mondo”, Rubettino, Roma, 2010. Sulla rivista e la sua collezione di fotografe: Il Mondo dei fotograf 1951-1966, cit.; Cutrupi M., Il Mondo e la fotografa. Il fondo Pannunzio, Nuova Arnica, Roma, 2005.
54 Pernici P., Il fotografo, in “Il Mondo”, 1953, a. V, n. 20, p. 11.55 Ricciardi A., Fotografo latente e meta-fotografa ne “Il Mondo” del 1953, relazione
dattiloscritta al Seminario di Storia della fotografa, docente T. Serena, Università degli Studi di Firenze, A.A. 2010-11.
56 Cit. in Bassi B., “Il Mondo” di Pannunzio visto dalla fnestra dell’archivio fotografco. Usi e trasformazioni degli oggetti fotografci, 1951-1952, Tesi di laurea, rel. T. Serena, Università degli Studi di Firenze, A.A. 2010-11, p. 98.
Il tesoro dei pirati
141
57 Carrieri M., Milano, Italia, Lerici, Milano, 1959. Il testo recepisce la lezione americana di William Klein, epigono della nuova fotografa americana di metà anni cinquanta, che con le sue fotografe sgranate e sgrammaticate e il rinnovato modello narrativo del fotolibro con tema una città. Klein aveva collaborato a Milano, fra 1952-3, con “Domus” (cit. in Russo A., Storia culturale della fotografa italiana, cit., p. 78).
58 Baldi G., La Madonna del Carmelo gli annunciò la liberazione, in “Epoca”, 1953, a. IV, n. 152, pp. 70-72 con 6 fotografe di De Biasi, che raggiungono al massimo ¼ di pagina; come “inviato speciale” compare presto nel tamburo di copertina di “Epoca”, 1953, a. IV, n. 154, pp. 15-18 con un fotoservizio di 6 fotografe molte delle quali stampate a ½ pagina (per l’articolo di De Monticelli R., Tito si è fermato a Okzogliza).
59 In “Fotografa”, 1956, n. 12, dicembre, pp. 18-19 (7 fotografe) e in “Foto illustrazione”, 1959, n. 12, dicembre, pp. 87-88 (4 fotografe). Su questo mitico reportage che conquistò le vette dei rotocalchi stranieri, cfr. Morello P. (a c. di), Mario de Biasi: Budapest 1956, ISSF, Palermo, 2006.
60 Oliva G., Gerosa G., Zannier I. (a c. di), Epoca: sette fotograf di Epoca, catalogo della mostra (Castelfranco Veneto 1989), Comune di Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto, 1989.
61 Attraverso uno spoglio dei rotocalchi l’attività di Meldolesi è stata parzialmente ricostruita e sono state rintracciate circa 1500 immagini fotomeccaniche: cfr. Camilli M., Ivo Meldolesi. Produzione e circolazione della fotografa nelle riviste illustrate, 1947-1958, Tesi di laurea, rel. T. Serena, Università degli Studi di Firenze, A.A. 2011/12).
62 Eco U., Il mito americano di tre generazioni antiamericane, in Chiarenza C., Vance W.L., Immaginari a confronto. I rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti: la percezione della realtà tra stereotipo e mito, Marsilio, Venezia, 1993, pp. 15-28.
63 Giulia Veronesi, Recensioni. Walker Evans, American Photographs, in “Corrente di vita giovanile”, II (19), 31 ottobre 1939, cit. in Paoli S. (a. c. di), Elio Ciol e gli anni del neorealismo, Allemandi, Torino, 2009, ora in <www.eliociol.it/wp-content/…/Gli-anni-del-neorealismo_Silvia-Paoli.pdf>.
64 Piovene G., De America, Garzanti, Milano, 1953, cit. da Valente L., Il mito americano in Epoca: luci e ombre di un nazionalismo inverso, relazione dattiloscritta al Seminario di Storia della fotografa, docente T. Serena, Università degli Studi di Firenze, A.A. 2010-11.
65 “I giochi dei bambini negri ad Harlem hanno quel “tono” che altre foto non posseggono, possono stare accanto a quelle di De Biasi e scoprono l’inutilità di tante altre immagini scattate dagli intellettuali (si vedano le foto del recente libro di Giorgio Soavi pubblicato da Mondadori, America tutta d’un fato)”, in Turroni G., Nuova fotografa italiana, cit., in cui pubblicava 3 sue fotografe. Le didascalie in questo volume sono accompagnate dalle solite note tecniche relative a macchine, obiettivi, pellicole e manipolazioni.
66 Luce H.R., Il mondo nuovo degli affari, in “Epoca”, 1954, a. V, n. 178, pp. 15-16 con due fotografe una delle quali realizzata da De Biasi probabilmente durante un’intervista.
67 Probabilmente nel mese di giugno stesso in corrispondenza forse delle morti di Capa e Bishof; cfr. s.a. [Gatto A.?], Qualche cosa della nostra vita, in “Epoca”, 1954, a. V, n. 193, 13 giugno, pp. 20-26.
68 Camisa A., Su alcune tendenze della fotografa italiana d’oggi, in Foto Annuario 1958, cit., pp. 105-108, ora in Colombo C., Lo sguardo critico, cit. a p. 108.
69 “Life”, vol. 36, n. 23, 7 giugno 1954, dedica a Capa un primo articolo sopra il sommario, So That a Brave Man Story Can Be Told, p. 25; seguito da un articolo illustrato A Great War Reporter and his Last Battle, pp. 27-30 e dalla testimonianza del corrispondente che era con lui Mecklin J., He Said: This is Going to Be a Beautiful Story, pp. 31-36; Gatto A., Italia domanda. Ricordo di Bischoff [sic], in “Epoca”, 1954, a. V, n. 193, 13 giugno, p. 5, seguito da Disse: sarà un servizio magnifco, in “Epoca”, 1954, a. V, n. 196, 4 luglio, pp. 29-34.
70 Fotograf d’oggi. Robert Capa, in “Il corriere fotografco”, 1954, a LI, n. 21. pp. 22-26.71 Cartier-Bresson H., Immagini di “straforo”, in “Il corriere fotografco”, 1953, a. L, n. 9, pp.
12-10 (con 5 fotografe). Il testo presenta una sintesi del volume del fotografo.
Arte moltiplicata
142
72 Fallaci O., Il re dei fotograf, in “Epoca”, a. III, n. 95, 2 agosto 1952, p. 39. È doveroso ricordare che le prime fotografe di Cartier-Bresson furono pubblicate con quelle di Leo Longanesi ne “L’Italiano” nel 1932 (cit. in Russo A., Storia culturale della fotografa italiana, cit., pp. 11-12), poi le sue fotografe cominciano a circolare in Italia dalla fne degli anni quaranta sporadicamente in varie riviste. Un’analisi degli archivi dei giornali potrebbe portare a nuove considerazioni (cfr. su anche altri possibili sviluppi la serie di tre conferenze promosse dalla Società Italiana per lo Studio della fotografa a Milano e Roma sugli archivi dei giornali, fra il 2011 e il 2013).
73 Zannier I., Due generazioni, in “Camera”, aprile 1956 ora in Colombo C., Lo sguardo critico, cit., pp, 97-98, cit. a p. 98.
74 La mostra di Venezia è allineata ad altre iniziative fotografche tutte sotto l’egida dell’etichetta internazionale proprio negli stessi anni, come la: II Mostra Internazionale della Fotografa di Montagna (Trento, 1957); I mostra internazionale biennale di Genova (1958); Mostra internazionale di fotografa ispirata alla vita agricola (Torino, 1958).
75 G.T., Mostra di Werner Bischof, in “Fotografa”, 1958, nn. 6-7, pp. 21-25. La mostra era stata curata da Remo Taccani e Lamberto Vitali.
76 La differenza fra una fotografa e un quadro, in “L’Europeo”, 1957, n. 601, 21 aprile, pp. 16-19, in cui il dilemma del bello fotografco è risolto chiedendo a Patellani di ricomporre le scene, creando dei tableaux vivants, di dipinti famosi di Toulouse Lautrec, Manet, Picasso, per metterli a confronto.
77 Annunciato sul n. 396, 11 maggio, con il n. 401, 8 giugno, inizia la serie dei fotograf: Otto consigli di H. Cartier-Bresson, pp. 80-82; n. 402, 15 giugno Sette Consigli di Cornel Lucas, pp. 64-66; n. 403, 22 giugno Dieci Consigli di Federico Patellani, pp. 72-73, 74; n. 404, 29 giugno Dieci Consigli di Mario De Biasi, pp. 70-71. Termina con il n. 409 con i 100 vincitori del chi l’ha visto fotografco. Devo la segnalazione a Desdemona Ventroni, che ringrazio.
![Page 1: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Il tesoro dei pirati. La fotografia a inchiostro fra rotocalchi e riviste fotografiche, 1947-1959 [2013]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042518/6334f93ea1ced1126c0a92f1/html5/thumbnails/26.jpg)