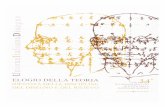Il sistema vivente: unità e modularità organica, "Complessità", anno VIII, n. 1-2,...
-
Upload
magaraibleo -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Il sistema vivente: unità e modularità organica, "Complessità", anno VIII, n. 1-2,...
Rivista semestraleanno VIII, n. 1-2, gennaio-dicembre 2013
complessità 1-22013Rivista del Centro Studi di Filosofia della Complessità «Edgar Morin»Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli Studi di Messinain collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napolie con la Fondazione “Bonino-Pulejo” di Messina
Direttore scientificoGiuseppe Gembillo
Comitato editorialeGiuseppe Giordano (coordinatore)Annamaria Anselmo (segretario)Maria Rita AbramoCostanza AltavillaMaria ArcidiaconoCaterina BasileAntonella ChiofaloFrancesco CrapanzanoDeborah DonatoAdele FotiEdvige GalboFabio GembilloMaria Laura GiacobelloGiuliana GregorioFederica MazzùCesare NatoliGiuseppina NotoLetizia NucaraFabiana RussoFlavia StramandinoAngela Verso
RefereesEdgar Morin (Parigi)Mauro Ceruti (Bergamo)Emilio Roger Ciurana (Valladolid)Girolamo Cotroneo (Messina)János Kelemen (Budapest)Mauro Maldonato (Napoli)Alfonso Montuori (San Francisco)David D. Roberts (Athens, Georgia)Massimo Verdicchio (Edmonton, Alberta)Gereon Wolters (Costanza)
Servizi editorialiSicania by Gem s.r.l.Messina
StampaEffegieffe Arti Grafiche s.r.l.Messina
Le immagini proposte in copertina sono opere diFabio Gembillo
© 2014 – SICANIA by GEM s.r.l.Via Catania, 62 – 98124 [email protected]
ISBN 978-88-7268-148-0
N. 15 in attesa di registrazioneFinito di stampare nel dicembre 2014
Sommario
4 Una lettera di Hegel a Creuzer traduzione di Deborah Donato
Saggi Gereon Wolters 8 Hans Jonas e il razzismo
Annamaria Anselmo 18 Werner Heisenberg e la filosofia kantiana
Nunzio Bombaci 31 La complessità dell’uomo. La urdimbre nel pensiero di Juan Rof Carballo
Franco Bosio 54 Destino della scienza e signoria della tecnica nell’epoca della complessità
Giuseppe Gembillo 72 Giambattista Vico e la matematica. Originalità e attualità di un’interpretazione
Giuseppe Giordano 86 Semplicità della complessità
Giovanni Giuffrè 111 L’armonia della Natura nella relazione tra il Rapporto Aureo e gli anelli di retroazione dell’analisi sistemica
Gaspare Polizzi 133 Imre Toth e Michel Serres. Sulla ricorrente epifania del sapere geometrico
Ivan Pozzoni 151 Il concetto di volontà in Benedetto Croce. Etica e politica
Emidio Spinelli 170 Hans Jonas e gli stoici. Per una neutralizzazione epistemologica della “sorte”
Maria Laura Giacobello 183 Edgar Morin. La riforma del pensiero per una conoscenza pertinente: insegnare la condizione umana
Discussioni Marco Centorrino 198 Dal collettivismo comunitario all’individualismo in rete delle community
Angela Cimato 212 Negare la negazione. Ermeneutica critica del negazionismo
Francesco Crapanzano Iterazioni e co-operazioni nella costruzione delle leggi scientifiche. 223
Edvige Galbo La verità plurale delle Impressioni. 233 Considerazioni intorno alla produzione di Claude Monet
Maria Laura Giacobello L’educazione come autoformazione permanente: 241 Emilio Roger Ciurana e la riforma delle scienze umane
Gaetano Giandoriggio A proposito di una nuova biografia di Benedetto Croce 254
Valeria Maggiore Il sistema vivente: unità e modularità organica 267
Giacomo Tripodi Some archaic toponyms of Middle Eastern origin in Western Europe 280
Recensioni Annamaria Anselmo Eugénie Vegleris, La consultation philosophique 290
Grazia D’Arrigo Bart Kosko, Fuzzy future. From society and science to heaven in a chip 293
Deborah Donato John Gribbin, Erwin Schrödinger. La vita, gli amori e la rivoluzione quantistica 296
Adele Foti Cesare Natoli, Il suono dell’anima 302 Musica e metafisica nella riflessione filosofica e teologica
Fabio Gembillo Edgar Morin, Il mio pensiero 309
Federica Mazzù F. Bonicalzi, P. Mottana, C. Vinti, J. Wunenburger (a cura di) 311 Bachelard e le “provocazioni della materia”
Fabiana Russo Edgar Morin, La mia Parigi, i miei ricordi 316
267
Valeria Maggiore1
Il sistema vivente: unità e modularità organica
Negli ultimi decenni del ventesimo secolo, l’affermarsi delle tematiche ecologiche ha favorito la scoperta di nuovi legami con-cettuali fra biologia e filosofia, in una contaminazione di saperi che ha aperto nuove prospettive d’indagine, solo in parte ancora analizzate. Il maggior peso esercitato dalle questioni biologiche su tutti i domini d’indagine della filosofia in generale e sull’estetica in particolare, ha promosso il rilancio delle tematiche morfologiche nel dibattito scientifico contemporaneo: si tenta, in tal modo, di recuperare una «dimensione qualitativa» della natura, favorendo il sorgere di un nuovo modello di scientificità in grado di offrire un’alternativa esplicativa all’impostazione gene-centrica avanzata dalla Sintesi Moderna e, allo stesso tempo, di gettare un ponte verso l’Estetica, con cui la scienza delle forme condivide tematiche e problemi.
I promotori della Sintesi Moderna focalizzarono, infatti, la loro attenzione sull’interiorità del vivente, ricercando le risposte ai loro quesiti nell’interpretazione di un codice chimico nascosto nel cuore della più piccola particella di vita, il codice genetico. Il «codice» è la chiave per svelare il segreto dei viventi; le loro forme, invece, sono un semplice epifenomeno che può facilmente esser compreso proprio effettuando una buona traduzione di quello che per i neodarwinisti è «il linguaggio cifrato» della vita.
Al giorno d’oggi la messa in questione del paradigma gene-centrico proposto dalla Sintesi Moderna orienta le ricerche verso una comprensione globale del vivente, spostando l’attenzione sempre di più sulle caratteristiche sistemiche della vita.2
1. PhD Student, University of Messina, Department of Human and Social Sciences.
2. Cfr. P. Huneman-C.T. Wolfe, The concept of organism: historical philosophi-cal, scientific perspectives, «History nd Philosophy of the Life Sciences», 32, 2010,
valeria maggiore 268
Il pensiero sistemico introduce in ambito scientifico un nuovo modo di rapportarsi all’analisi del mondo che ci circonda e di noi stessi: solo la presa di coscienza che l’individuo è una totalità caratterizzata da un funzionamento globale ci consente di com-prendere i processi che conducono all’organizzazione del vivente, o meglio alla sua auto-organizzazione, senza cadere in uno sterile riduzionismo. Ne consegue che gli stessi metodi della biologia, nel dibattito scientifico contemporaneo, necessitano di un’adeguata ridefinizione: la scienza del vivente non può più qualificare se stessa come una mera disciplina tassonomica, non può più limitar-si ad essere un semplice «specchio della realtà» e a fornire solo una «rappresentazione» del reale, ma deve esplicitare le «regole di costruzione» di quest’ultimo. Lo studio dell’organismo impone, pertanto, il passaggio da un paradigma meramente visivo a un paradigma costruttivo del vivente. Il sistema viene, infatti, inteso in termini dinamici: esso «si edifica» e le sue «matrici costruttive» possono essere comprese solo abbattendo i confini fra il sistema, le sue componenti (i singoli sottosistemi) e i domini in cui esso agisce (i sovrasistemi in cui è inserito).3 È per tale motivo che Edgar Morin ne La méthode. Tome I – La nature de la nature (1977) definisce la natura come un «tutto polisistemico»4 in cui la separazione è un’illusione perché il singolo sistema è costituito da una pluralità di strutture gerarchiche che interagiscono e coopera-no al suo stesso mantenimento.
Nel quadro di quella che Morin indica come «la stupefacente architettura di sistemi che si edificano gli uni sugli altri, gli uni fra gli altri, gli uni contro gli altri»,5 occorre capire in che senso l’or-ganismo possa essere definito una totalità di relazioni intra-siste-miche, spostando la nostra attenzione dall’analisi dei rapporti ecologici alla complessità strutturale dell’organico. La risposta a
p. 148. Cfr. anche E. Morin, La méthode. Tome I – La nature de la nature, Paris, Éditions du Seuil, 1977, trad. a cura di G. Bocchi (Parte prima) e Alessandro Serra (Parte seconda e terza) con il titolo Il metodo. 1. La natura della natura, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001, p. 111 i cui l’autore sostiene che «il nostro mondo organizzato è un arcipelago di sistemi nell’oceano del disordine».
3. Cfr. E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, cit., p. 112 in cui l’autore afferma che nell’universo non esistono entità completamente isolate le une dalle altre: la vita è «un sistema di sistemi di sistemi, non soltanto perché l’organismo è un sistema di organi che sono sistemi di molecole che sono sistemi di atomi, ma anche perché l’essere vivente è un sistema individuale che prende parte a un sistema di riproduzione, perché l’uno e l’altro prendono parte a un ecosistema, il quale prende parte alla biosfera…». Cfr. anche M. Ceruti, La hybris dell’onniscienza e la sfida della complessità. In: G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), La sfida della com-plessità, Feltrinelli, Milano 1985, pp. 25-48.
4. Ibid.
5. Ivi, p. 111.
il sistema vivente: unità e modularità organica 269
tale quesito è fornita da Hans Jonas nell’opera Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie (1994): «Il senso di “sistema” è determinato dal concetto dell’insieme, che presuppo-ne una molteplicità che si è trovata appunto ad essere nella rela-zione dell’insieme o che non può fare a meno di starvi. Il sistema è quindi necessariamente un che di molteplice, ma al di là di ciò il senso dell’insieme qui è che il molteplice ha un principio efficace nella sua unità».6 Il lessico dell’armonia, tradizionalmente asso-ciato alla prospettiva organicista e che trova la sua massima espressione nel pensiero leibniziano,7 rimanda a un equilibrio tra ordine e varietà, ma non fornisce la chiave di lettura per realizzare la conciliazione fra «l’uno e i molti»8 o fra «l’identico e il diverso»,9 dimensioni che concorrono congiuntamente alla costru-zione del vivente. «L’idea di unità complessa», sottolinea Morin, «prende densità se si intuisce che non si può ridurre il tutto alle parti né le parti al tutto, né l’uno al molteplice né il molteplice all’uno, ma che bisogna invece cercare di concepire insieme, in maniera contemporaneamente complementare e antagonistica, le nozioni di tutto e di parti, di uno e di diverso».10 Un aggregato di organi, infatti, diventa organismo solo quando l’armonia fra le sue componenti, quantitativamente e qualitativamente differenti, si coniuga con la dimensione dell’unità.11 «Il modello aristotelico
6. H. Jonas, Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie, Insel Varlag, Frankfurt am Main - Leipzig 1994; trad. a cura di P. Becchi con il titolo Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, Giulio Einaudi Editore, Torino 1999, p. 83.
7. Per un’analisi più approfondita cfr. G.W. Leibniz, Animadversiones in G.E. Stahlii teoria medicam, trad. a cura di A.M. Nunziante con il titolo Obiezioni contro la teoria medica di Georg Ernst Sthal. Sui concetti di anima, vita e organi-smo, Quodlibet, Macerata 2011, p. 179.
8. J.W. Goethe, Die Absicht eingeleitet, in Id., Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie, Stuttgart, bd. I, Heft I, 1817-1822, trad. a cura di S. Zecchi con il titolo Introduzione all’oggetto, in J.W. Goethe, La metamorfosi delle piante e altri scritti sulla scienza della natura, Ugo Guanda Editore, Parma 2008, p. 43 in cui il pensatore tedesco afferma che «ogni vivente non è un singolo, ma una pluralità; anche presentandosi come individuo, rimane tuttavia un insieme di esseri viventi e autonomi, che, eguali secondo l’idea e per natura, appaiono empi-ricamente identici o simili, diversi o dissimili».
9. Ibid. Goethe, infatti, afferma: «quanto più la creatura è imperfetta, tanto più queste parti sono uguali o simili tra loro, tanto più assomigliano al tutto; quanto più la creatura è perfetta, tanto più queste parti sono reciprocamente dissimili. Nel primo caso, il tutto è più o meno eguale alle parti; nel secondo, il tutto è dissimile dalle parti. Quanto più le parti sono simili, tanto meno sono subordinate le une alle altre: la subordinazione delle parti è indizio di una creatura più perfetta».
10. E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, cit., p. 119.
11. A.M. Nunziante, Vita e organismo tra filosofia e medicina: le ragioni di una polemica, in G.W. Leibniz, Obiezioni contro la teoria medica di Georg Ernst Sthal. Sui concetti di anima, vita e organismo, cit., p. 179.
valeria maggiore 270
(forma/sostanza) e il modello cartesiano (oggetti semplificabili e decomponibili), entrambi sottostanti alla nostra concezione degli oggetti, non costituiscono dunque un principio di intelligibilità del sistema. Questo non può essere compreso né quale unità pura o identità assoluta, né quale composto componibile. Ci occorre un concetto sistemico che esprima a un tempo unità, molteplicità, totalità, diversità, organizzazione e complessità».12
Confrontandosi con le teorie avanzate recentemente dal mondo accademico per quanto concerne il tema della sistematicità del vivente, il filosofo non può non scorgere numerose connessioni teoretiche fra il dibattito corrente e le discussioni sull’organismo che animarono l’Europa illuminista. Negli anni a cavallo fra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento la sinergia che si creò tra gli esiti della critica kantiana, in particolar modo tra la costituzione di una teoria filosofica dell’organismo inteso come «scopo della natura»13 e la nascita, proprio in quegli anni, della biologia in quanto scienza autonoma, condussero alla creazione di un legame sempre più solido fra estetica, scienze storiche e filosofia della natura, un connubio che ancora oggi continua ad avere forti riper-cussioni sulla storia delle idee.14 È per tale ragione che occorre sottoporre ad analisi la ripresa di tali tematiche nel dibattito scien-tifico contemporaneo in combinazione con una considerazione storica: biologia e storia della filosofia devono procedere di pari passo per giungere alla chiarificazione di un concetto che si rivela fondamentale per entrambi gli ambiti di ricerca. In questo dialogo il ruolo principale è affidato proprio alla Kritik der Urteilskraft (1790) di Immanuel Kant, strumento-guida nell’analisi filosofica del vivente: l’approccio kantiano all’essere organico (Organisierte Wesen) può, infatti, essere considerato la base teorica per la nascita della moderna nozione di organismo, completandone il processo di costruzione concettuale iniziato da Leibniz e influenzando ancor oggi le tematizzazione della biologia teorica.
In un passaggio divenuto celebre, Kant dà già in quest’opera una definizione del concetto di «sistema organico», affermando che «per un corpo che deve essere giudicato in sé come scopo naturale, è richiesto che le sue parti si producano vicendevolmente l’un l’altra, nel loro insieme, sia secondo la loro forma, sia secon-
12. E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, cit., p. 140.
13. Cfr. I. Kant, Kritik der Urteilskraft, Lagarde und Friedrich, Berlin und Libau 1790, pp. 289-295, trad. a cura di E. Garroni-H. Hohenegger con il titolo Critica della facoltà di giudizio, Giulio Einaudi Editore, Torino 20112, § 65, pp. 206-209.
14. S. Tedesco, Morfologia estetica. Alcune relazioni fra estetica e scienza natura-le, Palermo, Aesthetica Preprint, n. 90, dicembre 2010, p. 13.
il sistema vivente: unità e modularità organica 271
do il loro legame, producendo così per propria casualità un tutto».15 In altri termini, asserire che un determinato ente è un fine naturale significa che le parti di cui quest’ultimo si compone sono determinate dal tutto sia per quanto riguarda la loro esistenza sia per quanto concerne la loro forma.16 La materia vivente plasma, infatti, se stessa sulla base di quattro livelli di organizzazione mor-fologica: la proporzione, l’orientamento, la connessione e l’artico-lazione delle parti. Questi quattro livelli, nota Diego Rasskin-Gutman nell’articolo Modularity: Jumping Forms within Morphospace (2005), costituiscono non solo una strada privile-giata per la creazione di una cornice descrittiva del vivente, ma anche un modo per comprendere la logica della forma organica stessa,17 dal momento che ogni livello di organizzazione morfolo-gica è manifestazione dell’unità funzionale fra le singole parti e il tutto «lavora» per mantenere l’integrità dell’essere vivente.18
15. I. Kant, Kritik der Urtheilskraft, cit., p. 291, trad. cit., § 65, p. 207. Aggiunge, inoltre, che «in un tale prodotto della natura ogni parte, così come c’è solo median-te tutte le altre, è anche pensata come esistente in vista delle altre e del tutto, vale a dire come strumento (organo)». Cfr. anche P. Huneman, Métaphysique et biolo-gie. Kant et la constitution du concept d’organisme, Éditions Kimé, Paris 2008, p. 9 in cui l’autore afferma che «in poco meno di un secolo, sembra che siamo passati da un approccio allo studio dell’essere vivente in termini di anima e corpo, in cui il termine organismo significa, in un senso lontanamente galenico, un insieme di parti aventi ciascuna una propria utilità e dirette da un’anima, all’idea di un orga-nismo inteso come totalità di parti circolarmente legate da una causalità reciproca e la cui intellegibilità risiede precisamente in questa relazione specifica tra le parti stesse e le parti e il tutto». Cfr. infine W. Callebaut, The Ubiquity of Modularity, in W. Callebaut-D. Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity: Understanding the Development and Evolution of Natural Complex Systems, The MIT Press, Cam-bridge-Massachusetts 2005, p. 4. Il concetto di sistema, ammettendo un numero elevato d’interazioni fra le parti, va contro il principio di semplicità che costituiva uno dei punti fermi nella costruzione della scienza classica. Immaginiamo un siste-ma, afferma Callebaut, che si sviluppi moltiplicando le proprie componenti: il numero delle interazioni potenziali fra le parti aumenta esponenzialmente in rela-zione all’aumento cardinale delle componenti in gioco.
16. P. Huneman, Métaphysique et biologie. Kant et la constitution du concept d’organisme, cit., p. 288.
17. D. Rasskin-Gutman, Modularity: Jumping Forms within Morphospace, in W. Callebaut e D. Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity: Understanding the Devel-opment and Evolution of Natural Complex Systems, cit., p. 209, trad. a cura di A. Pinotti-S. Tedesco con il titolo Modularità. Forme che saltano all’interno del mor-fospazio, in A. Pinotti-S. Tedesco (a cura di), Estetica e scienze della vita. Morfolo-gia, biologia teoretica, evo-devo, Raffaello Cortina Editore, Milano 2013, p. 329.
18. Ivi, pp. 329-330. In tale passaggio l’autore afferma che «in questo senso, la funzione del cuore non e di pompare sangue, ma di interagire con le altre parti, come il sangue, le arterie, le vene, i muscoli e i nervi. La funzione viene compresa come interazione senza elementi finalistici. Perché ogni parte organica abbia un ruolo efficace nella vita dell’organismo e necessario che l’integrità funzionale si manifesti ai quattro livelli dell’organizzazione morfologica. Le sue proporzioni, il suo orientamento, le connessioni tra i suoi elementi e con gli altri elementi dell’or-ganismo e l’articolazione – ossia la capacità di cambiare l’orientamento – devono
valeria maggiore 272
La distanza che sussiste fra la prima formulazione del concetto di organismo nel pensiero leibniziano e la sua ripresa in termini sistemici nell’opera di Kant potrebbe essere riletta alla luce della teoria della conoscenza: ci viene incontro, in tale tentativo, Alan Love che, nell’articolo Evolutionary Morphology, Innovation, and the Synthesis of Evolutionary and Developmental Biology (2006), propone un’interessante distinzione fra i concetti di «integrazione» e di «sintesi», termini che fanno riferimento a due diversi modelli di relazione fra le parti.19 A prescindere dai contesti di utilizzo, infatti, il concetto di sistema concerne sempre il «modo» in cui elementi fra loro differenti possono stare insieme in maniera coe-rente, unitaria e finalizzata così da concorrere alla formazione di un fenomeno globale. L’integrazione, vicina alla prospettiva di Leibniz, è definita da Love come la messa in relazione di più com-ponenti, così da costituire una nuova entità in cui l’individualità di ciascuna parte originaria va persa o viene completamente can-cellata; al contrario, la sintesi si configura come l’unione di più elementi volti a formare una nuova entità che si fa forte dell’indi-vidualità di ciascuna parte, non la dissolve, ma potenzialmente la modifica.20 È questa la prospettiva che ci consente di interpretare in maniera corretta il pensiero di Kant e l’idea di organismo di cui la biologia contemporanea si avvale, determinando la nascita di un approccio metodologico che fa da contraltare alla prospettiva riduzionista perché la complessità delle relazioni in gioco non conduce alla disgregazione dell’unità, né a una frammentazione delle nostre tecniche d’indagine di essa. Né la descrizione né la spiegazione di un sistema possono essere effettuate a livello delle parti, intese come entità isolate, connesse soltanto da azioni e reazioni: la decomposizione analitica in elementi scompone il sistema, le cui regole di composizione non sono additive, ma trasformatrici.21
Nel tentativo di comprendere le dinamiche organiche, la biolo-gia deve dunque far leva su un approccio sistemico/sintetico in
essere quelli corretti. Se la modularità è una caratteristica inevitabile del design della vita organica, dobbiamo aspettarci che una serie di fenomeni ricorra conti-nuamente in differenti linee di discendenza: la serialità, la ridondanza, la specializ-zazione e l’integrazione».19. A.C. Love, Evolutionary Morphology, Innovation, and the Synthesis of Evo-lutionary and Developmental Biology, «Biology and Philosophy», 124 (2006), pp. 311-312, trad. a cura di A. Pinotti-S. Tedesco con il titolo Morfologia evoluzioni-stica, innovazione e sintesi della biologia evoluzionistica e dello sviluppo, in A. Pinotti-S. Tedesco (a cura di), Estetica e scienze della vita. Morfologia, biologia teoretica, evo-devo, cit., pp. 292-294.
20. Ivi, p. 293.
21. E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, cit., p. 140.
il sistema vivente: unità e modularità organica 273
grado di render conto di tre concetti che costituiscono la chiave di volta per la comprensione dei fenomeni viventi: modularità, gerar-chia ed emergenza.
L’applicazione della nozione di sistema alla scienza del vivente assicura la scomponibilità del corpo in «moduli», unità organiz-zazionali22 che consentono di affiancare a una spiegazione globale dell’organismo, una descrizione, più facilmente gestibile, dei vari sottosistemi.23 «Nello stesso albero», afferma a tal proposito Kant, «ogni ramo e ogni foglia può essere visto come semplicemente innestato o inocchiato su di esso e quindi come un albero per se stante, che semplicemente si attacca a un altro».24 I moduli di un sistema sono, infatti, dotati di semi-indipendenza nel senso che il legame che unisce le parti costitutive di un modulo è più forte del legame esistente fra quest’ultimo e le altre componenti organiche:25
22. G.J. Eble, Morphological Modularity and Macroevolution: Conceptual and Empirical Aspects, in W. Callebaut-D. Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity: Understanding the Development and Evolution of Natural Complex Systems, cit., p. 223. Cfr. anche A.D. Buscalioni-A. de la Iglesia-R. Delgado-Buscalioni-A. Dejo-an, Modularity at the Boundary Beetween Art and Science, in W. Callebaut-D. Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity: Understanding the Development and Evolution of Natural Complex Systems, cit., p. 286 in cui gli autori affermano che «la modularità fu concettualizzata nel mondo classico. Essa indicava originaria-mente un canone metrico; il modulo era stato utilizzato con la convinzione che la modularità fosse una proprietà reale e universale della Natura. Il canone di Poli-cleto e Myron, e più tardi di Da Vinci e Dürer, così come la sezione aurea e il Modulor di Le Corbusier, erano basati su questa idea delle proporzioni (in greco, analoga). Tali canoni sono stati formulati in arte e in architettura, nella convinzio-ne che il corpo umano possedesse la relazione perfetta tra il tutto e le parti. L’uso di tali moduli logici e “oggettivi” avrebbe dovuto trasmettere l’armonia dell’uni-verso, raccogliendo la variazione metrica del mondo in un’unità organica. I moduli classici erano e sono sia estetici che statici. Il modulo è un’unità metrica ideale per essere adottata e applicata a qualsiasi costruzione, al fine di mantenere la somi-glianza dei rapporti tra il tutto e le parti».
23. Cfr. D. Rasskin-Gutman, Modularità. Forme che saltano all’interno del mor-fospazio, cit., pp. 338-339 in cui l’autore asserisce che «la modularità è il contras-segno dell’organizzazione degli esseri viventi, e costituisce anche un materiale eccellente per la complessità. Essa è stata identificata a tutti i livelli dell’organizza-zione biologica: sequenze genetiche, motivi proteici, tipi cellulari, geometrie tissu-tali generiche, configurazioni ossee, strutture cerebrali, solo per nominarne alcuni».
24. I. Kant, Kritik der Urtheilskraft, cit., p. 288, trad. cit., § 64, p. 205.
25. D. Rasskin-Gutman, Modularità. Forme che saltano all’interno del morfospa-zio, cit., p. 330 in cui l’autore afferma che «i moduli sono parti di un sistema dotate di semi-indipendenza nel senso che i legami all’interno di tali parti sono più forti di tutti gli altri legami esistenti fra altre parti non appartenenti al moduli. Una mano è un modulo: le sue dita hanno più relazioni fra loro che con le altre parti del corpo (ad esempio, con le dita dei piedi). Tali relazioni sono relazioni di con-nessione, nel senso che esse sono topologicamente correlate, con la risultante condivisione di risorse anatomiche quali l’apporto di sangue o i modelli strutturali di innervazione». Cfr. anche D. McShea-C. Anderson, The Remodularization of the Organism, in W. Callebaut-D. Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity:
valeria maggiore 274
non si tratta di un semplice incapsulamento di un sistema in un altro, come in un gioco di scatole cinesi, ma di una pluralità di livelli interconnessi, fortemente integrati e, allo stesso tempo, rela-tivamente indipendenti gli uni dagli altri.26 È questa quasi indipen-denza dei caratteri, inoltre, che consente a un singolo modulo di modificarsi senza dar necessariamente luogo a ripercussioni sugli altri: il modulo si qualifica non solo come unità morfologica e organizzazionale dell’organismo, ma anche come un’«unità di variabilità»27 e sta, dunque, alla base della capacità di evolvere del vivente (evolvability).28
Ai criteri di forte integrazione interna e di relativa indipendenza delle parti occorre affiancare altri due criteri che consentono di identificare e di distinguere un modulo dall’altro: la «persistenza», in altre parole la possibilità di identificare ciascun modulo come un’unità riconoscibile per un lasso di tempo abbastanza lungo (nel caso dei moduli evolutivi per esempio, si fa riferimento all’arco di almeno una generazione), e la loro «ripetitività», cioè il fatto che sia possibile rinvenire moduli più o meno identici all’interno dello stesso sistema o in altri sistemi simili. I moduli sono, infatti, mani-festazione del principio di economia della natura perché la diversi-tà e la variabilità delle strutture risulta dall’originale ricombinazio-ne di una serie limitata di elementi di base.29 Fu proprio il
Understanding the Development and Evolution of Natural Complex Systems, cit., p. 189 in cui gli autori affermano che «un oggetto solido – come una cellula o un organo – è una parte per il fatto che i suoi componenti atomici o molecolari sono normalmente ben connessi gli uni gli altri e meno connessi a enti esterni». La «parte» viene qui intesa come un set di componenti organiche relativamente ben integrate e interconnesse, ma, allo stesso tempo, isolabili dalle componenti poste al di fuori di tale set per via delle loro caratteristiche morfologiche e funzionali.
26. Cfr. A. Minelli, Forme del divenire. Evo-devo: la biologia evoluzionistica dello sviluppo, Giulio Einaudi Editore, Torino 2007, p. 201 in cui l’autore afferma che «per modulo si intende ogni sequenza di eventi in grado di procedere in forma largamente autonoma rispetto a quello che succede attorno. Un po’ come la con-versazione che avviene fra un piccolo capannello di persone, in una piazza affolla-ta, che procede sostanzialmente indisturbata per un po’, proprio come sta avvenen-do a poca distanza, in altri distinti moduli di “conversazione”».
27. G.J. Eble, Morphological Modularity and Macroevolution: Conceptual and Empirical Aspects, cit., p. 223.
28. Cfr. I. Brigandt, Typology now: Homology and developmental constraints explain evolvability, «Biology and Philosophy», 22 (2007), pp. 709-725. Cfr. anche D. Rasskin-Gutman, Modularità. Forme che saltano all’interno del morfo-spazio, cit., p. 338 in cui l’autore afferma che «la modularità sembra essere stata considerata quasi esclusivamente come espressione di adattamento. In questa visione, i moduli sono letteralmente l’architettura biologica che permette agli “adattamenti” complessi di avere luogo».29. S.V. Jablan, Modularity in Art, in Werner Callebaut-Diego Rasskin-Gutman (a cura di), Modularity: Understanding the Development and Evolution of Natural Complex Systems, cit., p. 259.
il sistema vivente: unità e modularità organica 275
riconoscimento di una ripetitività a livello organico che condusse, nel corso dell’Ottocento, alla nascita di nuove discipline biologiche come, ad esempio, l’anatomia comparata e alla delineazione dei concetti di analogia e omologia che occupano un ruolo di prim’or-dine anche nell’ambito degli studi morfologici novecenteschi.30 La modularità del vivente ci consente, quindi, di mettere di volta in volta a fuoco la singola parte o il tutto, in un gioco di continui rimandi che caratterizza il disegno architettonico del corpo.31
Affinché s’instauri una relazione organica è però necessario che vi sia non solo una molteplicità quantitativa di elementi (più moduli), ma anche una varietà qualitativa (strutture morfologica-mente distinte). Non esiste, di conseguenza, alcuna contraddizione tra l’armonia e il suo opposto, la dissonanza: esse sono stretta-mente congiunte al punto che quest’ultima è completamente assorbita dalla precedente. L’armonia concerne, infatti, il tutto nella sua globalità; la dissonanza riguarda, invece, solamente una parte dell’organismo, una varietà modulare all’interno dell’unità. Il sistema organico è pertanto definibile, utilizzando un parados-so, come unitas multiplex:32 «considerato dal punto di vista del Tutto», afferma Morin, «esso è uno e omogeneo; considerato dal
30. Per un’analisi più approfondita delle origini dell’anatomia comparata e della controversia sull’unità di piano e di composizione degli esseri viventi cfr. J.W. Goethe, Principii di Filosofia Zoologica discussi nel marzo 1830 all’Accademia delle Scienze di Parigi da Stefano Geoffroy-Saint-Hilaire, in Id., Principii di Filo-sofia Zoologica e Anatomia Comparata, trad. a cura di Michele Lessona, Edoardo Perino Editore, Roma 1885; E.S. Russell, Form and function. A contribution to the history of animal morphology, John Murray, London 1916; S.J. Gould, The Struc-ture of Evolutionary Theory, Harward University Press, Harward 2002, trad. a cura di Telmo Pievani col titolo La Struttura della teoria dell’evoluzione, Codice Edizioni, Torino 2003; J. Pivetau, Le débat entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire sur l’unité de plan et de composizion, «Revue d’histoire des sciences et de leurs applications», 4 (1950); H. Le Guyader, Le concept de plan d’organisation: Quelques aspects de son histoire/The concept of Bauplan: Some aspects of its history, «Revue d’histoire des sciences», tome 53, 3-4 (2000), pp. 341-343. Sulla distinzione fra i concetti di analogia e omologia vedi R. Owen, Lectures on the comparative anatomy and physiology of the Invertebrate Animals, London, 1855 in cui Owen afferma che analogo è «parte o organo in un animale che ha la stessa funzione di un’altra parte o organo in un animale differente», mentre omologo è «lo stesso organo in animali diversi sotto ogni varietà di forma e funzione».
31. Cfr. D. McShea-C. Anderson, The Remodularization of the Organism, cit., pp. 189-190, in cui si sostiene che «una parte […] è un modulo in relazione a quello che potrebbe essere definito come la “funzionalità” di un organismo (per esempio, nella sua fisiologia o comportamento, piuttosto che nel suo sviluppo)». Cfr. A.D. Buscalioni-A. de la Iglesia-R. Delgado-Buscalioni-A. Dejoan, Modularity at the Boundary Beetween Art and Science, cit., p. 286 in cui gli autori affermano «noi concepiamo la modularità come triarchia: il tutto modulare, il modulo e il modello definito dalle relazioni o dalle interazioni tra i moduli».32. E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, cit., p. 119.
valeria maggiore 276
punto di vista dei costituenti, è diverso ed eterogeneo»;33 ciò che consente ai due aspetti di convivere è il fatto che l’insieme delle parti costitutive del corpo non è un neutrale essere l’una accanto all’altra, bensì un reciproco determinare che consente all’insieme di conservarsi attraverso il mutamento.34
«Harmonia, id est unitas plurimorum seu diversitas identite compensata»:35 unità del molteplice, unità che si gioca quindi a livello quantitativo e allo stesso tempo qualitativo perché ponendo ciascun termine in rapporto agli altri, l’ordine si fa gerarchia.36 Contropartita della differenziazione della totalità armonica è, infatti, l’«ineguaglianza gerarchica», risultato e condizione dell’or-dine.37 La gerarchia non deve però essere intesa come una forma di subordinazione autoritaria, ma come ciò a cui l’intero organi-smo tende, in altri termini come il risultato spontaneo verso il quale convergono le differenze: l’unità dei diversi conduce a una razionalità d’insieme che si instaura senza alcuna forma di coerci-zione.38 Morin nota a tal proposito che «non esiste un principio sistemico anteriore ed esterno alle interazioni fra gli elementi. Al contrario esistono condizioni fisiche di formazione in cui taluni fenomeni di interazione, prendendo forma di interrelazione, diventano organizzativi».39
In riferimento a ciò, Kant asseriva che «un essere organizzato non è dunque semplicemente una macchina, ché questa ha solamen-te una forza motrice, ma possiede in sé una forza formatrice, cioè tale da comunicarla alle materie che non l’hanno (cioè le organizza): ha quindi una forza formatrice che si riproduce e che non può essere
33. Ibid.
34. H. Jonas, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, cit., pp. 83-84. Cfr. anche J. Schlanger, Les métaphores de l’organisme, Éditions L’Harmattan, Paris 1995, p. 98. L’autrice suggerisce che l’immagine che può aiutarci maggior-mente a comprendere il modo in cui è costituito e opera l’organismo è, forse, quella dell’orchestra in cui i diversi strumenti concorrono alla formazione della medesima sinfonia: ogni strumento musicale ha un proprio ruolo, una partitura particolare, ognuno esegue note differenti con ritmi differenti, ma ciascun musi-cista tende l’orecchio al proprio vicino e si accorda ad esso in un gioco di rimandi continuo, contribuendo nell’individualità della proprio parte alla creazione di un’unica melodia.
35. J. Schlanger, Les métaphores de l’organisme, cit., p. 92.
36. H. Jonas, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, cit., p. 93.
37. Cfr. D. McShea-C. Anderson, The Remodularization of the Organism, cit., p. 190 in cui si afferma che «il termine “gerarchia”, in tale occasione, si riferisce alla relazione strutturale fra le parti». Cfr. anche M. Ereshefsky, Homology: Integrat-ing Phylogeny and Development, «Biological Theory», 4, 3 (2009), pp. 225-229.
38. Cfr. J. Schlanger, Les métaphores de l’organisme, cit., p. 93.
39. E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, cit., p. 116.
il sistema vivente: unità e modularità organica 277
spiegata mediante la sola capacità di movimento (il meccanismo)».40 I moduli morfologici si qualificano allora come il prodotto di pro-cessi auto-organizzazionali che hanno luogo nel corso dello svilup-po della forma organica e non della selezione naturale.41 «La pres-sione selettiva», conferma risolutamente Rasskin-Gutman, «può gettare un po’ di luce sulla distribuzione delle varianti di una data architettura modulare, ma non sarà mai in grado di spiegare le origini della sua modularità».42 Il filosofo tedesco sottolinea, infatti, che la costruzione dell’organismo si fonda sul legame spontaneo delle parti nell’unità di un tutto perché «solo in questo modo è possibile che in senso inverso (vicendevolmente) l’idea del tutto determini a sua volta la forma e il legame di ogni parte»;43 solo in questo modo, in altre parole, il tutto può esercitare delle costrizioni gerarchiche sulle parti modificandone il comportamento e determi-nando l’insorgere di proprietà emergenti.44
Come aveva già mostrato Aristotele nel libro Z della Metafisi-ca, il tutto è maggiore della somma delle parti perché le qualità e le proprietà del sistema presentano un carattere di novità rispetto alle qualità o alle proprietà delle componenti considerate in maniera isolata.45 L’emergenza, però, «è un prodotto dell’organiz-zazione che, benché inseparabile dal sistema in quanto tutto, non soltanto appare a livello globale, ma può anche apparire a livello delle componenti».46 Così dicendo, Morin afferma un principio che verrà esplicitato da Daniel McShea e Carl Anderson nell’arti-colo The Remodularization of the Organism (2005): le parti, entrando a far parte di un tutto, ottengono dei guadagni e delle
40. I. Kant, Kritik der Urtheilskraft, cit., pp. 292-293, trad. cit., § 65, p. 208. Cfr. anche S.A. Newman, Carnal Boundaries. The Commingling of Flesh in Theory and Practice, in R. Birke-R. Hubbard (a cura di), Reinventing Biology. Respect for Life and the Creation of Knowledge, Bloomington and Indianapolis, Indiana U.P. 1995, p. 207 ss.
41. D. Rasskin-Gutman, Modularità. Forme che saltano all’interno del morfospa-zio, cit., p. 339.
42. Ivi, pp. 339-340.
43. I. Kant, Kritik der Urtheilskraft, cit., p. 291, trad. cit., § 65, p. 207.
44. Cfr. A. D. Buscalioni-A. de la Iglesia-R. Delgado-Buscalioni - A. Dejoan, Modularity at the Boundary Beetween Art and Science, cit., p. 297 in cui si afferma che «la natura solitamente sceglie una gerarchia di tipo molto più sottile, che non solo è imposta dall’“alto”, ma che è anche in grado di emergere dalle numerose interazioni tra le entità più piccole ed è istituita da un particolare processo gerar-chico che si suole chiamare “auto-organizzazione”. L’auto-organizzazione è sup-portata da un particolare tipo d’interazione tra i sottosistemi (o moduli), la quale consiste essenzialmente di relazioni sia di tipo collaborativo che competitivo».
45. Aristotele, Metafisica, Z 17, 1041 b 12-19. Cfr. anche E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, cit., pp. 120 ss.
46. Ivi, p. 122.
valeria maggiore 278
perdite. Nel momento in cui entrano a far parte del sistema e divengono moduli di quest’ultimo, il tutto esercita una «retroatti-vità organizzazionale» sulle singole parti che possono, ad esem-pio, acquisire nuove proprietà.47 Si parla a tal proposito di «microemergenze» perché «alcune proprietà delle parti nell’ambi-to di un sistema dato sono assenti o virtuali quando queste parti sono in uno stato di isolamento; esse possono essere acquisite e sviluppate solo nel tutto e grazie al tutto».48 Viceversa, però, è possibile che le parti «perdano» qualcosa nel loro «divenire parti»49: il sistema richiede un ampio coordinamento fra i moduli e la coordinazione determina l’imposizione di limiti alla libertà della singola parte (i cosiddetti vincoli).50 Come affermano i due autori sopra citati, «al fine di svolgere il proprio ruolo, un organi-smo di livello inferiore deve comportarsi in modo appropriato, deve essere costretto a non comportarsi in un’ampia varietà di modi inappropriati».51 Nei fenomeni d’interrelazione entrano, infatti, in gioco forze contrapposte: forze di repulsione fra parti qualitativamente differenti e forze di attrazione imposte dal tutto. È necessario che quest’ultime predominino sulle spinte repulsive o, come afferma Morin, che le «virtualizzino», rendendole ininfluen-ti.52 «Le interrelazioni più stabili», nota il pensatore francese, «presuppongono che forze a esse antagonistiche siano contempo-raneamente neutralizzate e sormontate».53 È per tale motivo che
47. D. McShea-C. Anderson, The Remodularization of the Organism, cit., p. 185.
48. E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, cit., p. 122.
49. D. McShea-C. Anderson, The Remodularization of the Organism, cit., p. 185.
50. Ivi, p. 188 in cui leggiamo quanto segue a proposito del comportamento delle singole parti nel tutto: «quando rinunciano a un’esistenza indipendente, sono incorporate in un’entità di livello superiore e, nel momento in cui tale entità acqui-sisce la capacità di eseguire funzioni – nutrirsi, spostarsi, difendersi, riprodursi, e così via –, le richieste funzionali della componente di livello inferiore degli organi-smi vengono ridotte. Ci si aspetta quindi che la selezione favorisca la perdita, nell’interesse economico generale, di alcune tipologie di parti all’interno di tali macro-entità. Pertanto, la cellula epidermica di un mammifero sperimenta poche richieste funzionali, perché la maggior parte delle funzioni è svolta dall’animale nel suo complesso e, di conseguenza, la cellula richiede pochi elementi interni per svolgere tali funzioni. Un protista che vive in libertà, al contrario, deve eseguire egli stesso ogni funzione e, dunque, necessita di un numero maggiore di articolazioni interne. Un presupposto necessario, naturalmente, è che il numero dei tipi elemen-tari rifletta, o si correli adeguatamente, al numero di funzioni». Cfr. anche E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, cit., p. 127 ss.
51. Ibid.
52. E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura, cit., p. 134 ss.
53. Ivi, p. 135.
il sistema vivente: unità e modularità organica 279
Morin sostiene che il tutto è allo stesso tempo più e meno della somma delle parti.54
Le acquisizioni e le perdite qualitative sono indizio del fatto che gli elementi costitutivi di un sistema sono trasformati in quanto parti di un tutto. «Ci troviamo dinanzi», conclude Morin, «a un principio sistemico chiave: il legame fra formazione e tra-sformazione. Tutto ciò che forma trasforma. Questo principio diventerà attivo e dialettico alla scala dell’organizzazione vivente, in cui trasformazione e formazione costituiscono un circuito ricorsivo ininterrotto».55
È per tale motivo che, di concerto con il pensatore francese e reinterpretando il pensiero kantiano alla luce delle scoperte della biologia contemporanea, si può affermare che «l’organizzazione è a un tempo trasformazione e formazione (morfogenesi)».56 La costruzione della forma vivente trova il proprio contrappunto nel concetto di trasformazione, vale a dire in quella metamorfosi di goethiana memoria che obbliga gli elementi, divenuti parte di una totalità organica, a perdere alcune qualità, ma consente loro di acquisire compensativamente nuove possibilità d’azione. Affidan-doci ancora una volta alle parole di Morin, possiamo pertanto concludere che «l’organizzazione trasforma una diversità separata in una forma globale (Gestalt). Essa crea un continuum – il tutto pieno di interrelazioni – laddove vi era il discontinuo; essa opera in realtà un mutamento di forma, forma (un tutto) a partire dalla trasformazione (degli elementi). Si tratta senz’altro di morfogene-si: l’organizzazione dà forma, nello spazio e nel tempo, a una nuova realtà: l’unità complessa o sistema»57.
54. Ivi, pp. 128 ss.
55. Ivi, p. 131.
56. Ivi, p. 148.
57. Ivi, p. 149. Cfr. anche ivi, p. 140 in cui il pensatore francese afferma che La forma vivente è allora «la totalità dell’unità complessa organizzata che si manifesta sul piano fenomenico in quanto tutto, nel tempo e nello spazio. La forma, Gestalt, è il prodotto delle catastrofi, delle interrelazioni/interazioni fra elementi, dell’orga-nizzazione interna, delle condizioni, delle pressioni, dei vincoli dell’ambiente. Al forma cessa di essere un’idea di essenza per divenire un’idea di esistenza e di organizzazione».