Il Palazzo dell'Ateneo di Genova - Ex Collegio della Compagnia di Gesù
Transcript of Il Palazzo dell'Ateneo di Genova - Ex Collegio della Compagnia di Gesù
REALIZZAZIONE EDITORIALE
De Ferrari Comunicazione srlvia D’Annunzio 2 · 16121 GenovaTel 010 0986820/21/22 · Fax 010 [email protected] www.deferrarieditore.it
L’editore rimane a disposizione per gli eventuali diritti sulle immagini pubblicate.I diritti d’autore verranno tutelati a norma di legge.
CONSULENTE EDITORIALE: Mario Paternostro
PROGETTO GRAFICO: Barbara Colasanto
è il marchio librario dell’Università degli Studi di Genova
PROGETTO E CURA: Lauro Magnani
INTERVENTI E SCHEDE: Anna Boato, Valentina Borniotto, Sara De Maestri, Clario Di Fabio, Valentina Fiore, AnnaManzitti, Mauro Mariotti, Mauro Maspero, Maria Grazia Montaldo, Giacomo Montanari, Elena Parma, GuglielmoPolastri, Giovanna Rosso Del Brenna, Sara Rulli, Daniele Sanguineti, Rocco Spigno, Laura Stagno, Paola Valenti,Rossana Vitiello
CURA REDAZIONALE: Gruppo di lavoro per la Valorizzazione del Patrimonio di Ateneo
HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE: Azzurra Balistreri, Marco Bianchini, Mariangela Bruno, Corrado Cane-pa, Simonetta Cartaregia, Francesca De Cupis, Claudia De Nadai, Lilli Ghio, Gerardina Maglione, Marco Manferti,Mauro Maspero, Giacomo Molinelli, Bruno Moncalvo, Maximilian Rizzardi, Massimo Rossi, Rossana Trematerra,Annalisa Tursellino, Roberto Versari
Si ringraziano i Presidi delle Scuole, i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca interessati. Un ringraziamento al personale in servizio presso le diverse sedi per la disponibilità prestata.
La Camera di Commercio di Genova di Genova ha cofinanziato un Assegno di Ricerca dedicato allo studio e allacatalogazione del patrimonio artistico dell’Ateneo.
© CREDITI FOTOGRAFICI: Anna Boato, Azzurra Balistreri, Valentina Borniotto, Fulvio Capolupo, Lauro Magnani,Mauro Mariotti, Maria Grazia Montaldo, Giacomo Montanari, Mauro Moriconi, Armando Pastorino, Sara Rulli,Davide Scappini, Marco Serretta, Rasih Onur Süzen, Giacomo Vallarino, Lorenzo Zeppa, Archivio fotografico dellaSoprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria, Centro Doc SAI, Archivio Fotogra-fico, Istituto di Storia della Cultura Materiale – ISCUM, Studio Nicolini
133133
All’interno del palazzo al numero 5 di via Balbi, daquasi quattrocento anni si trova la sede dell’istituzioneUniversitaria della città di Genova. Il grandioso palazzovenne progettato dall’architetto comasco BartolomeoBianco come Collegio della Compagnia di Gesù, sul ter-reno comprato dai Gesuiti dal nobile Stefano Balbi, chene consentì l’edificazione grazie all’interessamento delfratello Paolo, membro egli stesso della Compagnia. Ilprimo disegno noto riguardante il Collegio risale al1634, anno in cui l’architetto avrebbe definito già inmaniera dettagliata il grandioso progetto che doveva svi-lupparsi in un lotto di terreno che presentava non pocheproblematiche tecniche per l’edificazione di un edificiodi quelle proporzioni. Lo spazio a disposizione dei PadriGesuiti si faceva infatti scosceso molto rapidamente apoca distanza dalla sede stradale, salendo a grandi balzesu per la collina di Pietraminuta. Era necessario pertantoil talento e il genio di un valente architetto come ilBianco per progettare e mettere in opera una strutturaagile e di impatto magnificente come quella che si puòoggi percorrere, salendo i dislivelli del fianco rocciosodel monte, senza rinunciare a strutturare spazi che servis-sero con agio gli scopi educativi e abitativi richiesti dallaCompagnia di Gesù. Bartolomeo Bianco pensò quindiad una successione continua di volumi che si inseguonoin profondità, inerpicandosi lungo il fronte scosceso del
declivio, elegantemente messi in comunicazione conagili rampe di scale che gettano ponti “aerei” da un livel-lo all’altro della struttura. È così che, accolti dal portalemonumentale, l’atrio appare quasi restringersi in con-fronto al gioco prospettico che trascina lo sguardo versol’alto, lungo lo scalone di ingresso e lo porta a percorrere,in anticipo, gli scalini delle rampe che si intersecano sul-lo sfondo del giardino pensile. Sotto lo sguardo dei pos-senti leoni scolpiti nel marmo da Francesco Biggi su dise-gno e progetto di Domenico Parodi nel 1718, si percorreil ripido scalone monumentale, per venire compresi nelluminoso spazio del cortile delle scuole. Gli archi a tuttosesto sono sorretti da eleganti colonne binate che, con illoro raffinato gioco di vuoti e di pieni, contribuiscono arendere il cortile uno spazio ricco di “circolazione d’aria”:il ritmo del colonnato tiene infatti l’occhio in costantemovimento e illude di trovarsi all’interno di uno spaziodi ben più ampio respiro. Il cortile, nell’idea architetto-nica dei Collegi della Compagnia di Gesù, doveva fun-gere da “cuore pulsante” dell’intero complesso: una sortadi luogo di incontro, educazione e anche possibilità dirappresentazione teatrale e religiosa. Tradizionalmentenei grandi collegi, come ad esempio quello di Brera aMilano, venivano realizzati due diversi cortili: il primoaveva le funzioni sopra accennate ed era dedicato all’usoda parte di studenti, ospiti e docenti, costituendo in
PALAZZO DELL’ATENEOEX COLLEGIO
DELLA COMPAGNIA DI GESÙRETTORATO E SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI - VIA BALBI 5
Rampe di accesso al secondo livello del loggiato del cortile
134
Veduta di insieme del cortile
Il portale di ingresso
Francesco Biggi (su disegno di Domenico Parodi),uno dei leoni posti sullo scalone d’ingresso, 1718
Atrio e scalone di ingresso
sostanza un luogo pubblico; il secondo invece era un cor-tile assolutamente dedicato alle private attività dei PadriGesuiti e a loro solo accessibile. A Genova tuttavia, acausa dell’impervietà del luogo, non era purtroppo possi-bile la realizzazione di ambedue le strutture e si decisepertanto di privilegiare quella pubblica, dando dunqueuna indicazione precisa riguardo all’importanza che lospazio in comune e la possibilità di poter abitare un luo-go come il cortile e i suoi aerei loggiati poteva avere peri giovani che si accostavano ad un percorso di studi lun-go e complesso. Al piano del cortile infatti erano presen-ti diverse aule di insegnamento, di cui oggi sopravvivo-no, come testimoni ancora tendenzialmente molto benidentificabili nella loro originaria struttura, l’Aula diTeologia (oggi Cappella Universitaria, lato sinistro) el’Aula di Legge (oggi Aula Cabella, lato destro). Attra-versato il cortile e imboccato lo scalone si viene condottial loggiato del primo piano: sul lato che affaccia sulla viaBalbi si apre il grandioso spazio dell’Aula Magna, untempo salone per gli Esercizi Letterari, decorato con unciclo di affreschi che ne ricopre l’intera superficie. Cen-tro ideologico della retorica gesuita, il salone vennedecorato tra il 1683 e il 1684 con tutta probabilità dallamano del pittore genovese Giovanni Andrea Carlone,
attivo anche nel palazzo di Francesco Maria Balbi (viaBalbi 4) oltre che nei cantieri del monastero di San Bar-tolomeo dell’Olivella, San Siro e Palazzo Rosso. L’artistaaveva già lavorato precedentemente nei grandi cantierigesuiti della chiesa del Gesù di Perugia e soprattutto inquella di Roma, dove aveva raffigurato le vicende di sanFrancesco Saverio. Le immagini rappresentate prendonocon tutta probabilità spunto dalle prediche proclamatedai grandi oratori di origine genovese della Compagnia,in particolare Gio. Paolo Oliva, che era stato Generaledell’Ordine a Roma fino all’anno della morte, avvenutanel 1681 e i cui libri erano conservati all’interno dellaBiblioteca del Collegio stesso in edizioni preziose e digrande formato. Tra grandi statue realizzate a grisaille,voli di putti e un tripudio di decorazione floreale che sca-turisce da vasi e valve di conchiglie agli angoli della vol-ta per poi intrecciarsi a formare una ricchissima ghirlan-da attorno al medaglione centrale, doveva potersi ammi-rare, secondo le descrizioni di Carlo Giuseppe Ratti, ilcosiddetto Anonimo del 1818 e Federigo Alizeri, la rap-presentazione di un tema molto caro alla Compagnia diGesù: il trionfo del Nome di Gesù, con la presenza diMaria Vergine e dei principali santi fondatori dell’Ordi-ne, come Ignazio, Francesco Saverio e Francesco Borgia.
138
140
Giovanni Andrea Carlone e aiuti, Re Salomone, Aula Magna,1683-1684
Lorenzo De Ferrari (?), San Bartolomeo, Aula Magna
Oggi purtroppo nulla sopravvive della decorazione del-l’oculo centrale: dopo aver subito il bombardamento del-l’esercito piemontese, guidato dal generale Alfonso LaMarmora, volto a soffocare nel sangue la rivolta dellacittà nel 1848, l’affresco cedette ai danni riportati e mairiparati a dovere il 27 dicembre di vent’anni dopo, nel1868. A ripristinare ciò che era stato perduto vennechiamato Giuseppe Isola, pittore genovese di ottimafama che aveva realizzato molte grandiose opere nel cuo-re dei palazzi simbolo del potere rinnovato, come PalazzoReale (acquistato dai Savoia nel 1822) e Palazzo Ducale.Nel frattempo però, a partire dalla soppressione dellaCompagnia di Gesù da parte di Papa Clemente XIVavvenuta nel 1773, la grande struttura del Collegio ave-va cambiato gestione sebbene avesse mantenuto la suavocazione educativa. Al posto dei padri della Compa-gnia di Gesù fu la Repubblica di Genova, nella sua purbreve esistenza, ad amministrare l’edificio e l’Università
sita al suo interno, che diveniva a tutti gli effetti il primovero e proprio Genuense Athenaeum di carattere pubbli-co: la sua grande biblioteca, arricchita con i libri prove-nienti dalle soppressioni religiose di inizio XIX secolo edaperta alla consultazione del pubblico, divenne assiemeall’ex Collegio centro culturale di una riconquistataindipendenza laica del sapere. Questa nuova dimensionelaicizzata dell’istituzione, ribadita in epoca Sabauda, por-tò pertanto Giuseppe Isola ad affrescare nello spazio cen-trale della volta non più soggetti di carattere religioso,bensì di celebrazione patriottica, scegliendo di illustrareil Trionfo della scienza dei Liguri, dove i grandi uomini del-la millenaria storia genovese attorniavano la personifica-zione della Sapienza. A questo periodo fortemente lega-to alla retorica celebrativa risorgimentale, risalgono ingran parte i busti marmorei e bronzei che sono visibilisotto i loggiati del primo e del secondo piano. Professori,studiosi, patrioti e importanti personalità cittadine eduniversitarie che donarono sapere, impegno e vita allapatria e all’Ateneo genovese dovevano indicare agli stu-denti gli esempi da seguire, funzione che fino a centoanni prima avevano assolto, nella retorica gesuita, i santie gli studiosi della Compagnia, le cui effigi ancora sonoriscontrabili all’interno delle decorazioni che adornanoalcune aree del complesso. L’opera dell’Isola non fu peròpiù fortunata di quella del Carlone e in seguito ai bom-bardamenti condotti su Genova dall’aviazione Alleatadurante l’anno 1944 crollò anch’essa al suolo. Se ne con-servano alcune foto storiche precedenti e successive ilcrollo ed alcuni frammenti strappati ad opera dellaSoprintendenza prima della rimozione delle parti perico-lanti, oggi conservati all’interno della sala professori del-la Presidenza della Scuola in Scienze Sociali. Dopo laconclusione del secondo conflitto mondiale, per colmareancora una volta il vuoto lasciato dalle bombe, fu indet-to un concorso pubblico che venne vinto dal pittore sar-do Francesco Menzio. Nel 1958 egli realizzò un’opera ditotale rottura con l’apparato decorativo circostante, ispi-randosi alla decorazione dei Portolani genovesi e recupe-rando un’idea religiosa che si concretizza, ai bordi delnuovo spazio astratto della volta, nella presenza del Cro-cifisso e delle tre Marie. Il complesso del Collegio si arti-cola però anche in una imponente struttura sita alle spal-le dello spazio del cortile, la ex Fabbrica Domestica oabitazioni dei Padri Gesuiti che oggi ospita uffici dell’A-teneo genovese insieme ad aule di studio ed insegna-
142
Giovanni Scanzi,Andrea Podestà, loggiato del cortile, piano terra
Francesco Menzio,Allegoria, Aula Magna,1958
mento. Il terzo piano comprende il lungo corridoio disant’Ignazio, culminante nell’Aula della Meridiana, l’O-ratorio Domestico, oggi denominato Aula Ligure e ilRettorato dell’Università degli Studi di Genova, che èospitato nei medesimi locali dove un tempo risiedeva ilRettore del Collegio dei Gesuiti. Sviluppato a ridosso deldeclivio ripido e scosceso della collina di Pietraminuta,il complesso della Fabbrica Domestica è composto di duediversi piani, che anticamente comprendevano sia ledimore dei Padri stessi, sia i locali ad uso della vita quo-tidiana all’interno del Collegio, come la sartoria, il refet-torio e gli ambienti di cucina, oggi destinati interamentead uso didattico e di uffici amministrativi. Le sale infatti,ideate ad hoc per godere di una eccellente illuminazionenaturale e per giovarsi di un clima secco e temperato,
sono luoghi ideali per le aule di studio e gli spazi di lavo-ro, oggi come quattrocento anni addietro. Dal terzo pia-no, o piano del Rettorato, è anche possibile accedere aquello che un tempo era il grande giardino del Collegio:strutturato su tre diversi livelli, ospitava la coltivazionedi vitigni, alberi da frutto e diverse essenze di agrumi edera ricco di peschiere e fontane di diverse dimensioni,alcune ancora presenti in loco. Il grande spazio, restau-rato e abbellito dall’architetto Emanuele Andrea Taglia-fichi alla fine del XVIII secolo, venne poi definitivamen-te trasformato nel XIX secolo in Orto Botanico e ancoraoggi è destinato a questo uso, con la costruzione dellaPalazzina Hanbury che ospita il Polo Botanico dell’Uni-versità di Genova (si veda il contributo in questo volu-me riguardo all’Orto Botanico dell’Università degli Stu-
144
di Genova). È dinanzi a questo accesso al giardino che sistende il lungo corridoio detto di Sant’Ignazio, che attra-versa tutta l’ala ovest del complesso, dalla roccia delmonte sino alla via Balbi: al suo inizio, a lato monte, siapre l’ambiente dell’Oratorio Domestico, oggi denomi-nato Aula Ligure e adibito a sala di rappresentanzadell’Ateneo. Voluto come spazio di devozione ritirato eprivato, per esclusivo uso dei Padri Gesuiti, le cui stanzepersonali si aprivano anche sul corridoio di Sant’Ignazio,la sala dell’Oratorio Domestico venne decorata dallamano virtuosa del pittore genovese Domenico Parodi,tra il 1704 e il 1709, rappresentando probabilmente l’ul-timo intervento di pittura a fresco dell’intero complessoprima dei rifacimenti ottocenteschi. In una totalizzantedecorazione di finte architetture realizzate con maestria
145
Corridoio di Sant’Ignazio
Scalone di accesso all’Orto Botanico
Domenico Parodi, Aula Ligure, ex Oratorio Domestico
sorprendente dal quadraturista bolognese Aldovrandini,occhieggiano le figure a monocromo plasmate dallamano del Parodi, rilevate con graduali e morbidi passag-gi d’ombra. Risaltano così sul finto marmo verde “polce-vera” le icone dei grandi santi della Compagnia, accom-pagnate dall’immagine della Vergine e dai volti dei tresanti Gesuiti crocefissi in Giappone, una devozione pocodiffusa, ma che nel Collegio genovese trova riscontroanche nell’iconografia di un dipinto conservato nell’uf-ficio del Rettore e che doveva servire per indicare aiPadri fino a che punto doveva spingersi la propria voca-zione missionaria. Non bisogna dimenticare che il Col-legio genovese era luogo di passaggio per tutti i gesuitiche desiderassero recarsi in Portogallo o essere inviati inmissione nelle terre dell’Est: esso rappresentava dunqueuna sorta di “porta per l’oriente” e il suo insegnamentospirituale non poteva che focalizzarsi sull’importanzadella vocazione missionaria. A chiusura del lungo corri-doio, sul quale si affacciano numerose porte decorate coneleganti infissi in legno sormontati da un oculo che per-mette alla luce di filtrare all’interno garantendo così unasicura illuminazione, si trova l’Aula della Meridiana.Oggi questa antica sala è adibita all’uso didattico e utiliz-zata anche per il conferimento delle lauree dei corsi inGiurisprudenza, mentre venne pensata dai Padri Gesuiticome sala di studio e, dal 1771, anche come luogo dovepoter misurare il tempo, avendo essi fatto realizzare dalfrancese Padre Correard una meridiana pavimentale inmarmo e ottone, strumento prezioso e ancora perfetta-mente funzionante che testimonia l’interesse assai vivoall’interno del Collegio per l’astronomia, la matematicae le tecniche di osservazione degli astri. Con il passaggiodel Collegio nelle mani della pubblica amministrazionenegli ultimi decenni del XVIII secolo ed il conseguenteincremento dei volumi della Biblioteca negli anni
seguenti, l’Aula della Meridiana venne adibita anch’essaa sala di conservazione libraria e rinominata “Sala Pri-ma”, diventando lo specchio della sua “gemella” sita nel-l’ala est dell’edificio, che prese il nome di “Sala Terza”,da sempre adibita a questo scopo. Le due sale erano poicollegate da una galleria che affacciava sul cortile sotto-stante, anch’essa contenente i volumi conservati dallaBiblioteca, chiamata “Sala Seconda”. Con la separazio-ne delle gestioni tra Biblioteca Universitaria (dipenden-te dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delTurismo) e Ateneo di Genova, la galleria venne chiusasegnando così la cesura tra le due istituzioni e tagliandoa metà questa area dell’antico Collegio. Dal disimpegnoche si trova dove un tempo si trovava l’accesso alla gal-leria è possibile ancora oggi accedere alle ampie terrazzesovrastanti i grandi loggiati del primo e del secondo pia-no, permettendo di ammirare la stupefacente bellezza eleggiadria architettonica che è la caratteristica principa-le del palazzo dell’Ateneo genovese. Lo sguardo puòinfatti tuffarsi tra i due ordini di loggiati sottostanti,attraversando e rincorrendo gli spazi tra le colonne bina-te e le balaustrate marmoree progettate da BartolomeoBianco e portate a effettivo compimento dal Padre Ora-zio Grassi, fine matematico e rettore del Collegio geno-vese. Le terrazze sono dominate dalla solida e austera fac-ciata della Fabbrica Domestica, dove campeggiano bendue orologi solari, utili a misurare l’uno l’ora della gior-nata, l’altro il periodo dell’anno in cui ci si trova, al disotto delle quali si scorgono le fronde sempreverdi degliaranci del giardino pensile, coronato dal sacrario agli stu-denti dell’Ateneo genovese caduti nella Grande Guerra,monumento eretto negli anni venti del XX secolo.
Giacomo Montanari
146
147
Domenico Parodi, San Francesco Borgia,
Aula Ligure
Domenico Parodi,I santi Luigi Gonzaga e Stanislao Kostka,
Aula Ligure
Monumento ai caduti della Grande Guerra e Fabrica Domestica
148
Gli studi che riguardano il complesso dell’ex Collegio deiGesuiti e l’Università di Genova hanno il principio nei fon-damentali volumi redatti da Emanuele Celesia e LorenzoIsnardi, Storia dell’Università di Genova, pubblicati tra il 1861e il 1867. A questi si aggiunse nel 1923 il volume L’Universitàdi Genova, pubblicato negli Atti della Regia Università diGenova: si trattava di un più organico volume, dedicato inparticolare al palazzo dell’Ateneo, dove confluirono studi didiversi esperti, come l’architetto Mario Labò, che ne tratteg-giò per la prima volta in maniera complessiva i caratteriarchitettonico – decorativi. Si deve però arrivare al 1987 perassistere ad una pubblicazione che affronti, con metodologieaggiornate, le diverse questioni aperte sul palazzo. Il testoedito dall’Università degli Studi di Genova e intitolato IlPalazzo dell’Università di Genova. Il Collegio dei Gesuiti nellastrada dei Balbi, vide la partecipazione di diversi studiosi atti-vi o formati nell’Ateneo genovese, tra i quali: Ennio Poleggi,
Emmina de Negri, Ezia Gavazza, Lauro Magnani, Piero Boc-cardo, Franco Renzo Pesenti, Franco Sborgi, Paolo Bensi,Silvana Macchioni, Federica Lamera per citarne solo alcuni.Al 1999 data il contributo monografico di Anna de Marini.Le principali fonti archivistiche consistono nei fondi del-l’Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) e dell’Archiviodi Stato di Genova (ASGe), mentre quelle storiografiche sirifanno ai testi di Raffaele Soprani (Soprani 1674), CarloGiuseppe Ratti (1766 e 1780), l’Anonimo del 1818 e le Gui-de di Federigo Alizeri (Alizeri 1846-1847; 1875 e 1864-1880). Di recente da parte degli studiosi genovesi è stata riaf-fermata l’importanza di riportare vivo l’interesse per il gran-de complesso ex gesuitico: a questo scopo si è stabilito unrapporto di collaborazione con l’Università di Wroclaw(PL), con la quale sono state realizzate, nel 2012 e nel 2013,due Giornate di Studi Internazionali sul rapporto tra i Col-legi Gesuitici e le strutture universitarie.
NOTA BIBLIOGRAFICA
PATRIMONIO MOBILE
Al piano del cortile, sul lato sinistro, si trova l’attuale CappellaUniversitaria, ex Aula di Teologia, l’unica insieme all’AulaCabella, posta a fronte sul medesimo piano, a conservare ancoraoggi i decori e i dipinti voluti dai Padri Gesuiti entro la metà delXVIII secolo. Oltre a raffinati ornati in stucco, è qui ospitato unciclo di tele interamente teso a celebrare la figura della VergineMaria nel ruolo di Corredentrice, dall’iconografia dell’Immaco-lata a quella dell’Assunta. Tra questi dipinti, tradizionalmenterestituiti all’ambito di Jacopo Antonio Boni, si distingue l’Im-macolata Concezione che vanta un’antica attribuzione a Dome-nico Fiasella. Lungo le pareti sono collocate sette formelle bron-zee dedicate alle Storie della Passione, realizzate a partire dal 1582dallo scultore fiammingo Jean Boulogne detto il Giambolognacon il suo collaboratore, il franco-fiammingo Pietro Francavilla.I bronzi, insieme alle sei Virtù oggi conservate in Aula Magna,erano state realizzate per la cappella di Luca Grimaldi nella poisoppressa chiesa di San Francesco di Castelletto e giunseroall’Università nel 1802 su iniziativa del Marchese Antonio Bri-gnole Sale.A destra del cortile è invece l’Aula Cabella, ex Aula di Legge,decorata da un fitto intreccio di raffinati stucchi policromi,che ne ricoprono la volta e che costituiscono un felice esem-pio di decoro rocaille. Anche qui sono ospitate diverse tele,ascrivibili all’ambito di Sebastiano e Giuseppe Galeotti, tese acelebrare alcuni episodi mariani e santi in particolare gesuiti. Salendo al piano superiore si trova l’attuale Aula Magna, exsalone del Collegio e dunque cuore dell’edificio, che, oltre aidecori ad affresco, ospita le sei Virtù del Giambologna: Fede,Speranza, Temperanza, Fortezza, Giustizia e Carità. Si tratta di
uno dei lavori più impegnativi in cui l’artista venne coinvolto,autentica eccellenza nel campo della statuaria di figure bron-zee di grandi dimensioni, caratterizzate da grande perizia tec-nica e raffinatezza di modellato.A memoria della volta dell’Isola, compiuta nel 1871 e distrut-ta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, sonocustoditi tre frammenti, strappati da Luciano Arrigoni oggicollocati in una sala posta al secondo piano, accanto all’AulaMagna. Nella stessa è custodita quella che, tradizionalmente,viene considerata una delle prime bandiere tricolori. Gli stu-denti genovesi, al seguito di Mameli, l’avrebbero sventolataper le strade della città il 10 settembre 1847 ricordando la cac-ciata degli austro-piemontesi avvenuta un secolo prima.L’ex Collegio gesuitico è infatti anche un luogo significativoper la memoria degli avvenimenti che portarono all’Unità d’I-talia. Per i suoi cortili e corridoi hanno transitato, come stu-denti, importanti protagonisti del Risorgimento come i fratelliRuffini, Goffredo Mameli, Giuseppe Mazzini: il loro ricordo ècelebrato, insieme a quello di altri personaggi come Garibaldio Vittorio Emanuele II, da busti e lapidi di diversi autori otto-centeschi disseminati lungo il cortile e i loggiati superiori.
Anna Manzitti
BIBLIOGRAFIA: Soprani, Ratti 1768, p. 155; L’Università diGenova...1923, p. 77; Il palazzo dell’Università di Genova…1987; Dugoni 2001, pp. 173-174, n. 57; p. 238, n. D101 e n.D100; Giambologna. Gli dei, gli eroi…2006; Seitun 2006, pp.132-151 (con bibliografia precedente).
PROPRIETÀProprietà dello Stato. Uso perpetuo e gratuito dell’Università di Genova
151
Giambologna, Incoronazione di spine, Cappella Universitaria (ex Aula di Teologia), particolare
Giambologna, Salita al calvario, Cappella Universitaria (ex Aula di Teologia)
152
Aula Cabella (ex Aula di Legge)
Giuseppe Galeotti, L’educazione della Vergine, Aula Cabella (ex Aula di Legge)






























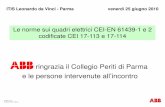













![[con P. BIANCHI], Uno spazio politico d’antico regime. La Compagnia di San Paolo fra corte, Stato e Consiglio di città (XVII-XIX sec.), in La Compagnia di San Paolo, a cura di W.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631e72d13dc6529d5d07f971/con-p-bianchi-uno-spazio-politico-dantico-regime-la-compagnia-di-san-paolo.jpg)


