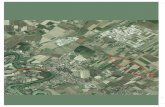Il madorbo. Estratto da Medium Urbis. Duemila anni di storia in riva alla Piave, Sismondi, Treviso...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Il madorbo. Estratto da Medium Urbis. Duemila anni di storia in riva alla Piave, Sismondi, Treviso...
IL M A D O R B O di Simone Menegaldo
L’ambiente del Madorbo si delineò più o meno definitivamente all’inizio dell’Età del ferro, e venne abitato per la prima volta pre-sumibilmente dai popoli venetici, giunti dalla Paftagonia, una re-gione dell’Asia Minore. Essi infatti, attestatisi a Oderzo, solevano piantumare un olmo come gesto bene augurante a ogni nascituro maschio presso i santuari dedicati alle dee dell’acqua, siti secondo i recenti rilevamenti archeologici, nella zona di Ronacadelle e del Madorbo dal fiume Negrisia alla Piave., Tuttavia la zona si sviluppò principalmente in Età Romana, e la componente essenziale di questo sviluppo fu la costruzione di una rete stradale adeguata, che rese i trasporti e le comunicazioni più comode e veloci, efficienti e sicure. La prima strada costruita nel Veneto, e per l’argomento di nostra trattazione la più interessante, fu la via Postumia, realizzata nel 148 a. C. dal console Spurio Postumio Albino, che congiungeva Genova ad Aquileia, passando per Verona e Oderzo. Essa, provenendo da Verona, attraversava la Piave nel punto in cui il greto si restringeva a causa della riunione dei due rami, la cui scissione poco più sopra ha dato origine alle odierne “Grave di Papadopoli”. Il guado in quel tratto doveva essere probabilmente agevolato dalla presenza di un traghetto, e proprio nel punto in cui le genti dovevano sbarcare sulla Sinistra Piave, Gino Gaiotto ebbe la fortuna di rinvenire pali e assi di legno, riaffiorati durante i lavori di consolidamento degli argini nel 1990. La tabula Peutingeriana è un apografo di un originale risalente al 222 d. C., al tempo cioè dell’Imperatore Alessandro Severo. Secondo il De Bon, la Postumia “arriva a Postioma (…) vien tagliata a Oriente di Villorba dalla Ongaresca. Siamo già al Piave. Il tracciato si arresta tra Case Folina (che sarà centro focale durante la Grande Guerra, come vedremo) e Case Ferrari (siamo a Candelù). Lo sorpassa (la Piave), a Borgo del Molino, continua la sua corsa in direzione di Oderzo, la romana Opitergium”. Borgo del Molino è una località posta tra il Madorbo e Roncadelle, di cui odiernamente si lega il nome al bar omonimo. Ma vediamo altri studiosi, come il Bosio ad esempio: “ la via Postumia perveniva quindi al corso del Brenta, l’antico Meduacus, da dove ha inizio il lunghissimo rettifilo che, attraverso l’alta pianura del Veneto centrale, raggiunge il Piave ai Ronchi di Maserada, presso Roncadelle, per continuare poi verso Oderzo”. Dopo questa citazione (errata visto che Roncadelle e Maserada sono su due sponde opposte del fiume, ci soccorre il Rosada, che concorda sostanzialmente con il Bosio nel ritenere un errore di calcolo il computo delle miglia sulla Tabula: “passato il Piave (attraversato secondo il Rosada ai Ronchi di Maserada), la strada continua con buona evidenza sul terreno fino a Roncadelle e Faè a sud ovest di Oderzo”. Ho sottolineato la frase “…fino a Roncadelle” perché essa significa che già da prima di entrare nella frazione ormellese il tracciato della Postumia è evidente, e noi sappiamo, che prima di entrare a Roncadelle arrivando dal grande fiume, c’è proprio il Madorbo. Ma com’era esso all’epoca? Con certezza, ormai lo abbiamo visto tutti concordano nell’individuare in questa zona il guado che collegava i due tratti della Postumia romana, ma ancora non sappiamo com’erano questi luoghi nel periodo della costruzione della strada. Secondo Jacopo Bonetto, la strada fu portata a “ raggiungere e guadare i due principali fiumi, Brenta e piave, in punti strategici del loro corso, dove l’alveo ancor oggi, perde la sua fisionomia a bracci anastomizzati e le acque si riuniscono in un unico braccio che mantiene ancora una modesta profondità”, e ritenendo che questa fosse la situazione del tratto plavense tra Candelù e il Madorbo, propone il tracciato, che la Regione Veneto con la legge-vincolo 8 agosto 1985 n. 431, ha vincolato in quanto il tratto dell’attuale strada provinciale ricalca il tracciato dell’an-tica Postumia dal guado del Madorbo alla località Tre Piere di Oderzo, e più precisamente dal “tratto Fornace di Calce-Ponte Tre Piere (cioè dalla fornace Bortot al ponticello che segnala l’ingresso in Faè arrivando costeggiando la Bidoggia). Il percorso è testimoniato dalla strada provinciale nel tratto Fornace di Calce-C.S. Sirnone e dal letto del canale Bidoggia nel tratto C.S. Sirnone fino al Ponte Tre Piere.” Il tracciato appena descritto, lo si può vedere nella figura che segue, con le doppie frecce a indicare il punto di passaggio del traghetto:
La Postumia e il guado del Madorbo Presso la Piave, a poca distanza dal guado del Madorbo, i Romani istituirono una stazione militare attrezzata per il cambio dei cavalli ed il rifornimento dei viaggiatori, ovvero in gergo romano, uno “stabulum”. Simili postazioni erano disseminate ovunque lungo le grandi vie di comunicazione, e in particolare in prossimità degli attraversamenti fluviali, chiamate anche con il nome di “Mansiones” (singolare Mansio) o “Mutationes” (singolare Mutatio), ed erano dotate di tutte le cose necessarie a soldati, cittadini e funzionari governativi per rifocillarsi e riposarsi dopo un lungo viaggio. Vi erano taverne per dormire e mangiare, spesso anche piccoli mercati di prodotti locali, e quello di Stabiuzzo in particolare, almeno sino alla terribile alluvione del 1313, era secondo per importanza solo a quello di Oderzo. Stabiuzzo nacque anche come presidio militare, costruito come tanti altri presso il guado di fiumi o gli attraversamenti di valichi montani, per prevenire le invasioni barbariche. A ridosso del guado, nell’odierno Borgo Madorbo, dovette sorgere dunque in parallelo alla costruzione della Postumia, una stazione militare dedita al controllo del guado e allo smistamento e trasmissione della posta. Ho già detto dei ritrovamenti lignei compiuti dal signor Gaiotto nel 1990, e di come lo stesso li abbia conservati intatti per tutto questo tempo, con grande senso civico e amore per la storia della propria terra. Essi sono di una importanza sensazionale per l’archeologia del posto, soprattutto per la disposizione che avevano all’epoca del rinvenimento. I due tronchi più lunghi erano disposti orizzontalmente alla banchina, e quelli più corti vi erano sovrapposti perpendicolarmente, quasi a formare una grata. Sopra a questi ultimi erano inchiodate delle lunghe assi in orizzontale, a loro volta fissate da altre assi più corte poste in verticale; ciò che le univa erano dei chiodi in legno, tutt’ora conservati e ancora incastonati nei pali che il signor Gaiotto conserva dal giorno della sua scoperta. Dai recentissimi sopraluoghi effettuati da esperti archeologi della Soprintendenza ai Beni archeologici della Regione Veneto e del Nausica, pare che questi resti lignei fossero il punto d’attracco di un traghetto, quel traghetto la cui esistenza è sottolineata anche dalle cronache romane, e che rimase attivo sino al boom economico; una tradizione di oltre duemila anni.
Il traghetto trasportava da una parte all’altra della Piave merci e persone (soprattutto militari), ed erano condotti da persone che le cronache medioevali locali ricordano col nome di “Passatori” .
Le tariffe dei Passatori andavano dai due denari per il passaggio di una persona ai sei per quello di un cavallo, mentre funzionari governativi e militari erano esentati dalla tassa di passaggio. Dal traghetto del Madorbo dunque, ripartiva la Postumia in direzione Oderzo, attraversando Stabulum, dove “si trovavano tutte le cose necessarie alle legioni, agli imperatori, ai cittadini che viaggiavano (…) vi erano buoi, muli, somari, vetture e carri d’ogni sorta. Ufficiali vigilavano sulle truppe dei postiglioni, dei vetturali, dei servi e degli schiavi. Vi dimorava stabilmente un decurione”. La fondazione di Stablucium e del passo barca del Madorbo devono dunque ritenersi, per i motivi sino a qui affrontati, di matrice romana.
Origini del nome Risalire alle origini del nome della nostra località non è affatto facile, e le conclusioni alle quali si può arrivare si prestano a essere smentite alla luce di nuovi ritrovamenti o fonti. Tuttavia qualche considerazione attorno al “Madorbo” può essere fatta in tale sede. Per avere una base di partenza, dobbiamo partire dalla laguna, ove esiste un’isola oggi nota con il nome di Mazzorbo. La prima considerazione è di natura linguistica, data dall’uso della “z” nella Destra Piave e in laguna in loco della “d” nella Sinistra Piave; quindi la denominazione in origine, forse latina, poteva essere la stessa, poi evolutasi in Mazorbo in laguna e Madorbo da noi. L’isola di Mazzorbo è assieme a Murano, Burano, Torcello, Costanziaco e Amiano, una delle sei isole colonizzate dagli altinati al tempo della distruzione della città per mano di Attila (452 d. C. ?). Giovanni Bonifacio però ricorda come gli Altinati chiamarono le sei isolette disabitate con gli stessi nomi dei sei sestieri della città di Altino. Carrer e Carnelos nel loro testo sulla storia di Ormelle scrivono: “La località Madorbo, posta fra Roncadelle e Stabiuzzo, ha un toponimo molto interessante, in quanto deriva da Major urbi cioè centro principale o incrocio che portava al centro di San Maurizio di Stablucio” (ovvero l’antica chiesetta, travolta dall’alluvione del 1313). La cosa interessante da notare riguardo questa teoria, sono i diversi nomi con i quali nel corso del tempo fu chiamata l’isola di Mazzorbo nelle fonti storiografiche: “Maedium Urbis”, “Maiurbo”, “Mazorbo”. Ho però già ricordato come l’isola fosse stata battezzata con il nome di uno dei sei sestieri della città di Altino e, così dicono le cronache e le scoperte archeologiche le stanno piano piano confermando, sei erano anche le porte che conducevano alla città, sovrastate da altrettante torri (quindi erano torri che fungevano da torre di osservazione si può supporre). Una delle porte di Altino, la Maedium Urbis appunto, era sita a nord-est e rappresentava uno degli estremi del kardines della città. Il significato latino di “Medium” (Maedium si trova nelle cronache medioevali, ma il latino è “medium”), non significa semplice-mente “medio”, bensì, nell’accezione di aggettivo, medius, a, um: centrale, nel mezzo, come sostantivo neutro, medium, ii: il centro, il mezzo. Urbs, is, inoltre, non era semplicemente città, ma città con le mura: “Medium Urbis” o “Maedium Urbis”, sarebbe quindi la “al centro della città murata”. Nel caso altinate, Altino era una città murata, la porta di “Medium urbis” doveva essere la porta di ingresso al centro della città e sottolineava ai viaggiatori l’ingresso nel territorio della città, non nella città vera e propria. Oderzo, come Altino, era anch’essa dotata di mura, e anche nel suo caso, maedium urbis era posta all’estremità del kardines maximus della centuriazione, particolare che riflette in pieno la situazione della città di Altino. Dato che sul Madorbo esisteva inoltre il passo barca per attraversare il fiume e ricongiungersi con la Postumia antica, è presumibile che l’insediamento madorbino fosse stato battezzato “Medium Urbis” in quanto era una borgata che si trovava sulla strada che si dirigeva “al centro della città”. Forse, ma questo potrebbe essere un azzardo, anche qui nel Madorbo esisteva una porta come ad Altino, che non sottolineava l’ingresso in Oderzo, ma soltanto l’entrata nel territorio degli opitergini, e che doveva essere sorvegliata da una postazione militare stabile, che regolasse il flusso di genti e merci che attraversavano il fiume nella nostra località. Bisogna sempre tenere presente infatti, come solo i centri principali avessere un nome, tutto attorno vi era l’immensa campagna centuriata dove si distinguevano delle attività che poi daranno il nome all’intero luogo; stalla, stabulum divenne Stabiuzzo, Medium Urbis, o Maedium Urbis, Madorbo.
La Guerra Gotica nell’Opitergino In questa sede purtroppo non potranno essere affrontate le diverse tappe della guerra gotica, e dovremo limitarci quindi a seguire le vicende che riguardano l’opitergino durante quel turbinoso perio-do. “I Franchi avevano infatti approfittato a proprio vantaggio delle difficoltà degli altri contendenti e senza colpo ferire si erano impadroniti delle terre che costoro si stavano disputando. Cosicché ai Goti erano rimaste solo poche fortezze nel Veneto e ai Romani le città costiere; tutto il rimanente lo avevano preso in loro possesso i Franchi. E mentre i Romani e i Goti continuavano a battersi tra di loro nella guerra che ho fin qui descritta, senza possibilità di affrontare, in aggiunta, altri avversari, i Franchi erano venuti a trattative coi Goti e avevano concordato che, fino a quando i Goti avessero dovuto seguitare la guerra con i Romani, sarebbero rimasti in pace fra loro, tenendosi ciascuno le proprie conquiste, e non si sarebbero fatti guerra l’un l’altro.” Incerto sul da farsi, Narsete chiese consiglio agli italici, e qualcuno gli fece notare che: “se anche i Franchi avessero consentito il passaggio, non avrebbero avuto in alcun modo la possibilità di arrivare fino a Ravenna ma soltanto di percorrere quella via al massimo fino a Verona. Dicevano infatti che Totila aveva scelto le truppe più valorose dell’esercito goto, mettendo a capo di queste il goto Teia, uomo di straordinarie capacità militari, e lo aveva inviato nella città di Verona, soggetta ai Goti, per impedire in qualunque modo all’esercito romano di passare.” Ma Totila sapeva anche che per i Romani sarebbe stato impos-sibile passare lungo la costa ionica, a causa della impercorribilità dei fiumi (fra i quali la Piave), ed era a conoscenza che i Romani non avevano navi a sufficienza per trasbordare, e che se essi avessero provato ad attraversare pochi alla volta lo sbarramento acqueo, sarebbe stato molto facile sconfiggerli. “Mentre Narsete si trovava in grandi difficoltà, Giovanni figlio di Vitaliano, che era pratico di quei luoghi, gli suggerì di procedere con tutto l’esercito lungo la costa dove le popolazioni, come si è detto prima, erano soggette ai Romani e di farsi seguire da alcune navi e molte imbarcazioni. Ogni volta, infatti, che l’esercito fosse giunto alle foci dei fiumi avrebbero potuto fare un ponte con queste imbarcazioni disponendole sul letto dei fiumi e facilmente e senza sforzo sarebbe stato possibile fare la trasversata. (…) Narsete gli diede ascolto e, in questo modo, con tutto l’esercito giunse a Ravenna.” Ma vediamo il nostro territorio: Treviso in un imprecisato periodo dell’anno 552 era sicuramente bizantina: infatti, quando Totila (Baduila) morì nello stesso anno a Gualdo Tadino vinto in batta-glia da Narsete, il suo successore Teia mosse da Verona per attaccare e conquistare Treviso, e poi l’Opitergino prima di dirigersi a sud. Questo fatto può suggerirci due cose:
- 1) non tutto l’esercito di Narsete dovette dirigersi a Raven-na, ma un distaccamento, anche piccolo, probabilmente venne inviato con una manovra diversiva su Treviso, pas-sando attraverso l’Opitergino, che si può presumere fece atto di sottomissione all’Impero, o forse ne era soggetto.
- 2) Questo manipolo avrebbe poi potuto guadare il fiume in corrispondenza del passo del Madorbo, e quindi assediare Treviso, costringendo le truppe di Teia a dirigersi nella Marca anziché in aiuto del fratello Totila a Ravenna.
E quest’ultima ipotesi sembra essere avvalorata da Giovanni Bonifacio nella sua pionieristica opera: “…Narsete informato divife il fuo Efercito in due parti: nell’una erano i Longobardi, del cui valore giuftamente molto promettendofi, gli inviò in quefta Marca Trivigiana contra Teja, e poi anche contra Totila, acciocchè da effi occupati, potefse in tanto Narsete comodamente venir più oltre, e pafsare i fiumi fenza alcuno impedimento: il che tanto più gli fu facile a fare, quanto ch’ei trovò l’acque, il mefe di Luglio, molto picciole”. Ma vediamo di fare un po’ d’ordine: i Bizantini, probabilmente presso la costa di Aquileia, hanno scisso in due parti l’esercito, ed inviato i Longobardi nella Marca facendo loro percorrere la Postumia, che collegava appunto Aquileia a Verona, ed era l’unica
strada che i Goti non distrussero proprio perché portava i Bizantini direttamente in bocca a Teia, che si trovava a Verona, mentre il resto puntò Ravenna percorrendo l’itinerario lagunare. Sconfitto Totila, il fratello Teia divenuto re dei Goti attacca Treviso e l’Opitergino; questo ci fa capire che i due territori erano caduti in mano nemica, e che la successione delle conquiste dovette essere questa: prima l’agro opitergino, e poi, guadato il fiume, la città di Treviso. Come detto, la Postumia era una delle poche vie rimaste in funzione durante l’era post-romana, tragitto preferito dalle orde barbariche che invade-vano le nostre terre. Al termine di quest’antica via c’è Aquileia; i Longobardi mercenari di Narsete dovettero percorrere la Postumia sino a Oderzo, e poi sino al fiume, dove trovarono i resti di un passo barca caduto in disuso. Essi allora, per attraversare la Piave, adottarono uno stratagemma singolare: ripararono o ricostruirono il punto d’approdo per il traghetto utilizzando dei chiodi in legno; sto ovviamente parlando dei resti lignei rinvenuti dal signor Gino Gaiotto in prossimità del guado.
L’ipotesi è verosimile per due motivi:
1) azioni diversive di questo tipo erano all’ordine del giorno nel modo di agire dei generali bizantini;
2) e più importante, quando si trattava di organizzare lunghe campagne militari, nessuno batteva gli eredi di Roma in quanto ad organizzazione. In particolare, essi solevano dotarsi di chiodi in legno per realizzare infrastrutture su terreni paludosi o ricchi d’acqua per due motivi: erano più leggeri del ferro, e quindi più facilmente trasportabili, ma soprattutto, a differenza del ferro, non arrugginivano.
Giorgio Ravegnani, uno dei maggiori bizantinisti d’Italia, che la pensa sostanzialmente allo stesso modo. Comunque, nel 553 con la morte di Teia, terminò la guerra gotica, e i Bizantini poterono così rientrare in possesso di buona parte d’Italia e anche dell’Opitergino, che è la zona che a noi più interessa in questa ricerca. Il guado nella storia Il corso della Piave rappresentava un ostacolo e una risorsa per i mercanti del Veneto, al tempo stesso via di comunicazione per gli zattieri e barriera insormontabile per le carovane. I passi barca nacquero proprio per questo: evitare lunghe e costose deviazioni verso i pochi ponti stabili; ma chi voleva passare doveva pagare un pedaggio al conduttore, ai nautae Plavis, cioè ai “traghettatori”. Il passo del Madorbo era un passo a barca semplice si trovava ancora segnato nelle mappe di fine Ottocento, proprio presso il sito, nei campi della famiglia Menegaldo, nel quale è stata rinvenuta una scalinata in pietra nell’argine vecchio, che nella mappa del Comune di Cimadolmo rilevata dal 15 maggio al 30 giugno 1891 e disegnata dal 20 gennaio al 15 febbraio 1892 dall’Ing. Arnaldo Capelli in scala 1 : 20000, è ancora segnato con la denominazione appunto di “passo”, con un piccolo quadratino a fianco a segnalare l’idrometro.
Da questi reperti si deve infine presumere, che l’antico abitato della Medium Urbis romana fosse alle spalle di questa scalinata rinvenuta sui campi della famiglia Menegaldo, nell’ampia zona coltivata che si estende dietro l’argine risistemato dagli Alpini alla fine della Grande Guerra. L’idrometro Con il nuovo ritorno dell’Austria (1815) al governo del Veneto, oltre al problema fluviale emerse anche quello della crisi agricola... “le penose condizioni esistenziali dei contadini poveri del Veneto potevano attenuarsi specialmente lungo i principali corridoi rivieraschi, dove i frequenti appalti per l’esecuzione di lavori idraulici costituivano importanti occasioni di impiego per i braccianti delle vicine campagne”. Una novità da loro introdotta fu l’installazione di 12 idrometri lungo il corso della Piave, dei quali 7 detti “principali” poichè misuravano ogni giorno a mezzogiorno il livello dell’acqua e ogni ora durante le piene, e 5 “secondari” perchè svolgevano solamente le misurazioni di piena. Uno di questi idrometri secondari fu posto a Stabiuzzo, ed era costituito da “gradinate di pietra sulle cui paladiane sono segnate le altezze”.
Le “gradinate di pietra” dell’idrometro sono state, sino a epoche davvero recentissime (lo feci anch’io) usate come scivoli da generazioni e generazioni di bambini vissuti nel Madorbo; si trovano sull’argine presso i campi di vite della famiglia Menegaldo, un reperto storico che indica non solo la straordinaria importanza del sito, ma che ci fornisce anche una ulteriore conferma “territoriale”: in questo periodo (1828) il Madorbo è sicuramente parte di Stabiuzzo e quindi del Comune di Cimadolmo. Distava 13800 metri dall’idrometro precedente, quello di Ponte della Priula, e 49200 metri dalla foce del fiume, con la quota idrometrica dello 0 posta a 19 metri sul livello del mare, ovvero all’altezza del 1,40 (un metro e 40 centimetri) e fu realizzato presso gli speroni. La realizzazione degli speroni migliorò così tanto la situazione del Madorbo, che il passo barca cominciò a essere riutilizzato, tanto che lo si trova indicato nelle mappe già a partire dal 1841, proprio presso l’idrometro, nel sito in cui è stata rinvenuta quella piccola scalinata…
La trincea “Costruita nel 1917 era larga 4 m e lunga altri 4, con una altezza di 2. Presentava postazioni di sparo, armata con mortaio e obice. I tedeschi l’avevano coperta di terra per nasconderla agli aerei e l’unico ingresso dava sulla strada che conduceva al guado del Traghetto. Questa strada era sorvegliata giorno e notte, ed era protetta da un’altra postazione trincerata posizionata presso il Traghetto, dove si trovava anche il cimitero tedesco; entrambe finiranno però distrutte dai bombardamenti durante l’attraversata italo-inglese (e i resti del campo santo furono portati a Candelù). Anche questa trincea aveva le stesse misure della precedente: quadrata, la porta sulla strada, costruita con l’ausilio di ferri avvitati nel terreno per reggere i reticolati a protezione della stessa, ricoperta poi di terra in modo che la bomba cadendo facesse meno danni (con questo espediente infatti molte di queste non esplodevano), con un tetto in cemento armato spesso 1 m rinforzato con ferri lunghi 20 cm inseriti a forma di reticolato nel cemento stesso.
In questa postazione c’erano una mitragliatrice e 5/6 uomini a guardia, ma erano entrambe importantissime per i Tedeschi, poiché sorvegliavano la via che portava al punto da loro prescelto per attraversare; questo era infatti per loro il fronte principale, mentre gli Italiani che intendevano sfondare presso le Grave di Papadopoli verso cui rivolgeva l’artiglieria, non se ne curavano. Presso il passo del Traghetto i Tedeschi avevano addirittura preparato un ponte in ferro con le barche, ma la piena improvvisa dell’ottobre 1918 li coglierà di sorpresa affogandoli durante la traversata, dando il via libera all’offensiva inglese e italiana sulle Grave di Papadopoli”. Più volte infatti gli Austro ungherese tentarono di attraversare il guado del Madorbo per attaccare le nostre linee, ma sempre con risultati fallimentari. Vediamo in dettaglio come la traversata del guado del Madorbo fu raccontata dal Capo di Stato Maggiore Vaccari: “57° divisione = Il IV/57, era accantonato a Roncadelle, di rincalzo al I/57 che tiene tratto di fronte da casa Faganello e fosso Ramon, ed ebbe l’ordine di passare il fiume e di attaccare decisamente la nostra linea sulla destra del fiume e di stabilirvisi. Il ramo orientale del Piave fu passato dal battaglione su barconi ed a guado; raccoltesi le compagnie in un isolotto entrarono nel ramo occidentale del fiume, per guadarlo, essendo stato detto ai soldati che l’acqua non superava i 50 cm. di profondità, ma la truppa si trovò nell’acqua fino alla gola ed alcuni uomini si sommersero del tutto. Molti furono travolti dalla corrente, rapida in quel punto; altri, procedendo a stento furono decimati dal fuoco nutrito delle nostre mitragliatrici (...) nel primo sommario interrogatorio si sono raccolte le seguenti informazioni: (...) Il 92° giunse ieri sera sul Piave con l’ordine di passare il fiume, di attaccare a fondo la nostra linea, e di penetrarvi profondamente, mantenendovisi. Accerchiato e preso sotto il fuoco delle fanterie e dell’artiglieria il 92° ha subito perdite rilevantissime in morti e feriti. Fra i morti vi sarebbero numerosi ufficiali”. Ma nonostante il fallito tentativo, il fronte del Madorbo continuò a rimanere centrale per l’esercito austro ungarico. Stante la necessità di conquistare delle teste di ponte sulla sponda destra della Piave, Boroevic von Bojna organizzò l’Isonzo Armee, così chiamata perché composta dalla stessa formazione che aveva difeso l’Isonzo prima di Caporetto, mettendola ai comandi del generale Von Wurm. Questa era costituita di quattro corpi d’armata: il XVI Corpo che includeva la brigata Landsturm presidiava da zona da Marcatelli a Casa Tonon, la 33° Divisione da Casa Tonon a Cimadolmo, la 58° Divisione Schutzen da Cimadolmo a Stabiuzzo e il IV Corpo d’armata, che comprendeva la 64° Divisione Honvèd (la milizia mobile ungherese) dal Madorbo a Casa Concie (Negrisia, oggi esiste una via che porta
questo nome). Con questo schiera-mento di truppe nel nostro territorio, l’Austria Ungheria cominciò, il 15 giu-gno 1918, la battaglia del Solstizio, ma l’attacco alla linea italiana di Candelù preparato per il 19, fu sventato dallo scorrere impetuoso della Piave in piena, che travolse ponti, passerelle e quanti stavano attraversando, a causa di un aumento improvviso del livello dell’acqua di oltre 90 cm.
Cominciò a piovere a dirotto… il livello dell’acqua salì di 70 cm, impossibili costruire altri ponti, quelli che c’erano il18 giugno erano già spazzati via, “l’acqua è salita di 3,90 metri al secondo”, recita un comunicato austriaco della sera del 17 giugno. Senza rifornimenti e rinforzi, la testa di ponte di Candelù venne presto circondata e smantellata dagli Italiani, mentre a Fagarè gli austroungheresi, bombardati dagli Italiani, ripiegarono in fretta e furia nella notte fra il 23 e il 24 … il Piave aveva mormorato… Quello fu l’ultimo tentativo di sfondamento austriaco, e pronta fu la risposta dell’esercito italiano nei mesi successivi, anche se qui vedremo solo l’organizzazione dell’attacco alla linea del Madorbo.
Gli Italiani, così come gli Austriaci prima, avevano bisogno di assicurarsi diverse teste di ponte per compiere la traversata. Tra Salettuol e Candelù era di stanza la X° Armata, che avrebbe avuto il compito di costituire una testa di ponte tra Roncadelle e Tezze, e come punto di attacco fu scelta Cimadolmo; l’attacco vero e proprio alle linee nemiche cominciò la mattina del 24, e l’armata di Lord Cavan penetrò facilmente nelle Grave istituendo una solida testa di ponte il 27 e cominciando l’attacco a Oderzo il 28, portando la linea della X° Armata sulla Livenza. Mentre tutto questo stava accadendo, una testa di ponte di un altro reparto della X° Armata si era andato costituendo fra il Madorbo e Stabiuzzo, consentendo il passaggio del XVIII° Corpo della riserva d’Arma-ta, mandato da Caviglia all’attacco di Conegliano, perché, sempre nella mattinata del 28 ottobre, una vittoria del battaglione d’assalto della 64° divisione Honvèd nei pressi della zona del Madorbo che ancora resisteva sul fiume impedendo l’ingresso a Roncadelle, rischiava di causare una strozzatura della testa di ponte inglese. Il contrattacco austroungherese fu così contenuto, e poté partire l’assalto anglo-italiano alla linea del Monticano, fase conclusiva della tragica eredità lasciata in queste terre dalla Grande Guerra. Dopo la cessazione delle ostilità conseguente all’Armistizio del 4 novembre 1918, si pose per le autorità civili e militari anche il grave problema della riparazione e del ripristino delle arginature dei fiumi veneti e friulani, gravemente danneggiati dai bombarda-menti e dagli scavi.
Il Governo investì del problema i vertici dell’Esercito, che incaricarono il Comando Generale del Genio, di condurre il Progetto di ricostruzione in accordo con il Reale Magistrato delle acque. Battaglioni del Genio e della Fanteria coadiuvati da tecnici e da centinaia di prigionieri di guerra, cominciarono i lavori all’inizio del dicembre 1918. Lungo il corso del fiume Piave furono aperti 14 cantieri, 7 in riva destra, Nervesa, Spresiano, Candelù, Saletto, Zenson, Fossalta, Passerella, 7 in riva sinistra, Susegana, Cimadolmo, Roncadelle, Ponte di Piave, Noventa, San Donà, Grisolera. Ogni cantiere aveva il compito di ricostruire circa 6 km di argini. Il lavoro iniziale fu essenzialmente di bonifica: rimozione del materiale bellico, fra cui molte bombe inesplose, del legname, di rottami d’ogni sorta e dei morti sepolti e insepolti. I cunicoli scavati negli argini vennero richiusi, le trincee smantellate così come le varie baracche e ripari di fortuna similari, ripristinate le murature e i terrapieni. Il Comando Supremo decise allora di assegnare al Comando Generale del Genio della 80° Divisione alpina, che aveva i suoi battaglioni ancora radunati a sud del Grappa, il compito della ricostruzione. La Divisione, al comando del Maggiore Generale Lorenzo Barco, ricevette il compito del ripristino totale del tratto arginale in riva sinistra da Cimadolmo a Ponte di Piave e da Salgareda a Cà Gonfo Mussetta, oltre 23 km di argina-tura da rifare, senza contare che poi a questi lavoratori sarebbero spettati anche la ricostruzione di ponti e strade, nonché di fabbricati privati e pubblici. Il Maggiore Generale Barco ripartì la responsabilità dei lavori tra due unità: l’VIII Raggruppamento Alpino (6° Gruppo Alpino: Battaglioni Aosta, M. Levanna, Val Toce e rispettive compagnie mitragliatrici e 13° Gruppo Alpino: Battaglioni Pieve di Cadore, M. Antelao, Val Cismon, con rispettive compagnie mitragliatrici) avrebbe ricostruito i 10,767 km di argine da Cimadolmo a Ponte di Piave, il IX Raggruppamento Alpino (17° e 20° Gruppi Alpini) operò sui 12 km dell’argine Salgareda-Cà Gonfo Mussetta. All’VIII Raggruppamento Alpino fu assegnato un capitano del Genio per la vigilanza e la consulenza tecnica. I lavori cominciarono il 4 febbraio 1919 e alla fine di aprile tutti gli argini di competenza della Divisione Alpina furono terminati. L’argine del Madorbo tuttavia, fu ripartito a metà; infatti esso si biforca proprio all’inizio della frazione nel tratto ora di Via Argine e la parte costeggiante il fiume fu riparata dagli Alpini, l’altra invece, quella che scende (oggi è una strada) verso Roncadelle per una lunghezza totale di 4 km e mezzo, terminando in via Saletto, fu l’ultimo argine a essere riparato e i lavori furono svolti dal 3° Ufficio Staccato Lavori, che era dipendente direttamente dal Genio Civile. L’argine del Madorbo sappiamo anche con certezza quando fu concluso: il 4 aprile 1919, come si legge nell’iscrizione alla base della paladiana di destra dell’idrometro austriaco. L’iscrizione recita così: Caporale Venier Luigi 4.4.1919 Non sappiamo ancora chi fosse questo Luigi Venier ma doveva essere un Alpino del Battaglione Val Cismon, che era di stanza a Ormelle e aveva in carico i lavori sul tratto arginale del Ma-dorbo. A capo del Battaglione c’era il Tenente Colonnello Ferruccio Pisoni, e il Venier poteva appartenere a una delle 4 compagnie del Battaglione: la 264°, la 265° o la 277° Compagnia Alpini, o la 1635° Compagnia Mitragliatrici. La fornace Bortot La fornace fu costruita da Davide Morandi e altri due soci, Carrer e Bontempi da Tempio, dopodiché, liquidati questi ultimi, l’unico proprietario della fornace rimase Davide Morandi. Il muratore che diresse i lavori fu Cleanto Sartor di Roncadelle, che eresse la fornace presso le fondamenta di un’ antica “calchera”, ovvero una fornace da calce “preistorica”. Durante il ventennio fascista, presso la fornace, nello spiazzo compreso fra la costruzione e l’argine, fu istituito nel 1929 -1930 il “campo solare”; vennero cioè costruite alcune baracche presso il boschetto, nelle quali i ragazzi e le ragazze del Comune di Ormelle venivano ospitati durante l’estate quando si recavano al fiume per prendere il sole e l’aria. La fornace che ancora oggi possiamo vedere, diversamente dalla calchera, fu costruita in muratura spessa circa un metro e mezzo e
rivestita internamente in pietra refrattaria; la peculiarità di questa pietra è di resistere alle temperature di cottura della calce (circa 1000° C); per raggiungere questa temperatura, nel 1920 venivano utilizzati ceppi di legno secchi tagliati a pezzi (radici estratte perlopiù dai fossi) e introdotti nelle “fornacette” (spazio ricavato per contenere il solo combustibile). La fiamma poi passava negli spazi fra i ciottoli contenuti all’interno del forno; in questo modo nel carbonato di calcio, cioè nel sasso, l’ossido di calcio contenuto si separava per mezzo del calore dall’anidride carbonica che fuoriusciva dal camino sotto forma di fumo; l’ossido di calcio è la calce viva, che ha perso il 46% del suo peso iniziale: 100 Kg di carbonato di calcio (sasso) – 46 kg di anidride carbonica = 54 kg di calce cotta. Il calore era la base del processo. La calce era tolta dal forno a mano tre volte al giorno, e ogni mezz’ora il forno era caricato di combustibile. Ogni otto ore si estraeva la calce e la produzione giornaliera era all’incirca di 35 quintali di calce viva negli anni ’30.
Nel 1964 la fornace fu riattivata dalla famiglia Bortot, dopo che era rimasta spenta per vent’anni. Non c’era la corrente elettrica, perciò la lavorazione era interamente condotta a mano, e l’illuminazione notturna era fornita da una lampada a petrolio. Anche l’argano era manovrato a mano, la calce era gettata nel forno ed estratta a mano coi badili. Nello stesso anno fu anche costruita una specie di “casetta” che sarebbe poi servita per contenere gli apparecchi per l’elettricità, ma soprattutto come spogliatoio per gli operai. In quegli anni cambiò anche il metodo di produzione, poiché la legna fu sostituita dalla segatura come combustibile; questo permise un aumento della produzione dai 35 ai 42 quintali al giorno, anche se questa era umida oppure di segheria. Per cuocere un quintale di calce servivano 50 kg di segatura e per 40 q di calce, che era la produzione giornaliera, servivano almeno 20 q di segatura. Al giorno d’oggi bastano solo 20 kg per ottenere 1 q. di calce. Il risultato del processo era denominato “calce a bassa reattività idonea per l’edilizia”, e il residuo della combustione erano una o due carriole di cenere al giorno; non esistevano i problemi ambientali, all’epoca la grande preoccupazione era quella di dare lavoro alla gente che ne aveva bisogno. Nella fornace lavoravano due persone al caricamento del forno, cinque alla produzione, un impiegato che in realtà era il proprietario stesso, più gli operai addetti a procurare i sassi e a raccogliere la calce. I carrettieri della fornace Bortot erano i Menegaldo già citati prima, soprattutto Antonio, che con due cavalli caricava 40-50 q. di ghiaia alla volta. La ghiaia pesa circa dai 16 ai 22 q. al metro cubo, e si utilizzava un rimorchio da 1,80-2 m di larghezza e 4 di lunghezza, con spondine di 30-40 cm.
Per il carico e lo scarico dei ciottoli si utilizzava una forca a mano da otto denti, così come per il caricamento su carriola e sul carrello della fornace; con essa si setacciava il sasso puro e se ne caricava una buona quantità, mentre la sabbia e la ghiaia fina cadevano. I carri venivano caricati sia con ghiaia grossa che con ghiaia fina, poiché ogni dimensione di inerte aveva il suo uso nell’edilizia. Si usavano cavalli rossi, bianchi o neri, non di razza piave perché essa non era razza da tiro; infatti essi avevano una grande forza, e qualcuno li usava per il trotto perché avevano una resistenza incredibile, ma il loro difetto era la difficoltà ad addomesticarli; bisognava fare anche molta attenzione a star loro vicino perché scalciavano e mordevano. Le strade di allora non erano asfaltate: il trasporto della calce continuò a essere effettuato coi carri a cavallo fino agli anni quaranta, quando subentrarono i camion.
Negli anni ‘60 c’erano sette giorni la settimana di lavoro, e il fuochista era sempre presente: lavorava otto ore al giorno per 60000£ al mese. Inoltre nella fornace c’era sempre una persona, tanto che essa era diventata un punto di ritrovo nel dopo lavoro, per scaldarsi d’inverno, ma anche uno svago alternativo all’osteria senza spendere soldi, un luogo di scambio di esperienze e opinioni, in cui si ascoltavano i racconti dei viaggi dei carioti. Le cosiddette “public relation” erano un saluto, una pacca sulle spalle, un’ombra in osteria, e l’ultimo viaggio del carrettiere alla sera era spesso e volentieri la tappa obbligata dal maniscalco che curava gli zoccoli dei cavalli, mentre il cariota raccontava ai bambini i posti che aveva visto durante il viaggio.
Negli anni ’70 trovare manodopera divenne sempre più difficile, poiché molti snobbavano i lavori faticosi e la soluzione fu la tecnologizzazione dei forni e degli impianti, realizzata in pochissimi anni; un atto necessario per continuare a produrre e garantire lavoro ai dipendenti dell’azienda, attraverso l’acquisizione di mezzi di trasporto e la meccanizzazione del forno, che ha permesso di tramutare il lavoro umano in un lavoro di controllo e supervisione delle macchine. Ma la fornace del Madorbo fu chiusa, perché ormai non era più possibile riuscire a pareggiare costi e ricavi.
I Menegaldo Lontane e antiche sono le testimonianze relative a questa famiglia di origine barbarica, franca o più probabilmente longobarda. Il cognome Menegaldo infatti, risulta essere un alterato di MENEGO, ipocoristico veneto per “Domenico” più il suffisso “– aldo” , che in antico germanico “vald” significava “regnare”. “Domenico” (Menico) si trova come nome diffuso dal IV sec., con il quale si solevano battezzare i figli nati la domenica. Esso si affermò poi nel corso del 1200; deriva da “dominus” ovvero “padrone”, in latino. Il suffisso “– aldo”, deriva (come il nome) da “walda” che significa “potere, comando” o meglio (“che ha il potere, che esercita il comando”) nella lingua longobarda e franca. Quindi, da tale fusione, risulterebbe “domenico che esercita il comando”. A questo proposito va ricordato che Carlo Magno durante la sua dominazione, aveva istituito i “missi dominici” (messi del signore, da “dominus”), funzionari statali attraverso i quali il sovrano controllava l’amministrazione dell’Impero. Questi erano un conte e un vescovo, che ricevevano ogni primavera l’incarico (legatio) dal sovrano di recarsi in una circoscrizione formata da varie contee. Nei villaggi da loro toccati riunivano il “mallo” (l’assemblea dei liberi), e avevano il compito di vagliare le lagnanze dei sudditi, giudicare le cause in appello, controllare l’amministrazione dei benefici del re e riferire poi a corte. L’istituto scomparve nel corso del X sec., ma molto probabilmente diverse famiglie di “missi dominici” continuarono a essere identificate con la loro carica, che divenne cognome. “Menegaldo”, o come si trova nelle antiche cronache “Manogald, Managolt, Managold, Manigold, Menegald”. Forse però il cognome esisteva già da prima dei Franchi, e fu portato dai Longobardi o da qualche altra stirpe germanica. Il termine “manigoldo”, da cui deriva il cognome Menegaldo, oggi usato in senso spregiativo, ma che in origine significava “giustiziere, boia, sgherro, sbirro”, derivava a sua volta dall’antichissimo nome proprio germanico “Manogald” o “Managolt”. Questo nome consta due parole: “mennl” cioè “collare” e “walt” trasformato per influenza delle lingue romanze (come il franco) in “gald” o “gold”, e deriva da “walten” cioè “ reggere, disporre, vegliare”, che dà il significato di “colui che regge il collare, l’uomo del collare (inteso come cappio)”, ovvero “boia, carnefice”. A questo proposito si ricordi come tra le funzioni dei “missi dominici” vi era anche quella di giudice nelle cause d’appello, nelle quali potevano decretare anche sentenze di morte, la quale avveniva per l’appunto per impiccagione. “Menegaldo”, diremmo oggi, doveva essere allora il giudice supremo, l’amministratore della giustizia penale. Nelle antiche società tribali germaniche i capi tribù avevano l’ultima parola su tutto, anche sulla vita dei loro accoliti. “Menegaldo” lo si deve quindi derivare dal nome che veniva conferito ai capi tribù, i quali durante la dominazione longobarda divennero dispensatori della giustizia in ogni sua forma, e quindi, anche “boia”, nel senso di “giudice supremo a capo di una moltitudine di uomini dei quali dispone liberamente”. Da qui si può notare la corruzione che subiscono le parole nel tempo. Il cognome “Menegaldo” si lega nel Trevigiano sempre a posizioni di comando, cosa che conferma l’origine dello stesso.
Nel 1216 troviamo un Albertino Menegoldo console a Treviso comporre la pace con i Veneziani a seguito di una gravosa disputa con la città, e nel 1218 lo stesso Albertino, ancora una volta eletto console, riceverà anche l’incarico di riformare gli Statuti della città di Treviso. Nel 1233 il figlio di Albertino, Gione, venne nominato Capitano della milizia della città nella lotta contro Conegliano e nel 1261 Gione fu inviato dai Consoli di Treviso a comporre una lite in merito ai confini a Vicenza e, forse memori delle capacità del padre Albertino, affidarono allo stesso il compito di riscrivere gli Statuti della città assieme a Riccio Azzoni nel 1270. Gione aveva due fratelli: Alberico e Aurerio, da cui nacque un altro Alberico mortò a Candia (Creta) nel 1254 combattendo per Venezia. Il ramo di quest’ultimo si estinse con lui, ma la famiglia si conservò in un altro ramo con il nome di Menegalda. Intorno all’anno 1300 circa, Giovanni Menegoldo cambiò il suo cognome in Menegaldo; egli era figlio di Pietro di Cambri, defunto nel 1229 e il padre di Pietro fu colui che lo storico vicentino Pagliarino ritiene essere stato il primo podestà di Vicenza (1184), e padre anche di Albertino e quindi nonno di Gione, la cui casa, una grande torre dice il Bonifacio, era a Treviso nel quartiere di Sant’Agostino. Giovanni Menegaldo fu podestà di Conegliano “ed Uomo di gran Prudenza, i Menegaldi viventi sono discesi, che hanno per arma (in araldica significa stemma, n.d.a.) due fascie bianche in Campo rosso”. Notizia questa confermata dal Commendatore Crollalanza, che riporta come il cognome comparve proprio grazie a questo atto, e che esso venne poi in tal nomea mantenuto dai discendenti di Giovanni. In araldica, per fascia si intendeva una striscia orizzontale a metà dello scudo, ed era pezza onorevole di prim’ordine, rappresentante il simbolo del cingolo cavalleresco (il cingolo era la cintura che reggeva la spada del cavaliere: chi posse-deva il cingolo nello stemma aveva l’obbligo di portarlo di fronte all’Impera-tore di Germania che, ricordo, era sulla carta il sovrano legittimo del Veneto), il rosso si rappresentava graficamente con linee perpendi-colari ed era simbolo di valore, spargimento di sangue in battaglia, audacia, fortezza, dominio e nobiltà cospicua (era un colore il cui uso veniva permesso solo a principi e cavalieri), mentre il bianco (in realtà era argento, ma in araldica veniva l’argento veniva rappresentato lasciando bianco il campo) indicava speranza, purezza, cortesia e gentilezza, amicizia, equità e innocenza. Nel 1317 Menegaldo Menegaldi venne chiamato a dirimere, con altri saggi, le controversie tra la città di Treviso e Gueccello da Camino, mentre, sommo privilegio, nel 1389 la famiglia Menegaldo fu inserita assieme alle altre famiglie nobiliari, nel “Libro del Collegio dei nobili originari della città di Treviso”, in cui figura accanto ai Collalto, agli Onigo, ai Bomben, ai Rinaldi, agli Ostan ecc... Nel 1603 infine, dopo che il cognome appare più volte nelle liste battesimali di Roncadelle, troviamo un Antonio Menegaldo a capo delle truppe della città di Oderzo.
Arma Menegalda.