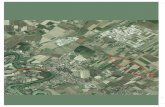CAMBIAMENTI NELL’ARCHITETTURA GIAPPONESE TRA OTTO-NOVECENTO: ORIENTE E OCCIDENTE A DIALOGO
D'arzere in arzere. Cambiamenti del territorio del Piave e tutela degli argini nel periodo veneziano...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of D'arzere in arzere. Cambiamenti del territorio del Piave e tutela degli argini nel periodo veneziano...
1
Simone Menegaldo, D’ARZERE IN ARZERE. Testo dell’intervento tenuto a Maserada sul Piave il 31/03/2012, nell’ambito del convegno IL PIAVE DA PONTE A PONTE A disposizione dell’Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Treviso, 13/07/2012 – Maborbo (TV)
D’ARZERE IN ARZERE
Per affrontare il presente tema, mi è stato suggerito, per non risultare troppo noioso,
l’utilizzo di un robusto repertorio iconografico.
Direi allora di cominciare con questa foto:
Quando noi pensiamo agli argini oggi, siamo abituati a farlo quando li percorriamo,
visto che gli argini principali del fiume Piave sono diventati strade.
La maggior parte degli argini però la troviamo in aperta campagna, dove non tutti
sentiamo la necessità di riflettere sulle mutazioni antropiche portate nei secoli.
Prendiamo l’esempio in questione.
Ci troviamo in località Arzeri a Campodipietra. Il nome della località già da solo
suggerisce la presenza in zona di argini, ma oggi risulta molto difficile pensare che
questo piccolo arginello un tempo fosse “l’arzere grando”.
Il problema è, quanto tempo fa era “l’arzere grando”? che senso ha la costruzione
dell’Arzeron così distante dal fiume Piave (quasi 4 km)? Ecco se ci poniamo queste
domande, significa che stiamo affrontando le cose con il piede sbagliato.
Partiamo dunque con ordine.
2
Questa carta rappresenta i paleo alvei del fiume Piave1 e ci offre un’utile prospettiva
della presenza di risorsa idrica nella pianura trevigiana. Alcuni di questi rami si
estinsero già precedentemente all’insediamento umano stabile in zona, ma come
dimostra la diffusa presenza di rii, fossi e risorgive odierni, l’attuale presenza
sotterranea d’acqua è molto notevole.
1 Tratta da: Aldino Bondesan, I fiumi le lagune il mare: la geomorfologia della pianura, in Il Piave, a cura di Aldino Bondesan, Giovanni Caniato, Francesco Vallerani, Michele Zanetti, Cierre, Caselle di Sommacampagna 2004, p. 80.
3
Andando maggiormente nel dettaglio grazie ai rilievi satellitari, strumento oggi
necessario per l’archeologia, possiamo vedere come la presenza d’acqua sia diffusa in
tutto il bacino Teviso-Oderzo2. Questa è una prima indicazione sui motivi per cui la
Piave non viene menzionata dai Romani sino al Tardo Impero, in quanto essa non
doveva avere un corso unico ma più rami, formanti rigagnoli, lagune, paludi.
2 Paolo Baggio, Sandra Primon, Sotto l’occhio del satellite, in Il Piave, Cierre, Caselle di Sommacampagna 2004, p 84.
4
Nella Tabula di Peutinger (apografo di un originale del 222 d. C.), vediamo infatti
raffigurati tutti i fiumi meno la Piave. C’è il Meduacum (Brenta), la Licenna
(Livenza), non la Piave. Ma soprattutto la Tabula, che raffigura l’intero dominio
romano, riporta in qualsiasi tratto l’esatta distanza tra località e località. In un solo
caso la misura non è corretta, ovvero nel tratto Vicetia-Opitergium, dove la Tabula
segna XXXIII miglia romane (50 km) anziché LIII (80 km). Posibile che nella sua
perfezione , la Tabula riporti un errore così grossolano proprio nel nostro territorio?
Che il territorio romano sia riportato con estrema perizia e proprio qui i cartografi
sbagliassero il computo delle distanze e dimenticassero anche di segnale il fiume
Piave? O c’è dell’altro?
Il più importante studioso della romanità veneta, Luciano Bosio, liquidò tale discrasia
come un banalissimo errore di calcolo, ma se avesse avuto anch’egli la disponibilità
degli strumenti di ricerca più recenti, sono certo che avrebbe compreso che tale non
era3.
3 Per tutti questi aspetti riguardanti la zona, vedi Simone Menegaldo, Medium Urbis. Duemila anni di storia in riva alla Piave, Sismondi, Salgaresa 2010, pp. 25-48.
5
Dalla foto possiamo notare la diffusione della lottizzazione romana nel territorio in
esame4. Se facciamo caso al corso della Postumia romana, la via che unisce Genova
ad Aquileia, osserviamo come attorno al punto in cui la strada attraversa il fiume c’è
una evidente mancanza di insediamenti. Si interrompono nel centro di Maserada sul
Piave (località Ronchi) in Destra Piave e ricominciano nel centro di Roncadelle in
Sinistra Piave. Già questa distanza è calcolabile in circa 10 km.
Se risaliamo la Postumia verso Castelfranco Veneto noteremmo le stesse dinamiche
attorno ad altri fiumi minori in tutta la zona compresa fra Oderzo e Treviso. Da ciò,
apprendiamo che quei 50 km non erano la reale distanza tra Oderzo e Vicenza, ma la
lunghezza della strada, che in più punti era interrotta dallo scorrere delle acqua di un
fiume che non rendeva possibile un insediamento stabile sulle sue sponde, ma
favoriva la presenza di attività di traghettamento (Madorbo, Ronchi, ecc.)5
Possiamo ora e solo ora rispondere a una delle domande prima poste, cioè quando fu
costruito quest’argine:
4 Baggio, Primon, Sotto l’occhio del satellite, p. 86. 5 Sui passi barca del Medio corso del fiume Piave, Simone Menegaldo, Medium Urbis, pp. 119-126. Foto scattate dall’autore in località Madorbo (Ci,adolmo), terreni della famiglia Menegaldo.
6
Presumibilmente dopo il 49 a. C., quando cominciò la lottizzazione romana della
zona, adibito alla distribuzione di lotti di terreno agricolo ai veterani di Cesare, uscito
vincitore dalla guerra civile. A destra dell’argine scorreva il fiume, un fiume
ingovernabile e incanalabile, che col tempo arriverà a chiamarsi Piave.
Com’è allora che questo manufatto si trova a così grande distanza dal fiume?
Cerchiamo brevemente di riassumere la storia del territorio.
Nel corso del Tardo Impero, come possiamo vedere6
6 Baggio, Primon, Sotto l’occhio del satellite, p. 86.
7
Il territorio venne sempre più frazionato e ripartito fra i veterani delle guerre
imperiali. La debolezza dello Stato centrale però, causò frequenti invasioni
barbariche con conseguenti distruzioni e l’inizio del processo di incastellamento,
attraverso il quale i veterani, divenuti grandi proprietari terrieri, si staccarono
dall’Impero.
Soprattutto in seguito all’invasione di Attila, il magister militum di Treviso ordinò la
dismissione dei guadi e l’abbattimento degli argini in Sinistra Piave per impedire il
passaggio del fiume ai futuri invasori, la trasmissione di epidemie, abbandonando a
sé stesse le popolazioni opitergine e prealpine.
Mancando uno stato centrale che riorganizzasse la regimentazione fluviale, il
territorio fu sconvolto da inondazioni frequenti7.
Com’era però costruito un argine romano? L’argine romano era diritto e basso, di 1,5
m di altezza, ma non essendo il fiume incanalato forzosamente, questo aveva una
portata più ampia e dispersiva che ne preveniva le piene.
La caduta dell’Impero d’Occidente (476 d. C.) priverà il territorio dell’ente sovrano
che monitorava la costante manutenzione degli argini.
La nostra zona fu abbandonata a lungo alle distruzioni (i Goti nel 552 per impedire il
passaggio di Narsete diretto a Ravenna, nella fase cruciale della guerra gotica,
distrussero strade, argini e ponti per intrappolare l’esercito bizantino), sino al
Duecento, quando il comune di Treviso per procurare la propria salvezza decise di
legiferare attorno alla manutenzione delle opere di contenimento fluviale8.
Negli statuti di Treviso del 1218, scritti da Albertino Menegaldo, compare per la
prima volta l’obbligo per i podestà di occuparsi delle arginature del Piave, con lavori
di manutenzione da eseguirsi trimestralmente dopo i periodi di piena.
Le operazioni di regimentazione tuttavia, piuttosto che portare alla gestione della
risorsa fluviale, erano destinate a mettere in sicurezza Treviso anche a scapito di
interi villaggi della Sinistra Piave9.
7 Simone Menegaldo, Medium Urbis, pp. 51-56. 8 Ivi, pp. 61-72. 9 Ivi, pp. 117-119 e 150.
8
Dopo la grande alluvione del 1313, che aveva reso impossibile la discesa delle zatte
dal Cadore, il fiume l’anno seguente fu decisamente incanalato nel letto mediano dei
tre che lo componevano in quel periodo, portandolo a scorrere presso l’Ospedale del
Piave, facendolo defluire da sotto Mandre, dove il fiume fu irreggimentato con alte
palizzate rinforzate con grosse pietre estratte dal suo alveo.
I lavori costarono 4000£, ma furono vanificati dalla guerra del 1318 fra Cangrande
della Scala e Treviso, quando il condottiero veronese fece rompere gli argini per
inondare la città e costringerla alla resa10.
Passata la burrasca della guerra, la Piave ruppe ancora nel 1409 sia in Destra che in
Sinistra Piave, portando Venezia a intervenire per la prima volta sul territorio.
L’obiettivo si trasferì dalla salvaguardia di Treviso e quella della laguna; per tale
motivo l’allora doge Michele Steno ordinò la costruzione dell’argine di Conegliano,
che scendeva da Bagnolo sino a Santa Lucia di Piave, portando le acque a defluire
verso la sponda opposta. Nel 1412 emanò un decreto secondo il quale “niuno ordisse
di tagliar argini o procurare rotte, sotto le più rigorose pene”11.
La realizzazione di tale opera però, non poteva che attirare le proteste di Treviso, che
porterà in causa la Serenissima. Alla fine Venezia accoglierà le istanze della città di
Treviso e approverà la modifica al progetto. Fu avviata una massiccia escavazione di
ghiaia da Nervesa a Candelù per rendere il fiume diritto e limitare, secondo il
progetto dei tecnici trevisani, la sua capacità erosiva. Accanto a questo, si decise di
scavare ulteriormente l’invaso per costringere il fiume nel suo nuovo corso,
chiudendo il ramo di Lovadina convogliando l’acqua nel ramo detto “rabbioso”,
accompagnando l’incanalamento in questo ramo con una serie di argini e pennelli da
Nervesa al bosco di Candelù. Il muraglione di Mandre fu prolungato diritto sino ad
arrivare a Salettuol e poi giù sino a proteggere il bosco di Candelù, preziosa fonte di
legname per Venezia.
I lavori cominciarono nel 1469 e durarono a lungo, sino a raggiungere spese di gran
lunga superiori ai preventivi. Si arrivò a denunce nei confronti delle comunità
10 Ivi, p. 118. 11 Ivi, p. 116.
9
rivierasche, ree del mancato servizio di corvées a cui erano tenute (prestazione di
manodopera gratuita), denunce del comune di Treviso a Venezia, colpevole di aver
nominato un responsabile di costruzione incompetente, denunce di Venezia a Treviso
colpevole di essersi costruita un muraglione non autorizzato a Saletto. Insomma, fra
gestione incapace dell’opera pubblica e denunce incrociate, l’opera cominciata nel
1469 fu terminata nel 1493. In questo periodo si verificarono ben 4 alluvioni12.
E in Sinistra Piave?
Il 19 febbraio 1530 fu emanato un decreto che vietava taglio e rottura degli argini
maestri pena la vita. La situazione degli argini doveva essere particolarmente precaria
se già l’anno dopo un’alluvione arrivò a distruggere la chiesa di San Michele a
Cimadolmo.
Per tale motivo i Savi Giustiniani nel 1534 proposero la regolazione anche del ramo
sinistro del fiume con un argine, l’argine di san Marco, che collegasse Santa Maria di
Piave a Roncadelle, aprendo poi un diversivo (cassa d’espansione) tra Negrisia e
Ponte di Piave.
Fu condotto dritto il più possibile, largo 6 passi alla base e due in cima, realizzato 4
passi sopra la portata di piena. La costruzione dell’argine fu accompagnata nel 1571
dal loro sbarramento, in modo che non potessero essere transitabili13.
12 Ivi, pp. 162-164. 13 Ivi, pp. 135, 144-145. Foto dell’autore.
10
L’argine di San Marco fu un’operazione totalmente inutile per la Sinistra Piave.
Nel 1598 la piena superò l’argine e travolse tutti i villaggi da San Michele a
Roncadelle14.
L’argine non venne più riparato da Venezia, impegnata nella guerra di Candia e le
misure della podesteria di Oderzo per la riparazione degli argini non entrarono mai in
vigore. Il Consorzio dei Comuni creato per risolvere la situazione di stallo, si
abbandonò a una serie di veti incrociati durante le riunioni, che portarono a non
prendere alcuna decisione in merito alla riparazione delle arginature.
I proprietari terrieri della zona, in larga parte nobili trevigiani e veneziani,
sopperirono a tali inerzie ricorrendo ognuno alle proprie sostanze, costruendo argini
al bisogno, senza alcuna programmazione15.
Ma come fu possibile l’alluvione del 1598? L’argine di San Marco non doveva
finalmente risolvere ogni problema?
Forse. Non fosse stato però, che mentre i Romani scelsero di assecondare il corso
delle acque, i Veneziani esigettero dal fiume ogni metro di terreno utile ai loro scopi.
L’afflusso costante di inerti portato dalle piene in età romana, fu ovviamente costante
anche in quella successiva e accompagnato da sedimi di varia natura, che portarono
alla nascita di boschi a Mandre, fra Santa Maria di Piave e San Michele di Piave,
nelle Grave, a Madorbo, a Roncadelle. In particolare quello di Madorbo-Roncadelle
14 Ivi, p. 145. 15 Ivi, p. 155.
11
era sottoposto a particolari attenzioni di legge, in quanto il bosco del Sacil era per
estensione il sesto rovereto di pianura della Dominante, risorsa da tutelare e sfruttare
per la costruzione delle galere. Interamente recintato e sorvegliato da guardiani, il
bosco del Sacil (oggi interamente scomparso) sorgeva in zona golenale, così come il
bosco dei Talpon a Campodipietra, che si trovava a destra della presente foto,
particolarmente ambito per il taglio di legna da ardere. Similmente, gli altri boschi di
pianura crebbero all’interno del greto del fiume, in zone che quindi Venezia
intendeva sottrarre all’acqua per adibirle al proprio sfruttamento16.
L’inutilità dell’argine non fu quindi causa dell’argine in sé, ma del loco in cui fu
costruito, ovvero all’interno del letto del fiume, a protezione dei boschi di Venezia,
causando un restringimento notevole della portata fluviale nel suo medio corso.
L’argine divenne così inutile a contenere piene eccezionali o improvvise, ma la
Serenissima, sull’orlo della bancarotta a causa delle folli spese per sostenere la difesa
di Candia contro i Turchi, non fu in grado di intervenire per rimediare a tale errore.
Per tutto il Seicento non vi furono attività di manutenzione arginale, ma solo
sporadici interventi dei signori locali volti a salvaguardare le rispettive proprietà.
16 Ivi, pp. 162-164.
12
Uno di questi casi è ad esempio l’Arzere Moro in Madorbo, realizzato dai nobili
veneziani Moro, aventi diverse proprietà in zona, per tutelare i propri terreni17.
Nel 1746 la situazione arginale era così disastrosa che la Piave era giunta a lambire la
Postumia, rompendo anche tutte le vie di collegamento fra Santa Maria di Piave e
Roncadelle18.
Soltanto il governo austriaco (1815-1866) intervenne con dovere di perizia per
cercare di sistemare una situazione ormai disperata.
Nel 1828 vennero approntate una serie di speronature su tutto il lato sinistro della
Piave per ributtare nel mezzo le acque e consentire settorialmente i necessari
interventi di riparazione. Gli argini furono portati all’altezza di 2,50 metri e allargati
di 4, costruiti di roccia grezza alla base e la metà superiore di terra e ciottoli. Fu
vietata la coltivazione in greto ed entro 26 metri di distanza dalle arginature, così
come per la costruzione di case, fabbriche e fossati. Fu nominato un sovrintendente
17 Ivi, p. 155. La riproduzione della mappa riguardante il progetto dell’arzere Moro in Madorbo è di proprietà dell’autore. Originale in ASTV, Mappe antiche. 18 Ivi, p 158.
13
alle arginature che risiedesse in loco, ognuno avente giurisdizione su 12.000 metri di
arginatura.
Oltre a ciò lungo tutto il corso del fiume vennero posizionati 12 idrometri, con la
funzione di monitorare costantemente la portata del fiume.
Dei 12 posti lungo tutto il corso fluviale, ne restano solo 2, Ponte della Priula e
Madorbo, ognuno dei quali 750 metri prima era protetto da uno sperone
perpendicolare all’argine di circa 700 metri di lunghezza e alto 1 metro, realizzato in
ciottoli.
I provvedimenti austriaci furono presi in seguito alla constatazione che i problemi
della Sinistra Piave erano tutti dovuti dal muraglione in cemento Mandre-Saletto, che
ributtava la acque in riva sinistra senza permettere alcuno sfogo in riva destra19.
19 Ivi., pp. 177-185.
14
Il Governo Italiano completò l’opera di regimentazione nel 1884-86 costruendo la
diga di Cimadolmo, lunga 800 metri e posizionata a martello, perpendicolare
all’argine del fiume e che serviva ad alleggerire la pressione delle acque sull’argine20.
Gli ultimi interventi sugli argini furono realizzati nei due dopoguerra, ma mi esimo
dall’analizzarli perché mancherebbe il tempo e, soprattutto, aprirei ferite ancora
aperte dovute alla pessima gestione fluviale del secondo dopoguerra.
Bibliografia essenziale
Il Piave, a cura di Aldino Bondesan, Giovanni Caniato, Francesco Vallerani, Michele
Zanetti, Cierre, Caselle di Sommacampagna 2004.
Simone Menegaldo, Medium Urbis. Duemila anni di storia in riva alla Piave,
Sismondi, Salgareda 2010.
20 Ivi, p. 189.