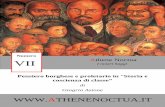Il luogo del pensiero. Un confronto tra Vitiello e Sini
Transcript of Il luogo del pensiero. Un confronto tra Vitiello e Sini
IL LUOGO DEL PENSIEROUN CONFRONTO TRA VITIELLO E SINI
LA MONADE
Iniziamo il nostro percorso evidenziando un tratto comune del
cammino filosofico di Carlo Sini e Vincenzo Vitiello, due filosofi
italiani contemporanei spesso in dialogo tra loro, animati da
reciproca stima e rispetto, ma divisi anche da posizioni
teoretiche per certi versi affini, per altri profondamente
divergenti.
Entrambi gli autori, come si evince anche solo attraverso un
rapido esame degli aspetti più importanti del loro pensiero, si
trovano d’accordo nel riconoscere l’impossibilità, per la
filosofia e in generale per ogni forma di sapere, di uno sguardo
panoramico in grado di abbracciare l’intera verità del mondo e
della storia.
Il sogno a lungo inseguito di una conoscenza universale e
assoluta, di un sapere in grado di tradurre ogni accadimento
presente, passato e futuro nel linguaggio oggettivo di una verità
certa e inconfutabile, viene definitivamente abbandonato. Si
tratta, a dire il vero, di una consapevolezza largamente raggiunta
da molte voci del panorama filosofico, e non solo filosofico,
dell’epoca moderna e contemporanea, consapevolezza che però viene
affrontata dai nostri autori in modo del tutto originale. Il
pensiero di Sini, come da lui stesso riconosciuto, presenta i
1
caratteri di una «monadologia aperta»1, dove la monade rimanda
inevitabilmente a Leibniz (ma anche a Bruno, Vico e Nietzsche2),
mentre la sua apertura l’avvicina invece più a Husserl e alla
fenomenologia.
Monadologia, alla luce degli accostamenti indicati, significa per
Sini «prospettivismo»: “tutto” il mondo (Uno) accade “ogni volta”
nell’oscillazione dell’evento (Due), nell’ora/qui della soglia,
varco nel quale il mondo precipita senza residui, dandosi a vedere
come prospettiva di mondo (Tre)3, o, secondo la lezione pragmatista
rielaborata da Sini, come figura di mondo “praticata”, come segno
che dà luogo ad un significato/abito di risposta, ad un concreto
modo di “reagire” all’incontro con il mondo. Questo pensiero
conduce direttamente alla crisi di ogni pretesa verità universale
e panoramica, incapace di guardare all’ergon4 della propria prassi,
alla soglia del suo accadere e, di conseguenza, del suo cadere come
prospettiva e come figura.
La medesima consapevolezza di non poter osservare il mondo
dall’alto di uno sguardo omnicomprensivo e assoluto è sottolineata
da Vitiello in molti luoghi della sua opera. Significativa a tal
proposito è la ricerca di un dire, di un linguaggio, capace di
esibire la particolarità della prospettiva da cui parla. Tale1 E1, p. 93, nota 1.66.2 Sull’incrocio tra monadologia e prospettivismo, nonché sull’accostamento tra ipensatori sopra indicati (Leibniz, Vico, Bruno, Nietzsche) cfr. AR. 3 Il “ritmo” tra Uno, Due e Tre rappresenta uno dei luoghi più discussi eproblematici di tutta l’Enciclopedia di Sini; Cfr. soprattutto E1, pp. 63-66.Questi riferimenti numerici vengono qui utilizzati, seguendo le indicazioni diRedaelli a riguardo (Cfr. NN, pp. 261-266), nonché la mia personale elaborazionedell’argomento, come termini indicativi di una problematica comune a Vitiello eSini, largamente sviluppata in tutto il saggio. Possiamo fin da ora anticipare,in modo del tutto indicativo e sommario, che essi si riferiscono al problemadell’origine (Uno), dell’evento (Due) e del significato (Tre), lasciando allettore il piacere di scoprire in seguito in che senso queste problematichevadano intese nei due autori. 4 Sull’accadere della soglia come essere nell’ergon cfr. E1, p. 39, 1.28.
2
dire, visto alla luce del nostro percorso, mostra di non voler
porre il proprio Tre, la propria particolare prospettiva o punto
di vista, come significato astratto e universale, ma di ricondurlo
al Due da cui trae origine, al limite dell’evento di soglia da cui
sorge. Questo dire, a giudizio di Vitiello, deve avere i caratteri
della testimonianza5. Testimoniare significa per Vitiello
innanzitutto essere consapevoli della propria particolarità,
dell’impossibilità di raggiungere un luogo di osservazione
esterno, panoramico, universalmente vero, rifiutando così ogni
linguaggio che si ponga come assertorio, con l’intento di assumere
una prospettiva esterna rispetto al mondo e alla vita. Consapevole
che ogni dire è già una figura del mondo e della vita, un episodio
interno a essi, colui che testimonia non avanza la pretesa di
sostenere alcuna verità universale, ma si limita ad esibire
l’esercizio della propria particolarità, senza cadere nella
tentazione di sollevare questo esercizio ad “insegnamento”.
Testimoniare significa perciò, nonché trincerarsi dal rischio di
parlare come se il proprio detto, il proprio Tre, fosse un
significato universale e assoluto, “far rimbalzare” il detto sul
dire, sull’evento di senso che lo rende possibile.
Proprio sul rapporto tra la particolarità della prospettiva e il
suo accadere come evento, nonché tra essa come “figura” e ciò che
ne costituisce lo sfondo, l’orizzonte, si giocano le principali
differenze tra i due pensatori. Le istanze fino ad ora avanzate
infatti, vertiginose e abissali se portate fino alle loro radicali
conseguenze, pongono il grande problema del rapporto tra la monade
come figura di mondo e il mondo, tra la parte e il tutto, tra5 L’analisi di questa tematica prende spunto dall’ascolto di una conferenzatenuta da Vitiello al Teatro Excelsior di Cesano Maderno il 12 Febbraio 2010,intitolata Testimoniare.
3
l’esperienza precipitata nel vacuum della soglia e ciò che “orla”
tale precipizio, rappresentandone il presupposto, il continuum,
l’origine.
Circa questo problema la soluzione di Sini è tanto chiara, quanto
ardua e problematica: se la soglia rappresenta quel varco, quel
vacuum, quel nulla6 in virtù del quale accade ogni precipizio di
mondo, allora ogni “figura” che la soglia si immagina, prima o
dopo di sé, ogni presupposta “realtà esterna”, ogni supposta
“origine”, non è che una sua proiezione anteflessa o retroflessa,
un’immagine che accade sempre ora e qui anche laddove ambisce a
denotare un supposto prima o poi, che come tale precipita a sua
volta nel nulla. Ogni figura della soglia, in altre parole, non è
che una finzione (non diversa però dalla verità), un’immaginazione
(non diversa però dalla realtà) con la quale la soglia della
pratica in atto si rappresenta ciò che la precede (o ciò che la
segue) e che sta al di “fuori” di essa. Emblematico a proposito è
l’esempio, proposto da Sini, dell’origine dell’alfabeto7: qualsiasi
ipotesi storica scegliamo di tenere in considerazione come valida
(Sini opta per quella dello scalpellino greco intento a registrare
il debito), essa è strutturalmente distante dall’intreccio di
pratiche all’interno del quale accadeva quell’apertura di mondo
che solo ora appare a noi sensato indicare con l’espressione
“origine dell’alfabeto”. L’origine, in altre parole, accade sempre
ora e qui, sicché la “vera” origine, allargando il discorso, come fa
Sini in altri luoghi, all’origine dell’universo8, non è l’Uno ma il
Due, l’evento, la soglia, vale a dire la distanza dall’origine,
6 Sul nulla della soglia come vuoto che accade nell’ergon, dando luogo ad esso,cfr. E1, p. 40, 1.30.7 Cfr. E1, p. 33 e sgg.8 Cfr. E5, pp. 29-45.
4
l’esser già accaduto del mondo in virtù del quale è possibile
formulare le più svariate ipotesi su ciò che vi sarebbe stato
prima di tale evento (ipotesi che vanno dalle cosmogonie
mitologiche alle moderne teorie sul Big Bang; anche in questo
caso, come in quello dell’origine dell’alfabeto, la scientificità
della tesi in questione è irrilevante ai fini della comprensione
del problema). Tale origine, in qualsiasi modo la si denoti,
appare come appare solo grazie al fatto di cadere sotto la luce
retrograda del presente, della prassi in atto, della figura di
mondo incontrata e praticata nell’ora/qui di questa attuale soglia.
Essa non ha perciò alcuna altra “verità” o “realtà” se non quella
che ottiene in virtù dell’operazione di retroflessione attuata
dalla pratica che ora accade. Riprendendo la terminologia
introdotta in precedenza e molto spesso usata da Sini, l’Uno è
sempre un Uno/Tre; il presupposto, direbbe Vitiello ripercorrendo
la riflessione ponente della logica hegeliana9, è sempre un
presupposto/posto. Nel pensiero di Sini però, non solo ciò che
precede l’essere nell’ergon della pratica attuale, l’accadere della
soglia, ciò che si può indicare con le espressioni ‘origine’,
‘Uno’, ‘continuum’, ‘presupposto’, assume i tratti di una figura
retroflessa, di un nulla che precipita nel nulla della soglia, ma
anche la soglia stessa, l’evento, il ‘Due’, l’accadere
dell’oscillazione non può mai essere afferrato “come tale”, ma
solo in quanto figura già “precipitata” nel Tre. Anche i termini
‘soglia’, ‘evento’, come sottolinea Sini, sono già «figure» in
atto della soglia, dicono «come la soglia si configura nel suo
ergon», nella figura della sua pratica»10. Anch’essi non sono altro
9 Per un approfondimento della questione cfr. FT, pp. 110-114 e NN, pp. 158-167.10 E1, p. 41.
5
che figure di ritorno, di retroflessione e di rimbalzo, prodotte
dalla pratica, sicché ogni volta che tento di dire, di scrivere,
di fissare una volta per tutte la differenza tra Due e Tre, tra la
soglia in atto e i suoi oggetti (tra l’evento e il significato
come dice Sini pressoché ovunque nei suoi testi), ecco che mi
ritrovo immediatamente “sbilanciato” dalla parte del Tre, del
significato, degli oggetti interni alla pratica che frequento,
come ad esempio parole, discorsi, argomentazioni, tutti incapaci
di collocarsi sulla soglia del loro stesso evento, ma destinati
inevitabilmente a cadere dal lato degli “effetti” che la soglia
produce, degli oggetti cui la kinesis dell’evento dà luogo. Scrive
Sini: «il nodo è la questione della differenza tra evento e
significato; ma la difficoltà è che questo nodo precipita subito
dalla parte del significato»11. Ora, prendendoci la libertà
interpretativa12 di indicare con il termine ‘evento’, alla luce del
suo utilizzo nel corso di tutta l’opera siniana, sia l’Uno che il
Due, sia il continuum che la soglia, vediamo bene, in base
all’ultima frase citata, la portata complessiva di tutto il
prospettivismo di Sini. La differenza tra evento (Uno e Due) e
significato (Tre) non può essere detta, scritta, colta, afferrata,
senza che essa trapassi istantaneamente dal lato del significato.
L’Uno “come tale”, il Due “come tale”, se ci è concesso esprimerci
in questo modo, non possono mai diventare oggetto di parola, di
scrittura, di esperienza possibile, dal momento che ciò che cade
sotto la luce della presenza è appunto un esperito empiricamente
incontrato, un significato/Tre inteso come oggetto delle più11 AS, p. 254.12 Supportata da un’importante passo dell’opera Sini che invita a muoversi inquesta direzione. Cfr. PS, p. 51. Nel testo la nozione di ‘evento’ vieneconsiderata in riferimento alle prime due categorie peirciane, mentre la terzacategoria viene associata alla dimensione del significato, dell’interpretazione.
6
diverse pratiche, laddove invece l’Uno e il Due, il continuum e la
soglia, rappresentano in senso lato le “condizioni trascendentali”
dell’esperienza, come tali ad essa irriducibili. La luce che “fa
vedere” non può, heideggerianamente, divenire a sua volta oggetto
di visione. O ancora, il che è lo stesso, non può far altro che
essere vista (la luce, cioè, tenendo fermo l’esempio, l’evento,
come Uno e come Due), detta, scritta, mostrata di continuo, nella
consapevolezza però che mi troverò sempre fra le mani un quid di
illuminato dalla luce stessa, ossia un significato, una figura
retroflessa. La retroflessione, del resto, non è per Sini un
qualcosa di evitabile, ma rappresenta uno degli aspetti peculiari
dell’ergon della prassi.
Alla luce di questa prospettiva però, l’impressione che potrebbe
sorgere è quella dell’impossibilità di qualsiasi contatto
“autentico” con l’esterno, con l’alterità che non si riduce
(eppure anche viene sempre inevitabilmente ridotta) allo stesso
della monade, con la differenza non assimilabile all’identità
della soglia. Ogni altro, ogni oltre, ogni prima e ogni poi,
diventa infatti una proiezione dello stesso, un nulla del suo
nulla. L’Uno e il Due, riprendendo i termini del nostro discorso,
vengono sempre detti, colti, descritti, come Tre, come figure
retroflesse del e dal Tre. Per sfuggire alla forza “cannibale”
della soglia in atto e all’azione riconfiguratrice dei suoi
“precipitati”, con l’intendo di aprirsi ad un più autentico
contatto con l’alterità, Vitiello tenta la strada di una nuova
“grammatica del pensiero”.
L’INCONTRO CON L’ALTRO7
Pur non riferendosi direttamente alla monadologia di Sini,
Vitiello avanza alcune considerazioni circa altre proposte
filosofiche riconducibili a forme di prospettivismo, come ad
esempio quelle di Leibniz o di Husserl. Tali considerazioni
inducono a riflettere sul rischio di “solipsismo” insito in ogni
forma di verità prospettica, che per fuggire dall’universalità di
quella che Vitiello chiama la “terza persona” (la voce dell’è, del
linguaggio universale e panoramico), si ritrova all’opposto
imbrigliata nelle difficoltà della prima persona, incapace di
pensare l’alterità se non come momento dell’identico, come
evidenziato nel rapporto problematico tra l’io monade e il Cogito
universale in Husserl (scrive Vitiello: «per quanto si apra
all’universo del “Noi”, il singolo resta nella sua singolarità […]
Il Noi è sempre e solo una prospettiva singolare del Noi»13).
Per sottrarsi all’alternativa tra terza e prima persona, tra
universalità e solipsismo, Vitiello elabora una logica della seconda
persona14. Tale logica nasce con l’intento di eludere la stringente
alternativa sopra richiamata, conservando in un certo senso,
potremmo osservare, gli aspetti positivi di entrambi i poli.
Vitiello infatti della terza persona, dell’è, apprezza l’apertura
all’altro, ma critica la riduzione di questo altro a
necessario/stesso, di cui è responsabile la distanza universale e
panoramica del suo punto di osservazione, che rende incapace di
cogliere la propria e altrui particolarità. Della logica della
prima persona invece egli apprezza la consapevolezza della propria
13 GP, p. 72.14 Tale logica viene esplicitamente presentata da Vitiello nel già citato GP, puressendo implicitamente presente e “sotterraneamente” in cammino lungo tutto ilcorso della sua produzione filosofica.
8
finitudine, ma critica lo scadimento di tale consapevolezza in
solipsismo, finendo così anch’essa, seppure in modo diverso, a
ricondurre l’altro allo stesso, e cioè in questo caso il Noi (come
abbiamo visto in Husserl) o il Tutto all’Io (l’Uno/Due a Tre).
Detto con le parole del nostro percorso, il compito della logica
della seconda persona è dunque quello di consentire un’apertura
del Tre verso l’Uno/Due che non sia confinata in due forme
altrettanto limitanti, a questo scopo, di Tre, ossia quel Tre che
pretende di annullare ogni distanza rispetto all’Uno e al Due,
descrivendo l’immagine universalmente vera del mondo, e quel Tre
che si rinchiude in un solipsismo che fa di ogni Uno/Due una sua
immagine, una sua proiezione retroflessa, negando così all’altro
la sua più propria alterità.
La logica della seconda persona, scrive Vitiello, non deve tradire
«l’alterità dell’Altro col dire cosa l’Altro È»15, ma deve saper
conservare la sua alterità rivolgendosi ad esso nella forma del
“tu sei”. Un esempio di questa forma di rapporto all’altro è
rintracciata da Vitiello nella filosofia di Anselmo, il quale si
rapporta a Dio dicendo «Signore, tu sei…»16 e in questo modo «non
descrive oggettivamente Dio, ma ne parla a partire da sé»17. Come possiamo
comprendere a partire da queste parole, ciò che il rivolgersi
all’altro in seconda persona deve evitare, è l’impossibile
descrizione oggettiva, e cioè panoramica, universale e assoluta,
propria della terza persona, descrizione che elimina l’incolmabile
distanza tra il finito e l’infinito, tra l’uomo e Dio, tra lo
stesso e l’altro, tra il Tre e l’Uno/Due, tra il significato e
l’evento, direbbe Sini. Viceversa la seconda persona cerca di15 GP, p. 141.16 Cfr. DP, p. 14.17 Ibidem.
9
rispettare questa distanza, di esibirla nell’impossibilità di
ridurre l’altro allo stesso attraverso la forma del “tu sei”,
utilizzata da Anselmo, capace di conservare l’altro come altro.
Scrive Vitiello: «la logica anselmiana del “tu sei” contrasta
radicalmente la logica dell’essere. Perché il suo dire, il suo
logos, è il dire, il logos, dell’uomo in quanto ente finito»18.
Al tempo stesso però, per far sì che il pensiero in seconda
persona sappia rispettare l’alterità dell’altro fino in fondo, è
necessario per Vitiello oltrepassare anche i limiti della prima
persona, sforzandosi di pensare l’altro anche come «altro
dall’Altro»19. Se infatti l’altro fosse pensato “solo” come altro,
la sua alterità verrebbe negata, dal momento che di esso si
avrebbe solamente l’immagine prodotta dallo stesso. Dicendolo con
i termini del nostro cammino: per poter pensare l’Uno come Uno
occorre non soffermarsi su quell’Uno che è sempre Uno/Tre, su quel
presupposto che è sempre posto dal pensiero, ma è necessario
esporsi alla sua ulteriorità, alla consapevolezza che esso è
“oltre” ciò che ne dice il Tre. Allo stesso modo l’altro è oltre
la “figura retroflessa” generata dallo stesso ed è perciò anche
altro dall’altro. Aprendo alla possibilità che l’altro sia anche
altro dall’altro, Vitiello non nega che, proprio per questo,
l’altro possa essere anche il medesimo, possa cioè coincidere con
ciò che ne dice lo stesso, con ciò che il parlante dice di lui.
Questo comporta, come scrive Vitiello, «la possibilità dell’Altro
di approssimarsi al finito»20, in assenza della quale la logica
della seconda persona perderebbe la sua finitezza, finendo per
18 DP, p. 16.19 DP, p. 17.20 Ibidem.
10
affermare «in modo assoluto, e cioè infinito, qualcosa di Dio
(dell’altro, n.d.r.)»21.
L’altro cui il parlare in seconda persona si rapporta, svincolato
dalla necessità cui veniva inchiodato dalla logica dell’essere, è
dunque concepito, come si può evincere dalle considerazioni
precedenti, come possibile. L’Altro infatti, scrive Vitiello, «non è
“essere”, ma “possibilità”»22. Possibilità/alterità a cui il
pensiero può approssimarsi solo rispettando la sua “oltranza”. Per
questa ragione, scrive Vitiello, «per poter corrispondere alla
possibilità dell’Altro, il pensiero ha sempre da aggiungere
possibilità alla possibilità dell’Altro, detto appunto: quiddam
maius quam cogitari possit»23. L’altro non è mai pensato davvero nella
sua possibilità estrema fin quando non si comprende la necessità
di aggiungere sempre possibilità alla sua possibilità, sfuggendo
al pericolo di acquietarsi in una “possibilità definitiva”, una
“stabile dimora” che avrebbe l’effetto contrario di negare la
possibilità dell’altro, mutandola in necessità. Per questo
l’altro, il possibile, o come spesso Vitiello dice rifacendosi ad
Anselmo e anche a molti altri luoghi della tradizione religiosa,
Dio, è sempre oltre ogni pensiero umano, oltre ogni possibilità
definitivamente mutata in necessità. Perciò, come scrive Anselmo,
Dio non è solo ciò di cui non si può pensare il maggiore, ma ciò
che è maggiore di quanto si possa pensare. Ma tutto questo, se
abbiamo capito il senso dell’esercizio di Vitiello, è detto male,
se espresso, come abbiamo fatto, ancora con la logica della terza
persona, tramite la quale Dio, l’altro, il possibile, viene
inchiodato alla necessità dell’è. Proprio per questo Vitiello21 Ibidem.22 DP, p. 17.23 GP, p. 141.
11
prende ad esempio Anselmo, il quale afferma: «Ergo, Domine, non solum es
quo maius cogitari nequit, sed es quiddam maius quam cogitari possit»24.
La logica del possibile e la logica della seconda persona fanno
dunque tutt’uno in Vitiello, entrambe motivate dalla medesima
necessità di sfuggire alle gabbie oggettivanti dell’universale,
del dire che, nella pretesa di stabilire in modo assertorio che
cosa è il possibile, nasconde la sua autentica natura di
possibilità, proprio laddove afferma di essa che è possibile. La
possibilità, al pari della dynamis aristotelica, viene così
vincolata alla necessità di poter essere x o y, di attuarsi in una
delle due opposte alternative, perdendo la possibilità anche di non
essere x o y, di non realizzarsi in nessuna delle due ipotesi. In
questo modo la possibilità, come scrive Vitiello, «non è possibile
in relazione a sé, ma solo ad altro, che non è insieme
impossibilità, perché i contrari li ha in sé, ma non è essa
medesima coinvolta nell’opposizione»25. Non è davvero possibilità
se non contiene in sé anche l’eventualità di non realizzarsi come
tale; non solo dunque la possibilità come alternativa tra strade
diverse, ma anche la possibilità che tale alternativa venga a
mancare del tutto: possibilità totalmente ripiegata su di sé,
«possibilità im-possibile»26 (dove il trattino indica la compresenza,
all’interno della possibilità, e non solo in riferimento alle
alternative opposte cui essa da luogo, di essere e di non essere,
di possibile e impossibile).
La necessità di aggiungere possibilità alla possibilità
dell’altro, vista all’opera nella descrizione della possibilità
24 Cfr. DP, p. 13 e DP, p. 16.25 FT, p. 189.26 DS, pp. 216-217.
12
come im-possibile27, implica per Vitiello, specularmente, il compito
di sottrarre qualcosa al pensiero che “dice” l’altro. Per questo,
anche per questo, il pensiero parla in seconda persona. Esso
mostra il paradosso di un io che è “tu” anche a se stesso28, che
toglie ogni centralità dal proprio dire, esibendo fino in fondo la
sua particolarità, la sua finitudine. Esso è perciò «quiddam minus
quam cogitari possit»29, ossia meno di ogni meno, perché, come scrive
Vitiello, «per minimo che sia, il suo essere, anche come solo
possibile, toglie spazio alla possibilità dell’Altro. L’esercizio
del pensiero, nella logica della seconda persona, è quindi un
esercizio kenotico»30, un esercizio cioè di svuotamento, di
impoverimento, indispensabile per approssimarsi ad una possibilità
strutturalmente “fraintesa” come tale in ogni parola, scrittura,
discorso, in ogni “determinazione”, che seppur minima è già troppo
“invasiva” verso l’alterità del possibile e per questo necessaria
di kenosi.
Kenosi, grammatica della seconda persona, logica della possibilità,
sono le strade che Vitiello percorre nel tentativo di gettare uno
sguardo “oltre”, uno sguardo che, pur nella consapevolezza della
sua finitudine, della sua collocazione prospettica, tenta di
aprirsi la via per un contatto con l’altro, con il possibile che
non lo riduca, come invece sembra fare l’ora/qui della soglia
siniana con le sue proiezioni retroflesse, ad una figura dello
stesso e dell’identico.
27 Oppure, come scrive Vitiello in DP, p. 18, della possibilità che non èpossibile, ma è possibile possibilità, dove l’ultimo è possibile tutto in corsivo hala funzione di copula.28 Cfr. GP, p. 131.29 GP, p. 141.30 Ibidem.
13
Cerchiamo di capire più a fondo le ragioni che spingono Sini a non
“sporgersi”, a non tentare la strada di questo “oltrepassamento”.
LA DISTANZA
In base a quanto detto fin’ora, Sini e Vitiello da un lato
sembrano d’accordo nel riconoscere, pur attraverso percorsi
filosofici diversi, la collocazione finita e prospettica del
proprio, come di ogni, pensiero; dall’altro lato invece sembrano
mostrare una diversa concezione del rapporto tra la “figura”
concretamente incontrata e ciò che la orla, il suo sfondo, il suo
orizzonte, denotato come soglia, evento, origine, possibilità etc.
Mentre Sini mostra più volte come qualsiasi tentativo da parte del
Tre di avvicinarsi all’Uno e al Due faccia di essi ancora dei Tre,
delle proiezioni della soglia in atto (compresa la stessa
soglia/evento, ridotta a significato anche solo nominandola come
‘soglia’), Vitiello, pur nella medesima consapevolezza che non è
possibile accedere all’Uno e al Due “in sé”, all’Uno e al Due
“come tali”, tenta la strada di una grammatica del pensiero in
grado di rispettare l’alterità dell’altro, di rapportarsi ad esso
senza farne immediatamente un’immagine dell’identico, senza
vincolarlo alla necessità della figura in atto. Le ragioni di
questa differenza risiedono nella diversa concezione che i due
autori hanno circa la finitudine del proprio pensiero e il
conseguente senso di “verità” in esso contenuto.
Entrambi infatti mostrano di avere piena consapevolezza del limite
che il pensiero non deve oltrepassare. Entrambi rifiutano quelle
parole e quei discorsi che dimostrano di non avere coscienza di14
questo limite, esercitando un logos assoluto, inconsapevole della
propria particolarità, della propria finitudine, della propria
collocazione. Se però è comune il riconoscimento del limite, diversi
sono, diciamo così, l’al di qua e l’al di là che il limite
traccia, così come diverse sono le motivazioni che spingono i due
autori ad invitare il lettore a non oltrepassarlo.
La preoccupazione di Sini è infatti quella e di mostrare
l’errore/distanza di ogni significato rispetto all’evento e di
rendere però il lettore pienamente consapevole che non c’è nessun
altro evento all’infuori di quello ora/qui presente, nell’assoluta
verità del suo accadere. Detto altrimenti: l’essere in errore
coincide con la verità, nonostante occorra comprendere (o meglio,
praticare, esercitare, esibire, mettere in atto) la consapevolezza
che tale coincidenza comporta sempre, al tempo stesso, differenza,
errore, distanza.
Procediamo con calma: secondo Sini ogni pensiero, e più in
generale ogni prassi, ogni prospettiva di mondo incontrata e
praticata a partire dal precipizio della soglia, è finita in
quanto inevitabilmente distanziata rispetto al suo stesso evento,
al suo accadere come prospettiva. Essa è dunque relativa al suo
evento, non, ed è un passaggio su cui Sini insiste parecchio,
relativa perché “debole”, perché meno vera rispetto a una presunta
verità forte e assoluta31. Ecco perché, come abbiamo letto poco
sopra, la verità (l’accadere dell’evento) coincide con l’essere in
errore (il precipitare del significato), termini che vengono
utilizzati da Sini in un’accezione diversa rispetto a quella del
linguaggio quotidiano, sicché a suo giudizio è opportuno parlare31 Il tema della verità relativa e del suo significato “autentico” è trattato daSini in molti luoghi della sua opera. Cfr. soprattutto E3, pp. 65-71 («Veritàassolute e relative») e AR, pp. 135-145 («Il relativo globale»).
15
di un doppio senso di verità ed errore32. La verità e l’errore,
potremmo dire, “empirici”, interni alla pratica, al Tre, al
significato (2+2=4 > vero; 8+5=4 > falso); la verità e l’errore
“trascendentali”, ossia l’incolmabile distanza del significato
(errore) rispetto al suo stesso evento (verità). Distanza che
però, come anticipato, è al tempo stesso anche coincidenza,
essendo l’evento sempre evento del significato, non accadendo
l’evento mai altrove che nel significato e mai altrimenti che come
significato33. La soglia, come abbiamo già visto, è un vacuum che
non trattiene nulla, e nel quale precipita tutto il mondo, con il
suo significato. La capacità di comprendere la distanza che separa
ogni significato dal suo evento, ma nello stesso tempo anche la
prossimità tra i due, comporta per Sini uno sforzo di carattere
etico e non più esclusivamente teoretico. Non si tratta infatti di dire
tale distanza, di affermarla, di oggettivarla, di scriverla, tutte
operazioni che porterebbero, come già osservato, al “precipizio”
di essa dalla parte del significato, allo “scadimento” del Due in
un Tre. Si tratta invece di abitarla, cioè di assumere un nuovo
sguardo, una nuova postura, un nuovo ethos nei confronti del
sapere, capace di rendere il soggetto auto-bio-graficamente
consapevole dei suoi limiti, della sua collocazione, dell’essere in
errore proprio delle sue prassi e delle sue conoscenze. Questa
operazione comporta l’abbandono della «superstizione» del soggetto
32 Si tratta di un altro passaggio largamente discusso. Cfr. soprattutto AS, pp.117-130; E3, p. 69; E6, pp. 182-183.33 Il tema dell’evento come evento del significato è uno dei passaggi piùdiscussi da Sini, ricorrente in moltissimi suoi testi, conferenze, lezioni. Ilpasso forse più riassuntivo e chiaro circa la questione si trova in E3, p. 61 esgg., ma è sicuramente fondamentale il concetto di «verità cruciale» in quantoappunto, nell’esemplificazione proposta da Sini, all’incrocio tra la rettaverticale dell’evento e quella orizzontale del significato. Cfr. a propositoIDV, p. 165 e sgg.
16
nei confronti dei significati interni alle prassi, delle loro
verità; l’abbandono cioè della convinzione che il mondo incontrato
e praticato nella prospettiva di ogni monade coincida con il mondo
“in sé”, il mondo oggettivamente e universalmente vero34.
Ciò che invece spinge Vitiello a rendere il pensiero consapevole
dei suoi limiti e della sua finitudine, non è la distanza tra il
significato e l’evento, ma quella tra il significato e l’altro, il
possibile. Detto con le formule del nostro percorso: non la distanza
tra il Tre e il Due ma la distanza fra il Tre e l’Uno. Ora, non è
che per Sini quest’ultima distanza non ci sia e non rappresenti il
minimo problema. Al contrario, abbiamo già visto la pregnanza, nel
suo pensiero, del tema della retroflessione, operazione inevitabile,
propria di ogni pratica, che porta a riconfigurare il passato
leggendolo sempre alla luce retrograda del presente. Anche in
Sini, di conseguenza, non mancano certo momenti di profonda
riflessione riguardo alla distanza tra Uno e Tre. Con la
differenza, però, che per Sini l’Uno non c’è mai, ma è sempre la
figura retroflessa che il Due proietta dietro di sé. L’Uno è
perciò sempre un Uno/Tre. Per questo l’aspetto, per così dire,
etico, della retroflessione si risolve tutto nell’esercizio
dell’abitare la prassi precedentemente visto. Sini è consapevole
che ogni pratica proietta dietro di sé la propria verità, e non
può evitare di farlo. Anche in questo caso la differenza sta nel
come, nel grado di “disincanto” del soggetto rispetto a questa
operazione. Il problema, in altre parole, è per Sini ancora quello
di sapersi collocare sulla soglia delle proprie pratiche e dei
propri saperi, consapevoli della coincidenza di verità ed essere
34 Tra i moltissimi passaggi dell’opera di Sini che trattano di queste tematiche,mi sembra opportuno rimandare soprattutto a FS, 147-149.
17
in errore, capaci di fare di ogni significato (anche del
significato retroflesso) un’occasione di esercizio35. Il soggetto
dunque deve muovere dalla figura dell’esser soggetto a verso quella
dell’esser soggetto di36, cioè abbandonare l’atteggiamento di cieco
assoggettamento alle pratiche di vita cui è assegnato (soggetto
a), per diventare consapevole della propria collocazione e del
proprio destino. Egli deve, in altre parole, comprendere il senso
delle sue inevitabili operazioni di retroflessione, senza
soggiacere ad esse inconsapevolmente.
Ogni pratica retroflette le sue figure. Non è dunque necessario,
in questo senso, alcun “impoverimento”, alcuna sottrazione del
pensiero, come se in questo modo fosse possibile per il soggetto
approssimarsi maggiormente con l’Uno, con la possibilità, direbbe
Vitiello, dell’Uno. L’impoverimento, potremmo dire, non sta per
Sini nei significati, non sta nell’esigenza di produrre forme di
pensiero kenotiche, quanto nella capacità di abbandonare un
atteggiamento di cieca superstizione assumendone uno più “povero”
perché meno illuso, meno ideologico, meno ancorato a delle verità
che pretende sciolte dal loro evento di senso (e quindi anche
nello stesso tempo immensamente più ricco).
Per Vitiello invece la questione è ben diversa. L’impoverimento
del pensiero e della parola umana, la necessità di passare dalla
terza (e dalla prima) alla seconda persona, è data dall’esigenza
di esibire l’incolmabile distanza rispetto all’Uno, ad un Uno che
è oltre l’immagine retroflessa che il Due proietta di sé. Tale Uno
è infatti inteso come possibilità, come altro che è sempre altro al
35 Cfr. E1, pp. 75-83 («Nona figura; l’occasione della verità), ma anche esoprattutto pp. 85-88 («Appendice; l’origine della filosofia e la sua occasionedi verità»).36 Cfr. FS, pp. 117-118.
18
punto da essere anche altro dall’altro. Lo sforzo di pensiero
operato da Vitiello rivela il fatto che non è a tema la distanza
siniana tra verità (del Due) ed errore (del Tre), ma la distanza
tra Verità/Mistero (dell’Uno) e Parola (del Tre), quest’ultima
caratterizzata da una «incolmabile distanza che la separa dalla
Verità»37. Partendo dalla possibilità dell’Uno come elemento rispetto
al quale ogni realtà, ogni prassi, ogni significato, si colloca
alla distanza di un salto incommensurabile e inspiegabile per il
pensiero (il mistero di fronte a cui ogni argomentare cessa),
Vitiello sostiene che «solo nella finitezza, nella distanza e
nell’abbandono posso fare esperienza della verità. Nella
consapevolezza che tutte le esperienze sono sospese alla Verità
che può negarle – tutte»38.
Anche in questo caso, come in Sini, abbiamo dunque un’esperienza
della verità che si dà come finita, perché distanziata rispetto a
qualcos’altro (distanziata rispetto alla Verità con la V maiuscola
che rimane sempre oltre, necessaria di mai sufficienti aggiunte di
“possibilità”). La differenza fondamentale, però, è che mentre per
Sini tra l’evento come verità e il significato come errore, nonché
darsi distanza, si dà anche una coincidenza data dal “precipizio”
dell’evento nel significato (l’evento è sempre evento del
significato, non è mai altrove che nelle sue figure), per Vitiello
tra i due “poli” della relazione si pone invece l’abisso del
Mistero, del possibile, sicché ogni parola sarà sempre “meno di
ogni meno” rispetto alla Verità dell’Uno.
Anche per Sini, occorre dire, questo è in un certo senso vero. Non
c’è parola mai abbastanza adeguata per dire l’origine “come tale”,
37 DP, p. 29.38 Ibidem.
19
per descrivere, come negli esempi precedenti, l’origine
dell’alfabeto, o dell’universo. Anche per Sini ogni parola dice
“già troppo” rispetto all’obiettivo che si pone, dal momento che
non è mai in grado di collocarsi sulla soglia dell’evento, evento
che accadeva in un intreccio di pratiche per noi irrecuperabile,
ma soltanto riconfigurabile alla luce della nostra apertura di
senso. Anche per Sini, dunque, il Tre non è mai in grado di dire
l’Uno “com’era”, di coglierne il senso ormai perduto che aveva
sulla soglia del suo accadere. Tutto ciò, però, non rappresenta
per Sini un problema, poiché l’Uno di cui parla è appunto sempre
l’immagine retroflessa ora e qui a partire da questo Due. Questo Uno
d’altro canto, “mentre accadeva”, non era altro che un Due, a sua
volta impegnato a riconfigurare la sua origine e a darsi un
destino, a retroflettere e anteflettere i Tre/significati da lui
prodotti. Non c’è perciò alcun “mistero” nell’Uno di Sini, e
nemmeno nel passaggio dall’Uno al Due (tematica più volte
affrontata da Vitiello), nell’accadere della prassi, ragion per
cui non c’è bisogno di sospendere la soglia, l’evento, l’ora/qui,
sull’abisso della sua (im)possibilità. Scrive Sini: «L’Evento è
l’accadere che sempre (cioè per sempre) accade. Esso semplicemente
mostra e dice che accade (che “qualcosa” accade)»39. Il che
dell’evento che accade è per Sini l’ineludibile e inaggirabile
punto di partenza di qualsiasi prassi e di qualsiasi pensiero. In
esso e per esso accade ogni rapporto con l’altro, con quell’altro che
non può che essere visto come una “figura” dello stesso, una sua
“necessità”, una sua posizione. L’origine, come sostiene Sini in
contrasto con qualsiasi forma di platonismo o neo-platonismo40, è
39 E1, p. 40.40 Cfr. MC, p. 107.
20
il Due, la monade, l’evento, la fessura, il nulla che accade, la
soglia41. Per questo ogni “alterità” le è negata. Non però in nome
di un chiuso solipsismo, essendo la monade sempre aperta, sempre
in contatto continuo innanzitutto con il corpo dell’altro, con la
carne del mondo, direbbe Merleau-Ponty, cui tutti apparteniamo.
L’alterità negata a questo Due come origine è l’alterità
dell’altro come possibile, come Uno da cui proviene e il cui
passaggio rappresenta per Vitiello un “mistero”.
Per questo, ancora una volta, la soglia, per dir così, non ha da
“rimproverarsi” questo suo carattere cannibale. Il vacuum sempre
accadente della soglia è infatti per Sini l’origine, l’unica
origine che c’è, ed è perciò impensabile impoverire le sue
determinazioni per sollevarsi al problema di relazionarsi con
un’impossibile origine “prima” di questa origine. Per Sini,
differentemente che per Vitiello, il pensiero, in un certo senso,
“va bene così com’è”. Il passaggio, il salto, la rivoluzione, sta
nel diverso abito del soggetto, nella diversa postura assunta nei
confronti delle proprie prassi e dei propri saperi, non in una
necessità di trovare “strade alternative”, nuove grammatiche del
pensiero che spingano il soggetto ad impoverire i propri contenuti
aggiungendo parallelamente possibilità alla possibilità
dell’altro, dal momento che tale “altro” per Sini non è (nemmeno è-
possibile), o è casomai ancora una volta il “sogno” dell’origine
ora/qui della soglia.
La necessità kenotica di Vitiello sorge invece dall’esigenza di
confrontarsi con il “suo” Uno, con l’Uno sempre altro, sempre
possibile, Uno che “precede” l’intreccio di pratiche, che non è
l’Uno/Tre (che, a sua volta, non era che un Due e così via), ma41 E5, p. 101.
21
che è, diciamo così, il presupposto di questo movimento, di questo
ritmo, la possibilità del suo accadere o non accadere (e anche
l’impossibilità del suo accadere e non accadere).
Vitiello, come abbiamo già visto, per conservare fino in fondo
questa estrema possibilità dell’altro (tale da non essere solo
possibilità dei suoi contrari, ma da piegarsi anche su di sé),
arriva ad ammettere che esso coincida con lo stesso, con quanto ne
dice il parlante. Ora, proprio questa coincidenza sarebbe per Sini
impossibile, dal momento che la verità è per lui sempre distanziata
rispetto al suo evento, ma proprio per questo sempre vera nel suo
errore, mai “inadeguata”, mai necessaria di sottrazione.
Questa differenza tra le due prospettive è data, come abbiamo
visto, dal fatto che la distanza/errore della verità si gioca su
due coppie di poli differenti. Distanza del Due dal Tre per Sini
(sicché inevitabilmente il Due non potrà mai essere ciò che il Tre
ne dice, ma proprio perciò è sempre vero nel suo errore), distanza
del Tre dall’Uno (il “suo” Uno, l’Uno come mistero, come
possibile) per Vitiello (con la conseguenza di una parola che non
è mai verità, perché sempre sospesa alla possibilità che l’altro
sia/non sia ciò che la parola ne dice). Cerchiamo a questo punto
di capire quali profonde differenze di ethos, prima ancora che di
teoria o di pensiero, siano implicite in queste diverse posizioni,
per poi cercare di delineare quale in quale luogo esse trovano
dimora.
L’ETHOS
22
Parlare di ethos, di etica del pensiero, significa mostrare la
consapevolezza che le parole del linguaggio metafisico, le parole
della tradizione filosofica occidentale, non sono più sufficienti
a rapportarsi, direbbe Heidegger, con la cosa stessa della filosofia,
motivo per cui è necessario un nuovo atteggiamento nei confronti
del sapere. Il senso di questa inadeguatezza, di questa mancanza,
di questa insufficienza del linguaggio tradizionale, è pienamente
avvertito da entrambi i nostri autori. Mentre però esso si traduce
per Vitiello nella necessità di elaborare nuove forme di pensiero,
come osservato attraverso le tematiche della kenosi, della
testimonianza, della possibilità im-possibile, della logica della
seconda persona, per Sini il vero cambiamento di prospettiva, il
vero salto, risiede nell’assunzione, da parte del soggetto, di una
nuova postura nei confronti di ogni sapere e di ogni linguaggio,
anche (e soprattutto) di quello della tradizione occidentale,
metafisica, filosofica.
L’obiettivo di Sini è infatti quello di porre l’attenzione sulla
pratica stessa, su quello che è in atto nel mentre si fa ciò che
si fa, sulle conseguenze che questo fare produce, compresi i
problemi che esso pone. Il “problema” dell’evento, delle pratiche,
della soglia, dell’Uno, Due, Tre, dell’origine, così come
qualsiasi altro problema filosofico, diventa perciò del tutto
indifferente, sul piano del contenuto, del significato, in relazione
alla svolta etica verso cui Sini vuole condurre il lettore. Ogni
tematica, ogni questione proposta da Sini ha infatti valore di
puro “indice”, di espediente pratico avente l’obiettivo di
soffermare l’attenzione del lettore sulla sua stessa prassi, di
suscitare in lui un esercizio autobiografico di riconduzione delle
proprie verità alle pratiche da cui traggono origine, comprese, in23
modo certo del tutto problematico e paradossale da pensare, quelle
verità che parlano di pratiche, di eventi, soglie o quant’altro.
La “torsione di sguardo” che Sini promuove è dunque tutta
incentrata sugli effetti (Peirce: siamo là dove produciamo effetti)
impliciti in ogni nostro dire o fare (di qui tutto il tema delle
pratiche, assente in Vitiello). In Vitiello invece si ha sempre
l’impressione, leggendo i suoi testi e le sue argomentazioni, che
il “problema” principale sia comunque quello dell’Uno, del Due,
della possibilità im-possibile, del mistero (pur con la profonda
consapevolezza etica che spinge il lettore a testimoniare, a
parlare in seconda persona, a impoverire le proprie
determinazioni, etc.). In Sini invece il “problema”, se così si
può dire, diventa quello di guardare alla pratica che si sta
frequentando mentre ci si pongono determinati problemi (filosofici
come di ogni altro tipo). Sini invita insomma a guardare cosa si
sta facendo, a vedere le questioni sollevate come conseguenze del
fare, della prassi nella quale si è, spesso ciecamente, immersi.
Il fatto che Vitiello, pur con la massima consapevolezza di ogni
inganno e paradossalità nascosti come trappole dietro alle gabbie
del dire metafisico, rimanga convinto della necessità che la
questione si giochi sul piano del dire, del parlare, è
riconosciuta da lui stesso, in risposta ad un’obiezione
avanzatagli indirettamente da Sini e da lui riportata in Filosofia
teoretica42. Egli infatti, mosso dall’obiezione siniana a guardare
alle «concrete operazioni»43 che sorreggono la produzione dei suoi
contenuti, in questo caso dei contenuti della topologia44, risponde
che «L’apertura come tale, l’evento come tale, la pratica come tale –42 Cfr. FT, pp. 280-282.43 Ibidem.44 Altra grande tematica ermeneutica del cammino filosofico di Vitiello.
24
non possono essere ridotte a “oggetto” di visione. E tuttavia la
filosofia non può fare a meno di parlare di essi»45. E ancora:
«Già, perché è questa la sfida della topologia: horizein to aoriston,
dare immagine a ciò che non può avere immagine, icona all’aidos»46.
Se guardiamo i problemi da questo punto di vista, possiamo
osservare come sia Vitiello che Sini compiono un passo avanti e un
passo indietro rispetto ai problemi posti, ma in un senso, per così
dire, specularmente inverso.
Potremmo dire così. Dal punto di vista del sapere, in Vitiello c’è un
tentativo di fare un passo avanti, che consiste nel dirigersi comunque
verso un tentativo di “risposta”, che è consapevole della propria
finitudine, necessaria di kenosi, etc., ma è comunque una risposta.
In che senso? Nel senso che il suo tentativo è quello di
sporgersi47, di gettare uno sguardo “oltre”, uno sguardo in seconda
persona, testimoniante, “in segreto”, contra-dittorio, ma pur
sempre uno sguardo, ossia un’azione che si pone l’obiettivo di
“vedere” cosa c’è di là, nel Mistero, nel passaggio dall’Uno ai
molti. Da un punto di vista del sapere come fare, come azione, il
suo però è un passo indietro, ossia un passo rivolto a interrogare i
limiti (esterni e interni) del suo discorso, non rivolto alle
“conseguenze” che il discorso produce.
In Sini la situazione è esattamente capovolta. Dal punto di vista
del sapere infatti, il suo è un passo indietro. Egli, in relazione alla
domanda (come ad esempio quella che potrebbe porre Vitiello circa
45 Ibidem.46 Ibidem.47 Come egli dice esplicitamente in un dialogo con Sini alla Casa della cultura,in occasione della presentazione dei suoi testi Ripensare il cristianesimo e Oblio ememoria del sacro, riportato sul sito dell’associazione. Cfr.http://www.lospaziodellapolitica.it/audio/20090203_vitiello.mp3, consultato il3/3/2010 alle 17.09.
25
l’Uno, il Mistero, il passaggio dall’Uno ai molti etc.) non si
dirige, come fa Vitiello, verso la risposta (seppure in modo
“eticamente” consapevole, attraverso tutte le strategie mostrate:
logica della seconda persona, pensiero kenotico, testimonianza
etc.), ma si sofferma sulla domanda stessa (per questo compie un
passo indietro e non un passo avanti). Di fronte alla domanda di
Vitiello che si interroga su come sia accaduta la divisione
dell’Indiviso originario48, ad esempio, Sini non tenterebbe di
rispondere, ma obietterebbe: «guarda cosa stai facendo mentre ti
poni questa domanda», collocati sulla soglia del tuo stesso fare e
domandati “a partire da che” ti è possibile porre queste domande.
Potremmo dire che mentre Vitiello promuove un’“etica della
risposta” (cioè un modo di rispondere alle varie domande
riguardanti l’Uno e il Due che sia consapevole della riduzione di
ogni Uno/Due a Tre, del fatto che ogni parola è inadeguata,
bisognosa di impoverimento, sempre destinata ad essere una
«maschera» o «icona» del «Senzavolto»49), Sini introduce invece
l’istanza di un’“etica della domanda”, che “sospende” la risposta
ancor prima che tenti di “dire” alcunché, invitandola ad abitare
il luogo del suo stesso domandare. Per questo tale pratica, tale
etica, dal punto di vista del sapere come “fare”, come “azione”,
compie un passo avanti, perché guarda alle conseguenze prodotte dalla
sua stessa pratica. Sini è consapevole della portata “etico-
politica” del suo esercizio, di come esso implichi una diversa
“postura” del soggetto nei confronti del sapere, di come cioè la
sua stessa proposta filosofica, il suo stesso discorso, vada messo
tra parentesi, vada inteso come provocazione etica atta a produrre
48 Cfr. TM, p. 140.49 FC, p. 140.
26
quella torsione di sguardo di cui parlavamo prima. I testi di Sini
esigono una seconda lettura50, che “sospenda” i contenuti trasmessi
e utilizzi quegli stessi contenuti come occasione di esercizio.
Ecco, in Vitiello sembra mancare l’istanza di questa seconda
lettura, proprio perché egli inverte l’ordine siniano del passo
avanti e del passo indietro. La seconda lettura non si rende necessaria
poiché non c’è alcun passo indietro verso la domanda e nessun passo
avanti verso le conseguenza etiche del domandare stesso. C’è invece
un passo avanti (pur condotto in modo “eticamente” consapevole, cioè
sapendo abitare il carattere menzognero, iconico delle parole, che
necessitano di essere impoverite: anche per Vitiello dunque le
parole sono “espedienti etici” ma, potremmo dire, espedienti per
“dire” e non per “fare”) verso la risposta e un passo indietro verso i
luoghi (Uno e Due) cui la risposta conduce, ma non verso le
conseguenze, gli effetti di questo stesso dire, domandare,
interrogare, rispondere.
Quale dunque il “luogo” del pensiero abitato dai nostri autori,
alla luce delle considerazioni svolte? Proviamo a dirlo in questo
modo. Il luogo del pensiero di Vitiello è un non-luogo, una utopia,
nel senso del termine proposto in Utopia del nichilismo51, dove utopia
dice «il medesimo che: estraneità, differenza»52. Il pensiero di
Vitiello abita il luogo della distanza dall’origine, dall’Uno, il
luogo dell’abisso che separa l’umano dal divino, percorrendo le
strade che portano a sostare, secondo un’immagine più volte
ripresa da Vitiello, nell’exaiphnes, nell’in-stante platonico,
nell’instabile dimora che continuamente oscilla tra alterità e
prossimità, tra reale e possibile. La frattura, per Vitiello, non50 Come evidenziato da E. Redaelli in NN, p. 51 Cfr. la «Premessa» in UN.52 Ibidem.
27
può essere ricomposta, nessuna parola è in grado di farlo. Non per
questo però il pensiero deve cessare di interrogare l’origine, di
rapportarsi al mistero, nella consapevolezza che «tutte le
esperienze sono sospese alla Verità che può negarle – tutte.
Questo esser sospesi alla possibile impossibilità della Parola, di
tutte le Parole, è il legame che tutti ci affratella. Il legame di
un medesimo destino di finitezza – da cui non c’è redenzione,
perché l’unica redenzione dalla finitezza è la morte»53.
Il luogo del pensiero di Sini è invece, secondo un’espressione da
lui spesso usata, evidente perifrasi di un celebre motto nicciano,
un «via da tutti i luoghi»54, un’«esplosione multiversa»55 chiamata
ogni volta da capo a tracciare il suo donde e il suo verso dove.
Un luogo, dunque, che non ha nella relazione con l’origine la sua
dimora privilegiata, sebbene ad essa, con tutti i conseguenti
paradossi, non rinunci a rapportarsi. Un luogo che invece getta
uno sguardo verso il suo destino, verso le conseguenze, verso gli
effetti, nella piena consapevolezza di non poter disporre del
senso di essi, di non poter controllare e governare dall’alto il
corso degli eventi, ma di esporsi, peircianamente,
all’interpretazione altrui, unica vera custode della sua vita e
del suo sapere.
Il luogo del pensiero di Sini è dunque il luogo dell’evento, visto
però non come “nozione teoretica” da apprendere, ma piuttosto come
occasione etica di esercizio da ripetere “sempre di nuovo”, nella
consapevolezza che ogni nuovo pensiero, ogni nuova parola, lungi
dal catturare il segreto dell’evento, dell’origine, dell’universo,
non fa che replicarne la kinesis, prendendo anch’esso luogo nel suo53 DP, p. 29.54 MC, p. 78 e pp. 106-107.55 Ibidem.
28
essere via da ogni altro. Un luogo, dunque, che assume i caratteri
di un «pianeta errante, albergante, come la navicella di Nietzsche, la
sua verità nelle figure transeunti dell’essere in errore. Pianeta
errante che porta con sé, come un’astronave lanciata nello spazio,
tutti i suoi “materiali” e tutti i suoi “viventi”. Messaggero che
percorre lo spazio nella globale ricerca di un’origine e perciò di
un destino: desiderio di condivisione del suo diventare ciò che è»56.
56 MC, p. 137.29
BIBLIOGRAFIA E SIGLE
TESTI DI CARLO SINI
- C. Sini, Passare il segno. Semiotica, cosmologia, tecnica, Il Saggiatore,
Milano 1981 (PS).
- C. Sini, Immagini di verità. Dal segno al simbolo, Spirali edizioni,
Milano 1985 (IDV).
- C. Sini, Filosofia e scrittura, Laterza, Roma 1994 (FS).
- C. Sini, La materia delle cose, Cuem, Milano 2004 (MC).
- C. Sini, Figure dell’enciclopedia filosofica, Jaca Book, Milano 2004-2005:
Libro primo. L’analogia della parola. Filosofia e metafisica (E1)
Libro terzo. L’origine del significato. Filosofia ed Etologia (E3)
Libro quinto. Raccontare il mondo. Filosofia e cosmologia (E5)
- C. Sini, Archivio Spinoza. La verità e la vita, Edizioni Ghibli, Milano 2005
(AS).
- C. Sini, Da parte a parte. Apologia del relativo, Ets, Pisa 2008 (AR).
30
TESTI DI VINCENZO VITIELLO
- V. Vitiello, Utopia del nichilismo. Tra Nietzsche e Heidegger, Guida, Napoli
1983 (UN).
- V. Vitiello, Dire il silenzio, in «Filosofia ’90» (a cura di G.
Vattimo), Laterza, Bari 1991 (DS).
- V. Vitiello, Filosofia teoretica. Le domande fondamentali: percorsi e
interpretazioni, Bruno Mondadori, Milano 1997 (FT).
- V. Vitiello, La favola di Cadmo, la storia tra scienza e mito. Da Blumemberg a
Vico, Laterza, Roma 1998 (FC).
- V. Vitiello, Il Dio possibile. Esperienze di cristianesimo, Città nuova, Roma
2002 (DP).
- V. Vitiello, Grammatiche del pensiero. Dalla kenosi dell’io alla logica della
seconda persona, Ets, Pisa 2009 (GP).
31