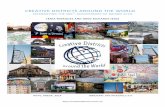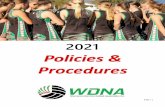I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]
Transcript of I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]
VENETO AGRICOLTURA
I DISTRETTI RURALI: UNA PROPOSTA DI ANALISI
Quirino Biscaro (Università di Venezia)
Ferruccio Bresolin (Università di Venezia)
Pietro De Lotto (Università di Trieste)
12 aprile 2004
INDICE
I. IL DIBATTITO SUI CARATTERI TERRITORIALI DEI SISTEMI
RURALI
I.1 Le unità di indagine
I.2 La filiera agroalimentare
I.3 Le teorie sulla localizzazione e sulle caratteristiche territoriali delle attività
agricole
I.3.1 Le prime teorie spaziali della Geografia Economica
I.3.2 Le moderne teorie-base sulla localizzazione
I.3.3 Il dibattito internazionale
I.3.4 Il dibattito nazionale
I.4 Alcuni approfondimenti sui caratteri territoriali dei sistemi agricoli
I.4.1 La contiguità territoriale delle attività agroalimentari
I.4.2 Le strategie localizzative delle grandi imprese
I.4.3 La dimensione territoriale delle attività agricole e agroindustriali
I.4.4 Le procedure ottimali per la soluzione dei problemi di dimensione e
localizzazione territoriale
I.5 Il dibattito distrettuale
I.5.1 Visione distrettuale, visione "atomistica", visione istituzionale
I.5.2 Distretto agricolo-rurale e agroalimentare: concetto tecnico o culturale ?
Bibliografia
II. IL DISTRETTO NELLA PROGRAMMAZIONE PUBBLICA
II.1 L'impostazione nazionale
II.2 La "declinazione" regionale delle normative nazionali
II.3 La nuova normativa della Regione Veneto
II.3.1 Un commento del DDL della Regione Veneto "Disciplina dei Distretti
Produttivi ed Interventi di Politica Industriale Locale"
Bibliografia
III. CARATTERI E FATTORI DETERMINANTI DI UN DISTRETTO
III.1 Perché programmare i fattori dello sviluppo distrettuale anziché i settori
della produzione
III.2 Fattori distrettuali di base
III.3 Fattori distrettuali "trasversali"
III.3.1 Produttività e competitività
III.3.2 Economie di agglomerazione.
III.3.3 Credito e finanza
III.3.4 Formazione
III.4 Un fattore distrettuale specifico: il lavoro
Bibliografia
IV. IL RUOLO DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE NON-MARKET
INTERACTION
IV.1 Le non-market interaction come premessa, e non come alternativa, al ruolo
del capitale sociale
IV.1.1 Effetti delle non-market interaction sul tasso di crescita
IV.2 Il capitale sociale
IV.2.1 Il ruolo del capitale sociale sui processi di sviluppo
IV.2.2 Il ruolo delle istituzioni
IV.2.3 I beni pubblici locali
IV.2.4 Alcuni principi di base connessi alle istituzioni locali
IV.2.5 Come inquadrare le istituzioni locali
IV.2.6 La programmazione economico-territoriale
IV.2.7 Caratteristiche delle istituzioni per lo sviluppo locale
Bibliografia
V. METODOLOGIE QUALI-QUANTITATIVE PER LA DELIMITAZIONE
DEI DISTRETTI RURALI
V.1 Criteri logico-qualitativi
V.2 Criteri quantitativi
V.2.1 La fonte informativa
V.2.2 Le unità di analisi
V.2.3 La procedura
V.2.3.1 Indicatori puramente territoriali
V.2.3.2 Indicatori demografici e del mercato del lavoro
V.2.3.3 Indicatori della struttura dimensionale delle aziende
V.2.3.4 Indicatori dei sistemi di conduzione
V.2.3.5 Indicatori di specializzazione produttiva
VI. TIPOLOGIE DI DISTRETTO RURALE
VI.1 Le politiche comunitarie come origine di scenari distrettuali
VI.2 Aree territorialmente omogenee di tipo rurale
VI.2.1 Distretti rurali-produttivi di qualità
VI.2.2 Distretti rurali-produttivi intensivi
VI.2.3 Distretti rurali-turistico ambientali
VI.3 Gli obiettivi dell'individuazione-delimitazione dei distretti rurali
1
I. IL DIBATTITO SUI CARATTERI TERRITORIALI
DEI SISTEMI RURALI
I.1 Le unità di indagine
Non v'è dubbio che molte analisi sull'agricoltura in quanto attività economica su base
territoriale, ed in particolare delle relazioni che la stessa intrattiene con altri settori
produttivi, prendono spunto, direttamente o indirettamente, dagli studi di J.H. Davis e
R.A. Goldberg (A concept of agribusiness, 1957).
Questi filoni di ricerca sono floridi anche nel nostro Paese, e si sono sviluppati lungo
due grandi linee tematiche, che sostanzialmente differiscono per il livello di
aggregazione delle unità d'indagine:
in De Castro e Furesi 1990, come pure in Scarano 1997, ad esempio, l'oggetto
dell'indagine sono i sistemi agroalimentari complessivamente considerati;
in altri contributi, come Fanfani e Montresor 1991 e 1994, e Iacoponi 1994a e 1994b,
si è accentrata l'attenzione su sottosistemi quali le filiere agroalimentari e i sistemi
che ruotano attorno a grandi imprese agroalimentari.
Ai fini della presente indagine, però, sembra opportuno riferirsi agli studi di
Malassis, in quanto si ritiene che in tali analisi si possano ritrovare validi spunti per il
dibattito della relazione tra attività agricole e altri settori produttivi. Tali spunti sono
individuabili soprattutto in Malassis 1973 e Malassis e Ghersi 1996, contributi dai quali
emergono fondamentali chiavi di lettura del dibattito in oggetto :
l'abbandono della prospettiva puramente e rigidamente settoriale;
il ruolo da assegnare al contesto storico;
il ruolo da assegnare alle componenti non agricole dei sistemi agroalimentari, come
ad esempio la distribuzione;
il passaggio dalla visione che assegnava un peso centrale ai mercati dei prodotti
agricoli a quella che invece privilegia le filiere.
2
I.2 La filiera agroalimentare
Ovviamente Malassis non è l'unico che sviluppa l'approccio per filiera1: si possono
infatti ritrovare ulteriori validi spunti in Scarano 1989, Fanfani e Montresor 1991 e
1994, De Muro 1992, Belletti 1992, Iacoponi 1994a e 1994c, Stefani 1994. È però
indubbio che la sua definizione di filiera agroalimentare (Malassis 1973) è piuttosto
utile poiché mette in luce tutti le fasi ed i "meccanismi" che nella filiera coordinano i
flussi di produzione. In pratica, la visione di filiera sviluppata da tale autore consente di
valutare tutte, nessuna esclusa, le componenti di qualsiasi variabile di tipo economico e
socio-politico.
Nell'assumere una determinata concezione della filiera, ci si scontra con la miriade di
sfaccettature introdotte sul concetto dall'abbondante dibattito sul tema. Per un policy-
maker è però necessario adottare una linea di condotta ben precisa. A tal fine va rilevato
che al decisore pubblico probabilmente risulta utile arricchire la visione di Malassis con
quella di altri autori (Belletti 1992a e 1992b; Belletti, Giancani, Marescotti e
Scaramuzzi 1994; Iacoponi 1994a e 1994c; Stefani 1994), che presentano i seguenti
vantaggi:
abbinano ai vantaggi tipici degli approcci quantitativi (come, ad esempio, quello
delle tavole input-output) quelli derivanti dall'inclusione di variabili qualitative;
danno il giusto peso al processo produttivo inteso come tecnica di produzione in
senso stretto;
individuano i confini di filiera sulla base degli elementi ai due punti precedenti.
I.3 Le teorie sulla localizzazione e sulle caratteristiche territoriali
delle attività agricole
I.3.1 Le prime teorie spaziali della Geografia Economica
È stato J. E. Von Thunen nel 1829 (Der Isolierte Staat) il primo autore ad elaborare
una compiuta teoria dell'uso razionale del territorio. È noto che in Der Isolierte Staat si
1 Per una più approfondita analisi dell’approccio per filiere si rimanda a
3
fa un evidente utilizzo della rendita di Ricardo, con una importante variante: ciò che
spiega l'uso del territorio non è il grado di fertilità ma i costi di trasporto generati dalla
distanza che intercorre tra luogo di produzione e mercato di sbocco.
Gli studi di Von Thunen, però, non sfociano in una vera e propria teoria della
localizzazione. Per un primo ma fondamentale passo in tale direzione si deve aspettare il
1909, anno in cui Weber pubblica Reine Teorie des Standorts.
Da quel momento seguiranno una vastità di contributi sul tema, peraltro molti dei
quali tentano di rilassare alcune ipotesi di Weber, unanimemente ritenute
eccessivamente restrittive; gran parte di questi studi non fanno altro che applicare i
dettami della teoria neoclassica alle teorie della localizzazione.
Si deve poi aspettare la metà del secolo scorso perché il concetto di distanza, che
ovviamente è la pietra angolare di qualsiasi teoria di localizzazione, si arricchisca di
contenuti, nel senso che non conta più soltanto la distanza fisica ma la distanza nei costi,
nelle opportunità di mercato, ecc.. Ciò non poteva non avere l'effetto di mettere in
secondo piano la visione neoclassica della localizzazione, poiché concetti qualitativi di
distanza, come ad esempio la distanza sociale, mal si prestavano per "meccanismi"
quantitativi come quelli che, nel pensiero neoclassico, regolano gli equilibri di mercato.
Ma non è solo questo che negli anni '50 e '60 mette in crisi le teorie neoclassiche
della localizzazione. Non si possono infatti dimenticare fatti che Galbraith 1988 e
Lazonick 1993 ben sottolineano:
il diffondersi della visione keynesiana dell'economia (ruolo dello Stato);
il fatto che i mercati non sono pervasi di piccoli, uguali e innumerevoli operatori
(cominciano ad affermarsi le grandi imprese, e l'oligopolio appare sempre più
frequentemente come alternativa alla concorrenza perfetta).
Sempre negli anni '50 e '60 appaiono le prime teorie di sviluppo di tipo locale
(Myrdal 1957, Hirschmann 1958, Hicks 1959) che accreditano il ruolo delle teorie di
localizzazione. Infatti lo sviluppo economico regionale sarebbe sostanzialmente il
risultato di processi localizzativi che trovano origine nelle fasi di disequilibrio
economico-territoriale.
4
I.3.2 Le moderne teorie-base sulla localizzazione
Esistono due visioni fondamentali nelle teorie della localizzazione: la visione
strutturalista (vedi ad esempio Dicken e Lloyd 1997) e quella comportamentista (vedi
ad esempio Healey e Ilbery 1990). Gli economisti che appartengono alla prima non
ritengono che esistano teorie generali che, indipendentemente da fattori contestuali al
sistema territoriale, possano descrivere tutti i processi localizzativi, in pratica si ritiene
che la localizzazione in un certo territorio dipenda strettamente dal contesto locale. Gli
economisti che invece appartengono alla visione comportamentista, partendo da analisi
empiriche sulle effettive scelte localizzative, tentano di derivare teorie generali che
spiegano le stesse omettendo il ruolo dei caratteri storico-geografici.
Al di là di queste due impostazioni generali, v'è chi tenta di spiegare i fenomeni
localizzativi assegnando un ruolo determinante a fattori specifici. Tra questi va
menzionato, ad esempio, il fattore tecnologico. Riguardo ad esso, è innegabile l'impatto
localizzativo che può avere l'evoluzione tecnologica nel campo dei trasporti (Finardi e
Tombola 1995, Marchese 1996). Al di là del ruolo specifico dei trasporti, è evidente
che, più in generale, ogni qualvolta le innovazioni modificano le varianti produttive vi
possono essere dei paralleli input localizzativi. Un secondo fattore che può influenzare i
fenomeni localizzativi è quello dell'organizzazione delle attività economiche (Conti
1996). Va notato che la relazione tra organizzazione dell'attività e localizzazione è
biunivoca, quindi se è vero che determinate soluzioni organizzative influiscono sulle
scelte localizzative, è altrettanto vero che specifici contesti locali di per sé stimolano
l'innovazione di tipo organizzativo.
Infine, se si considerano le specificità delle attività agricole, un elemento
innegabilmente determinante nelle teorie localizzative sono i fattori di tipo naturale
(Paterson 1984).
I.3.3 Il dibattito internazionale
Per quanto riguarda il pionieristico contributo di Von Thunen, è noto che i suoi studi
hanno subito notevoli evoluzioni e integrazioni, ma, per quanto riguarda la
localizzazione agricola in particolari contesti territoriali, v'è chi ritiene (Berry, Conkling
5
e Ray 1993, Conti 1993, Formica 1996) che l'impostazione di tale autore2 possa ancora
in qualche modo spiegare i fenomeni localizzativi.
Lo studio dei caratteri territoriali dell'agricoltura è stato generalmente impostato in
termini di capacità di attrazione di uno specifico territorio nei confronti delle aziende,
mentre è molto rara la visione opposta: su questo versante è da considerare l'analisi di
Knox e Agnew 1996 dove si analizzano fenomeni localizzativi che nascono da una
strategia puramente aziendale, come il caso delle multinazionali agricole.
Ulteriori evoluzioni del dibattito avviato da Von Thunen, ma anche da Weber, hanno
portato a sviluppi quali lo studio della dimensione territoriale dei sistemi agricoli
complessivamente considerati (Grigg 1974), come pure dell'effetto localizzativo delle
relazioni che intercorrono tra le attività agricole e le altre attività economiche (Scarpelli
1994).
Anche l'impostazione di Weber ha suscitato un ampio dibattito a livello
internazionale. L'evoluzione dei concetti weberiani è stata tale che oramai si ritiene che
la capacità interpretativa del modello originario sia oramai alquanto ridotta. Il motivo di
ciò è che l'analisi weberiana è sostanzialmente quantitativa, mentre invece oggi giorno
si riconosce l'importanza di dimensioni qualitative che derivano, ad esempio, dal fatto
che gli operatori economici non sono perfettamente razionali. In ogni caso si deve
rilevare che il ruolo delle distanze per il trasporto di alcuni prodotti agricoli può avere
ancora un pur parziale impatto sulle scelte localizzative; vi sono alcuni studi, come
Merlini 1970, Estall e Buchanan 1973, Laulajainen e Stafford 1995, che hanno infatti
evidenziato la rilevanza empirica di alcuni concetti weberiani.
Come è noto, il dibattito internazionale inerente le teorie localizzative non si è
sviluppato solamente lungo la direzione tracciata da Von Thunen e Weber, ma, come
prima evidenziato, ha dato origine a un corposo dibattito opponendo il filone
strutturalista a quello comportamentista. Volendo sintetizzare tali sviluppi teorici, oltre
a quanto già rilevato su questi due approcci, è opportuno aggiungere queste
constatazioni:
2 Come già prima evidenziato, si fa riferimento all'impatto localizzativo delle rendite differenziali
generate dalle distanze dai mercati, e quindi dai costi di trasporto.
6
il filone strutturalista ha ampiamente sottolineato l'impatto di fenomeni quali la
globalizzazione, modelli produttivi non più basati sull'economia di scala ma sulla
flessibilità, processi di ristrutturazione delle imprese di più grandi dimensioni;
il filone comportamentista ha dato largo peso alle analisi empiriche; come si può
desumere da Chapman e Walker 1991, molte di queste analisi pongono attenzione
agli elementi che caratterizzano il processo decisionale che porta un agente
economico alla scelta localizzativa, come ad esempio le procedure decisionali e la
varietà del set delle preferenze.
Riguardo all'approccio comportamentista, vale la pena di osservare che il peso
assunto dalle indagini empiriche ha paradossalmente limitato l'obiettivo finale, se così si
può dire, dell'approccio stesso, cioè elaborare teorie localizzative generali basate sul
comportamento degli operatori (e non degli specifici contesti storico-geografici): ciò
perché, come desumibile da Watts 1993 e Laulajainen e Stafford 1995, tali indagini
hanno palesato la grande varietà di tali comportamenti.
I.3.4 Il dibattito nazionale
Nel nostro Paese esiste un dibattito rilevante sulle relazioni tra la localizzazione delle
attività agricole ed il generale processo di sviluppo economico. Per una rassegna
esaustiva di questo filone di studio si rinvia a Fanfani e Montresor 1991 e 1994, De
Rosa 1996 e 1997a.
Sintetizzando quanto rilevato in tali contributi, si può ritenere che:
generalmente l'analisi di filiera si rivela incompleta poiché, se da un lato ben
approfondisce gli effetti della stessa verso il territorio, dall'altro lato non fa
altrettanto sull'influenza che il contesto territoriale esercita verso la filiera;
in molti casi l'analisi di filiera è strettamente collegata all'analisi distrettuale, ma i
distretti agricoli, agroindustriali e rurali non sempre posseggono una ben delineata
connotazione territoriale.
7
Altri autori affrontano validamente il tema dei caratteri territoriali della filiera, come
ad esempio Bagarani, Magni e Mellano 1988, Iacoponi 1990 e 1995c, Cecchi 1992,
Favia 1992 e Carbone 1992.
Un'interessante sviluppo di questo dibattito può ricollegarsi, ad esempio, a Brunori
1995 e 1999, che richiama il concetto di network, successivamente ampliato e
approfondito in Iacoponi 2001a. L'attività di localizzazione, infatti, può dar luogo non
solo ad un distretto puro e semplice, ma ad una struttura territoriale definibile come
network, cioè, come si legge in Iacoponi 2001a, "un sistema di organizzativo intermedio
tra mercato e organizzazione aziendale, nel quale la transazione non avviene attraverso
lo scambio di mercato né attraverso imposizioni amministrative, ma attraverso reti di
relazioni preferenziali e cooperative di reciproco sostegno". Su questa stessa posizione
si allineano Zan 1987 e Cooke e Morgan 1993.
Il network appare come la migliore opportunità di sopravvivenza per l'impresa
agricolo-rurale, soprattutto se impegnata su più fronti: coltura, allevamento, agriturismo
(Iacoponi 2001a). Un'impresa agricola complessa deve giocoforza destrutturarsi, cioè
utilizzare servizi produttivi esterni; il network facilita questa modalità operativa.
Va notato che esiste un'alternativa al network, concetto sostanzialmente produttivo,
che fa propendere l'impostazione distrettuale verso funzioni ambientali. Si tratta del
concetto di bioregione (Iacoponi 2001b), che riconoscerebbe all'impresa agricola un
ruolo non solo razionale-economico ma di grande spessore pubblico (Iacoponi 2001a),
di raccordo fra sistemi diversi (Magnaghi 2000). Infatti, la bioregione, soprattutto
nell'accezione nord-americana (molto più delineata dell'accezione europea), è un
sistema territoriale che consente di mettere in luce una funzione agricola poco
appariscente ma fondamentale, quale la gestione coordinata e interattiva del territorio: in
altri termini, un sistema territoriale che consente la sostenibilità delle attività umane
(Simonis 1997, Diffenderfer e Birch 1997). È nell'aggregazione territoriale di imprese
agricole secondo i dettami della bioregione che è più chiaro e netto il passaggio dal
sistema produttivo agricolo al sistema rurale. Tale modalità di aggregazione territoriale
possiede, in sintesi, i seguenti caratteri:
1. gli aspetti socio-culturali non vengono offuscati da quelli produttivi;
2. si affronta concretamente il tema della sostenibilità ambientale dell'uso del territorio;
8
3. emerge pienamente il ruolo ambientale dell'impresa agricola.
I.4 Alcuni approfondimenti sui caratteri territoriali dei sistemi
agricoli
Nella letteratura specialistica nazionale ed internazionale si possono individuare
alcuni filoni d'indagine che costituiscono un approfondimento dei grandi temi della
localizzazione prima discussi, con validi spunti per le teorie localizzative, per le analisi
di filiera e di distretto. Si sta facendo riferimento a:
la contiguità territoriale delle attività agroalimentari;
le strategie localizzative delle grandi imprese;
la dimensione territoriale delle attività agricole e agroindustriale
le procedure ottimali per la soluzione dei problemi di dimensione e localizzazione
territoriale.
I.4.1 La contiguità territoriale delle attività agroalimentari
È evidente che le teorie basate sulla contiguità territoriale possono certamente offrire
un valido contributo nello studio della dimensione territoriale di una filiera
agroalimentare. Però, d'altra parte, si può andare al di là del concetto di contiguità
territoriale, soprattutto se si accoglie la definizione di filiera agroalimentare che si
ritrova in Malassis 1973 poiché in essa si fa riferimento soltanto agli operatori
economici e alle operazioni che essi fanno per ottenere il prodotto e per trasferirlo
all'utilizzatore finale.
Si possono trovare degli interessanti approfondimenti sui caratteri territoriali della
filiera in Belletti, Giancani, Marescotti e Scaramuzzi 1994, Belletti 1992b, Pacciani
1994, Pacciani, Belletti, Giancani, Marescotti e Scaramuzzi 1996.
9
I.4.2 Le strategie localizzative delle grandi imprese
Dalla rassegna contenuta in Fanfani e Montresor (1991 e 1994) emerge il ruolo delle
decisioni localizzative delle grandi imprese, in particolare le multinazionali
agroindustriali.
Gli spunti offerti da tale contributo sono stai però poco approfonditi, nonostante
appaiono evidenti i legami tra tale tematica e l'analisi di filiera. Il punto centrale è il
seguente: nonostante tali imprese si dotino di strategie globali, non si tratta di imprese
"virtuali" ma, come per tutte le altre imprese, anche per esse v'è il problema di stabilire
una localizzazione reale. Quindi, come tutte le altre, sono dotate di una dimensione
territoriale; il fattore di diversità è che si tratta di aziende di grandi dimensione, le cui
strategie localizzative impattano anche quelle di tutto il sistema agro-alimentare.
Altri contributi da citare sul filone delle strategie spaziali delle grandi imprese sono i
seguenti:
Connor (1983), che indaga il tema degli investimenti diretti esteri;
Perez (1996) e Tozanli (1996), che si occupano delle multinazionali agroalimentari.
I.4.3 La dimensione territoriale delle attività agricole e agroindustriali
In fatto di dimensione territoriale si possono isolare due prevalenti approfondimenti:
un approccio italiano, di tipo sostanzialmente quantitativo, che si fonda su
metodologie di analisi statistica (si considerino, ad esempio, Terrasi 1985, Ievoli
1986, Balestrieri 1988, Sopranzetti e Carbonari 1996, Henke e Sardone 1997 e
1998);
un approccio internazionale, prevalentemente qualitativo e imperniato sull'analisi
dimensionale in senso stretto, sulle determinanti localizzative, sull'impatto
dimensionale dei trasporti (si vedano Olson 1959, Henry e Seagraves 1960, French
1960, Williamson J.C. 1962, Blood 1964, Ulrey 1964, Lauth 1969, Nichols 1969,
Felton 1968, Sorenson 1973, Michaels, Levins e Fruin 1982, Beilock e Casavant
1984, Sorenson 1984, Fuller, Freeman e Beilock 1984, Nowak e Romanowska 1985,
10
Dunn, Lee e Thatch 1987, Amador e Starbird 1989 Lopez e Henderson 1989,
Leistritz 1992).
L'approccio italiano alla dimensione territoriale dei sistemi agricolo-rurali e
agroalimentari s'impernia più che altro su fonti statistiche nazionali, sull'individuazione
dell'unità territoriale di riferimento, sull'analisi di grandi imprese (anche multinazionali).
Nell'approccio più internazionale, invece:
per quanto riguarda le problematiche dimensionali in senso stretto, si riconsiderano
le tematiche originarie della localizzazione rispetto ai mercati di approvvigionamento
e di sbocco;
in relazione ai trasporti, si sviluppano non solo gli effetti della logistica, ma anche gli
impatti dimensionali che direttamente o indirettamente possono derivare da aspetti
specifici quali le politiche tariffarie, la regolamentazione pubblica, l'innovazione
tecnologica;
sulle scelte localizzative, si analizzano le determinanti prevalenti.
I.4.4 Le procedure ottimali per la soluzione dei problemi di dimensione e
localizzazione territoriale
Questo filone di studio fa abbondante uso di modelli matematici idonei a risolvere
problemi di minimizzazione e massimizzazione vincolata (si considerino Stollsteimer
1963, King e Logan 1964, Polopolus 1965, Bobst e Waananen 1968, Tyrchniewicz e
Tosterud 1973, Ladd e Lifferth 1975, Fedeler, Heady e Koo 1975, Von Oppen e Scott
1976, Kilmer, Spreen e Tilley 1983), tra i quali vale la pena di segnalare:
scelta localizzativa di impianti di trasformazione;
sub-ottimalità dei sistemi territoriali in presenza di regimi di mercato non
concorrenziali;
impatto del flussi commerciali sulla configurazione territoriale dei sistemi
agroalimentari;
organizzazione dei servizi di trasporto.
11
I.5 Il dibattito distrettuale
Considerare le imprese agricole alla stregua di qualsiasi altra PMI, dimenticandone
così la specificità, e quindi come entità che necessitano delle tradizionali politiche
territoriali3, farebbe propendere l'ago della bilancia verso il concetto di distretto
territoriale-produttivo. Se invece le imprese agricole sono viste come unità con attività
che impattano il territorio anche, pur se non solo, in senso biologico e ambientale, allora
si orienterebbe il policy-maker verso il concetto di distretto territoriale-ambientale.
Questo dubbio, d'altra parte, non è solo degli economisti ma ha anche una natura
giuridica. Si deve infatti rammentare l'uso "indifferente" dei concetti di sistema (o
distretto) produttivo e di sistema territoriale-biologico-ambientale, sia nel Codice Civile
(art. 2135) sia nel D.L. 228/2001. In Iacoponi 2001a si propende indirettamente verso il
concetto territoriale-produttivo, per due chiari motivi:
1. gli "spazi" biologici l'impresa agricola li dovrebbe contendere a multinazionali
farmaceutiche e biotecnologiche;
2. il carattere territoriale-produttivo consente una maggiore visibilità, e comunque è il
carattere più radicato.
I.5.1 Visione distrettuale, la visione "atomistica", la visione istituzionale
Il dibattito sui sistemi agricolo-territoriali non è inquadrabile solamente con una
visione nazionale ed una internazionale, oppure nell'accogliere le logiche del tipo Von
Thunen-Weber o nel loro diniego, ma ha una chiave di lettura trasversale nella quale i
fattori discriminanti sono le teorie economiche che spiegano i meccanismi dei mercati e
dei processi di sviluppo.
Seguendo questa impostazione, è noto che la più evidente critica all'efficienza del
distretto proviene dagli economisti agrari di impostazione neoclassica. Il motivo è
chiaro: la teoria neoclassica, e tutti i suoi successivi sviluppi, fondandosi sull'atomismo
del mercato, sulla piena razionalità degli operatori, sulla perfetta trasferibilità dei fattori
e sulla completa conoscenza di tutte le informazioni (Walras 1876, Dasgupta 1987), non
3 Servizi, infrastrutture, credito, formazione, ecc..
12
può riconoscere né il peso dei fattori organizzativi né il ruolo delle economie di
agglomerazione (semplicemente perché non necessari).
I limiti di tale scuola di pensiero, però, sono evidenti: non si tratta soltanto della
scarsa aderenza alla realtà delle vincolanti ipotesi neoclassiche, e dell'incapacità di
spiegare i fallimenti del mercato e quindi di negare l'utilità dell'intervento pubblico, ma,
nel caso specifico dell'agricoltura, risulta praticamente impossibile spiegare alcuni
schemi comportamentali dell'imprenditore agricolo. Questi, infatti, non si sofferma
esclusivamente sul mero punto di pareggio tra ricavi e costi, sui vantaggi di incrementi
infinitesimali dei propri fattori di produzione, ma rivolge attenzione anche a elementi
quali il fondo conferito all'azienda e la famiglia coltivatrice.
Un ulteriore elemento di debolezza della visione neoclassica, e quindi anche della
sua contrapposizione alla visione distrettuale, è che essa punta al cosiddetto steady-
state, situazione in cui si nega la vera funzione imprenditoriale poiché le decisioni da
prendere sono routinarie. In contesti come quelli attuali, però, lo steady-state è una
configurazione teorica e praticamente irraggiungibile. Nei continui cambiamenti dei
sistemi-mercato che caratterizzano i sempre più veloci processi di globalizzazione, i
momenti di disequilibrio sono frequenti e spesso profondi: in queste fasi emerge così il
ruolo del distretto, che con la sua capacità di innovazione endogena consente alle
imprese di sopravvivere e reagire ai momenti di intensa evoluzione.
Per ciò che concerne la visione istituzionalista, non v'è una vera e propria
contrapposizione con la visione distrettuale. Anzi, in alcuni casi, ci sono possibili
convergenze. Si pensi ad esempio alle teorie dei costi di transazione (Williamson O.E.
1985), che sostengono (correttamente) che l'accesso ai mercati non è gratuito4: i costi di
transazione sono crescenti, ad esempio, in condizioni di incertezza, ed è noto che uno
dei pregi ascritti al distretto è quello di creare reti di fiducia che consentono la
compressione di tali costi, al punto da consentire i cosiddetti contratti impliciti.
4 Ciò è invece quanto asseriscono i neoclassici.
13
I.5.2 Distretto agricolo-rurale e agroalimentare: concetto tecnico o culturale ?
Come si osserva in Iacoponi 2001a, i dettami del distretto industriale possono
trasporsi sul distretto agricolo ma non completamente. In particolare è l'elemento
territoriale che può non coincidere: infatti le imprese industriali possono assumere una
densità territoriale irraggiungibile per quelle agricole. Ciò farebbe propendere verso
similitudini produttive, piuttosto che territoriali.
Sulla base di questo, in letteratura si è affrontato il tema di come tracciare la linea di
confine tra distretto agricolo-rurale e agroalimentare, cioè in quale caso prevale la
componente agricola su quella di trasformazione industriale del prodotto, e viceversa.
Su ciò i suggerimenti degli economisti, soprattutto quelli agrari, sono numerosi. Vale la
pena di evidenziale i due seguenti:
1. il distretto sarebbe agricolo-rurale se la fase a valle di quella puramente agricola è
debole o assente, e viceversa (Iacoponi 1990);
2. il distretto sarebbe agricolo-rurale anche in presenza di forti segmenti a valle della
fase puramente agricola, se però tali segmenti sono specializzati nella trasformazione
di prodotti agricoli locali (Cecchi 1992).
È evidente che le diversità tra il concetto di distretto agricolo-rurale e distretto
agroalimentare non possono, e infatti così non è, limitarsi solo a questi aspetti definitori.
La ruralità di un distretto di imprese agricole non emerge da fatti tecnici, ma da fatti
sistemici e culturali. Da Iacoponi 2001a si deduce la seguente connotazione della
ruralità:
demografia diffusa e modesta;
attività agricole non marginali;
attività agricole di vario tipo (non c'è monocultura) e in armonia con il territorio.
14
Da ciò si deriva una immediata conseguenza: il concetto di distretto rurale va oltre
quello di distretto agroalimentare, nel senso di essere un concetto più ampio. Infatti
possiede tre chiavi di lettura:
quella (ovviamente) economico-produttiva;
quella biologico-ambientale;
quella sociale.
Com'è noto, può aver poco senso (se non averne per nulla) proporre la seconda e la
terza chiave di lettura per i distretti agroalimentari.
Se invece il dibattito si sposta dal binomio agricolo-rurale e agroalimentare, verso la
più generale contrapposizione tra distretto industriale e distretto primario, il tema si fa
più tecnico e meno socio-culturale. Infatti, come si può derivare da Becattini 2000, vi
sono alcune caratteristiche dei distretti industriali che, almeno a priori, sembrerebbero
non esattamente replicabili per distretti di attività primarie. Tra questi vale la pena di
sottolineare i seguenti:
divisione dei processi produttivi;
contrapposizione tra domanda globale e capacità locale;
rispetto delle regole del gioco distrettuali, soprattutto dei contratti impliciti;
legame tra prodotto e territorio locale;
codifica del know-how.
Si può ritenere che la non replicabilità di questi caratteri in un contesto di attività
primarie in realtà sia un falso problema, già superato nei fatti (De Rosa 1997b e 2000,
Iacoponi 2001b).
15
BIBLIOGRAFIA
Amador R.E. e Starbird S.A. (1989) - "The evaluation of international agribusiness
investment locations using multidimensional scaling", Agribusiness, 2, pp. 139-
151.
Bagarani, M., C. Magni, M. Mellano (1988) - "La specializzazione agricolo-alimentare
nelle regioni italiane nei diversi gradi di integrazione", in Strategie e adattamenti
nel sistema agroindustriale (Atti del XXIV convegno di studi della SIDEA), INEA-
Il Mulino, Bologna.
Balestrieri G. (1988) - "Aspetti dimensionali e di forma giuridica delle imprese nella
localizzazione dell'industria alimentare in Italia", in Strategie e adattamenti nel
sistema agroindustriale (Atti del XXIV convegno di studi della SIDEA), INEA-Il
Mulino, Bologna.
Becattini G. (2000) - "Distrettualità fra industria e agricoltura", La Questione Agraria, 2
Beilock R. e Casavant K. (1984) - "Perishables - The new intermodal battleground",
American Journal of Agricultural Economics, 5, pp. 651-656.
Belletti G. (1992a) – "Evoluzione dei consumi alimentari e filiere agroalimentari,
Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Pisa, Pisa.
Belletti G. (1992b) - "Delocalizzazione dei processi produttivi agroalimentari e analisi
di filiera. Una applicazione alla Toscana mediante l'approccio per subsistemi", La
Questione Agraria, 46, pp. 165-208.
Belletti G., Giancani L.A., Marescotti A., Scaramuzzi S. (1994) - "Potenzialità e limiti
dell'approccio di filiera su scala regionale, un'applicazione alla Toscana", Rivista di
Economia Agraria, 1, pp. 3-35.
Berry B.J., Conkling E.C. e Ray D.M. (1993), "The global economy", Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, NJ.
Blood D.M. (1964) - "The impact of transportation rate structure on the movement of
agricultural commodities", Journal of Farm Economics, pp. 1297-1305.
Bobst B.W. e Waananen M.V. (1968) - "Cost and price effects of concentration
restrictions in the plant location problem", American Journal of Agricultural
Economics, 3, pp. 676-686.
Boccaletti S. (1988) - "L'organizzazione interna delle imprese agro-alimentari, il caso
canadese", Rivista di Economia Agraria, 2, pp. 241-263.
Brunetta R. (1983) – "La multilocalizzazione produttiva come strategia d’impresa",
Franco Angeli, Milano.
Brunori G. (1995) - "Sistema agro-alimentare e impresa agraria", in F. Mantino (a cura
di), Impresa agraria e dintorni, INEA, Roma.
Brunori G. (1999) - "Sistemi agricoli territoriali e competitività", relazione presentata al
VI convegno della SIDEA.
Calvelli A. (1995) - "Diversificazione e ricentraggio”, in L. Caselli (a cura di), Le
Parole dell’Impresa, Franco Angeli, Milano.
Carbone A. (1992) - "Integrazione produttiva sul territorio e formazione di sistemi
agricoli locali", La Questione Agraria, 46, pp. 137-163.
Cecchi C. (1992) - "Per una definizione di distretto agricolo e distretto agroindustriale",
La Questione Agraria, 46, pp. 81-107.
Chandler A.D. (1976) – "Strategia e Struttura, Storia della Grande Impresa Americana",
Franco Angeli, Milano (traduzione italiana di Strategy and structure chapters in the
history of the industrial enterprise, MIT Press, 1962).
16
Chandler A.D. (1981) – "La Mano Visibile, La Rivoluzione Manageriale nell'Economia
Americana", Franco Angeli, Milano. (traduzione italiana di "The visible hand, the
managerial revolution in american business", Belknap Press of Harvard University
Press, 1977).
Chapman K. e Walker D.F. (1991) – "Industrial Location. Principles and Policies",
Basil Blackwell, Oxford.
Cecchi C. (1992) - "Per una definizione di distretto agricolo e distretto agroindustriale",
La Questione Agraria, 46
Cibin R. e Genco P. (1995) - "Integrazione e deverticalizzazione”, in Caselli L. (a cura
di), Le parole dell’impresa, Franco Angeli, Milano.
Cooke P. e Morgan K. (1993) - "The network paradigm: new departures in corporate
and regional development, environment and planning", Society and Space, 11
Connor J.M. (1983) - "Determinants of foreign direct investment by food and tobacco
manufacturers", American Journal of Agricultural Economics, 2, pp. 395-404.
Conti S. (1993) - "L'organizzazione territoriale degli spazi agricoli", in S. Conti, G.
Dematteis, C. Lanza e F. Nano, Geografia dell'economia mondiale, UTET, Torino.
Conti S. (1996) – "Geografia economica. Teorie e metodi", UTET, Torino.
Dasgupta A.K. (1987) – "La teoria economica da Smith a Keynes", Il Mulino, Bologna
De Castro P. e Furesi R. (1990) - "Il sistema agro-alimentare, stato dell'arte e
problematiche aperte", Rivista di Politica Agraria, 3, pp. 51-56.
De Castro P. e Deserti R. (1995) - "Imprese multinazionali, strategie di mercato e nuovi
scenari del sistema agro-alimentare italiano", Rivista di Politica Agraria, 3, pp. 3-
11.
Dematteis G. (1989) - "Regioni geografiche, articolazione territoriale degli interessi e
regioni istituzionali", Stato e Mercato, 27, pp. 445-467.
De Muro P. (1992) - "Sul concetto di filiera", La Questione Agraria, 46, pp. 15-79.
De Rosa M. (1996) - "L'approccio territoriale all'analisi del sistema agro-alimentare,
una rassegna della letteratura italiana", Rivista di Politica Agraria, 2, pp. 31-38.
De Rosa M. (1997a) - "Quale approccio per lo studio dei sistemi agro-alimentari
locali?", Rivista di Economia Agraria, 4, pp. 509-531.
De Rosa M. (1997b) – "Modelli locali di sviluppo e sistema agroalimentare", Liguori,
Napoli
De Rosa M. (2000) – "Aspetti istituzionali e sistemi agricoli locali: problemi teorici ed
evidenze empiriche", Liguori, Napoli
Dicken P. e Lloyd P. (1997) – "Nuove prospettive su spazio e localizzazione", Franco
Angeli, Milano. (traduzione italiana di Location in space. Theoretical perspectives
in economic geography, Harper Collins, 1990).
Diffenderfer M. e Birch D. (1997) - "Bioregionalism. A comparative study of the
Adirondacks and the Sierra Nevada", Society and Natural Resources, 10(1)
Dunn J.W., Lee D.R.e Thatch D.W. (1987) - "The effect of transportation rates on
interregional competition in agriculture, a general case", Agribusiness, 4, pp. 393-
402.
Estall R.C. e Buchanan R.O. (1978) – "La localizzazione industriale", Franco Angeli,
Milano (traduzione italiana di Industrial activity and economic geography,
Hutchinson University Library, 1973).
Fanfani R. e Montresor E. (1991) - "Filiere, multinazionali e dimensione spaziale nel
sistema agro-alimentare italiano", La Questione Agraria, 41, pp. 165-201.
17
Fanfani, R. e E. Montresor (1994) - "Gli strumenti interpretativi del sistema
agroalimentare italiano", in Cesaretti G.P., Mariani A.C.e Sodano V. (a cura di),
Sistema agroalimentare e mercati agricoli, Il Mulino, Bologna.
Favia F. (1992) - "L'agricoltura nei sistemi produttivi territoriali", La Questione Agraria,
46, pp. 109-136.
Fedeler J.A., Heady E.O.e Koo W.W. (1975) - "A national grain transportation model",
in Heady E.O.e Srivastava U.K. (a cura di), Spatial sector programming models in
Agricolture, Iowa State University Press, Ames, IA.
Felton J.R. (1968) - "Technological change and internal economies in railroad transport,
some implications for the Great Plains", American Journal of Agricultural
economics, 3, pp. 720- 733.
Finardi S. e Tombola C. (1995) – "Il sistema mondiale dei trasporti", Il Mulino,
Bologna.
Formica C. (1996) – "Geografia dell'agricoltura", La Nuova Italia Scientifica, Roma.
Foti D'Amico S. (1978) - "Le multinazionali ed il settore agricolo-alimentare", Rivista
di Politica Agraria, 3, pp. 49-62.
French B.C. (1960) - "Some considerations in estimating assembly cost functions for
agricultural processing operations", Journal of Farm Economics, pp. 767-778.
Friedmann H. e Mc Michael P. (1990) - "L’agricoltura nel sistema degli stati nazionali.
Ascesa e declino delle agricolture nazionali dal 1870 ad oggi”, La Questione
Agraria, 38, pp. 171-203.
Fuller S., Freeman J. e Beilock R. (1984) - "Motor carrier service to rural and
agricultural shipper/receivers in regulated and unregulated economic
environments", American Journal of Agricultural Economics, 5, pp. 657-662.
Galbraith J.K. (1988) – "Storia dell'Economia", Rizzoli, Milano. (traduzione italiana di
Economics in perspective, 1987).
Giovannetti E. (1994) - "Processi di aggregazione e di integrazione nelle filiere
agroindustriali, una applicazione del modello Funds and Flows, in L. Iacoponi L. (a
cura di), Il sistema del parmigiano reggiano, INEA-Il Mulino, Bologna.
Goodman D. e Watts M. (1993) – "Reconfiguring the rural or fording the divide?
capitalist restructuring and the global agro-food system", mimeo.
Green R.H. e Rocha dos Santos R. (1993) - "Economia di rete e ristrutturazione del
settore agroalimentare”, La Questione Agraria, 52, pp. 83-110.
Grigg D.B. (1974) – "The agricultural systems of the world", Cambridge University
Press, London.
Healey M.J. e Ilbery B.W. (1990) – "Location and change", Oxford University Press,
New York.
Henke R. e Sardone R. (1997) - "Dinamiche strutturali e localizzative dei principali
comparti dell'industria agro-alimentare italiana", Rivista di Economia Agraria, 4,
pp. 457-488.
Henke R. e Sardone R. (1998) – "L'industria alimentare italiana. Struttura e
localizzazione regionale", INEA, Roma.
Henry W.R. e Seagraves J.A. (1960) - "Economic aspects of broiler production
density", Journal of Farm Economics, pp. 1-17.
Hicks J.R. (1959) – "Essays in world economics", Oxford University Press, Oxford
Hirschman A.O. (1958) – "The strategy of economic development", Yale University
Press, New Haven
18
Iacoponi L. (1990) - "Distretto industriale marshalliano e forme di organizzazione delle
imprese in agricoltura", Rivista di Economia Agraria, 4, pp. 711-743.
Iacoponi L. (1994a) - "Sistema, filiere e distretti agro-alimentari", in Iacoponi L. e
Romiti R., Economia e politica agraria, Edagricole, Bologna.
Iacoponi L. (1994b) - "Le teorie dell'organizzazione dell'impresa", in Iacoponi L. e
Romiti R., Economia e politica agraria, Edagricole, Bologna.
Iacoponi L. (1994c) - "Mercato, filiera e distretto agro-alimentare, occasioni di
confronto per gli economisti agrari ed industriali", in Iacoponi L. (a cura di), Il
sistema del Parmigiano Reggiano, INEA-Il Mulino, Bologna.
Iacoponi L. (1994d) - "L’organizzazione delle imprese e dei sistemi d’impresa in
agricoltura”, in Iacoponi L. e Romiti R., Economia e politica agraria, Edagricole,
Bologna.
Iacoponi L. (1994e) - "Modelli dei processi produttivi ed analisi del progresso tecnico”,
in Iacoponi L. e Romiti R., Economia e politica agraria, Edagricole, Bologna.
Iacoponi L. (1995a) - "Impresa e distretto, un'interpretazione della sostenibilità
dell'impresa familiare", in Mantino F. (a cura di), Impresa agraria e dintorni, INEA,
Roma.
Iacoponi L. (1995b) - "Modelli di adozione delle innovazioni e sistemi agricoli locali",
in Iacoponi L.e Marotta G. (a cura di), Nuovi modelli di sviluppo dell'agricoltura e
innovazione tecnologica, INEA, Roma.
Iacoponi L. (1995c) - "Organizzazione dell'impresa agraria e sistema agricolo locale", in
Il sistema agrimarketing e le reti di impresa (Atti delle Giornate Tassinari, 14-15
luglio 1994), CESAR, Assisi.
Iacoponi L. (2001a) – "Impresa agraria e ipotesi distrettuale: dai sistemi produttivi
agroalimentari ai sistemi territoriali", paper presentato alla Conferenza Nazionale
dell'Impresa Agricola, Confederazione Italiana Agricoltori, Roma.
Iacoponi L. (2001b) - "Il concetto di bioregione", in Iacoponi L., La bioregione: verso
l'integrazione dei processi socioeconomici e ecosistemici nelle comunità locali,
ETS, Pisa.
Ievoli C. (1986) - "Economie di dimensione e strutture di mercato nell'industria
alimentare", La Questione Agraria, 23, pp. 95-125.
Kilmer R.L., Spreen T.e D. Tilley S. (1983) - "A dynamic plant location model, the east
Florida fresh citrus packing industry", American Journal of Agricultural
Economics, 4, pp. 730-737.
King G.A. e Logan S.H. (1964) - "Optimum location, number and size of processing
plants with raw product and final product shipments", Journal of Farm Economics,
pp. 94-108.
Knox P. e Agnew J. (1996) – "Geografia economica", Franco Angeli, Milano.
(traduzione italiana di The geography of the world economy, Edward Arnold,
1994).
Kohls R.L. e Uhl J.N. (1985) – "Marketing of agricultural products", Macmillan, New
York.
Ladd G.W. e Lifferth D.R. (1975) - "An analysis of alternative grain distribution
systems", American Journal of Agricultural Economics, 3, pp. 420-430.
Laulajainen R. e Stafford H.A. (1995) – "Corporate geography", Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht.
Lauth J.H. (1969) - "Economic considerations in rate making and rate structures for
farm products", American Journal of Agricultural Economics, 5, pp. 1464-1470.
19
Lazonick W.H. (1993) – "L'organizzazione dell'impresa e il mito dell'economia di
mercato", Il Mulino, Bologna. (traduzione italiana di Business organization and the
myth of the market economy, Cambridge University Press, 1993).
Leistritz F.L. (1992) - "Agribusiness firms, location determinants and economic
contribution", Agribusiness, 4, pp. 273-286.
Linda R. (1988a) - "Strategie di sviluppo delle imprese dell'industria agro-alimentare",
in Strategie e adattamenti nel sistema agro-industriale (Atti del XXIV convegno
della SIDEA), INEA-Il Mulino, Bologna.
Linda R. (1988b) - "Crescita, diversificazione e denominazione nelle strategie delle
megaaziende europee dell'industria alimentare e delle bevande", Rivista di Politica
Agraria, 4, pp. 37-55.
Lopez R.A. e Henderson N.R. (1989) - "The determinants of location choices for food
processing plants", Agribusiness, 6, pp. 619-632.
Malassis L. (1973) - "Economie de la consommation et de la production agro-
alimentaire", in Malassis L. (a cura di), Economie agro-alimentaire, Cujas, Paris.
Malassis L. (1996) - "Considerazioni sull'economia agroalimentare", La Questione
Agraria, 61, pp. 169-181.
Malassis L. e Ghersi G. (1996) - "Economie de la production et de la consommation.
Méthodes et concepts", in Malassis L. (a cura di), Traité d'economie agro-
alimentaire, Cujas, Paris.
Magnaghi A. (2000) – "Il progetto locale", Bollati Boringhieri, Torino,
Marchese U. (1996) – "Lineamenti e problemi di economia dei trasporti", ECIG,
Genova.
Marengo G. e De Benedictis M. (1967) – "La localizzazione della produzione agricola. I
modelli di programmazione lineare", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
Merlini G. (1970) – "La geografia e le industrie. La localizzazione industriale", Pàtron,
Bologna.
Michaels G.H., Levins R.A. e Fruin J.E. (1982) - "Rail/truck competition for grain
traffic in Minnesota, implications for rate making", American Journal of
Agricultural Economics, 2, pp. 276-279.
Monaldi V. (1993) - "Tendenze della internazionalizzazione delle industrie
agroalimentari", in Querini G. e Turri E. (a cura di), L'agroindustria nell'area
mediterranea, Franco Angeli, Milano.
Myrdal G. (1957) – "I paesi del benessere e gli altri", traduzione 1962, Feltrinelli,
Milano
Nichols T.E. (1969) - "Transportation and regional development in agriculture",
American Journal of Agricultural Economics, 5, pp. 1455-1463.
Nowak J. e Romanowska H. (1985) - "Locational patterns of the food-processing
industry in Poland", European Review of Agricultural Economics, pp. 233-246.
Olson F.L. (1959) - "Location theory as applied to milk processing plants", Journal of
Farm Economics, pp. 1546-1559.
Pacciani A. (a cura di) (1994) - "L'agricoltura toscana in un sistema che cambia,
un'analisi per filiera", Quaderni di Studi & Informazioni della Banca Toscana, 46.
Pacciani A., Belletti G., Giancani L.A., Marescotti A.e Scaramuzzi S. (a cura di) (1996)
– "Agricoltura toscana e sistema agro-industriale. Caratteristiche strutturali e
rapporti organizzativi", INEA, Osservatorio agro-industriale per la Toscana,
Firenze.
20
Paterson J.H. (1984) – "Introduzione alla geografia economica", Franco Angeli, Milano.
(traduzione italiana di Land, work and resources. An introduction to economic
geography, Edward Arnold).
Perelli A., Flematti F.e Ruivenkamp G. (1984) - "Agribusiness multinazionale e regione
mediterranea", La Questione Agraria, 15, pp. 53-76.
Perez R. (1996) - "Les stratégies des firmes multinationales alimentaires", Economie
Rurale, 231, pp. 21-28.
Piccinini A. (1994) - "Forme associative e rapporti di integrazione", in Trevisan G. (a
cura di), L'impresa agraria, attuali problemi di organizzazione e gestione (Atti del
convegno di studi della SIDEA), INEA-Il Mulino, Bologna.
Polopolus L. (1965) - "Optimum plant numbers and locations for multiple product
processing", Journal of Farm Economics, pp. 287-295.
Pugliese C. (1995) - "Sopravvivenza e ridimensionamento”, in Caselli L. (a cura di), Le
parole dell’impresa, Franco Angeli, Milano.
Ravazzoni R. (1991) - "Concentrazione e internazionalizzazione dell'industria
alimentare italiana", Rivista di Politica Agraria, 1, pp. 29-54.
Rogers R.T. e Sexton R.J. (1994) - "Assessing the importance of oligopsony power in
agricultural markets", American Journal of Agricultural Economics, 5, pp. 1143-
1150.
Rosa F. (1988) - "La performance delle imprese nel settore agro-alimentare italiano,
verifica delle ipotesi di industrial organization"", in Strategie e adattamenti nel
sistema agroindustriale (Atti del XXIV convegno di studi della SIDEA), INEA-Il
Mulino, Bologna.
Saccomandi V. (1991) – "Istituzioni di economia del mercato dei prodotti agricoli",
REDA, Roma.
Saccomandi V. (1999) – "Economia dei mercati agricoli", Il Mulino, Bologna.
Scarano G. (1991) - "Condizioni e determinanti dell'integrazione verticale in
agricoltura, il caso italiano", La Questione Agraria, 43, pp. 125-158.
Scarano G. (1997) - "Dall'agribusiness ai sistemi agroalimentari, la parabola evolutiva
di un paradigma teorico", La Questione Agraria, 66, pp. 45-75.
Scarpelli L. (1994) - "Interdipendenza tra agricoltura e industria, riflessi territoriali",
Bollettino della Società Geografica Italiana, pp. 149-154.
Scoppola M. (1992) "Il ruolo delle multinazionali nel commercio mondiale dei cereali",
La Questione Agraria, 47, pp. 23-55.
Scoppola M. (1993) - "Gli interessi delle multinazionali e la politica agricola
comunitaria", La Questione Agraria, 52, pp. 55-81.
Sexton R.J. (1994) - "Fattori territoriali nei mercati dei prodotti agricoli", in Cesaretti
G.P., Mariani A.C. e Sodano V. (a cura di), Sistema agroalimentare e mercati
agricoli, Il Mulino, Bologna.
Simonis U.E. (1997) - "Bioregionalism: a pragmatic european perspective", Ekistics,
382-383-384
Sodano V. (1988) - "Strategie dell'industria alimentare e prospettive di crescita per il
settore agricolo, il caso dell'industria degli ortaggi surgelati in Italia", La Questione
Agraria, 31, pp. 131-156.
Sodano V. (1994) - "I meccanismi di coordinamento verticale all'interno del sistema
agroalimentare", in Cesaretti G.P., Mariani A.C. e Sodano V. (a cura di), Sistema
agroalimentare e mercati agricoli, Il Mulino, Bologna.
21
Sopranzetti C. (1997) - "L'evoluzione dei principali gruppi multinazionali operanti nel
settore agro-alimentare", Rivista di Politica Agraria, 1, pp. 33-40.
Sopranzetti C. e Carbonari F. (1996) - "L'evoluzione della struttura dell'industria
alimentare italiana", Rivista di Politica Agraria, 3, pp. 7-18.
Sorenson L.O. (1973) - "Rail-barge competition in transporting winter wheat",
American Journal of Agricultural Economics, 5, pp. 814-819.
Stefani G. (1994) - "La filiera, tra sistema economico ed unità di produzione
organizzate", Rivista di Economia Agraria, 4, pp. 581-612.
Stollsteimer J.F. (1963) - "A working model for plant numbers and locations", Journal
of Farm Economics, pp. 631-645.
Terrasi M. (1985) - "I fattori di localizzazione dell'industria alimentare in Italia", Rivista
di Economia Agraria, 1, pp. 59-81.
Tozanli S. (1996) - "L'évolution des structures des groupes agro-industriels
multinationaux", Economie Rurale, 231, pp. 29-38.
Traill B. (1997) - "Globalisation in the food industries?”, European Review of
Agricultural Economics, pp. 390-410.
Tyrchniewicz E.W. e Tosterud R.J. (1973) - "A model for rationalizing the Canadian
grain transportation and handling system on a regional basis", American Journal of
Agricultural Economics, 5, pp. 805-813.
Ulrey I.W. (1964) - "Problems and issues in transportation policy and implications for
agriculture", Journal of Farm Economics, pp. 1281-1289.
Von Oppen M. e Scott J.T. (1976) - "A spatial equilibrium model for plant location and
interregional trade", American Journal of Agricultural Economics, 3, pp. 437-445.
Walras L. (1876) - "Elements d’économie politique pure, Guillamin, Parigi
Watts D. (1993) – "Geografia industriale", Zanichelli, Bologna. (traduzione italiana di
Industrial geography, Longman, 1987).
Williamson J.C. (1962) - "The equilibrium size of marketing plants in a spatial market",
Journal of Farm Economics, pp. 953-967.
Williamson O.E. (1985) – "The economic institutions of capitalism", The Free Press
Zan S. (1987) - "Il quadro concettuale di riferimento", in Zan S., Le interdipendenze
organizzative in agricoltura: analisi di forme associative e cooperative operanti nel
sistema agro-industriale dell'Emilia-Romagna, Bologna, Regione Emilia-Romagna,
1987
22
II. IL DISTRETTO NELLA PROGRAMMAZIONE
PUBBLICA
II.1 L'impostazione nazionale
È utile ripercorrere il cammino seguito dai tentativi di applicazione della legge 317
del 1991, poiché è anche dall’analisi dei limiti di questa impostazione che si traggono
gli spunti per una più efficace politica distrettuale.
L'art. 36 della legge 317/91 ha posto alle nostre Regioni il problema della
delimitazione geografica dei distretti. I criteri generali da rispettare sono dettati dal
Decreto "Guarino" (Ministro dell’Industria, aprile 1993), che introduce cinque
parametri da utilizzare per assegnare lo status distretto ad un sistema territoriale.
I. Industrializzazione dell'area
Aree caratterizzate da industrializzazione manifatturiera superiore del 30% alla
media nazionale.
tp
mp
tp
mj
A
A
A
A3,1
dove:
A = addetti
m = totale settori manifatturieri
t = totale attività produttive
j = zona j-esima
p = Italia
II. Densità imprenditoriale
Aree con numero di imprese manifatturiere per residente superiore alla media
nazionale.
mp
mp
mj
mj
R
UL
R
UL
dove:
UL = unità locali
23
R = popolazione residente
m, t, j, p = come criterio I
III. Grado di localizzazione
Si tratta del peso dell'occupazione di un settore manifatturiero sull'occupazione
manifatturiera totale dell'area considerata, relativizzato allo stesso quoziente
calcolato a livello nazionale. In pratica un indice di specializzazione che viene
utilizzato come indice di localizzazione. Il limite critico è, anche in questo caso, il
30% in più rispetto alla media nazionale.
mp
xp
mj
xj
A
A
A
A3,1
dove:
x = settore manifatturiero x
A, m, j, p = come criterio I
IV. Specializzazione locale
Sempre nella logica della specializzazione produttiva misurata con il peso
dell'occupazione, si richiede che quella del settore manifatturiero considerato sia più
del 30% dell'occupazione manifatturiera totale locale.
V. Piccola dimensione
Aree non solo specializzate settorialmente, ma anche pervase di PMI. Si richiede che
gli addetti di un settore occupati in PMI, definite come aziende con meno di 200
addetti, siano almeno il 50% degli addetti totali dello stesso settore.
Tali criteri appaiono poco flessibili ed al tempo stesso troppo generali; tale critica
assume maggior valore nel momento in cui si applica a territori per nulla omogenei. La
critica più rilevante, come si può desumere da Corò 2001a, è che essi sono
particolarmente finalizzati a individuare distretti laddove v'è un settore che prevale sugli
altri5.
5 Per approfondimenti su tali critiche si rinvia a Anastasia, Corò e Occari 1993 e Anastasia, Corò e
Crestanello 1995.
24
Al di là di questo, in un modo o nell'altro va compiuta l'identificazione dei distretti, e
a tal fine rilevano sia la delimitazione dell'ambito locale nel quale applicare i 5
precedenti criteri, sia il concetto di specializzazione. Si consideri quanto segue.
1) L'ambito territoriale.
Il Ministero delle Attività Produttive considera come area di riferimento ciò che
l'ISTAT definisce Sistema Locale del Lavoro. Si tratta di un gruppo di comuni la cui
popolazione attiva può lavorare senza cambiare residenza6. La delimitazione-
dimensione dei Sistemi Locali del Lavoro è decisiva, visto che le scelte localizzative
hanno effetti sul mercato del lavoro non solo locale; anzi, la loro diffusione
territoriale può essere molto ampia. Al di là degli aspetti definitori, vi possono essere
alcuni problemi applicativi. In Tattara 2000 si dimostra che la tecnica del Sistema
Locale del Lavoro raramente mette in luce le interdipendenze territoriali. Inoltre, da
Corò 2001a si desume che, in ogni caso, questa tecnica mal si presta alle rigidità
insite nella legge 317/91.
2) La specializzazione
Gli indici di specializzazione del III e IV criterio della legge 317/91 sembrano
piuttosto restrittivi, ma soprattutto è criticabile il concetto in sé si specializzazione
settoriale. L'esperienza dimostra infatti che al successo di un distretto non basta la
specializzazione, in quanto sono necessari servizi e attività complementari.
II.2 La "declinazione" regionale delle normative nazionali
I percorsi regionali verso l'individuazione dei distretti sono tra loro diversificati
(Caloffi 2000).
L'Emilia Romagna, ad esempio, da più peso alle specificità territoriali che non al
concetto di distretto. La Lombardia discerne tra distretto produttivamente specializzati e
metadistretti (Buonanno 2002). La Toscana ha individuato 28 sistemi produttivi locali
praticamente coincidenti con i Sistemi Locali del Lavoro, assegnando a 12 di questi lo
status di distretto. In Veneto è stata utilizzata in prima battuta la procedura del Decreto
6 Per approfondimenti si rinvia a ISTAT 1997 e Corò e Occari 1998.
25
"Guarino". Poi nel 2001 c'è stato un cambiamento di rotta, inserendo nella procedura di
individuazione dei distretti anche elementi sociali e istituzionali. Così facendo, si
riconosce l'esistenza di un distretto non solo per la presenza di opportuni caratteri
quantitativi, ma anche per la capacità degli attori locali nel fare sistema al fine di
stabilire opportune strategie condivise in tutto l'ambito territoriale coinvolto. Piemonte,
Marche e Friuli Venezia Giulia si sono invece basate fedelmente sul Decreto "Guarino".
Il processo di individuazione dei distretti delle varie Regioni si può scindere in tre
momenti (Caloffi 2000).
1. Individuazione degli ambiti geografici (Lombardia 15 ambiti, Friuli Venezia Giulia
4, Liguria 1, Toscana 12, Marche 9, Piemonte 14 distretti, Abruzzo 4, Campania 7,
Sardegna 4, Veneto 19).
2. Definizione degli interventi
3. Inserimento coerente delle politiche distrettuali nell'ambito complessivo delle
politiche regionali.
In queste fasi, gli aspetti sui quali si ritiene utile concentrare l’attenzione sono i
seguenti (Corò 2001a):
1. Personalità giuridica dei distretti.
Possedere personalità giuridica significa poter essere destinatari di risorse, quindi si
tratta di una questione estremamente rilevante. Tale aspetto viene regolamentato dalla
combinazione fra la legge 317/91 e due delibere del CIPE (25/2/94 e 21/3/97). Il
quadro che emerge è il seguente. Il soggetto dotato di personalità giuridica non è il
distretto in sé ma un Consorzio di Sviluppo, che ottiene risorse (da impiegare nel
distretto) dalla Regione e dallo Stato, sulla base di uno di tre strumenti alternativi:
Contratto di Programma, Patto Territoriale, Contratto d'Area. Probabilmente è
positivo il fatto che il legislatore non assegni personalità giuridica al distretto in sé
per sé, giacché si rischierebbe di confonderla con il "cuore operativo" del distretto,
che esiste indipendentemente dal riconoscimento formale.
2. Comitato di Distretto.
26
Con nomi diversi (ad esempio, Comitato di Indirizzo e Coordinamento nelle Marche,
Comitato d'Area in Toscana), tali Comitati sono presenti in tutte le Regioni dotate di
una specifica normativa sui distretti. I suoi compiti sono fondamentali e possono
essere così sintetizzati: definizione delle strategie distrettuali, selezione dei progetti
da implementare. In alcuni casi i Comitati sono dotati di risorse proprie, in altri casi
sono i componenti dei Comitati a farsi carico dei costi dello stesso (tra questi ci sono
sempre enti pubblici locali e CCIAA). La soluzione migliore sembra essere la
seconda, sia perché l'assunzione di costi equivale all'assunzione di rischio e quindi
maggiore efficienza, sia perché il finanziamento esterno rischia di rendere il Comitato
troppo burocratico7. Il potere dei Comitati è diverso da Regione e Regione; solo in
alcuni casi esprimono un parere vincolante. La loro operatività si è talvolta rivelata
piuttosto vischiosa: si può ipotizzare che ciò avviene perché nei distretti in cui
operano in realtà non v'è l'abitudine al confronto fra attori locali (pubblici e privati)
sui problemi distrettuali8.
3. Piani di Sviluppo Locale.
Sono predisposti dai Comitati di Distretto, e approvati dalla Giunta Regionale. In essi
si concretizza gli orientamenti strategici dei distretti. Al di là di questi caratteri molto
generali, comuni a tutte le Regioni che hanno legiferato sui distretti, emergono delle
differenze tra le varie Amministrazioni. Ad esempio, vi sono Regioni che per legge
definiscono, pur se schematicamente, i contenuti del Piano; altre invece si affidano
all'iniziativa dei Comitati. In taluni casi i Piani vengono utilizzati come documento di
riferimento per bandire le risorse che l'Amministrazione mette a disposizione delle
politiche distrettuali. Si deve però sottolineare un limite diffuso nell'impiego di tali
Piani, limite cui sfuggono solo l'Abruzzo ed il Veneto. Si tratta del fatto di utilizzare i
Piani anche per creare occasioni di contatto fra distretti diversi; il vantaggio sarebbe
quello di ovviare agli errori dovuti a provvedimenti eccessivamente locali e mirati. I
Piani di Sviluppo Locale potrebbero anche essere utilizzati, ma non sempre lo sono,
anche per risolvere problemi specifici, quali la codifica dei "linguaggi" di produzione
oppure la gestione dei "marchi di distretto" (Corò 2001a, Corò e Micelli 2001);
7 Ad esempio, nelle Marche, dove i Comitati godono di finanziamenti ragguardevoli, all'interno degli
stessi si è istituito una Giunta Esecutiva. 8 In altri termini, i Comitati funzionano bene laddove già preesiste una cultura di cooperazione tra attori
locali sui temi della politica economica. Negli altri casi i Comitati sono una forzatura, un'imposizione.
27
quest'ultimo aspetto è piuttosto rilevante: la strategia di distretto deve assolutamente
impedire il free-riding di pochi produttori, che potrebbe spiazzare tutti quelli che
invece si adoperano per mantenere elevata la qualità del marchio.
4. Soggetti che realizzano i Piani di Sviluppo Locale
È questo forse l'aspetto più controverso, nei confronti del quale le soluzioni adottate
dalle Amministrazioni regionali divergono sensibilmente. Alcune Regioni, infatti,
ritengono essere Consorzi e associazioni temporanee di imprese soggetti idonei a dare
esecutività al Piano. Altre privilegiano attori pubblici, oppure gli stessi soggetti
sottoscrittori del Piano di Sviluppo Locale. Vi sono poi Regioni che ammettono come
soggetti attuatori, pur se con specifici limiti, anche soggetti esterni al distretto. Come
si osserva in Corò 2001a, tali impostazioni sottendono un limite comune, cioè il
volere fissare per legge i requisiti dei soggetti; si ritiene invece opportuno non
focalizzare l'attenzione sulla natura giuridica degli operatori, o sulla loro
localizzazione, quanto invece nella loro capacità di attivare sinergie e generare
esternalità.
II.3 La nuova normativa della Regione Veneto
L'impostazione attuale della Regione Veneto da un lato supera il concetto di distretto
industriale, dall'altro lato sposta l'attenzione sul concetto di sistema produttivo locale. Il
risultato, se così si può dire, è il nuovo concetto di distretto produttivo
Si tratta di una nuova dimensione economico-istituzionale-territoriale che viene
definita come "espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali
di sviluppare una progettualità strategica" [legge regionale n. 8 del 4 aprile 2003 (BUR
n. 36/2003), art. 2, comma2].
La nostra Regione ha introdotto questi elementi di novità:
1. ruolo esplicito assegnato alle componenti istituzionali;
2. attenzione verso la progettualità territoriale, e non tanto (o non esclusivamente) su
parametri numerici che riguardano addetti e unità locali.
28
La novità più rilevante sembra essere l'aspetto istituzionale del nuovo concetto di
distretto. In particolare, i soggetti che hanno titolo per essere attori di questa modalità
della politica regionale non sono solo destinatari di risorse ma, soprattutto, sono in
prima fila nella fase progettuale9. Questa fase costituisce la seconda grande innovazione
della normativa veneta.
L'effetto combinato è il seguente: un distretto produttivo sarà riconosciuto tale non
come risultato di una procedura di calcolo, come sarebbe applicando i cinque criteri
della legge 317/91, ma per l'esistenza di una coalizione istituzionale che sottoscrive un
Piano di Sviluppo Locale che descrive la strategia più idonea al territorio coinvolto.
Questa nuova impostazione ha uno specifico obiettivo: superare le inefficienze della
legge 317/91 soprattutto in fatto di burocratizzazione della politica regionale
distrettuale.
In ultima analisi, il distretto cessa di essere una categoria speciale, e la politica
regionale distrettuale riesce a coinvolgere appieno gli attori che possono essere
strategici per lo sviluppo locale.
II.3.1 Un commento del DDL della Regione Veneto "Disciplina dei Distretti
Produttivi ed Interventi di Politica Industriale Locale"
Art. 1 - Oggetto
Stabilisce l'obiettivo della Regione Veneto sulla materia in oggetto: promuovere
azioni a sostegno delle sviluppo regionale.
Art. 2 - Definizione
Definisce la tipologia degli attori e delle relazioni che intercorrono tra loro, relazioni
idonee a qualificare il distretto produttivo.
Fa espressamente riferimento alla capacità degli attori a declinare progetti e strategie
comuni.
Art. 3 - Indicatori di rilevanza del Sistema Produttivo Locale
9 L'aspetto istituzionale non va inteso restrittivamente, nel senso che possono essere attori non solo enti
pubblici ma anche organismi di rappresentanza delle varie categorie produttive.
29
Specifica quali variabili quantitative consentono ad un qualsiasi sistema locale di
essere riconosciuto come distretto produttivo: 80 imprese e 250 addetti.
Art. 4 - Soggetti
Definisce i soggetti che possono essere considerati attori della programmazione
distrettuale:
imprese, in ragione della sede operativa e non di quella legale; non rileva nemmeno
la loro dimensione;
enti pubblici locali territoriali;
CCIAA, Università, consorzi, fondazioni, aziende speciali, ecc..
Art. 5 - Patto di Sviluppo Locale
Pone alcune specifiche amministrative del Patto di Sviluppo Locale: modulistica da
utilizzare e durata del Patto.
Art. 6 - Garante del Patto di Sviluppo
Richiama la figura di un soggetto terzo che garantisce la stesura e l'esecuzione del
Patto di Sviluppo Locale.
Art. 7 - Ammissibilità del Patto di Sviluppo
Indica nella CCIAA il soggetto titolato a verificare l'ammissibilità del Patto di
Sviluppo Locale.
In fato di ammissibilità si specifica anche il ruolo della Regione, che dovrà verificare
alla conclusione del Patto la vigenza delle condizioni che lo hanno reso ammissibile.
Art. 8 - Procedure di ammissibilità
30
Specifica l'iter del Patto: si presenta al 1° marzo, entro la fine del mese la CCIAA lo
trasmette alla Regione, che entro fine giugno emana il bando di partecipazione
all'assegnazione delle risorse.
Art. 9 - Consulta dei distretti
Stabilisce un organo di controllo regionale, la Consulta dei Distretti, che sorveglia
tutta la materia in oggetto.
Art. 10 - Bandi di assegnazione
Ribadisce il metodo del bando pubblico quale via maestra per accedere ai
finanziamenti regionali.
Si definiscono i soggetti che possono partecipare ai bandi, nonché i criteri che questi
soggetti devono rispettare per essere presi in considerazione.
Art. 11 - Criteri di valutazione
Chiarisce i criteri di valutazione dei progetti. Si privilegiano ambiti territoriali che si
estendono su più province, la coerenza con la politica economica regionale, l'assunzione
di rischio e l'autofinanziamento dei sottoscrittori del Patto, la generazione di esternalità,
la valorizzazione di fattori produttivi locali, il numero e rilevanza dei soggetti coinvolti,
l'attivazione di sinergie con altri Patti.
Art. 12 - Interventi agevolabili
Indica le materie finanziabili, tra le quali primeggiano opere e infrastrutture per il
sistema produttivo, nonché attività e servizi utili allo sviluppo locale.
31
Art. 13 - Soggetti destinatari
In tema di risorse distribuibili, crea abbinamenti tra soggetto ricevente e tipologia di
intervento, nel senso che determinati soggetti sono preferiti per taluni interventi.
Art. 14 - Attività di promozione e verifica
Attribuisce alla Giunta Regionale il compito di ispezione e verifica.
Fa obbligo al soggetto di riferimento del Patto di Sviluppo Locale di fornire
periodicamente alla Regione le informazioni necessarie.
Art. 15 - Adeguamento alla normativa comunitaria
Richiama la normativa UE sul tema delle agevolazioni pubbliche.
Art. 16 - Norma finanziaria
Afferma che nel bilancio regionale devono esservi appositi finanziamenti per i
distretti produttivi.
Art. 17 - Norma di prima applicazione
Fa obbligo alla Giunta Regionale di mettere a disposizione la modulistica adatta alla
presentazione del Patto di Sviluppo Locale.
Art. 18 - Norma abrogativa
Abroga la precedente zonizzazione regionale per distretti.
32
BIBLIOGRAFIA
Anastasia B. e Rullani E. (1982) - "La nuova periferia industriale. Saggio sul modello
veneto", Arsenale Cooperativa, Venezia
Anastasia B., Corò G. e Occari F. (1993) - "Valutazioni e simulazioni sui criteri ufficiali
per la delimitazione geografica dei distretti industriali", Oltre il Ponte, 42
Anastasia B., Corò G. e Crestanello P. (1995) - "Problemi di individuazione dei distretti
industriali: esperienze regionali e rapporti con le politiche", Oltre il Ponte, 52
Bagnasco A. e Pini R. (1981) - "Sviluppo economico e trasformazioni socio-politiche
dei sistemi territoriali ad economia diffusa", Quaderni della Fondazione G.
Feltrinelli, 14, Milano
Bagnasco A. e Trigilia C. (1984) - "Società e politica nelle aree di piccola impresa: il
caso di Bassano", Arsenale Editrice, Venezia
Balestri A. e Caloffi A. (2000) - "Le politiche regionali per i distretti industriali", Centro
Studi Unione Industriali e Università di Firenze, Prato
Becattini G. (1998) - "Distretti industriali e Made in Italy", Bollati-Boringhieri, Torino
Becattini G. (2000a) - "Il distretto industriale", Rosenberg e Sellier, Torino
Becattini G. (2000b) - "Dal distretto industriale allo sviluppo locale", Bollati-
Boringhieri, Torino
Borghesi A. (2001) - "Il distretto simbiotico come nuovo modello di
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese distrettuali italiane", Atti del
Convegno L'internazionalizzazione delle PMI nell'Europa centro orientale,
Fondazione dell'Amore, Milano
Bruzzo A. (2000) - "Le politiche strutturali della Comunità Europea per la coesione
economica e sociale", Cedam, Padova
Bruzzo A. (2001) - "La politica regionale in Italia: un’analisi delle più recenti tendenze",
Economia e Società regionale, 4
Buonanno P. (2002) - "Metadistretti, una realtà lombarda", Per l'Impresa, 4
Caloffi A. (2000) – "Politiche regionali per i distretti industriali", Unione Industriale
Pratese, Prato
Caselli L. (1974a) - "L'ambivalenza del decentramento produttivo", Economia e Politica
Industriale, 6
Caselli L. (1974b) - "Decentramento produttivo e sviluppo dualistico", Economia e
Politica Industriale, 7-8
Clark C. (1957) - "The conditions of economic progress", Macmillan, London
Conti G. (1975) - "Nota sulla posizione relativa dell'Italia dal punto di vista della
specializzazione produttiva", in Graziani A. (a cura di), Crisi e ristrutturazione
dell'economia italiana, Torino
Conti G. (1978) - "La posizione dell'Italia nella divisione internazionale del lavoro", in
di Conti G., Falconi F., Antonelli C. e Garofalo (a cura di), Specializzazione e
competitività internazionale dell'Italia, Il Mulino, Bologna
Corò G. (2001a) - "Il ruolo, la situazione e l’evoluzione della subfornitura nelle realtà
distrettuali del Veneto", Direzione Industria Regione del Veneto, Venezia
Corò G. (2001b) - "Processi produttivi, Stato sociale, modelli di sviluppo", Ediesse,
Roma
Corò G. e Micelli S. (1999) - "Distretti industriali e imprese transnazionali: modelli
alternativi o convergenti?", Sviluppo Locale, 10
33
Corò G. e Micelli S. (2001) - "I distretti industriali nell’economia digitale: una
convergenza possibile?", Economia e Politica Industriale
Corò G. e Occari F. (1998) - "I sistemi locali del lavoro come nuovo strumento di analisi
e politica economica", in Agenzia per l’Impiego del Veneto (a cura di), Il Mercato
del Lavoro nel Veneto, Franco Angeli, Milano
Corò G. e Rullani E. (1998) (a cura di) - "Percorsi locali di internazionalizzazione",
Franco Angeli, Milano
CUOA (1985) - "Organizzazione del territorio ed evoluzione del sistema produttivo
veneto"
Daggett S. (1955) - "Principles of inland transportation", Harper & Row, New York
Eckaus R. S. (1955) - "Il problema del rapporto tra i fattori nelle aree sottosviluppate",
in Agarwala A.N. e Singh S.P. (a cura di), L'economia dei paesi sottosviluppati,
Feltrinelli, Milano
Fadda S. (2001a) - "Istituzioni economiche e economia delle istituzioni nei sistemi
produttivi locali", Argomenti, 1
Fadda S. (2001b) - "Decentramento delle politiche pubbliche e sistemi locali. Alcune
riflessioni di base", Argomenti, 3
Favaretto I. (2000) - "Le componenti territoriali dello sviluppo", Carocci, Roma
Frey L. (1974a) - "La problematica del decentramento produttivo", Economia e Politica
Industriale, 6
Frey L. (1974b) - "Teoria dell'impresa, piccola imprese, decentramento delle attività
produttive: considerazioni finali", Economia e Politica Industriale, 7-8
Friedman J. (1959) - "Regional planning: a problem in spatial integration", Papers and
Proceedings, Regional Science Association, 5
Fuà G. (1991) - "Orientamenti per la politica del territorio", Il Mulino, Bologna
Fuà G. e Zacchia C. (1983) - "Industrializzazione senza fratture", Il Mulino, Bologna
Garofoli G. (1983) - "Industrializzazione diffusa in Lombardia", Franco Angeli, Milano
Garofoli G. (1988) - "Le politiche di sviluppo locale", Franco Angeli, Milano
Garofoli G. (1991) - "Modelli locali di sviluppo", Franco Angeli, Milano
Graziani A. (1969) - "Lo sviluppo di un'economia aperta", Esi, Napoli
Hicks J.R. (1959) - "Essays in world economics", Oxford University Press, Oxford
Hirschman A.O. (1957) - "Investment policies and dualism in underdeveloped
countries", American Economic Review, settembre
Hirschman A.O. (1958) - "The strategy of economic development", Yale University
Press, New Haven
Krugman P. (1996) - "Geografia e commercio internazionale", Milano, Garzanti
Istat (1997) - "I sistemi locali del lavoro", Roma, Istat
Leibenstein H. (1954) - "Economic backwardness and economic growth", Wiley, New
York
Lonsdale R.E. e Seyler M.L. (1979) - "Nonmetropolitan industrialization", Winston e
Sons, Washington
Lutz V. (1958a) - "Il processo di sviluppo in un sistema economico dualistico, Moneta e
Credito", pp. 459-506
Lutz V. (1958b) - "Il concetto di sviluppo in un sistema economico", Moneta e Credito,
44
Lutz V. (1961) - "Alcuni aspetti strutturali del problema del mezzogiorno: la
complementarietà dell'emigrazione e dell'industrializzazione", Moneta e Credito, 56
34
Lutz V. (1962) - "A study in economic development", Oxford University Press, Oxford
Maruyama M. (1963) - "The second cybernetics: deviation amplifying mutual causal
processes", American Scientist, 51
Medolesi L. (1972) - "Disoccupazione ed esercito industriale di riserva in Italia",
Laterza, Bari
Medolesi L. (1973) - "Accumulazione e occupazione", Inchiesta, 12
Meier G.M. e Baldwin R.E. (1966) - "Economic development: theory, history, policy",
Wiley, New York
Myrdal G. (1957) - "Teoria economica e paesi sottosviluppati", Feltrinelli, Milano
Myrdal G. (1962) - "I paesi del benessere e gli altri", Feltrinelli, Milano (ediz. orig.
1957)
North D.C. (1955) - "Location theory and regional economic growth", Journal of
Political Economy, 63
North D.C. (1990) - "Institutions, institutional change and economic performance",
Cambridge, Cambridge University Press
Okun B. e Richardson R.W. (1966) - "Regional income inequality and internal
population migration", Economic Development and Cultural Change, 9
Parr J. (1966) - "Out migration and the depressed area problem", Land Economics, 42
Parri L. (2002) - "Le istituzioni dello sviluppo economico: I distretti italiani a confronto
con il modello tedesco e il sistema giapponese", in Provasi G. (a cura di), "Le
istituzioni dello sviluppo", Roma, Donzelli
Pasinetti L. e Spaventa L. (1960) - "Verso il superamento della modellistica aggregata
nella teoria dello sviluppo economico", Rivista di Politica Economica
Porter M. E. (1997) - "On Competition", Harvard Business Press, Cambridge,
Massachussets
Rullani E. (1974) - "Un'inversione di prospettiva nello studio del decentramento
produttivo", Economia e Politica Industriale, 7-8
Rullani E. (1982) - "L'economia delle differenze: il capitalismo industriale della
periferia", in Goglio S. (a cura di), Italia: centri e periferie, Franco Angeli, Milano
Rullani E. (2002) - "Sistemi produttivi locali in Europa: tra governance e competitività",
Sviluppo Locale
Schmitz H. (1999) - "Efficienza collettiva e rendimenti di scala", in Di Tommaso M. R.
e Rabellotti R. (a cura di), Efficienza collettiva e sistemi di imprese, Bologna, Il
Mulino
Signorini L.F. (2000) (a cura di) - "Lo sviluppo locale. Un’indagine della Banca d’Italia
sui distretti industriali", Donzelli, Roma
Signorini L.F. e Omiccioli M. (2002) - "L’efficienza dei distretti industriali: una
risposta", Economia e Società regionale, 1/2
Spaventa L. (1959) - "Dualism in economic growth", BNL Quarterly Review, 51
Tassinari F. (1989) - "Industria manifatturiera e terziario avanzato per le imprese",
Franco Angeli, Milano
Tattersall J.N. (1962) - "Exports and economic growth: the pacific northwest 1880-
1960", Papers and Proceedings, Regional Science Association, 9
Tattara G. (2000) - "Il piccolo che nasce dal grande. Le molteplici facce dei distretti
industriali veneti", Franco Angeli, Milano
Tattara G. (2001) - "L’efficienza dei distretti industriali. Una ricerca condotta dal
servizio studi della Banca d’Italia", Economia e Società regionale, 4
35
Thompson W.R. (1965) - "A preface to urban economics", John Opkins Press,
Baltimore
Thompson W.R. (1968) - "Internal and external factors in the development of urban
economies", in Perloff H.S. e Wingo L. jr. (a cura di), Issues in urban economics,
John Opkins Press, Baltimore
Ullman E.L. (1958) - "Regional development and the geography of concentration",
Papers and Proceedings, Regional Science Association, 4
Vaccà S. (1980) - "Il terziario nella società industriale", Franco Angeli, Milano
Vaccà S. (1986) - "L'economia delle relazioni tra imprese: dall'espansione dimensionale
allo sviluppo per reti esterne", Economia e Politica Industriale, 51
Vitali G. (2001) (a cura di) - "Imprese e mercati nell’Europa della moneta unica", Utet,
Torino
Weber A. (1909) - "Theory of location of industries", University of Chicago Press,
Chicago
Williamson J.G. (1965) - "Regional inequality and the process of national development:
a description of the patterns", Economic Development and Cultural Change, 13,
parte 2
Wolpert J. (1964) - "The decision process in spatial context", Annals Association
American Geographic, 54
36
III. CARATTERI E FATTORI DETERMINANTI DI UN
DISTRETTO
Ogni realtà distrettuale fonda il suo successo su alcuni elementi peculiari,
strettamente legati al settore di attività, se non allo specifico prodotto, ma anche su
alcune caratteristiche che sono comuni a più distretti. Questi "fattori distrettuali" sono
sia di tipo tradizionale, come quei caratteri che discendono dalla contrapposizione tra i
classici fattori lavoro e capitale, sia di tipo più innovativo e trasversale. Prima di
esaminarli nel dettaglio è bene soffermarsi brevemente su una fondamentale premessa:
perché il policy-maker dovrebbe interessarsi alle problematiche fattoriali di un distretto
piuttosto che a quelle settoriali ?
III.1 Perché programmare i fattori dello sviluppo distrettuale
anziché i settori della produzione
Le esperienze di programmazione dei decenni passati si sono basate su di un'ottica
settoriale. Sia l'analisi che le politiche privilegiavano un'economia fondata sia sulla
omogeneità merceologica che lungo linee già codificate dalle strutture amministrative e
dalla normativa in campo economico. Una tale impostazione è in contrasto con quella
della teoria economica che ha sempre rivolto la propria attenzione primaria ai fattori
della produzione, alla scelta della loro combinazione ottimale, alle modalità di
cambiamento di tale mix, in relazione all'evoluzione dei prezzi relativi dei beni e dei
fattori. Lo sviluppo tecnologico, l'aumentata complessità dei processi produttivi, la
rilevante crescita di funzioni non strettamente produttive hanno contribuito a far
diminuire progressivamente le peculiarità settoriali dell'economia e a far emergere la
superiorità di un approccio che ne privilegiasse, in un'ottica trasversale, gli aspetti
comuni. Tali aspetti trovano la propria espressione proprio nei fattori della produzione,
intesa ormai nel suo senso più ampio ed inclusiva quindi anche di tutte le funzioni non
strettamente produttive.
La presenza sul territorio di aree a diversa intensità economica, complesse e
dinamiche, dotate di storia ed identità proprie, richiedono analisi specifiche e scelte
operative coerenti. Le relazioni territoriali, indispensabili alla riproduzione dei contesti
37
socio-economici, hanno creato esigenze che sfuggono ai classici rapporti gerarchico-
funzionali. I nuovi contesti spaziali, parzialmente svincolati dalla rete amministrativa,
hanno proposto un nuovo rapporto tra attività agricole e territorio da gestire
accuratamente, non più sul piano settoriale ma su quello fattoriale.
Il principio fondamentale che perciò deve ispirare le azioni per lo sviluppo
sostenibile delle attività rurali deve essere quello che punta ad una valorizzazione dei
fattori della produzione disponibili, prima ancora che ad un rafforzamento dei settori,
proprio perché i vincoli interessano risorse "chiave", sia nuove che tradizionali. Una
politica orientata ai fattori della produzione e alle risorse, piuttosto che ai settori, ha
l'obiettivo finale di valorizzare le interrelazioni e le interdipendenze che endogenamente
ed esogenamente verrebbero attivate.
Da quanto finora osservato, la strategia del policy-maker che intende intervenire sui
fattori della produzione piuttosto che sui settori appare vincente. È però necessario, e
opportuno, andare al di là della classica dicotomia tra lavoro e capitale, muovendosi
lungo altre direttrici.
III.2 Fattori distrettuali di base
L’idea che la capacità competitiva di un area dipenda, almeno in parte, dalla presenza
di concentrazioni sul territorio di imprese è apparsa parecchi decenni fa negli scritti di
Alfred Marshall. L’aspetto interessante in Marshall 1920 è la presenza di meccanismi di
auto-sviluppo, ora detti causazione cumulativa, che portano a sostenere e rinforzare i
processi agglomerativi verso la formazione di veri e propri distretti. Questi meccanismi
si fondano principalmente su quattro fattori:
la creazione di legami d’offerta, tramite la presenza di imprese fornitrici di input a
vari livelli;
la creazione di un mercato del lavoro "spesso", cioè la presenza di un folto gruppo di
lavoratori specializzati;
la possibilità di sviluppo di una specializzazione produttiva;
38
la presenza di effetti di spill-over e, in generale, di sapere formale e informale tra le
imprese.
Tutto ciò però è condizione necessaria ma non sufficiente per aversi un distretto. Su
un piano astratto, in una realtà distrettuale occorre anzitutto che siano compresenti
spazialmente i prevalenti elementi caratterizzanti, ad un tempo necessari e sufficienti
per aversi distretto. In modo sommario essi sono:
1. territorio;
2. dimensione delle imprese
3. contesto socio-economico;
4. relazioni tra imprese.
Il territorio è forse l'elemento più importante per la caratterizzazione distrettuale. Il
territorio infatti non funge solo da base localizzativa ma anche da tessuto connettivo tra
gli operatori economici e sociali del distretto.
Con riguardo al secondo elemento, la dimensione delle imprese, si assume in
letteratura che in un distretto le unità produttive siano piccole e medie imprese. Si tratta
invero di una dimensione relativa, che assume significato diverso per ciascuna specifica
tipologia produttiva.
L'inclusione del contesto socio-economico tra gli elementi caratterizzanti il distretto
deriva dall'importanza del coinvolgimento di tutte le componenti di una data
localizzazione per generare le economie di scala legate ai fattori agglomerativi10
(equilibrio dinamico tra concorrenza e cooperazione, reti cognitive).
Da ultimo, le relazioni tra imprese, intese come forma permanente di interazione,
implementano il processo di specializzazione territoriale, che da solo non è sufficiente a
giustificare l'esistenza di un distretto. I continui contatti tra le imprese, riducono da un
lato il grado di concorrenza tra imprese di fase, dall'altro, attraverso il conseguimento di
vantaggi agglomerativi (informazioni sui mercati dei fattori e dei prodotti, adozione di
tecnologie innovative, apertura e penetrazione di nuovi mercati, ecc.), consentono una
riduzione dei costi di transazione.
10
Per questi si rinvia al prossimo paragrafo.
39
Partendo da questi fattori di base si arriva ad una prima distinzione tra distretti veri e
propri (caratterizzati dalla compresenza di tutti gli elementi menzionati), aree a
specializzazione territoriale con omogeneità di tipo settoriale (specializzazione di
prodotto), filiere territoriali in cui la specializzazione interessa le varie fasi di un
processo di produzione, consorzi, marchi o altre forme di associazioni tra produttori;
queste ultime categorie sono meglio discriminate includendo tra gli elementi definitori il
grado di formalizzazione raggiunto dall'aggregato territoriale.
III.3 Fattori distrettuali "trasversali"
È oramai imperante la visione che considera la dinamica produttiva fortemente
condizionata dall'ambiente in cui si svolge e, soprattutto, dai fattori che impiega. È
chiaro che i fattori caratterizzanti un distretto non sono più soltanto quelli appena
evidenziati, e quindi sia nelle analisi che nelle politiche si devono prendere in
considerazione altri fattori la cui importanza sta diventando preponderante. Peraltro si
tratta di fattori trasversali a qualsiasi tipologia di distretto.
III.3.1 Produttività e competitività
Le imprese, soprattutto quelle di minore dimensione, si trovano a dover affrontare
uno scenario economico caratterizzato da una accresciuta incertezza. Per quanto
riguarda i processi aziendali, lo scenario è dato da uno spostamento della frontiera verso
le applicazioni di sistema, dove più forte è lo svantaggio relativo delle imprese di
minore dimensione, più carenti sotto l'aspetto della disponibilità delle numerose e
necessarie competenze specialistiche, così come della capacità di formarle al proprio
interno o di acquisirle all'esterno.
Normalmente, in ambito distrettuale sono le medie imprese ha mostrare il più elevato
processo di mutamento nella composizione della forza-lavoro, poiché in esse emerge un
importante elemento di differenziazione rispetto alle imprese minori: la complessità
organizzativa e l'articolazione per aree funzionali. Si tratta di trasformazioni interne,
indotte dall'accelerazione competitiva, che possono permettere un più veloce
adeguamento all'introduzione di nuovo know-how gestionale e produttivo.
40
I temi della produttività e della competitività incrociano inevitabilmente con quelli
della qualità. In ambito distrettuale l'intersezione tra produttività e competitività, da un
lato, e qualità, dall'altro lato, è complessa ma visibile.
1. la spesa delle aziende in servizi appare la strada necessaria per mantenere
competitività sui mercati; in questa prospettiva, quindi, la produzione non è
caratterizzata soltanto dalle modalità produttive;
2. l'evoluzione distrettuale normalmente procede nella direzione di promuovere
tecnologie factor-saving;
3. viene potenziata e favorita la diffusione dell'informatica come strumento di gestione;
4. essenziale è la raccolta e la trasmissione delle informazioni.
Il policy-maker che programma interventi che coinvolgono queste aree tematiche
deve essere consapevole che le sinergie distrettuali di natura organizzativo-tecnologica
sono un nodo cruciale di qualsiasi processo di sviluppo locale, poiché assumono sia la
veste di oggetto dello sviluppo stesso che quella di soggetto.
III.3.2 Economie di agglomerazione
L'ampliarsi dell'orizzonte competitivo pone nuove sfide. La grande recente apertura
dei mercati, nazionali ed esteri, in pratica produce iperconcorrenza (repentina
acquisizione e perdita di leadership, adozione di strategie che "sacrificano" prodotti,
ingresso in alleanze temporanee, ecc.). Infatti, la globalizzazione richiede agli agenti
economici di strutturare fortemente la propria presenza sul mercato passando, mediante
notevoli capacità di accordo e integrazione con altre aziende.
Dal punto di vista commerciale sono evidenti gli svantaggi che comporta una piccola
dimensione produttiva. Essi non risultano chiaramente in un'ottica di breve periodo, che
anzi fa risaltare alcuni elementi di vantaggio per le imprese minori, in quanto la
presenza poco strutturata di imprese nel mercato consente di riallocare i flussi produttivi
con costi contenuti in presenza di instabilità nei volumi di domanda. Ma questo
vantaggio di breve periodo è più che superato dagli svantaggi di medio-lungo periodo,
sotto l'aspetto della presenza stabile ed efficace sul mercato. Si deve rammentare che
quanto più sono incerti gli scenari di riferimento e tanto più le PMI tendono a
41
conseguire profitti di breve periodo: ciò le induce a sviluppare prodotti tradizionali ma
che proprio per questo sono più soggetti alla concorrenza.
Su queste problematiche la "risposta" distrettuale è duplice: da un lato il distretto può
costituire l'ambiente idoneo per creare e/o difendere la tipicità delle produzioni, che
permette di sostenere i prezzi, dall'altro consente economie di agglomerazione, che
allentano la tensione sui costi.
Queste ultime, in particolare, assumono un ruolo determinante. Infatti le
agglomerazioni tendono continuamente ad ampliarsi e ad attirare nuove imprese, per
effetto delle economie che l'agglomerazione presenta, e la tendenza al raggruppamento
spaziale delle imprese è una delle caratteristiche dell'attività economica che possono
originare lo sviluppo per aree.
Le economie di agglomerazione appartengono alla categoria delle economie di scala
esterne. Ricordiamo brevemente che quelle interne sono dovute a variazioni della scala
di produzione, mentre quelle esterne derivano dallo sviluppo economico in sé per sé, e
quindi sono ottenibili dalle imprese senza modificare il livello di attività. Il vantaggio
delle economie di agglomerazione deriva dalla particolare localizzazione di più attività
economiche. La loro esistenza fa si che più aziende ottengano diminuzioni relative nei
costi, senza modificare la scala di produzione ma per la particolare associazione
spaziale, e per le imprese ciò significa essere più efficienti in mercati sempre più
contendibili,e quindi sempre più concorrenziali. È quindi evidente che le economie di
agglomerazione sono uno degli elementi decisivi che influenzano la decisione degli
imprenditori riguardo il sito della propria attività, e perciò anche del formarsi di aree più
sviluppate di altre.
L'e economie di agglomerazione "aiutano" il distretto a superare il livello di soglia
oltre il quale lo sviluppo distrettuale diviene autoalimentantesi. In sostanza, affinché lo
sviluppo dell'area si autogeneri è necessario raggiungere una certa dimensione minima
di mercato: in tal senso le economie di agglomerazione fanno sentire tutto il loro peso,
soprattutto nel caso in cui la spinta iniziale non sia superiore ad un certo livello minimo.
In caso contrario lo sviluppo dinamico dell'area non sarà di tipo cumulativo
(Leibenstein 1954, Meier e Baldwin 1966, Tattersall 1962, Thompson 1965).
42
III.3.3 Credito e finanza
Negli ultimi 10-15 anni è aumentato il peso dei vantaggi tradizionali della grande
dimensione, non solo in termini di maggior dotazione di capitale umano e di maggior
capacità di penetrazione commerciale stabile a livello globale, ma soprattutto di
maggior facilità nelle provviste delle necessarie risorse finanziarie.
La posizione finanziaria delle piccole e medie imprese, com'è noto, provoca
l'erosione dei vantaggi della maggiore efficienza economica. La situazione è critica
soprattutto per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, soprattutto per la
rarefazione di strumenti finanziari di carattere anticipativo, predisposti cioè a finanziare
i processi più rischiosi.
In un quadro che presenta investimenti dal rendimento particolarmente incerto e
legato alla stabilità della penetrazione su nuovi mercati, emerge con forza il problema
del reperimento sia di capitale di rischio che di credito.
Questa fragilità finanziaria è più rarefatta in ambito distrettuale. Nella "filiera
finanziaria" dalla quale traggono origine le diverse soluzioni tecniche e le diverse
modalità operative può distinguersi un modello di tipo anglosassone, in cui la creazione
di capacità imprenditoriale precede quella di capacità produttiva, ed un modello italiano
o del Nord-Est in cui spesso nella piccola impresa distrettuale, che lavora nell'indotto, si
assiste al processo inverso: prima si allestisce la capacità produttiva poi quella
imprenditoriale. In termini di fabbisogni finanziari, le conseguenze del modello italiano
più sbilanciate rispetto a quelle del modello anglosassone. Infatti, il preventivo
allestimento di capacità produttiva comporta un più veloce esaurimento delle
potenzialità di indebitamento dell'impresa elevando così il rischio e, allorché trattasi di
costruire la capacità imprenditoriale, detto rischio è destinato ad accrescersi sia per il
più esteso orizzonte temporale coinvolto.
III.3.4 Formazione
È noto che la capacità di un'impresa a reagire ad evoluzione impreviste dei mercati
risiede anche nella capacità della propria forza-lavoro adeguatamente preparata ed
elastica, in grado di trasferire rapidamente le proprie competenze da un'attività all'altra.
43
Infatti le caratteristiche della forza-lavoro richieste dalle aziende cambiano con una
velocità che dipende strettamente dall'intensità di fenomeni tradizionali, quali il
decentramento produttivo e la segmentazione del mercato del lavoro (in un mercato
primario, secondario e marginale), e di fenomeni nuovi, come la corsa alla tecnologia,
all’informatizzazione aziendale e alla globalizzazione dei mercati. Questi sono i
fenomeni che complessivamente implicano il rinnovamento dei livelli di professionalità
richiesti dalle aziende, e delle conseguenti qualifiche necessarie, e che stimolano
l'emergere di caratteri formativi legati alla capacità di organizzazione e di controllo di
situazioni impreviste e complesse.
In ambito distrettuale queste capacità sono ben apprezzate, soprattutto all'interno di
agglomerazioni verticali di imprese (filiere). Ma nemmeno un distretto sfugge ad alcune
evoluzioni recenti che impattano direttamente o indirettamente il fattore formazione:
1. la situazione demografica si presenta piuttosto diversa rispetto al passato; sono
prevedibili numerose conseguenze su vari aspetti della vita sociale ed economica, in
particolare sul mercato del lavoro e sulla domanda di servizi;
2. la spesa in istruzione aumenta più che proporzionalmente sotto l'impulso di una
domanda che vede in essa un valido e necessario investimento;
3. le persone con istruzione elevata tendono ad aumentare, così come le loro
retribuzioni relative;
4. in una società soggetta a rapida evoluzione anche la struttura per professioni della
domanda di lavoro cambia rapidamente, anche se in direzioni non facilmente
prevedibili.
In questa situazione di incertezza, l'unico modo per ridurre il rischio individuale è
tutt'ora quello di dotarsi di basi conoscitive sufficientemente ampie che permettano di
acquisire nuove capacità e specializzazioni, e di questo una realtà distrettuale non può
che beneficiarne.
44
III.4 Un fattore distrettuale specifico: il lavoro
Alcuni caratteri delle attività economiche assumono ruoli particolari se riferiti a
specifici settori di attività. Nel caso di economie locali di tipo rurale ciò avviene, ad
esempio, per il fattore lavoro. Come si può desumere da Corsi 2002, il ruolo di un
fattore produttivo specifico, quale il lavoro di tipo agricolo, cambia a seconda della
varietà di situazioni che consentono/non consentono uno sviluppo delle attività agricole
al tempo stesso ben specializzato e precisamente localizzato. Tali situazioni sono
rilevanti poiché potrebbero spiegare le differenze nei redditi medi agricoli di aree
diverse.
Questa visione del mercato del lavoro in ambito rurale si basa sull'ipotesi che
l'ambito distrettuale consentirebbe una maggiore efficienza del mercato del lavoro, con
benefici sui redditi conseguiti dalla famiglia rurale. In particolare, se il mercato del
lavoro locale è di modesto spessore, per la famiglia agricola può essere difficile
impiegare fuori dell'azienda qualsivoglia quantità di lavoro eccedente. Tale lavoro
(eccedente) sarà giocoforza impiegato nell'attività agricola: se i rendimenti marginali
dei fattori produttivi, lavoro compreso, sono decrescenti la conseguenza sarà una
diminuzione della produttività media del lavoro agricolo. Tale effetto sarebbe
probabilmente differenziato per dimensione aziendale, e non sarebbe nemmeno l'unica
conseguenza (Corsi 2002). Infatti ne risentirebbe il ritmo dello sviluppo locale, giacché
una riduzione di reddito nel periodo corrente si traduce quasi inevitabilmente in minore
propensione all'investimento; ne risentirebbero così anche i redditi futuri.
Tutto ciò, però, si basa sull'ipotesi che il mercato del lavoro rilevante per una
famiglia agricola sia quello locale; se non fosse così la famiglia agricola potrebbe
cedere senza ostacoli il lavoro eccedente in altri mercati del lavoro. Su tale questione
sono necessarie alcune considerazioni (Corsi 2002):
1. esiste una distanza oltre la quale è possibile lavorare fuori dell'azienda agricola solo
cambiando residenza;
2. ciò avviene con la contemporanea rinuncia ai vantaggi legati alla permanenza nella
famiglia rurale;
45
3. alcuni di tali vantaggi non sono presenti in altre tipologie familiari, e ciò significa
che per allocare lavoro altrove il differenziale di remunerazione deve essere più
elevato di quanto non possa essere per occupati in altri settori;
4. in pratica, a parità di differenziale nella remunerazione, la scelta del lavoratore
agricolo (appartenente ad una famiglia rurale) di occuparsi altrove è più difficile di
quanto non sia per altri occupati, e ciò spiegherebbe perché per tale lavoratore
assumono maggior rilevanza i mercati locali.
Detto questo, se si vuole esaminare l'offerta di lavoro extra aziendale, soprattutto
nella situazione in cui la famiglia agricola non può decidere liberamente la quantità di
lavoro da spostare all'esterno della propria azienda, è opportuno ricorre alla
strumentazione economica di Singh, Squire e Strass 1986, Corsi 1990, Huffman 1991.
Negli studi di questi autori si può riconoscere un modello di comportamento che si può
così stilizzare11
:
1. se non esiste alcun mercato del lavoro locale, le decisioni di lavoro della famiglia
agricola sono circoscritte all'attività della propria azienda; in tal caso, un agente
razionale presta il proprio lavoro nella stessa fino a che la sua produttività marginale
è superiore o uguale al saggio marginale di sostituzione tra lavoro e reddito dallo
stesso prodotto;
2. se esiste un mercato del lavoro locale, si può prendere in considerazione la cessione
di lavoro al di fuori dell'azienda agricola: ciò avverrebbe quando la produttività
marginale del lavoro prestato in azienda è inferiore al saggio di salario.
In un'area distrettuale certamente non si verifica la prima situazione, anche se è
altrettanto difficile che sia presente un mercato del lavoro perfetto, cioè un mercato in
cui non c'è alcun effetto di razionamento. È probabile che la contiguità spaziale di molte
unità produttive offra occasioni per prestare lavoro al di fuori della propria azienda, ed
in questo contesto sono rilevanti le modalità con cui ciò avviene.
Considerando una funzione di trasformazione tra lavoro e reddito caratterizzata da
una produttività marginale del lavoro che sia decrescente, in presenza di un esteso
11
Quanto segue è abilmente chiarito in Corsi 2002 (grafico 1).
46
mercato del lavoro, come già osservato, la famiglia rurale inizia ad cederlo altrove
quando la sua produttività marginale nell'azienda diviene inferiore al saggio di salario
percepibile in altre aziende. Se tale mercato oltre che esteso è anche perfetto, la cessione
di lavoro al di fuori della famiglia rurale può essere discrezionale in termini di quantità
(trasferimento anche infinitesimale) e libera in fatto di localizzazione. Si tratta di vedere
se in un ambito locale è effettivamente possibile scegliere liberamente tra lavoro nella
propria azienda e lavoro in altre aziende.
È probabile che in ambiti non distrettuali la mancanza di agglomerazioni aziendali
implichi un mercato del lavoro di modesto spessore, che dia meno opportunità di
occupazione alternative. Si può dimostrare che quando ciò avviene il reddito medio
agricolo (reddito per ora di lavoro) tende a ridursi. Più in generale, se la quantità di
lavoro cedibile all'esterno della famiglia rurale è limitata, indipendentemente dal motivo
(assenza di idonee opportunità, rigidità sulle quantità di lavoro scambiabile, ecc.) la
funzione di trasformazione tra lavoro e reddito è diversa da quella del caso di mercato
del lavoro perfetto (Nakajima 1986), ed è tale che:
1. aumenta la quota di lavoro che resta nell'azienda agricola di appartenenza;
2. aumenta la produzione dell'azienda;
3. visto che la produttività marginale del lavoro in azienda è decrescente, si riduce il
reddito medio.
In sintesi, quanto più stringenti sono i vincoli sul lavoro extra aziendale tanto
maggiori sono gli effetti negativi sui redditi medi agricoli, con differenziali tra zona e
zona che dipendono dal grado di separazione dei mercati locali del lavoro.
Si può anche dimostrare che tali effetti sono peggiori per le piccole aziende che non
per le grandi (Corsi 2002). Infatti, nella misura in cui una maggiore dotazione di
capitale consente una superiore produttività del lavoro, la funzione di trasformazione tra
lavoro e reddito è diversa anche per dimensioni aziendali. Quella della grande azienda
agricola è tale per cui i vincoli all'allocazione di lavoro in azienda/fuori azienda sono
meno stringenti, e conseguentemente gli effetti negativi prima discussi sono meno
rilevanti.
47
Al di là delle variazioni della produzione aziendale e del reddito mediamente
conseguibile, esistono anche altri effetti (Corsi 2002). Infatti, l'aumento di produzione
locale normalmente non ha grossi effetti sul ribasso dei prezzi dei complessivi mercati
agricoli, e ciò implica che tale aumento non subisce alcuna disincentivazione (di
mercato, perché dal punto di vista reddituale gli effetti prima descritti sono negativi). In
tal caso, se le condizioni ambientali non consentono modificazioni delle combinazioni
produttive12
, l'aumento di produzione crea pressione sulla domanda di terra con
conseguente aumento della rendita fondiaria a danno del reddito agricolo.
Tale vasta gamma di effetti indesiderati possono attutirsi in ambito distrettuale, dove
le opportunità di impiego sono superiori e più flessibili, dove cioè è più flebile il
vincolo di accesso razionato al mercato del lavoro.
12
A favore di quelle più labour-intensive.
48
BIBLIOGRAFIA
Bagnasco A. (1977) - "Tre Italie: la problematica territoriale dello sviluppo italiano",
Bologna, Il Mulino
Becattini G. (a cura di) (1987) - "Mercato e forze locali, il distretto industriale",
Bologna, Il Mulino
Brigo L., Fiorani L. e Gatti S. (1992) - "Un distretto agro-industriale, l’attività di
trasformazione della carne suina nel modenese", La Questione Agraria, n. 45
Caillavet F., Guyomard H., Lifran R. (a cura di) (1994) - "Agricultural household
modelling and family economics", Amsterdam, Elsevier
Cecchi C. (1992) - "Per una definizione di distretto agricolo e distretto agroindustriale",
La Questione Agraria, n. 46
Corsi A. (1990) - "I modelli famiglia azienda: una rassegna della letteratura", La
Questione Agraria, n. 39, pp. 65-95
Corsi A. (1994) - "Imperfect labour markets, preferences, and minimum income as
determinants of pluriactivity choices", in Caillavet F., Guyomard H. e Lifran R. (a
cura di), "Agricultural household modelling and family economics", Amsterdam,
Elsevier, 87-109
Corsi A. (1995) - "Azienda familiare e mercati del lavoro", in Mantino F. (a cura di),
"Azienda agraria e dintorni", Roma, INEA, 143-79
Corsi A. (2002) – "Sviluppo agricolo locale e mercato dei fattori", in Basile E. (a cura
di), "Sviluppo rurale: società, territorio, impresa", Milano, Franco Angeli, 245-263
Corsi A. e Findeis J.L. (2000) - "True state dependence and heterogeneity in off-farm
labour participation", European Review of Agricultural Economics, n. 2
Cosentino V. e De Benedictis M. (1976) - "Forme di conduzione e equilibrio
dell’impresa", Rivista di Economia Agraria, n. 2, pp. 247-283
Huffman W.E. (1991) - "Agricultural household models: survey and critique", in
Hallberg M.C., Findeis J.L. e Lass D.A. (a cura di) - "Multiple job holding among
farm families", Ames, Iowa State University Press, 79-111
Iacoponi L. (1990) - "Distretto industriale marshalliano e forme di organizzazione delle
imprese in agricoltura", Rivista di Economia Agraria, n. 4
Iacoponi L. (1995) - "Impresa e distretto: un’interpretazione della sostenibilità
dell’impresa familiare", in Mantino F. (a cura di), "Azienda agraria e dintorni",
Roma, INEA, 55-98
Leibenstein H. (1954) - "Economic backwardness and economic growth", Wiley, New
York
Lopez R.E. (1986) - "Structural models of the farm household that allow for
interdependent utility and profit-maximization decisions", in Singh I., Squire L. e
Strauss J. (a cura di), "Agricultural household models, extensions, applications, and
policy", Baltimore, John Hopkins University Press, 306-325
Marshall A. (1920) - "Principles of economics", VIII edition, Macmillan, London
Meier G.M. e Baldwin R.E. (1966) - "Economic development: theory, history, policy",
Wiley, New York
Monke E., Avillez F., Pearson S., Marenco G. e Perone Pacifico C. (a cura di) (1998) -
"Small farm agriculture in Southern Europe", Aldershot, Ashgate
Nakajima C. (1986) - "Subjective equilibrium theory of the farm household",
Amsterdam, Elsevier
49
Singh I., Squire L. e Strauss J. (a cura di) (1986) - "Agricultural household models,
extensions, applications, and policy", Baltimore, John Hopkins University Press
Tattersall J.N. (1962) - "Exports and economic growth: the pacific northwest", Papers
and Proceedings, Regional Science, 9, pp. 46-58
Thompson W.R. (1965) - "A preface to urban economics", John Opkins Press,
Baltimore
50
V. IL RUOLO DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE
NON-MARKET INTERACTION
Da sempre i modelli di crescita endogena si concentrano sul ruolo determinante
assegnato al capitale umano ed all'innovazione tecnologica, per il loro effetto sulla
crescita economica; recentemente, però, l'attenzione si è spostata verso i fattori politico-
sociali, evidenziando come il cosiddetto capitale sociale sia un fattore altrettanto
importante nel generare performance di crescita profondamente differenziate per aree
(Hall e Jones 1999). Con il termine capitale sociale si comprendono molti fenomeni: si
spazia dal ruolo svolto dalle istituzioni (Barro 1996, Perotti 1996) fino ai rapporti
formali ed informali che si instaurano tra gli agenti economici.
Occorre tenere presente che un distretto rurale è qualcosa di più di un distretto
agricolo, poiché congloba al suo interno non solo componenti strettamente economiche,
ma anche socio-economiche. Il voler riconoscere il ruolo dei fattori sociali all'interno di
un distretto rurale implica il dover considerare anche le cosiddette non-market
interaction. Si tratta di un approccio (teorizzato compiutamente in Glaeser e
Scheinkman 2000), che solo apparentemente è in contrapposizione con il ruolo del
capitale sociale. Anzi, a nostro avviso lo esalta poiché quest'ultimo sostanzialmente
prevede l'intervento di istituzioni (locali e non), con anche (e ovviamente non solo) il
compito di mediare l'operatività di regole di mercato con regole non di mercato.
Nell'ambito del distretto rurale questo è un ruolo piuttosto importante. Nel mercato,
infatti, è il sistema dei prezzi che indirettamente incide sulle relazioni agenti. Le non-
market interaction possono produrre esternalità, giacché l’effetto dell’azione di un
agente può essere influenzato dalle scelte degli altri agenti che appartengono allo stesso
distretto, e tutto ciò può accadere senza che via sia nessuna mediazione dei prezzi
(Carillo 2003).
Va considerata anche l’intensità non-market interaction. Al fine di valutare
pienamente gli effetti di questa caratteristica vi sono autori utilizzano il concetto di
distanza sociale (Akerlof 1997, Kirman 1999). Si tratta di uno strumento analitico
sviluppato originariamente in ambito non economico (Merton 1968), nel quale è stato
successivamente introdotto per definire la vicinanza-lontananza sociale tra uno o più
agenti, al fine di studiare l'intensità dello scambio che avviene tra essi. La funzione di
distanza sociale è stata delineata come the number of links in the shortest path between
51
the agents (Kirman 1999, pag. 24). Nel momento in cui la distanza sociale tra due
agenti diviene minima, allora è possibile che lo scambio tra essi sia massimo: è in
questa situazione che l'influenza di un agente sull’altro agente è piuttosto sensibile.
A questo punto, però, è necessario chiedersi perché recentemente si è diffusa l'ipotesi
il comportamento socio-economico degli agenti distrettuali possa essere compreso
valutando anche gli effetti delle non-market interaction. Una risposta sufficiente può
essere ritrovata in quanto prima osservato sulla necessità di mediazione tra regole di
mercato e non, quando queste ultime assumono un peso non irrilevante. Ma non si tratta
soli di questo. Nel ben noto lavoro di Lucas 1988, ad esempio, si mette in luce come il
know-how acquisito di alcuni operatori raggiunga anche chi non ha posto in essere
nessuna attività di apprendimento. Lucas dimostra che tale passaggio di conoscenze, che
incide sull'accumulazione di capitale umano, può aumentare il tasso di crescita. Al di là
di quanto osservato in Lucas 1988, è noto ed evidente il ruolo del distretto nel facilitare
questa trasmissione di know-how.
Inoltre, come recentemente è stato messo in luce (Bowels e Gintis 2000, Durlauf S.
2000), il considerare anche le non-market interaction implica l’allontanamento (pur
parziale) dalle note ipotesi walrasiane, cioè dalla visione di un agente che opera solo
attraverso i meccanismi di mercato, tra l’altro perfetti. Quando queste ipotesi divengono
più sfumate, grazie alle non-market interaction, è possibile analizzare i casi in cui
l'agente sia influenzato dal contesto socio-economico, come appunto avviene in un
distretto rurale.
V.1 Le non-market interaction come premessa, e non come
alternativa, al ruolo del capitale sociale
La scelta di un operatore può non essere irrilevante su quella di un altro per tre vie:
ne condiziona le preferenze, ne modifica le aspettative, ne altera i vincoli da cui dipende
l’ottimalità delle scelte (Manski 2000).
A titolo di esempio si possono citare situazioni di impatto sui vincoli: si pensi alla
congestione provocata da operatori che utilizzano risorse non riproducibili, oppure
quando l’investimento in ricerca e sviluppo altera lo stato della della tecnologia dal
quale dipendono altre imprese (Romer 1986 e 1990). Esempi di interazione attraverso la
52
modifica delle aspettative si ritrovano nei fenomeni di observational learning (Kalai e
Leher 1993, Manski 1993), cioè quei casi in cui un operatore rivede le proprie
aspettative studiando quelle degli altri. L'interazione che si manifesta attraverso il
condizionamento delle preferenze si ha, ad esempio, quando nella ricerca di status un
agente modifica le proprie sulla base delle preferenze degli altri agenti (Carillo 2003).
V.1.1 Effetti delle non-market interaction sul tasso di crescita
In presenza di un evidente peer group effect, cioè una situazione in cui gli agenti
sono influenzati dal comportamento degli altri agenti che appartengono al loro stesso
gruppo (Durlauf S.N. 2002), è forte l'incentivo alla formazione e separazione di gruppi
di agenti, tanto differenziati esternamente quanto omogenei internamente. In tale
contesto l'equilibrio economico è inefficiente, visto che consentirebbe un minore tasso
di crescita di quanto altrimenti possibile. Ciò accade perché vi possono gruppi meno
avvantaggiati di altri, e l’effetto di separazione tra gruppi fasi che questi abbiano minori
incentivi all’accumulazione di know-how, con conseguente riduzione del livello medio
di capitale umano dell'intero distretto. In pratica, si può ritenere che le non-market
interaction possono accrescere le disparità di reddito, fino a provocare situazioni che si
possono definire trappole della povertà, poiché dalle stesse gli agenti più svantaggiati
hanno grandi difficoltà ad uscire (Benabou 1996).
Le non-market interaction consentirebbero anche di valutare l'impatto sulla crescita
locale del ruolo svolto dalla famiglia rurale in ambito distrettuale. Esiste un intero
gruppo di modelli che accentra l'attenzione sul ruolo della famiglia, pur se non
necessariamente rurale, nella processo di formazione delle scelte degli agenti. Sia
nell'analisi di Galor e Tsiddon (1994 e 1997) che in quella di Hassler e Rodriquez Mora
(2000) si può vedere come la scelta occupazionale, e quindi anche l'accumulazione di
capitale umano, dipenda anche dalle relazioni familiari. Ad esempio, un soggetto i cui
genitori svolgono un'occupazione che prevede un alto livello di capitale umano è
fortemente incentivato all'accumulazione dello stesso; anche in questo caso, perciò,
compare la situazione della trappola della povertà, per quei soggetti i cui genitori hanno
un'occupazione cui sono associati bassi livelli di capitale umano: tali soggetti avrebbero
minori incentivi (e probabilità) di accumulare alti livelli di tale capitale.
Un'ulteriore via attraverso la quale le non-market interaction impattano sul tasso di
53
crescita economica è l'ipotesi che un agente adotti delle scelte anche in base agli effetti
delle stesse sul proprio status (Carillo 2003); si tratta di un'ipotesi non rara nelle scienze
economiche, e risale addirittura a Smith 1776. L'esistenza di un ranking tra gli agenti
sociale implica che chi gode di un buon status usufruisca di trattamenti più favorevoli.
Questa situazione può appalesarsi, ad esempio, in un maggior ricorso non solo a beni di
mercato ma anche a quelli non di mercato: si pensi al ruolo di fattori quali l'autorità e il
potere. Va notato che le imperfezioni di mercato rendono i beni non liberamente
acquisibili (si pensi all'informazione), e in questo uno status elevato gioca un ruolo
rilevante: gli agenti che lo posseggono consumano di tali beni a livelli più elevati di
coloro con status modesto (Postlewaite 1998, Weiss e Fershtman 1998).
In Fershtman, Murphy e Weiss 1996 si sostiene che la ricerca di status può risolvere i
problemi delle esternalità, nel senso che potrebbero assumere un buon status coloro che
svolgono attività cui sono associate esternalità positive. Ciò fa pensare, ad esempio, a
coloro che svolgono attività rurali rispettose dell'ambiente.
Gli impatti sulla crescita economica provocati dalla continua ricerca di status da
parte degli operatori, ivi compresa la crescita che interessa ambiti distrettuali, sono
controversi. Ad esempio, Hirsh 1976 ritiene che all'incedere dello sviluppo il desiderio
di status sposta la domanda verso il consumo di beni non da investimento, con l'ovvia
conseguenza di limitare il processo di accumulazione e, conseguentemente, la crescita.
Nell'analisi contenuta in Fershtman, Murphy e Weiss 1996, ove si considera il
parallelismo tra livello di status e occupazioni ad alto tasso di conoscenza-istruzione, si
arriva alla conclusione che nel caso di disuguale distribuzione della ricchezza,
soprattutto quando ciò avviene in modo sensibile ed evidente, gli agenti ricchi optano
comunque per attività lavorative che, per essere convenientemente svolte,
richiederebbero livelli di conoscenza-abilità piuttosto elevati, indipendentemente dal
fatto che le conoscenze e le abilità necessarie siano effettivamente presenti. Ciò
provocherebbe una sorta di crowding out, cioè un effetto di spiazzamento degli agenti
molto meno abbienti ma certamente più dotati in fatto di conoscenze e abilità. È
evidente che, se tale scenario viene confermato, gli impatti sulla crescita non potranno
che essere riduttivi.
V'è anche chi, al contrario, ritiene possibili scenari esattamente opposti a quelli
appena descritti,. Ad esempio, sia in Cole, Mailath e Postlewaite 1992 che in Corneo e
54
Jeanne 1997, si conviene che vi sono impatti positivi sul processo di accumulazione e
crescita se la ricerca status è funzione della ricchezza, poiché ciò favorirebbe la
propensione al risparmio.
V.2 Il capitale sociale
Oggigiorno negli studi economici è molto diffusa l'ipotesi che il ruolo del capitale
sociale sia un tassello critico di qualsiasi processo di sviluppo economico, al punto da
essere oramai considerato un fattore direttamente paragonabile ai tradizionali fattori
produttivi di tipo fisico e tecnologico (Carillo 2003); anzi, meriterebbe però un livello di
attenzione superiore poiché del processo di sviluppo economico non sarebbe solo uno
degli input ma anche uno degli output. Inoltre esso appare come il punto di raccordo tra
interessi di mercato e non (prima discussi).
Questa attenzione degli economisti verso il ruolo del capitale sociale, però, è un fatto
relativamente recente, e quindi, con tutta probabilità, foriero di nuovi sviluppi. Tale
concetto è stato per decenni molto approfondito nelle scienze sociali; uno dei lavori cui
si può retrodatare l'interesse delle scienze sociali è Hanifan 1922. Si deve attendere la
fine del secolo scorso per la sua prepotente assunzione a fattore "degno" di grande
attenzione anche per le scienze economiche; prova lampante ne sono lo studio sulle
istituzioni sviluppato in North 1990, e quello sugli effetti delle tradizioni civiche di
Putnam 1993a.
Secondo la definizione che si ritrova in Putnam 1993b (pag. 167) il "social capital
refers to features of social organization, such as trust, norms, and networks, that can
improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions". Un visione un po'
diversa si ritrova in Woolcock e Narayan 2000 (pag. 226): "social capital refers to the
norms and networks that enable people to act collectively".
In Woolcock 2000 si ritrovano le prevalenti varianti tipologiche che può assumere il
capitale sociale. Non sono certamente le uniche, ma è da ritenere che ai fini dell'analisi
distrettuale sia essenziale considerarne almeno tre di quelle proposte dall'autore;
specificamente si tratta di:
a) le associazioni orizzontali, cioè quelle che regolano le relazioni tra gruppi sociali
55
diversi (bridging social capital);
b) la qualità delle istituzioni governative (governance);
c) la natura delle relazioni tra agenti e Stato (state-society relations).
L'autore dimostra che a seconda delle possibili combinazioni che possono derivare
dalle suddette varianti tipologiche, più precisamente, del fatto che tra tali tipologie vi sia
succedaneità o complementarietà, possono aversi impatti molto diversi sul processo di
sviluppo economico. Si consideri ad esempio la presenza di un evidente legame di
complementarietà tra Stato e agenti privati, cioè quando sia la governance che il
bridging social capital giocano un ruolo di primo piano: il risultato potrebbe essere
virtuoso, cioè con effetti positivi sul processo di sviluppo, poiché una tipologia di
capitale sociale "confermerebbe" l'altra. Una configurazione diametralmente opposta,
cioè un impatto negativo sul processo di sviluppo, potrebbe aver luogo quando una delle
due citate tipologie è di basso profilo: nel caso in cui, ad esempio, sia modesto il
bridging social capital sarebbe possibile che la governance (cioè le istituzioni
pubbliche) si sostituiscano agli agenti (relazione di succedaneità). Gli effetti negativi
sullo sviluppo deriverebbero dal fatto che tale configurazione delle due tipologie di
capitale sociale amplierebbe le disuguaglianze, invece di smorzarle, con il (possibile)
risultato finale di escludere i gruppi sociali "non dominanti".
Questi due esempi sottendono una "regola" generale in fatto di legami tra diverse
tipologie di capitale sociale: la complementarietà avrebbe impatti positivi, mentre la
succedaneità potrebbe indurre (ma non necessariamente) impatti negativi sul processo di
sviluppo (Carillo 2003).
V.2.1 Il ruolo del capitale sociale sui processi di sviluppo
Sulla base di quanto finora rilevato, diventa centrale la questione sul ruolo del
capitale sociale sullo sviluppo economico.
Non sono poche le analisi in cui l'ipotesi prevalente poggia su una sorta di effetto-
fiducia del capitale sociale, cioè un elemento assolutamente centrale in ambito
distrettuale: la fiducia che gli agenti riporrebbero sul capitale sociale avrebbe un impatto
positivo sul processo di sviluppo, giacché ciò implicherebbe la riduzione dei cosiddetti
costi di transazione. Su questa linea si pongono Zak e Knack 2001 e Guiso, Sapienza e
56
Zingales 2000. I primi considerano l'effetto-fiducia sugli agency cost e quindi sugli
investimenti e sul processo di sviluppo, i secondi concentrano l'attenzione su un tema
particolare, ma altrettanto importante: l'effetto-fiducia sui rischi che il sistema bancario
sopporta nella concessione di credito alle imprese, sostenendo che la maggior fiducia
indotta dal capitale sociale favorisce l'efficienza del sistema creditizio. Su questo vi
sono verifiche empiriche parallele, ottenute cioè in altri ambiti di ricerca. Si veda al
riguardo Russo e Rossi 1999 in cui si riscontra una migliore disponibilità di credito in
ambito distrettuale13
, che notoriamente è fortemente caratterizzato da contratti impliciti
(basati cioè sulle reti di fiducia).
In Bowles e Gintis 2002 e Routledge e von Amberg 2003 si considerano altri legami
tra ruolo del capitale sociale e sviluppo. L'ipotesi di base in entrambe le analisi è che il
capitale sociale ha un ruolo economico poiché favorisce comportamenti cooperativi:
1. Bowles e Gintis ritengono che a livello locale si possono sviluppare meccanismi di
governo che facilitano gli equilibri cooperativi;
2. Routledge e von Amberg ritengono che il capitale sociale consenta equilibri Pareto-
ottimali nelle cosiddette situazioni di "dilemma del prigioniero"; per essi il capitale
sociale è un bene pubblico che deriva dalla frequenza degli scambi tra agenti, e dalla
possibilità del loro controllo, e che consentirebbe equilibri Pareto-ottimali
ogniqualvolta la "mano invisibile" del mercato non li garantisce (e
contemporaneamente è troppo costoso scrivere contratti completi).
Altre analisi si concentrano sulle caratteristiche delle relazioni che si instaurano tra
agenti privati e istituzioni pubbliche. In Knack e Keefer 1997 trovano conferma gli
impatti positivi sullo sviluppo, e anche sul welfare, derivanti da relazioni di
complementarietà tra agenti privati e istituzioni pubbliche. Secondo gli autori le
relazioni complementari sono favorite dall'omogeneità degli agenti e dalla non rilevante
difformità nella distribuzione della ricchezza; come si può notare, sono pre-condizioni
che è più probabile riscontrare in ambiti distrettuali.
13
Minor costo del denaro e minore probabilità di subire razionamenti.
57
V.2.2 Il ruolo delle istituzioni
Il possibile ruolo dei policy-maker in ambito distrettuale deriva dal ruolo
determinante del capitale sociale nei processi di sviluppo, ruolo che, come prima
rilevato, deriverebbe dalla riduzione dei costi di transazione e dell'incertezza associati
agli scambi: ciò a sua volta favorisce gli investimenti (di qualsiasi tipo) e permette la
soluzione cooperativa dei problemi dell'azione collettiva.
Nel momento in cui il decisore pubblico ritiene opportuno intervenire nell'evoluzione
distrettuale, deve essere consapevole del ruolo delle istituzioni (con forma associativa
tra enti locali) nei processi di sviluppo.
Il peso delle istituzioni pubbliche nel tracciare i sentieri di sviluppo discende
strettamente dalla loro attività di strutturazione delle scelte economiche prese dagli
agenti privati. Infatti, è oramai un'idea comunemente accettata il fatto che i fattori
tradizionali (capitale e lavoro) da soli non riescono ad attivare processi di sviluppo, e
che perciò richiedono l'idoneo supporto di fattori complementari e strutturali (Solari
2002). Non a caso il pensiero economico distrettuale indica i fattori capitale e lavoro
come necessari ma non sufficienti: lo diventano solo se affiancati da idonei fattori
istituzionali.
Un altro caposaldo del pensiero economico distrettuale è il ruolo svolto da
"meccanismi" di sviluppo endogeno: non v'è alcuna forza di attrazione (o se c'è è
modesta) di imprenditori (e quindi investimenti) non locali se non esiste
un'imprenditoria locale che da sola possa garantire la cumulatività del processo di
sviluppo. Da ciò logicamente derivano ulteriori funzioni delle pubbliche istituzioni che
desiderano occuparsi dello sviluppo locale: creare e mettere a disposizione dei beni
pubblici "locali", nel senso di essere fruibili entro uno specifico territorio, con
caratteristiche idonee ad accompagnare i processi di sviluppo autoalimentatesi.
Su questo tema è opinione diffusa che le istituzioni pubbliche locali possono
avvantaggiarsi nella soluzione dei problemi locali grazie alle informazioni che
posseggono sulle specificità locali. È altrettanto vero che questi vantaggi sono troppo
modesti se l'amministrazione locale è di dimensione troppo esigua, ad esempio
comunale; il concetto di adeguatezza dimensionale dell'istituzione, però, è relativo, in
quanto proporzionato alla dimensione delle aree potenzialmente destinatarie delle
58
politiche di sviluppo. Se si prende a riferimento il livello comunale, ad esempio,
l'amministrazione pubblica si rivelerebbe probabilmente non adeguata a gestire le fasi di
sviluppo sia per l'ammontare di risorse sia per l'ottimale gestione delle infrastrutture
economiche (Solari 2002). È proprio per questo che nel nostro Paese si ribadisce
l'opportunità gestire processi di sviluppo territoriale su area vasta.
V.2.3 I beni pubblici locali
Occorre innanzitutto premettere la diversità concettuale tra istituzioni pubbliche
formali ed informali (Voigt 1999b). Le formali possono essere così caratterizzate:
1. dipendono da norme di diritto pubblico e diritto amministrativo;
2. in alternativa possono essere di natura contrattuale;
3. sono in evoluzione per le varie riforme che stanno puntando a ridefinire i ruoli
amministrativi locali.
In altri termini, sono state introdotte (legge 142/90 e legge "Bassanini") o stanno per
essere introdotte:
1. nuove modalità di pianificazione e gestione dei processi di sviluppo economico;
2. nuove forme di gestione (istituzionale) di alcuni servizi locali
.
È soprattutto negli anni '90 che sono apparse nuove forme istituzionali per le
amministrazioni che tra i loro scopi hanno anche la programmazione territoriale dello
sviluppo economico. Le norme attuali permettono l'impiego di strumenti innovativi e
flessibili per la pattuizione delle regole e per la delimitazione del territorio entro il quale
esse vanno rispettate.
Tra i motivi della frammentazione e della diffusione territoriale dello sviluppo
economico del Nord Est del Paese v'è anche la rarefazione della programmazione
(Solari 2002); per certi versi si tratta di caratteri positivi, perché è stata ampia la
porzione di territorio che si avvantaggiata del processo di sviluppo, ma negli anni
recenti sono apparsi limiti evidenti che consistono nell'inadeguatezza dei servizi e nella
congestione delle infrastrutture. Si tratta di inefficienze che ancora una volta, se ce ne
59
fosse bisogno, dimostrano l'opportunità non solo di programmare il processo di
sviluppo, ma di farlo anche su aree vaste. Quanto vaste è certamente un parametro
relativo, ma è oramai certo la dimensione distrettuale appare più consona a quella
comunale.
Se questo è vero, sono necessari sia un parziale "ripensamento" delle funzioni delle
istituzioni formali, sia l'ottimale dimensionamento delle aree destinatarie di politiche di
sviluppo locale. Nel far questo è quasi certo che si incontreranno vischiosità del tipo
seguente:
1. modesto interesse verso forme associative (la teoria economica affronta questo
problema mediante il cosiddetto "dilemma del prigioniero");
2. le difficoltà di relazione tra amministrazioni, direttamente proporzionale al loro
livello;
3. l'eterno problema della disponibilità di risorse (vincolo di bilancio).
V.2.4 Alcuni principi di base connessi alle istituzioni locali
Prima di delineare il quadro teorico che definisce le istituzioni pubbliche locali in
relazione alla strutturazione dello spazio economico, è opportuno premettere lo spettro
delle forme istituzionali esistenti (Solari 2002):
1. in base all'origine: istituzioni progettate dall'alto ed istituzioni (relativamente)
spontanee (le cosiddette iniziative dal basso);
2. in base al loro operato: istituzioni che organizzano gli insediamenti, che coordinano i
piani di sviluppo, che organizzano servizi, che gestiscono finanziamenti, che
realizzano interventi di marketing territoriale;
3. in base al modo con cui attuano le politiche: istituzioni che intervengono
direttamente, istituzioni con attività di supporto, istituzioni con attività promozionale,
istituzioni con attività di coordinamento.
Sulla base di questa gamma tipologica è utile delineare i principi basilari che possono
tracciare l'evoluzione delle istituzioni pubbliche locali, evoluzione che si sviluppa
parallelamente alla soluzione dei problemi che inevitabilmente si incontrano nella
60
strutturazione dello spazio economico.
Ordine spontaneo e progettato
La prima tipologia di ordine trova i suoi fondamenti nella seconda metà XVIII
secolo, ma viene portato alla ribalta dagli studi di Hayek 1960 e 1973; due decenni dopo
il dualismo con l'ordine progettato14
diviene uno strumento per l'analisi delle istituzioni
(Kasper e Streit 1998, Voigt 1999a, 1999b e 1999c).
Questa contrapposizione è in fase di ridefinizione, giacché l'attuale fenomeno del
veloce decadimento delle regole fa perdere peso al concetto di ordine spontaneo inteso
come "determinazione della tradizione". La nuova interpretazione dell'ordine spontaneo
trova fondamento in ciò che a tutti è noto come "concertazione di interessi". In pratica,
il concetto di spontaneità da rilievo ai processi di partecipazione delle varie parti nello
stabilire le regole.
Istituzioni formali ed informali
Per quanto riguarda le istituzioni formali si rinvia a quanto precedentemente rilevato
(sezione V.2.3). Le istituzioni informali trovano fondamento non solo in elementi
culturali e regole comportamentali, ma anche in forme associative spontanee.
Questa contrapposizione emerge in tutta la sua rilevanza nel momento in cui si
applicano i concetti del federalismo funzionale, che infatti è sostanzialmente un
tentativo di legittimare le istituzioni pubbliche locali originate del basso.
Il sistema di regole
Su questo tema Buchanan 1990 e Vanberg 1994 focalizzano l'attenzione su due
aspetti:
1. scelte all'interno di un sistema di regole;
2. regole che inquadrano i meccanismi di scelta.
14
Un insieme di regole "intenzionali".
61
Anche in questo caso si tratta di concetti piuttosto rilevanti, soprattutto perché
attivare un ente che abbia la responsabilità di progettare lo sviluppo su base territoriale
equivale ad assegnare un set di norme ad uno spazio economico.
V.2.5 Come inquadrare le istituzioni locali
In Voigt e Kiwit 1998 si individuano le istituzioni immedesimandole nelle regole a
loro volta classificate sia in base al modo con cui vengono applicate (meccanismo
interno ed esterno15
) sia per la loro origine (la pubblica autorità, i costumi prevalenti, i
principi etici, ecc.).
In Voigt 1999a si ritiene che l'efficacia delle regole (quindi delle istituzioni) discende
dal grado con cui le stesse ripropongono i principi etici. Si tratta di una visione che
potrebbe avere una certa rilevanza proprio a livello locale, cioè un contesto in cui
istituzioni (regole) di tipo esterno potrebbero stridere con consuetudini locali.
Da North 1990 si possono dedurre tre livelli di analisi del tema in oggetto:
1. l'ambito delle scelte socio-economiche e delle conseguenti azioni;
2. i contratti (espliciti ed impliciti) che definiscono le azioni;
3. le regole cui i contratti si adeguano.
V.2.6 La programmazione economico-territoriale
Come chiaramente desumibile da Solari 2002, è opportuno riflettere su cinque aspetti
rilevanti, che rendono evidenti i tratti che deve assumere la programmazione
economico-territoriale.
Una prima riflessione va fatta sulla definizione delle aree per insediamenti produttivi:
da un lato è certamente un modo efficace per "governare" le attività economiche,
dall'altro lato, però, si modifica la struttura di proprietà del territorio.
Una seconda riflessione concerne l'estrema diffusione territoriale dello sviluppo
economico del Nord-Est, che ha prodotto un processo di accumulazione capitalistica che
15
Le norme delle istituzioni esterne vengono fatte rispettare da autorità esterne, mentre quelle interne
godono di meccanismi di autoriproduzione.
62
può certamente ritenersi frammentato. I fattori che hanno favorito questi caratteri sono
sostanzialmente due:
1. la programmazione territoriale di micro area, che trova giustificazione nelle facoltà
delle amministrazioni comunali;
2. la ricerca di accessi diretti alle vie di comunicazione.
Lo sviluppo territorialmente frammentato, per altri motivi definito anche
"periferico", è probabilmente il principale fattore che ha consentito il fiorire della
piccola e micro imprenditorialità, ma è altrettanto vero che si tratta di una modalità di
sviluppo che ha "consumato" molto spazio, forse troppo.
Una terza riflessione riguarda le forze spontanee ed endogene che caratterizzano il
modello di sviluppo del Veneto: non tutte le micro aree comunali se ne avvantaggiano.
In tal contesto non si possono sottovalutare fenomeni di adverse selection indotti da
politiche di sviluppo non ottimali:
1. richiamo di investimenti non adatti, o meno utili alla cumulatività dello sviluppo;
2. struttura produttiva fragile;
3. difficoltà nell'organizzare forme di coordinamento locale.
Una quarta riflessione va fatta sulla necessità di valorizzare il territorio. Si sta
facendo riferimento al marketing territoriale; ma non è solo questo che conta, ma anche
la sua necessaria premessa: la conoscenza del territorio, fatto fondamentale che consente
di indirizzare gli investimenti evitando le posizioni di rendita.
Una quinta riflessione considera il già citato "dilemma del prigioniero", che nei
processi di sviluppo su base locale produce, ad esempio, una corsa al ribasso nei costi
per l'insediamento di attività produttive in micro-aree. A prima vista trattasi di un fattore
desiderabile, in realtà rischia di ergersi a parametro soglia della decisione
d'investimento: se ciò offusca le altre necessarie valutazioni di opportunità ne
deriverebbe uno sviluppo locale "disordinato", a "macchia di leopardo".
Queste riflessioni forniscono la vera ragione della programmazione territoriale su
spazi economici perlomeno distrettuali, e non su micro aree.
63
V.2.7 Caratteristiche delle istituzioni per lo sviluppo locale
Com'è noto, vi sono numerose tipologie di istituzioni che si occupano di sviluppo
locale. In questa sede si considerano quelle di forma associativa.
1. Consorzi di sviluppo. Hanno l'obiettivo principale di trasformare aree per scopi
produttivi. Obiettivo secondario è la costruzione di infrastrutture e la fornitura di
servizi per rendere conveniente l'insediamento produttivo in tali aree. Posseggono
una visione dello sviluppo locale non limitata a quanto ruota attorno agli
insediamenti produttivi, giacché tendono ad occuparsi di tutto ciò che è in grado di
creare esternalità positive per le aziende e per il territorio. Nascono per iniziative
locali e non; sono poco frequenti i consorzi di sviluppo voluti da amministrazioni
comunali.
2. Unioni di comuni. Unificano la produzione di alcuni servizi al fine di raggiungere la
dimensione economica minima. Il numero di tali iniziative è stato frenato da una
norma, ora rimossa, che prevedeva che l'unione sfociasse in una fusione dei comuni
partecipanti.
3. Aziende di servizi pubblici. Fatta eccezione per lo smaltimento rifiuti, non sono molti
gli esempi da citare in fatto di forme associative di gestione.
4. Sportelli unici. Nel Veneto sono le Camere di Commercio che collaborano con le
associazioni di categoria per la realizzazione di tale servizio.
5. Enti Parco. Tipicamente producono beni pubblici ambientali, ma regolano anche
l'economia del parco con lo scopo di promuovere uno sviluppo sostenibile.
6. Patti Territoriali. In essi il carattere associativo è decisivo, poiché il loro scopo è
sostanzialmente quello di negoziare gli interventi per lo sviluppo locale. I vari attori
che vi partecipano si impegnano sia a realizzare un piano di investimenti sia ad
operare in modo tale da ridurre l'incertezza del processo di sviluppo; quest'ultimo
carattere deriva, ad esempio, dagli studi preliminari alla formulazione del piano.
7. Gruppi d'Azione Locale. Il loro operato si lega ai programmi comunitari Leader.
Com'è noto, si tratta di programmi finanziati dall'Unione Europea nelle aree ad
obiettivo 5b, che riguardano soprattutto lo sviluppo integrato di zone rurali. Per tale
finalità di base i GAL partecipano all'elaborazione dei piani di sviluppo locale.
64
BIBLIOGRAFIA
Akerlof G. (1997) - "Social distance and social decisions", Econometrica, 65, 1005-1027
Barro R. J. (1996) - "Democracy and growth", Journal of Economic Growth, 1, 1-27
Benabou R. (1996) – "Heterogeneity, stratification and growth: macroeconomic
implications of community structure and education finance", American Economic
Review, 86, 584-609
Bowels S. e Gintis H. (2002) - "Social capital and community governance", Economic
Journal, 112, 419-436
Buchanan J.M. (1990) - "The domain of constitutional economics", Constitutional Political
Economy, 1(1), 1-18
Carillo M.R. (2003) – "Interazioni sociali e capitale sociale nella teoria della crescita: una
rassegna critica della letteratura", Economia Impresa e Mercati Finanziari, 2, 27-47
Cole L., Mailath G. e Postlewaite A. (1996) - "Class system and the enforcement of social
norms", mimeo, University of Pennsylvania
Corneo G. e Jeanne O. (1997) - "On the relative wealth effects and the optimality of
growth", Economic Letters, 70, 37-51
Durlauf S. (2000) - "A framework for the study of individual behaviour and social
interactions", mimeo, University of Wisconsin
Durlauf S. N. (2002) - "Groups, social influences and inequality: a membership theory
perspective on poverty traps", mimeo, University of Wisconsin
Fershtman C., Murphy, K. e Weiss Y. (1996) - "Social status, education and growth",
Journal oJ Politica l Economy, 104, 108-132
Galor, O. e Tsiddon, D. (1997) - "Technological progress, mobility and economic growth",
American Economic Review, 87, 363-382
Glaeser, E. e Scheinkman, J. (2000) - "Non-market interactions", NBER working paper, n.
8053
Guiso L., Sapienza P. e Zingales L. (2000) - "The role of social capital in financial
development", NBER working paper, n. 7563
Hall R. E. e Jones, C. I. (1999) - "Why some countries produce so much more output per
worker than others ?", Quarterly Journal of Economics, February, 83-116
Hanifan L. J. (1922) - "The community centre", Silver, Burdett and co., Boston
Hassler J. e Rodriquez Mora J. (2000) - "Intelligence, social mobility and growth",
American Economic Review, 90, 888-908
Hayek von F.A. (1960) - "The constitution of liberty", Chicago University Press, Chicago
Hayek von F.A. (1973) - "Law, legislation and liberty", Routledge, London
Hirsh F. (1976) - "Social limits to growth", Harvard University Press, Cambridge MA
Kalai E. e Lehrer E. (1993) - "Rational learning leads to Nash equilibrium", Econometrica,
61, 1019-1045
Kasper W. e Streit M. (1998) - "Institutional economics. Social order and public policy",
Edward Elgar, Cheltenham, UK
Kirman A. (1999) - "Interactions and markets", in Gallegati M. e Kirman A. (ed.), "Beyond
the representative agent", Edward Elgar, Cheltenham, UK
Knack S. e Keefer P. (1997) - "Does social capital have an economic pay-off ?", Quarterly
65
Journal of Economics, 62, 1251-1273
Lucas R. E. (1988) - "On the mechanics of economic development", Journal of Monetary
Economics, 22, 3-42
Manski C. F. (2000) - "Economic analysis of social interactions", Journal of Economic
Perspectives, 14, 115-136
Merton R. (1968) - "Social theory and social structure", Free Press, Glencoe
North D. C. (1990) - "Institutions, institutional change and economic performance",
Cambridge University Press, Cambridge
Perotti R. (1996) - "Growth, income distribution and democracy: what the data say",
Journal of Economic Growth, 1, 149-187
Postlewaite A. (1998) - "Social status, norms and economic performance", European
Economic Review, 42, 779-800
Putnam R. (1993a) - "Making democracy work", Princeton University Press, Princeton, NJ
Putnam R. (1993b) - "The Prosperous community: social capital and public life", The
American Prospect, 13, 35-42
Romer P. M. (1986) - "Increasing returns and long-run growth", Journal of Political
Economy, 94, 1002-1037
Romer P. R. (1990) - "Endogenous technical change", Journal of Political Economy, 98,
71-102
Routledge B. R. e Von Amsberg J. (2003) - "Social capital and growth", Journal of
Monetary Economics, 50
Russo P.F. e Rossi P. (1999) - "Costo e disponibilità del credito per le imprese nei distretti
industriali", Banca d'Italia, Temi di Discussione n. 360
Smith A. (1776) - "The wealth of nations", ristampa (1937), Modern Library, New York
Solari S. (2002) – "Le istituzioni per lo sviluppo locale in forma associativa", LEP, Verona
Vanberg V. J. (1994) - "Rules and choices in economics, Routledge, London
Voigt S. (1999a) - "Explaining constitutional change. A positive economics approach",
Edward Elgar, Aldershot
Voigt S. (1999b) - "Breaking with the notion of social contract: constitutions as based on
spontaneously arise institutions", Constitutional Political Economy, 10, 283-300
Voigt S. (1999c) - "Improving welfare by seeking rents or: on the ambiguity of rent seeking
for explaining constitutional change", Jena discussion papers, 12/99
Voigt S. e Kiwit D. (1998) - "The role and evolution of beliefs, habits, moral norms, and
institutions", in Giersch H. (ed.), "Merits and limits of markets", Springer, , Berlin, 83-
108
Weiss J. e Fershtman C. (1998) - "Social status and economic performance: a survey",
European Economic Review, 42, 801-20
Woolcok K. (2000) - "The place of social capital in understanding social and economic
outcome", mimeo, The World Bank
Woolcok M. e Narayan D. (2000) - "Social capital: implications for development theory,
research and policy", The World Bank Research Observer, 15, 225-249
Zak P. L. e Knack S. (2001) "Trust and growth", The Economic Journal, 111, 295-321
66
V. METODOLOGIE QUALI-QUANTITATIVE PER
L'INDIVIDUAZIONE-DELIMITAZIONE DEI
DISTRETTI RURALI
V.1 Criteri logico-qualitativi
I distretti rurali potrebbero essere individuati sulla base di criteri non esclusivamente
quantitativi. Utilizzando anche criteri qualitativi, potrebbero così essere considerati tali i
sistemi locali nei cui territori si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
1. si realizzano uno o più prodotti specifici, anche tipici o di qualità16
,
merceologicamente affini, con una dimensione rilevante su scala regionale17
;
2. esistono filiere, o perlomeno forme di integrazione tra imprese (produzione,
trasformazione, commercializzazione);
3. parte della domanda di assistenza organizzativa e tecnologica è soddisfatta da
operatori locali18
.
Per quanto riguarda il criterio del punto 2, va specificato quanto segue:
- per filiera s'intende una concatenazione di imprese delle fasi di produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione collegate da relazioni di
mercato;
- riguardo alle forme di integrazione si deve far riferimento a decisioni prese da più
imprese in forma coordinata (non si deve necessariamente giungere a veri e propri
patti cooperativi, ma sono sufficienti accordi interprofessionali o semplici contratti
privati); una forma più stringente di integrazione è quella verticale, che esiste
laddove un unico soggetto economico controlla giuridicamente (con atto di proprietà)
le varie fasi del ciclo produttivo-distributivo, o buona parte di esse.
16
Il termini "anche" sta a significare che la non tipicità o non elevata qualità non pregiudicano il
riconoscimento del distretto rurale. 17
La rilevanza può essere quantitativa in senso stretto (unità di misura non monetaria) o economica. 18
Si può discutere quanto debba la parte soddisfatta in tal modo, ma certamente non deve essere
minoritaria.
67
V.2 Criteri quantitativi
V.2.1 La fonte informativa
La fonte informativa quantitativamente più vasta e affidabile è certamente il
Censimento dell'Agricoltura.
Anche tale fonte, però, presenza alcuni punti deboli. Il principale è proprio di tipo
localizzativo. L’unità di rilevazione censuaria, cioè l’azienda agricola, viene
geograficamente assegnata al comune in cui si trovano, letteralmente, "l'insieme dei
fabbricati situati nell’azienda agricola e connessi all’attività dell’azienda stessa". Poiché
non è raro che tra questi prevalgano le abitazioni del conduttore e della manodopera,
accade che aziende con terreni e/o bestiame in più comuni siano localizzate in un
comune dove non necessariamente si svolge prevalentemente l'attività aziendale. È
chiaro che tale imprecisione è modesta a livello provinciale ma evidente a livello
comunale.
In ogni caso, nonostante questo, le localizzazioni desunte dal Censimento sono
certamente utili, poiché da esse si può individuare il quadro territoriale delle
specializzazioni produttive, come pure riconoscere ambiti locali interessati da particolari
problemi.
V.2.2 Le unità di analisi
Probabilmente è opportuno sviluppare l'analisi ad un livello che non corrisponda al
Comune, alla Provincia e alla Regione, ma che sia intermedio a queste realtà
amministrative. Tale livello va stabilito a seconda dei casi, orientandosi
prevalentemente in base ai caratteri della produzione e alle variabili socio-economiche.
Potrebbe essere opportuno zonizzare il territorio regionale riprendendo la logica,
datata ma in questo caso opportuna, adottata dall'Istat alla fine degli anni '50 quando
definì le regioni agrarie. Queste erano aggregazioni di comuni contermini, che
condividevano il livello altimetrico e gli orientamenti produttivi, anche solo potenziali.
Tale metodo, ovviamente, richiede alcuni aggiornamenti. Infatti, nella sua versione
originaria tenderebbe a generare aree piuttosto stabili nel tempo. Oggigiorno, però, i
68
confini di tali aree non dovrebbero risultare praticamente immutabili: si pensi, ad
esempio, alla logica della Regione Veneto che introduce Patti di Sviluppo Locale
prescindendo dalla contiguità geografica dei soggetti partecipanti. Inoltre alcuni fattori
rendono i confini territoriali sostanzialmente labili, qualora determinati strettamente con
il metodo ISTAT prima richiamato: in aree morfologicamente uniformi, diffusione di
colture non permanenti, struttura idrografica non costante nel medio-lungo periodo.
Alla luce di quanto appena osservato, è evidente che gli ambiti territoriali che così si
otterrebbero non sono automaticamente distretti rurali, ma sistemi agrari territoriali
dotati e non di specificità agricole. Nonostante questo tali zone sarebbero però utili per
la successiva individuazione dei veri e propri distretti rurali, pur essendo possibile che
alcuni di essi possano poi effettivamente rivelarsi trasversali alle zone suddette.
V.2.3 La procedura
L'applicazione dei criteri logico-qualitativi, precedentemente discussi, ai suddetti
ambiti territoriali dovrebbe condurre alle tipologie dei distretti rurali e ad una loro
zonizzazione perlomeno approssimata.
Dopodiché, nel caso in cui i confini distrettuali non sia precisamente definiti, in
presenza di aree potenzialmente distrettuali ma non contigue, e per l'individuazione
delle filiere produttive (e dei segmenti di filiera), è opportuno tarare la pre-mappatura
distrettuale ricorrendo ai seguenti criteri quantitativi, ovviamente declinati per ciascuna
delle tipologie qualitative individuate:
1. indicatori puramente territoriali;
2. indicatori demografici e del mercato del lavoro;
3. indicatori della struttura dimensionale delle aziende;
4. indicatori dei sistemi di conduzione;
5. indicatori di specializzazione produttiva.
69
V.2.3.1 Indicatori puramente territoriali
Una prima caratterizzazione dei potenziali distretti può essere impostata sulla base di
tre indicatori che sottendono una relazione diretta o indiretta tra azienda agricola e
territorio:
1. la densità di popolazione residente, che segnala il grado di urbanizzazione (abitanti
per kmq);
2. la densità territoriale delle aziende agricole, che segnala l'intensità territoriale delle
attività primarie (aziende agricole per kmq);
3. SAU media per azienda, che approssima la struttura dimensionale delle aziende
agricole (ettari per azienda).
V.2.3.2 Indicatori demografici e del mercato del lavoro
Tali indicatori rivestono un grande significato nell'accezione rurale del distretto. A
tal fine sono infatti rilevanti aspetti quali l'età media degli imprenditori, il peso del
lavoro attinto all'interno della famiglia conduttrice, caratteristiche specifiche del
mercato del lavoro (stabilità dell'occupazione, peso sul complessivo mercato del lavoro
locale).
Gli indicatori idonei sono:
1. quota di giornate di lavoro prestate dalla manodopera extrafamiliare;
2. quota di imprenditori con meno di un certo numero di anni (da stabilire);
3. grado di femminilità imprenditoriale;
4. quota di manodopera familiare con più di 180 giornate di lavoro annue;
5. rapporto tra gli occupati in agricoltura e quelli dell’industria e di altri settori non
agricoli.
70
V.2.3.3 Indicatori della struttura dimensionale delle aziende
Va sviluppata l'informazione di prima approssimazione fornita dal terzo indicatore
puramente territoriale. I temi da enucleare sono, ad esempio, la frammentazione della
SAU, la presenza di aziende (territorialmente) marginali, ecc.
Ciò si può determinare con i seguenti indicatori:
1. quota di territorio occupata dalla superficie totale delle aziende;
2. quota di territorio occupata dalla SAU;
3. quota di SAU tenuta da aziende con meno di X ettari di SAU;
4. quota di SAU tenuta da aziende con più di Y ettari di SAU, con Y molto maggiore di
X (esempio, un rapporto da 1 a 25)
V.2.3.4 Indicatori dei sistemi di conduzione
Vanno evidenziati i livelli di complessità e di forma giuridica con cui viene gestita la
SAU. Gli indicatori utili sono:
1. quota di SAU di aziende che riavvalgono di salariati;
2. quota di SAU in affitto;
3. quota si SAU gestita con altre forme contrattuali.
V.2.3.5 Indicatori di specializzazione produttiva
Il tema della specializzazione è piuttosto rilevante, poiché si interseca con la
definizione di distretto. Gli indicatori devono distinguere tra colture e allevamenti. Per
le prime si devono mettere in luce le vocazioni alle concentrazioni, per i secondi occorre
discriminare tra tre categorie: autoconsumo, commercio, industria alimentare.
Il processo per definire le specializzazioni, sulla base delle categorie appena
descritte, richiede la determinazione dapprima di:
1. nel caso di coltivazioni, della superficie investita sul totale della SAU;
71
2. nel caso di allevamenti, del numero di capi sul totale degli stessi per tutte le
tipologie.
Successivamente queste percentuali vanno poi messe a confronto l'analogo indicatore
calcolato sulla macro area di riferimento (uno specifico ambito territoriale, la Provincia,
la Regione), andando poi a evidenziare le sub-aree dotate del massimo scarto positivo
(in punti percentuali).
La classificazione che così si otterrebbe può ritenersi indicativa delle specializzazioni
locali, nel senso che si tenderebbe ad esaltare le concentrazioni anomale delle diverse
categorie, a prescindere dalla loro incidenza in termini assoluti.
Dal punto di vista statistico, si consiglia di integrare tali indicatori con i seguenti:
1. indice di Champernowne19
delle principali colture;
2. quota di SAU investita per produzioni con riconoscimento comunitario (doc, ecc.);
3. quota di aziende che praticano produzioni biologiche;
4. quota di allevamenti con ricoveri dotati di un certo numero (da stabilire) di impianti
tecnici20
.
19
Complemento all’unità del rapporto fra le medie geometrica (g) e aritmetica (a): C = 1 – g/a. L’indice
registra la massima concentrazione quando assume valore 1. 20
Impianti per alimentazione automatizzata, abbeveraggio automatizzato, sgombero letame e rimozione
rifiuti, depurazione dei liquami o mungitura meccanica.
72
VI. TIPOLOGIE DI DISTRETTO RURALE
L'evoluzione delle attività rurali per distretti non è soltanto un fenomeno spontaneo,
direttamente guidato dalla "mano invisibile" del mercato, ma si può presumere che,
invece, sia indotto anche dalle politiche comunitarie e internazionali che nel decennio
scorso hanno interessato il mondo agricolo. Com'è noto, infatti, il futuro delle attività
agricole risente fortemente delle passate versioni della PAC, come pure degli accordi
GATT-WTO. Più recentemente, dopo l'impatto di Agenda 2000 si deve registrare anche
quello della cosiddetta Mid-Term Review, la proposta di una ulteriore revisione a medio
termine della PAC formulata nel luglio 2002. Le nuove proposte della Commissione
riguardano anche lo sviluppo rurale21
.
VI.1 Le politiche comunitarie come origine di scenari distrettuali
Con il "senno di poi" difficilmente si può smentire la tesi secondo la quale il
problema originario siano state le eccedenze produttive, a loro volta un sottoprodotto
del sostegno dei prezzi. Da un lato le eccedenze, dall'altro la progressiva contrazione
della domanda (sia a causa dei consumi alimentari interni sia della domanda estera) ha
in più riprese messo in crisi molti settori agricoli, ma soprattutto quelli dei prodotti
lattiero-caseari, dei cereali, delle carni bovine e suine.
In relazione a questo, numerose furono le critiche rivolte alle prime versioni della
PAC, poiché le misure correttive intraprese (quote di produzione, set-aside,
prepensionamento, ecc.) non sortirono completamente gli effetti sperati a priori.
Com'è noto si passò così ad una revisione più profonda, se non ad una vera e propria
riforma, proposta dal commissario Mac Sharry: l'idea centrale fu quella di sostituire
gran parte del sostegno del prezzo con aiuti al reddito, decrescenti rispetto all'ampiezza
aziendale ed in parte condizionati alla messa a riposo temporanea di parte della
superficie coltivabile. Gli scopi della riforma erano sinteticamente i seguenti:
1. ridurre progressivamente i prezzi per allinearli a quelli del mercato mondiale;
21
Le altre sono misure di mercato, il disaccoppiamento degli aiuti diretti, la cross-compliance, l’audit
aziendale, la modulazione dinamica.
73
2. introdurre misure di sostegno non più legate alle quantità prodotte ma basate sulla
dimensione dell'azienda agricola e sulla media produttiva dell'area;
3. per le aziende agricole di grandi dimensioni, subordinare il pagamento delle misure
di sostegno al set-aside, che poteva essere destinato per coltivazioni industriali,
incoraggiando così la produzione di materie prime non alimentari;
4. migliorare le condizioni per il prepensionamento degli agricoltori;
5. aiutare gli agricoltori più poveri con integrazioni di reddito dirette.
Come si può intuire, tale revisione delle politiche agricole (anni '90), che aveva la
teorica finalità di incrementare la competitività e l'efficienza dei vari comparti, non fu
altro che un puro e repentino "ritorno al mercato", sancito dagli accordi GATT di quel
periodo. In questo si poteva intravedere un tentativo, nemmeno velato, di attivare
esogenamente la "mano invisibile" del mercato, che per la verità fino a quel momento
non aveva operato pienamente.
Si può discutere a lungo se ciò sia stata una virata desiderabile e condivisibile, è
certo però che il ritorno al mercato non poteva che creare pressione sull'efficienza
aziendale con la conseguente ricerca di economie di costo, di vantaggi localizzativi,
ecc., cioè quanto si può ritrovare in ambito distrettuale. In ultima analisi, in una
prospettiva di lungo periodo si poteva, e si doveva, prevedere un peggioramento degli
squilibri tra zona e zona, a causa della continua ricerca di economie di scala, che ha
portato, porta e porterà verosimilmente ad una diversa distribuzione territoriale delle
produzioni.
Un ulteriore cambio di direzione delle politiche comunitarie è successivamente
registrabile con Agenda 2000 e, più recentemente, con la Mid-Term Review della PAC
(luglio 2002). Queste due fasi delle politiche comunitarie confermano, tra le altre cose,
il passaggio dal concetto di sviluppo agricolo a quello di sviluppo rurale. In particolare,
le nuove proposte sullo sviluppo rurale tentano di sostanziare i fondi disponibili con
nuove misure, mettendo nel contempo ordine in una parte della PAC che poteva
apparire perlomeno disordinata. Si tratta delle misure di accompagnamento, il cui
ventaglio è stato allargato22
aggiungendo tre nuove linee di azione:
22
Si ricorda che le originarie misure di accompagnamento riguardano i seguenti quattro capitoli: misure
agroambientali, forestazione, aree svantaggiate e pre-pensionamento.
74
1. Qualità
l'obiettivo è concretizzare la promozione della qualità, che da più parte è indicata
come punto debole della PAC. La proposta si articola in:
- promozione della partecipazione degli agricoltori a programmi di certificazione
e di garanzia della qualità23
;
- sostegno alle associazioni di produttori, per attività promozionali di determinati
prodotti agricoli designati nell’ambito di determinati regimi di certificazione.
2. Rispetto delle norme
l'obiettivo è spingere gli operatori agricoli ad adeguarsi alle norme più rigorose
del nuovo regime di cross-compliance, attivando due tipi di aiuto:
- uno temporaneo e decrescente, per compensare dei maggiori costi associati
all’adeguamento alle nuove norme;
- uno forfetario, per contribuire ai costi di avvio dell’audit aziendale.
3. Salute e benessere degli animali
Si concedono aiuti ai produttori disposti ad assumere impegni in materia di
benessere degli animali che vadano oltre i requisiti obbligatori previsti dalla cross-
compliance.
Più in generale, al di là di queste nuove specifiche linee d'azione, è possibile dare una
valutazione globale di tale nuova impostazione (Agenda 2000 e Mid-Term Review della
PAC) considerando i seguenti aspetti:
1. il potenziamento del ruolo dello sviluppo rurale all’interno delle politiche
comunitarie;
2. la semplificazione degli interventi;
3. il rafforzamento della sussidiarietà e del decentramento.
Riguardo al primo aspetto, al di là delle considerazioni strategico-politiche e
limitando l'attenzione alla sola dimensione finanziaria, il risultato finale di questa nuova
impostazione potrebbe non rivelarsi così positivo come atteso a priori; tale giudizio vale
23
Si propone l’erogazione di un aiuto forfetario per azienda, per un periodo massimo di cinque anni.
75
nella misura in cui la politica di mercato continuerà a prevalere sulle altre politiche. Il
peso delle risorse finanziarie a favore dello sviluppo rurale sarà deciso su due fronti: la
contrapposizione tra settore agricolo e gli altri settori, l’efficienza della spesa.
Sul secondo aspetto occorre rilevare i riflessi positivi della riduzione degli obiettivi,
del numero di programmi e delle procedure finanziarie, ecc.. Lo sviluppo rurale, però,
necessita non solo della riduzione della quantità di norme, ma anche di norme chiare e
facilmente interpretabili. Inoltre il processo di semplificazione deve essere tale da non
alterare il sistema organizzativo e procedurale pre-esistente. Tali problemi rendono
opportuna la concertazione tra Commissione, Stato e Regioni.
Il terzo aspetto si potrebbe risolvere, per quanto riguarda il nostro Paese, in un
maggior spazio d'azione delle Regioni. Senza dubbio ciò rappresenta un elemento
positivo per le politiche locali di sviluppo rurale, ma allo stesso tempo impone uno
sforzo di coordinamento tra amministrazioni centrali e regionali.
VI.2 Aree territorialmente omogenee di tipo rurale
Senza voler qui riproporre una definizione di distretto, peraltro in evoluzione, tant'è
che anche i distretti industriali stanno subendo una apertura che li tende a far diventare
più virtuali che territoriali, è opportuno utilizzare il concetto di distretto soprattutto in
chiave progettuale, ovvero come strumento di valorizzazione di un territorio.
Infatti, se in territori rurali possono essere facilmente individuabili distretti produttivi
di tipo agricolo, per specializzazione o qualità delle produzioni, o per capacità di
integrazione tra più settori (agro-industria, integrazione di filiera, ecc.), in molti altri
territori caratterizzati da ruralità la natura distrettuale non può essere riconducibile al
solo aspetto produttivo. In queste aree diventa obiettivo prioritario valorizzare le
suscettività tipiche dell'ambiente rurale su cui agire con logica progettuale, a carattere
multisettoriale, per valorizzare al massimo le potenzialità del territorio.
Questo è il caso che potremmo definire distretto-progetto, in cui gli strumenti classici
della politica economica territoriale (agricola, industriale, terziaria) si intersecano
profondamente con le preesistenze socio-ambientali e culturali, definibili come "capitale
sociale". Chiaramente l'azione progettuale, indispensabile affinché il territorio
acquisisca la connotazione di distretto, deve essere accompagnata e seguita da un'azione
76
di governance territoriale, in cui istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria
e portatori di interessi trovino gli opportuni strumenti di concertazione, al fine di
definire obiettivi, strumenti e vincoli del progetto.
Molto spesso si assiste nella realtà a sovrapposizioni di momenti di concertazione
finalizzata allo sviluppo locale (Patti Territoriali, Gruppi ai Azione Locale, ecc.), che
spesso animati da visioni settoriali rendono estremamente complessa la gestione unitaria
del processo di sviluppo territoriale. Nel mentre si è convinti che il livello di densità
istituzionale costituisce una ricchezza, come strumento di valorizzazione del territorio,
quello che qui si vuole sottolineare è l'esigenza di un maggior coordinamento tra queste
forme di gestione della sussidiarietà sia orizzontale che verticale.
Il distretto rurale dovrà pertanto connotarsi per il riconoscimento dei valori più
profondi della vita rurale, come elemento fondante di qualità della vita, di tutela
dell'ambiente, di tutela della persona nelle sue caratteristiche relazionali. Tutto ciò,
ovviamente, andrà compenetrato con la capacità di creare valore aggiunto utilizzando al
meglio i vantaggi competitivi dell'area.
Il distretto-progetto potrebbe quindi configurarsi come un'operazione anche di
marketing territoriale, volta a conferire competitività e attrattività a un territorio, ma
soprattutto inteso a metterlo in rete per usufruire delle potenzialità che l'attuale
"economia della conoscenza" può ormai diffondere anche su aree un tempo definite
marginali.
Le tipologie di distretto che maggiormente si attagliano all'obiettivo di valorizzare
un'area rurale sono quelle legate al carattere agricolo-turistico-ambientale che
generalmente connotano un'area rurale. Ciò non esclude che in aree rurali possano
insediarsi anche attività di alto profilo tecnologico e di ricerca, che proprio per la qualità
della vita che queste aree offrono trovano un habitat favorevole. Si pensi ad esempio
alle attività di ricerca in campo delle bioteconologie, esistenti in certe aree statunitensi,
danesi e olandesi, o a quelle reti di centri rurali che in Francia formano un sistema
"agropolitano". Nel contesto delle aree rurali venete sembrano tuttavia essere suscettivi
di implementazione quei territori rurali aventi potenzialità produttive in campo agricolo-
turitisco-ambientale, che potrebbero da luogo a distretti secondo le seguenti tipologie.
77
VI.2.1 Distretti rurali-produttivi di qualità
Si caratterizzeranno, com'è ovvio, dal valore intrinseco dei prodotti agricoli, dalla
loro freschezza e tipicità, dalla loro esclusività e non sostituibilità. Nel Veneto
potrebbero essere formalizzate aree distrettuali di questo scenario, ad esempio, per
alcuni prodotti vinicoli e del settore lattiero-caseario, ma anche per produzioni che, pur
se per il momento hanno uno scarso peso sulla PLV, sono caratterizzate dall'assenza di
esternalità negative e possono garantire positivi sviluppi sia per il possibile connubio
con l'agriturismo sia per la crescente domanda di prodotti naturali, domanda disposta a
pagare prezzi remunerativi.
Questo scenario distrettuale coinvolge produzioni la cui quota di mercato può
aumentare solo con accorte politiche di certificazione degli standard. Infatti si rivelerà
estremamente pericoloso credere che questi tipi di produzione si "autoproteggano" con
la fama già acquisita, anche se tradizionalmente riconosciuta dai consumatori. In futuro,
in questa tipologia distrettuale si potrà affrontare la concorrenza se si passerà dal
limitato concetto di qualità intesa come caratteristiche igienico-sanitarie a quello più
vasto di qualità caratterizzata dal ricorso a tecniche collaudate e dalla produzione in
uno specifico ambiente.
VI.2.2 Distretti rurali-produttivi intensivi
Teoricamente potrebbero interessare le zone dove sono concentrate le produzioni
erbacee e la gran parte dei capi degli allevamenti. Più che sugli standard qualitativi, la
competitività futura di tali distretti è strettamente legata al grado di elasticità della
produzione ed a quello di integrazione con i settori della trasformazione e della rete
distributiva. All'interno di questo modello distrettuale si devono ovviamente operare le
opportune distinzioni fra colture e prodotti zootecnici, non tanto per la diversa natura
produttiva quanto per la diversa dinamica dei costi e del valore aggiunto.
Dal punto di vista del valore aggiunto, il futuro dei distretti intensivi basati sulle
colture dipende strettamente da una maggiore integrazione con le attività di
trasformazione e di distribuzione, attraverso formule di accordo che garantiscano gli
sbocchi produttivi. La crescente globalizzazione dei mercati, però, tende a "distrarre
78
l'attenzione" dalle opportunità di integrazione a livello locale; per superare questo
ulteriore ostacolo la risposta è sempre la solita: ricorrere alla cooperazione, che in
ambito distrettuale, però, richiede necessariamente l'incremento delle capacità
imprenditoriali e manageriali. Qualche problema nella dinamica del valori aggiunto per
i prodotti zootecnici può essere risolto se il modello distrettuale abbinerà ai caratteri
intensivi anche quelli della qualità.
VI.2.3 Distretti rurali-turistico ambientali
La particolarità di questa forma distrettuale è che consente l'integrazione fra diverse
attività economiche, e di conseguenza genera effetti reddituali indiretti anche a favore di
operatori del settore primario economicamente marginale.
Vale infatti la pena di sottolineare che questa tipologia distrettuale teoricamente
fornisce una possibilità aggiuntiva per la sopravvivenza e lo sviluppo di piccole aziende
agricole, in quanto consente:
di consentire un'integrazione dei loro redditi, soprattutto nelle zone svantaggiate;
di valorizzare e conservare la cultura rurale;
di collegare direttamente i produttori con i consumatori.
Questo tipologia distrettuale ha anche una valenza ambientale. In tali tipologie
distrettuale, infatti, gli operatori rurali potrebbero opportunamente essere coinvolti con
iniziative ambientali che si integrino con le attività turistiche (queste iniziative
potrebbero essere, ad esempio, la pulitura dei boschi, il mantenimento di siepi, la
realizzazione di sentieri interpoderali, la predisposizione di punti di alimentazione per
animali non domestici, il mantenimento delle piante arboree tipiche, la conservazione
dei fabbricati rurali, ecc.). In questa particolare connotazione, i distretti rurali-turistico
ambientali potrebbero investire parti non irrilevanti del territorio regionale, soprattutto
in zone montane: aree boschive e pascoli, ma anche parte di alcune superfici coltivate.
Si tratta di aree che, più delle altre, vedranno così accrescere la loro vocazione di
produzione di servizi ambientali.
79
L'intervento pubblico è utile per neutralizzare diseconomie che un operatore privato
non è in grado di superare. I problemi che si potrebbero verificare sono innanzitutto il
rischio che questa attività soppianti quella agricola quando invece dovrebbe integrarla,
costituendone un'occasione di diversificazione produttiva; in secondo luogo,
l'instaurarsi di un tessuto produttivo slegato dal contesto locale.
VI.3 Gli obiettivi dell'individuazione-delimitazione dei distretti
rurali
L'individuazione-delimitazione dei distretti rurali è la fase operativa di un più vasto
percorso di riconoscimento giuridico di tali entità territoriali. Ma quali sono i motivi per
cui è opportuno un riconoscimento legale? È evidente che a questa domanda si potrebbe
rispondere in molti modi, ma in questa sede le risposte più rilevanti sono due:
1. il riconoscimento legislativo offre visibilità;
2. il riconoscimento legislativo è la premessa a successive fasi di pianificazione
istituzionale.
È giusto però porre qualche attenzione all'incedere di questo processo legislativo. Il
policy-maker, infatti, deve sempre valutare i seguenti aspetti:
1. Il riconoscimento istituzionale di un distretto agricolo-rurale deve avere un possibile
risultato in termini di sviluppo delle attività agricole e della ruralità.
2. Il distretto agricolo-rurale non esiste perché lo dice una legge, ma perché in uno
specifico territorio sono riscontrabili (ante-legge) sistemi socio-produttivi che si
fondano su un know-how rurale comune e diffuso, e che si evolvono in base a
strategie condivise dagli operatori.
3. Sono sempre possibili i fenomeni del moral hazard e dell'adverse selection. Gli
operatori socio-economici di un qualsiasi distretto (cioè indifferentemente dalla sua
tipologia) possono "adagiarsi" contando sul sostegno pubblico, senza la necessaria
razionalità nel decidere la fattibilità dei progetti e l'uso ottimale delle risorse (moral
hazard). Diretta conseguenza a questo comportamento non efficiente è l'errore del
80
policy maker nel selezionare i soggetti meritevoli di attenzione e sostegno (adverse
seletcion)24
.
Detto questo, il riconoscimento legislativo dei distretti apre la strada, come prima
rilevato, alla pianificazione pubblica. Le ipotetiche politiche di intervento per un
distretto rurale potrebbero mirare a:
a) valorizzare (ovviamente) i prodotti che contraddistinguono il distretto;
b) sostenere la proiezione delle imprese agricole sui mercati nazionali ed internazionali,
soprattutto favorendo filiere e forme di integrazione (verticale, orizzontale,
diagonale);
c) sostenere il reddito degli imprenditori;
d) sostenere la qualità delle produzioni;
e) favorire l'efficienza del complessivo sistema territoriale;
f) incentivare l'occupazione;
g) promuovere prodotti e metodologie produttive sostenibili;
h) promuovere accordi e contratti finalizzati a strategie distrettuali comuni.
Lo strumento principale per il perseguimento di questi obiettivi sembra essere il
Patto di Sviluppo Locale, che operativamente dovrebbe consentirne il raggiungimento
occupandosi principalmente, anche se (ovviamente) non esclusivamente, dei seguenti
temi:
a) aspetti strutturali delle varie fasi della filiera (produzione, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione);
b) diffusione dei servizi di sviluppo e delle forme di aggregazione fra imprese;
c) qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
d) ammissibilità dei progetti verso finanziamenti pubblici (regionali, nazionali,
comunitari).
24
La soluzione sembra essere quella, per altro diffusamente adottata da svariate pubbliche
amministrazioni di richiedere l'assunzione di rischio, cioè la compartecipazione dell'operatore a qualsiasi
iniziativa di incentivazione e sostegno
81
Tra i temi suddetti, l'ultimo (punto d) assume un ruolo centrale poiché, in un modo o
nell'altro, direttamente e/o indirettamente, sintetizza tutti gli altri. La progettualità cui si
riferisce dovrebbe riguardare le seguenti tipologie di intervento:
a) attività formative (seminari, stage, ecc.) finalizzate allo sviluppo di nuovi
imprenditori;
b) sostegno a eventuali ristrutturazioni aziendali mediante interventi (anche formativi)
di riconversione degli addetti;
c) attivazione di sportelli informativi sui temi distrettuali (lo stesso tipo di strumento già
attivato dalle CCIAA, anche se su temi diversi da quelli qui discussi);
d) incentivazione alla ricerca e sviluppo tecnologico (di processo, di prodotto e di
organizzazione gestionale);
e) diffusione della logica del total quality management;
f) razionalizzazione della fase di commercializzazione e aumento della capacità di
penetrazione dei mercati;
g) assistenza legale, non solo per i contratti commerciali ma anche per le fasi di
aggregazione dell'offerta (partnership, fusioni, consorzi, ecc.);
h) attivazione e sostegno delle forme di supply chain management distrettuale (reti
logistiche fisiche e telematiche);
i) prestazione di servizi finanziari evoluti (finanza innovativa, sviluppo dei confidi,
ecc.);
j) progettazione di metodologie produttive sostenibili.
Gli attori di tale progettualità dovrebbero essere:
a) istituzioni pubbliche ed enti locali;
b) operatori dei vari settori economici, e loro organismi di rappresentanza;
c) banche e istituzioni creditizie
d) consorzi o società consortili costituiti anche in forma cooperativa tra PMI agricole,
industriali-artigiane, commerciali-turistiche;
e) consorzi interprofessionali;
f) le Società consortili a capitale misto pubblico privato;
![Page 1: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/68.jpg)
![Page 69: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/77.jpg)
![Page 78: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/78.jpg)
![Page 79: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/79.jpg)
![Page 80: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/80.jpg)
![Page 81: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/81.jpg)
![Page 82: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/83.jpg)
![Page 84: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: I distretti rurali: una proposta di analisi [The rural districts: a proposed analysis]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051112/633e30a1858bd41dda062256/html5/thumbnails/85.jpg)