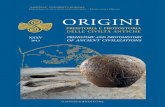Gli studi sulla civiltà spettacolare dell’antica Capua nel XIX secolo, in La tradizione classica...
Transcript of Gli studi sulla civiltà spettacolare dell’antica Capua nel XIX secolo, in La tradizione classica...
FILOLOGIA E TRADIZIONE CLASSICA Collana diretta da Salvatore Cerasuolo
1
LA TRADIZIONE CLASSICA E L’UNITÀ D’ITALIA
Atti del Seminario Napoli - Santa Maria Capua Vetere 2-4 ottobre 2013
II
a cura di
Salvatore Cerasuolo, Maria Luisa Chirico, Serena Cannavale, Cristina Pepe, Natale Rampazzo
SATURA EDITRICE
Opera pubblicata con il finanziamento del PRIN 2009
intitolato “L’Unità d’Italia e la cultura classica” e con il contributo del Dipartimento di Lettere e Beni culturali
della Seconda Università di Napoli
I contributi sono stati sottoposti, in forma anonima, a peer-review ed accettati
dal Comitato Scientifico della Collana
DIRITTI DI AUTORE RISERVATI Copyright 2014 Satura Editrice s.r.l. via G. Gigante, 204 - 80128 Napoli tel. 081 5788625 - fax 081 5783097 sito web: www.saturaeditrice.it e-mail: [email protected] ISBN 978-88-7607-145-4 In copertina: Il corpo dello Stato. Affresco di Giulio Aristide Sartorio (Roma, Camera dei deputati. Pa-lazzo Montecitorio).
In quarta di copertina: Natura morta con cesto di frutta. Dipinto di Johannes Bosschaert.
SERENA CANNAVALE Gli studi sulla civiltà spettacolare dell’antica Capua nel XIX secolo
Nel corso del XIX secolo, con il progressivo trasformarsi del casale di S. Maria in una città moderna, dotata di ferrovia, illuminazione, ser-vizi idraulici, interessata da interventi di riqualificazione urbana, il tes-suto connettivo della città antica lentamente sbiadisce, obliterato dal nuovo: è in questo momento, come ha scritto Carlo Rescigno, che «le strutture dell’antico si trasformano fisicamente in ruderi, definiti cultu-ralmente monumenti»1. Al graduale smarrimento del senso di connes-sione topografica tra i monumenti, determinato dal sovrapporsi delle strutture moderne, si contrappone una spinta a ricercare e studiare le vestigia del passato, di cui si avverte sempre più la necessità in quanto exempla di un’identità storica che si va perdendo. Si registra allora, nel-la prima metà dell’Ottocento, una costante crescita d’attenzione, tanto sul versante della letteratura antiquaria che della ricerca archeologica, verso i monumenti dell’antica Capua2. D’altra parte, in tale interesse si può leggere anche una finalità eminentemente politica, di recupero del-le antichità come simboli di prestigio e veicolo di celebrazione della di-nastia regnante3. Il fenomeno si può osservare compiutamente sceglien-do, come punto d’osservazione privilegiato, i due principali edifici per spettacolo della città romana: l’anfiteatro e il teatro.
È noto che nel corso dei secoli, dal Medioevo in poi, il più maestoso dei monumenti di Capua, l’anfiteatro, aveva svolto il ruolo di cava di pie-tre e di reperti scultorei, fino a quando l’editto municipale del 6 mag-
*#Ringrazio il prof. Cerasuolo e la prof. Chirico per avermi invitato ad esporre in occa-sione del Seminario i risultati di un’indagine maturata nell’ambito di un progetto di ricerca, promosso dal Dipartimento di Lettere e Beni culturali della Seconda Università di Napoli, finalizzato allo studio della civiltà teatrale della Campania antica.
1#C. RESCIGNO, Dalla pianta del Costa al Museo Provinciale Campano, in RESCIGNO -
SAMPAOLO 2009, pp. 18-33, in part. 24. Per le trasformazioni urbane di S. Maria C. V. nel XIX secolo, cf. S. CASIELLO - A.M. DI STEFANO, Santa Maria Capua Vetere, Napoli 1980, pp. 98-116.
2#Cf. CAMMAROTA 2000. Per una sintesi degli scavi a Capua nel XIX secolo, cf. L. BU-
RELLI - M. BONGHI JOVINO, Capua, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Occidente e nelle isole tirreniche, dir. da G. NENCI - G. VALLET IV, Pisa-Roma 1985, s.v.
3#Questi aspetti sono illuminati in FRIELLO 2008-2011.
SERENA CANNAVALE
382
gio 1514 non era intervenuto ad evitarne la totale distruzione, vietando l’estrazione di materiale di costruzione dal sito4. Il problema, mai defi-nitivamente risolto, come dimostra il dispaccio emanato da Carlo di Borbone nel 1751 per vietare l’uso, nel cantiere della Reggia di Caserta, di materiali provenienti dall’anfiteatro 5 , emerge con forza in alcuni scritti di letterati e filologi tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX seco-lo. Una lettera di Giovanni Cassitto su un viaggio a Capua del 1791 sot-tolinea «lo strazio crudele del magnifico e superbo edificio», destinato, secondo lo scrittore, ad «imminente ruina»6. Sedici anni più tardi, i dan-ni arrecati al monumento ai fini dell’estrazione del salnitro, di cui siamo informati dalla documentazione d’archivio7, furono denunziati dal lette-rato e archeologo Francesco Daniele (1740-1812)8, che, in una lettera indirizzata all’Intendente della Provincia di Terra di Lavoro9 del 9 feb-braio 1807, rilevava il preoccupante stato di conservazione del monu-mento, definito «poco men che distrutto»10.
4#Cf. I. DI RESTA, Il ruolo dell’anfiteatro campano nel Medioevo, «Archivio storico di
Terra di Lavoro» IX (1984-1985), p. 106; FRIELLO 2008-2011, p. 181 s. Sullo stato di de-grado del monumento, probabilmente riconducibile ad una deliberata volontà di demoli-zione, cf. MAIURI 1937b, p. 174 ss.; F. CAIROLI GIULIANI, Alcune osservazioni in margine al- l’anfiteatro campano, in Beni culturali in Terra di Lavoro. Prospettive di ricerca e metodi di valorizzazione. Atti del Convegno (Santa Maria Capua Vetere, 9-10 dicembre 1998), Santa Maria Capua Vetere 1998, pp. 33-40.
5#Cf. Archivio storico Reggia di Caserta, Dispacci e relazioni, 1545, 67. Il documento
è citato da FRIELLO 2008-2011, p. 182 e da CECERE - RENDA 2012, p. 96, nn. 65-66. 6
#Cf. Lettera del Dottor Giovanni Cassitto al dottissimo Sig. Ab. D. Michele Arcangelo Lupoli su di un brevissimo viaggio per Capua, «Analisi ragionata», settembre 1793, pp. 65-79; su questa lettera vd. A.M. RAO, Tra erudizione e scienze: l’antiquaria a Napoli alla fine del Set-tecento, in L’incidenza dell’Antico. Studi in memoria di Ettore Lepore III, a cura di C. MON-TEPAONE, Napoli 1995, p. 132 s.
7#Archivio storico della Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta, VI D1, fasc.
5, citato da CAMMAROTA 2000, p. 174, n. 9. 8
#Su cui vd. C. CASSANI, Daniele, Francesco, in DBI 32 (1986), s.v.; A. TIRELLI, France-sco Daniele: un itinerario emblematico, in Cultura*, pp. 3-51.
9#Si trattava di Lelio Parisi (1756-1824), Intendente della Provincia di Terra di Lavoro
dal 13 agosto 1806 al dicembre del 1808, quando fu nominato giudice della Gran Corte di Cassazione.
10#Daniele scriveva: «[...] recatomi un giorno all’Anfiteatro, con la mia infinita meravi-
glia lo trovai poco men che distrutto affatto; e dimandando della cagion di tanta ruina nel corso di pochi anni, fummi risposto, che veniva ad arte demolito per opera di un certo Ma-rina, il quale ritraeva da quel materiale il Salnitro: e forte maravigliandomi io di tanta barba-rie, e dicendo perché non gli si impediva di ulteriormente far tanto male, mi si rispose, ch’egli era autorizzato a far ciò dal Ministro della Guerra, almeno tanto vantava. E siccome fa gran torto alla felicità del presente Governo, che sotto i suoi occhi, e forse con l’autorità sua si malmenano e si distruggono Monumenti, che furono già rispettati da’ Goti, da’ Lon-gobardi, da’ Saraceni e da quanti barbari vennero ne’ trapassati secoli a danni nostri; perciò mi sono ardito far tutto presente a V.E. implorando ordini i più efficaci, diretti alla conser-
GLI STUDI SULLA CIVILTÀ SPETTACOLARE DELL’ANTICA CAPUA NEL XIX SECOLO
383
I diversi interventi messi in atto dalle autorità, documentati da al-cune missive degli Intendenti di Terra di Lavoro pubblicate in un pre-zioso articolo di V. Trombetta11, non dovettero in alcun caso rivelarsi risolutivi, se nel 1818 Giuseppe Castaldi giungeva a segnalare all’Acca- demia ercolanese il pericolo di una integrale distruzione del monumen-to12. Alla segnalazione di Castaldi fecero seguito alcuni progetti per la creazione di un recinto o di un doppio fossato volti a preservare i ruderi esistenti13; al contempo, nel 1819 l’anfiteatro Campano veniva dichiara-to proprietà dello Stato e affidato alla direzione degli scavi e dei deposi-ti antiquari14. Nel 1824 i lavori erano affidati all’architetto Pietro Bian-chi15, il quale due anni più tardi poté avviare la prima campagna di sca-vo sistematica presso l’Anfiteatro Campano16. Tra il 1826 e il 1830 fu-rono completamente liberati l’arena e gli ambienti sotterranei del mo-numento17. Per comprendere la significatività dell’intervento, sarà suffi- vazione di quelle Antichità [...]» (cito da TROMBETTA 1986, p. 86). La lettera è conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli, fasc. 987, I inv. del Ministero degli Interni. Testimonia la progressiva degradazione del sito anche la lettera di Giuseppe Mazzucca, avvocato napo-letano, al Ministro dell’Interno (26 ottobre 1806), in cui si denuncia la necessità di provve-dere alla conservazione dei monumenti, da considerarsi più importanti delle fonti letterarie, in quanto testimoni imperituri della storia di un territorio; in particolare, la necessità di tu-telare il monumento capuano è tanto più urgente dal momento che «quanto vide e descrisse il Ch. Mazzocchi nell’Anfiteatro Campano, quasi tutto oggi è perduto, sebbene sia passato appena un mezzo secolo». Cf. D’ALCONZO 1999, p. 100. Un’ulteriore, seppur diversa, testi- monianza sullo stato di conservazione del monumento all’inizio dell’Ottocento proviene dai disegni conservati nel quaderno di viaggio del pittore Giuseppe Bossi, che fu a S. Maria il 17 luglio 1810, cf. CORLÀITA SAGLIARINI 1977. L’immagine di un anfiteatro diroccato, privo degli ordini superiori e ingombrato nell’arena da piantagioni che impedivano di scorgere il podium, è restituita in quei medesimi anni da R. PAOLINI, Memorie sui monumenti di anti-chità e di belle arti, [...], Napoli 1812, p. 257 s.
11#Cf. TROMBETTA 1986.
12#La vicenda è compiutamente ricostruita da FRIELLO 2008-2011, pp. 183-188.
13#FRIELLO 2008-2011, pp. 189-192.
14#Cf. D’ALCONZO 1999, p. 129; CASIELLO 2000, p. 89.
15#A. VENDITTI, Bianchi, Pietro, in DBI 10 (1968), s.v.; M. PAGANO, Pietro Bianchi ar-
cheologo: da architetto fiscale a direttore degli scavi di Pompei, in Pietro Bianchi 1787-1849 architetto e archeologo, a cura di N. OSSANNA CAVADINI, Milano 1995, pp. 151-153.
16#Cf. il Decreto portante delle disposizioni per effettuarsi il prescritto fossato intorno al-
l’anfiteatro Campano, emanato da Francesco I il 5 gennaio 1826. Sull’azione di Francesco I vd. anche Della civiltà delle due Sicilie dal MDCCXXXIV al MDCCCXXX, «Annali civili del Regno delle due Sicilie» I (1833), p. 35: «Perché la soverchia ricchezza non ci facesse negli-gono custodi delle opere degli antichi pervenute fino a noi, comperava nuove terre intorno alla basilica di Pesto ed all’Anfiteatro Campano e, cinti que’ venerandi avanzi di larghe fos-se, facevali securi da nuove ingiurie devastatrici».
17#Cf. CAMMAROTA 2000, p. 174 e n. 10. Lo scavo dei sotterranei restituì materiale ar-
chitettonico antico, oltre a circa 40 monete d’oro e altre di bronzo con l’effigie dei vari Impe-ratori, poi trasportate nel Real Museo Borbonico: cf. D. SPINELLI, «Bullettino dell’Instituto
SERENA CANNAVALE
384
ciente ricordare le parole di Werner Johannowsky, il quale, nel definire la storia degli scavi di Capua come «uno dei più tristi capitoli dell’ar- cheologia campana», individuava l’unica eccezione nei «lavori compiuti nell’Anfiteatro negli anni ’20 dell’Ottocento18».
Le indagini ridestarono l’interesse antiquario nei confronti del mo-numento: non a caso, le tre più importanti monografie ottocentesche sul- l’anfiteatro si collocano nello stretto giro d’anni, immediatamente suc-cessivo alla ripresa degli scavi. La prima è l’opera di Giacomo Rucca19, Capua Vetere, o sia Descrizione di tutti i monumenti di Capua antica e particolarmente del suo nobilissimo anfiteatro, Napoli 182820. Una prima prova dell’interesse del Rucca verso questo soggetto può rintracciarsi in una dissertazione sull’anfiteatro campano a sua firma pubblicata nel pe-riodico napoletano «Ape Sebezia. Giornale di scienze, lettere ed arti»21 (n. 17, 20 luglio 1827, pp. 167-171), di cui una redazione manoscritta si conserva presso l’archivio storico del Museo Campano di Capua (AMC di Corrispondenza Archeologica» (1830), p. 180 s.; Atti della settima adunanza, p. 631. Gia-como Rucca contestò che potessero essere state ritrovate delle monete in quel sito, che per anni aveva ospitato la milizia saracena; a confortare la tesi del Bonucci sarebbe però intervenu- to Giuseppe Fiorelli (cf. Atti della settima adunanza, p. 632). In generale, sugli studi antiquari e archeologici in Campania tra Settecento e Ottocento vd. MAIURI 1937a; L.A. SCATOZZA
HÖRICHT, Gli studi archeologici: dall’antiquaria alla storia, in Cultura**, pp. 815-823. 18
#JOHANNOWSKY 1989, p. 13. Non mancarono comunque in quegli anni insidie all’in- tegrità del sito, come rivela il materiale archivistico: il 15 luglio 1826 l’Intendente di Terra di Lavoro rassegnava al Segretario e Ministro di Stato di Casa Reale un rapporto del Sinda-co di S. Maria, il quale riferiva delle pressioni fatte dal comandante austriaco affinché fosse possibile riprendere l’esercizio del bersaglio nel recinto dell’Anfiteatro Campano; il 20 lu-glio il Ministro respingeva la richiesta, esprimendo il proprio disappunto per la condotta poco lodevole del Sindaco ed invitandolo, per il tramite dell’Intendente, a vigilare sulla con-servazione del monumento: cf. Archivio di Stato di Napoli, Ministero degli Affari Interni, Inv. II, 2061, 219.
19#Sul quale vd. le notizie bio-bibliografiche riportate da A. LAURI, Dizionario dei citta-
dini notevoli di Terra di Lavoro, Sora 1915, rist. 1979, s.v.: nativo di S. Maria Capua Vetere, visse tra il 1785 e il 1860. Storico e archeologo, socio ordinario dell’Accademia Ercolanese, appassionato alle antichità della sua patria, collaborò con l’architetto Francesco Alvino nella pubblicazione della sua monumentale opera sull’Anfiteatro (su cui vd. infra).
20#Successivi studi anfiteatrali del Rucca furono presentati nelle Memorie della Regale
Accademia Ercolanese di Archeologia: cf. G. RUCCA, Memoria su le naumachie date nell’anfi- teatro, «Memorie della Regale Accademia Ercolanese di Archeologia» III (1843), pp. 79-94; ID., Dell’uso de’ sotterranei anfiteatrali. Memoria, ibid., IV. Parte 1a (1852), pp. 203-237; ID., Memoria su l’ipogeo dell’anfiteatro puteolano, ibid., pp. 239-252; ID., Sul primato dell’anfitea- tro Campano. Memoria, ibid., VI (1853), pp. 285-316. Sulle «Memorie della Regale Accademia Ercolanese di Archeologia» vd. TROMBETTA 1991, p. 333 ss.; ID., L’editoria napoletana del- l’Ottocento. Produzione circolazione consumo, Milano 2008, pp. 126-131. Un contributo del Rucca sull’anfiteatro Campano è anche in «Real Museo Borbonico» XV (1856), pp. 1-23.
21#Sul periodico, cf. Ape Sebezia. Giornale scientifico letterario (Indici 1824-1827), a cu-
ra di P. BASILE, Salerno 2003.
GLI STUDI SULLA CIVILTÀ SPETTACOLARE DELL’ANTICA CAPUA NEL XIX SECOLO
385
564, fasc. 5, n. 2). Il breve contributo, intitolato Cenno su l’anfiteatro campano, presenta, oltre ad una rapida descrizione delle rovine supersti-ti, l’esposizione in forma compendiata di due tesi compiutamente svi-luppate nello studio più ampio: la datazione del monumento ai tempi non di «Capua colonia, ma di Capua libera e autocrata» e la maggio- re magnificenza dell’anfiteatro Campano rispetto al Flavio. L’incentivo principale alla pubblicazione di uno studio di ampio respiro sulle anti-chità di Capua, come si spiega nella Prefazione al volume del 1828, sono gli scavi avviati da Francesco I, cui è dedicata l’opera22:
Parrà forse strano a taluni, che vantando la nostra Capua tra suoi Figli illustri non pochi valorosi Scrittori, i quali hanno delle sue anti-chità dottamente e ampiamente ragionato, sorgiamo ora noi a mi-schiarci audacemente tra quelli, le medesime antichità prendendo ad illustrare. A costoro ei si vuol render ragione di questa nostra qua-lunque siasi fatica. Mercé le cure illuminate dell’Augusto nostro RE, fervido Protettore delle Arti e delle Scienze, il famosissimo Anfiteatro Campano, le di cui rovine a dispetto del tempo distruggitore parlava-no ancora di magnificenza all’Osservator curioso, torna pienamente a rivedere la luce del giorno, ed autenticare con prove irrefragabili di fatto la sua primitiva grandezza, a null’altra seconda. [...] Alla piena compiacenza, che provavasi da ognuno in mirare così prezioso mo-numento della veneranda antichità, mancava solo il conoscere chia-ramente l’artificiosa organizzazion delle parti, la descrizione e l’uso del tutto insieme. Si vide il bisogno d’una penna illustratrice. Caldi della carità del natio luogo, e sospinti dalla rimembranza delle sue glorie vetuste, nulla misurando le proprie forze, prendemmo noi stes-si l’onorato, ma difficile incarico d’appagare la comun curiosità, ecci-tata vivamente dalla presenza inaspettata di tanti nobilissimi fram-menti, e degli stupendi sotterranei (pp. V-VI).
Dopo aver anticipato il «vero paradosso» emerso dai suoi studi e
ampiamente argomentato nel volume, e cioè che l’anfiteatro campano non sarebbe stato secondo neppure al Colosseo, Rucca passa in rasse-gna l’opera dei suoi predecessori, al fine di dimostrarne l’insufficienza. Gli studi di Camillo Pellegrino (1598-1663) sull’anfiteatro erano pur-
22#L’opera fu sottoposta all’esame dell’Accademia Ercolanese, che, avendola «trovata
scritta con somma erudizione, e fornita dall’autore con assai dotte, e sensate osservazioni», non solo espresse parere favorevole in merito alla richiesta dello stesso Rucca di dedicare l’opera al Sovrano, ma rimarcò anche l’opportunità di incoraggiare l’autore «a continuare collo stesso zelo le ulteriori ricerche tanto sull’Anfiteatro, quanto sugli altri avanzi dell’an- tica Capua, la cui celebrità nacque veramente dal sommo ingegno de’ suoi abitanti»: cf. Ar-chivio di Stato di Napoli, Ministero degli Affari Interni, II inv., 2091, 240.
SERENA CANNAVALE
386
troppo andati perduti23; la monografia di Alessio Simmaco Mazzocchi (1684-1771), incentrata sulla descrizione e integrazione della famosa epigrafe rinvenuta mutila tra le rovine24, non dedicava che un capitolo alla descrizione del monumento, capitolo che, peraltro, «lascia moltissi-mo a desiderare: e quel poco, che ne contiene non è il più felicemente pensato sulla materia»25; «piccolo cenno» ne faceva poi Francesco Maria Pratilli (1689-1763), fondandosi sull’opera del Mazzocchi, integrata con qualche notizia tratta da un manoscritto di F. Vecchioni26; Ottavio Ri-naldo (1712-1773) l’avrebbe semplicemente nominato27; e Francesco Granata (1704-1771) «avrebbe fatto meglio a passarlo sotto silenzio»28.
Secondo l’impostazione tipica delle opere di antiquaria – che, come insegna Momigliano, si distinguono per il fatto di non procedere secon-do un criterio cronologico, come quelle storiche, ma sistematico29 – la monografia del Rucca è composta da venticinque capitoli, che trattano in ordine sparso argomenti variamente connessi alla storia di Capua an-tica e ne illustrano i diversi monumenti. La parte più ampia dello studio è dedicata all’Anfiteatro (pp. 136-290), le cui «dignitose rovine – dice l’erudito – ad onta del presente stato di degradazione, imprimono a col-
23#L’opera sull’Anfiteatro Campano del Pellegrino, in quattro libri, sarebbe stata data
alle fiamme dai familiari dietro sua specifica richiesta (RUCCA 1828, p. VII). Di Pellegrino ci rimane però l’Apparato alle Antichità di Capua, ovvero Discorsi della Campania Felice, Napo-li 1651, ristampato dal Gravier nel 1771 (cf. BELOCH 1989, p. 339).
24#MAZZOCCHI 1797, pp. 134-148; le pagine seguenti (148-161) sono dedicate alla sto-
ria dell’anfiteatro successiva all’età imperiale. L’iscrizione, oggi conservata al Museo Cam-pano di Capua, corrisponde a CIL X 3832.
25#RUCCA 1828, p. VII.
26#Ibid. Cf. PRATILLI 1745, pp. 300-308. Sulla scarsa attendibilità di Pratilli e delle sue
fonti si espresse come è noto Mommsen (cf. CIL X, p. 373), seguito da BELOCH 1989, p. 339 s.; non sono mancate però recenti riabilitazioni, cf. ad es. MAIURI 1937a, p. 47; R. PAL-MIERI, Su alcune iscrizioni pratilliane, «Miscellanea Greca e Romana» 8 (1982), pp. 417-431; H. SOLIN, Corpus inscriptionum Latinarum X. Passato, presente, futuro, in Epigrafi e studi epigrafici in Finlandia, a cura di H. SOLIN, Roma 1989, p. 93.
27#RUCCA 1828, p. VIII. Cf. O. RINALDO, Memorie istoriche della fedelissima città di Ca-pua I, Napoli 1753, p. 235 s.
28#RUCCA 1828, p. VIII. Cf. GRANATA 1752, pp. 93-98.
29#A. MOMIGLIANO, Ancient History and the Antiquarian, «JWCI» XIII 3/4 (1950), pp.
285-315 (in part. 286 s.), poi in ID., Contributo alla storia degli studi classici, Roma 1955, pp. 67-106. D’altra parte, Rucca – così come gli autori delle altre due monografie di cui si trat-terà in seguito, Alvino e de Laurentiis – rientra bene nella tipologia dello studioso di anti-quaria della prima metà dell’Ottocento delineata da Salmeri: «si può affermare che nella prima metà del secolo [scil. il XIX secolo], in Italia, la figura dell’antiquario si andò sempre più qualificando come quella di uno studioso specializzato nel campo delle antichità mo-numentali – soprattutto della sua area geografica e dell’antichità romana» (cf. G. SALMERI, L’antiquaria italiana dell’Ottocento, in Lo studio storico del mondo antico nella cultura italia-na dell’Ottocento, a cura di L. POLVERINI, Napoli 1993, p. 273).
GLI STUDI SULLA CIVILTÀ SPETTACOLARE DELL’ANTICA CAPUA NEL XIX SECOLO
387
po d’occhio ammirazione e stupore in chiunque si avvicini a contemplar-le» (p. 136). Dopo il doveroso omaggio al sovrano borbonico, che «ha fatto cessare le ingiurie degradanti» e «ha ordinato lo sgomberamento» del monumento, lo studioso, confutando le posizioni di Pellegrino e di Mazzocchi, e allineandosi invece ad un’ipotesi già avanzata da Pratilli30, difende con convinzione la tesi della maggiore antichità dell’anfiteatro campano, edificato a suo avviso ai tempi dell’indipendenza di Capua, rispetto al Colosseo31. L’assunto è fondato sulla considerazione della grandezza di Capua prima della conquista romana e della straordinaria passione dei Campani per i giochi Gladiatori, testimoniata dalle fonti letterarie. Rucca cita i luoghi di Strabone32, di Silio Italico33 e di Nicola Damasceno34 che testimoniano la pratica campana di accompagnare i banchetti con combattimenti gladiatori. Ricorda quindi il passo di Li-vio35, in cui lo storico parlando del successo riportato sui Sanniti dai Romani e dai loro alleati Campani nel 310/309 a.C.36 racconta che que-sti ultimi fecero vestire i gladiatori, in occasione di spettacoli organizzati durante i banchetti, con le armi dei nemici vinti, e chiamarono tali gla-diatori ‘Samnites’. La presenza di un gran numero di gladiatori nell’an- tica Capua, certificata dall’esistenza della scuola di Lentulo Batiato, da cui sarebbe partita la rivolta di Spartaco, e di un ludus gladiatorio che Giulio Cesare avrebbe posseduto nella città campana37, è un ulteriore argomento a favore dell’antichità del monumento: «or si può immagina-re una città inclinatissima fino al furore ai gladiatorj giuochi, e ridon-dante di gladiatori, senza un Anfiteatro?» (p. 169). C’è da dire che il te-
30#PRATILLI 1745, pp. 300-303.
31#A favore della propria posizione Rucca richiama l’autorità di Antonio Sanfelice (Cam-
pania, Napoli 1562, c. DIV) e di Pietro Lasena (Dell’antico Ginnasio Napolitano, Roma 1641, p. 172).
32#V 13: K·Ì·ÓÔÖ˜ ‰b Û˘Ó¤‚Ë ‰Èa ÙcÓ Ùɘ ¯ÒÚ·˜ Â鉷ÈÌÔÓ›·Ó â’ úÛÔÓ àÁ·©áÓ àÔ-
Ï·ÜÛ·È Î·d ηÎáÓ. âd ÙÔÛÔÜÙÔÓ ÁaÚ âÍÂÙÚ‡ÊËÛ·Ó œÛÙ’âd ‰ÂÖÓÔÓ âοÏÔ˘Ó Úe˜ ˙‡ÁË ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ, ïÚ›˙ÔÓÙ˜ àÚÈ©ÌeÓ Î·Ùa ÙcÓ ÙáÓ [Û˘Ó]‰Â›ÓˆÓ àÍ›·Ó.
33#XI 51-54: quin etiam exhilar<ar>e uiris conuiuia caede/ mos olim et miscere epulis spectacula dira/ certantum ferro, saepe et super ipsa cadentum/ pocula, respersis non parco sanguine mensis.
34#Apud Ath. IV 39.16: Ùa˜ ÙáÓ ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ©¤·˜ Ôé ÌfiÓÔÓ âÓ ·ÓËÁ‡ÚÂÛÈ Î·d
©Â¿ÙÚÔȘ âÔÈÔÜÓÙÔ ^PˆÌ·ÖÔÈ, ·Úa T˘ÚÚËÓáÓ ·Ú·Ï·‚fiÓÙ˜ Ùe ö©Ô˜, àÏÏa ÎàÓ Ù·Ö˜ ëÛÙÈ¿ÛÂÛÈÓ. Rucca specifica che il riferimento è da intendersi agli Etruschi Campani.
35#IX 40.17: et Romani quidem ad honorem deum insignibus armis hostium usi sunt:
Campani ad superbiam et odio Samnitium gladiatores, quod spectaculum inter epulas erat, eo ornatu armarunt Samnitiumque nomine compellarunt.
36#Sul passo, vd. il commento di S.P. OAKLEY, A commentary on Livy, Books VI-X, III:
Book IX, Oxford 2005, pp. 524-526. 37
#Rucca cita al riguardo Cic. Att. VII 14 e Caes. civ. I 14.
SERENA CANNAVALE
388
ma dello straordinario amore dei Campani per ogni genere di spettacoli era già stato affrontato dal Mazzocchi tramite il richiamo ai medesimi te-sti (p. 126 ss.: Caput V); si ricollegava peraltro ad un topos, quello del- la luxuria dell’antica Capua, ampiamente richiamato nelle fonti classi- che e riecheggiato nella letteratura: per alcuni esempi ottocenteschi, si possono vedere il Capitolo LXXII. Di Cleobolo a Mnesilla. Capua, Lusso, voluttà, gladiatori del Platone in Italia di Vincenzo Cuoco (III, Milano 1806, pp. 172-182), oppure le pagine dedicate alla città campana nel Corricolo di Alexandre Dumas, in cui si fa derivare dall’eccesso di volut-tà campana l’invenzione stessa della gladiatura38.
Lo studio del Rucca prosegue con la descrizione dell’edificio39 e della molteplicità degli spettacoli che in esso dovevano tenersi (pp. 207-225; combattimenti pedestri, equestri, con animali acquatici e pugne na-vali40), sintomo della magnificenza e della straordinaria propensione del- l’antica Capua per gli spettacoli: «essa (scil. Capua) profondeva i suoi tesori nel suo Anfiteatro, che formava la più antica e la prediletta delle sue inclinazioni: basta dire, che essa fu la prima ad avere Giuochi gla-diatorj ed Anfiteatro, ed essa fu l’ultima a privarsi di quelli, vivendo fin oggi le reliquie di questo»41. La preminenza dell’anfiteatro Campano ri-spetto a qualsiasi altro anfiteatro e segnatamente rispetto al Colosseo fu peraltro oggetto di una nota letta all’Accademia Ercolanese pochi anni più tardi da parte dell’abate sammaritano42. Dietro tale enfatica esalta-
38#Cf. A. DUMAS, Il corricolo, Introduzione e note di G. DORIA, Napoli 20042 (ed. or.
Parigi 1841), p. 542: «Capua, questa città della Campania in cui la civiltà etrusca aveva pre-corso di cinquant’anni la civiltà di Roma, e che Roma, la grande invidiosa di tutte le glorie, trattò come Cartagine, aveva un magnifico anfiteatro di cui possono ancora ammirarsi le ro-vine; giacché fu Capua, la città civilizzata per eccellenza, che inventò i combattimenti gla-diatori. Donde veniva quella ferinità istintiva ne’ feroci abitanti della Campania? Dall’ecces- so medesimo della voluttà».
39#Nello specifico, con l’illustrazione delle misure del monumento (pp. 177-182), del
recinto esterno (pp. 182-200), delle statue (pp. 200-203), della pianta dell’edificio e delle vie d’accesso nell’arena (pp. 203-207).
40#La possibilità di sfruttare le strutture anfiteatrali per i combattimenti acquatici è di-
fesa da Rucca nella Memoria sulle naumachie date nell’anfiteatro, letta nel 1830 (cf. supra, n. 20) in polemica con l’archeologo Lorenzo Re, che aveva invece sostenuto che le naumachie non si svolgevano negli anfiteatri ma in siti appositamente predisposti (Osservazioni sull’Are- na, e sul podio dell’anfiteatro Flavio, fatte dal signor Pietro BIANCHI di Lugano, illustrate e difese da Lorenzo RE, Roma 1812).
41#RUCCA 1828, p. 222. Rucca procede poi alla descrizione di gradi, vomitori, precin-
zioni, scalette, cunei (pp. 225-234) e delle scale interne (pp. 234-239); quindi affronta il pro- blema del numero degli spettatori e della loro distribuzione (pp. 240-262); infine si sofferma sul sito dell’anfiteatro (pp. 262-267), sul velario (pp. 267-272), sui sotterranei (pp. 272-280), sulle varie denominazioni e sulla storia del monumento nei secoli posteriori, fino alla presa saracena (pp. 280-290).
42#Cf. n. 20.
GLI STUDI SULLA CIVILTÀ SPETTACOLARE DELL’ANTICA CAPUA NEL XIX SECOLO
389
zione delle antichità capuane si può leggere senz’altro un intento cele-brativo della Casa Reale, non alieno peraltro da una nota di orgoglio municipale43; eppure all’accademico ercolanese va riconosciuta la fon-damentale intuizione, suffragata dagli eruditi riferimenti alle fonti lette-rarie, della presenza di un anfiteatro stabile a Capua ben prima che a Roma, presenza certificata dalle recenti indagini archeologiche che han-no portato alla luce strutture pertinenti ad un primo edificio per spetta-coli, databile ad età graccana44.
L’opera del Rucca si concentra però anche su altre strutture per spet-tacolo dell’antica Capua: diverse pagine sono dedicate al circo (pp. 52-60)45 e al teatro (pp. 112-128). Per quanto concerne quest’ultimo monu-mento, in particolare, Rucca parte dalla constatazione che di esso non rimane che un «miserabile avanzo». Nell’affrontare l’argomento, l’auto- re si rifà ampiamente alle notizie sul teatro rinvenibili negli scritti di Maz-zocchi, il quale poteva ancora scorgere parte dell’emiciclo della cavea46,
43#Critico nei confronti del libro del Rucca è il recensore della «Biblioteca Italiana o sia
giornale di Letteratura Scienze ed Arti compilato da vari Letterati» LVIII (1830), p. 260 s.: «[...] Quindi si passa a parlare lungamente del famoso anfiteatro Campano, e a noi sembra con tono esagerato in quanto all’antichità, all’ampiezza ed ai confronti che si fanno di questo col Flavio di Roma, e coll’altro Veronese, sostenendosi il Campano per il più vasto, per il più nobile, e per il più antico di tutti. In quanto alle sostruzioni ultimamente scoperte in quel- l’anfiteatro, se ne discorre, come se quelle del Colosseo non fossero state scoperte 15 anni prima con tanto clamore e con tante dispute dei romani archeologi. Si osa affermare che di queste assai scrissero gli antichi, i quali in verità non ne fecero alcun motto direttamente, e si tace il molto che a’ giorni nostri fu detto e pubblicato in Roma all’occasione di quelle mara-vigliose scoperte. Noi dunque abbiamo ragione di credere che sorgerà ben tosto alcuno tra i dotti accademici Ercolanesi, il quale, pieno di vera, solida ed imparziale dottrina parlerà più adeguatamente di quel celebrato monumento ora che per munificenza del regnante sovrano vi si vanno facendo scavamenti e scoperte di tanta importanza».
44#Negli anni ’50 del Novecento sono tornati alla luce i primi resti delle fondazioni di
una struttura a pianta radiale. Altri cospicui resti del monumento sono stati riscoperti a par-tire dal 2005, nei lavori per la sistemazione della piazza I Ottobre 1860. Sulla base della tec-nica edilizia si riporta la costruzione del monumento ad età graccana. Sull’anfiteatro repub-blicano, cf. K.E. WELCH, The Roman Amphitheatre From Its Origins to the Colosseum, New York 2007, pp. 198-202; V. SAMPAOLO, Il quartiere degli anfiteatri: l’espansione di Capua fuori le mura occidentali, in Il Mediterraneo e la storia. Atti dell’incontro internazionale di studio, Napoli 4 e 5 dicembre 2008, a cura di L. CHIOFFI, Napoli 2010, pp. 78-81; S. DE CARO, La terra nera degli antichi campani. Guida archeologica della provincia di Caserta, Na-poli 2012, p. 45 s.
45#Vd. M. PAGANO, Il circo di Capua, «Archivio storico di Terra di Lavoro» IX (1984-
1985), p. 155 s. Anche per il circo Rucca pone la cronologia della costruzione al tempo di Capua libera ed indipendente, come dimostrerebbero gli accenni nelle fonti all’eccellenza della Cavalleria Campana, risultante dalla bontà tanto dei cavalli quanto dei cavalieri.
46#MAZZOCCHI 1797, pp. 169-184. Un primo accenno al teatro si trova nell’opera di Mi-
chele Monaco, che, fondandosi sulla pianta del Costa, lo collocava tra il Criptoportico e il Campidoglio: cf. M. MONACO, Sanctuarium Capuanum, Napoli 1630, p. 123 ss. Durante tutto il
SERENA CANNAVALE
390
Pratilli47 e Granata48. Sulla datazione dissente però dal Mazzocchi, il quale, pur ammettendo la possibilità di strutture temporanee, in legno, per l’età precedente, collocava l’origine del teatro stabile capuano in età imperiale. Diversamente il Rucca difendeva la tesi di una prima struttura in pietra di età repubblicana49, individuando l’errore della ricostruzione mazzocchiana nella convinzione che Capua avesse tratto da Roma i mo-delli dei suoi edifici per spettacoli: al contrario, fu dagli Etruschi campa-ni che i Romani derivarono i modelli per gli edifici spettacolari, e finan-che «le commedie, gli Attori ed i Poeti, e fino il gusto, fino anche il gusto di siffatti spettacoli»50. Insomma, molto prima di Roma Capua avrebbe avuto un teatro stabile, e forse addirittura più d’uno51.
Autore della seconda monografia apparsa in quello stretto giro di anni52 fu l’architetto e archeologo partenopeo Francesco Alvino, inter-venuto negli scavi capuani a partire dal 1828. La sua opera, intitolata Anfiteatro campano ristaurato ed illustrato, di cui fu pubblicata una pri-ma edizione nel 1833, e quindi, circa dieci anni più tardi, un’edizione rivista e ampliata53, si inserisce nel filone – molto diffuso nella cultura Settecento, un’ampia porzione della cavea doveva ancora essere visibile, come dimostra una veduta di Carlo Labruzzi del 1789. Dal quaderno di G. Bossi pubblicato da Corlàita Sagliarini ricaviamo l’immagine del teatro nel 1810: «Presso all’arco e al Criptoportico in una casa da contadini vedonsi gli avanzi d’un teatro considerabile». Cf. CORLÀITA SAGLIARINI 1977, p. 44.
47#Cf. PRATILLI 1745, p. 308 ss. Pratilli descriveva le rovine superstiti come poche reli-
quie consistenti in «alcune piccole volte di mattoni sostenute da due ordini di pilastri». In merito alla questione della datazione, Pratilli seguiva il Mazzocchi nel riferire le strutture superstiti all’età imperiale, pur non escludendo che in Capua fosse esistito un altro teatro in legno databile ad età repubblicana. L’ipotesi nasceva anche in questo caso dalla considera-zione della straordinaria passione per gli spettacoli manifestata dagli antichi abitanti di Ca-pua e testimoniata dalle fonti (p. 309). L’influenza pratilliana sul Rucca è deprecata da BE-LOCH 1989, p. 340, che per il resto giudica «utilissima» la monografia del 1828.
48#Cf. GRANATA 1752, p. 116 s. Granata ricalca sostanzialmente quanto affermato da
Pratilli, aggiungendo un solo dato originale, ovvero che il teatro sarebbe stato colpito da un fulmine al tempo dell’imperatore Gaio: ma nel passo di Svetonio cui egli si richiama (Cal. 57.2.1) si parla dell’adiacente Campidoglio, non del teatro (Capitolium Capuae Id. Mar<t.> de caelo tactum est).
49#Sulla questione si dividono anche gli studiosi moderni: per una sintesi, cf. G. TOSI,
Gli edifici per spettacoli nell’Italia romana, Roma 2003, p. 132 s. 50#Cf. RUCCA 1828, p. 114. 51
#RUCCA 1828, p. 117. Sul tema, cf. CHIRICO - CANNAVALE 2009, p. 65 ss. 52
#Tra le opere di Rucca e Alvino si inserisce, dal punto di vista cronologico, il Saggio storico delle antichità di Capoa, sive Spicilegium Campanum, Caserta 1829, di Bonaventura Natale, erudito originario di Casapulla. Anche in quest’opera si trova sostenuta l’anteriorità dell’Anfiteatro Campano rispetto al Colosseo e la sua maggiore magnificenza; ampio spazio è dedicato a quella che Natale definisce «la celebre spelonca sotterranea, di cui si è fatto lo scavo», dunque ai sotterranei, di cui si espongono le diverse funzioni.
53#L’innovazione principale dell’edizione del 1842 – fatta eccezione per gli ampliamen-
ti e le correzioni imposti da «i cambiamenti che la esperienza di dieci anni ci consiglia» (cf.
GLI STUDI SULLA CIVILTÀ SPETTACOLARE DELL’ANTICA CAPUA NEL XIX SECOLO
391
archeologica e artistica della prima metà dell’Ottocento – del ‘restauro ideale’54. Il ‘restauro’ cui si fa riferimento nel titolo va infatti inteso co-me restituzione grafica dell’aspetto originario del monumento, fondata sulle attestazioni materiali55, una vera e propria «palingenesia per la quale dai residui delle parti originali risorge la perduta maestà del tut-to», avrebbe detto l’Alvino in una successiva pubblicazione56. Il pode-roso volume sull’anfiteatro di Capua antica fu composto con la collabo-razione di Giacomo Rucca57, che l’avrebbe «affiancato co’ suoi savi con- sigli» (p. VI), e dedicato a Michele Arditi (1746-1838), allora direttore del Real Museo Borbonico e Soprintendente agli scavi di Antichità58. Dopo un primo capitolo dedicato ai cenni storici sulla città di Capua e alle vicende dell’anfiteatro dall’antichità al Medioevo, Alvino procede alla descrizione del monumento «qual era nei tempi della prosperità di Capua» e qual è invece nello «stato attuale», con il conseguente «ristau-ro», che si concretizza in una dettagliatissima ricostruzione del prospet-to, della pianta, dell’interno, delle scale, della cavea con la disposizione e il numero massimo degli spettatori, stimato in sessantamila. Un capi- Anfiteatro Campano, illustrato e restaurato da F. ALVINO, col paragone di tutti gli anfiteatri d’Italia, ed un cenno sugli antichi monumenti di Capua, Napoli 1842, p. 6) – consiste nell’ag- giunta di tre capitoli, intitolati rispettivamente Iscrizioni lapidarie antiche rinvenute in Capua e ne’ dintorni; Breve cenno sulle ruine di Capua; Paragone degli anfiteatri d’Italia. Rapidissimi e privi di notizie originali, perché desunti principalmente dall’opera del Rucca, i cenni riser-vati al teatro e al circo nel capitolo sulle rovine di Capua: d’altronde, Alvino aveva dichiara-to esplicitamente in sede prefatoria che non avrebbe offerto lunghe descrizioni o dettagli, ma si sarebbe limitato ad indicare con brevissimi cenni «sia i monumenti i cui ruderi esisto-no ancora, che quelli distrutti di cui si fa parola nelle pagine di antichi scrittori, o che si leg-gono nominati nelle iscrizioni» (cf. ibid.). L’affinità con il volume del Rucca si ravvisa anche nel successivo capitolo Paragone degli anfiteatri d’Italia: è qui proposto, seppure in forma più schematica, il confronto tra Anfiteatro Campano, Romano e Veronese, che costituiva un tema portante già della monografia del 1828. Le misure riportate, per quanto leggermente difformi in relazione al Colosseo, consentono ad entrambi gli studiosi di evidenziare la so-stanziale equivalenza, nelle dimensioni, di Colosseo e Anfiteatro Campano, e la loro palese superiorità rispetto al Veronese.
54#Cf. F. MANGONE, Capri e gli architetti, Napoli 2004, p. 21.
55#Cf. F. VIGGIANI, Il «restauro» come restituzione grafica: «L’Anfiteatro campano» di
Francesco Alvino, «Capys» 19 (1986), pp. 44-52. 56
#Le antiche ruine di Capri disegnate e restaurate dall’architetto Cav. F. ALVINO e illu-strate dal Cav. B. QUARANTA, Napoli 1835, p. 2.
57#Su cui vd. supra. Rucca e Alvino sono accomunati nel giudizio del Mommsen, che a
proposito del loro apporto alla scienza epigrafica affermava recisamente: «non multum dede-runt» (il giudizio si trova espresso nel vol. X del CIL, sotto la dicitura de auctoribus Campanis, laddove lo studioso tedesco stila una personale ‘pagella’ dei dotti che si erano interessati alle epigrafi capuane; cf. L. CHIOFFI, Da Theodor Mommsen al ‘Lapidario Mommsen’. Capua Ro-mana nei testi latini della collezione epigrafica, in Il Museo Campano di Capua: storia di un’istituzione e delle sue raccolte, a cura di R. CIOFFI - N. BARRELLA, Napoli 2009, pp. 58-60).
58#Cf. A. PIRONTI, Arditi, Michele, in DBI 4 (1962), s.v.
SERENA CANNAVALE
392
tolo è quindi dedicato al «gusto degli Etrusci pe’ giuochi gladiatori»: vi si stabilisce una diretta derivazione della passione dei Romani per gli spettacoli dagli Etruschi di Capua sulla scorta della testimonianze lette-rarie59; d’altronde, sostiene Alvino, l’amore degli antichi Campani per i giochi dell’arena è incontrovertibilmente dimostrato dallo splendore ec-cezionale dell’anfiteatro stesso:
Nell’Anfiteatro Campano stupendo, e meraviglioso edifizio [...] tutto era degno della più alta ammirazione; la sua ampiezza, le deco-razioni, che l’abbellivano, la quantità immensa di rarissimi marmi, che vi si osservava con profusione, la bellezza delle statue, e de’ capi d’opera dell’arte, tutto in somma offriva lo spettacolo del genio, e della perfezione, aggiungasi a tutto questo la magnificenza, e la gran-diosità degli spettatori, la varietà de’ medesimi, le ingegnose macchi-ne, che si metteano in azione, il concorso riunito di 60mila e più spet-tatori, e si avrà una ragione bastevole a giudicar la mania, che avea quella culta, e gentile nazione per un genere di giuochi capace di per se stesso a rivoltar la natura, e destar orrore pel sangue umano che vi si spargea60.
Di che genere di giochi si trattasse è spiegato subito dopo, con la
descrizione dei vari tipi di combattimenti gladiatori, delle «cacce delle fiere» e dei «simulacri di pugne navali»; concludono il volume 16 tavole e riproduzioni (per le quali l’autore si avvalse della collaborazione di G. Morghen e A. Autran), con le relative spiegazioni61. L’accuratezza delle riproduzioni, che, nell’opinione di Beloch, costituiscono il maggior pre-gio del volume62, fu entusiasticamente lodata da Bernardo Quaran- ta (1796-1867), che, in un articolo sull’anfiteatro Campano pubblicato nel 1834 negli «Annali civili del Regno delle due Sicilie», ricordava co-me i disegni avessero eccitato la sua fantasia, al punto di provocargli la
59#In particolare i passi di Strabone (V 13), Silio (XI 28 ss.), Nicola Damasceno (apud
Ath. IV 39.16), Livio (IX 40), Cesare (civ. I 14), Cicerone (Att. VII 14.1-3). 60
#ALVINO 1833, p. 15. 61
#Questi i soggetti delle Tavole: 1) Pianta generale dello stato attuale; 2) Pianta gene-rale ristaurata; 3) Dettagli esterni nello stato attuale; 4) Dettagli esterni restaurati; 5) Pro-spetto; 6) Pianta interna nello stato attuale; 7) Pianta interna restaurata; 8) Pianta restaurata divisa in quattro porzioni, ognuna delle quali appartiene ad un piano differente per la dimo-strazione delle scale; 9) Sezione; 10) Dettagli interni nello stato attuale; 11) Dettagli interni restaurati; 12) Pianta de’ sotterranei; 13) Veduta de’ sotterranei nello stato in cui ora esisto-no; 14) Veduta interna anche nello stato attuale; 15) Veduta esterna come sono attualmente i ruderi dell’Anfiteatro Campano; 16) Decorazioni ornamenti ed altro nello stato attuale e restaurati. Un’accurata analisi delle tavole è ora in CECERE - RENDA 2012, pp. 97-99.
62#BELOCH 1989, p. 340.
GLI STUDI SULLA CIVILTÀ SPETTACOLARE DELL’ANTICA CAPUA NEL XIX SECOLO
393
sensazione di assistere, insieme con gli antenati, ad uno degli antichi spettacoli63.
Particolare ammirazione avrebbe destato l’opera dell’Alvino anche in Salvatore di Giacomo, che nella breve guida archeologica Da Capua a Caserta ritenne di illustrare il monumento capuano riportandone un am- pio stralcio64; si noti poi che l’accuratezza dello studio dell’Alvino è sta-ta riconosciuta di recente anche da Johannowsky e Sampaolo65, e le sue misurazioni giudicate «omogenee» nella fondamentale monografia sulle strutture anfiteatrali del Golvin66.
La monografia è seguita, a distanza di pochi anni, dal meno noto vo-lume dell’abate Mariano de Laurentiis67: Descrizione dello stato antico, e moderno dell’anfiteatro campano, Napoli 1835. L’abate sembra ignorare completamente le opere di Rucca e di Alvino, mai nominate nel corso del suo studio, fondato invece preminentemente sull’autorità degli scritti di Pellegrino e di Mazzocchi. Dopo una sezione introduttiva sulla storia
63#B. QUARANTA, L’anfiteatro campano, «Annali civili del Regno delle due Sicilie» VI
(1834), p. 33. 64
#S. DI GIACOMO, Da Capua a Caserta, Bergamo 1924, pp. 20-22. Così è presentato lo studio dell’Alvino: «Nello stato in cui era a’ tempi della prosperità di Capua l’anfiteatro Campano ottiene dalla splendida opera dell’Alvino una illustrazione assai peculiare: è da por mente che lo scrittore non pure aveva con amor grande studiato le antichità ma era ar-chitetto, anche, e però degno e capace di poter ricostruire, su vestigia di tanta magnificenza, quel singolar monumento».
65#JOHANNOWSKY 1989, p. 13: «tuttora fondamentale l’opera monumentale di France-
sco Alvino sull’anfiteatro campano». Vd. già E. CIONE, Napoli romantica 1830-1848, terza edizione interamente rifatta, Napoli 1955, p. 83, secondo il quale l’opera dell’Alvino «segnò una tappa nella storia degli studi archeologici partenopei». Sull’opera di Alvino si può vede-re anche il giudizio di A. VENDITTI, Architettura neoclassica a Napoli, Napoli 1961, p. 34 s., che colloca l’architetto «tra le figure più notevoli di studiosi di patrie memorie» e mette in ri-lievo come «il senso di rispetto e di amore per le vestigia dell’antichità classica [...] fa dell’Al- vino un tipico esponente della cultura del suo tempo». Infine SAMPAOLO 1997, p. 12: «dopo la monografia dell’Alvino [...] non vi sono stati studi così approfonditi sull’argomento».
66#J.C. GOLVIN, L’amphithéâtre romain. Essai sur la théorisation de sa forme et de ses
fonctions, Paris 1988, p. 204, n. 414. 67
#Nato a Napoli nel 1778, ebbe come maestro di latino Nicola Ciampitti e di greco Carlo Rosini; ordinato sacerdote nel 1802, nel 1818 divenne professore di Storia e Geografia nel Real Educandato de’ Miracoli e professore di Lingua greca nel Seminario Diocesano di Napoli. Dal 1819 al 1825 ricoprì anche la cattedra di retorica e lingua greca nel Real Collegio dei Padri Barnabiti. Le sue opere, oltre a quella sull’anfiteatro campano, sono: Universi Campaniae Felicis antiquitates a Mariano DE LAURENTIIS elucubratae, Neapoli 1826 (dedicate all’Anfiteatro Campano sono le pp. 18-22); Notti Bajane al Sepolcro di Agrippina, Napoli 1841; Salvatoris Fuschi Elogium, Neapoli 1849; Dedica delle sue opere in latino alla santità di Pio IX, Napoli 1849. Per la biografia cf. A. EICHHOLZER, Necrologia del sacerdote napoletano D. Mariano de Laurentiis, socio straordinario della Real accademia ercolanese, «La scienza e la fede» 168, dicembre 1854. L’anno di morte del de Laurentiis (1854) si trova registrato an-che in G. DE’ SIVO, Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861 III, Verona 1865, p. 132.
SERENA CANNAVALE
394
dell’antica Capua e sugli anfiteatri nel mondo romano68, de Laurentiis affronta il problema della cronologia dell’edificazione del monumento ca-puano, a suo parere eretto ai tempi dell’indipendenza della città69 (come peraltro volevano già Rucca e Alvino). Segue la dettagliata descrizione del- l’anfiteatro e degli spettacoli che in esso dovevano avere luogo70, con una divagazione su altre città dell’Italia meridionale dotate di anfiteatri, nello specifico Pompei e Pozzuoli71, e una disquisizione sulla straordinaria passione per gli spettacoli dei Campani72, divenuta canonica in scritti di questo tipo a partire dal Mazzocchi73. Originale invece rispetto ai model-li precedenti l’inserzione di un breve excursus sui martiri esposti alle fiere e sulla considerazione negativa degli spettacoli da parte dei primi cristia-ni74. Una sintesi delle conoscenze sull’anfiteatro campano ai tempi del Pellegrino e del Mazzocchi75 introduce la trattazione delle recenti inda-gini svolte nell’edificio. Un momento dirimente è individuato nel 1826, anno in cui, come si è visto, furono avviati i lavori sotto la direzione di Pietro Bianchi. Sottolinea, de Laurentiis, che in tali circostanze
[...] si rinvennero nell’arena sostruzioni molto differenti a quelle, le quali anni addietro furon ritrovate nell’Anfiteatro Flavio, e che de-starono l’ammirazione, ed insieme somma contesa tra gli antiquarii romani (p. 219).
68
#Questi i temi affrontati nei primi cinque ‘capi’: I, Cenno storico sull’origine, gran-dezza e decadenza di Capua; II, Origine degli Anfiteatri presso i Romani, e quando comin-ciarono ad ergersi i medesimi; III, Si cerca di sapere, se mai i Greci innalzassero queste grandiose fabbriche. Si fa brieve motto de’ giuochi presso i medesimi: loro pubbliche fab-briche destinate per gli spettacoli; IV, Fabbriche pubbliche, spettacoli, e lusso eccessivo de’ Campani; V, Colonia di Capua.
69#Cf. Capo VI, Anfiteatro Campano da chi eretto. Ristaurato da Adriano imperadore. 70
#Capo VII, Descrizione dell’Anfiteatro Campano, e sue varie parti; VIII, Podio, ed ordine delle gradazioni; IX, Quale numero di spettatori conteneva l’Anfiteatro Campano, e regolato ordine nel sedere; X, Tende per covrir l’Anfiteatro; XIII, Numero strabocchevole delle fiere sull’arena. Naumachie, ed altri differenti giuochi; XIV, Da chi celebravansi gli spettacoli; XVI, Decadenza degli spettacoli cagionata per la debolezza de’ Cesari, e per la venuta de’ Barbari; XVII, Differenti nomi dati all’Anfiteatro Campano, e ciò che gli avven-ne ne’ secoli della mezzana età.
71#Capo XV, Città dell’Italia meridionale, che ebbero gli Anfiteatri. Si descrivono in
brieve quelli di Pozzuoli, e di Pompei. 72
#Capo XII, Da chi furono introdotti gli spettacoli. Eccesso de’ Campani pei medesi-mi. Gladiatori, e loro uffizi.
73#Cf. supra, p. 388.
74#Capo XI, Di quale cosa veniva sparsa la piazza, dove combattevano i gladiatori. Ara
in mezzo all’arena. SS. Martiri esposti alle fiere. Orrore de’ primi cristiani di assistere agli spettacoli.
75#Capo XVIII, Stato dell’Anfiteatro Campano conosciuto dal Pellegrino, e dal Mazzoc-
chi per gli scavi eseguiti.
GLI STUDI SULLA CIVILTÀ SPETTACOLARE DELL’ANTICA CAPUA NEL XIX SECOLO
395
Il nostro autore fa qui riferimento ad un tema particolarmente di-battuto nella cultura antiquaria ed archeologica del tempo76. Come è no-to, la scoperta delle sostruzioni dell’anfiteatro Flavio, avvenuta nel 1810, aveva infatti innescato una vivace polemica tra Lorenzo Re, convinto che l’arena fosse sostenuta dai muri portati alla luce dagli scavi, e Carlo Fea, che aveva invece preteso che essa fosse situata a livello del terreno e che tali muri fossero di epoca più tarda77, giungendo a parlare di «di-spendiosissimi inutilissimi sotterranei creati immaginariamente a scon-volgere tutte le idee più sicure dell’anfiteatro»78. de Laurentiis, pur ac-cogliendo le tesi di Fea in relazione al Colosseo, delinea la diversa situa-zione dell’Anfiteatro Campano, dotato di sotterranei destinati ad ospi-tare le belve feroci e macchinari utili alla riuscita degli spettacoli. La questione, già affrontata dal Rucca nella monografia del 1828, è appro-fondita da quest’ultimo qualche anno più tardi, nella Memoria Dell’uso dei sotterranei anfiteatrali, letta nel giugno 1841 presso la Reale Acca-demia Ercolanese79. Le tesi del Rucca e del de Laurentiis sostanzialmen-te coincidono. Le sostruzioni, sostiene Rucca nella Memoria, servivano «interamente ed esclusivamente ad uso degli spettacoli. Quanto rappre-sentavasi nell’Arena, tutto veniva su dall’ipogeo: tutto, macchine, bestie, gladiatori» (p. 208); lo sfruttamento dell’ipogeo rendeva possibili piog-ge di croco (p. 209 s.), naumachie e cacce in acqua di animali acquatici e terrestri (pp. 11-20); qui si ospitavano le macchine (pp. 20-25), «che producevano tutto il mirabile degli spettacoli» (p. 20), le fiere (pp. 25-28) e i gladiatori (pp. 210-220). Insomma, «l’esercizio de’ diversi uffici, a’ quali servir doveano le sostruzioni anfiteatrali, può solo dar la spiega della magnificenza e solidità di loro struttura: ed è pregio non lieve del solo anfiteatro Campano l’averle conservate nella primitiva integrità, donde riflette sugli antichi Scrittori una luce sfolgorante che mirabil-mente li rischiara» (p. 237)80.
76#L’aver ignorato tale questione era stato invece motivo di critica dell’opera del Rucca,
cf. supra, n. 43. 77#Cf. R.T. RIDLEY, Fea, Carlo, in DBI 45 (1995), s.v. 78
#Osservazioni sull’Arena, e sul podio dell’Anfiteatro Flavio, fatte dal sig. Pietro Bianchi di Lugano, illustrate e difese dal sig. Lorenzo Re romano, discusse e confutate dall’avvocato C. FEA I, Roma 1813, p. 17.
79#Pubblicata nelle «Memorie della Regale Accademia Ercolanese» IV/1 (1852), pp.
203-237. 80
#Nella stessa tornata Rucca propose anche la Memoria su l’ipogeo dell’anfiteatro pu- teolano, ivi, pp. 239-252, in cui sviluppava un confronto tra i sotterranei degli Anfiteatri Ve-ronese, Campano e Puteolano. La tesi dell’utilizzo dei sotterranei anfiteatrali da parte dei gladiatori fu ribadita dal Rucca in occasione del Settimo congresso degli Scienziati del 1845, cf. Atti della settima adunanza, p. 632. Sul tema della destinazione dei sotterranei sareb-
SERENA CANNAVALE
396
Il nuovo interesse verso il monumento, risvegliato dalla ripresa de-gli scavi e dai successivi rinvenimenti, di cui sono testimonianza le tre monografie del Rucca, dell’Alvino e del de Laurentiis, trova un’ulteriore dimostrazione nell’articolo sull’Anfiteatro campano pubblicato da Cesa-re Malpica (1804-1848) nel vol. 2, fasc. 32, del «Poliorama Pittoresco» del 1837-183881. Coerentemente con l’impostazione del periodico, volto a «istruire e dilettare nel modo più semplice»82, il capuano Malpica – che alle ‘impressioni di viaggio’, accompagnate da note storico-artistiche, aveva affidato la propria fortuna letteraria83 – prova ad immaginare una giornata di festa all’anfiteatro ai tempi della grandezza di Capua. Il ra-pido quanto superficiale schizzo della parabola storica del monumento offerto dal romantico Malpica culmina in un’enfatica contrapposizione tra lo splendore del passato e la degradata situazione attuale:
[...] ed oggi! oggi è quel immenso cumulo di marmi deformati, di archi rovinanti, di suolo sprofondato, di sassi coperti qua di bronchi e di erbe, là dalla pianta del fico selvatico che vi si abbarbica intorno. Non ha dell’antica grandezza che il pavimento esteriore, e alcune co-lonne che serbatesi in piedi ad onta degli assedi e de’ secoli, servono a far fede dell’antica sua magnificenza, e della prima sua forma84.
be intervenuto successivamente Giovanni Scherillo (1811-1878), autore di una serie di stu- di anfiteatrali pubblicati negli «Atti della Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti» tra il 1865 e il 1868 (cf. V. TROMBETTA, Indici delle riviste, in Secondo contributo, p. 530 s.), nei quali si analizzava soprattutto l’anfiteatro di Pozzuoli, senza trascurare gli op-portuni confronti con l’Anfiteatro Campano.
81#MALPICA 1837-1838.
82#Introduzione al cortese lettore, «Poliorama Pittoresco» I/1 (1836), p. 2. Sulla rivista,
vd. N. BARRELLA, Il dibattito sui metodi e gli obiettivi dello studio sull’arte a Napoli negli anni quaranta dell’Ottocento e il ruolo di «Poliorama Pittoresco», in Percorsi di critica: un archivio per le riviste d’arte in Italia dell’Ottocento e del Novecento, a cura di R. CIOFFI - A. ROVETTA, Milano 2007, pp. 21-34; R. CIOFFI - N. BARRELLA, Le riviste di cultura artistica a Napoli tra Sette e Ottocento, in Le riviste a Napoli dal XVIII secolo al primo Novecento (Atti del Convegno In-ternazionale - Napoli 2007, 15-17 novembre), a cura di A. GARZYA, Napoli 2008, p. 647 ss.
83#Cf. A. CARRANNANTE, Malpica, Cesare, in DBI 68 (2007), s.v. Icastica la descrizione
dell’attività del Malpica offerta da M. SANSONE, La letteratura a Napoli dal 1800 al 1860, in Storia di Napoli IX. Dalla Restaurazione al crollo del Reame, Cava dei Tirreni 1972, p. 503: «era insomma una specie di inviato speciale, o un precursore del De Amicis narratore di viaggi, ricco di facili impressioni e di una cultura superficiale e di facile accatto».
84#MALPICA 1837-1838, p. 250 (cf. anche Pensieri del tramonto. Prose di C. MALPICA,
Napoli 1839, pp. 119-121). All’interno di tale sconfortante quadro, l’unica nota positiva è ri-conosciuta dal Malpica nell’iniziativa del Governo di porre a guardia delle antiche rovine due uomini, ad impedire «che le sue pietre si trasportassero onde edificar le case e lastricar le strade della città. Tardo, ma non inutile riparo: che almeno l’artista e lo straniero, e tutti co-loro che amano di adorare gli avanzi d’un tempo famoso pe’ monumenti delle arti, avran do-ve posar l’occhio commosso, e sederanno fra questi marmi ad ispirarsi». Da una lettera del
GLI STUDI SULLA CIVILTÀ SPETTACOLARE DELL’ANTICA CAPUA NEL XIX SECOLO
397
La storia degli studi sugli edifici per spettacolo dell’antica Capua è, da questo momento in poi e fino all’Unità, sostanzialmente storia delle saltuarie indagini archeologiche e degli occasionali rinvenimenti, regi-strati nella documentazione d’archivio e nei periodici specializzati. Dai documenti pubblicati da Michele Ruggiero (1811-1900), apprendiamo che in quegli anni venivano riportate alla luce e, contestualmente, dan-neggiate le strutture del teatro romano. In particolare, in data 30 maggio 1839 la missiva di Francesco Cerbo, ispettore corrispondente per il terri-torio di Santa Maria Capua Vetere, a Francesco Maria Avellino (1788-1850), allora direttore del Real Museo Borbonico e Soprintendente agli Scavi di Antichità del Regno di Napoli85, registra la distruzione di strut-ture pertinenti al monumento, ricadenti al di sotto di una rotonda, posi-zionata da S. Quilici Gigli 185 m circa ad ovest dell’attuale Piazza S. Francesco86 e la conseguente asportazione da parte di privati di preziosi reperti87. Il 17 luglio dello stesso anno Cerbo si lamentava con l’Avellino dell’estrazione e dispersione di «grandissimi travertini base una volta dell’ex teatro campano»88. Qualche anno più tardi, nel 1847, in occasione degli scavi intrapresi per la realizzazione della Cavallerizza nel Quartiere
7 maggio 1841 apprendiamo che il «tardo riparo» cui Malpica fa riferimento dovette rivelarsi ben presto assai poco utile, o comunque insufficiente, se il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni Santangelo doveva intervenire presso l’Intendente di Terra di Lavoro a causa dell’«indecente modo» in cui si teneva l’Anfiteatro campano. Cf. CHILLEMI 1991-1992, p. 4 s.
85#Epigrafista, numismatico, archeologo, filologo e giurista, membro delle maggiori ac-cademie d’Europa, nel 1839 nominato da Ferdinando II di Borbone Direttore del Real Mu-seo e Soprintendente Generale agli Scavi del Regno. Nel 1842 fondò il «Bullettino Archeo-logico Napoletano». Cf. P. TREVES, Avellino, Francesco Maria, in DBI 4 (1962), s.v.; L.A. SCATOZZA HÖRICHT, Francesco Maria Avellino, in Cultura**, pp. 825-845.
86#S. QUILICI GIGLI, Strutturazione e monumentalizzazione dello spazio pubblico a Ca-
pua: il Criptoportico lungo la Via Appia, in L. QUILICI - S. QUILICI GIGLI, Spazi, forme e strutture dell’abitare, Roma 2008, p. 113.
87#«Il taglio dell’antico Teatro campano per oggetto di migliorare il regio cammino con
formare in quel sito una piazzetta rotonda, ha dato l’occasione a più persone di rinvenire in quei grottami quantità di spezzoni di diversi cornicioni d’ornato del sud.° Teatro, tutti d’orientali pregevoli marmi e specialmente di giallo e rosso antico non che una specie di marmo con fondo negro e caricato di puntine color pignuolo come porfido, per me nuovo; come pure qualche pezzetto di bronzo ed un idoletto coronato che da un soldato rinvenitore si passò ad un uffiziale di quella artiglieria [...]». Cf. RUGGIERO 1888, p. 304 s. Vd. anche RUGGIERO 1888, p. 303, documento non datato di mano del Cerbo dove pure si fa riferimen-to alla demolizione del Teatro campano.
88#Documento pubblicato da CAPALDI 2010, p. 104 s. (ASSNa VI D1, 2). BELOCH
1989, p. 350, registra inoltre che parte delle strutture del teatro furono intercettate nei lavo-ri di costruzione di Palazzo Teti, terminati nel 1869. Sull’argomento, vd. S. FORESTA, Gari-baldi, la famiglia Teti e l’archeologia dell’antica Capua, in Archeologia italiana e tedesca in Italia durante la costituzione dello Stato unitario. Atti delle giornate di studio, a cura di C. CAPALDI - TH. FRÖHLICH - C. GASPARRI, Pozzuoli 2013, pp. 93-106.
SERENA CANNAVALE
398
della Torre, vennero alla luce le sostruzioni di un settore della cavea: in da-ta 1° maggio Carlo Bonucci, architetto direttore degli scavi, era in grado di affermare che «dai ruderi nuovamente scoperti risulta che quel teatro tro-vasi in uno stato di piena degradazione e rovina», dal momento che «le cavee superiori più non esistono», mentre «pochi gradini appartenenti alla porzione più vicina all’orchestra [...] si presentano non intieri né in continuazione del semicerchio, ma con interruzione e privi in gran parte dei marmi che li decoravano»89. I resti consentono nondimeno all’ispet- tore Sideri di affermare «la sontuosità di quest’altro edifizio dell’antica Capua che ben può reggere al confronto del portentoso anfiteatro Cam-pano»90. Nonostante la consapevolezza dell’eccezionalità della scoperta, le indagini non furono proseguite per motivi economici:
D’altronde gli scavi ulteriori offrirebbero difficoltà e spese consi-derevoli ... la strada regia che fiancheggia i detti antichi gradini sco-verti e sotto della quale corrisponde la continuazione dell’emiciclo (se tuttavia esiste) dovrebbe essere interrotta, e la grande strada rifatta più in là ed alimentata altrimenti91.
Addirittura Poerio, nel marzo del 1848, suggeriva di «rimettere le co-
se nel loro pristino stato, là dove erano stati rinvenuti i resti del teatro»92. Mentre nel 1851 nuovi scavi, che si protrassero però solo pochi me-
si, venivano avviati presso l’anfiteatro campano93, nel 1852 Raffaele
89#Cf. RUGGIERO 1888, p. 310. Carlo Bonucci, nato a Napoli nel 1799 e morto nella mede-
sima località nel 1870, fu nominato «architetto direttore funzionante del Real Museo Borboni-co con la direzione de’ reali scavi di Pompei, Ercolano, Pozzuoli, Capua, Pesto, ecc.» il 28 apri-le 1844, confermato il 10 maggio 1847. Ad Ercolano diresse gli scavi per il recupero dell’antico Teatro, come ricorda orgoglioso egli stesso: «io potei così compiere la scoverta del più vasto e considerevole teatro dell’antichità pervenuto quasi intatto ai nostri giorni» (C. BONUCCI, Erco-lano, Napoli 1835, p. 20). Su questa figura vd. A. VENDITTI, Bonucci, Carlo, in DBI 12 (1971), s.v.; L.A. SCATOZZA HÖRRICHT, Carlo Bonucci, in Secondo contributo, pp. 163-173.
90#Cf. Archivio di Stato di Napoli, Ministero della Pubblica Istruzione 324, I, 4, pub-
blicato in CAPALDI 2010, p. 106, n. 46. Vd. anche RUGGIERO 1888, p. 312 s. 91
#C. BONUCCI, in RUGGIERO 1888, p. 310. 92
#Cf. CAMMAROTA 2000, p. 176. Cf. anche il documento del 1849 ricordato in RESCI-GNO - SAMPAOLO 2009, p. 37, n. 21. In quegli stessi anni, tra il 1847 e il 1848, fu affrontato il problema del restauro e della messa in sicurezza dell’Anfiteatro Campano, che versava in precarie condizioni: la vicenda è ricostruita da CASIELLO 2000, pp. 89-92.
93#Gli scavi, avviati nell’anfiteatro campano il 4 ottobre 1851 e conclusisi il 6 aprile
1852, portarono alla scoperta di alcuni frammenti architettonici delle decorazioni e di un condotto che recingeva esternamente l’edificio, interpretato dall’architetto Ulisse Rizzi come canale di scolo delle acque piovane: cf. U. RIZZI, Relazione dei nuovi scavi eseguiti nell’Anfi- teatro Campano, «Bullettino Archeologico Napolitano» n.s. I/8, ottobre 1852, p. 62 s.; RUG-GIERO 1888, p. 299 s.; G. FIORELLI, Sulle scoverte archeologiche fatte in Italia dal 1846 al 1866, Relazione al Ministro della Pubblica Istruzione, Napoli 1867, p. 55.
GLI STUDI SULLA CIVILTÀ SPETTACOLARE DELL’ANTICA CAPUA NEL XIX SECOLO
399
Garrucci (1812-1885)94 pubblicava sul «Bullettino Archeologico Napo-litano», della cui nuova serie (1852-1858) fu direttore insieme al Miner-vini95, un’epigrafe significativa per la ricostruzione della storia del tea-tro: si trattava della futura CIL X 3782 = I2 685, rinvenuta in località S. Prisco e ora conservata al Museo Archeologico di Napoli96. Databile al 108-105 a.C., l’epigrafe riguarda una fase dell’attività costruttiva avviata dai magistri relativa alla cavea e alla destinazione dei suoi diversi setto-ri97. Garrucci richiamava in quella sede anche il teatro ricordato nel- l’iscrizione del pagus herculaneus trovata a Recale (futura CIL X 3772 = I2 682), già commentata dal Mazzocchi98, deducendo dalla lontananza dei luoghi di rinvenimento il riferimento a due diverse strutture spetta-colari. La nuova iscrizione consente allo studioso di rilevare la precocità degli edifici teatrali campani, edificati quando ancora a Roma, secondo la testimonianza di Livio (perioch. XLVIII), i teatri di pietra venivano considerati «inutili e perniciosi ai pubblici costumi»99.
Pochi mesi più tardi, il «Bullettino» accoglieva un articolo di Mi-nervini, che informava circa un frammento di iscrizione rinvenuto pres-so l’antico teatro di Capua100. L’archeologo coglie l’occasione per anno-tare che
I recenti scavi ci danno una più chiara idea di questo nobilissimo edifizio, novello argomento della splendidezza dell’antica Capua. Il rivestimento di marmo tuttora visibile in alcuni de’ gradi, frammenti di colonne di marmo cipollino, ed alcuni pezzi anche di marmo con ornati e fregi di assai fino gusto, sono una valida dimostrazione della magnificenza dell’opera.
94
#Studioso di epigrafia latina e italica, di numismatica e di archeologia, membro ordi-nario dell’Instituto di corrispondenza archeologica in Roma dal 1851, socio di prestigiose accademie italiane e europee, fu coinvolto in un’aspra polemica con Theodor Mommsen. Su di lui cf. C. FERONE, Garrucci, Raffaele, in DBI 52 (1999), s.v., con bibliografia precedente, nonché gli scritti dello stesso Ferone riuniti in ID., Opuscula III. Lo studio delle Antichità clas- siche nel Mezzogiorno d’Italia. Scritti su Raffaele Garrucci, a cura di A. RUSSI, San Severo 2013.
95#Cf. TROMBETTA 1991, p. 350.
96#Cf. GARRUCCI 1852, pp. 13-15.
97#Su questa, e le altre iscrizioni inerenti l’attività dei magistri campani in relazione al
teatro, vd. L. CHIOFFI, Quando fu costruito l’anfiteatro campano? Edifici per spettacolo dalle epigrafi di Capua, «Orizzonti» I (2000), pp. 67-82.
98#MAZZOCCHI 1797, pp. 164-168; poi riproposta anche in F. DANIELE, Monete anti-
che di Capua, Napoli 1802, p. 101 ss. 99
#GARRUCCI 1852, p. 14. Sull’argomento, vd. CHIRICO - CANNAVALE 2009, p. 65 s. 100
#G. MINERVINI, Frammento d’iscrizione presso l’antico teatro di Capua: con osserva-zioni del Conte Borghesi, «Bullettino Archeologico Napolitano» n.s. I/5, settembre 1852, p. 38 s. L’iscrizione corrisponde a CIL X 3845 ed è databile al II-III secolo d.C.
SERENA CANNAVALE
400
È ancora Minervini, dalle pagine del «Bullettino Archeologico Na-politano» del luglio 1858101, a dare la notizia della ripresa degli scavi presso l’Anfiteatro, dopo la parentesi del 1851-1852102:
Ora ci gode l’animo di annunziare che in questo anno sono stati gli scavi riattivati; essendosi diretti particolarmente i lavori alla parte orientale, per proseguire la scoperta de’ sotterranei trafori, dalla qua-le verrà, a nostro avviso, non poca luce sulla destinazione e sull’uso delle sostruzioni, e de’ vasti corridoj che lor fanno continuazione.
Dopo aver illustrato diversi frammenti rinvenuti in loco, Minervini
concludeva il contributo con il seguente auspicio:
[...] vogliamo augurarci che si proseguano al più presto i lavori fe-licemente ricominciati: affinché si vegga una volta in tutta la sua am-piezza interamente scoperto uno de’ più nobili monumenti di queste nostre regioni. L’anfiteatro Campano, liberato dalle terre che intorno intorno lo circondano, apparirà in tutta la maestosa bellezza delle sue colossali forme.
Sarebbe purtroppo rimasto, per numerosi decenni, solo un auspi-
cio: appena due anni più tardi, nel 1860, gli scavi sarebbero stati sospe-si103. Dopo l’Unità, unico tra i monumenti di Terra di Lavoro l’anfitea- tro fu affidato alla Soprintendenza per la conservazione e la tutela di Na- poli con decreto regio del 17 ottobre 1869, n. 5313. Non vi si condusse-ro però scavi sistematici o restauri fino al 1927104. I reiterati tentati- vi, portati avanti tra il 1873 e il 1880 da Minervini, in qualità di vice-Presidente della Commissione Conservatrice dei Monumenti di Terra di Lavoro, di ottenere la custodia del monumento e pertanto la licenza di poter provvedere quantomeno allo sgombro delle terre che ricoprivano gran parte dei sotterranei, e tutta la cinta esteriore, furono respinti dalla direzione degli Scavi di antichità del Regno105.
101#G. MINERVINI, Nuove scavazioni all’anfiteatro Campano, «Bullettino Archeologico
Napolitano» n.s. VI/147, luglio 1858, p. 184. Cf. anche RUGGIERO 1888, p. 300 s. Una lette-ra dell’Ispettore Sideri all’Intendente preposto testimonia che gli scavi ripresero nel feb-braio del 1858: cf. CHILLEMI 1991-1992, p. 14.
102#Vd. supra, p. 398.
103#Cf. la corrispondenza tra il Prefetto di Caserta e il Ministro dell’Interno (lettere del
18 novembre e del 6 dicembre 1865) pubblicata in POLI CAPRI 2002, III, p. 354 e p. 357. 104
#Nelle «Notizie degli scavi» pubblicate tra il 1876 e il 1927 si registrano solo occasio-nali rinvenimenti di materiale architettonico e ornamentale in fondi limitrofi al monumento.
105#Cf. «Atti della Commissione conservatrice di Terra di Lavoro» IV (1873), p. 53 ss.
e p. 116; ibid. V (1874), pp. 59-61; ibid. VI (1875), p. 25, p. 33 s. e p. 52; ibid. X (1879), p.
GLI STUDI SULLA CIVILTÀ SPETTACOLARE DELL’ANTICA CAPUA NEL XIX SECOLO
401
I lavori ripresero solo a partire dalla seconda metà degli anni ’20 del Novecento106, quando finalmente il monumento fu liberato dagli alti ammassi di terra che ne ingombravano il perimetro – frutto dello scari-co degli scavi effettuati in età borbonica – e che impedivano di apprez-zarlo appieno nella sua maestosa grandezza107. Si sarebbe dovuta atten-dere la metà del Novecento108 anche per la ripresa dei sondaggi relativi al teatro, peraltro occasionati da circostanze del tutto fortuite, con l’atti- vità del Carettoni e del de Franciscis109.
In estrema sintesi, mi sembra che le vicende ripercorse in questo studio consentano di concludere che con il tramonto delle Regno delle due Sicilie si chiudeva una fase significativa della storia delle indagini, archeologiche ed antiquarie, sugli edifici per spettacolo dell’antica Ca-pua: una fase da un lato contraddistinta dagli scavi all’anfiteatro campa-no e dal conseguente impulso agli studi sul monumento, dall’altro para-dossalmente coincidente con la progressiva scomparsa del teatro, ancora visibile nei primi decenni dell’Ottocento ma successivamente destinato
45 e p. 55; ibid. XI (1880), p. 12; Archivio storico del Museo Campano 608/41. Si veda an-che la corrispondenza tra Gallozzi e Fiorelli datata 1875 e relativa all’Anfiteatro campano pubblicata in POLI CAPRI 2002, V, p. 753; VI, p. 774; 806-809; 847-849.
106#Un incremento dell’attenzione verso questo sito si registra negli anni 1910-1912: sul
«Giornale d’Italia» n. 79 del 29 giugno 1910 si legge che una Commissione formata dagli on. Enrico Morelli, Manfredo Manfredi e dal prof. Ernesto Papa ha incontrato il comm. Corrado Ricci, direttore generale per le Antichità e Belle Arti, per proporre lavori di ‘inro-bustamento’ della antiche strutture; lo stesso Papa aveva infatti elaborato, in collaborazione con la Soprintendenza di Napoli, un progetto completo di sterro, rafforzamento di fabbri-che e di riordinamento, a seguito del quale Ricci fece eseguire alcuni saggi: cf. E. PAPA, L’anfiteatro Campano in S. Maria Capua Vetere, «Arte e storia» 21/11 (1912), pp. 329-333; ma il degrado del monumento veniva ancora denunciato da Muzio NOVELLI in due articoli, apparsi l’uno su «Emporium» XXXVI/214 (1912), p. 293 (L’anfiteatro Campano nella storia e nel tempo) e l’altro su «Il Mattino» 116, 23-24 aprile 1913, p. 13 (Un superbo monumento abbandonato: l’Anfiteatro Campano), dai quali si ricava peraltro che il Governo d’Italia, do-po averlo dichiarato Monumento Nazionale, l’avrebbe circondato d’un «brutto muro» che l’avrebbe sottratto ancor di più alla vista dei viandanti (cf. ancora lo stesso M. NOVELLI in «La Lettura» del 1927, pp. 529-532, in part. 530).
107#A. MAIURI, Lavori di restauro della Soprintendenza alle antichità della Campania
nel biennio 1927-28, «BA» VIII (1928-1929), p. 555 s.; MAIURI 1937b, p. 171 ss.; SAMPAO-LO 1997, p. 12.
108#Va registrato che nel corso di lavori effettuati dal Genio militare nel cortile del
Quartiere nuovo nei mesi di agosto e settembre del 1887 tornarono alla luce alcuni ruderi del teatro e oggetti di marmo e terracotta pertinenti al monumento, poi trasferiti presso il Museo Campano: cf. A. SOGLIANO in «Notizie degli Scavi» (1888), p. 64 ss.
109#Nel febbraio del 1942 nel corso di lavori di fognatura nel cortile della Caserma I
Ottobre fu intercettato fortuitamente un settore della cavea. Da qui nacque lo spunto per ulteriori indagini: cf. G. CARETTONI, Elementi di un edificio teatrale nella Caserma «1° Ot-tobre 1860», «NSA» (1943), pp. 149-154; A. DE FRANCISCIS, Capua, Santa Maria Capua Ve-tere, «Fasti Archeologici» V (1952), p. 354 s.
SERENA CANNAVALE
402
ad essere irrimediabilmente danneggiato e poi addirittura sottratto alla pubblica percezione.
SERENA CANNAVALE Seconda Università di Napoli
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE ALVINO 1833 = F. ALVINO, Anfiteatro campano ristaurato ed illustrato, Napoli
(ed. rivista e ampliata 1842). Atti della settima adunanza = Atti della settima adunanza degli scienziati italia-
ni, tenuta in Napoli dal 20 di settembre a’ 5 di ottobre del MDCCCXLV, Napoli 1846.
BELOCH 1989 = J. BELOCH, Campania. Storia e topografia della Napoli antica e dei suoi dintorni, a cura di C. FERONE - F. PUGLIESE CARRATELLI, Napoli (trad. it. di J. BELOCH, Campanien. Geschichte und Topographie des anti-ken Neapel und seiner Umgebung, Breslau 1890).
CAMMAROTA 2000 = D. CAMMAROTA, Per una storia degli scavi dell’800 nel- l’antica Capua: contributi dalla documentazione d’archivio, «Orizzonti» I, pp. 173-179.
CAPALDI 2010 = C. CAPALDI, Una nuova attestazione dell’evergetismo edilizio di Augusto a Capua, in Il Mediterraneo e la storia. Atti dell’incontro inter-nazionale di studio, Napoli 4 e 5 dicembre 2008, Napoli, pp. 95-118.
CASIELLO 2000 = S. CASIELLO, Restauri in Campania nella prima metà dell’Ot- tocento, in Beni culturali a Napoli nell’Ottocento, Roma, pp. 81-92.
CECERE - RENDA 2012 = I. CECERE - G. RENDA, Immagini dell’Anfiteatro Cam-pano tra arte e archeologia: disegni, vedute e incisioni del Settecento e del- l’Ottocento, «Orizzonti» XIII, pp. 83-100.
CHILLEMI 1991-1992 = R. CHILLEMI, Anfiteatro e antichità capuane in vecchie carte d’archivio, «Capys» 24-25, pp. 3-18.
CHIRICO - CANNAVALE 2009 = M.L. CHIRICO - S. CANNAVALE, La via dei tea-tri nella Campania settentrionale, in Lungo l’Appia. Scritti su Capua antica e dintorni, a cura di M.L. CHIRICO - R. CIOFFI - S. QUILICI GIGLI - G. PI-GNATELLI, Napoli, pp. 65-76.
CORLÀITA SAGLIARINI 1977 = D. CORLÀITA SAGLIARINI, Viaggio archeologico tra Capua Vetere ed Aquino in un quaderno di Giuseppe Bossi, «Prospetti-va» 9, pp. 38-54.
Cultura*-**= La cultura classica a Napoli nell’Ottocento. Premessa di M. GI-GANTE, ‘Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica dell’Univer- sità degli Studi di Napoli Federico II’ 1*-**, Napoli 1987.
D’ALCONZO 1999 = P. D’ALCONZO, L’anello del Re. Tutela del patrimonio storico-artistico nel Regno di Napoli (1734-1824), Firenze.
GLI STUDI SULLA CIVILTÀ SPETTACOLARE DELL’ANTICA CAPUA NEL XIX SECOLO
403
FRIELLO 2008-2011 = A. FRIELLO, Aspetti della tutela e del restauro in età bor-bonica. L’anfiteatro campano, «RAAN» n.s. LXXV, pp. 181-209.
GARRUCCI 1852 = R. GARRUCCI, Iscrizioni di Capua (S. Maria), «Bullettino ar-cheologico napolitano» n.s. I/2, luglio, pp. 13-15.
GRANATA 1752 = G. GRANATA, Storia civile della fedelissima città di Capua, Napoli.
JOHANNOWSKY 1989 = W. JOHANNOWSKY, Capua antica, Napoli. MAIURI 1937a = A. MAIURI, Gli studi di antichità a Napoli nel Sette e Ottocen-
to, «RAAN» XVII, pp. 31-57 (rist. in Itinerario Flegreo, Napoli 1983, pp. 11-28).
MAIURI 1937b = A. MAIURI, Le ultime vicende dell’Anfiteatro di S. Maria Ca-pua Vetere, «RAAN» XVII, pp. 171-177.
MALPICA 1837-1838 = C. MALPICA, L’anfiteatro campano, «Poliorama pitto-resco» II/32, p. 249 s.
MAZZOCCHI 1797 = A.S. MAZZOCCHI, In mutilum Campani amphitheatri titu-lum aliasque nonnullas Campanas inscriptiones commentarius, editio se-cunda auctior, Neapoli (17271).
POLI CAPRI 2002 = Pompei, Ercolano, Napoli e dintorni, Lettere e documenti, a cura di P. POLI CAPRI, I serie, Roma.
PRATILLI 1745 = F.M. PRATILLI, Della Via Appia riconosciuta e descritta da Ro- ma a Brindisi, Napoli.
RESCIGNO - SAMPAOLO 2009 = C. RESCIGNO - V. SAMPAOLO, Capua: una città al doppio, in Terra di Lavoro: i luoghi della Storia, a cura di L. MASCILLI MIGLIORINI, Avellino, pp. 1-42.
RUCCA 1828 = G. RUCCA, Capua Vetere, o sia Descrizione di tutti i monumenti di Capua antica e particolarmente del suo nobilissimo anfiteatro, Napoli.
RUGGIERO 1888 = M. RUGGIERO, Degli Scavi di Antichità nelle Province di Terraferma dell’Antico Regno di Napoli dal 1743 al 1876, Napoli.
SAMPAOLO 1997 = V. SAMPAOLO, L’Anfiteatro Campano, in L. SPINA (ed.), L’Anfiteatro Campano di Capua, Napoli, pp. 12-21.
Secondo contributo = La cultura classica a Napoli nell’Ottocento. Secondo contri-buto. Premessa di M. GIGANTE, ‘Pubblicazioni del Dipartimento di Filolo-gia Classica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II’ 4, Napoli 1991.
TROMBETTA 1986 = V. TROMBETTA, Una pagina di storia dell’Anfiteatro Cam-pano (documenti d’archivio), «Capys» 19, pp. 81-96.
TROMBETTA 1991 = V. TROMBETTA, La conoscenza dell’antico e gli strumenti di divulgazione. Indici delle riviste napoletane di archeologia, in Secondo contributo, pp. 329-533.