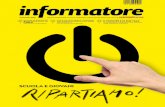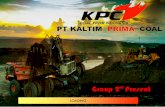Firenze insurgent city, prima parte
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Firenze insurgent city, prima parte
I materiali qui presentati derivano da una ricerca svolta all’interno del Lapei
(Laboratorio di progettazione ecologica degli insediamenti) del Dipartimento di
Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell’Università di Firenze.
Coordinamento della ricerca: Giancarlo Paba
Gruppo di lavoro: Giovanni Allegretti, Marvi Maggio, Anna Lisa Pecoriello, Camilla
Perrone, Daniela Poli, Francesca Rispoli, Lorenzo Tripodi
Progetto grafico e cura editoriale: Manuela Conti, Lorenzo Tripodi
I materiali pubblicati sono no-copyright. Essi possono essere liberamente diffu-
si, senza fini commerciali e con citazione della fonte.
I N S UR G EN TC I T YR A C C O NT I E GE OGR A FI E D I U N’ A L T R A FI R EN Z E
2
contenuti
1
3456
4CONTESTED PLACES
RACCONTI E GEOGRAFIE DI UN’ALTRA FIRENZEGiancarlo Paba
71
81
105
119
10FIRENZE ‘INSURGENT CITY’?Marvi Maggio, Anna Lisa Pecoriello, Francesca Rispoli, Lorenzo Tripodi
GEOGRAFIE URBANE, NETWORK COLORATI, NUOVE PRATICHE SOCIALICamilla Perrone
POCO FIUME E MOLTI PONTI
LA CITTÀ LETTA DAL MARGINE, ATTRAVERSO LO SGUARDO DEI SUOI
OSPITI-COSTRUTTORI
Daniela Poli
GENTE DELL’ISOLOTTO
Giovanni Allegretti
GENIO E SREGOLATEZZA: I MOMENTI-SPAZIO DELLA TRASGRESSIONE
COME UN ‘DIAVOLO IN CORPO URBANO’Giovanni Allegretti
LA CITTÀ CANCELLATA
LA CITTÀ INSURGENT
Contested spaces/centri sociali: mappa
PIAZZA SANTO SPIRITO
16
19
22
24
MOVIMENTO DI LOTTA PER LA CASA
I luoghi storici della sinistra nel quartiere di Santa Croce: mappa
DISCONTINUITÀ
CASE OCCUPATE, LABORATORI DELLA DIVERSITÀ:
L'ESPERIENZA DI VIA ALDINI
32
38
39
44
CSA EX EMERSON
CPA
AGGIORNAMENTI
50
60
70
Le case occupate: mappa 43
Francesca Rispoli
Marvi Maggio
Marvi Maggio
Marvi Maggio, Francesca Rispoli, Lorenzo Tripodi
Anna Lisa Pecoriello
Marvi Maggio
Lorenzo Tripodi
Marvi Maggio
138
132
142
144
147
150
152
156
160
164
167
170
173
177
179
183
186
188
190
194
198
130
Un quotidiano dissociato
7Intervista a Piero Colacicchi, coordinatore dell’Associazione Diritti delle Minoranze
Intervista a un graffitista rom
Anche noi possiamo contribuire a rinnovare questa citta'
Intervista a un bancarellaio brasiliano regolare
Un sognatore su strada
Intervista a un “marchettaro” brasiliano
Sprecare l’Arno, dandogli le spalle
Il centro è un buco neroIntervista a un lavavetri marocchino
Attraverso le crisi: ridare un senso al mio viaggio
Intervista a una domestica filippina
Firenze: uno sguardo esterno, dal limite
Intervista a un operaio albanese
L’ombelico del mondo
Siamo anche corpi e non solo braccia
Intervista a due immigrati rumeni
La periferia è un villaggio
La città ha un senso di marcia
Intervista a un bancarellaio senegalese
Scontento e contestatore: verso un sindacalismo informale
Intervista a un operaio senegalese
Una città di archi e porte di vetro
Conversazione con la gestrice di una rosticceria indiana
Una ‘via larga’ per la fede
Restituzione di una conversazione ‘corale’ con cinque rappresentanti della comunità islami-
ca di via Ghibelli na, di diverse nazionalità.
Ascoltare la città
Intervista a un g r i o t del Burkina Faso
La casa è un diritto
Intervista a Lorenzo del Movimento di lotta per la casa a cura di Marvi Maggio
Autocostruzione o autorecupero?Intervista a Dario di via Aldini a cura di Anna Lisa Pecoriello
Centro Popolare Autogestito
intervista a Edoardo del CPA a cura di Marvi Maggio e Francesca Rispoli
La civetta Lepolda e una geografia ipersensibile
Riorganizzazione di un’intervista ad un attivista e un’attivista di ‘Azione Gay e Lesbica’
a cura di Giovanni Allegretti
Il Territorio della prostituzione a Firenze: oltre il concetto di
confine amministrativo
Conversazione con alcuni operatori del C.I.P. e con la mediatrice culturale nigeriana della
cooperativa C.A.T a cura di Giovanni All egretti.
Intervista a un giovane rom
Intervista a un ambulante e maratoneta kenyota
Intervista a un ambulante senegalese
ATLANTE DI VOCI
a cura di Lorenzo Tripodi
Interagire con i ‘figli del ghetto’
4
1. “UNA MACCHINA PERVERSA DI BELLEZZA”
“La città, popolata da due categorie di persone, gli affaristi e le loro vittime, è abitabile [...]
in maniera dolorosa, disturbante ogni indole naturale, col tempo perturbante e devastante,
molto spesso unicamente subdola e micidiale. Da un lato le esasperate condizioni atmosfe-
riche, irritanti, snervanti e comunque ammorbanti per chi vive nella città, e dall’altro l’ar-
chitettura, che in queste condizioni atmosferiche ha effetti sempre più disastrosi sulla
costituzione di questa gente [...], un clima che produce in continuazione, con incredibile irri-
guardosità, siffatti abitanti irritanti e snervanti e ammorbanti e umilianti e urtanti, dotati
di grande volgarità e bassezza. [...] Colui che sia cresciuto in questa città [...], colui che fin
dall’infanzia più remota, con grandissima disponibilità emotiva e intellettuale per questa
città, sia stato incapsulato da un lato nel vistoso evolversi della sua fama mondiale come in
una macchina perversa di bellezza, macchina bugiarda che produce vero denaro e finto
denaro [...], costui non può far altro che conservare un ricordo tremendo [...] della città e
delle condizioni di vita in questa città [...], una città che da sempre ferisce, esaspera e
comunque annienta qualsiasi personalità creativa. [...] Per colui che tenta di trovare equili-
brio e giustizia in questa città che in ogni parte del mondo gode fama soltanto di bellezza
e nobiltà, e [...] della fama derivata dall’arte, la cosiddetta Grande Arte, essa, la città, ben
presto non risulta altro che un freddo museo di morte, esposto a malattie e bassezze di ogni
genere, e in questa città si ingigantiscono per lui tutti gli ostacoli immaginabili e inimmagi-
nabili, i quali spietatamente devastano e profondamente ledono le sue energie e le sue doti
e attitudini spirituali; ben presto dunque la città, per lui, non è più una bella natura e un’e-
semplare architettura, ma nient’altro che un groviglio umano impenetrabile di volgarità e di
bassezza, ed egli non cammina più in mezzo [all’arte] quando passa per le strade della città,
ma è soltanto disgustato dal pantano morale in cui sono immersi i suoi abitanti.”
(Thomas Bernhard, L’origine, Adelphi, Milano, 1982, pp. 9-13)
L’i nvettiva di Thomas Bernhard, nella citazione che apre questo scri tto, è rivolta naturalmente a Salisburgo. Sono state neces-
sarie poche correzioni nella forma per adattarla a Firenze e nessuna correzione sarebbe davvero necessaria nel la sostanza.
Firenze è diventata anch’essa “una macchina perversa di bellezza” e di morte dell’anima. Ed è soprattutto, per una parte
importante dei suoi cittadini vecchi e nuovi, una macchina di sofferenza materiale, e di difficile e contrastata sopravviven-
za. L’atmosfera mortale - per la comunione del clima e della devastazione ambientale - la rende nociva, il contrasto tra cen-
tro e periferia la rende bugiarda e bi fronte, il dominio del commercio e del denaro la rende cinica e crudele, lo sfruttamento
parassitario della cultura antica e la crisi della cultura contemporanea la rendono sterile e opaca, l’avarizia materiale e men-
tale delle sue classi dirgenti la rende spesso ostile e non accogliente.
Come nella Salisburgo di Bernhard la scena pubblica fiorentina riflette il degrado fisico-ambientale della città: stanche azio-
ni di governo, sceriffi e “securizzatori” accaniti, imbonitori e modiste, registi e comici di regime, cantanti ex-alternativi ven-
duti e imbolsiti, teatri sclerotizzati e teatrini che riciclano show televisivi, in generale culture fossili e ortogonali alla speri-
mentazione e al coraggio critico.
La macchina perversa di bellezza di Firenze - “ freddo museo di morte” - è rappresentata in mille mappe e in mille guide in
modo adeguato. Iper-rappresentata: un’i nflazione di immagini e racconti, di camere con vista, di viste convenzionali e bana-
lizzate: vera alluvione terminale, e deserto di significato, della comunicazione di Firenze nel mondo.
La nostra ricerca ha ignorato questa figura della città del l’arte e del commercio culturale - solo qualche accenno vi è dedi-
cato - e si è rivolta invece alla ricostruzione di qualche parte dell’altra geografia di Firenze: una geografia interstiziale,
nascosta, fluida, mutevole, e tuttavia attiva, densa, creativa, la contro-geografia di un’altra Firenze, di una città nascente,
emergente, mescolata a quella esistente, dentro e contro la città esistente. Semmai questa geografia si ricollega alla gran-
de linea storica sotterranea della Firenze delle lotte sociali e di popolo, e della resistenza al potere e al conformismo cultu-
rale, da Savonarola a Enzo Mazzi, da don Milani a Ernesto Balducci, dalla rivolta dei Ciompi alle lotte della Firenze operaia,
dai movimenti giovanili del dopoguerra alle iniziative di base della comunità delle Piagge, fino alle mille altre manifestazio-
ni e figure, insofferenti e inquiete, della storia fiorentina recente e lontana.
CONTESTED PLACES
RACCONTI E GEOGRAFIE DI UN’ALTRA FIRENZE
Giancarlo Paba1
5
2. INSURGENT CITY
“Molti abbandoneranno le proprie abitazioni, e porteran con seco tutti e sua valsenti, e
andranno abitare in altri paesi.”
(Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, 370 v.a)
“L’esuberanza di vita […], la tendenza ad arrampicarsi verso l’alto, per cogliere più energia
di quella necessaria alla sopravvivenza, correndo rischi, compiendo salti avventurosi, col-
locando la bandiera della vita su qualche montagna più alta, prima di cercare di nuovo sicu-
rezza – alla fine la morte – nella valle sottostante.”
(Lewis Mumford, The Conduct of Life, Secker & Warburg, 1952, p. 38)
“L’esagerazione è nel corso delle cose. La natura non manda nel mondo nessun essere, nes-
sun uomo, senza aggiungere un piccolo eccesso della stessa specifica qualità. Dato il piane-
ta occorre aggiungere l’impulso; cosicché la natura aggiunse per ogni essere uno scatto di
violenza di direzione sul suo particolare sentiero, una spinta per metterlo sul suo cammino;
in ogni esemplare un di più di generosità, una goccia di troppo. Senza elettricità l’aria si cor-
romperebbe, e senza questa violenza di direzione che hanno in sé uomini e donne, senza
un pizzico di ostinazione e di fanatismo, non avremmo né incentivo, né efficienza. Dobbiamo
mirare al di sopra del segno, per colpire nel segno. Ogni atto ha in sé una qualche falsità di
esagerazione.”
(Ralph Waldo Emerson, Nature, 1844)
Definiamo spesso nel testo quest’altra Firenze come insurgent city, ed è necessario qualche chiarimento sul signi ficato che
viene dato a questa espressione, e più in generale alla parola i n s u r g e n t. James Holston ha denominato qualche anno fa “spa-
ces of insurgent citizenship” 1 gli spazi sottratti al dominio moderno e pianificato della città. Secondo Holston essi “includo-
no i l territorio dei senza casa, le reti dei migranti, i quartieri dell’appartenenza omosessuale, le peri ferie autocostruite [...] ,
le g a n g l a n d s, i condomini fortificati, i luoghi dell’ autoproduzione, gli insediamenti degli s q u a t t e r s, i campi suburbani degli
stranieri, i s w e a t s h o p se le cosiddette zone del nuovo razzismo” 2. Holston considerainsurgent tutti gl i spazi nei quali si svol-
gono pratiche che “disturbano le storie consolidate” della città moderna. Si tratta per i nostri fini di un’accezione forse trop-
po vasta e internamente contraddittoria, comprendendo insieme i luoghi di opposizione creativa e i luoghi di nuovo sfrutta-
mento e degrado.
Più vicina al nostro punto di vista è la ripresa del l’espressione da parte di Leonie Sandercock in un numero recente della rivi-
sta Plurimondi da lei curato. Sandercock chiama “ insurgent planning practices” le iniziative di pianificazione e di resisten-
za/trasformazione che si oppongono alla città esistente (alla sua struttura organizzativa e di potere) e nello stesso tempo
positivamente costruiscono i primi congegni di una città alternativa e differente. Friedmann collega queste iniziative alla
dinamica delle cittadinanze in espansione, ad un allargamento progressivo degli spazi di democrazia3. Le nuove cittadinan-
ze creano un contesto plurale e creativo, una vera e proprio m u l t i p l i / c i t y, all’interno della quale diventano praticabili forme
di utopia concreta, a c h i e v a b l e, per una più completa fioritura degli esseri umani4.
Pur tenendo conto di questi contributi più recenti, il termine insurgent mantiene tuttavia per noi un campo di risonanze più
antico, ma ancora suggestivo, ed è per questo che preferiamo non tradurlo (emergente, insorgente, e traduzioni simili, impo-
verirebbero e renderebbero banale questo campo di significati). In particolare è alla central ità di questa espressione nel pen-
siero del grande planner scozzese dei primi anni del Novecento Patrick Geddes (e alla declinazione di quel concetto negli
scritti di Lewis Mumford) che facciamo riferimento. Sul pensiero di Geddes è forse possibile fondare una sorta di in s u r g e n t
u r b a n i s m: come idea di trasformazione della città capace di mettere in moto “the forward movement of life” , il movimento
in avanti del la vita, “ its insurgence and its expectancy” 5. I n s u r g e n c e, ha scritto Mumford, è appunto la “capacità di supera-
re, attraverso il potere o l’astuzia, attraverso il piano o il sogno, le forze che minacciano l’organismo” 6. Le pratiche indivi-
duali e collettive insurgent sono un dato biologico ed esistenziale, prima che poli tico; sono per noi la manifestazione ele-
mentare del diritto alla vita e alla città dei suoi abitanti più poveri e deprivati.
I n s u r g e n t, nel senso che abbiamo qui precisato, sono quindi i movimenti stessi dei corpi in città, degli organismi che voglio-
no sopravvivenza e speranza di futuro. I movimenti molecolari: le traiettorie dei corpi nella scena pubblica della città, alla
ricerca di occasioni di vi ta e di felici tà; i movimenti associati: le interazioni tra i corpi, l’aiuto reciproco, la solidarietà nell’a-
micizia e nel lavoro comune; le reti organizzate di resistenza e di azione: il radicamento delle nuove comunità nello spazio,
nel processo di costruzione o trasformazione dei luoghi e degl i insediamenti .
Al centro del nostro racconto abbiamo quindi collocato le pratiche di vita dei nuovi cittadini, le piccole antropologie del quo-
tidiano, le storie o le microstorie individuali e di gruppo, i vissuti personal i o col lettivi. Per utilizzare di nuovo una metafora
geddesiana, abbiamo cercato di ricostruire qualche ramificazione del web of life, del reticolo di vita, delle nuove cittadinan-
ze in espansione nei territori di Firenze.
Insurgent city non è quindi città sovversiva o rivoluzionaria (non è così Firenze, non sono così oggi le città i tal iane, che lo si
desideri o meno). È però campo di forze, tensioni, desideri, conflitti , aspirazioni. È l’insieme di azioni compiute o parziali di
trasformazione, di piccole utopie realizzate o di semplici gesti di sopravvivenza, di manifestazioni di resistenza e di lotta,
di conquiste individuali o collettive, di micropoteri diffusi (“ thousand of tiny empowerments” , per riprendere ancora una
volta una definizione di Sandercock7). I n s u r g e n tnon è soltanto l’azione antagonista, algebricamente negativa, rovesciamen-
to meccanico che contesta e nello stesso tempo legittima l’ ordine sociale (e spaziale) costituito. Le pratiche sociali i n s u r g e n t
sono invece il risultato di intenzionalità collettive positive, progettuali, costruttive: esse trasformano l’antagonismo in pro-
6
tagonismo. Pratiche che stanno su un altro piano, su altri mille piani, indifferenti al mondo tradizionale della lotta politica, e
delle ideologie. Pratiche “ impolitiche” , spesso cattive e bastarde, in qualche misura, e forse proprio per questo le sole effi-
cacemente politiche.
3. LO SPAZIO DEI PUNTI DI VISTA
L’ intenzione originaria della ricerca era quella di costruire un vero e proprio atlante della città, in particolare della sua nuova
morfologia sociale. Esistono molti modi di intendere la costruzione di un atlante. Un modo, possiamo dire classico, è quello di
raggrumare in immagini compatte e definite le conoscenze consolidate di qualche porzione di mondo o di società. L’atlante
fissa in questo modo il territorio conosciuto, la terra cognita, in una figura unitaria e condivisa. Questa modalità di rappre-
sentazione presuppone l’ unità e la stabi lità del mondo, e l’univocità del punto di vista. Essa implica che il tempo dell’esplo-
razione sia finito, e che la funzione di sanzione del possesso e del comando, implicita in ogni geografia, prevalga su quella
della conoscenza e dell’azione. Materialmente alla fine questo tipo di atlante è un prodotto organico, omogeneo, definito
nelle scale di rappresentazione, e nella corrispondenza biunivoca tra l’universo dei segni grafici utilizzati e l’universo dei
fenomeni reali rappresentati. Come potevamo arrivare ad una rappresentazione certa e fissa delle cittadinanze mutevoli di
Firenze e delle loro mutevoli relazioni con lo spazio? Non era questa la strada che era possibile intraprendere.
Esiste tuttavia un altro modo di intendere un atlante, ed è quello che abbiamo scelto per la nostra esperienza. Esso presup-
pone i l fatto che l’esplorazione non sia compiuta ed anzi impone che la rappresentazione sia al servizio dell’esplorazione e
della scoperta. Le “mappe” e le narrazioni - i resoconti iconografici e topografici - si riempiono di piste, di segni provvisori,
si coprono di immagini e suggestioni util i per avanzare nella terra incognita, nel territorio sconosciuto. L’atlante consolida
temporaneamente l’andamento di un percorso, quasi fosse un diario di bordo, più che la carta di orientamento di un pacifico
baedeker. Questo secondo tipo di rappresentazione ha il vantaggio di restare vicino alle cose raffigurate e alle persone rac-
contate, accostandole e mettendole in relazione senza unificarle in un dispositivo ordinato e uniforme.
Una complicazione ulteriore era costituita dal fatto che l’ oggetto della rappresentazione doveva essere proprio il mondo in
ebollizione della città i n s u r g e n t: la città delle soggettività liberate, delle cittadinanze in espansione e in movimento, un
campo fluido e dinamico, abitato da una pletora di attori e iniziative. I materiali da rappresentare non erano quindi costitui-
ti da oggetti, ma da intrecci di relazioni umane, di nuovi rapporti intersoggettivi, e dal loro difficile e controverso rapporto
con la struttura morfologica e organizzativa della città.
Abbiamo quindi pensato a un atlante plurale, polimorfo, decentrato, che puntasse a rappresentare “lo spazio dei punti di
vista” della città emergente nella sua estensione e nella sua complicazione, un atlante di voci e di relazioni, di percorsi e di
testimonianze. Ci ha guidato questa indicazione di Pierre Bourdieu, in un volume che avevamo assunto come modello (e la cui
qualità non siamo riusciti neppure ad approssimare): “per capire ciò che accade nei luoghi [...] che riavvicinano persone che
tutto separa, costringendole a coabitare, sia nell’ ignoranza o nella reciproca incomprensione, sia nel confl itto, latente o
dichiarato, con tutte le sofferenze che ne risultano, non basta rendere conto di ciascuno dei punti di vista presi in modo sepa-
rato. Bisogna anche confrontarli come sono nel la realtà [...] per fare apparire, attraverso il semplice effetto di giustapposi-
zione, ciò che risulta dallo scontro di visioni del mondo differenti o antagoniste: cioè, in certi casi, il t r a g i c o, che nasce dallo
scontro senza concessioni o compromessi di punti di vista incompatibili, perché ugualmente fondati su qualche ragione socia-
le” . Le nuove geografie urbane sono “diff icili da rappresentare e pensare” e richiedono una rappresentazione multipla e com-
plessa: “abbandonare il punto di vista unico, centrale, dominante, quasi divino, nel quale si colloca volentieri l’osservatore,
[...] a favore della plural ità di prospettive corrispondente alla pluralità di punti di vista” 8.
Al la fine di questo tentativo rimane sospesa la risposta a questa domanda: il disordine dei materiali finali del nostro lavoro
è soltanto il risultato dei limiti della nostra capacità di ricerca e interpretazione o rappresentano viceversa, almeno parzial-
mente, lo spazio dei punti di vista che abbiamo cercato di indagare?
4. EFFETTI DI LUOGO
Un altro aspetto della ricerca ha creato problemi e difficoltà. La nostra intenzione era di arrivare a definire i contorni fisici,
perfino morfologici e architettonici, della città alternativa ed emergente. Non soltanto raccontare vicende e raccogliere
testimonianze, ma anche rappresentare trasformazioni, catturare la nuova figura spaziale della città, il territorio i n s u r g e n t
di Firenze, il reticolo fisico di una nuova geografia. Pensavamo che nelle energie sociali dispiegate dalle nuove cittadinanze
ci fosse capacità di progetto e di trasformazione della città e volevamo raff igurare i risultati di questa capacità.
In realtà l’universo del le soggettività emergenti non è ancora in grado di produrre un cambiamento organico e strutturato
della città. I movimenti i n s u r g e n tsono al l’origine di modificazioni puntuali , di microtrasformazioni, e qualche volta deposi-
tano solo sintomi di presenza, lasciano tracce di percorso. Abbiamo quindi cercato di rilevare quei fenomeni che è possibile
chiamare, utilizzando ancora una volta un’espressione di Bourdieu, gli “effetti di luogo” delle nuove azioni collettive. Tenendo
conto dei molti modi di incisione del lo spazio fisico e sociale abbiamo cercato di registrare un campo molto vasto degli effet-
ti di luogo delle nuove pratiche sociali sul territorio fiorentino: cambiamenti d’uso e di funzione, processi di ri-semantizza-
zione e di ri-significazione di edifici e luoghi pubblici, creazione o ri-creazione di luoghi collettivi, “colorazione” dello spazio
urbano (dal w r i t i n g, alle modi ficazioni di arredo e di aspetto, ai suoni e ai segni della vita sociale, ai mercati e alle presenze
volanti, ecc.), riconfigurazione dei tempi urbani (una diversa organizzazione della notte e più in generale dei ritmi di funzio-
namento della città), occupazione e riorganizzazione di spazi costruiti e non, auto-ristrutturazioni, progetti partecipati,
occupazioni alternative dell’etere e dello spazio immateriale, riqualificazioni in forme autoprodotte di immobili e aree urba-
7
ne (immobili collettivi di abitazione, autorecupero di edifici e di aree per nuovi usi sociali, adozione e gestione di spazi aper-
ti, ecc.), e in qualche caso la creazione di veri e propri cantieri sociali di trasformazione della città (Isolotto per il passato di
Firenze, Piagge oggi), capaci di incidere in modo più evidente e significativo sull’organizzazione della città.
Insomma la definizione più giusta, entro la quale riassumere gli effetti di luogo delle nuove cittadinanze, è quella secondo la
quale lo spazio urbano è contested space9: spazi e luoghi del la città disputati e contesi, in particolare gli spazi pubblici, le
piazze, le strade, e in generale il territorio aperto, i parchi, i giardini, le aree marginali e di connessione, le zone e gli edifici
abbandonati. Luoghi contesi tra diverse opzioni d’uso, traiettorie di vita e di fferenti aspettative e progetti di città: Homi
Bhabha li ha chiamati third space, “spazio terzo”, interstiziale, i n b e t w e e n, nel quale si articolano le differenze e viene nego-
ziata la vita, contrattata e giocata l’ esistenza1 0.
La scelta del soggetto e del modo di costruzione della ricerca ha quindi condizionato la sua costituzione materiale, impo-
nendoci un cambiamento di rotta rispetto alle intenzioni di partenza. I contenuti di questo resoconto figurato di ricerca
nascono da sondaggi , messe a fuoco parziali, contatti e immersioni nei movimenti della città, e naturalmente da ricerche vere
e proprio su argomenti specifici, o da ricerche-azione su alcuni territori. Spesso i contenuti sono costituiti da ragionamenti
attorno a piccoli accadimenti, microfenomeni, e qualche volta naturalmente anche da indagini di fenomeni più complessi ,
incontrati nell’esplorazione della città e del lo spazio sociale. I materiali qui presentati sono costituiti da molte cose mesco-
late tra di loro: documenti iconografici in prima istanza (fotografie, carte, mappe, diagrammi, schemi interpretativi), ma
anche racconti, storie, interviste, narrazioni.
5. DALLA RESISTENZA AI CANTIERI SOCIALI
“Potentially, the list of acts of resistance is endless - everything from footdragging to wal-
king, from sit-in to outings, from chaining oneself up in treetops to dancing the night away,
from parody to passing, from bombs to hoaxes, from graffiti tags on New York trains to
stealing pens from employers, from no voting to releasing laboratory animals, from mug-
ging yuppies to buying shares, from cheating to dropping out, from tattoos to body piercing,
from pink air to pink triangles, from loud music to loud T-shirts, from memories to dreams
- and the reason for this seems to be that definitions of resistance have become bound up
with the ways that people are understood to have capacities to change things, through
giving their own (resistant) meanings to things, through finding their own tactics for avoi-
ding, taunting, attacking, undermining, enduring, hindering, mocking the everyday exercise
of power.” 11
(S. Pile, M. Keith, eds., Geographies of Resistance, Routledge, London/New York, 1997)
Qualche osservazione è necessaria per spiegare i contenuti e l’articolazione delle diverse sezioni della ricerca. Vi si trovano,
spesso incrociati, due tipi di racconto. Alcuni temi sono presenti in modo trasversale nei contributi e nelle interviste, a volte
ripetuti e riesaminati da diversi punti di osservazione. In altri materiali, relativamente ad aspetti della ricerca più circoscritti ,
vengono utilizzati modi più tradizionali di resoconto, in forma quasi di piccolo saggio o ricostruzione critica. Infine i mate-
riali iconografici e i brani di interviste costituiscono una sorta di infrastruttura della narrazione, intesi quasi come momenti
di irruzione della realtà nelle diverse parti del volume.
Scorrerò ora i contenuti della ricerca in modo libero soffermandomi sugli aspetti che mi sembrano più interessanti (magari
in disaccordo con i “miei” ricercatori). Non è possibile una classificazione ordinata e in qualche modo gerarchizzata delle
azioni e dei movimenti indagati. Non c’è logica unitaria e piani ficazione dall’alto nella città “altra” . Sarebbe quindi sbagliato
collocare i movimenti urbani e le azioni progettuali o ribelli in una linea crescente di importanza e di significato. Molte pic-
cole azioni ripetute possono avere una capacità di incisione dello spazio urbano maggiore rispetto a quella di una singola
grande iniziativa organizzata. In realtà un carattere rilevante del mondo che abbiamo esplorato è proprio la mescolanza
delle cose significative e il loro emergere imprevedibile nei diversi luoghi della città, in una semplice biografia individuale,
così come nell’esperienza politicamente gestita di un’occupazione o nella trasformazione partecipata di un immobile o un
q u a r t i e r e .
Sullo sfondo del le esplorazioni urbane rappresentate è possibile intravedere da ogni parte il profilo minaccioso della città
ostile alle nuove cittadinanze in espansione. L’abbiamo chiamata gated city: città vietata, sorvegliata, città che respinge e
si chiude nel tentativo di imbrigliamento e contenimento delle energie urbane alternative. È la città dei recinti, delle barrie-
re, dei cancelli, dei codici di accesso, del controllo remoto o ravvicinato, delle limitazioni di tempo e di spazio, del la privatiz-
zazione e della sorveglianza dello spazio pubblico. È la ci ttà che discrimina e respinge ai margini, la città della pulizia etnica
nelle vie centrali e della pulizia “ecologica” sulle sponde del l’Arno (per eliminare anche negli spazi periferici le presenze
sociali ritenute pericolose). È una “architettura della paura” che in questo modo si consolida, attraverso piccoli e grandi dis-
positivi spazial i e di controllo: una visione paranoica e “securizzata” della vita urbana che contrasta con la stessa più pro-
fonda sostanza dell’i dea di città1 2.
La prima dimensione dell’opposizione alla città-fortezza che diventa necessario considerare è quindi quella della resisten-
za. Le “arti della resistenza” sono le armi dei poveri, una sorta di “ infrapolitica di coloro che non hanno potere” 1 3.
Nascondersi , dissimulare, non collaborare, disobbedire, fingere ignoranza, arrangiarsi: le arti della sopravvivenza costitui-
scono un insieme di attività spontanee e informali, che non richiedono coordinamento e piani ficazione, una sorta di “ brech-
tiana - o schweickiana - forma di lotta di classe” 1 4. Anche nei movimenti più consapevoli, progettuali e trasformativi, la resi-
stenza costituisce un fondamento e un punto di partenza. Ed è su una base di resistenza e ribell ione, molte volte individua-
le e soli taria, qualche volta organizzata e intenzionale, che poggiano anche le esperienze con un contenuto più alto di rea-
8
l izzazione e di speranza.
Resistenza al controllo e organizzazione positiva della sopravvivenza si dispiegano in particolare nello spazio pubblico, spa-
zio conteso per eccellenza della città. Abbiamo esaminato questa disputa col lettiva dello spazio in alcuni luoghi sensibili: le
piazze storiche, i luoghi di aggregazione del centro antico, la stazione e i territori del commercio e del transito, le strade
stesse della città alla fine. Ed abbiamo registrato i segni positivi di questa disputa, le microtrasformazioni e i processi di riap-
propriazione dello spazio collettivo (piazze multietniche, strade colorate, ecc.).
In particolare abbiamo cercato di disegnare una cartografia degli abitanti provenienti da lontano, degli “stranieri”, dei
migranti. Vivere, cercare di continuare a vivere, dispiegare “insurgent living practices” , potremmo dire parafrasando l’e-
spressione di Sandercock dalla quale siamo partiti, significa davvero in questo caso essere costretti a resistere e insieme a
cambiare la città. La vita non è garantita per questa categoria di cittadini negati, la loro esistenza non si è ancora quieta-
mente cristallizzata nelle case e nella città. Vivere per i migranti è ancora un obiettivo, non una condizione naturale di par-
tenza, ed è quindi necessariamente un progetto. “Allo straniero non domandare il luogo di nascita, ma il luogo d’avvenire”1 5
, ha scritto una volta provocatoriamente Edmond Jabès. Vivere significa conquistare un riparo, attrezzare uno spazio collet-
tivo di sopravvivenza, garantire i l soddisfacimento di bisogni elementari, adattare la struttura dei consumi e dei commerci,
assicurarsi le possibilità di movimento e di comunicazione, aggredire i problemi del lavoro e del la formazione, affermare il
diritto a una famiglia e a una discendenza, aff rontare anche il problema del tempo libero, del sesso, del pane e delle rose
insieme. È allora come conseguenza di questo progressivo radicamento del la vita dei migranti che gli effetti di luogo si accu-
mulano nello spazio e la città si deforma, si trasforma e si colora1 6.
Se leggete con attenzione le interviste vedrete che gl i itinerari di vita dei migranti non sono mai lineari e banali. Emergono
biografie complesse e contraddittorie: resistenza e progetto, devianza e desiderio di normalità, individualismo e fratellan-
za. Emergono inquietudine e adattabilità, rabbia e fiducia nel futuro, voglia di fare e di costruire, astuzia e imprenditoriali-
tà, e anche molta cultura, e una conoscenza delle altre culture e degli altri l inguaggi magari superiore alla maggioranza dei
cittadini “ordinari” . In qualche caso le storie di vita sono costrette ad attraversare una sorta di zona selvaggia, di “wild
zone” , il territorio di frontiera della città, collocato sul bordo, qualche volta oltre il bordo, della norma e del la legalità1 7.
Spazio terzo, zona selvaggia, oppure ancora spazi obliqui, ibridi , ambigui, come nel caso dei queer spaces, degli spazi “sba-
gliati” delle libere pratiche sessuali. Si diffondono allora le nuove geografie del desiderio e della libertà dei corpi1 8, anche in
questo caso spesso sul confine tra auto-espressione e auto-sfruttamento.
Una parte importante della ricerca è dedicata alla geografia dei luoghi occupati della città, degli immobili liberati da gruppi
di ci ttadini senza casa, del la aree o delle fabbriche abbandonate che sono diventate luoghi complessi della città alternativa
ed emergente. Le occupazioni - uso questo termine per indicare una fenomenologia di azioni internamente molto articolata
- sono all’origine di una contesa spaziale diffusa in tutto il territorio della città. Nella ricostruzione contenuta in questo volu-
me sono messi in evidenza le reti organizzative, le strategie, il carattere intenzionale e poli ticamente deliberato di molte
iniziative, in particolare sul grande tema generale della casa e dei centri sociali. In queste note mi piace tuttavia sottolineare
di queste esperienze il carattere aperto, imprevedibile, non programmato, persino impolitico, nel senso che ho all’ inizio pre-
cisato. Dell’occupazione di via Aldini, per esempio, e dell’occupazione dell’ immobile di via Bufalini duramente interrotta e
repressa, mi sembrano importanti, intrisi di futuro e di speranza, il carattere complesso dell’ esperienza, il tessuto relazio-
nale, l’ incontro di vissuti e culture, l’ intreccio di età e di aspettative, la valorizzazione del sentimento e del lavoro colletti-
vo, pur tra molte difficoltà e contraddizioni. Del l’esperienza dei centri sociali, a Firenze come altrove molto differenziata sia
tra i diversi centri sia tra i modi di vivere il senso dell’ esperienza all’ interno di ciascun centro, ciò che mi sembra anche in
questo caso più radicalmente ostile al la struttura di potere della città esistente è alla fine il contenuto materiale e concre-
to delle occupazioni, quotidiano, esistenziale, anche in questo caso l’aspetto i n s u r g e n tnel senso geddesiano: insurgent è la
vita collettiva in quel momento, l’ energia sprigionata, la pratica diretta del cambiamento. È un punto di vista non completa-
mente condiviso da tutti i partecipanti a questa ricerca, che mi premeva tuttavia qui di valorizzare e offrire alla discussio-
ne. E in ogni caso il testo ingloba in diverse parti la voce diretta dei protagonisti e sarà possibile per i lettori apprezzare
signi ficati e differenze.
Fondamentali sono infine le parti della ricerca dedicate alla ricostruzione di due esperienze particolarmente ri levanti nell’a-
rea fiorentina che abbiamo chiamato “cantieri sociali” : le esperienze delle comunità dell’Isolotto e delle Piagge. Si tratta di
“cantieri” che hanno una storia e un significato differente. La comunità dell’Isolotto ha una lunga e nobi le storia trentenna-
le, legata al la figura importante e decisiva di Enzo Mazzi, molto conosciuta e studiata. Qui viene ripresa secondo un partico-
lare punto di vista: la storia del la comunità viene guardata a partire dalla piazza, dal modo in cui la struttura fisica e simbo-
lica della piazza riflette le vicende della comunità e del rapporto della comunità con i poteri - religiosi, social i e politici - della
c i t t à .
Quello delle Piagge è viceversa un cantiere in corso, caldo e turbolento, al quale dedicheremo uno scritto più organico in un’al-
tra occasione 1 9. Le Piagge sono un laboratorio di trasformazione fisica e sociale, un deposito mutevole di energie positive,
anche scomposte e contraddittorie, una ragnatela di associazioni e di gruppi di volontariato. Da questo minuto e differen-
ziato universo di attività collettive - nel quale il centro del la comunità di via Lombardia coordinato da Don Alessandro Santoro
esercita un ruolo determinante - derivano microazioni trasformative, di natura puntuale, spesso circoscritte, e tuttavia
emergenti , attive. La protesta diventa rivendicazione positiva, la resistenza diventa iniziativa e progetto, le strategia di
sopravvivenza diventano impegno diretto nella costruzione del proprio insediamento e del proprio destino.
Che cosa accomuna queste esperienze, pur tra tante differenze del la storia individuale e collettiva dei loro protagonisti? Direi
proprio il carattere articolato e ambiziosamente completo del loro raggio d’azione. I cantieri sociali dell’ Isolotto e della
Piagge sono ipotesi di città all’opera, pratiche alternative di città che cercano di investire tutti gl i aspetti della struttura
urbana, micro-utopie in corso di real izzazione. Le attività della comunità delle Piagge riguardano per esempio la casa e l’ac-
9
coglienza, il lavoro e la formazione, la comunicazione e l’ incontro, la spiritualità e l’aiuto materiale, e molti altri aspetti anco-
ra. E questo complesso di attività è specificamente orientato alla riprogettazione del luogo, alla riqualificazione del quartie-
re, nel le sue componenti urbanistiche e sociali2 0.
6. UNA RICERCA FAZIOSA E PLURALE
Le immagini e le storie di questa ricerca nascono da indagini coinvolgenti, esposte, faziose. Abbiamo utilizzato strumenti
diversi, a seconda dei casi, forse con qualche confusione e qualche rischio di approssimazione: colloqui partecipati e intensi,
più densi della semplice intervista a testimoni privilegiati (intervista-dialogo dunque, ad alto tasso di interazione-interpre-
tazione); “ ricostruzioni critiche del caso” condotte molto dall’i nterno; qualche volta “osservazione partecipante” nel senso
tradizionale, complicata da una grado di adesione emotiva più spinta, nel corso delle esplorazioni urbane; “ ricerche-azione”
(è il caso del laboratorio di quartiere delle Piagge, ancora in corso) nelle quali i ricercatori hanno partecipato attivamente ai
progetti e alle realizzazioni. In molti casi i ricercatori erano quindi interni alle situazioni raccontate, o quasi-interni, oppure
lo sono diventati . Alcune parti del rapporto di ricerca assumono per certi aspetti anche una forma di auto-descrizione.
Il punto di vista espresso non è mai neutrale, anzi è contaminato dalla relazione con gli interlocutori della ricerca. Molti svol-
gimenti dell’indagine sono stati l’esito imprevedibile dell’ interazione con i soggetti, come nel caso di molte interviste. Le
interviste-dialogo sono state rilavorate, e poi ricontrollate con gli interlocutori, in un lavoro comune e circolare.
Il gruppo stesso dei ricercatori costituisce un esempio della molteplici tà di prospettive e orizzonti del la città insurgent e
alternativa. I ricercatori coinvolti hanno opinioni e atteggiamenti differenti, qualche volta un punto di vista interno ai movi-
menti, quasi complice, qualche volta un punto di vista più distaccato e perplesso. Quasi tutti hanno infine uno sguardo più
estremo del coordinatore della ricerca, ed alcuni di essi, dopo molte discussioni, fanno ancora oggi fatica ad accettare l’i dea
che le pratiche di vi ta per così dire biologicamente insurgent risultino significative e davvero alternative, e sono viceversa
più affezionati agli aspetti organizzativi e poli tici in qualche modo più tradizionali dei movimenti sociali urbani. I materiali
derivanti da questo diff ici le intreccio di sensibilità e posizioni sono quindi assai differenziati tra di loro, a volte persino inter-
namente contraddittori, ma abbiamo preferito rinunciare a un lavoro di riduzione e di omologazione. Ci è sembrato insomma
che l’articolazione di voci e di linguaggi del gruppo di lavoro potesse rappresentare meglio la pluralità di voci, atteggiamen-
ti e speranze di quella parte di città che abbiamo cercate di indagare e comprendere.
Note
1 J. Holston, “Spaces of Insurgent Citizenship” in J. Holston, ed., Cities and Citizenship, Duke University Press, Duhram/London, 1999, pp.
155-173 (la prima versione di questo saggio è del 1995).2 J. Holston, cit., p. 167.3 L. Sandercock, “Translations: From Insurgent Planning Practices to Radical Planning Discourses”, J. Friedmann, “Claiming Rights:
Citizenship and the Spaces of Democracy”,Plurimondi. An International Forum forResearch and Debite on Human Settlements,n. 2, 1999,
pp. 37-46, 287-303.4 J. Friedman,“ The Good City: In Defense of Utopian Thinking”, International Journal of Urban and Regional Research, 2, 2000, pp. 460-
472.5 L. Mumford, The Conduct of Life, Secker & Warburg, London, 1952, p. 30.6 L. Mumford, “Mumford on Geddes”, Architectural Review, 108, 1950, p. 83.7 L. Sandercock, Toward Cosmopolis: Planning for Multicultural Cities, John Wiley & Sons, Chichester/New York, 1998.8 P. Bourdieu, a cura di, La misère du monde, Seuil, Paris, 1993, pp. 13-14.9 L’espressione è utilizzata largamente in N.R. Fyfe, ed., Images of the Street: Planning, Identity and Control in Public Space, Routledge,
London/New York, 1998.10 H. Bhabha, The Location of Culture, Routledge, New York/London, 1994, pp. 101-10211 Chiedo scusa per non essere riuscito a tradurre in modo efficace questa citazione, un lavoro superiore alle mie forze (e anche a quel-
le di molti amici cui mi sono rivolto) e di aver quindi deciso di riprodurre l’originale. Credo infatti che l’elenco di gesti alternativi, a mio
parere bello ed espressivo, risulti alla fine sufficientemente comprensibile così come lo hanno scritto gli autori.12 N. Ellin, ed., Architecture of Fear, Princeton Architectural Press, New York, 1997.13 Da una citazione dell’antropologo J. Scott in D.S. Moore, “Remapping Resistance: ‘Ground for Struggle’ and the Politics of Place”, in S.
Pile, M. Keith, a cura di., Geographies of Resistance, Routledge, London, 1997, pp. 89-91.14 D.S. Moore, cit.15 E. Jabès, Uno straniero con, sotto il braccio, un libro di piccolo formato, SE, Milano, 2001, p. 15.16 G. Paba, “Cortei neri e colorati: itinerari e problemi delle cittadinanze emergenti”, Urbanistica, n. 111, 1998, pp. 20-24.17 La wild zone è quello spazio che è possibile nominare come deregolato. […] È lo spazio alternativo di urbanizzazione It is the alterna-
tive space of urbanization as an affirmative postmodern wilderness. These spaces are not without law, bur rather are the spaces of the
without-laws”, cfr. C. Stanley, “Not drowning but waving: urban narratives of dissent in the Wild Zone”, in S. Redheed, a cura di, The Club
Cultures Reader:Readings in Popular Cultural Studies, Blackwell, Oxford, 1997, p. 36.18 D. Bell, G. Valentine, a cura di, Mapping Desire, Routledge, London/New York, 1995; D. Higgs, Queer Spaces: Gay Urban Histories Since 1600,
Routledge, London/New York, 1999.
10
FIRENZE ‘ INSURGENT CITY’?
Marvi Maggio, Anna Lisa Pecoriello, Francesca Rispoli, Lorenzo Tripodi 2
11
Al l’inizio di questa ricerca la domanda che ci siamo posti è stata se davvero potessimo considerare Firenze una città “ insorgente” in
qualche modo. La risposta istintiva, attraverso la nostra esperienza personale di ricercatori, attivisti e in definitiva di cittadini, è stata:
no, non lo è. La nostra percezione era quella di una città chiusa, soffocante, impermeabile al cambiamento, una città strettamente sotto
controllo. Firenze città fossile, Disneyland del rinascimento, centro commerciale di Tokyo: queste definizioni derisorie ed impietose ci
sembravano purtroppo calzanti e precise.
12
Cercavamo trasformazioni positive dello spazio urbano, “effetti di luogo” delle nuove pratiche sociali, tracce e segni di
fratellanza e di nuove comunità, modifiche nella percezione, nell’uso e nella forma dello spazio urbano provocate da
identità locali e da aggregazioni sociali alternative; ma ciò che trovavamo ci sembrava insignificante a un primo sguar-
do, non apprezzabile in una ricerca a scala urbana.
Volevamo costruire una mappa della città emergente, ma non riuscivamo a comporre la percezione dei piccoli cristalli di
nuova socialità in una diversa geografia dello spazio urbano. Una nuova configurazione della città non si rivelava anco-
13
ra e ci sembrava di scoprire soltanto casi sporadici di relazioni non convenzionali con il territorio.
Abbiamo dovuto compiere allora un passo indietro e considerare la città nella sua complessità, delinearne i meccanismi
di controllo e di contestazione, i poteri e i contropoteri diffusi, le forme di pianificazione e la reinterpretazione dal basso
di quelle forme.
Partendo dalla configurazione di norme, leggi economiche, confini e dispositivi di controllo sarebbe stato possibile defi-
nire la città insurgent in negativo: la città che contesta, o si nasconde, e fugge.
14
È possibile individuare, nell’esperienza della città, due reti che si compenetrano e si attraversano, si confondono e si includono, in un
conflitto che si moltiplica su tracciati che scavalcano le logiche binarie buono/cattivo, formale/informale, pianificato/spontaneo.
Tracciati spesso nascosti, poco visibili o latenti, che talvolta si impongono all’attenzione perché in un nodo, in un punto di intersezione,
alcune forze si scontrano, e qualcosa esplode. Da una parte cresce l’uniformazione, la semplificazione, la frammentazione, la segrega-
zione e l’esclusione; dall’altra si evolvono living practices, pratiche di vita alternative che rimescolano significati e confini, amplificano
spazi e rumori, inventano forme di territorialità e convivenza.
Nel corso della ricerca la prima impressione di inconsistenza della città alter-
nativa si è alla fine dissipata. Un catalogo di segni di autonomia positiva di
vita e di (r)esistenza si è svolto a poco a poco: esperienze di gruppi organiz-
zati che cercano di dare risposte a bisogni primari, luoghi caratterizzati da
usi irregolari dello spazio e una molteplicità di microconflitti e identità locali
in formazione. Molti piccoli fuochi sembrano bruciare sotto le ceneri della
città. Collocare questi segnali su una mappa ha consentito una prima visione
di Firenze “insurgent city”, come città diffusa fatta di punti, costellazione
casuale di spazi contestati o temporaneamente conquistati.
Una mappa di servizio necessaria, ma provvisoria, dalla quale ci siamo subito
allontanati per cercare altre forme di restituzione di questo pluriverso mute-
vole, inafferrabile, resistente a ogni riduzione e classificazione. Inseguire
segnali attraverso percorsi e derive inconsuete ci ha portato a organizzare
delle sezioni urbane piuttosto che delle visioni planimetriche, a praticare
degli attraversamenti, che ci consentissero delle messe a fuoco traslate
rispetto alla tipica visione prospettica della città, di perderci nei rivoli dei
microsegni in alternativa ai grandi segni orientati della città. Siamo partiti da
segnali effimeri che indicano l’affiorare di nuove pratiche, fino ad arrivare a
manifestazioni complesse di strutturazione di spazi urbani e definizione di
nuove identità, individuando situazioni in grado di generare livelli di organiz-
zazione superiori.
Ci siamo sforzati di ricondurre la nostra attenzione verso i luoghi, pur muo-
vendoci in contesti nei quali la rivendicazione, l’assetto difensivo e ideologi-
co, ha assunto suo malgrado carattere prevalente rispetto all’azione costrut-
tiva e alla progettualità.
Abbiamo scelto di ripercorrere in forma sintetica, tramite due attraversa-
menti le due città complementari e divergenti: la “città cancellata” e la “città
insurgent”.
15
ATTRAVERSAMENTO 2
ATTRAVERSAMENTO 1
È la città uff iciale, ultraliberista e postindustriale, prodotto del mercato in cui si fondono conservazione formale, flessibi-
l ità finanziaria, e mobilità “globalitaria”. Una città che si caratterizza per la scomparsa dello spazio pubblico, reso inutile
dalla dissoluzione della prossimità sociale e riassorbito dall’imperativo consumistico. Quando non sia esplicitamente priva-
tizzato, lo spazio urbano è interdetto da inferriate, cancelli , muri , catene; è la città sorvegliata, in cui strade e piazze, slar-
ghi e giardini sono ridotti a spazio di transito: andare a lavorare, rientrare a casa, fare shopping, consumare il proprio
tempo libero di riproduzione vagando tra bar, discoteche e locali . Una città in cui la funzione preponderante diventa il con-
trollo, e lo sforzo progettuale sembra solo voler ridurre la possibilità di deviare dalle funzioni prestabil ite e di instaurare
relazioni spontanee con il territorio. Lo spazio e il tempo urbano si appiattiscono nel la banalizzazione delle forme d’uso; lo
scenario sociale si polverizza nella dispersione dei circuiti di fruizione prestabi liti e semplificati delle funzioni di produ-
zione e consumo non solo di merci, ma di relazioni interindividuali , di desideri , di rapporto con i luoghi. La città diventa
un’agglomerazione di persone parzializzate come somma di diverse categorie di bisogni, uno spazio socialmente vuoto. La
vita sociale e il coinvolgimento degli individui vengono progressivamente sostituiti dal consumo standardizzato e dall’uso
transitorio; diventa impossibile modificare, sentir proprio, interpretare il significato dello spazio.
Nelle sue recenti trasformazioni Firenze mostra alcune dinamiche significative, comuni forse ad altre città storiche, ma che
qui toccano vertici inauditi. La città storica si trasforma progressivamente da centro della vita sociale a teatro di auto-
rappresentazione di elementi formali ormai scissi dalle dinamiche che li hanno generati: punto d’incontro tra un parco
tematico del Rinascimento e un centro commerciale dedicato al bon gout italiano. Gli edifici del centro diventano luoghi di
rappresentanza o strutture ricettive. I grandi poteri espellono progressivamente, senza lasciare scorie, ogni residuo di vita
locale dalla città; in una sorta di continua operazione di l i f t i n g, tutto ciò che “odora di vita” viene sospinto all’esterno. Il
feticcio della conservazione si trasforma in imbalsamazione; e, in effetti, un’i mplacabile operazione di tassidermia sta
strappando ogni residua traccia di viscere dal tessuto urbano, trasformando il centro in pura esteriorità, e il resto in peri-
feria. In un certo senso è in atto una ricostruzione virtuale delle mura antiche: l’accesso al centro è regolato da accurati
controlli e da porte telematiche (in gran parte coincidenti con le porte antiche), mentre il potere del mercato produce l’ e-
spulsione del “popolo”, ormai esteso a chiunque non partecipi alle dinamiche commerciali e turistiche. Cancellate chiudono
le logge, spunzoni compaiono a impedire la seduta, ordinanze vietano di sedersi sul le scale: “stare” nella città diventa un
reato; puoi percorrerla, riempirti gli occhi, acquistare un souvenir.
È importante notare come la gestione dello spazio pubblico tenda a diventare un settore produttivo finalizzato allo sfrut-
tamento del suolo urbano, attraverso la privatizzazione delle funzioni di controllo e il moltiplicarsi di operatori impiegati
nella riscossione e nella gestione: cooperative di parcheggiatori, addetti alle rimozioni, “vigilini”, vigilanze ambientali,
guardie giurate, che diventano un settore economico non secondario a livel lo locale, da cui derivano effetti paradossali;
solo per fare un esempio, le contravvenzioni cessano di avere una funzione deterrente e diventano voci di bi lancio essen-
ziali dell’economia della ci ttà; il traffico diventa una fonte di reddito da preservare, piuttosto che un problema da risolve-
r e .
Nello stesso tempo la vita sospinta fuori dalle mura si riorganizza intorno a nuove polarità: nuovi centri (commerciali, in
sostanza), intorno a cui si organizzano nuove identità, ma anche nuove resistenze e nuovi conf litti.
16
LA CITTÀ CANCELLATA
17
Imboccando via Cavour dalla porta di San Gallo, siamo subito inquadrati da una telecamera: le nuove porte telematiche (non ancora in
funzione) individueranno automaticamente i veicoli non autorizzati ad entrare in centro; è un primo segnale di come il centro storico si
vada configurando sempre di più come qualcosa di “altro”, cittadella di rappresentanza uniformata all’economia turistica globale piutto-
sto che all’organismo urbano locale. Un’inversione di tendenza rispetto alle operazioni ottocentesche che dall’eliminazione delle mura in
poi miravano a ricomporre la città moderna e quella storica. Seguendo una pista ciclabile sovradimensionata e quasi inutilizzata arrivia-
mo in piazza San Marco; il portico dell’Accademia di Belle Arti, da sempre luogo di ritrovo degli studenti, è stato di recente chiuso con
una pesante cancellata. Sono sempre di più i loggiati, gli slarghi, gli spazi aperti della città ad essere chiusi da inferriate e cancellati dalla
geografia sociale della città; in questa logica, il non-uso, la sottrazione cautelativa del patrimonio comune viene costantemente prefe-
rita ad usi collettivi vivaci, problematici, proponendo un’immagine falsa di decoro e di sicurezza.
Ancora pochi passi e ci troviamo in piazza SS. Annunziata: storicamente sede di strutture di utilità sociale come lo Spedale degli
Innocenti brunelleschiano, la piazza resiste ancora ai processi di sottrazione sociale anche in virtù della sua architettura: le ampie sca-
linate che si fronteggiano (impossibili da chiudere!), il meraviglioso equilibrio tra altezza e ampiezza degli edifici e l’esposizione solare
la rendono luogo di sosta e di ritrovo ideale. Qui gli studenti e i turisti che si riposano convivono senza troppo stridore con i punk e i loro
cani, con gli immigrati che aspettano il pasto alla mensa dell’opera pia, e qualche senza casa che dorme sotto gli archi. È impressionan-
te la capacità della piazza di resistere e mostrare il suo carattere conviviale pur al centro di un quartiere quasi del tutto disinfestato da
forme di vita locale residenziale. Proseguiamo seguendo l’imponente richiamo della cupola brunelleschiana. In una giornata tipo, guar-
dando a destra in via degli Alfani, non è raro scoprire un lungo serpentone di turisti che si dipana fin lì intorno a tutto l’isolato
dell’Accademia. Sul muro dell’isolato le tracce della annoiata attesa di vedere il David: scritte, graffiti con nomi ed iniziali, e una curiosa
stratificazione di gomme da masticare appiccicate ad altezza uomo, una installazione un po’ repellente che qualcuno ha iniziato per caso
e ha generato un catastrofico effetto a catena che, anche se periodicamente rimosso, tende a riformarsi in breve tempo.
Pochi metri e siamo già al Duomo, zona al centro dell’economia turistica cittadina, strettamente controllata dalle forze dell’ordine, rego-
lamentata come puro spazio museale; uno spazio denso, attraversato e furiosamente fotografato da decine di migliaia di persone al gior-
no, oggetto del desiderio dei venditori ambulanti abusivi; osservato dall’alto, il precipitoso ritrarsi dei vu cumprà al passaggio periodico
delle volanti appare come un coreografia inquietante, mentre i mezzi della nettezza urbana irrompono più volte al giorno a lavare la
piazza e le strade limitrofe. In pochi anni intere strade sono state riconvertite ad opera dell’economia turistica, una trasformazione tut-
t’altro che trascurabile: money shops, lavanderie a gettone, internet pointshanno sostituito in breve tutte le forme di commercio di scala
locale; il modello di negozio in franchising omologa velocemente le strade della world city. Anche l’immagine della ” tradizione locale” al
centro del mercato turistico è reinventata su modelli costruiti a tavolino dalle strategie di marketing: è un fiorire di nuove “antiche” gela-
terie, botteghe e osterie, ossimori esibiti senza reticenza. Persino l’onesta pensione “Splendor” si ricicla in hotel “Orto dei Medici”.
ATTRAVERSAMENTO 1
18
Proseguendo, dopo poche decine di metri si apre piazza della Repubblica, la piazza borghese ottocentesca per eccellenza, “da seco-
lare squallore a nuova vita restituita” dopo la demolizione del ghetto ebraico.
Interessante notare come ad usare la piazza come spazio di ritrovo e di sosta siano sempre più spesso i nuovi cittadini immigrati, arabi
e asiatici, che vi trascorrono lunghe ore sulle panchine e sotto il loggiato, osservando e chiacchierando, esibendo posture e atteggiamenti
quasi scomparsi negli abitanti autoctoni.
Da qui in poi siamo nel salotto dello shopping di classe: l’area dell’antico accampamento romano, da via del Corso a via Tornabuoni, si va
sempre più drasticamente specializzando come distretto internazionale della moda, talmente specializzato da espellere poco a poco ogni
esercizio di genere diverso: è il caso di negozi storici come la libreria internazionale Seeber, il caffè Giacosa , la “profumeria inglese”, i
dischi Nannucci e molti altri, in procinto o già sostituiti dalle boutiques di grandi firme.
Il nostro percorso non rivela più grosse sorprese inoltrandosi nella “Disneyland del Rinascimento”; lo spazio urbano, come rivelano i car-
telli presso logge e monumenti, è da considerarsi assimilabile a spazio museale e pertanto soggetto a rigide norme di comportamento.
Piazza della Signoria: immerso in questo “universo parallelo”, il Palazzo Vecchio, sede del comune di Firenze, appare in tutta la sua
alterità, suggerita dall’imponente architettura difensiva. Chi vi entra scopre però la piacevole atmosfera affaccendata del palazzo pub-
blico che ancora concentra molte funzioni civiche nel centro urbano; già si parla però di istituire un biglietto di ingresso e limitarne l’ac-
cesso. [Al momento della redazione finale del testo, questo processo si è già verificato].
Il porticato degli Uffizi è caratterizzato dalle file di visitatori in attesa di accedere alla Galleria, irreggimentati da transenne di rara
trasandatezza; ad intrattenerli l’ormai identica ovunque genia degli “artisti (?) di strada” che si esibisce in un malinconico repertorio
standard. Mimi, musicisti, ritrattisti: regolarizzati dai permessi, normalizzati nei contenuti, industrializzati nell’approccio, i buskers
fanno ormai un lavoro come tutti, partecipi anch’essi della filosofia del franchising. Possiamo scorrere senza intoppi via Por Santa Maria,
il Ponte Vecchioluccicante attraversato da un flusso ininterrotto di turisti che percorrono il tracciato storico-commerciale più famoso
della città.
Da via Guicciardini si giunge a piazza Pitti, dove l’articolazione dello spazio e delle architetture conserva ancora il suo carattere monu-
mentale e celebrativo. A lato di palazzo Pitti si trova uno degli accessi al grande giardino di Boboli, che si estende fino a Porta Romana.
Da alcuni anni il giardino, che era sempre stato uno dei luoghi più frequentati dai residenti dell’Oltrarno e da tutta la città, oltre che dai
turisti, è stato ‘chiuso’. Chiusura che permette l’accesso libero solo ai residenti provvisti di documento di identità, mentre prevede il
pagamento di un biglietto per tutti gli altri.
19
Mentre da un lato le città d’arte
come Firenze si specializzano nella
funzione turistica diventando un
prodotto pubblicitario e di consumo
scambiabile nel circuito della compe-
tizione globale, simulacro di un luogo
collettivo che diventa contenitore
anonimo del l’esclusione e della
riproposizione di false forme di
socialità, l’ambiente urbano continua
a lanciare segnali intermittenti, ma
difficilmente ignorabili, che rendono
lo spazio strumento e contesto di
comunicazione.
La città alternativa e insofferente
non esiste solo nell’immaginario di
alcune persone che vorrebbero vive-
re i luoghi e i tempi urbani in manie-
ra diversa, ma si manifesta attraver-
so pratiche di vita che lasciano trac-
ce e sedimenti materiali, espressioni
di una cittadinanza esigente che per-
cepisce la città come patrimonio di
differenze, opportunità e contesti di
relazione.
Il carattere affermativo delle nuove
forme di socialità e cittadinanza si
riconosce dalle discontinuità, dalle
microlesioni che si vengono a creare
quando azioni sociali quali tativa-
mente diverse da quelle che caratte-
rizzano la città del controllo emer-
gono dall’uniformità dei comporta-
menti imposta dal sistema socio-
urbano dominante, e si manifestano
in spazi dislocati qua e là, connotan-
doli in maniera complessa (conflitto,
contraddizione, identificazione, ...).
Piccole “catastrof i” che creano
“movimento sociale”, pratiche di vita
che si impongono per specificità, per
fluttuazioni che generano lembi di
tessuto sociale territorializzato e
che si materializzano in alcune aree
e parti di città che richiamano le
“zones d’ambiance” individuate dalla
critica situazionista. Zone caratte-
rizzate da un’atmosfera urbana par-
ticolarmente intensa, costituita dal-
l’intreccio di molti fattori: non solo la
composizione sociale o le architettu-
re, ma gli elementi mutevoli della
scena urbana, il gioco di presenze e
assenze, delle luci e dei paesaggi
sonori, degli spostamenti, delle per-
cezioni temporali, del circolare delle
idee.
LA CITTÀ INSURGENT
d i i n s o r g e n z a :atti, comportamenti, segni che indica-
no relazioni emergenti e alternative
con lo spazio urbano; resistenza alle
trasformazioni e alle espropriazioni,
nuove forme di aggregazione, condi-
visione e comunicazione. Eventi che
innescano percezioni mutate dello
spazio, nuovi significati che modifi-
cano il valore degli spazi nelle geo-
grafie comunitarie.
Tra i comportamenti rilevati spicca
l’uso dei muri e delle superfici urbane
come strumento di comunicazione e di
denuncia: un tessuto di piccoli atti,
formalmente illegali, ma che raccon-
tano insostituibilmente il residuo fer-
mento, l’indignazione, la caparbietà
delle minoranze senza voce del la
città. Manifestazioni che hanno luogo
prevalentemente negli spazi saturati
della città, dove il valore fondiario
intensifica il livello di controllo e di
conf li tto, ma dove la capacità di
comunicazione è altissima grazie alla
concomitanza, alla densità del le
traiettorie che si incrociano.
Scritte e volantini, graffiti e striscio-
ni: testi volatili, graffi che lasciano
tracce, vengono coperti, riappaiono, si
stratificano labilmente e sbiadiscono,
lasciando comunque aleggiare la sen-
sazione di un’indomita e combattiva
vivacità.
S E G N A L I
20
Ci muoviamo dalla stazione, da quell’area di Santa Maria Novellacosì fitta d’incroci e di sensi nelle innumerevoli geografie persona-
li, dalle più distratte alle più coinvolte, attraversata ogni giorno da un fiume di persone. Quanti si soffermano per un attimo sui volanti-
ni affissi all’ingresso dei sottopassaggi, che indicano eventi, denunciano soprusi e azioni politiche? Di certo non v’è luogo della città in
cui la comunicazione murale spontanea abbia una maggiore potenzialità, anche se si perde nei flussi distratti dei pendolari e nella ridda
di lingue straniere. Qui notiamo anche molte scritte in amarico, in arabo ed in altre lingue, che ci segnalano quanto questo luogo sia impor-
tante nella geografia delle comunità immigrate, luogo di socialità, spazio pubblico per antonomasia della città dispersa e straniera.
Imboccando via Nazionale troviamo il teatro Apollo, in disuso da quindici anni, le cui serrande costuiscono una imponente bacheca.
Notiamo una serie di manoscritti ad opera di un cittadino classe 1926 che rivolge accorati appelli agli amministratori per salvare questo
edificio storico della cultura fiorentina abbandonato al degrado. L’Apollo è il più grande tra i numerosi cinema e teatri rimasti in abban-
dono per anni, e tra gli ultimi ad essere interessati da progetti di recupero come centri commerciali, cinema multisala o sale Bingo.
Ci inoltriamo nel centro viscerale della città, il mercato diSan Lorenzo; gli incroci delle stradine limitrofe al Mercato centrale sono piene
di volantini che pubblicizzano soprattutto le attività dei centri sociali. Anche la zona di san Lorenzo sta subendo evidenti trasformazio-
ni legate all’insediamento delle comunità straniere; vi si notano in particolare alcune strade già fortemente connotate da empori africa-
ni e orientali.
attraversamento 2
21
La mensa universitaria in via San Galloci introduce in una zona diversa, in cui emerge una nuova significativa presenza; dal mercato
inoltrandoci nella via degli Alfani ci ritroviamo nell’ultimo residuo di una geografia “disinteressata” e “culturale” della città: quel siste-
ma universitario minacciato anch’esso dallo smembramento e dall’espulsione verso nuovi poli periferici. Il fiorire dei volantini ai muri
segnala le sedi universitarie più significative e frequentate, le sedi di lettere e di architettura inpiazza Brunelleschi, poi il muraglio-
ne di via degli Alfani : un muro cieco di oltre trenta metri che ospita da anni notizie il succedersi di eventi e di mobilitazioni, graffian-
ti slogan polemici o interventi artistici e che può essere letto nelle sue stratificazioni, nel suo ciclico diradarsi e sbiadire e riempirsi di
nuovo come tornasole dei movimenti dell’underground fiorentino.
Al di fuori di questo percorso, l’attacchinaggio spontaneo si limita ad alcune isole in concomitanza delle scuole superiori.
Sembra che solo gli studenti restino a creare fermento e una minima resistenza alla sterilizzazione del centro; è significativo che nella
mappa dell’attacchinaggio spontaneo negli ultimi anni luoghi come Santa CroceeSan Fredianosiano andati scomparendo, mentre i muri
di questi quartieri storicamente impegnati denunciano solo poche istanze locali degli abitanti: la difesa dallo smog e dal traffico, dal
degrado e dal rumore...
Il nostro percorso si chiude emblematicamenteall’arco di San Pierino, residuo di una firenze popolare ormai scomparsa, crocevia pro-
blematico della città che cambia, tra studenti in fila sotto l’arco per un kebab, i pochi immigrati di lunga data che ancora si ritrovano qui,
spacciatori e clienti invecchiati insieme, periodiche proteste di sparuti comitati di residenti che lamentano un degrado diventato ormai
istituzionale, e che appare più psicologico che fisico.
Alla fine di questa esplorazione ci sembra di poter rilevare come negli ultimi anni sia avvenuta una contrazione dei luo-
ghi della città funzionali alla comunicazione interpersonale ed alla mobilitazione collettiva. Ormai lo sforzo di comuni-
care le iniziative e le istanze degli spazi alternativi si concentra esclusivamente nei percorsi tra le facoltà universita-
rie del centro fino alla stazione, mentre assume maggior rilievo l’uso delle radio locali e di Internet come strumenti di
comunicazione. Anche in questo si nota come lo spazio urbano perda progressivamente la connotazione di spazio di rela-
zione, demandando sempre di più la funzione comunicativa ad ambienti mediati e controllati. Per contro va notato come
abbastanza regolarmente la stampa cittadina, e non solo quella di sinistra, accolga le segnalazioni degli eventi che si
svolgono all’interno degli spazi occupati al fianco delle normali attività culturali “legali “, riconoscendo un ruolo cultu-
rale e politico quasi istituzionale ai centri sociali.
La mappa che segue non è il risultato di un rilievo accurato di dati, e non evidenzia territori omogenei secondo classificazioni di alcun
genere: è l’individuazione di aree “interessanti” , su cui appuntare la nostra attenzione, fatta in via preliminare da noi ricercatori come
primo passo nell’affrontare questo viaggio. E’ un piano di esplorazione, un appunto mentale su quella geografia della nostra città che
consideravamo pulsante, interessata da fenomeni di trasformazione e conflitto, dal futuro incerto; in sostanza soggetta a fenomeni
coincidenti con la definizione di “insurgent city” che avevamo adottato. E’ una mappa che non abbiamo ulteriormente sviluppato, sem-
plice punto di partenza senza pretesa di conclusione.
Essa include gli ultimi residui di spazi indeterminati, interstiziali, della città: terrains vagues come l’ Argingrosso, un vasto triango-
lo residuale delimitato dall’Arno, dal viadotto dell’i ndiano e dal viale Canova, che riserva esperienze inattese come il laghetto bucoli-
co sorto da una cava abbandonata o la teoria di piccoli orti spontanei; o come la vicina area delle C a s c i n e, con l’anfiteatro e la palaz-
zina dell’Indiano, incrocio continuo di usi e consuetudini non ufficiali e regolarizzati, o il contiguo mondo delle discoteche e dei bar
estivi, con le esplosioni di socialità e gli effetti collaterali nei mercati illegali delle droghe e del sesso.
Include aree dismesse in seguito allo smantellamento di istituzioni pubbliche o industriali, come San Salvi, micro-garden city della
malattia mentale, i cui padiglioni ospitano oggi le più svariate funzioni ed esperienze, occupazioni abitative di famiglie immigrate,
laboratori artistici e teatrali, o funzioni residue dell’apparato sanitario pubblico; o come l’area ex Longinotti, fabbrica dismessa
occupata per oltre un decennio da un centro sociale, la cui vicenda ha rappresentato un cardine emblematico del dibattito sulla pia-
nificazione urbana di Firenze. O ancora, piazze e strade calde, come Santo Spiritoo Santissima Annunziata, in cui si riversa cicli-
camente la foga compressa dei giovani e l’i rrequietudine della città negata.
In generale sono luoghi che oltre a ospitare storie e vicende di sopravvivenza, resistenza e di elaborazione politica , creano un intor-
no, generano effetti perturbanti nella città che li circonda: sono valvole di sfogo per esigenze castrate, territori di conflitto tra cul-
ture e generazioni, impasse gestionali delle politiche consolidate. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva
riduzione di questi territori indeterminati, soggetti a progetti di rinnovamento, a controllo soffocante, ad operazioni di sanificazione
esasperate. L’adozione di nuovi strumenti urbanistici ha ridato slancio al progetto di rigenerazione delle ultime aree dismesse in poli
commerciali e direzionali. Lo spazio disponibile ad alternative di vita è in estinzione grazie al dominio incontrastato dell’etica di mer-
cato, mentre il braccio di ferro sempre più duro con le forze dell’ordine a difesa delle proprietà degli spazi ha finito per ridurre l’im-
pegno nelle occupazioni a una pratica prevalentemente difensiva che ne mortifica l’aspirazione costruttiva e progettuale. Senza voler
qui scendere nel merito della liceità o della qualità delle attività che vi avevano luogo, non possiamo non rilevare come la trasforma-
zione in senso regolato e controllato di ogni spazio della città non si sia dimostrato in grado di rispondere al sempre crescente senso
di frustrazione, di alienazione, di insofferenza che una ingente parte della cittadinanza avverte nei confronti della vita urbana di
Firenze.
22
CONTESTED SPACES / CENTRI SOCIALI
23
CENTRI SOCIALI
- C P A ., Centro popolare autogestito fi-sud. Nasce nel settenbre 1989 con l’ occupazione dell’ ex fabbrica longinotti, una grande area indu-
striale dismessa di 37000 mq, per rispondere al bisogno di un luogo di aggregazione nella parte sud della città. Malgrado le molte minac-
ce di sgombero, avanzate a partire dal 1996 quando la Coop, proprietaria dell’ area, inizia a presentare progetti speculativi , il Cpa cerca
di contrastare non solo lo sgombero, ma soprattutto la costruzione di un grande centro commerciale Coop nell’ area. Sgomberato il 28
novembre 2001. Rinasce dopo poche settimane con l’occupazione di una ex scuola in via Vill amagna
- Ex- Emerson. Centro sociale autogestito. Nel settembre dell’ 89 viene occupata l’ ex fabbrica Emerson in via Bardazzi, un grande edi-
ficio abbandonato da 9 anni nel quartiere di Novoli, nella periferia nord-ovest dell a città. La scelta del luogo è legata ad una lotta intra-
presa in quegli anni contro la costruzione di un inceneritore di ri fiuti tossici nella zona. Situato al centro di un’area di trasformazione urba-
na strategica per l’amministrazione, viene sgomberato nel lugli o 1993.
- Ex- Emerson. Centro sociale autogestito, via Niccolo da Tolentino. Viene occupato lo stesso giorno dell o sgombero di via Bardazzi dall o
stesso nucleo di persone decise a proseguire l’ esperienza di autogestione un ex calzaturificio dismesso da 10 anni nella zona di Careggi.
- La vill a.Centro sociale autogestito, via Salvi Cristiani. Nasce nell’ estate del 1994 con l’occupazione, da parte di alcuni abitanti del quar-
tiere, di una grande casa colonica di proprietà comunale, posta in mezzo ai palazzi del quartiere di Coverciano. Dopo alcuni anni La Vill a
funziona come circolo di quartiere, si susseguono varie esperienze di autogestione da parte di gruppi diversi, con connotazione politiche
più marcate. Nel marzo 2000 il Comune, avendo deciso la vendita dell o stabile nel quadro di un progetto più ampio di ali enazione di gran
parte del patrimonio storico-architettonico di sua proprietà, decide di sgomberare il centro.
- Il mulino., Centro sociale autogestito. Occupato nel maggio 2000 come risposta allo sgombero della Vill a. La nuova occupazione avrà
vita breve e si conclude nel giugno 2000 con lo sgombero.
- I n d i a n o .. Primo centro sociale autogestito di Firenze nato nel dicembre 1997 con l’ occupazione di una palazzina in fondo al parco dell e
cascine. Diventa alla fine degli anni 80 il principale luogo di espressione dell a cultura punk-anarchica in città. Vi ene sgomberato nel marzo
del 1991. Dopo lo sgombero il comune ristruttura la palazzina e, dopo svariate vicende, accetta la richiesta di assegnazione degli ex-occu-
panti, ormai costituiti in associazione. Nel luglio 2000 il Comune decide di rientrare in possesso dell o stabil e e l’associazione lascia spon-
taneamente la palazzina.
Nel corso del 2001 sono avvenute le seguenti occupazioni:
-Il bandone, Via Maragli ano
-I n f o - s q u a tVia Bufali ni
ex-emerson
indiano
le piagge
Poderaccio
Olmatello
le Cascine
S.Salvi
S.Spirito
Argingrosso
il bandone
info squat
CPA fi-sud
la villa
24
LUOGO PUBBLICO ALTERNATIVO PERCHÉ RESIDUALE?
La cancellazione progressiva delle forme di uso pubblico degli spazi urbani
muta le geografie della città.
La privatizzazione crescente della sfera pubblica e la strategia manageriale
di gestione della città, divenuta prodotto da scambiare sui mercati interna-
zionali, trasformano i modi in cui la società si auto-rappresenta nello spazio
urbano. I meccanismi di valorizzazione economica della rendita urbana e del
mercato immobiliare, associati ai dispositivi di controllo che rispondono alle
nuove “emergenze sicurezza”, si coniugano con la proposizione di spazi di
nuova socialità come le discoteche, gli stadi o i centri commerciali.
Ma al di là delle accattivanti immagini video riprodotte sui megaschermi delle
nuove stazioni ferroviarie dell’alta velocità, o delle finte strade e piazze
ricreate all’interno degli shopping malls, libere dal traffico veicolare e dalla
presenza di residenti, viene da chiedersi dove e come si producano oggi le
nuove forme di urbanità, di interazione sociale, di aderenza al territorio della
città, ancora tutte da scoprire.
Di certo possiamo dire che il valore sociale eurbano dello spazio pubblico sta
mutando radicalmente.
Uno degli aspetti più evidenti della scomparsa dello spazio pubblico nella città
contemporanea si manifesta laddove le piazze perdono la loro natura di luo-
ghi dell’agire sociale, nei quali flussi di persone in movimento incrociano iti-
nerari individuali, rallentano di velocità, improvvisano soste e forme di fre-
quentazione, incontro e aggregazione.
Negli ultimi dieci anni le piazze di Firenze sono scomparse, sottratte alla città
vissuta e agli abitanti per essere trasformate in spazi di transito, di passag-
gio rapido o sosta distratta per i turisti. Presidiate dalla polizia e tenute “in
ordine” da vigili, ausiliari del traffico e guardie ambientali, le piazze subisco-
no un processo di riduzione complessiva delle possibilità di accesso e fruizio-
ne, messo in atto tramite ordinanze speciali e divieti (di entrare, sedersi,
stare, giocare, ecc.) emessi dal sindaco in nome del decoro urbano, della puli-
zia, della vivibilità, della sicurezza.
Firenze è diventata una sequenza di spazi in cui si espongono merci, monu-
menti e architetture, immagine urbana del parco tematico internazionale del-
l’arte, della cultura, della storia e della moda, finalizzata alla cattura dei flus-
si finanziari che attraversano l’economia mondiale.
La vita pubblica sopravvive solo in alcuni luoghi residuali della città, manife-
standosi come capacità di inventare più modi di relazionarsi allo spazio, di
attraversarlo ed essere presenti, di conferirgli significati. La percezione indi-
viduale e talvolta socializzante dei luoghi genera il dinamismo irriducibile
dello stare e dell’andare che si crea in una piazza urbana, spazio connotato,
racchiuso dal volume degli edifici che lo circondano, membrana di costruito
che crea osmosi con il contesto e intrecci tra il dentro e il fuori.
Piazza Santo Spirito è in questo senso un luogo urbano residuale, l’unica piaz-
za di Firenze che sopravvive alla cancellazione. La piazza, di origine storica
e popolare, ha mantenuto negli ultimi vent’anni alcune caratteristiche che le
altre piazze storiche di Firenze hanno perso.
In una città che vive della propria immagine storico-artistica (il disegno urba-
nistico, le architetture, le opere d’arte) e delle merci di lusso (le vetrine del
centro), piazza Santo Spirito si distingue per alcune peculiarità: una piazza
rimasta fortemente integrata con il quartiere, che ospita ancora il mercatino
rionale giornaliero, dove la gente si incontra per stare e per parlare, dove si
può sedere per terra e sui gradini senza che vigili e polizia ti facciano alzare
per problemi di decoro.
Un luogo urbano nel quale si riproducono forme di prossimità e solidarietà, si
tessono reticoli di socialità invisibili ma duraturi, nel quale le differenze - di
PIAZZA SANTO SPIRITO Francesca Rispoli
25
reddito, di cultura, di etnia - cercano forme di convivenza, creando microco-
munità occasionali.
“Molti quartieri storici di Firenze sono stati svuotati dagli abitanti, come
Santa Maria Novella e Santa Croce, quartieri una volta popolari i cui abitanti
vivono adesso nei blocchi-dormitorio del la periferia, dal l’Isolotto alle
Piagge”.
“La zona d’Oltrarno è invece caratterizzata ancora dalla presenza di residen-
ti, soprattutto anziani, che farebbero di tutto per non andarsene da questo
quartiere, nel quale ancora esistono rapporti di comunità e legami di solida-
rietà e mutuo aiuto. In questo senso è possibile riconoscere ancora forme
residue di resistenza e di radicamento.
L'Oltrarno era, storicamente, il quartiere più povero di Firenze, come testi-
moniano certe strutture, per esempio i Bagni Pubblici, nei quali ancora oggi il
sabato vengono a fare la doccia più di cento persone, o l’Albergo Popolare,
servizi che non avrebbero mai fatto costruire, ad esempio, a Coverciano”.
“I momenti storici del cambiamento delle condizioni di vita della zona si pos-
sono far coincidere con le fasi di spopolamento. Ci sono cantieri aperti da
vent’anni, perché il quartiere è stato in parte abbandonato negli anni 60-70,
quando le famiglie più povere, non avendo i soldi necessari per ristrutturare
le vecchie case, si facevano assegnare dal comune le case popolari di perife-
ria. Ma qui la gente piange se deve andare via. Quando vado alle Piagge trovo
la gente di Santo Spirito, cambiata e intristita.
Il legame tra gli abitanti e con il luogo è sempre stato forte.
Oltre ad essere collocata in un quartiere i cui abitanti mantengono un senso
di territorialità e forme di relazioni sociali che sembrano opporre resistenza
alla frammentazione e singolarizzazione degli individui, la piazza accoglie e
include le realtà sociali che la città respinge dai luoghi centrali dell’offerta
turistica, come la Stazione, il Duomo, piazza Signoria, piazza Santa Croce,
strettamente controllati per limitare la presenza degli esclusi, che la città
deve nascondere all’occhio del turista. Nel quartiere di Santo Spirito esistono
ben 45 strutture di accoglienza della marginalità sociale”.
La piazza funziona quindi anche come luogo di incontro, aggregazione e tes-
situra di reti solidali per gli homelessche vanno a lavarsi ai Bagni Pubblici di
via S. Agostino, per gli abitanti dell’Albergo Popolare di via della Chiesa, per
chi normalmente vive nella strada, e per i cosiddetti soggetti a rischio del
quartiere.
UNA PIAZZA, MOLTE GEOGRAFIE
Santo Spirito è sempre stata una piazza “dalle molte vite”, frequentata da
tipi di persone anche molto diverse tra loro. Luogo in cui si realizza una pre-
senza relazionale tanto legata al corpo e alla materialità delle pietre e delle
architetture, quanto agli affetti invisibili e alla comunicazione simbolica tra
gli individui e lo spazio urbano.
L’atmosfera particolare di questo luogo, che favorisce gli incontri, gli scambi
e le forme di socializzazione, risente forse di alcune tracce, appena percet-
tibili, di una realtà storica che ha sedimentato situazioni sociali vissute in
questo spazio in tempi passati, come l’antica struttura economica del quar-
tiere, fondata sull’artigianato, che incoraggiava le forme di interazione e la
costruzione di relazioni sociali.
“Il bar della piazza non era solo un luogo di ritrovo, ma anche un ufficio di
collocamento permanente. Si trovava sempre qualche lavoretto da fare, per-
ché serviva un aiuto a questa o a quella bottega; così, in maniera spontanea,
si imparava il mestiere del pellettiere, del fabbro, del vasaio fiorentino, del
vetraio, del tessitore, del falegname. In quel modo si combinava la trasmis-
sione di conoscenze alle nuove generazioni e la costruzione di una rete di pic-
cola economia di quartiere”.
26
“Qui sono state fondate in passato diverse IPAB, strutture di beneficenza per i
bambini poveri dotate di scuole e botteghe artigiane, create dall’aristocrazia
fiorentina, come i Frescobaldi di via Maggio. Molte di queste esistono ancora,
con affitti vincolati: Il Conventino, gli Artigianelli, l’Istituto Fuso, il Pio Istituto
dei Bardi, dove si insegnava l’arte orafa e da cui provenivano i migliori orafi fio-
rentini. San Pier Martire, in Piazza San Felice, funziona oggi in parte come scuo-
la parificata, mentre alcuni dei fondi sono stati venduti a privati”.
“La tradizione artigianale del quartiere e l’esistenza di queste strutture garan-
tivano il mantenimento di un reticolo di piccole botteghe in tutta la zona
d’Oltrarno. Passando per strada si veniva investiti dagli odori più disparati:
legno, verniciatura, ferro bruciato, trucioli bagnati, pelli conciate, che si mesco-
lavano all’odore del cibo che usciva dalle finestre delle case; oggi questi odori
sono scomparsi”.
“Adesso gli artigiani sono diventati un problema, vivono della loro abilità e del
loro ingegno, ma devono affrontare molte difficoltà. La più grande tra queste è
avere la bottega, perché sempre più gli artigiani, che non possono comprare i
fondi dove lavorano, sono costretti ad abbandonarli e di conseguenza o cessare
l’attività, oppure trasferirla in zone lontane. Il problema è che fino a qualche
anno fa pagavano quote irrisorie di affitto per il fondo della bottega, magari 50
mila lire al mese; quote che sono salite oggi a cifre che possono arrivare fino ai
3 milioni al momento del rinnovo del contratto. Molti artigiani mantengono qui
la residenza, ma hanno il laboratorio in campagna.
Da parte dell’amministrazione non esiste una volontà seria di affrontare questo
problema. Il comune organizza corsi di formazione professionale all’artigianato
che sono solo un mezzo per ottenere finanziamenti, perché non insegnano nulla
a nessuno. L’amministrazione dovrebbe invece comprare i fondi al piano terra e
darli agli artigiani con affitti agevolati, considerando anche che l’Oltrarno è
pieno di strutture pubbliche abbandonate”.
“Un’altra caratteristica del quartiere di Santo Spirito, quella di essere stato nel
passato il più povero e popolare di Firenze, ha forse creato le condizioni per la
permanenza di una cultura della solidarietà e dell’accoglienza che ancora oggi è
percepibile nella vita della piazza.
Piazza Santo Spirito è sempre stata il luogo centrale del quartiere. Il mercatino
rionale che troviamo oggi ogni mattina è uno dei più antichi della città, e risale
al 1400.
Esiste però il problema del cosiddetto degrado, che ha origini complesse.
Innanzitutto bisogna considerare che ci troviamo in quello che era il quartiere
più povero e più popolare di Firenze, dove situazioni di microcriminalità sono in
qualche modo sempre esistite. Era anche il quartiere più comunista e più anar-
chico della città. Basti pensare a personaggi storici come il prete del quartiere,
soprannominato “il Cuba”, che è sempre stato il prete delle carceri e ha aiutato
molte persone della zona, perché questo era anche un quartiere di carcerati o
comunque di gente che, come succede in ogni situazione di estrema povertà,
aveva problemi con la legge”.
“Fino a qualche decennio fa la situazione di microcriminalità era circoscritta a
livello locale, tutti si conoscevano nel quartiere e la convivenza era sempre
stata tranquilla. I problemi veri sono cominciati dalla fine degli anni ‘60, quan-
do è arrivata l’eroina che si fa strada tra le fasce più povere della popolazione.
Qui gli spacciatori trovarono una situazione favorevole per i loro commerci: in
breve tempo Santo Spirito era diventato il quartiere dei tossicodipendenti; e da
qui nasce anche la fama della piazza come simbolo dello spaccio. Molti giovani
della zona sono stati falcidiati dall’eroina. Posseggo ancora una foto scattata
negli anni ‘70, durante un controllo di polizia sulla scalinata della chiesa, affol-
lata di ragazzi del quartiere: i giovani ritratti nella foto sono tutti morti di eroi-
na.
Ma anche durante gli anni ‘70 e fino all’inizio degli ‘80 la situazione, benché
molto grave, era in qualche modo sotto controllo, perché sempre di scala loca-
le. Ora non si capisce più nulla.
E non è tanto il problema della delinquenza portata dagli immigrati, come
27
1 l’ingresso principale (lato Borgo Tegolaio)
2 il sagrato della chiesa con gli scalini
3 il lato del sagrato
4 il lato Cabiria-Caffè Ricchi
5 l’angolo di Palazzo Guadagni con la seduta in
pietra, detto il molo
6 l’ingresso dal fondo e la parte di piazza dove
c’è il monumento su via S. Agostino
7 l’angolo dell’edicola e il lato dell’Osteria S. Spirito
e del Pop Caffè
8 l’angolo della caserma
9 la fontana, le panchine e gli alberi al centro della piazza
12
3
9
8
5
7
6
sostengono in molti. La presenza di extracomunitari nel quartiere non ha mai
rappresentato un problema, perché qui gli immigrati ci sono sempre stati: si
stava tra poveri.
Magari succedeva qualche lite tra noi, qualche piccolo “regolamento di conti”
che finiva al massimo con un bagno nella fontana, ma niente di più. Ricordo che
nelle sere d’estate si mangiava in piazza, si portavano fuori dalle case il cibo, i
tavoli e le sedie, si faceva il fuoco e si stava tutti insieme a cena. E spesso chi
passava per caso si sedeva a mangiare con noi”.
Ed è ancora più significativo il fatto che l’eroina, elemento di disgregazione e
polverizzazione sociale, non sia riuscita, come è successo nelle piazze di molte
città, a cancellare le reti di amicizia e solidarietà che ancora oggi caratteriz-
zano i rapporti tra i frequentatori più assidui.
Oggi Santo Spirito è una piazza urbana, di quartiere e di zona, che si anima di
varie geografie nelle diverse ore della giornata, effetto dell’intreccio tra le
trame socializzanti e i luoghi.
La configurazione spaziale e temporale della piazza è molto complessa, frut-
to dell’intersezione di almeno nove luoghi interni, che vivono situazioni diver-
se nell’arco della giornata.
La piazza, essendo priva di portici o altre strutture che possano facilitarne la
fruizione anche nei mesi invernali, assume caratteristiche diverse nei vari
periodi dell’anno. Durante la primavera, e soprattutto in estate, è sempre
molto frequentata da persone provenienti da ogni parte della città, sia di gior-
no che di notte, mentre in inverno diventa luogo d’incontro per chi abita nel
quartiere.
4
28
UN GIORNO D’ESTATE. I TEMPI E I LUOGHI DELLA PIAZZA
La piazza si anima presto lamattina, con gli ambulanti che montano il mercatino (nella parte che affaccia su via S. Agostino), la gente
che compra il giornale e fa colazione nei bar. Al mattino è una piazza di quartiere, dove si trovano le signore a fare la spesa e gli anzia-
ni a chiacchierare. I luoghi più vissuti in questa fascia oraria sono il fondo della piazza, dove viene fatto il mercato, e la zona centrale
della fontana: anziani sulle panchine, nipotini a giocare, persone che conversano.
Dal primo pomeriggio la piazza, che ha un’ottima esposizione, assume una connotazione più urbana: qualche turista si ferma a man-
giare un panino sul sagrato o alla fontana, qualcuno si riposa sulle panchine sotto gli alberi, altri leggono un libro o prendono il sole. Sulla
seduta in pietra di Palazzo Guadagni c’è sempre qualcuno: gente del quartiere, frequentatori “storici” della piazza, ospiti dell’Albergo
Popolare, homeless.
Dal tardo pomeriggio comincia ad arrivare la gente di piazza, i frequentatori più assidui che siedono di solito sul fondo del sagrato o
sui gradini della chiesa.
Al tramonto la piazza si popola di persone che rimangono fino all’ora di cena.
Alcuni sugli scalini della chiesa, molti al bar Cabiria, dentro e fuori, seduti ai tavoli o sui gradini del marciapiede; qualcuno al Caffè Ricchi,
altri al “bar del centro”, quello dell’Associazione Santo Spirito, bar estivo all’aperto che occupa lo spazio adiacente alla fontana.
29
Alle otto i carabinieri, che presidiano sempre lo spazio, si danno il cambio e certe volte la piazza rimane scoperta per un po’, fino all’ar-
rivo della pattuglia successiva.
All’ora di cenasono pieni sia i tavoli del Cabiria (aperitivo lungo con spuntino), che quelli del Borgo Antico (trattoria e pizzeria); sono pieni
anche quelli del Caffé Ricchi, che ha aperto da poco un nuovo ristorante “solo pesce” (il più caro in assoluto della piazza) e dell’Osteria
Santo Spirito (piuttosto cara anche questa). Sugli scalini rimangono poche persone.
Alle dieci comincia lo spettacolo delle notti di Santo Spirito, sul palco posto a margine della zona centrale della fontana. Il palco ha un
doppio affaccio: alcuni spettacoli sono rivolti verso “l’esterno”, verso la facciata della chiesa, altri verso il centro della piazza. Il pub-
blico, sempre numeroso, è composto in maggioranza da persone del quartiere (anziani, famiglie con bambini, giovani coppie, ecc.).
Gli spettacoli finiscono alle undici ed è l’ora in cui la piazza comincia a riempirsi di gente (molti ci passano la serata, altri passano “a
vedere chi c’è” e bere qualcosa).
A questo punto è difficile trovare un posto a sedere sulle scale. Anche il sagrato è affollato di persone, sedute in cerchio; qualcuno gioca,
qualcuno suona, qualcuno vende birre fresche a poco prezzo; ogni tanto arriva Roberto, il mangiafuoco più conosciuto in città, che, se ne
ha voglia, improvvisa qualche spettacolo.
Molta gente è in piedi tra la chiesa e la fontana, e si addensa in prossimità dei bar. L’angolo più tranquillo è quello del Pop Caffè, a cui è
vietato servire da bere ai tavoli esterni.
Durante le sere d’estate Santo Spirito, frequentata da molta gente di tutti i tipi, diventa uno dei luoghi di incontro e di aggregazione più
significativi della città.
Una delle caratteristiche distintive della piazza è quella di avere sempre funzionato come luogo dove le persone si conoscono, si incon-
trano, scambiano idee; questo ha generato talvolta gruppi di affinità di varia natura. Citiamo solo due esempi: negli anni ‘70 il primo
nucleo fiorentino di Lotta Continua nacque per iniziativa di alcune persone che si trovavano a Santo Spirito, e così accade oggi per alcu-
ni gruppi di espressione artistica, come il MAC.
Intorno alle due la piazza si svuota, ma rimangono sempre gruppi di persone, più o meno numerosi, che trascorrono la notte continuan-
do a parlare, bere birra e suonare, incrociandosi tra loro. Da varie parti della piazza coloro che rimangono confluiscono a poco a poco
nella zona centrale della fontana, quella più lontana dalle abitazioni, per disturbare il meno possibile i residenti.
30
ESTATE 2000Sembrava una giornata come tante...
Tutto filava liscio fino a mezzanotte e mezzo, l’una, quando, d’improvviso, un
presunto problema di ordine pubblico si trasformò in questione di igiene urba-
na.
Domenica 2 luglio- Compare sui giornali un articolo di cronaca (prima pagina
de La Nazionedi Firenze) in cui si descrive il degrado sociale e igienico della
piazza, “frequentata da gente sporca e poco raccomandabile fino all’alba”.
Il sindaco emette un’ordinanza che impone la pulizia di Santo Spirito ogni sera
alle 0.30.
Lunedì 3 luglio - Ore 0.30: arrivano in piazza due grandi camion del
Quadrifoglio, società che ha in appalto dal comune di Firenze il lavoro di rac-
colta dei rifiuti e di pulizia delle strade. Arrivano anche due pattuglie di vigi-
li e un furgone di carabinieri (nel caso che le forze dell’ordine che presidiano
sempre la piazza non fossero sufficienti a placare le eventuali proteste).
I carabinieri cominciano, a partire dal lato della caserma, a invitare le perso-
ne a spostarsi dal sagrato e dalle scale. La gente si sposta, malvolentieri ma
in silenzio, e si avvicina al lato del marciapiede (angolo Cabiria).
Una volta liberato il campo (un’operazione che non richiede più di dieci minu-
ti) un addetto del Quadrifoglio, con una tuta da marziano, comincia a lavare il
sagrato con l’idrante mentre i due camion cominciano a passare avanti e
indietro spruzzando acqua mista a sapone e disinfettante.
La gente borbotta ma, dopo essere rimasta per un po’ in piedi, se ne va dalla
piazza. E questo è lo scopo reale dell’”Operazione Igiene Pubblica”: creare
una situazione di estremo disagio. I camion del Quadrifoglio, che riempiono
l’aria di gas di scarico, i mezzi dei vigili e delle forze dell’ordine occupano
quasi tutto lo spazio libero della piazza. Marciapiedi, gradini e sagrato della
chiesa vengono spruzzati e bagnati. Il tutto genera molto rumore e lascia
nell’aria un nauseante odore di Lysoform.
Rimangono i frequentatori più assidui, quelli che in piazza ci stanno di solito
dal pomeriggio fino a tardi la notte (le solite 20-30 facce che vedi tutti i gior-
ni, più qualcun altro), ad aspettare che finisca il “teatrino delle pulizie”, per
poi rioccupare il loro spazio di sempre. E ci si risiede quasi subito, non impor-
ta se le pietre dei gradini sono bagnate, ma ormai la piazza è vuota, è solo
l’una e mezza e sembrano le quattro di notte.
Per una settimana, ogni sera, la scena si ripete. Per le persone che frequen-
tano la piazza la tendenza ad abituarsi al fatto che “all’una ci sono le pulizie”
entra in conflitto con la coscienza del significato reale dell’ordinanza del sin-
daco: scoraggiare la fruizione dello spazio pubblico di Santo Spirito, e dare un
segnale della presenza dell’autorità cittadina: si può stare in piazza fino
all’una di notte, ora di chiusura dei locali.
Venerdi 7 luglio- Ore 1.00. La piazza è piena di persone, ovunque.
Solita procedura: arrivano i camion, i vigili e i carabinieri, che fanno sfollare
la gente. Oggi ci vuole più tempo del solito, la piazza è veramente affollata.
Arrivati a metà del sagrato, i carabinieri cominciano a incontrare un po’ di
resistenza, nel senso che le persone sedute, impegnate nel fare i fatti propri,
non si alzano né spontaneamente, né alla prima sollecitazione delle forze del-
l’ordine. Qualcuno chiede a un carabiniere (sono in quattro) chi ha avuto que-
sta “bella idea” delle pulizie; lui risponde, sorridente, che è stato il comune,
perché vuole mandare via la gente dalla piazza. Anche chiedendo a vigili e
operatori del Quadrifoglio la ragione reale di quest’ordinanza, la risposta che
si ottiene è sempre la solita: “Non abbiamo deciso noi, è un ordine del comu-
ne, a cui non piace che questa piazza sia così frequentata per tutta la notte”.
A un certo punto, dal lato del sagrato vola una bottiglia verso l’angolo ester-
no; dopo pochi minuti una seconda, poi un’altra ancora. I carabinieri sono
rimasti fermi, parlano tra loro, e uno dice: “Se rimaniamo qui tra poco ci bec-
chiamo una bottigliata in testa”. Gli altri sembrano essere d’accordo. Tornano
indietro e si mettono accanto ai camion a parlare con gli uomini del
Quadrifoglio. Dopo qualche minuto i camion fanno inversione e se ne vanno dal
fondo della piazza, mentre i carabinieri escono dall’ingresso principale. La
gente crea un corridoio silenzioso che lascia passare il furgone. A un tratto,
arrivati all’altezza del marciapiede del Cabiria, una ragazza sale sulla scalet-
31
ta che c’è sul retro del furgone e improvvisa una danza che dura fino all’in-
crocio con via Maggio. La gente applaude lo spettacolo, mentre i carabinieri
fanno finta di nulla, e vanno via. Per stasera niente pulizie.
Sabato 8 luglio- Riprendono regolarmente le pulizie, con una scorta più con-
sistente di forze dell’ordine. Tutti si rendono conto dell’assurdità della cosa,
ma che fare?
Giovedì 13 luglio- Ormai la scena si ripete da dieci giorni, e la dinamica è sem-
pre la solita: le persone che decidono di rimanere, un numero maggiore
rispetto ai primi giorni, si spostano verso il centro della piazza o all’angolo
del Cabiria, aspettano che la pulizia finisca per poi tornare a sedersi. Stasera
ci sono dei ragazzi che, ironizzando sull’ordinanza, distribuiscono fogli di
giornale da mettere sui gradini bagnati.
Andati via i camion, le scale sono cosparse di giornali e la gente rimasta si
siede.
Seconda metà di luglio, primi di agosto. La piazza è sempre meno frequenta-
ta, la gente sta partendo per le vacanze, c’è la Festa dell’Unità alla Fortezza
da Basso dove si trovano i bar e le discoteche più alla moda della città: i prez-
zi sono ovunque altissimi, però i concerti sono gratis. Ma quello che più sco-
raggia le persone a frequentare la piazza è senza dubbio l’operazione di puli-
zia notturna, che costringe a spostarsi o ad andarsene ogni sera alla stessa
ora, come una sorta di chiusura della funzione pubblica dello spazio. È curio-
so notare che la pulizia viene fatta anche se ha piovuto tutto il giorno, e
quindi la piazza è già pulita e non c’è stato nessuno. Già nei primi giorni di
agosto si nota che la popolazione della piazza è sottoposta a una selezione
progressiva. Le persone che rimangono, e che incontri tutte le sere, sono
quelle che non hanno i soldi per andare in vacanza e che non si fanno sot-
trarre gli spazi dalle ordinanze del sindaco.
Agosto.A parte lo spopolamento della piazza, qualcosa si muove e in un certo
senso si rinnova.
Ogni notte qualche musicista di strada si ferma in piazza a suonare e nel giro
di pochi giorni si crea una band improvvisata che arriva verso le 2 di notte, si
unisce al gruppo dei frequentatori assidui e suona (chitarra, contrabbasso,
percussioni, sax, voce). Questo trasforma la geografia notturna della fre-
quentazione e della sosta: per fare in modo che la musica non disturbi gli abi-
tanti non si sta più sul marciapiede all’angolo del Cabiria, e quindi ci si sposta
sul palco nella parte centrale della piazza, la più lontana dalle abitazioni. Di
solito i carabinieri vanno via verso le 2, e intorno alle 4/5 della notte passa-
no sempre un paio di pattuglie di polizia a dare un’occhiata; non sono mai
arroganti, e spesso si fermano a fare due chiacchiere: la città è veramente
vuota, tutti sono in vacanza, e forse anche i poliziotti si annoiano e vengono
in piazza a sentire un po’ di musica...
Settembre.La gente è tornata dalle ferie, ma la piazza non è più affollata
come nelle serate di luglio. L’operazione di pulizia ha avuto l’effetto deside-
rato, le persone preferiscono andare in altri posti piuttosto che avere l’ap-
puntamento fisso con i camion del Quadrifoglio. Rimane comunque il gruppo
dei frequentatori assidui che, mescolandosi con gli abitanti del quartiere,
continua in qualche modo a mantenere in vita la dimensione pubblica della
piazza, anche nelle ore notturne. Le situazioni di incontro e di sosta si adden-
sano in corrispondenza dei bar e dei ristoranti, che con i grandi ombrelli a
coprire i tavoli esterni simulano per certi versi la funzione dei loggiati,
offrendo ripari anche quando il tempo comincia a essere non più favorevole
agli incontri negli spazi aperti. Altri luoghi interni alla piazza sempre fre-
quentati sono i gradini della chiesa, la fontana e il molo.
Ottobre.Finita la bella stagione, la piazza, che continua a essere molto fre-
quentata solo nei pomeriggi assolati, torna a una dimensione di quartiere.
32
“... aumentano i senza casa e gli sfrattati, e paradossalmente aumentano
anche le case sfitte. Aumentano gli affitti ma i salari restano, per tanti, sala-
ri da fame. In questo quadro desolante l’amministrazione comunale pare
scomparsa, pronta ad avallare solo progetti che rendono denari, come nel
caso delle Murate, una speculazione che porterà alberghi e negozi, dopo che
per anni avevano parlato di alloggi in edilizia residenziale pubblica, di ripo-
polamento del centro cittadino, di strutture sociali e sanitarie per il quartie-
re di Santa Croce.
TUTTO CANCELLATO, I BISOGNI DEGLI ABITANTI NON SONO NIENTE DAVANTI ALLA
POSSIBILITÀ DI INCAMERARE RICCHEZZA...
sabato 25 novembre in Santa Croce contro lo stillicidio di sfratti esecutivi nei
confronti degli abitanti e contro la truffa delle Murate appuntamento alle ore
9,30 nel giardino di via dell’Agnolo."
(dal volantino a firma “L’assemblea del movimento di lotta per la casa”, “Di
nuovo in piazza contro i padroni della città” diffuso in occasione delle tre
manifestazioni di zona tenute fra novembre e dicembre 2000)
MOVIMENTO DI LOTTA PER LA CASAMANIFESTAZIONE S. CROCE 25/11/2000 Marvi Maggio
Il Movimento di Lotta per la Casa nasce a Firenze nel 1990, in concomitanza
con l’acutizzarsi e l’estendersi di processi di valorizzazione fondiaria ed
immobiliare che rendono la questione abitativa sempre più pressante. Il suo
scopo è garantire il diritto alla casa attraverso l’azione diretta, l’auto-orga-
nizzazione e l’autogestione. La pratica delle occupazioni di immobili inutiliz-
zati e della difesa degli inquilini dagli sfratti, si inscrive in una lotta com-
plessiva contro i responsabili del problema abitativo: proprietari fondiari,
imprese immobiliari ed istituzioni.
All’amministrazione ed allo Stato il movimento chiede di requisire le case sfit-
te, sanzionare gli affitti in nero ed allargare l’offerta di edilizia popolare. Lo
sforzo è quello di inserire la costruzione di strutture autonome, esterne alla
logica del mercato e del profitto, come le occupazioni, all’interno di una lotta
in grado di “aggredire” i meccanismi ed i termini complessivi delle contraddi-
zioni sociali, in modo da trovare soluzioni collettive e condivise invece che
individuali e selettive.
Le occupazioni sono quindi affiancate da manifestazioni, presidi, occupazioni
simboliche di luoghi come il duomo, il consiglio comunale e piazza della
33
Giardino di via dell’Agnolo angolo via Borgo
Allegri. 25 novembre 2000 ore 10,
Manifestazione del Movimento di lotta per
la casa e del Comitato Santa Croce. Ci sono
già un po’ di persone davanti al giardino:
italiani, maghrebini, cinesi, rumeni, polacchi,
eritrei, di tutte le età. Appoggiato al cancel-
lo di ingresso c’è il pannello suddiviso in
quadri che illustra la vicenda delle Murate,
dalle promesse di un intervento di edilizia
sovvenzionata e di servizi per i residenti
del centro storico, alla resa alla logica spe-
culativa, che verrà raccontata dalla bandi-
trice un po’ di volte lungo il percorso.
Signoria, da accuse e proteste nei confronti delle immobiliari, da rappresen-
tazioni teatrali di strada che mettono in scena tematiche legate al diritto alla
casa. È un modo per imporre all’attenzione dell’intera città i propri obiettivi e
le proprie pratiche, alla ricerca di solidarietà e dell’allargamento della lotta
per il diritto alla città.
Il Movimento fra il novembre e il dicembre 2000 indice tre manifestazioni di
zona “contro i padroni della città” nei quartieri di Campo di Marte, Santa
Croce e Castello, individuati in relazione alla presenza di occupazioni o per
l’elevato numero di sfratti. L’obiettivo è creare vincoli di solidarietà fra gli
occupanti, gli sfrattati, i senza casa e gli altri abitanti della città, e far cre-
scere la consapevolezza delle cause che stanno alla base del problema abita-
tivo. Il corteo che si snoda per Santa Croce assume un significato particolare:
questo quartiere, popolare e proletario fino agli anni Settanta, ha progressi-
vamente perso il suo carattere ed ora si trova allo stadio finale di un proces-
so di espulsione della popolazione e delle attività che non sono in grado di
sostenere i prezzi imposti dal mercato fondiario ed immobiliare.
È il luogo dove è nato il Movimento di lotta per la casa e dove sono state
attuate la maggior parte delle prime occupazioni. Con questa manifestazione
attraversiamo i luoghi della memoria storica della sinistra rivoluzionaria fio-
rentina, e contemporaneamente assistiamo ad una protesta che rende visibi
li i propri valori: la solidarietà, l’uguaglianza nella diversità e la socialità
senza discriminazioni, ed esplicita ancora una volta i propri obiettivi: contra-
stare gli effetti della logica del profitto e della rendita sul territorio e riaf-
fermare il diritto alla casa ed allo spazio per tutti.
Il Movimento di Lotta per la casa, nel 2001 comprende circa 350 persone ed
autogestisce dodici occupazioni cinque delle quali in immobili di proprietà pri-
vata: si tratta di fabbriche, alloggi, un ex manicomio, un ex ospedale psichia-
trico infantile, un ex asilo nido vuoti da tempo. Delle dieci occupazioni pre-
senti nel 1993 solo quattro hanno resistito fino ad oggi; molti altri edifici sono
stati occupati, molti sono stati sgomberati. Le prime occupazioni nate nel
periodo dello scoppio del movimento degli studenti della Pantera e nel perio-
do ascendente della diffusione dei centri sociali, vedevano una grossa parte-
cipazione di giovani e studenti, cui si sono aggiunte le famiglie dei quartieri
popolari e successivamente, dopo il 1994, gli immigrati.
34
“La nostra storia nasce nel 1990 in relazione ad un bisogno casa che all’epo-
ca era particolarmente sentito tra le persone: le coppie, i giovani e alcune
famiglie italiane. Molti erano studenti, altre erano famiglie dei quartieri che
non riuscivano a soddisfare il proprio bisogno abitativo. Ci furono un insieme
di incontri alla sede che all’epoca era dell’Unione Inquilini. Non c’era ancora il
costituendo movimento di lotta per la casa. In queste prime riunioni fu deli-
neato un primo programma che partì da uno stabile abbandonato in via di
Mezzo al numero 39: c’era stata una grossa speculazione, una storia di tan-
genti di Cragnotti, e qui i lavori non erano mai cominciati. Occuparono una
famiglia del quartiere e alcuni ragazzi studenti universitari. Erano due allog-
gi. E in più si fece una prima sede del movimento... subito dopo siamo riusci-
ti ad organizzare un’occupazione di uno stabile in via del Giglio, che è stata
abbastanza famosa, perché entrò in questa contraddizione sul diritto all’abi-
tazione, in un momento in cui esplodeva anche il fenomeno dei centri sociali
e la questione studentesca legata alla Pantera. Per cui veniva portata questa
contraddizione sul diritto all’abitare nella città, in particolare in quel momen-
to, nel centro cittadino. Questa occupazione di via del Giglio era mista: com-
prendeva famiglie, tantissimi giovani, coppie. Non c’era ancora in questa
prima fase del movimento questo fenomeno migratorio di famiglie immigra
te. Questo è legato agli anni successivi. C’era un bisogno degli studenti e di
famiglie italiane, anche dei quartieri popolari, che non riuscivano a soddisfa-
re il proprio bisogno abitativo. Poi voi pensate al contesto, affitti sempre più
cari, una speculazione che cominciava a macinare denari su denari, nessuno
riusciva a rispondere a questo bisogno casa”.
“...nello stesso anno alcune famiglie autonomamente, collegandosi al movi-
mento di lotta per la casa, occuparono sei alloggi in via Manni, angolo via
Gelli. Vennero a parlarne con noi. Si costituirono anche loro con il Movimento
di Lotta per la Casa. Erano tutte famiglie di Coverciano che abitavano con i
genitori o nelle case popolari però con una forma di sfratto... In quel momen-
to diventò determinante l’occupazione di via Manni perché dava una dimen-
sione popolare ad una questione che stava esplodendo...Subito dopo se ne
organizzò altre sei. Sempre case in edilizia pubblica. L’Unione Inquilini dava il
sostegno, esterno, però c’era, per lo meno in tutti i primi mesi del movimen-
to...si occuparono anche alcuni alloggi in via Ghibellina e in via delle Casine,
tre alloggi”.
Il corteo parte, percorre Borgo Allegri,
attraversa il vicino mercato di S. Ambrogio,
passa dalle Murate e piazza Santa Croce. In
quest’area negli anni ‘70 erano concentrate
le sedi storiche dell’estrema sinistra. Nei
primi anni ‘80 in via di Mezzo 46, già sede di
Lotta Continua per il Comunismo, si forma il
Centro di Comunicazione Antagonista, dal
quale hanno avuto origine il Movimento di
Lotta per la Casa, il centro sociale ex-
Emerson, la Camera del Lavoro Sociale, il
mensile Comunicazione Antagonista.
Lì vicino si trova il Quadrilatero con via di
Mezzo 39, la prima occupazione del
Movimento di lotta per la casa.
35
“Il primo moto repressivo fu a giugno luglio del 90. Sgomberarono lo stabile
di via del Giglio e contemporaneamente quello di via Ghibellina, che erano
alloggi, con un livello di pesantezza dell’ordine pubblico enorme...In modo
spontaneo fu rioccupato la sera stessa lo stabile di via Aldini, dagli occupan-
ti di via del Giglio e da alcuni di via Ghibellina, non tutti... Il giorno dopo si
riuscì a sentire i poliziotti che parlavano di sgomberare le case di via
Manni...si riuscì ad organizzare l’occupazione la sera stessa, e la difesa alle
sei di mattina dell’occupazione di via Manni... L’anno dopo ci sono stati altri
sgomberi in via di Mezzo, però siamo riusciti in quei due, tre anni a ricostrui-
re un minimo di lavoro serio sui senza casa e sulla questione degli sfratti che
stava venendo fuori in modo prepotente nella città”.
“Questo è stato un po’ l’inizio. Poi ci sono stati degli anni di costruzione di
alcuni percorsi, alcuni sono riusciti, altri sono falliti. Ci sono state nuove occu-
pazioni, sono state sgomberate alcune case e ne sono state rioccupate altre.
Diciamo che c’è stato un periodo transitorio che è durato più o meno fino al
‘94. Nel ‘94 il movimento sceglie di cominciare a fare occupare anche famiglie
immigrate, perché riconosce i diritti delle persone che venivano anche da
altre terre e vivevano e lavoravano in questa città... Diciamo così: non è faci
le. Facciamo questo passo con l’occupazione di via del Romito... e con l’occu-
pazione di via Primo Maggio a Sesto Fiorentino, dove occupano sia famiglie
italiane, sia famiglie immigrate. Non è stato tutto rose e fiori, no anzi, però
poi piano piano... diciamo che i problemi non sono nati sulla questione del-
l’immigrazione, ma quando ci sono stati comportamenti che sono propri di
tutti i tessuti sociali che vivono situazioni di disagio”.
Dopo esperienze di occupazioni monoetniche che tendevano a mettere in atto
processi di esclusione, ora si cerca di realizzare in ogni occupazione un mix di
diversi gruppi di provenienza. In un primo tempo il rapporto fra italiani e
immigrati era equilibrato, ora la presenza di stranieri è sempre più prepon-
derante. La maggior parte degli occupanti oggi sono immigrati, oltre che
famiglie italiane a basso reddito e studenti fuori sede. La convivenza fra per-
sone differenti per cultura e valori talvolta è difficile, crea conflitti ma anche
crescita, per quanto faticosa. Impone di mettersi in discussione, ma anche di
escludere chi ha atteggiamenti discriminatori che contrastano fortemente
con le prospettive sociali e politiche del movimento.
Un problema particolare è costituito dal ruolo delle donne che, nelle culture di
alcuni gruppi di immigrati, è particolarmente subordinato: quelle “di una
Il corteo si conclude in piazza San Pierino.
La stessa piazza dove il 15 dicembre 1990,
una festa popolare contro l’eroina e per
rivendicare più spazi in città, organizzata
dall’Emerson e dal Circolo Sportivo autoge-
stito Spartaco, era finita con l’intervento
della polizia e con l’arresto di due compagni
per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
In piazza San Pierino c’è il sole, si fa festa e
si balla, con l’arco in controluce e l’infilata
di via Palmieri, dove si trova la nuova sede
del Movimento...
36
QUADRO 1Potete qui vedere il triste carcere delle Murate
Dove sono stati a marcire di giorno e di notte,
tra scarafaggi, topi e botte:
ladri, barboni, occupanti di case,
truffatori e puttane,
morti di fame,
sindacalisti,
ubriaconi, anarchici e comunisti.
QUADRO 3Passano i giorni, i mesi, gli anni
ma non succede niente,
di discorsi se ne fanno ancora
ma le Murate vanno in malora.
Solo d’estate c’è un locale nel cortile:
una birra 10.000 lire.
QUADRO 2Ma nell’anno 19.. ecco il nuovo carcere di
Sollicciano (un pò fuori mano)
le Murate restano vuote e sole
e inizia il tempo delle belle parole.
Si chiamano architetti,
si fanno grandi progetti
si organizzano convegni,
si prendono impegni:
si faranno alloggi popolari
botteghe artigiane e servizi sociali.
occupazione non vanno alle assemblee perché non le fanno uscire”. Non sono questioni facili da affrontare e il
Movimento di lotta per la Casa cerca di farlo “con la pazienza e con la discussione, fin quando si può”. In casi estremi
il movimento ha sempre preso provvedimenti prontamente, fino ad espellere chi aveva comportamenti inaccettabili.
Invece le situazioni meno eclatanti, ma più diffuse, di discriminazione e violenza nei confronti delle donne, risultano più
difficili da trattare e da risolvere, malgrado i tentativi non solo del Movimento, ma anche delle donne del centro socia-
le ex Emerson e di alcune occupanti. C’è da fare ancora un lungo lavoro, ma la convivenza crea i presupposti per supe-
rare gli stereotipi ed affrontare i problemi collettivamente, costruendo una alternativa reale fondata sull’accettazione
dell’altro e sul rispetto reciproco.
Per il movimento di lotta per la casa andare con le famiglie di immigrati occupanti nei quartieri popolari a difendere gli
inquilini dagli sfratti è un modo per favorire la creazione di reti di solidarietà e di conoscenza reciproca.
Abitare in una casa occupata implica un impegno nelle iniziative del movimento e un lavoro di sensibilizzazione nel quar-
tiere in cui ci si trova. In ogni edificio occupato c’è una stanza per le assemblee settimanali che vertono sulla gestione
della casa e sulle iniziative da prendere. Al lunedì invece si tiene l’assemblea del Movimento di lotta per la casa, che
coordina le attività e mette in discussione le proposte.
Nella sede esiste uno sportello sull’emergenza casa e sugli sfratti al quale si rivolge chi ha problemi abitativi: si trova
assistenza legale e si discute insieme agli attivisti del movimento sulle soluzioni possibili. Chi vuole occupare deve tene-
re conto anche degli oneri che questa scelta comporta: rischio di sgomberi con la polizia in assetto di guerra, denuncie
e processi, impegno a difendere gli inquilini dagli sfratti che avvengono in città e tutte le occupazioni del movimento.
Gli occupanti hanno tutti un reddito basso e alcuni sono disoccupati o sottoccupati. L’offerta pubblica è insufficiente
rispetto al loro bisogno. Molti non sono ammessi alle liste per l’accesso all’edilizia popolare, per esempio i singoli. Fra
gli occupanti c’è chi ha coscienza politica e chi ha semplicemente bisogno di una casa e questo è l’unico modo per otte-
nerla. Il movimento si impegna da sempre nella difesa degli sfrattati e negli ultimi anni contro i centri di “permanenza
temporanea” per gli immigrati e in favore del diritto al permesso di soggiorno per tutti.
“...si parla inizialmente di diritto alla casa, ma poi anche di avere occupazioni in diversi punti della città e di far vede-
re che rappresentano un modo di vivere fra di noi e di rispondere ai bisogni”.
“Abbiamo avuto un momentaccio nella nostra storia, che è stato fra il 95 e il 96, nel momento di maggior forza, che è
stato rappresentato dagli organi repressivi. Dopo l’occupazione del Duomo e del Consiglio Comunale c’è stata una onda-
ta repressiva fortissima, alimentata da una serie di figure di pentiti del movimento che ci hanno messo in difficoltà per
lo meno un anno e mezzo. Tutte le iniziative del movimento per un anno e mezzo sono state blindate dalle forze del-
l’ordine. È partita una inchiesta, che per fortuna non ha avuto conseguenze, per il reato di associazione per delinquere
per una decina di noi”.
37
QUADRO 4Ma arriva una proposta ben più conveniente,
allettante,
convincente.
Chi se ne frega di sfratti,
case e servizi sociali,
i privati si occupano solo di affari e capitali.
Faranno un grande albergo
con parcheggio a tergo
e negozi per vendere e farci spendere.
QUADRO 5Il nostro sindaco è contento:
ma che bell’affare, se ne può parlare,
un bell’albergo!
Un bel centro commerciale!
Fare le case per la gente
si sa che non rende niente.
E’ il nuovo che avanza:
800.000 lire per una stanza.
Per l’occupazione del Consiglio Comunale del 6 novembre 1995 ci sono stati 17 rinvii a giudizio per interruzione di pub-
blico ufficio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza. Tre dei 17 inquisiti diventano collaboratori di giustizia
e consentono di montare un processo per il reato di “associazione per delinquere”. I tre collaboratori insieme ad altri
ex occupanti, in tutto quattro italiani e due immigrati, accusano gli attivisti del Movimento di essere “attestati su posi-
zioni ideologiche estremiste facendo della lotta per la casa unicamente uno strumento per contrapporsi allo Stato” (“Le
tappe del processo per l’occupazione del Consiglio Comunale”, Comunicazione Antagonista, n.11, dicembre 1998). La
magistratura e la polizia puntano a sostenere che il Movimento di lotta per la casa è un organismo in cui si sono “infil-
trati” esponenti della locale autonomia, che avrebbero formato una sorta di cupola che lo controlla, tenendo in ostag-
gio i senza casa per costringerli a contestazioni violente contro lo stato. L’accusa è stata archiviata, ammettendo che
gli scopi del movimento non sono altro che lottare per affermare il diritto alla casa.
“.. E quello è stato il momento più difficile... eravamo impossibilitati proprio a fare occupazioni. Ne avevamo fatta una
in una palazzina alle Cascine: è stata sgomberata dopo due mesi da 50 vigili e 200 poliziotti, con botte agli occupanti.
Le cocche le tirarono i vigili, furono i vigili che spaccarono le case, riempirono di botte gli occupanti. Insomma è stato il
periodo peggiore nella nostra storia”.
“Il primo momento di tregua è stato probabilmente quest’estate (1999) quando hanno accettato un insieme di proposte,
cioè un tavolo pubblico sull’autorecupero. Una soluzione non di ordine pubblico per due occupazioni...”
Per garantire agli occupanti la permanenza nelle loro case, dal 1993 il movimento propone al comune di “legalizzare”
l’autorecupero già in atto nelle occupazioni, come modello replicabile di soluzione alla questione abitativa, fondato sulla
partecipazione degli abitanti alla progettazione ed alla costruzione, sull’autogestione, sul recupero e quindi sul rici-
claggio di risorse altrimenti destinate all’abbattimento e al non utilizzo. Tuttavia fino al 1998 non ha ottenuto alcuna
attenzione da parte delle amministrazioni di diverso colore politico che si sono succedute nel corso del tempo.
L’autorecupero prevede la permanenza degli occupanti negli stabili occupati e la loro partecipazione alla costruzione
delle parti non strutturali, mentre il Comune si dovrebbe far carico delle altre. Via Aldini, l’ex Asilo Ritter, cui si è suc-
cessivamente aggiunta San Salvi, la prima di proprietà della ASL e le altre due del Comune, sono state proposte come
candidate di questa nuova pratica. Per il momento l’amministrazione ha accettato la sperimentazione solo sull’Asilo
Ritter, pretendendo la formazione di una cooperativa e mettendo in dubbio il diritto degli occupanti degli altri edifici a
rimanere nelle loro case.
“ora... siamo di nuovo con l’acqua alla gola sia sull’emergenza abitativa sia sulla questione degli sfratti, perché per la
questione degli sfratti le uniche soluzioni che ci propongono sono queste dei contributi. E di sfratti ne abbiamo tanti”.
(intervista a un attivista del Movimento di Lotta per la Casa)
L’obiettivo è “ un progetto più ampio di ricomposizione sociale tra tutti coloro che vivono il problema abitativo e che lo
vogliono collegare a tutte le battaglie contro questa forma di società”.
(“La nuova fase del Movimento di lotta per la casa”, Comunicazione Antagonista, n. 8, giugno 1998)