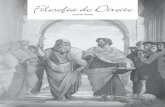*Filosofia scientifica versus Filosofia della scienza*
Transcript of *Filosofia scientifica versus Filosofia della scienza*
Filosofie scientifichevecchie e nuove
A cent’anni dal IV Congresso Internazionale
di Filosofia
a cura diMario Castellana
Ornella Pompeo Faracovi
Laboratoire“Pensée des sciences”
Volume stampato con il contributo del Centro Studi Enriques di Livorno e del Dipartimento
di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento
ISBN volume 978-88-6760-189-9ISSN collana 000-000
2014 © Pensa MultiMedia Editore s.r.l.73100 Lecce • Via Arturo Maria Caprioli, 8 • Tel. 0832.23043525038 Rovato (BS) • Via Cesare Cantù, 25 • Tel. 030.5310994
www.pensamultimedia.it • [email protected]
INDICE
Prima parte
7 Cent’anni dopoOrnella Pompeo Faracovi
________________________
27 La filosofia italiana verso il Congresso internazionale del 1911 Maurizio Torrini
________________________
43 Federigo Enriques e la volontà del veroMario Castellana
________________________
71 Filosofia scientifica versus filosofia della scienzaAlberto Peruzzi
________________________
103 Note sur le synthétique a prioriJean Petitot
________________________
109 Scientificità e storia. Note sparseLuca Maria Scarantino
________________________
125 Sur les traces du IV Congrès international de Philosophie:Gaston Bachelard face aux mathématiquesCharles Alunni
________________________
155 La storia della filosofia scientifica. Tra Enriques e EinsteinMassimo Ferrari
________________________
Seconda parte
187 Appendice La polemica fra Croce e Enriques(a cura di O. Pompeo Faracovi)
191 Intervista a Guido De RuggieroBenedetto Croce
199 Polemiche e non polemiche col prof. EnriquesBenedetto Croce
201 Esiste un sistema filosofico di Benedetto Croce?Federigo Enriques
215 A proposito di una criticaBenedetto Croce
217 Mettiamo le cose a postoFederigo Enriques
221 Ancora del prof. EnriquesBenedetto Croce
223 Risposta a Benedetto CroceFederigo Enriques
229 Indice dei nomi
Il mio contributo è dedicato a Ornella Pompeo Faracovi, direttrice del CentroStudi Enriques, per l’ammirevole impegno con cui da tanti anni si è dedicataa far conoscere l’opera, e l’eredità culturale, di Federigo Enriques. Ringraziole istituzioni e le associazioni culturali che hanno promosso questo volumein rapporto al centenario del quarto congresso internazionale di filosofia chesi tenne a Bologna nel 1911. Prenderò spunto da alcune riflessioni sul sensoche quel congresso avrebbe dovuto avere nelle intenzioni di Enriques, chel’organizzò, e sugli effetti che invece (non) ebbe in Italia, per impostare unconfronto tra filosofia scientifica e filosofia della scienza.
I caratteri che ascriverò alla filosofia scientifica sono diversi da quelli ge-nerici di una filosofia che attribuisce importanza alla scienza e che con questavuole dialogare; e in particolare saranno un po’ diversi da quelli che Enriquesle ascriveva, ma penso di valorizzare alcune potenzialità presenti nel suo at-teggiamento. Invece di insistere sulle pur dovute correzioni di rotta associateal corso principale della successiva filosofia della scienza, proporrò un paio diidee che si possono riassumere così: 1) l’impulso a ciò che si chiama “filosofiascientifica” è presente anche dove non si usa tale termine e 2) la filosofiadella scienza tende a danneggiare quest’impulso.
Lo spirito del mio intervento intende essere costruttivo, mentre sarà facilepercepirlo come esclusivamente polemico, se non provocatorio. Invito fin d’oraa non ridurne il senso a una contrapposizione manichea: non mi risulta, in-fatti, che esista una legge scritta nella natura, nella storia o nell’essenza delpensiero, che costringa a considerare insuperabile l’alternativa che comparenel titolo. L’alternativa corrisponde nondimeno a un dato di fatto, che ovvia-mente ha le sue radici storiche e i cui effetti sono, a mio parere, perniciosi per-ché allontanano il design concettuale dall’analisi. Chi sottostima l’alternativane favorisce la persistenza e, finché persiste, s’impone una scelta di campo.
Alberto Peruzzi
FILOSOFIA SCIENTIFICA VERSUS FILOSOFIA DELLA SCIENZA
1. Qualche richiamo al congresso del 1911
Nell’intervento d’apertura al IV congresso internazionale di fi-losofia, il 6 aprile 1911 (intervento poi pubblicato su «Scientia»lo stesso anno) Enriques affermava che in quel congresso «se ren-contrent les esprits de cette Renaissance»1. Non era la prima voltache usava quest’ultimo termine. Ma in quale senso si poteva dav-vero parlare di Renaissance? Enriques alludeva a una nuova sta-gione di pensiero, nel segno di un dialogo collaborativo e fecondotra filosofi e scienziati, in Italia così come all’estero. Era, ancor piùambiziosamente, una Renaissance imperniata sulla correlazione traprogresso scientifico e progresso civile, in uno slancio di fratel-lanza trasnazionale. A distanza di un secolo, l’implicito auspicioconserva tutto il suo valore. Nel nostro paese, soltanto negli ultimidecenni si sono avvertiti i segni di una maggiore sensibilità versotale correlazione e questo implica che la nuova stagione, che En-riques pensava essere lì per sbocciare, non sbocciò.
Nel descriverne i caratteri Enriques usava un’espressione si-gnificativa, che non considero semplicemente retorica: la Renais-sance era legata alla ‘recherche de la verité’. E già su questo puntosi potrebbe discutere molto, perché in tale recherche ci sono dueaspetti, ciascuno dei quali vuole la priorità sull’altro. Detto in pa-role molto povere, si tratta di scegliere se privilegiare (a) o (b): a) darsi da fare a capire cosa è vero e cosa è falso, impegnandosi
a spiegare qualcosa del mondo intorno a noi, o qualcosa inpiù di quanto pensiamo di aver già spiegato, ovvero, darsi dafare a capire com’è fatto il mondo;
b) darsi da fare in un’altra attività, impegnandosi a chiarire cosas’intende per ‘verità’ e se poi ha senso, e se è necessario, par-larne o no, ovvero, darsi da fare a capire meglio un concettofamiliare, ma usato e abusato.È chiaro che (a) e (b) sono aspetti connessi tra loro, ma chi
Alberto Peruzzi72
1 F. ENRIQUES, Il problema della realtà, «Scientia», V, IX, 1911, pp. 257-274(anche in Atti del IV Congresso Intrernazionale di Filosofia, Bologna 1911,vol. I, Formiggini, Genova, pp. 5-20).
li sovrappone vive nell’ingenuità. Una volta distinti, quale sce-gliere come prioritario? Una simile scelta prefigura un contrastooggi avvertibile in maniera più marcata ma sicuramente più ni-tida – rispetto a cent’anni fa e il contrasto si è così irrigidito nelcorso del Novecento da segnare il discrimine non solo tra dueatteggiamenti ma anche fra due tipi di pensiero, quello scienti-fico e quello filosofico. Premesso che, se (a) e (b) sono due aspettidi una stessa ricerca, una simile dicotomia è superficiale, il con-trasto si sovrappone piuttosto a quello che intendo tracciare trafilosofia scientifica e filosofia della scienza.
Non vorrei dare l’impressione di voler negare l’evidenza. Che(a) corrisponda all’attività degli scienziati è indubbio. Che (b)corrisponda all’attività che i filosofi del Novecento, grazie ainuovi strumenti offerti dall’analisi logica del linguaggio, hannocoltivato più intensivamente che in tutti i secoli passati, è altret-tanto indubbio. Che questi due tipi di attività siano fra loro di-stinti è, infine, un dato di fatto non meno indubbio. Potevaandare diversamente? Be’, sul fatto che (a) sia qualcosa in cui siavanzi anche riflettendo su concetti e discutendo metodi si puòfacilmente convenire; già un po’ meno facilmente si può con-venire sul fatto che (b) sia qualcosa in cui è proficuo far riferi-mento all’immagine scientifica del mondo; mentre, sul fatto che(a) sia qualcosa in cui la filosofia è coinvolta e non semplicementequalcosa su cui la filosofia riflette, c’è molto meno consenso.Non pochi scienziati sorridono all’idea che la filosofia vi sia coin-volta. È davvero così ridicolo?
Ridicolo è che un filosofo, standosene in poltrona, emettasentenze su com’è fatto il mondo, o più spesso su come non èfatto, e fornisca spiegazioni o previsioni di fatti (come ‘il tra-monto dell’Occidente’ o il fallimento di ogni futuro tentativodi IA). A chi fa questo manca l’umiltà di affrontare le piccole egrandi difficoltà che qualunque seria ricerca si trova davanti. Mase la competenza in materia spetta agli scienziati, se è la scienzache può dire cosa è vero e cosa è falso (o, se preferite, cosa è ra-gionevole credere vero e cosa è ragionevole credere falso), alloraalla filosofia non resta che (b). L’ingerenza della filosofia in (a) èdunque banalmente assurda. Invece così non è se teniamo pre-
73Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
sente la definizione di “filosofia” data da Wilfrid Sellars in unarticolo del 1962: «The aim of philosophy, abstractly formulated,is to understand how things in the broadest possible sense of theterm hang together in the broadest possible sense of the term»2.
Da questa definizione Sellars non traeva un invito di tipoidealmente enriquesiano (solo idealmente, per ragioni che diròpiù avanti) a promuovere un nuovo Rinascimento nel nome diuna filosofia scientifica. Al riguardo, anzi, le parole di Sellars pos-sono anche fuorviare se prese da sole, facendo perdere di vistache nel lavoro filosofico c’è una componente di certosino det-taglio su questioni particolari che non sono, e non possono es-sere, esclusivamente linguistico-concettuali: in filosofia ci sonoesperimenti di pensiero e ci sono metodi in uso oltre che inmenzione, c’è l’impiego di linguaggi formali e c’è rigore argo-mentativo praticato oltre che descritto. Se mettiamo insieme leparole di Sellars con tutto ciò, si delinea una via lungo la qualeprende corpo una filosofia scientifica. Ma una filosofia scientificanel senso che intendeva Enriques?
Torniamo dunque al congresso del 1911. Il resoconto, accuratoquanto schierato, che ne fu offerto a caldo dalla «Revue néo-sco-lastique de philosophie»», celebrava la Renaissance della filosofiain Italia. L’autore del resoconto, Maurice de Wulf, il quale presie-dette anche una delle sessioni plenarie del congresso, così elencavale linee direttrici del Rinascimento filosofico italiano:
Aujourd’hui on rencontre partout des foyers d’activitéphilosophique. Le positivisme d’Ardigô se prolonge; lekantisme a ses admirateurs; le néo-hégélianisme est servipar des hommes de grand talent; la scolastique rajeunieétend son cercle d’influence. Puis les sociétés philoso-phiques se multiplient, les revues philosophiques ga-gnent en importance, les hommes de science les plus
Alberto Peruzzi74
2 W. SELLARS, Philosophy and the scientific image of man, in Frontier of Sciencxeand Philosophy, R. Colodny ed., Pittsburgh Univ. Press, Pittsburgh, 1962;poi in W. SELLARS, Empiricism and the Philosophy of Mind, Routledge &Kegan Paul, London, 1963, pp. 1-40.
remarquables deviennent philosophes par tempérament.Tout fait prévoir que l’Italie occupera dans le mouve-ment philosophique de l’avenir une place grandissante3.
Il positivismo di Ardigò non si è prolungato in alcunché di si-gnificativo. Il kantismo di Martinetti ebbe soprattutto valenzaetica, non epistemologica, tant’è che non si preoccupava di fare iconti con gli sviluppi della scienze, naturali o sociali, come invecesuccedeva nelle scuole neokantiane in Germania. Il neo hegelismoera sicuramente ‘servito’ e avrebbe lasciato un’impronta profondae duratura, ma antiscientifica. La neo-scolastica era animata da am-mirevole fervore che però poco si preoccupava di misurarsi conil fatto che la scienza moderna, dalla rivoluzione del Seicentoin poi, è stata caratterizzata dall’abbandono delle categorie ari-stoteliche e, per dirla con Cassirer, da un progressivo passaggioda concetti-di-sostanza a concetti-di-funzione. Quanto, infine,all’affermato nesso tra la crescita del dibattito filosofico e l’in-cremento della coscienza filosofica degli scienziati italiani, ...fosse stato vero!
Al congresso del 1911, tra gli italiani assenti spiccavano inomi di Peano e di Gentile. Croce partecipò ma reagì con stizza.Non era d’accordo sull’impostazione data al congresso e si offeseper il ruolo marginale accordatogli, quando è verosimile che giàda prima abbia abilmente fatto il vuoto (locale) intorno all’ini-ziativa. Fra i francesi presenti c’erano Boutroux, Bergson, Dur-kheim, e Poincaré. Quanto ai contributi di inglesi, americani etedeschi, pochi furono quelli di rilievo (per esempio, Meinong)e comunque ebbero una corposità filosofico-scientifica non ec-celsa. Vaihinger non poté intervenire ma inviò la relazione. Ri-salta un dato: non c’erano né Russell né Husserl. Strano cheEnriques non ci abbia pensato ... Se l’ha fatto, sarebbe interes-sante sapere come mai non presero parte al congresso.
Enriques aveva scelto di trattare nella sua prolusione il pro-blema della realtà, senza però dar segno di aver presente le sottili
75Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
3 Cfr. «Revue néo-scolastique de philosophie»», 70, 1911.
analisi che da Platone in poi ne erano state fornite dai filosofi esenza distinguere i numerosi sensi del termine ‘realtà’. Si limitavaa distinguere due tipi di realtà: quella scientifica e quella religiosa.Il che aveva un immediato corollario: se i filosofi non parlanodella prima (perché non sanno parlarne), non resta loro che par-lare della seconda. Non è solo da parte degli idealstoricisti nostraniche sarebbe stato difficile essere d’accordo sul fatto che la meta-fisica è per forza ‘religiosa’. Finché Enriques dava alla contrappo-sizione il senso di una dicotomia tra giudizi fattuali, empirici,sperimentalmente suffragati, e giudizi metafisici, che postulanoinvarianti sub-fe nomenici, il carattere ‘religioso’ non entrava ne-cessariamente in gioco. Nel momento in cui questi invariantisono investiti-di-valore, come in effetti Enriques intendeva, lafede nella loro esistenza poteva aprire la porta alla religione.
Come concessione al dialogo, i due piani – esortava Enriques– non devono essere confusi e, se li teniamo ben distinti, non c’ècollisione; tuttavia, non vanno neppure pensati come immuni dareciproche influenze, perché anche nella scienza si cercano inva-rianti. E come si configurano queste influenze? Dovrebbero con-figurarsi sotto il profilo epistemologico mentre, stando al discorsoproferito al congresso, il profilo sembra essere soprattutto psico-logico e storico. A parte quest’inconveniente, la saldatura è indi-viduata da Enriques nel fatto che la conoscenza scientifica,sempre parziale, tende verso un suo ideale completamento, nelsenso di convergenza a un limite, che resta trans-empirico. Milimito a fare due osservazioni al riguardo. La prima è che, salvol’uso del termine ‘invarianti’, l’accenno al completamento ripro-pone pari pari una tesi kantiana espressa nella Critica della ragionpura, e specificamente all’inizio della Dialettica4. La seconda os-servazione è che Enriques si sbarazza in maniera un po’ tropporapida di un aspetto del ‘problema della realtà’, ovvero quello ri-guardante il realismo diretto, in nome del quale pochi anni
Alberto Peruzzi76
4 Sul senso nient’affatto univoco di questo ideale completamento, mi sonosoffermato nei voll. II e III dei Dialoghi della ragione impura, Aracne,Roma 2009-2011.
prima Moore e Russell si erano ribellati all’idealismo di marcabritannica.
Anche tenendo conto delle varianti sofisticate che l’appello aun realismo del genere avrebbe ricevuto in seguito (e penso so-prattutto alla variante commonsensical, in stile Wittgenstein-Put-nam) il fatto di non battere sul contrasto tra realtà alla mano erealtà scientifica poteva anche essere indizio di una visione piùampia che accoglie in sé entrambe le prospettive, se non fosseche nel discorso di Enriques c’è, sì, un richiamo alle evidenzeempiriche, ma esse sono soltanto quelle matematicamente de-scritte e sperimentalmente certificate: non si lascia spazio aun’ontologia del senso comune e non si asseconda la nostalgiaverso la perduta fusione con la Lebenswelt e i suoi oggetti-alla-mano – era ancora la lezione di Galileo, con il suo richiamo alle“sensate” esperienze.
Una volta che si prendeva la via della continuità invece chedella spaccatura fra due tipi di realtà, restava però inspiegato,come già da parte di Galileo, il nesso tra quantità e qualità. Nonera un difetto esclusivo di Enriques: il problema del nesso eralasciato irrisolto anche dai più autorevoli esponenti del pensierofilosofico-scientifico dell’epoca e tale è rimasto nella successivafilosofia della scienza.
Circa il salto dall’empirico al trans-empirico, la prolusioneesprimeva perplessità sui tentativi di scambiare un’intuizionedelle essenze-valori per un’intuizione della realtà. Non erano iConcettologi locali a fare un simile, immediato, corto circuito– e neanche i neokantiani che riassorbivano perfino lo spazio eil tempo tra i concetti puri. Erano piuttosto Bergson (con ladurée interiore), James (con le sue analisi introspettive), Husserl(con l’intuizione eidetica) e di lì a poco Scheler (che nel 1912avrebbe dato una curvatura psicologica al metodo trascenden-tale). Eppure, un inequivocabile ricorso all’intuizione c’era daparte dello stesso Enriques! E non erano da meno i Concetto-logi, che evitavano il corto circuito per poi far sì che il loro he-gelismo si distillasse in atti intuitivi (a ripensarci, un’operazioneda veri funamboli). Non vorrei essere frainteso: appellarsi all’in-tuizione non è peccato. L’ambito scientifico in cui si studia ‘l’in-
77Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
tuizione’ è però la psicologia. Un secolo fa la psicologia lottavaancora per entrare nel novero delle scienze, quindi l’appello po-teva essere tuttalpiù un invito a indagini ancora da fare. Se l’in-tuizione è invece una sorta di Dio tappabuchi – scientificamenteineffabile – la filosofia potrà anche custodirla come sua, ultimobaluardo contro le invasioni barbariche degli scienziati, ma allorale perplessità di Enriques si applicano (e si dovevano applicare)anche al suo stesso discorso.
Ora, le analisi epistemologiche di Enriques fondevano in-sieme considerazioni di tipo metodologico con considerazioniora di tipo psicologico ora di tipo storico. In relazione alla lo-gica, questa fusione andava incontro a un bel guaio, perché nonsi misurava con le critiche già formulate da Frege e Husserl neiconfronti dello ‘psicologismo’, mentre, in relazione alla geome-tria algebrica, Enriques considerava l’intuizione, scientificamenteallenata, come essenziale. Ne è testimonianza l’episodio, raccon-tato da Fabio Conforto, in cui Enriques afferma di vedere la veritàdi una proposizione matematica di cui non si riesce ancora atrovare la dimostrazione:
Avendogli una volta dichiarato di non vedere la veritàdi un’affermazione, che egli [Enriques] riteneva evi-dente, ma che invano avevamo tentato di dimostrare lo-gicamente, egli si fermò di botto (eravamo nel corso diuna delle abituali passeggiate) e, invece di tentare un’ul-tima dimostrazione, roteò il suo bastone appuntandolosopra un cagnolino sul davanzale di una finestra, dicen-domi: non vede? Per me è come se mi dicesse che nonvede quel cagnolino5.
La visione della verità avrebbe meritato un’analisi che peròmancava, come mancava un chiarimento del rapporto tra le op-zioni (a) e (b). Queste lacune non aiutarono il riconoscimentodell’impegno di Enriques a difesa del valore della scienza. Psico-
Alberto Peruzzi78
5 F. CONFORTO, Intuizione visiva degli enti geometrici, «Periodico di Mate-matiche», IV, XXIX, XXV, 2, 1946, pp. 115-116.
logica, storica, o spirituale, se c’è una dimensione che sfugge allascienza, e se questa dimensione è importante per capire l’Essenzadell’Uomo, la consapevolezza dei limiti della scienza è facil-mente sfruttabile a sostegno di una reazione anti-scientifica. En-riques non poteva immaginare che in Italia la marea montantecui si opponeva avrebbe poi superato ogni soglia di guardia: miriferisco a coloro che allora parlavano di una ‘bancarotta dellascienza’, poi nobilitatasi nella husserliana ‘crisi delle scienze eu-ropee’ e in seguito faustianamente dipinta come ‘dialettica del-l’illuminismo’. Enriques non riuscì a fermarla né ci riuscì,qualche decennio dopo, Giulio Preti. Del resto, la marea si ali-menta anche con gli scrupoli empiristici che l’uno e l’altro ave-vano a cuore; e dunque la croce non può essere messa addossoa Croce (e neanche a Gentile). Sarebbe troppo facile. Dopotutto,se qualcuno ci racconta una frottola, sta a noi riuscire a produrreargomenti dai quali risulti che è tale. Se non ci riusciamo, ab-biamo poco di cui lamentarci.
Avete presente quei signori che un tempo giravano per laMagna Grecia cercando di capire la natura e il posto che l’uomoha in essa? Ecco, quell’attività è caratterizzata da argomenti edalla consapevole preoccupazione per la loro correttezza, nonda suggestivi affreschi, non da paratattici sunti di visioni-del-mondo, non da commenti più o meno letterari a testi immodi-ficabili, non da dotte note biografico-etimologiche a piè dipagina di testi che letterari non volevano essere, e non da discorsiin linguaggio ordinario che prendono come buone alcune no-zioni e stravolgono il senso di altre aggiungendovi un alone evo-cativo, quasi fosse la cosa più ovvia – il tutto a uso dei futurimanuali di filosofia per i nostri licei. Il fatto che dalla MagnaGrecia in poi molta filosofia sia degenerata in chiacchiere eruditenon impedisce di riconoscere la differenza. I filosofi sono spessoaltro da sé, ma la presenza dell’altro non rende qualcuno un fi-losofo. Anche il più coeso quadro storico-culturale, se non è ar-ticolato in argomenti con premesse e conclusioni ben distintole une dalle altre, è insufficiente ad avere un quadro ‘filosofico’in un senso più che colloquiale. Croce era intellettuale liberale,acuto critico letterario, storico di vasta erudizione, abile saggista,
79Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
non filosofo. Gentile era un filosofo, anche se possiamo dissentiredalle sue tesi, peccato che solo vent’anni dopo il congresso bo-lognese si decise a parlare della ‘filosofia delle quattro parole’ conriferimento a Croce e a denunciarne il ‘dilettantismo’. Con pa-role più misurate delle mie, è stato osservato: «Come si sa, Crocenon amava i filosofi ‘di professione’, ma è difficile sottrarsi al-l’impressione che nel suo caso un po’ di professionalità nonavrebbe guastato»6.
Gli argomenti, e quelli dei filosofi non fanno eccezione, pos-sono essere corretti o scorretti. Discutendone la correttezza co-minciamo a fare filosofia. Se invece degli argomenti ci sono solointerpretazioni, facciamo al più storia (h) della filosofia (p). Perchi sottoscriva l’equazione p = h(p), è chiaro che quel che hoappena detto è sbagliato. Bene, allora si produca un argomento(corretto) che si concluda con tale equazione. Dicono che ci sia.Io non l’ho ancora trovato. Esigendo da Enriques di restituire ilmaltolto – la filosofia ai filosofi –, Croce avrebbe dovuto esigerloanche da se stesso.
Il rimedio contro la marea montante non è venuto dalla fi-losofia della scienza e neanche da una sua sofisticata integra-zione epistemologica, pur con tutti i meriti che le possiamo edobbiamo ascrivere, invece di ignorarne l’esistenza o di volga-rizzarne il senso. È a questo tema, e non limitatamente allo sce-nario italiano, che rivolgerò l’attenzione d’ora in poi. Dunquenon entrerò nel merito delle controversie che scaturirono inambito nazionale dal congresso del 1911. Su questo esistonogià numerosi studi e, in particolare, Ornella Pompeo Faracoviè intervenuta più volte. Basti segnalare, per la sua concisa chia-rezza, l’introduzione che ha anteposto alla ristampa anastatica,nel 1990, della raccolta di saggi di Enriques intitolata Scienza erazionalismo7.
Alberto Peruzzi80
6 P. PARRINI, Filosofia e scienza nell’Italia del Novecento: figure, correnti, batta-glie, Guerini, Milano, 2004, p. 71.
7 F. ENRIQUES, Scienza e razionalismo [1912], introduzione di O. PompeoFaracovi, Zanichelli, Bologna, 1990, pp. A-P.
Nel 1911, e specialmente nelle linee ispiratrici del IV con-gresso, la differenza tra filosofia scientifica e filosofia della scienzanon si era ancora definita in modo netto: la discussione si trovavain uno stato simile a quello del gatto di Schrödinger e, una voltache il sistema è stato disturbato ed è uscito dalla sovrapposizione,non possiamo riportarlo a com’era prima. Anche se fosse possi-bile, il recupero di uno stato difettoso sarebbe poco raccoman-dabile. Si è prodotta una biforcazione – o meglio: è giunta acompimento – e conviene essere chiari in merito, prima di pre-occuparci di una convergenza, di là da venire, tra due tipi di at-tività molto diversi.
Inizierò questo chiarimento osservando che nella ricerca(senza aggettivi) c’è tanto una fase di problem solving quanto unadi problem raising, su un piano di parità di valore. Il contributo diciò che per viscosità storica chiamiamo ‘filosofia’ è prevalente-mente associato alla seconda delle due fasi. In realtà, tutto di-pende dal livello di approfondimento al quale si pongono e siaffrontano i problemi. C’è poco di filosofico nel sollevare do-mande che hanno solo una funzione addestrativa per studenti especializzandi in qualche disciplina scientifica. L’inverso (c’è pocodi scientifico ...) credo che valga per la fase di problem solving, mapoiché mi preme mettere l’accento sul problem raising quale trattoelettivo dell’atteggiamento filosofico, è sufficiente che i problemiin questione non siano confusi con quelli che si sa già come ri-solvere restando all’interno di una data cornice teorica.
Se pensate che, andando più a fondo, la differenza tra grandiproblemi filosofici e grandi problemi scientifici sia labile, essendorelativa a quello che di volta in volta è lo specifico assetto delleconoscenze, tanto meglio. L’importante è non confondere l’at-tività del problem raising filosofico con un’attività essenzialmentemetateorica e, nello specifico, meta-scientifica. Evitare questaconfusione è il PRIMO PASSO per intendere il senso proprio diuna filosofia scientifica. (Quindi, tanto per fare esercizio, il po-sitivismo non è una filosofia scientifica e il neopositivismo nep-pure). Tra le domande non metateoriche, la prima difficoltà daaffrontare non sta nel capire che cosa differenzi la via metafisicadalla via della filosofia scientifica, bensì nel farsi un’idea di
81Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
quest’ultima, in modo – ecco il SECONDO PASSO – da evitareun’altra confusione, derivante dal pensare la filosofia scientificacome un tipo di pensiero che, mantenendo una sua autonomiaconcettuale e teorica rispetto alle scienze che ne sono oggettod’indagine, voglia presentarsi come scienza assumendo configu-razione assiomatico-deduttiva. Evitando queste due confusioni,non si è ancora precisato il concetto. Perciò ho l’onere di chia-rire il senso del termine ‘filosofia scientifica’.
2. Filosofia scientifica
Parigi, 1935: Philosophie scientifique è il titolo dell’intervento diEnriques al primo congresso, appunto, di filosofia scientifica. Inquest’intervento le critiche mosse alla filosofia della scienza dimarca viennese-berlinese esprimono il timore che si stia profi-lando una ricaduta nel positivismo, che si dimentichi il farsi sto-rico del sapere, che si ignori il ruolo costitutivo dell’a priori eche non si avverta l’esigenza di unità della scienza. Il timore diEnriques scaturiva da un fraintendimento di cui Paolo Parriniha offerto una lucida analisi in due dei saggi raccolti nel volumesu ricordato. Il punto è che Enriques (e non solo lui) usa il ter-mine ‘filosofia scientifica’ in un senso molto lato rispetto a quelloche intendo proporre, il quale però non coincide con il sensodi ‘filosofia positiva’, non solo come intesa alla fine dell’Otto-cento e nel primo Novecento ma anche come intesa in anni re-centi. È stato infatti lo stesso Parrini a proporre una nuova‘filosofia positiva’ i cui contorni differiscono da (benché pursempre imparentati con) l’uso che del termine era stato fatto inpassato. Personalmente, considero la proposta di Parrini come lapiù equilibrata che il panorama della filosofia contemporaneaha da offrire, ma la filosofia scientifica ha per me un senso di-verso e vorrei appunto esplicitarlo. Se risultasse che i due sensisi possono integrare, e non semplicemente essere compatibili,sarebbe una gradita notizia.
Per gli internauti, segnalo che Wikipedia non ha una voceautonoma per scientific philosophy e rimanda solo a una coppia
Alberto Peruzzi82
di voci, logical empiricism ed experimental philosophy (intesa comenatural philosophy), Nessuna delle due voci coglie nel segno, per-ché nel primo caso abbiamo un esempio (il principale) di filo-sofia della scienza e nel secondo abbiamo quella cosa che hagenerato quanto oggi chiamiamo ‘scienza’. Il secondo caso nonmi crea alcun fastidio, ma appellarsi alla filosofia come madredelle scienze sarebbe un impudico gesto di captatio benevolentiaee lo eviterò, servendomene più avanti in un unico punto, con-trassegnato da @.
Ciò che qui interessa chiarire è non un essere ma un fare. Eb-bene, che cosa si può intendere con ‘fare filosofia scientifica’?Le due principali risposte sono, a mio giudizio, le seguenti. R1. S’intende affrontare problemi classici della filosofia con
gli strumenti offerti dalla scienza (quella che di volta involta è ‘contemporanea’), riformularli di conseguenza, darloro una risposta, trarre spunto dalla loro riformulazionee soluzione per sollevare problemi nuovi circa l’immaginecorrente del mondo; o, nel caso in cui quegli strumentinon consentano di dare una risposta, elaborare argomentibasati sul sapere contemporaneo che ne mostrano l’inso-lubilità oppure argomenti che suggeriscono un possibilemodo di risolverli rivedendo alcuni presupposti dell’at-tuale quadro scientifico.
R2. S’intende sollevare domande di respiro trans-disciplinareche, anche se non fanno parte della tradizione filosofica,sono nondimeno formulabili grazie al progresso della co-noscenza in un qualche campo ed entrano così a far partedella filosofia; s’intende poi l’impegno a rispondere inmodo tale da arricchire un’area scientifica già esistente oda prospettare una nuova area di ricerca consapevoli dellavalenza filosofica delle domande.
R1 e R2 non si escludono affatto. Ma è soprattutto nel faredescritto in R2 che viene svolto il lavoro di design concettuale senzail quale in R1 si andrebbe poco lontano. In R2, la “valenza filo-sofica” può anche essere legata all’adozione esplicita di una par-ticolare prospettiva filosofica ma non è detto che questo legamedebba esserci. Quando c’è, si è subito portati a pensare a una pre-
83Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
costituita visione generale, se non la più generale possibile, mentretale generalità è solitamente un frutto successivo, che giunge (segiunge) dopo numerosi tentativi di risposta, e invece di essereprecostituita, è all’inizio abbastanza indefinita. Di fatto, si pongonodomande, talvolta estremamente specifiche, e le si affrontano conuna batteria di concetti che solo in seguito si dimostrano rilevantiper impostare molte altre questioni. La misura di tale rilevanza èqualcosa di cui all’inizio si può avere solo parziale, se non minima,consapevolezza, o addirittura si può esserne inconsapevoli, comesi può esserlo della pertinenza di certe linee di ricerca scientificaalle questioni da cui si prende avvio in R1, cioè a quelle che nelcorso della storia sono entrate a far parte della filosofia.
La pertinenza alla tradizione filosofica è forte se tale consa-pevolezza è fatta valere nel procedimento risolutivo (per esem-pio, con riferimento a difetti riscontrati in precedenti dottrinefilosofiche riguardanti il problema in esame); è invece debole seconfinata all’interpretazione, in termini della stessa tradizione,di ciò che si sta facendo. Al riguardo è possibile delineare un’am-pia fenomenologia di esempi storici. In alcuni casi si ha fin dal-l’inizio il senso della rilevanza delle nuove domande e dellepotenziali risposte per ridisegnare un’immagine complessiva del-l’area di ricerca interessata o della conoscenza umana in toto, inaltri casi non è così. Che un lavoro specifico di ricerca, tecnicoquanto si vuole, contribuisca a fornire un’immagine coerentedel mondo e prefiguri un assetto in cui componenti prima sle-gate sono ora legate, e componenti prima legate in un modosono ora legate in un altro, con il risultato di farci capire piùcose di quelle che capivamo prima (nel senso della definizionedi Sellars), non è comunque assicurato dalle dichiarazioni pro-grammatiche dei ricercatori. Qui entra in gioco la dimensioneeuristica di una filosofia scientifica e questa dimensione si prestaa essere pesata in più modi. Verrebbe da dire che in passato taledimensione è stata più attestata di quanto sia oggi, ma è da met-tere in conto che quest’impressione può essere dovuta a una de-formazione prospettica.
Quanto al rapporto con la filosofia della scienza, una filosofiascientifica nel senso appena delineato può anche ospitare una
Alberto Peruzzi84
meta-riflessione su linguaggi, teorie e metodi, e più specifica-mente sui linguaggi, sulle teorie e sui metodi che attualmentehanno un ruolo centrale in matematica, in fisica, in biologia ...Ciò fa sì che una filosofia scientifica non escluda temi che sonoappannaggio, solitamente considerato esclusivo, della filosofiadella scienza. Ma il fatto di ospitare una dimensione meta-ri-flessiva non esaurisce il senso della filosofia scientifica e non neè comunque il tratto primario.
Quel che ho detto finora sulla filosofia scientifica è troppopoco per caratterizzarla e per giunta è alquanto vago. A chiunquenon ne condivida lo spirito, le indicazioni fornite risulteranno in-sopportabilmente velleitarie. È chiaro che per precisare quale tipodi fare sia proprio della filosofia scientifica ci vuole ben altro. Potreia questo punto cominciare un lavoro di fino, dando il via a uncrescita esponenziale di distinguo a partire da quelli già accennati.Sarebbe però, come legittimare ciò che chiamo “SCC”, Sindromeda Consapevolezza Critica, di cui molti filosofi della scienza sonovittime, presi come sono da quell’ossessione per le pulizie lingui-stico-concettuali che poi impedisce loro di avere tempo da dedi-care alla comprensione del mondo.
Per avere un’idea concreta di cosa intendo per ‘filosofiascientifica’, mi servirò di un antico rimedio: quello che consistenel fare degli esempi. Non è solo un ausilio, in mancanza diun’appropriata definizione, bensì è tutto ciò che abbiamo a di-sposizione (per un motivo che sarà indicato più avanti). Fornirò,dunque, un elenco di opere che hanno i caratteri della filosofiascientifica, come fin qui rozzamente delineati. Quando, nell’av-vertenza iniziale, alludevo all’impressione polemica, se non pro-vocatoria, che può dare questa relazione, anticipavo l’effetto cheprobabilmente susciterà l’elenco che segue. Ma, prima del-l’elenco, tre precisazioni, il cui carattere lessicale indurrà proba-bilmente chi non condivide lo spirito della filosofia scientifica arivolgermi l’accusa di essere anch’io vittima della SCC.
1. Negli esempi che seguiranno, il termine ‘filosofia scientifica’non è esplicitamente indicato come settore disciplinare d’ap-partenenza. Inoltre, non pochi degli autori delle opere sotto-
85Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
elencate, anche quando fanno riferimento esplicito alla filo-sofia, sgranerebbero gli occhi sentendo dire che quel loro testoappartiene alla filosofia. Tale reazione è in parte dovuta a unimprinting grammaticale: l’aggiunta di un aggettivo a unnome comune lascia supporre che si individui un sottoin-sieme di ciò che il nome denota e quel che c’è nel sottoin-sieme non potrà avere caratteri troppo dissimili da quel chec’è nel suo complemento (entro l’insieme dato), come se peravere una gatta da pelare bisognasse avere per forza una gatta.
2. Non potrebbe andare ugualmente bene l’espressione sim-metrica ‘scienza filosofica”? La risposta è più no che sì. Fermorestando che tanto l’espressione ‘filosofia scientifica’ quantola sua simmetrica, ‘scienza filosofica’, presentano inconve-nienti, nel caso della simmetrica bisognerebbe prestare ulte-riore attenzione a non intenderla in uno dei sensi correnti:quello hegeliano, quello MIUR-esco e quello tipico di certetraslitterazioni formalistiche, più volte tentate nel corso delNovecento, di dottrine filosofiche del passato.
3. ‘Scienza’ e ‘filosofia’ sono parole cariche di troppi sedimenti: inumerosi, e incompatibili, significati che hanno avuto nel corsodei secoli. Unirle in un sintagma nominale crea giustamentesconcerto. Varrebbe la pena, allora, introdurre un nuovo termine?Può anche darsi, ma non me ne viene in mente uno che siapassabile. Ridurre lo sconcerto affidandosi a qualche acronimo,tipo SCIFIL? Non ne vedo la necessità. Piuttosto, se mi è con-cesso un minimo ricorso al lessico matematico, alla filosofiascientifica è associata le composizione di due tipi, H e R, dimappe/processi, ove H corrisponde alla componente descrittain R2 e R alla componente descritta in R1. La collezione dellemappe di tipo H (per Helmholtz) è dunque quella raccoltanell’esponenziale (spazio di funzioni) FS: sono i percorsi che daproblemi scientifici portano alla filosofia. La collezione dellemappe di tipo R (per Riemann) è SF, che comprende la formascientifica che riusciamo a dare ai problemi filosofici ed è quiche prendono corpo gli sforzi di chi s’impegna in un lavoro diprecisazione, formalizzata ed empiricamente significativa, di ideefilosofiche. Potremmo esprimere l’idea guida della filosofia
Alberto Peruzzi86
scientifica nel prodotto FS x SF.Si genera quindi un duplice loop,uno dalla filosofia alla filosofia (passando per la scienza) e unodalla scienza alla scienza (passando per la filosofia). Ciascun loopnon riporta al punto iniziale, bensì innesca un processo mediatodi ‘crescita della conoscenza’. Mettendo da parte la questionedell’inevitabilità o no del processo in H e di quello in R ai finidi questa crescita, è essenziale non scambiare il duplice loop conun doppio circolo linguaggio-metalinguaggio.
3. Esempi di filosofia scientifica
– 1950. Ludwig von Bertalanffy, The theory of open systems inphysics and biology
– 1950. Alan Turing, Computing machinery and intelligence– 1950. Jean Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique– 1957. Noam Chomsky, Syntactic structures – 1958. Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale– 1964. John Bell, On the Einstein-Podolsky-Rosen paradox– 1967. Ulrich Neisser, Cognitive psychology– 1969. Bill Lawvere, Adjontness in foundations– 1970. Jacques Monod, Le hasard et la nécessité– 1972. René Thom, Stabilité structurelle et morphogénèse– 1972. Niles Eldredge, Stephen Jay Gould, Punctuated equilibria– 1972. Gregory Bateson, Steps to an ecology of mind– 1973. George Ellis, Stephen Hawking, The large scale structure
of spacetime– 1973. Konrad Lorenz, Die Rückseite des Spiegels– 1974. Hao Wang, From mathematics to philosophy– 1975. Benoit Mandelbrot, Les objets fractals– 1975. Edward Wilson, Sociobiology: the new synthesis– 1976. Richard Dawkins, The selfish gene– 1979. James Gibson, The ecological approach to visual perception– 1983. Jerry Fodor, Modularity of mind– 1979. Jean Petitot, Morphogénèse du sens– 1986. John Barrow, Frank Tipler, The anthropic cosmological
principle
87Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
– 1986. David Rumelhart, James McClelland, PDP ResearchGroup, Parallel Distributed Processing
– 1987. George Lakoff, Women, fire and dangerous things: whatcategories reveal about the mind
– 1989. Roger Penrose, The emperor’s new mind– 1991. Gaetano Kanizsa, Vedere e pensare– 1997. Ilya Prigogine, Gregoire Nicolis, Self-organization in
non-equilibrium systems
Sette avvertenze sull’elenco che precede: 1) pur limitandosia considerare articoli e libri pubblicati dal 1950 al 2000, è estre-mamente parziale; 2) la selezione è legata ai miei interessi per-sonali (anche se credo, e spero, non idiosincratici); 3) il fatto chealtri possano fornire un elenco diverso non ostacola minima-mente lo scopo dell’elenco qui fornito; 4) non importa se neitesti elencati ci sono idee che condividiamo o no, ma che in essisia stata espressa un’idea da cui scaturisce, direttamente o indi-rettamente, un’esigenza di approfondimento scientifico-filoso-fico e che quest’esigenza abbia avuto conseguenze significative;5) le voci sono in ordine cronologico e non tematico-concet-tuale, il che impedisce di raggrupparle per contiguità di conte-nuti; 6) è solo per semplicità tipografica che invece di una mappac’è un elenco, dal quale non emergono i legami tra contributiin aree distinte; 7) per ragioni di tempo non fornisco le moti-vazioni relative a ciascuna voce dell’elenco, sperando sia chiaroche le motivazioni sono di genere diverso passando da una voceall’altra, dovute ora all’introduzione di nuove idee, ora alla sintesidi idee precedenti, ora a tutte e due le cose insieme.
Nessuno degli autori il cui nome compare nell’elenco è unfilosofo ‘di professione’ o è solo un filosofo: sono matematici, fi-sici, biologi, psicologi ... Ciascuno dei lavori menzionati toccaproblemi filosofici, più o meno classici. Non c’è una sola dellegrandi domande filosofiche, dalle origini greche in poi, che nonsia affrontata in qualcuno di questi lavori.
Gli esempi elencati offrono una prima concreta approssima-zione all’idea di filosofia scientifica. Stando a quest’approssimazione,quali concetti e quali metodi accomunano e con traddistinguono
Alberto Peruzzi88
le domande della filosofia scientifica? Non c’è nessun carattere spe-cifico che le accomuni. Qualora si fosse optato per un elenco dipuzzle più o meno celebri (Paradosso di Banach-Tarski, Dilemmadel prigioniero, ecc.) la cui soluzione ha comportato una discus-sione a un tempo filosofica-e-scientifica, sarebbe emerso un trattopiù particolare (e temo più particolare del dovuto), ma non ancoraun carattere che identifica, tematicamente o metodologicamente,le domande della filosofia scientifica. Quel che vale per le domande,vale anche per le risposte, e viceversa.
Si può semmai notare che in tutti gli esempi è rappresentatoun solo fattore della filosofia scientifica, cioè quello indicato comeH, corrispondente alla spazio FS. En passant, né a FS né a SF ap-partengono testi impostati a partire da due domini del pensiero,F e S, che si danno per già autonomamente costituiti in paralleloe che si cerca di collegare con qualche ponte. Per illustrare un‘im-postazione del genere, ampiamente frequentata dai filosofi dellascienza, ci sarebbe voluto un elenco alquanto diverso. Bene, senell’elenco è rappresentato solo FS, l’altro fattore arriverà da qual-che altra parte. Il primo candidato che potrebbe venire in mentecome fonte del secondo fattore, SF, è la filosofia della scienza. Mail senso della filosofia della scienza è stato diverso. Altre sono statele sue domande e, se anche l’insieme dei percorsi SF vi fosse statoincluso come un aspetto da sviluppare, questo sviluppo non si èverificato o è stato troppo esiguo rispetto a quanto avrebbe do-vuto verificarsi per ottenere il fattore mancante.
4. Filosofia della scienza
Si tratta di un corpus disciplinare ormai consolidato, i cui carat-teri generali è legittimo supporre che siano noti a chiunque oggisi interessi dei rapporti fra scienza e filosofia. In quest’occasionemi preme metterne in rilievo le differenze dalla filosofia scien-tifica e a tale scopo inizierò con due osservazioni.
La prima è che, fin da quando è nata, la filosofia della scienzaha avuto legami strettissimi con l’epistemologia, ai quali si sonopoi aggiunti i legami con la storia della scienza. Quanto ai le-
89Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
gami con l’epistemologia (come pure con la filosofia del lin-guaggio), essi sono evidenti nell’opera di filosofi come VanQuine, Hilary Putnam, Ian Hacking e Paolo Parrini. Quanto ailegami con la storia della scienza, non è che nel primo Nove-cento mancassero, ma si tenga presente che la loro importanzaha impiegato molti decenni a essere apprezzata. Per esempio,l’opera di Pierre Duhem è stata riscoperta solo dopo Quine. Piùin generale, questi legami sono stati riconosciuti come decisivida un’ampia parte della comunità dei filosofi della scienza solodopo la metà del Novecento. E se essi si fanno particolarmentecritici quando si tien conto delle rivoluzioni scientifiche – quellenon dimenticate (Thomas Kuhn) e quelle dimenticate (LucioRusso) –, entrano non meno in gioco anche quando si consi-derano figure specifiche (si pensi al Bacone di Paolo Rossi e alGalileo di Enrico Bellone).
La seconda osservazione è che, se non il marchio di fabbrica,uno dei tratti della filosofia della scienza è stato l’uso esplicito diuno strumento: la logica matematica. È stato questo e rimane que-sto, anche se il ruolo del calcolo delle probabilità è cresciuto, finoa segnare una differenza radicale dalle riflessioni del primo Nove-cento, come per esempio quelle ospitate dal congresso del 1911,che invece ospitavano riflessioni di carattere storico. Dunque, in uncorso universitario di filosofia della scienza si passa, di norma, perl’analisi logica del linguaggio (scientifico), si fissa l’architettura delleteoria scientifiche e si definiscono i caratteri della razionalità insitanel metodo scientifico integrando gli aspetti assiomatico-deduttivicon quelli induttivi, aggiungendo a tutto questo una serie di rife-rimenti storici (dell’impostazione inversa, che parte dalla storia earriva alla formalizzazione, non sono a conoscenza).
La storia della scienza raccontata dai filosofi della scienza ècostellata di Galileo come metodologo, Newton come meto-dologo, Einstein come metodologo. Se le stesse condizioni chedefiniscono la sensatezza di un discorso che pretende di espri-mere conoscenze passano per la verificabilità o la falsificabilità,la filosofia della scienza è molto più di una particolare area dellafilosofia tra le altre. Questa posizione privilegiata emerge ancorpiù se teniamo conto del ruolo che la logica svolge nella filosofia
Alberto Peruzzi90
della scienza. L’ingegneria concettuale che porta dal verificazio-nismo ai gradi di conferma e dal falsificazionismo ai gradi di ve-rosimilitudine reca infatti l’impronta di un approccio formalereso possibile dall’uso della logica come strumento principedell’analisi meta-teorica. L’esplicita considerazione degli schemidi ragionamento individua il capitolo 1 della filosofia e, benchéquest’idea suoni antipatica a molti, oggi come ieri, la sottoscrivo(e con ciò sollecito anche un’immediata accusa di incoerenzacon quanto mi è capitato di dire in altre occasioni – ma i tempisono cambiati e la caduta libera nelle conoscenze di logica daparte dei giovani ricercatori in ambito filosofico-scientifico èben più pericolosa di un’eccessiva enfasi sulla logica.
La progressiva “liberalizzazione” dell’empirismo logico e ledisavventure della concezione popperiana hanno colpito leaspettative verso quell’unità di metodo che, oltre a trovare ri-scontro nella pratica scientifica, avrebbe dovuto avere ancheforza sufficiente per individuare i caratteri distintivi della razio-nalità tout court (senza farla diventare un elastico che, pragmati-camente, si può tirare a piacimento o quasi). La scena si èframmentata, i criteri per valutare l’incisività di questa o quellatesi di filosofia-della-scienza si sono fatti labili. Si è passati dal-l’oggetto “scienza” in generale alla filosofia di singole scienze,fino a sofisticati dibattiti su un particolare problema in un par-ticolare ambito di una singola scienza. È qui che si trovano alcunidei contributi più efficaci degli ultimi decenni: penso alla filo-sofia della geometria, alla filosofia della probabilità (in Italia,Bruno De Finetti), alla logica quantistica (cui, in Italia, MarisaDalla Chiara ha dato contributi di rilievo), all’esame critico cheAdolf Grünbaum ha fatto della psicanalisi.
Su un piano più generale, il guaio è stato che, mettendosi afare i conti con la storia della scienza, i conti non tornavano più.Così, nel caso di Popper, la stabilità del binomio realismo-falsi-ficazionismo giunse a una fase critica negli anni Settanta. Proprionel 1970 uscì un volume, Criticism and the growth of knowledge, incui era ormai chiaro che, ben al di là del caso Popper, l’impo-stazione puramente logico-metodologica mostrava delle crepe.Per tenerla in piedi ci volevano epicicli a non finire.
91Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
Insieme ad altri (prima e dopo il 1970), Imre Lakatos e PaulFeyerabend misero a nudo le difficoltà di una metodologia so-vradeterminata, univoca e statica, e contribuirono alla nascitadella cosiddetta “nuova filosofia della scienza”, nella quale ilruolo dell’apparato logico si riduce e l’asse del discorso si spostasul piano della dinamica storica delle teorie. S’inaugurava l’etàd’oro per gli storici del pensiero scientifico. Sul piano teoretico,se da un lato la struttura portante, ormai manualistica, della fi-losofia della scienza si è raffinata preservandone pressoché im-mutati i caratteri di fondo, dall’altro la morale che molti hannotratto dalla “crisi” di un impianto logico-linguistico unitario haavallato un ritorno a far filosofia come in passato. Non solo si èrispolverato l’equazione p = h(p), ma, a quanto pare, c’è dinuovo posto per tutti: si può tornare a chiacchierare.
Nonostante il trambusto che ho malamente riassunto, è si-gnificativo che, a differenza che per la filosofia scientifica, perla filosofia della scienza si possano identificare i concetti fon-damentali e articolare i settori propri: formalizzazione e assio-matizzazione delle teorie, semantica delle teorie empiriche(modellistica), definibilità dei concetti (ben oltre le osservazionidi Alessandro Padoa e Giuseppe Peano che Enriques non con-siderò), rapporto fra termini teorici e termini osservativi, si-gnificato dei disposizionali e dei controfattuali, natura deiprincipi (a priori, convenzionali, necessari), riduzionismo e an-tiriduzionismo, status delle definizioni coordinative (peccatoche si considerino solo in fisica), metodologia della scienze co-gnitive (per esempio, comportamentismo, vetero e neo – intermini di reti neurali), logica induttiva e interpretazioni dellaprobabilità (si pensi al dibattito sul Teorema di Bayes), causalità,leggi di natura, determinismo e indeterminismo, spiegazione(modello nomologico-deduttivo e suoi limiti, teleonomia edemergentismo), naturalizzazione dell’epistemologia, status delle“verità” matematiche, rapporti tra matematica e fisica, inter-faccia linguaggio quantitativo – linguaggio qualitativo, con-fronto tra immagine scientifica del mondo e immagine delsenso comune. Il tutto cucendo trattazioni molto tecniche evisioni panoramiche.
Alberto Peruzzi92
Su ciascuno di questi temi c’è ormai una letteratura vastis-sima, che è contraddistinta da un approccio metateorico. Questo,ripeto, è anche ciò che primariamente differenzia la filosofiadella scienza dalla filosofia scientifica. In simboli, da una parteabbiamo F(S), con F espressa in un metalinguaggio più o menoformalizzato e S espressa nel linguaggio di una o più teorie ac-coppiate con le relative basi osservativo-sperimentali, dall’altraabbiamo FS x SF. Si tratta anche di due modalità di lavoro cui cor-rispondono atteggiamenti molto diversi, benché vi siano puntidi contatto, talvolta palesi e talvolta latenti. Mi vedo dunque co-stretto a dire qualcosa sulla possibilità di un raccordo tra le duemodalità, anche se di fatto questo raccordo mi sembra ancoralontano dall’aver preso consistenza. Ebbene, si può passare dal-l’una all’altra? In linea di principio, sì. Ci possono essere transi-zioni di fase in entrambi i sensi.
m: FS x SF ! F(S)m*: F(S)!FS x SF
Purtroppo, sono pochi coloro i quali si sono cimentati seria-mente nell’articolazione di questi passaggi. Dunque non consi-dero quegli scienziati che, arrivati al culmine della carriera, simettono a riflettere su quel che hanno fatto, sui rapporti tra laloro disciplina e altre, su problemi filosofici che riguardano illoro specifico ambito di ricerca, sugli scopi della scienza, sui suoiusi buoni e cattivi, sul suo posto nella cultura. Pochi sono infattii contributi di questo tipo capaci di lasciare una traccia signifi-cativa nell’ambito della filosofia della scienza. Ma pochi sonopure i contributi dei filosofi della scienza che partendo da con-siderazioni metateoriche giungono ad avere conseguenze incampo teorico-sperimentale.
Se poi cerchiamo chi si sia interessato alla composizione mm*o m*m, il numero tende a zero. Si capisce: entrambi i passaggisono oggettivamente difficili e rischiosi. Soprattutto, è moltodifficile riuscire a evitare, in m, il rischio di fare un’apologia diquel che si è realizzato nella propria specifica ricerca o il rischiodi restare, in m*, su un piano troppo generale. Che, a dispetto
93Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
delle difficoltà, ci siano state in passato grandi figure di scien-ziati-filosofi nelle quali si trovano compresenti le due modalitàdi lavoro e i due atteggiamenti non deve indurre a pensare chevadano facilmente d’accordo o che i legami tra loro siano es-senziali come farebbe comodo credere. La filosofia scientifica è,per costituzione, non generica. La filosofia della scienza è, percostituzione, generica.
Nel caso di Enriques, non ebbe luogo nessuno dei due pas-saggi. Il suo campo d’elezione era la geometria algebrica mal’impatto epistemologico sull’architettura della matematicavenne dall’impostazione rigorosa di Emmy Noether, non dal-l’approccio “intuitivo” degli italiani. Il passo successivo per ren-dersi conto del potenziale insito nella geometria algebrica per ifondamenti della matematica fu compiuto da Alexandre Gro-thendieck. In una riflessione di tono informale come quella chesto facendo mi sia consentito un minimo cenno formale: è aGrothendieck che si deve il concetto di sito (al posto di quellodi spazio). Dal sito si passa poi ai fasci su un sito e così si arrivaal concetto di ‘topos di Grothendieck’, segnando una svolta de-cisiva per lo sviluppo della teoria delle categorie, che si verificaintorno al 1970 quando Bill Lawvere apre la strada alla formu-lazione categoriale della logica (appunto in un topos). Ma allorala logica non è più estranea alla struttura degli oggetti su cuivertono le proposizioni di un dato linguaggio.
Con ciò abbiamo un esempio paradigmatico del doppio loopsu menzionato: grazie all’incremento d’astrazione realizzato daGrothendieck la geometria algebrica è rifiorita e grazie allanuova geometria algebrica il discorso logico-fondazionale si ètrasformato in maniera profonda rispetto a come si configuravanel primo Novecento e a come poi si è mantenuto nella filosofiadella scienza. Il potenziale epistemologico insito nell’area dellamatematica cui Enriques dette importanti contributi era più in-cisivo della raffinatezza concettuale dei neoempiristi.
Alberto Peruzzi94
5. Il mito del meta
Qual è dunque il motivo per cui contrappongo filosofia scien-tifica e filosofia della scienza? Che cos’è che, indipendentementeda vicende storiche, pratiche invalse o casi personali) obbliga adistinguerle? Il punto dolente di una simile contrapposizione(qualunque ne sia il motivo) risiede nella traducibilità del me-talinguaggio nel linguaggio di una data teoria e nella conse-guente chiusura della teoria rispetto alla propria metateoria(sintattica e semantica). L’esame di questo punto dolente offreanche una chiave per valutare le transizioni di fase m e m*.
Ovviamente è possibile immergere il linguaggio nel meta-linguaggio, mentre l’inverso non è possibile in generale senzagenerare paradossi. L’impossibilità è stabilita da alcuni dei teo-remi più celebri della logica matematica: i teoremi di Gödel (in-completezza sintattica), Tarski (indefinibilità della nozionesemantica di verità) e Turing (insolubilità del problema della fer-mata). Questi risultati non impediscono la ricaduta di conside-razioni metateoriche sul piano della teoria-oggetto. Anzi! Diricadute, ce ne sono state parecchie e di grande portata. In chesenso, però, possiamo valutarle essenziali? Non potendo esem-plificarle, basti notare che è stato proprio grazie ai suddetti teo-remi “limitativi” che si è potuto precisare, e apprezzare, l’effettoteorico di considerazioni metateoriche.
Circa l’essenzialità del sollevamento dal linguaggio al meta-linguaggio per la soluzione di problemi interni a una data teoriascientifica, lo schema pertinente è quello di un diagramma com-mutativo, in cui la soluzione del problema “?” si ottiene solo pas-sando per f, purché si sia garantito che m* • m sia un isomorfismo(qui, per isomorfismo è sufficiente intendere un’equivalenza in-trateorica). Cioè, deve valere che ? = m* • f • m.
95Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
TEORIA METATEORIA
p ——————–> mp
? f
q <————––— mq
In generale, ma in particolare anche per quanto riguarda lamatematica, l’approccio via filosofia-della-scienza non ha pro-dotto gran che in questo senso, a dispetto della quantità di lavoripubblicati. In base a tale approccio l’attenzione si è focalizzatasul problema dell’ontologia (per esempio, che roba sono gli entimatematici?) e dell’epistemologia (come facciamo a conoscerli?),senza significative ricadute su problemi aperti e, in particolare,sul problema dei fondamenti della matematica. Se uno, ispirandosiall’impostazione categoriale invece che insiemistica, spostava ildiscorso dal che cosa è x al che cosa fa x (oppure, che cosa cifacciamo con x), il fraintendimento ricorrente era: Ah, sta pro-ponendo un’ontologia dei processi. Ma cosa sono i processi? No, stacercando di uscire dalla priorità dell’ottica referenziale in se-mantica. Analogamente, chi distingueva senso e riferimento si sen-tiva chiedere: A che cosa ti riferisci con ‘senso’? (Come notai giànella mia tesi di laurea, la domanda è non solo legittima mal’unica possibile se si usa la teoria degli insiemi come metateoriasemantica, perché in tal caso anche le funzioni sono insiemi; lavia ‘intensionale’ aveva un’unica chance per essere perseguita ef-ficacemente, ovvero, passare alla teoria delle categorie.)
In Enriques ci sono spunti consonanti con lo spirito espressoin questo diagramma commutativo, anche se non sviluppati alpunto tale da sostanziare le sue critiche alla filosofia della scienzadi matrice neoempiristica. Proseguendo la linea Grothendieck-Lawvere, diventa invece possibile esprimere i processi fondanticome schemi in ultima analisi geometrici, di cui gli stessi schemilogici sono una proiezione, in questo modo facendo qualcosache credo sarebbe piaciuto a Enriques (e credo anche che gliavrebbe fatto più comodo che roteare il bastone). I maldiposti
Alberto Peruzzi96
eventualmente presenti stanno già rispondendo negativamentealla domanda se da questo pulpito sia mai venuto un minimocontributo alla filosofia scientifica così come qui intesa. Rivol-gendomi ai bendisposti, mi limito a esprimere il rammarico cheun’attività di questo tipo occupi una tanto esigua parte del la-voro dei filosofi di professione.
‘Filosofia’ e ‘scienza’ sono due nomi per attività che nel corsodei secoli si sono sviluppate variando, in più o in meno, la reci-proca distanza. Oggi sono due attività svolte da comunità di ri-cerca ben distinte. Non propongo di ridefinire i due termini inmodo da riavvicinare per magia battesimale quel che nei fatti èlontano; né il concetto di una filosofia scientifica ha la stabilitànecessaria per orientare in maniera precisa un simile riavvicina-mento. Tanto meno intendo negare che ci siano delle ragionidietro all’attuale divaricazione. Invito semplicemente a non di-menticare una cosa:
(@) lungo l’arco della storia del pensiero (filosofico escientifico) ci sono stati momenti decisivi in cui l’avan-zamento nella comprensione del mondo è dipeso dacontributi di tipo SF, che dunque rientrano nella filosofiascientifica e non nella filosofia della scienza, salvo i pochicasi in cui c’è stato un loop di tipo m* • f • m.
Il che non significa che se un testo scritto cui si riconoscacarattere di filosofia scientifica è diventato un modello di pen-siero e ha funzionato, o funziona ancora, dobbiamo sottoscri-verne le tesi o, quanto meno, seguirne l’impostazione. Non c’èun modello canonico di filosofia scientifica, non c’è mai stato epresumibilmente non ci sarà, mentre c’è stato un modello di fi-losofia della scienza. In un certo senso, la filosofia scientifica èpiù deperibile non solo della filosofia e della filosofia dellascienza, come generalmente insegnate e manualizzate, fino a di-ventare museali e quindi predisposte alla conservazione. Ag-giungo che non è un male che la filosofia scientifica sia soggettaalla transitorietà, legata alla sorte che tocca allo sviluppo teoricoe pratico di un pacchetto di idee. È vero che qualcosa di similesi può dire anche per la filosofia della scienza, ma c’è un incon-
97Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
veniente, ovvero, la carenza di loop virtuosi, che non mancanoinvece nella filosofia scientifica semplicemente perché questa nevive – e non fa che selezionare quelli fecondi.
La frazione dei filosofi-scienziati rispetto al numero dei filo-sofi, o a quello degli scienziati, è piccola. E con ciò? Perché maiun filosofo dovrebbe sentirsi un’anomalia se s’impegna in unproblem raising e in un problem solving che non siano unicamentemetascientifici? E lo chiedo in uno spirito che è alquanto diversodal recupero di una “seconda ingenuità” com’è intesa da un fi-losofo analitico come Putnam, perché è uno spirito che non hanulla a che vedere con l’eredità di Wittgenstein e con il ritornonel grembo del realismo del senso comune. Tra l’altro, le cosepiù interessanti riguardo al mondo del linguaggio ordinario sonola ‘fisica ingenua’ e la ‘psicologia ingenua’ (il supposto modulotheory-of-mind), che vanno ben oltre l’analisi del significato deglienunciati e costituiscono già da tempo dominî di ricerca filo-sofico-scientifica, non un hic sunt leones come continuano a cre-dere tanti filosofi del linguaggio.
Non è la prima volta che indico nel ‘mito del meta’ uno degliabbagli del pensiero contemporaneo (fermo restando che cisono ancora tanti filosofi che confondono linguaggio e meta-linguaggio) e non ripeterò qui considerazioni già fatte al ri-guardo. Vorrei però evitare un equivoco: non sto negandol’importanza, e la necessità, di fare considerazioni metateoriche.Piuttosto, sto dicendo che occorre mostrarne l’efficacia scienti-fica (vedi diagramma commutativo).
All’interno della matematica, la possibilità di ‘ricadute’ delsollevamento dal linguaggio al metalinguaggio si è di fatto rea-lizzata già negli anni Trenta del Novecento e ha in seguito ac-quistato un rilievo tale che alcuni si sono spinti a proporre ilmetodo della reverse mathematics ben al di là dei confini in cuiaveva mostrato la sua efficacia nell’affrontare alcuni problemi diteoria degli insiemi (personalmente, ho qualche riserva su questadilatazione). Al di fuori della matematica, il maggior esempio diricadute metateoriche sull’impianto di una teoria è rappresen-tato, in fisica, dal ruolo fondamentale che è riconosciuto a prin-cipi di simmetria e leggi d’invarianza. In questo caso, abbiamo
Alberto Peruzzi98
dei concetti che si prestano a una doppia lettura, teorica e me-tateorica e questa doppia lettura non fa che integrare il prece-dente diagramma commutativo con il suo duale.
Tra le ragioni per cui ho denunciato il ‘mito del meta’ c’è lapretesa autonomia del piano metateorico (epistemologico, seman-tico, fondazionale – o antifondazionale) da uno specifico impegnoteorico, seppure non necessariamente così tendenzioso come isostenitori della theory-ladeness hanno argomentato per gettar di-scredito sull’oggettività degli asserti metascientifici, aprendo cosìle porte a un sofisticato relativismo. Questo relativismo è quantodi più lontano si possa immaginare dalla mia denuncia del ‘mitodel meta’. Non si tratta di rinfacciare ai metamitomani un’ipo-crisia: se hanno ragione, neppure il loro discorso è immune dauna qualche theory-ladeness – e, più in generale, non si tratta diindicare come difetto della filosofia della scienza quello di nonriuscire a liberarsi di un qualche ontological o theoretical commitment.Critiche del genere sono già state fatte da tanti, ma sono critichea buon mercato. Perché? Le opzioni sono due, che indicherò conF1 e F2 (ove la F sta per ‘fallimento’).
F1. Nell’ipotesi di riuscire a liberarsi di ogni assunzione, lafilosofia della scienza che otterremmo o non dice nulla o dicetroppo, cioè prescrive che cosa è da considerarsi, una volta pertutte, come scientifico (anche se scientifico’ non è sinonimo di‘vero’). In ambedue i casi, l’esito è fallimentare.
F2. Nell’ipotesi di non riuscire a liberarsene, i casi sono nuo-vamente due: o si è dogmatici nell’adottare un presupposto pro-prio di una specifica teoria o si tratta di un presuppostointrinseco alla nostra architettura cognitiva. Escluso facilmenteil primo caso, resta il secondo. Se non tutte le lingue logicamentepossibili sono umanamente apprendibili, è legittimo pensare checi siano anche dei vincoli intrinseci sulle teorie umanamentecomprensibili. Impegnarsi in questo senso non è automatica-mente fallimentare. L’unico modo che da Kant in poi è datoscorgere per dar corpo a quest’impegno consiste nel fornire unaprova che, al variare delle nostre conoscenze, esistono invariantiepistemici, nello specificare quali sono e nello spiegare perchéproprio essi e non altri. I relativisti ovviamente pensano che la
99Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
ricerca di tali invarianti sia destinata al fallimento, ma anche tragli anti-relativisti c’è chi pensa la stessa cosa, ragionando per in-duzione sui fallimenti dei tentativi precedenti d’individuare taliinvarianti. Poiché considero fallace questa induzione (metateo-rica), resto in attesa di un altro argomento.
Nel frattempo mi limito a dire che, con tutti i meriti che sidebbono riconoscere a Kant, il più importante responsabiledell’esilio della filosofia dalla scienza è proprio lui, non tanto peril suo indebito commitment verso una particolare immagine scien-tifica del mondo (quella newtoniana, che sfruttava la geometriaeuclidea), quanto per il modo in cui ha semplificato la doppialettura dei principi. Infatti, per Kant i principi della natura sonodirettamente fondati sui principi a priori della conoscenza dellanatura. Questo l’ha portato a definire il metodo proprio dellafilosofia come essenzialmente, e ricorsivamente, metateorico, inciò seguito sia da trascendentalisti liberali come Giulio Preti, ilquale amava ripetere che la filosofia è una metariflessione (cheslitta sistematicamente di piano), sia da chi identifica la filosofiacome analisi chiarificatrice del linguaggio, dunque, ancora unavolta, come un’attività essenzialmente metalinguistica.
Già nel 1911 si poteva forse rimproverare a Enriques scarsaattenzione all’analisi dei problemi filosofici mediante la chiari-ficazione del linguaggio, ma non si poteva immaginare che in-torno alla metà del Novecento la filosofia si sarebbe configuratacome un metodo, essenzialmente e ricorsivamente ‘meta’, in-centrato sull’analisi logica del linguaggio oppure sull’analisi er-meneutica. In entrambi i casi non mi sembra che il risultato siastato pari alle aspettative. Gli esempi del diagramma commuta-tivo su indicato sono stati pochi.
Pur di sfuggire ai rischi dei sistemi metafisici del passato, lafilosofia ha, in gran parte, preferito fermarsi al momento del-l’analisi, finendo comunque per riproporre antiche domandemetafisiche, fatte slittare di piano, cui le risposte sono state oneo-medievali o psico-socio-pragmatiche. Ahimé, psicologia esociologia sono lungi da rappresentare il top della ‘scientificità’e la praxis è tutto e il contrario di tutto. Se l’analisi del linguag-gio ordinario o del linguaggio scientifico deve restare confinata
Alberto Peruzzi100
al piano meta-linguistico, mettersi poi a discutere se sia trascen-dentale o logica o storica, o tutte e tre le cose insieme, è il meno,perché si dà per scontato che conoscenza del linguaggio e co-noscenza del mondo siano indipendenti (e chi ha contestatoquest’assunto nell’ottica della filosofia della scienza si è ritrovatoil dilemma F1-F2).
Ora, una filosofia scientifica non può essere solo, e neancheprioritariamente, analisi. Lo è anche, ma non solo e non priori-tariamente. Anzi, più l’analisi si raffina e si estende, fino a diven-tare ipertrofica, meno si promuove nelle giovani menti losviluppo dell’atteggiamento proprio di una filosofia scientifica.
Nell’ottica metalinguistica la filosofia è diventata indagine suipresupposti ultimi della struttura di un linguaggio formalizzato,sui principi della pragmatica della comunicazione, sulla naturadelle convenzioni presenti nel discorso scientifico, sulle basi diuna teoria del significato, sulle condizioni di sensatezza entro unorizzonte interpretativo. È stata un gran bella impresa, non c’èche dire. È vero: ha ormai esaurito il suo slancio. Ma non è questoil guaio. Il guaio è che ne è venuto fuori poco o niente quanto aintelligibilità del mondo pre-umano, umano o post-umano.
L’ipertrofia del momento analitico ha portato la filosofia dellascienza a richiudersi su di sé, ritrovandosi poi a dover venire apatti con la storia della scienza, in un battibecco che continua an-cora. Anche quella di far nascere e portare a un sofisticato sviluppouna disciplina come la filosofia della scienza è stata una gran bellaimpresa, i cui meriti non sono in questione. C’è stata tutta unafioritura di lavori di filosofia della logica, della matematica, dellafisica, anche se un po’ meno di tutto il resto, e sono state indub-biamente chiarite molte questioni che nel 1911 non erano chiareper niente. Il rigore richiesto, la competenza scientifica richiesta,nonché il costume, tra chi partecipa a tale comunità di studi, direciproco controllo sugli argomenti in modo da individuare ecorreggere gli errori eventualmente commessi, attestano che citroviamo di fronte a un’area di studi filosofici di maggiore atten-dibilità rispetto alle altre aree, pur ugualmente degne.
Resta nondimeno una difficoltà di fondo. Se non la giudicassiinsuperabile (e sarei contento di sbagliarmi al riguardo), non
101Filosofia scien!fica versus filosofia della scienza
avrei insistito sulla filosofia scientifica come alternativa alla filo-sofia della scienza. Dietro a un fuoco di sbarramento fatto di raf-finate sottigliezze – le varie forme di convenzionalismo,realismo, empirismo, le varie accezioni e componenti del signi-ficato, della nozione di verità e della nozione di oggetto, i varisensi di conoscenza e di razionalità, ecc. – non si capisce qualiricadute tutta questa fatica abbia sulla crescita della conoscenza,sulla comprensione del mondo, sull’esistenza umana, su quel chedecidiamo di fare o di non fare. Va bene, si dirà, e allora? A) Chinon capisce una cosa può forse pretendere che sia impossibile capirla?Oppure si dirà: B) Perché mai dovrebbero esserci delle ricadute? Oancora: C) Perché mai dovrebbe cambiare qualcosa nella nostra imma-gine del mondo in conseguenza della riflessione filosofica sulla scienzache ci fornisce quest’immagine? E infine, D) chi sta pontificando nonha egli stesso riconosciuto dei casi, seppur considerandoli isolati, che at-testano una ricaduta proficua?
Circa A), l’osservazione è più che giusta, ma non vedo provea sostegno di una simile generosità che non siano prove dovutea contributi di filosofia scientifica. Circa B)-D), la risposta saràellittica per ragioni di spazio. Mi limiterò alla terza domanda,cioè a C), perché nella sua brevità, la risposta permette di evi-denziare un aspetto dell’atteggiamento caratteristico della filo-sofia scientifica – un aspetto che considero decisivo. Dovrebbecambiare qualcosa perché della conoscenza che abbiamo delmondo, vicino e lontano, fa parte la comprensione delle condi-zioni che rendono possibile l’esistenza di un essere capace di taleconoscenza e queste condizioni hanno a che fare con una fine-stra cosmologica non dico strettissima ma sicuramente né banalené arbitraria.
Alberto Peruzzi102








































![La psicologia italiana tra scienza e filosofia: Una prassi senza teoria? [Italian psychology between science and philosophy: A practice without theory?]. Il Giornale Degli Psicologi,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314759a3ed465f0570b27d9/la-psicologia-italiana-tra-scienza-e-filosofia-una-prassi-senza-teoria-italian.jpg)