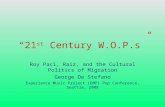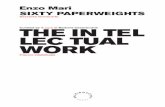KATE PEARCE Esclavos del Sexo Escaneado por PACI -‐ Corregido por Mara Adilén
Filosofi a Milano 1: Enzo Paci
Transcript of Filosofi a Milano 1: Enzo Paci
FILOSOFI A MILANO
1Collana diretta da
Massimiliano CAPPUCCIOed Erasmo Silvio STORACE
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 1 (Nero/Process Black pellicola)
FILOSOFI A MILANO - 1
ENZO PACIa cura di
Massimiliano CAPPUCCIOe Alessandro SARDI
Massimiliano CAPPUCCIOMassimiliano LUCEGiuseppe MOSCATISandro MANCINIAlfredo MARINIGuido Davide NERIFulvio PAPIEmilio RENZIAlessandro SARDICarlo SINILuca VANZAGOSalvatore VECAAmedeo VIGORELLIStefano ZECCHI
in collaborazione conla redazione della rivista Chora
e con l’associazione Astufilo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 3 (Nero/Process Black pellicola)
© Proprietà letteraria riservataCUEM Edizioni, Milano 2005
ISBN 88-?????-??-?
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 4 (Nero/Process Black pellicola)
INDICE
Prefazionedi Emilio Renzi 7
Introduzionedi Massimiliano Cappuccio e Alessandro Sardi 11
Attraversando il Diario fenomenologicodi Enzo Paci 13
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamentodi Fulvio Papi 17
Il giovane Enzo Paci:dal confronto con Croce all’esistenzialismo positivoIntervista ad Amedeo VIGORELLIa cura di Massimiliano Cappuccio e Alessandro Sardi 41
Platone nella riflessione del giovane Pacidi Matteo Bianchetti 47
Principii di una filosofia dell’essere,ovvero da Platone a Jaspers,l’accordo tra idealismo e ontologismodi Sandro Mancini 59
Presenza di Enzo Pacinella crisi della cultura contemporaneadi Stefano Zecchi 81
L’esistenza che diventa filosofiaPer una rilettura dell'opera di Enzo Pacidi Giuseppe Moscati 89
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 5 (Nero/Process Black pellicola)
Enzo Paci e la polis: dalla nascita di Aut Autalla fine del comunismoIntervista a Salvatore VECAa cura di Massimiliano Cappuccio 99
Paci e Whitehead: la processualità relazionale della natura e il proble-ma della soggettività emergentedi Luca Vanzago 107
Paci e Merleau-PontyUna testimonianza e qualche riflessionedi Guido Davide Neri 121
Enzo Paci, la fenomenologia, e il pensiero politicoIntervista ad Alfredo MARINIa cura di Massimiliano Cappuccio, Alessandro Sardi, Erasmo Silvio Storace 129
Enzo Paci: la fenomenologia dei processi in relazionedi Alessandro Sardi 145
Editoria, periodici e conferenze:Enzo Paci fuori dall’universitàIntervista a Emilio RENZIa cura di Massimiliano Cappuccio 171
Enzo Paci e l’Americadi Massimiliano Luce 179
Il filosofo e il drammaturgoEnzo Paci e Thomas Mann,storia di una corrispondenza 191
Enzo Paci e la scuola di MilanoI maestri, i colleghi, gli allievi in un'intervista a Carlo SINIa cura di Federico Leoni 197
Dal computazionalismo alla fenomenologiaEnzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazionedi Massimiliano Cappuccio 211
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 6 (Nero/Process Black pellicola)
EMILIO RENZI
PREFAZIONE
Una felice sorpresa. Questa la reazione di molti, e certamentemia e delle persone di mia conoscenza, all’apparizione del numerodella rivista “Chora” dedicato a Enzo Paci1. Che dei giovani studio-si, da poco laureati e non ancora nati quando Paci moriva trent’an-ni fa, avessero scelto Paci come terreno di una fatica editoriale nonindifferente e di una scelta filosofica impegnativa e solo in parte inriga coi tempi – ecco la prima felice sorpresa. E, subito, una secon-da: il numero e l’intensità dei contributi, distribuiti tra le intervisteche nascono come testimonianze e si concludono in arricchimentidi conoscenza e in molteplicità di punti di vista; e i saggi e le sche-de e gli articoli. Tutti o quasi scritti dai giovani studiosi. Gli stessiche per l’appunto hanno curato le interviste. La lettura si salda inun circolo il cui risultato non è soltanto un gesto di rievocazione,un atto di memoria.
Intendiamoci: Paci non è scomparso da quei promiscui deposi-ti della memoria che sono i paragrafi delle storie della filosofia, difascia alta e per i licei. Dei suoi laureati in trent’anni di insegna-mento nelle università di Pavia e di Milano, alcuni siedono in cat-tedra, a Milano, a Trieste e a Bologna e altrove; molti hanno inse-gnato nei licei milanesi e lombardi; alcuni sono stati dirigenti d’in-dustria. Ancora oggi, dire “ho studiato con Paci” significa essercapiti e apprezzati da architetti, professionisti, giornalisti e lettera-ti. Sono volutamente impreciso e non indico nomi e postazioniaccademiche; la posta in gioco è più importante. Nei processi dellastoria e della memoria e della rammemorazione e delle comme-
7
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 7 (Nero/Process Black pellicola)
morazioni, vi sono - ha scritto Paul Ricoeur - un oblio buono,quello conseguente a una elaborazione degli studi e delle introie-zioni per cui lo spirito si fa traccia pronta a riemergere se sotto sti-molo; e vi è un oblio cattivo, per quel guardare indietro che è“umano, troppo umano”. E come conseguenza di fattuali sorpassiaccademici, su cui quell’unico vero giudice di gara che è il matu-rare del senso tragico del tempo storico interverrà appunto in untempo altro, che ha tempi suoi.
Così, da studente in aula, Massimiliano Cappuccio sentì parlardi Paci da Carlo Sini e da Luca Vanzago; e Alessandro Sardi dal suoinsegnante di filosofia, Renato Marazza. Si legga il breve scritto diapertura di Sardi: Paci nascosto e rubato. Deciso a scrivere la tesi suPaci Sardi non ne trova in libreria le opere e non le trova quasi nem-meno nell’università che fu di Paci. Si imbatte invece nei segni diun certo tipo di assenza: collezioni sparigliate, pagine strappate“da qualche collezionista di carta strappata”. Mi permetto di cor-reggere Sardi: non un collezionista purchessia, ma precisamenteun papirofago di Paci e solo di Paci. Insomma un segno ex contra-rio di un certo tipo di presenza. (Mentre scrivo, una bella voce fem-minile sta chiedendo alla rubrica cercalibri della trasmissioneFahrenheit su RadioTre un esemplare del Diario fenomenologico, per-ché non lo trova da nessuna parte.)
Nessuna felice sorpresa, invece, e anzi una conferma, dalla partedegli allievi intervistati. Non esiste una scuola paciana. Nel sensoche Paci ha fatto scuola ma non creato accademia, diadochi e pri-mazie. Esiste la voce di un maestro, il ritmo di una scrittura, unaindicalità di temi. “Aut aut” non è il guardiano di nessuna ortodos-sia, anche per il buon motivo che ortodossia è un termine o concet-to o criterio o prassi che non si trova in nessuna delle migliaia dipagine paciane e di ore di sue lezioni. La radice di Paci fu e restafeconda perché nata e vissuta all’insegna della fedeltà nello spirito- e della variabilità nella lettera - nei confronti dei suoi maestri edei propri successivi risultati personali. Il tratto unificante delleinterviste è un altro ed è persin monocorde: il debito per lo stile deldocente. Per il resto, ognuno è diventato grande a modo suo.
Altra felice sorpresa: la scelta degli argomenti e la loro scansio-ne. Perché riporta alla luce di quanti e quali problemi Paci sia statostudioso e interprete e originale riformulatore. L’uno e i molti, l’i-stante, l’essere e il non essere nel Parmenide; e quindi attraversoPlatone l’intero arco della filosofia occidentale. Il vitale in Croce equindi il rapporto tra storia ed esistenza. Le idee e gli scontri ideo-
Emilio Renzi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 8 (Nero/Process Black pellicola)
logici del secondo Novecento e quindi sia Dewey che Marx, sial’America che la Francia, sia la grande letteratura europea che l’al-ta scienza mondiale. Ora tutto questo non è che un sommario diquella filosofia della cultura sotto forma di enciclopedia non unifi-cata ma aperta che Paci praticò lungo l’intera vita eppure vi è dipiù. Vi sono i temi classici della teoria e le loro figure e nodi neitempi storici. Il tempo, la possibilità della episteme, una concezio-ne schellinghiana e bruniana della natura. La permanenza e l’emer-genza, la terribilità della condizione umana, l’Altro e il linguaggiodel corpo, la trascendenza e il giudizio morale. La ricerca di“Chora” va nella direzione della tesi che una lettura o rilettura diPaci mostra che la sua opera torna ad aver qualcosa di importanteda dire alla ricerca filosofica del nuovo secolo e delle nuove gene-razioni. Perché l’husserliano (e paciano) invito al “ritorno alle cosestesse”, ora e dopo anni, può risuonare come invito ai filosofi al“ritorno ai problemi stessi”. Alle grandi domande, all’etica. A unapensiero forte. Alla verità. Alla vita come verità, diceva Paci.
Dalle pagine di “Chora”, di cui credo si possa pur dire che ema-nano l’ondivago fascino della mescola tra ricordi e ripensamentidei sessantenni e settantenni, e vertigini da scoperta e avanzata deinon ancora trentenni, vien fuori infatti un senso complessivo dirichiesta di un pensiero capace di guardare ai fondamentali dellafilosofia e al contempo agli incroci tra i saperi professionali, cheoggi sono iperspecialistici.
Paci guardava in verticale; stava sulla pagina e sull’oggetto esulle fonti documentarie. I libri della sua biblioteca personale sonotutti graffiti dai segni del matitone rosso e blu. Lettore all’antica,gran schedatore. Peccato siano scomparsi dalla conoscenza comu-ne e corporativa gli scritti di storia: quelli sulla filosofia greca, quel-li sulla filosofia moderna. Al tempo stesso, guardava e si muovevain orizzontale. La sua pagina inizialmente trae in inganno: periodibrevi, minime le subordinate, pochissimi i rimbalzi che gli aggetti-vi forniscono con gratuità apparente. Rare le formulette del mestie-re. E tuttavia la pagina prende e avvolge e porta in avanti perchéva a prendere le cose e le aggetta l’una sull’altra inserendole senzaforzature. E’ la cultura umanistica all’opera. Il lettore di oggi trovaqui riprodotte alcune pagine del Diario che dovrebbero essere unesempio sufficiente. Rileggiamone una.
Le torri di Pavia si animano sotto lo sguardo del filosofo trenta-cinquenne che sta andando a far lezione, che ne esce con un grup-petto di allievi: faccio il nome di Guido Davide Neri, per dire il più
9
Prefazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 9 (Nero/Process Black pellicola)
10
caro a tutti noi. Quelle torri “scabre, rosseggianti”, nominano glistati d’animo del filosofo: il silenzio, la paura di star sbagliando, lareazione di una serie di domande che spostano il fuoco sull’io, sulsoggetto. L’io come uomo. Homo medium mundi. Che può sceglieredi immergersi nell’oscurità o innalzarsi alla verità, emergereinsomma come vita intenzionale in prima persona. “Ma questo -commenta Paci - è Husserl.” Poche righe, pochi passi e la lezioneè tratta: dall’evidenza delle cose al dato culturale che ritorna allecose e che all’ascoltatore o lettore restituisce la pienezza del sensoche l’oggettivazione ha rubato, l’assolutizzazione nascosto.
Emilio Renzi
Note al testo
Si fa riferimento al numero 11 di Chora, e al suo dossier monografico“Enzo Paci: il filosofo, la vita, la cultura”, a cura di M. Cappuccio e A. Sardi(AlboVersorio, Milano, Estate 2005). La maggior parte dei contenuti ripro-dotti nel presente volume proviene infatti da quella pubblicazione [NdC].
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 10 (Nero/Process Black pellicola)
MASSIMILIANO CAPPUCCIO - ALESSANDRO SARDI
INTRODUZIONE
Capita a volte di cogliere in un testo letterario, in un brano musi-cale, in un dipinto o semplicemente osservando un paesaggioall'imbrunire, una suggestione: quasi la risposta a tante domandeche la vita, nella sua complessità, continuamente pone e ripropone.Leggendo l'opera di Enzo Paci si ha la sensazione che l'urgenza diqueste domande, declinate in tutte le forme possibili, siano stretta-mente cucite e irrelate alla vita di tutti noi, quasi costituissero l'e-norme 'testo' dell'immaginario collettivo. Ci si sente coinvolti eproiettati nella riflessione, nella ricerca, nell'incompiutezza e nellabreve gioia di un risultato apparente che la relazione tra linguaggispesso distanti riesce a dare al fruitore attento: come quando siscorge la fenomenologia di Husserl fra le torri adornate dalle ron-dini, in una Pavia primaverile, alla sera.
Paci ha saputo tentare quest'opera: trovare la relazione capillarein tutta la produzione umana. Perché di questo si tratta: dell'uomo,specie quando ne va della sua vita. È spesso drammatica la deter-minazione con la quale si cerca la via: Parmenide, Platone, Kant,Dewey, Melville, Whitehead, Husserl, Schöenberg, Mann,Cezanne, Sartre, Merleau-Ponty... Ma la scelta resta sempre incom-piuta e sospesa, in attesa della comunicazione possibile fra univer-si distanti, con la speranza che si avveri il migliore mondo possibi-le: la "comunità degli eventi in relazione", eidos e telos fungenti dellafilosofia paciana.
Ancora oggi, alcuni dei saggi fenomenologici di Paci valgonocome strumenti di introduzione, di studio e di approfondimento
11
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 11 (Nero/Process Black pellicola)
insuperati per la chiarezza espositiva e per l'ampiezza della pro-spettiva teoretica; un percorso speculativo nel quale e per il qualel'autore si è imposto come una delle figure più autorevoli di "filo-sofo della cultura". A coloro che lo scoprono per la prima volta, aquasi trent'anni dalla sua scomparsa, il profilo di Enzo Paci affioracon i lineamenti ben riconoscibili del pensatore impegnato davantialla società del suo tempo, quella "comunità intermonadica" allaquale ha sempre sentito di appartenere: la comunità degli uomini.
Lo scopo di questa raccolta di saggi è di ricordare Paci.Lasciamo parlare i contributi scritti da allievi reali e virtuali, e leloro testimonianze, siano esse del presente o del passato.Lasciamo soprattutto che altri accolgano l'invito a continuare l'o-pera di ristrutturazione editoriale di uno dei grandi assenti dellacultura italiana.
Ringraziamo gli allievi e gli studiosi del pensiero di Paci chehanno generosamente contribuito alla realizzazione di questovolume; la redazione e i collaboratori della rivista Chora, dallaquale (numero 11 dell’Estate 2005) provengono la maggior partedegli interventi ristampati su queste pagine; e infine l’Editore - ein particolare il Dott. Mario Gallarati - per aver condiviso e soste-nuto il progetto editoriale e culturale che anima lo spirito di que-sta collana e di questo primo volume che la inaugura. Tale proget-to aspira ad avviare un percorso che unisca studi e testimonianzee che si rivolga alla memoria e alla comprensione della ricerca filo-sofica di cui l’ateneo milanese è stato protagonista.
I curatori
Milano, 10-11-2005
12
Massimiliano Cappuccio - Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 12 (Nero/Process Black pellicola)
ENZO PACI
ATTRAVERSANDO ILDIARIO FENOMENOLOGICO
Riproduciamo alcuni passaggi tra i più suggestivi e significativi del-l’opera del 1961 [NdC].
Pavia, 14 marzo 1956
Piazza Leonardo da Vinci, isolata, quasi chiusa. Le torrimedievali, scabre, rosseggianti. Le rondini le circondano.Silenzio di secoli. Mi siedo su una panchina isolata, dopo lelezioni all’Università. Sento di dover ricominciare, di aver sba-gliato, di non aver perseguito con chiarezza, con tenacia, conprofondità, quello che cercavo. E’ vero: in ogni fatto, in ogni cosaisolata, si rivelano legami con tutte le cose, con tutti gli altri fatti.Nel tempo, nel tempo della natura e della storia. Ed ogni fatto èindividuale anche se ha la forma di tutti gli altri fatti del suo tipo.Individuazione? Ma cosa vuol dire? L’individuo è unico e pure èil tutto. La filosofia comincia quando questo uno-singolo scopreche ha in sé relazioni tipiche, essenziali con tutto il resto. Nessunfatto è solo individuale, nessun fatto è solo universale.
Questa necessaria mediazione del fatto non è ne cosa né idea,così come l’uomo non e né bestia né angelo. Ogni realtà è qual-cosa di più dell’astratta universalità è qualcosa di meno dellarealtà assoluta singolare o totale. II fatto primo sono io, il sogget-to. Non il soggetto dell’idealismo, non l’assoluto, ma l’incontro
13
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 13 (Nero/Process Black pellicola)
concreto del finito e dell’infinito, della luce e dell’ombra. Iocome uomo, come l’uomo che ha in sé il mondo, anche il mondoche ignora. Uomo: «dignum omni admiratione animal»,«medium mundi». Può riimmergersi nell’oscurità o innalzarsialla verità, né celeste, né terreno. Non da solo — ma con tutti glialtri, vivi e morti: in relazione con tutti, con tutti i soggetti. Puòscegliere per la ragione che è vita, può scegliere per la morte,per l’autodistruzione atomica. Ma è «dignum omni admiratio-ne» perché porta con sé la verità perché già in sé l’evidenza dellaverità, perché per parlare del male deve avere in sé il bene, lavita del bene, una vita che non può negare perché è la sua vitaintenzionale in prima persona, il suo essere soggetto, il suo emer-gere come soggetto.
Ma questo é Husserl. Ed è il contrario dell’assolutizzazionedell’io perché é la mediazione relazionale, l’autoriconoscimentodella verità che l’uomo porta in sé e che dev’essere realizzatanella storia, nel tempo, nel mondo. Individuazione come sensodella verità. Verità che diventa compito, che nega il mondo giàcostituito per ricostituirlo, per renderlo vivo. Trasformazioneradicale per l’uomo: per diventare uomo come mai fino ad ora èstato. Ma questo non è il ritorno husserliano al cogito? II mio rela-zionismo sarà possibile senza la ripresa della fenomenologia?L’esistenzialismo è una specie di situazione di dubbio fattuale.Era giusto far vedere che la negatività non è neppure concepibi-le senza la positività della verità che portiamo in noi, anche se lamisconosciamo. Si vive con la propria epoca, e lottano in noi lesue contraddizioni, le sue verità, i suoi errori. Bisogna ancorauna volta, con tenacia e con pazienza, ricominciare, riprendere laricerca, correggersi, bruciare la coscienza impura per ritrovare inse stesso il senso della verità, il telos del mondo.
Appena si riflette sul proprio cammino si é gettati brutal-mente nella strettezza della propria incapacità: si sente che l’er-rore, l’oscurità, la vanità, la superficialità, sono in noi, li portia-mo in noi stessi. Ma in noi stessi c’é verità e la vita. II mondogreco. Pericle. L’errore di Atene. Colloquio con i Meli inTucidide. Sofocle sente la presenza della pazzia. Euripide sirifugia in Tracia. Meglio stare con gli stranieri se Atene diventastraniera a se stessa.
Machiavelli interroga gli antichi e «quelli per loro umanità glirispondono». Un nuovo Rinascimento? Un Rinascimento pertutta l’umanità?14
Enzo Paci
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 14 (Nero/Process Black pellicola)
2 Aprile 1956
Le torri. II passato. Sentire il loro senso, la loro ragione. Laloro storia nel mondo nel quale hanno vissuto e vivono, nellerelazioni che le costituiscono e mi costituiscono. Lasciare chediventino documenti, che il loro silenzio maturi in un nome.Risvegliarle, risvegliarsi.
10 aprile 1956
Queste antiche torri medievali, questo solido passato. Dura edimpenetrabile alterità dell’oggetto. Sono irrisolvibili nella miasoggettività? Ma la natura e la storia non sono separate da noi.Siamo noi in esse, addormentati, oggettivati. Noi che attendiamodi svegliarci.
Milano, 12 aprile 1956
Noi e le cose siamo legati da un misterioso piacere, «ce plaisirspecial» di cui parla Proust a proposito dei campanili di Martin-ville. «En constatant, en notant la forme de leur flèche, le dépla-cement de leurs lignes, l’ensoleillement de leur surface, je sentaisque je n’allais pas au bout de mon impression, que quelque choseétait derrière ce mouvement, derrière cette clarté, quelque chosequ’ils semblaient contenir et derober à la fois.»
Non qualcosa «dietro», ma qualcosa che si e occultata o che siè sedimentata e che bisogna ora disoccultare, nel presente, per l’av-venire. Tutta la nostra vita, come presenza evidente, è il risve-gliarsi e il chiarirsi del passato: è temps retrouvé. La verità che dor-miva si trasforma, diventa verità tipica, figura essenziale. Ma con-tinua, risvegliandosi, a cercarsi, a correggersi nelle reciprocherelazioni che la costituiscono, a cercare un compimento, un telos.
15
Attraversando il Diario fenomenologico
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 15 (Nero/Process Black pellicola)
FULVIO PAPI
ENZO PACI: LE FORME DEL SOGGETTO TRA
AUTOBIOGRAFIA E FONDAMENTO*
1. Le tre radici del «mondo della vita»
II libro di Enzo Paci Dall’esistenzialismo al relazionismo del 1957cade proprio nel mezzo dei quattro decenni di profonda passionefilosofica, e di quel libro, in particolare, sono gli ultimi due saggi atenere unite le proposizioni che costituiscono il testo con la sicurez-za delle mosse acquisite, e insieme, l’inquietudine vaga di quelleche recano il segno di una prova ulteriore e di un movimento. Paciallora faceva lezione a Pavia sulla Crisi delle scienze europee diHusserl: e si interrogava sul significato più pieno, anzi sulla rete disignificati, che stava conducendo un concetto come quello di«mondo della vita», che si trovava a interagire con un lessico filo-sofico dove dominavano semi come processo, emergenza, perma-nenza, tempo, trascendenza, relazione, schematismo, forma, essen-za, vita, consumo, apertura, lavoro, soggettività.
Nel lessico di Paci degli anni avvenire nessuno di questi termi-ni sarà destinato a cadere nell’ombra, e tuttavia verranno altreparole molto potenti, così che ognuna, del precedente dizionario, siaggregherà in nuovi contesti semantici, e si troveranno nuovegerarchie di significati. È a queste variabili di senso, che scandisco-no forme di temporalità filosofica, che occorre prestare attenzione.Una prima volta per comprendere l’emergenza di un nuovo ordinediscorsivo e il modo della sua argomentazione, la strategia filosofi-
17
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 17 (Nero/Process Black pellicola)
ca, attraverso la quale esso diviene una permanenza concettuale, o,per trasformare la parola in lingua filosofica, una verità; una secon-da volta per non smarrire noi stessi in qualche ostinata sintesi dicontenuto (di cui Paci, credo, sia stato un poco vittima), e chieder-ci, piuttosto, se, in questi mutamenti, non vi sia una forma filosofi-ca prevalente, che ripeta la sua marca nella metamorfosi dei conte-nuti. Non cercherò quindi l’oggettività filosofica, quella che comu-nemente si dice «il pensiero», ma al di là della figura che pure ènecessario evocare, una modalità del pensare.
Da quali orizzonti filosofici era atteso il tema husserliano del«mondo della vita»? Direi che esso viene reso omogeneo al patri-monio di interpretazioni già solidificate attraverso tre tramiti moltopotenti che agiscono tra loro in modo solidale. L’esistenza è incom-piuta, ed è un insieme di relazioni che attraversano un mondosenza possibile compimento. L’identico è una costruzione intellet-tuale che stabilisce una forma astratta, incorporata in un oblio deltempo. Non c’è identico nell’esistenza temporale, e persino lanostra percezione «non è separabile — dice Paci — dalla storia del-l’universo»: rimuovere questa radice naturalistica e vitale che col-loca la vicenda del pensare (spesso ricevuta dalla filosofia come undestino originario) sarebbe una dimenticanza che impedisce dicapire. Pensare, aprire il discorso è certamente tutto ciò che noipossediamo, ma è come un piccolo astro che passa per un firma-mento infinito e cede e acquista luce ed energia prima di trovare lasua metamorfosi. Questo scenario evoluzionistico, che veniva daWhitehead, non sarà più ripetuto così, ma la sua efficacia si faràsentire, in tutta la costellazione concettuale in movimento: corpo,intenzionalità, cogito, ego, trascendentale.
II secondo tramite che offre un sicuro schema di intelligibilità al«mondo della vita di Husserl», (data la relazione diretta tra questoMerleau Ponty e l’ultimo Husserl) è il mondo della percezione, cosìcome viene descritto da Merleau Ponty. Le grandi filosofie, l’ideali-smo, l’empirismo, il realismo sono tutte costruzioni intellettuali chedimenticano la radice di senso da cui nasce ogni possibilità di veri-tà. II corpo come «impressione del processo che non possiamo fer-mare», è il medio concreto tra l’astrazione spirituale della coscienzae l’astrazione materiale della cosa: il mondo della percezione è ilmondo della verità in quanto direzione, forma, intenzionalità.
Paci ripete con Merleau Ponty: «La soggettività, a livello dellapercezione, non è nient’altro che temporalità». Si può dire che quisiamo nel luogo di confine dove la temporalità dell’organismo18
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 18 (Nero/Process Black pellicola)
che tende inevitabilmente al consumo e all’estinzione, divienecontemporaneamente processo di temporalizzazione, «tempo chesi riapre» e che trasforma in senso e direzione della vita l’energiache va perduta, per cui la costituzione del senso porta il segnodella sua origine vitale.
II terzo tramite, anche qui con una valenza di assimilazione, del«mondo della vita» di Husserl, è stato senz’altro l’interpretazionedello schematismo trascendentale kantiano derivata dal famosolibro di Heidegger e inteso (lo schematismo) come «arte segretadella natura», con un’espressione che è presa dal testo kantiano.«Lo schematismo diviene la Lebenswelt dell’ultimo Husserl»: l’iden-tificazione è senza residui.
L’oggetto si trascende nella immagine e si oltrepassa nello schemasecondo un processo temporale: nello schematismo l’oggetto si costi-tuisce nell’orizzonte della soggettività e la conoscenza mostra la suaradice sensibile e storica. Questa costruzione, dove convergono orga-nicismo, filosofia della ambiguità, critica della conoscenza e mondodella vita, agisce come una memoria naturale profonda che, nel suoriconoscimento o nel suo misconoscimento, spartisce gli spazi delladimenticanza e della consapevolezza, dell’illusione e della verità, equindi istituisce il compito di una filosofia fenomenologica.
Dunque critica alla metafisica classica, geometrico tempio diconcetti che restituiscono il mondo come un disegno senza autore,poiché aboliscono il tempo, luogo della contingenza e del movi-mento, quando è proprio la caducità temporale a costruirne la solaemergenza possibile, attraverso la quale la parola può disegnarsivitalmente nella scena incompiuta del mondo.
2. Tempo entropia verità
L’unica metafisica possibile non è quel costrutto dimentico dellapropria origine — quella storia delle costruzioni intellettuali dellapresenza secondo Heidegger o regno della fenomenologia delleidee antinomiche secondo Banfi — , ma è la metafisicità che identi-fica ogni nostra parola, gesto, sguardo, desiderio, concetto, o azio-ne come circoscritta nell’orizzonte di un tempo che lavora alla per-dita della nostra permanenza alterandone in ogni istante lo stato,poiché varia il sistema di relazioni che ne sorreggono la continuità.E pure è un tempo che disegna la forma di ogni nostra possibilitàulteriore come valorizzazione del senso.
19
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamento
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 19 (Nero/Process Black pellicola)
Occorre saper ascoltare il suggerimento o la voce della memoriaprofonda. La tradizione della metafisica cade quando lo stare neltempo, l’essere costituiti di temporalità diviene la verità che non sivede, che non si costruisce secondo le due lenti — vedere — dellametafisica e — costruire — della scienza, ma si sente nel propriocorpo come una irrimediabile contingenza e come un campo apertodi possibilità: luogo di smarrimento e di possibile annullamento inaltri ordini naturali capaci di nuovi coinvolgimenti, oppure luogo dicostruzione di un soggetto che trasforma la caducità del suo desti-no in orizzonte di verità: la percezione, l’intenzionalità, la forma chenasce dalla relazione che precede ogni ordinamento intellettuale,ogni opposizione tra soggetto e oggetto, devono essere ascoltate.
La critica alla tradizione della metafisica, giocata tutta con lamossa del tempo, assomiglia più di quanto non si sia ammessofinora alla critica della metafisica di Bergson (che del resto era unodegli autori giovanili di Paci). Solo che in Bergson la visione del-l’essere ritorna nella irrevocabilità del passato di cui la funzionedella memoria evocatrice è l’atto metafisico, l’esperienza metafisi-ca per eccellenza. Per Paci, al contrario, tutto il passato, la storiadell’universo che entra nella complessione del nostro corpo, lamemoria inconscia che agisce nei movimenti stessi del desiderare,del percepire, del formare, apre la possibilità del futuro, secondoun processo di metabolizzazione del tempo — consumo — entro-pia, impossibilità e valore. L’impossibilità di superare l’irreversibi-le, diviene una sintesi del passato, che, se realizza la regola pro-fonda della memoria, e non si perde nell’astrazione dell’intelletto,del metodo, della coscienza, stabilisce un successo certo tra iltempo e il possibile, l’entropia e la verità.
Questa certezza, questa continuità, per così dire, tra inconscio econscio questa paideia della verità o questo insegnamento all’auten-ticità è il non detto, ma nello stesso tempo la marca profonda diquesta riflessione filosofica. Così che la filosofia, nel suo non detto,è in realtà l’unica salvaguardia della vita, il libro di una saggezzanon avara che, secondo uno schema di tutta la culturadell’Occidente — costruisce la libertà proprio sul riconoscimentodella sua radice condizionale. Come essa è critica della metafisica,così è critica della metodologia: la verificazione è una ritualizzazio-ne della conoscenza che avviene dopo che la direzione della cono-scenza è già stata agita in un altrove, che la verificazione, per il suomodo di considerare i fatti, non può nemmeno investire. I fattidella teoria — sostiene Paci — sono costruzioni delle teorie e non20
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 20 (Nero/Process Black pellicola)
sono quelle condizioni di esperienza che rendono possibile l’aper-tura delle domande che si normalizzano nel teorico.
C’è un fondamento, che è proprio il «fondo», la radice e che, aldi là delle procedure mondane attraverso le quali si costruisconole figure sociali della verità, costituisce la verità. Esso può esseresentito, indicato nell’insieme dei processi della sua espressione,ma non può essere detto secondo lo stile della proposizione «alprincipio è lo spirito» o «al principio è la materia», perché questomodello di proposizioni che definiscono, sono prigioniere di undestino curioso, quello di trovare per sé nella forma della propriacomunicazione una verità che le sottrae al flusso del tempo, cioè alluogo dal quale parlano. Affermiamo così un contenuto d’infor-mazione che, in quanto richiede il valore della massima oggettiva-zione, perderà il suo senso.
Ma l’esistenza non può che costruirsi nell’Altro: pena il solipsi-smo, l’intellettualismo, la vuota contemplazione della propria origi-ne: contemplare la propria origine è perdere la possibilità della pro-pria verità. II tempo come possibilità aperta di senso va metaboliz-zato nel discorso, e la lezione dell’autenticità che si realizza, nonpuò che invitare a costruire la verità. La strada della verità conducesolo all’Altro: ma la separazione non deve essere perseguita.Occorre rimanere nella ambiguità che è il rapporto inevitabile travita e pensiero. Profonda ambiguità, ma che nessun gesto del pen-siero, che non si illuda di uscire dai confini del mondo, può evitare.
La verità è una possibilità sempre aperta, un bisogno continuodell’alterità per poter essere costruita, proprio come un amore chenon può immaginare di realizzare se stesso, se non nella dimensio-ne dell’altro, e in una relazione che non è mai conclusa, e che nonsi trasferisce mai nel sistema pacificato del possesso, dove l’amorenon è più se stesso, ma, piuttosto, morte silenziosa, incapace dialtra trasformazione, perdita di soggettività, rifusione nel flussodella vita, smarrimento anche del nome.
3. lo e soggetto filosofico: la trama del testo
Per chi, come me, si è messo sulla strada, un poco avventurosa,di cercare una marca profonda del lavoro filosofico di Paci, questisegni non valgono solo come contenuti dell’enunciato che mi staaspettando come interprete, ma già come interpretazione dellostesso enunciante. Se mi è concesso di fare questo ricorso a una dia-
21
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamento
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 21 (Nero/Process Black pellicola)
lettica tra opera e autore. L’io narrativo e l’io filosofico in Pacihanno un continuo scambio di parti: chi parla vuole costruire nelcolloquio con le filosofie una forma del senso e della verità, e quin-di una norma intersoggettiva e, nel fondamento di verità, un inse-gnamento, che tuttavia appartiene anche alla sua propria mancan-za d’essere. II filosofo è intimo al proprio testo, tant’è che è persinopossibile ritrovarlo come insorgenza empirica. Come parola chenon è periferica rispetto al proprio oggetto, ma ne costituisce partecostitutiva e quindi argomento pertinente.
All’inizio del penultimo saggio del libro di cui ho riferito letracce che mi paiono più rilevanti, c’è la riflessione di un io che siosserva e che ascolta il linguaggio dei tempi plurali delle cose cheappartengono allo sguardo «le torri medioevali si innalzano nudee rosseggianti davanti a me. A primavera le circondano le rondi-ni. Si inseguono a volo e il loro acuto garrire punteggia un silen-zio di secoli»), o che appartengono alla memoria («I morti vivonoin noi, col loro senso della vita [... ] e se li interroghiamo per laloro umanità ci rispondono, e si aprono in noi, nel presente unvarco verso l’ avvenire»).
Oggi confesso che questo «varco», questa possibilità sempreaperta, questa intenzionalità limitata e circoscritta e pure sempretotalmente esistente, questo «adesso» che si trasforma sempre inun «momento» del tempo e quindi senza significati più generali dicui sia l’appartenenza e il segno, e, pur tuttavia, momento sempredonativo di un senso coinvolgente, mi pare un modo per non sen-tire in sé l’invisibile trama delle rovine. Invece Paci, in un flusso deitempi e dei sensi, concludeva «occorre sentire la verità».
«Sentire»: a suo tempo questo «sentire» mi sembrò più che sog-gettivo addirittura «privato», tanto la fragilità dell’interpretare, ilpre-giudizio può condurre all’incomprensione. Giovane intellettua-le, avrebbe risposto Paci, che avrebbe avuto bisogno, per la sua sal-vezza o solo per il suo decoro, di una radicale esperienza di conver-sione, quale quella della riduzione fenomenologica, al fine di smet-tere la sua professione involontaria di voce di tempi; calcificati, disperanze fossilizzate, etiche conformistiche e fedeltà distruttive.
Certamente l’io del testo di Paci è autoreferenziale, ma questonon conduce ad alcuna particolare evidenza, poiché occorre sape-re di quale «io» si parla per comprendere il valore dell’autoreferen-zialità. L’io è l’io della pazienza, di una poesia di Valery citata daPaci. La pazienza è il saper essere luogo di ascolto, e di percezionedel flusso dei sensi che si intrecciano nel mondo attraverso lo spa-22
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 22 (Nero/Process Black pellicola)
zio vivente dal nostro corpo e dalla nostra esperienza: lo sguardo,ma anche il tatto, ma anche il ricordo, che stabilisce una linea trainteriore ed esteriore tra senso riposto e senso ritrovato, tra evoca-zione e archeologia (del resto Paci citava Proust). Vi è dunque unanorma filosofica che costruisce l’autoreferenzialità dell’io nel testo,il pudore emotivo e la regola intellettuale del suo potersi enuncia-re: la norma filosofica e l’educazione all’io nella verità e quindicome processo naturale, emergenza, permanenza, campo percetti-vo, formatività, temporalità.
La costellazione delle parole filosofiche come pedagogia viventecostruisce la possibilità dell’io di modo che il dirsi avvenga secondouna direzione di verità. In questo caso scrivere «io», poiché corri-sponde a una scrittura filosofica, è già realizzarsi in un insieme disensi o se si preferisce, con un’antica parola, è già una formazione.Nel testo che ho preso in considerazione c’è, filosoficamente, unsovrappiù di informazione rispetto a quella che viene usata per pro-vocare la coincidenza dell’io che narra con l’io filosofico, sovrappiùche mi pare da utilizzare per procedere nel mio sentiero.
4. La solidarietà tra senso e artificio
È molto forte in Paci il tema del consumo della vita, dell’irre-versibilità temporale come entropia degli organismi (solo nelsistema dei sistemi la quantità d’energia non muta): tema che siconiuga con il problema del lavoro, «Se la percezione dice Paci —prende la strada della autocoscienza, cioè diviene oggetto a sé, ciòche si toglie è la dimensione del lavoro». Cioè si crea una autosuf-ficienza del concettuale: il mondo non è più una relazione di espe-rienza ma un sapere oggettivo da enciclopedia. La critica assomi-glia abbastanza alla critica che il giovane Marx avanza in unmanoscritto parigino alla Fenomenologia di Hegel: ma la ragione diquesta parentela credo sia facile a dirsi. Paci, probabilmente, avevain mente la valorizzazione del lavoro che compie Kojève nel suocommento alla Fenomenologia di Hegel. Intellettualizzazione,significa inaugurare il mondo fittizio della figura senza corpo,delle verità che si debbono dire con una parola che non appartie-ne al nostro vissuto, ma al tempo della professione o al tempo delrito, luogo del precipitare della nostra vita in passioni estenuanti,opache e senza verità proprio perché prigioniere di metafisicherappresentate nella loro sufficienza intellettuale, puri, arcigni
23
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamento
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 23 (Nero/Process Black pellicola)
oggetti di una mente astratta. La percezione e il mondo della vita,per lo meno nel 1957, indicano l’orizzonte di una intelligenza cheè vitale o operativa al tempo medesimo (assieme a Whitehead e,nella sua forma di ragione come «arte della vita» vi è certamenteanche il ricordo di Dewey). La sua prosecuzione spontanea nelmondo è costituita dall’artificio della tecnica. L’originaria raziona-lità, che fu già compresa nella formatività della percezione (vita eragione di Banfi — dirà Paci — che qui quasi trovano la loro sinte-si sensibile a portata della mano), si prolunga nel mondo, e divie-ne la formalità implicita nell’artificio tecnico. II telos che appartie-ne all’organismo e che ha nel senso la sua direzione essenziale,cioè essenza - visione nell’al di là del momento, e quindi trascen-denza, continua la sua opera di formazione nella relazione opera-tiva. La tecnica è la razionalità che segna l’introduzione nel mondodi una finalizzazione lavorativa: è un organismo orientato. È diffi-cile trovare nella filosofia contemporanea una solidarietà cosìdiretta tra il mondo della percezione, del senso e dell’intenziona-lità e l’intelligenza artificiosa e tecnica. Tanto che, se non vi èarmonia tra il mondo naturale delle emergenze dove la razionali-tà vitale consente di organizzare la permanenza e la struttura delmondano, cioè se la tecnica diviene strumento di servitù sociale edi esiti mondani catastrofici, allora questa tragedia — poiché ognidis-armonia e segnata dal tragico — deriva dal fatto che «al lavo-ro - dice Paci - è stato tolto ogni valore». La razionalità della per-cezione, il nucleo originario di senso s’incontra con un mondo cheè socialmente rovesciato. Questa è un’immagine che conduce a unantichissimo topos della disarmonia tra legge del mondo e statodel mondo ma, nel caso specifico, deriva da una generalizzazionepropria di una filosofia dialettica della storia latente che attendegià il nostro autore come futura analitica del mondano.
5. L’esistenza, la metafisica, il trascendentale
La forma di questa filosofia, la cui prova di verità consiste nelpoter costituire il fondamento, il linguaggio e lo stile dell’idealizza-zione (io filosofico) del soggetto che scrive (io narrativo), è la rego-la di una fenomenologia autobiografica che viene da «molto lonta-no». Detto questo, è detto molto poco, poiché occorrerebbe vedereanaliticamente come si può costruire filosoficamente una autobio-grafia, cioè esaminare gli strumenti di linguaggio che consentono di24
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 24 (Nero/Process Black pellicola)
fondare la messa in scena di questa forma della verità e quali sianole relazioni con altre forme della autobiografia. Spero che qualcheparziale risposta si potrà trovare per via di discorso. La regola fon-damentale di tutte le figure della fenomenologia autobiografica è laricerca del valore intersoggettivo della comunicazione attraverso lostrumento classico della tradizione filosofica: la problematica delfondamento. Non è una scena episodica o spettacolare, una compli-cità effimera e futile con l’ascoltatore, una seduzione di superficieche è sempre, come sapeva Paci, l’indefinita ripetizione dello spec-chio, ma è una costruzione figurativa del linguaggio che si realizzaattraverso la durezza di una regola esterna alla lingua: il fondamen-to filosofico, che, solo, costituisce la struttura dell’Altro, la suanecessità e non revocabilità: unico modo perché «l’eros autobiogra-fico raggiunga il compimento di Sé come verità nella trascendenza.Ora vediamo il «molto lontano» che ho nominato qualche momen-to fa. Focalizzerò un tempo della vita e un episodio della riflessionefilosofica. Il tempo vuole descrivere il ritrovamento della forma filo-sofica, il processo di strutturazione del senso della filosofia.L’episodio si riferisce, invece, alla relazione che Paci stabilirà con l’o-pera filosofica di Banfi alla fine degli anni Trenta.
Molto recentemente, un giovane studioso, pieno di meriti, in unsuo bel lavoro ha dato notizia di appunti di Paci, incentrati sullafigura di Gobetti, che risalgono all’inizio degli anni Trenta, emostrano una precocità intellettuale e anche una qualità di infor-mazione filosofica e di giudizio, piuttosto straordinari. Credo chelo studio analitico di questo testo sia molto importante. In questiframmenti si possono distinguere tre livelli comunicativi: anche sela distinzione, come sempre in questi casi, indica prevalenze disenso, e non assolute esclusioni.
II primo livello è quello dove prevale la rappresentazione del Sé,l’affetto alla propria immagine: «Siamo noi stessi a proclamare l’ir-realtà storica della nostra vita e l’inutilità della nostra azione poichéprofessiamo la fede nella azione disinteressata». II secondo livello èquello del contenuto ideologico del messaggio: «L’eresia di Gobettidiventa metafora di un complesso atteggiamento di critica dellapolitica e insieme di ricupero, magari contro la storia, di una piùautentica e radicata storicità esistenziale». La seconda parte dellacitazione introduce bene al terzo tema, quello della rappresentazio-ne della forma del pensiero filosofico come ricerca del senso, dovela costruzione ideale della propria autobiografia va in parallelo conla polemica contro (e contemporaneamente) la filosofia della storia
25
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamento
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 25 (Nero/Process Black pellicola)
e la storiografia. II che significava: contro l’entificazione del Sé inuna qualsiasi rappresentazione concettualizzata, e contro la ridu-zione del Sé in una metodica che, nella sostanza, circoscrive un’eti-ca professionale. C’è un «io» che cerca di trovare la propria identitàal di fuori di qualsiasi codificazione acquisita. L’io si presenta comeun «aperto». Questa condizione consente al Paci ventenne di trova-re uno spazio filosofico fuori dall’opposizione crociana di filosofiadella storia e storiografia che per un lungo periodo ha invece rap-presentato la opposizione tra metafisica e critica. In ogni caso inquesti frammenti si ritrova un’asse oppositiva che tiene insieme, dauna parte, io, azione, durata e, dall’altra, oggettività, politica, pro-fessione, periodizzazione. Questo è lo spazio entro il quale puòaccadere un lavoro filosofico che costruisca un discorso connotatosecondo strutture di oggettività discorsiva, ma nel quale sia conti-nuamente rappresentabile il momento autobiografico e la domandadi senso che costituisce l’apertura del discorso; di modo che nel pro-dursi del discorso, e cioè nella simbolizzazione filosofica, possaavvenire la scelta di sé come direzione ideale. In uno scritto giova-nile Giulio Preti aveva detto la «persona».
Paci, una volta, scrisse di essere stato esistenzialista prima diconoscere gli autori e i problemi di questa filosofia. Si sa del restoche è stato il concetto di esistenza (il meno concettuale tra i possi-bili concetti) a consentire di organizzare filosoficamente quellospazio aperto che si manifestava come luogo personale delladomanda filosofica. L’esistenza che, poi sempre si rappresentò nelpensiero di Paci nell’immagine, nel mito, nella ragione o nell’ideasecondo una relazione fondamentale ma nello stesso tempo insta-bile e caduca; com’è proprio di un tempo e di un amore che sonocostretti alla ricerca di un’anima o di una forma per sfuggire allaconsumazione insensata di un vivere quotidiano, nel propriodiscorrere vano, privo di simbolo e di memoria. Così che l’esisten-za agisce da fondamento necessario e profondo che si manifesta neiritmi del tempo e la filosofia dell’esistenza diviene una autobiogra-fia filosofica che deve continuare a costruirsi in un discorso chediviene altro da sé e che, tuttavia, non può mai avere il potere dinormalizzarla definitivamente. L’educazione all’idea — secondo lalettura platonica di Paci ispirata allo Stenzel — è resa possibile dalcorrelato del nulla e, proprio per questo, è una tensione che non siesaurisce mai. L’esistenza diviene la categoria della irriducibilitàdell’esperienza al contenuto di ragione, e, nello stesso momento, lapossibilità di una filosofia non definita in un tempo categoriale lon-26
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 26 (Nero/Process Black pellicola)
tano dalla radice vitale. Paci cerca di fondare questa trasfigurazio-ne dell’autobiografico, in cui il racconto degli eventi è già tutto uni-ficato dalla domanda intorno al loro senso, mostrando l’irriducibi-lità dei due limiti di esistenza e di ragione, di modo che l’isolamen-to dal razionale o dall’irrazionale come totalità, crei una situazionedi impensabilità per lo stesso concetto. Che cosa è l’irrazionalesenza l’esistenza dei processi di razionalizzazione, e che cosa sonoquesti processi d’ordine della ragione filosofica, che struttura unmondo abitabile da figure di pensiero senza la sconfinata area del-l’oscuro, dell’indeterminato e del nulla? È su questo tema che Pacidialoga per oltre un decennio, dalla fine degli anni Trenta, con lafilosofia contemporanea e con la tradizione classica.
Vediamo brevemente il medesimo problema dalla parte dellarelazione teoretica con Banfi. Credo debba essere chiaro che Paciarrivò da Banfi con una propria radice filosofica: non apprende daBanfi il lessico della filosofia, e nemmeno riproduce passivamentele selezioni culturali di Banfi. Se mai se ne appropria per un inte-resse sempre più articolato al proprio problema. Che cosa gli inte-ressa soprattutto della filosofia del maestro universitario? Direi ilrapporto che vi è tra il fenomenologico e il trascendentale, e cheriguarda proprio lo statuto della filosofia e la tradizione della meta-fisica. Nei Principi di Banfi questo rapporto tra criticità della ragio-ne filosofica e realismo del pensiero metafisico è regolato dal siste-ma delle antinomie che in Banfi fonda l’impossibilità di oggettiva-re una qualsiasi totalità nell’unità di un concetto: la realtà, l’essere,l’evidenza, la coscienza ecc. Questo vale per la forma della metafi-sica, la cui fenomenologia non è altro che la riproduzione oggetti-vata delle varie possibilità antinomiche: l’uno — il molteplice: l’es-sere — O divenire; la materia — lo spirito, così come vale per tuttala filosofia della cultura, dove la vita dell’esperienza, qualsiasiesperienza, non è indicabile nell’esaustività di un concetto ma solonella vuota formalità di una antinomia. Non è questo apparato cri-ticistico che, a mio modo di vedere, porta la filosofia al limiteimmanente della lingua, a interessare Paci. In Banfi esso conduce inconcreto a una filosofia della cultura come fenomenologia delleforme culturali e quindi come vicenda contemporaneamente dioni-siaca — nel tempo — e apollinea nella comprensione dello spirito.A Paci interessa che il trascendentale, l’idea — come limite dell’e-sperienza —, non si realizzi mai nell’esistenza — ogni momentodell’esistenza è possibilità di valore, e nessun momento è definiti-vamente valorizzato — , e anzi interessa che il trascendentale eser-
27
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamento
PACI£.qxp 17/11/2005 9.18 Pagina 27 (Nero/Process Black pellicola)
citi la sua efficacia negativa nella impossibilità che una qualsiasi«espressione della tensione dell’esistenza» (le parole sono di Paci)possa chiudere l’orizzonte, e identificare in un deforme costrutto laricchezza del tempo conquistato nella rappresentazione come epi-logo della dinamica tra infinito e finito.
In Banfi vi è una pratica filosofica, la fenomenologia della cultu-ra che deriva dalla forma teoreticamente corretta della comprensio-ne delle forme spirituali che nascono dall’humus inesausto dellavita. A Paci non interessa la pratica filosofica del filosofo checostruisce i suoi occhi per guardare il grande spettacolo dello spi-rito: il suo punto di arrivo non sono le grandi fenomenologie dellacultura. L’idea stessa di pratica filosofica, come esercizio critico inBanfi conduce a considerare l’azione come propria dell’orizzontedella fede: qui vi è un «io» che rischia la propria identità in quantoagisce e assume per se stesso il peso reale della sua azione. Non esi-ste in Banfi la figura dell’io filosofico anche se vi è sempre stato unforte io esistenziale che ha interagito, spesso in silenzio con lenorme della filosofia. Tra la contemplazione della filosofia dellacultura dove fu il grande silenzio della vita come orizzonte infor-me, e l’azione, la decisione che avviene nella solitudine e quasi nel-l’orfanezza filosofica, Paci guarda al momento precedente: quelrapporto tra la vita e la ragione che in Banfi è decisivo per noncadere in una banale idealizzazione dell’esperienza, ma che noncostituisce una vera pratica filosofica.
È in questo «non fatto» ma anche «non fattibile» di Banfi chePaci sceglie la sua forma di filosofia come filosofia fondata edespressiva. E qui si apre una situazione che può apparire parados-sale. Proprio questa continua fondazione della finitizzazione dellafilosofia, questa attenzione a che il discorso non sopprima il tempo,e la scena della vita non si trasformi in un teatro delle grandi figu-re filosofiche, provoca un effetto straordinario: quello di assolutiz-zare filosoficamente l’io, non il concetto, la figura, che questa sareb-be una osservazione ridicola rivolta a Paci, ma il linguaggio cheaffonda nell’orizzonte dell’io la sua possibilità di senso.
«La religione — ha scritto Paci — non è qualcosa che l’uomopuò avere o non avere, è il fondamento della sua vita». Questa reli-gione senza istituzioni, questa religione della coscienza che nonvuole essere compresa ed emancipata da una filosofia che la obiet-tivi, quest’eco profonda della teologia protestante sino aKierkegaard, assomiglia molto, se non è la stessa cosa, alla radicedi una filosofia espressiva dell’esistenza o anche come preludio a28
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 28 (Nero/Process Black pellicola)
una forma d’arte. Religione, arte, filosofia dunque come triade del-l’espressione dell’esistenza, figure della sua verità. La filosofia ècontigua a questa religione, e certamente non ne muta il contenutoproblematico che rimane l’esistenza, si complica certamente il suotesoro metaforico, per cui le parole che esprimono il finito comelontananza di Dio si aggregano molto bene con il lessico fondanteche offre il linguaggio alla centralità caduca del soggetto. La filoso-fia è altresì un lessico di traduzione di quella esperienza d’arte cheha il suo momento di costituzione di senso nell’indefinita e riccafenomenologia dell’immagine.
6. La decostruzione filosofica del mondano
A questo punto direi che sono tre i temi che devono essereintrecciati in questo percorso: l’orizzonte del mondano, la salvezzao il senso ravvicinato, la dialettica o il senso partecipato. In una let-tera a Luigi Rognoni del gennaio del 1958 Paci scrive «Da quandotu non ci sei non parlo più con nessuno in modo immediato e spon-taneo, e sono sempre più convinto che gli intellettuali vanno sotto-posti a una severa epochizzazione».
Gli intellettuali appaiono come i razionalizzatori del mondano:essi perdono la loro possibilità di soggettività nelle trame dellaserietà pesante dell’essere. Parlano di storia, di politica, di scienza,di iniziative da prendere o da appoggiare, di casi morali, di curio-sità indiscrete, di decisioni difficili, hanno problemi personali chetrasferiscono in conflittualità oggettive naturalmente rappresenta-te, prestigi personali da radicare e diffondere, esercizio di poteri: inquesto labirinto non si può prendere la parola se non si predispo-ne il discorso in una strategia. Ma entrare nella strategia non è unafinzione, è però già consumare la parola nello spazio del mondano,e ciò appartiene alla propria mondanizzazione immediata, e quin-di la relazione di senso, che per Paci è sempre la radice filosofica, sispegne come un fuoco senza alimento.
II mondano o l’inautentico è tema che in Paci ritorna, e che costi-tuisce per alcuni anni il suo punto cruciale: il rischio che la profon-da ricerca del senso è che l’educazione al senso possa essere oscu-rata dalle forme prevalenti dell’intreccio sociale: in questa avventu-ra è in gioco la forma stessa della filosofia. Ma se è in gioco la filo-sofia, allora è in gioco la qualità di qualsiasi forma di esperienza. IIdogmatismo politico è anche una forma di pensiero regressivo.
29
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamento
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 29 (Nero/Process Black pellicola)
Riprendere la strada del senso per Paci significa stabilire un eserci-zio e uno stile della riflessione che contrasta con il rischio che lafilosofia perda il suo ruolo gerarchico di scienza prima in quantoproduttrice del senso della vita. Sensi mondanizzati o metaforemorte (per parlare il linguaggio di Ricoeur) razionalizzano la vitaquotidiana: prevale la ritualizzazione sociale.
Se andiamo a vedere il lessico che Paci adopera per parlare delmondano, troviamo una curiosa koiné linguistica di Heidegger (sinasce nel mondano dove si é gettati), di Marx (sovrastrutture mon-dane, mondo che si feticizza), di Sartre (mondano è l’interesseimmediato): naturalmente è un lessico che è dominato e significatodalla prospettiva husserliana della naturalizzazione: anche questadetta da una particolare contaminazione interpretativa: «Siamoperduti nel mondo, così come è, e il significato della nostra vita è ilsignificato della verità di fatto».
La scienza della natura che lavora e produce conoscenza trami-te le sue oggettivazioni positive, e che esclude dalle operazioniche compie la rimemorizzazione del fondamento vitale origina-rio, che sa e non pensa, appartiene al medesimo universo, dove lamia vita viene letta nelle generalizzazioni della sociologia, dellapsicologia, della antropologia, della storia costruita con le solu-zioni pubbliche della memoria.
Per comprendere non tanto l’atmosfera filosofica in senso speci-fico che ora vedremo, quanto per avere quasi una precomprensio-ne affettiva di questa insistenza di Paci sul mondano, ricorderei l’e-spressione che, in quel medesimo periodo, anno più, anno meno,fu propria di un grande scrittore che ci ha lasciato: «Il mare dell’og-gettività». Nel mare tutti gli orizzonti sono eguali, le rotte equiva-lenti: non esiste alcuna centralità che disegni un ordine, ogni indif-ferenza e già decisa in un solido sistema di certezze. Per quantoriguarda Paci, viviamo come cose costruite in quella particolareintellezione della natura che Husserl identifica in Cartesio e inGalilei: falsi ulissidi senza moto e senza memoria.
C’è nell’aria di quegli anni una crisi della figura spontaneadella soggettività, non ancora manifestata a livello filosofico contutte le complesse derivazioni che conosciamo, mancano le dissol-venze filosofiche: non c’è episteme, struttura, logocentrismo,archeologia, genealogia, ma piuttosto la sensazione che il sensodeclini, perché il mondo degli oggetti parla una lingua che ha uncodice potente che detta l’apprendimento e il comportamento: èin atto una mutazione materiale che rischia di sottrarci il privile-30
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 30 (Nero/Process Black pellicola)
gio della confidenza con il futuro, perché ogni variazione è giàstata preordinata.
II potere dell’oggetto ha la forza della scoperta e della sorpresa,e la nostra storia che è stata per un lungo periodo il libro dellanostra vita, del quale sempre era raccomandabile la lettura, comeappartenente alla costellazione stessa della nostra identità, diventaquello Wahrengeschichte di cui parla Horkheimer. Ovviamente nonso misurare esattamente la pertinenza di questa evocazione, percomprendere il lavoro di Paci in direzione di quello che ho chiama-to un «avvicinamento del senso».
Per quanto riguarda lo scenario diretto della filosofia di Paciverso la metà degli anni Cinquanta calano le prime ombre sullafocalizzazione teorica precedente, il relazionismo, per cui noiveniamo da un sistema di relazioni naturali, dove la nostra emer-genza e permanenza sono condizionate dai consumi entropici, edove, pur tuttavia, la storia naturale che ci ha costruiti, ci ha ancheaffidato una struttura percipiente e temporalizzante capace dicostruire nuove relazioni fondanti in un mondo che, del resto, nonle attendeva.
Questa vicenda precedente dove la filosofia della natura diWhitehead neutralizza qualsiasi opposizione rigida tra in sé e persé, come avviene per esempio in Sartre, non è scomparsa, maappartiene a ciò che nel presente immediato e invisibile, a ciò chesi è, ma di cui è nascosta in uno strato inerte dell’esperienza la con-sapevolezza e il sapere. Tra l’organismo naturale e l’organismosociale — che aveva nella struttura percettiva il suo momento dicontinuità — si è invece creata nel «nostro tempo» una rottura. IIsenso possibile rischia di svanire. Direi che ora il problema fonda-mentale di Paci è di focalizzare nuovamente e con strumenti filoso-fici potenti la polarità soggettiva e la sua potenzialità di senso nelmondo. Questa mi pare la circostanza filosofica attraverso la qualeegli si trova a ripercorrere l’esperienza dell’ultimo Husserl.L’autobiografia, per così dire, trova ora una eccezionale macchinafilosofica che costruisce un io filosofico capace di riaprire in tutte ledirezioni della cultura attuale il problema del senso, e quindi dimettere in crisi le strutture di oggettività delle varie istituzioni delsapere. C’è una radicale eversività del senso.
Nei testi di Paci che parlano della fenomenologia si legge spes-so che il mondo della vita contiene potenzialmente tutte le catego-rie logiche e le stesse categorie scientifiche, che tutto ciò che è cate-goriale ha già una sua struttura concreta e profonda nel mondo
31
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamento
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 31 (Nero/Process Black pellicola)
della vita, che ciò che è fondato sono i giudizi che si trovano nel-l’immediatezza fungente, nei quali si rivelano le cose stesse e cheessi solo costituiscono la condizione primaria di fondatezza delgiudizio scientifico. Non esiste un processo di autofondazione sto-rica e se si crede a questa certezza oggettiva, si scambia la pigriziadel pensiero per l’ordine delle cose. Occorre trovare il fondamento,ma da queste affermazioni non deriva, diversamente da quantoaccade in Husserl, per esempio nella Logica formale e trascendentale,alcun lavoro di fondazione trascendentale di una ragione scientifi-ca o della forma apofantica del discorso. Non è su questo terreno,ultima Thule di una immagine della filosofia prima, fondatrice del-l’universo complessivo della conoscenza, un’impresa grandiosaquanto irrealizzabile, che si esercita la riflessione di Paci.
7. «Avvicinare il senso»: l’intenzionalità
II suo punto centrale è, invece, «avvicinare il senso», e avvici-nare il senso vuol dire riuscire a trovarlo come struttura dell’inten-zionalità nella soggettività o, con equivalenti semantici, che sonointerscambiabili nella riflessione husserliana di Paci: io, Ego, cogi-to, corpo, monade, coscienza reale e anche coscienza fisica o «ciòche si nasconde nel più profondo divenire genetico». II riuscire atrovare il senso non è una operazione spontanea, il senso non è lì,deve essere trovato da una askesis filosofica, per la semplice ragio-ne che il senso di Paci è senso buono, senso autentico, radice dellastessa filosofia, luogo delle possibilità del linguaggio che parlasecondo verità, certezza dell’io filosofico, definitivamente uscitodalla generalità di una narrazione qualsiasi. Ma, domandiamoci,chi vive in realtà senza una forma di senso? II senso di Paci, pre-sentato come il senso del corpo, della monade, il senso che regolala corrente della vita, una volta spezzata la prigionia del monda-no, è in realtà, come chiunque immagina, una costruzione cultura-le del senso autentico e quindi contiene il progetto di un rifaci-mento del mondo reificato.
II dover rifare l’io filosofico in ogni tempo, e quindi ricomicia-re, il far coincidere il desiderio e la possibilità, mi pare già uneccesso filosofico sulla strada di una radicale renovatio. II sensodell’io è una relazione particolare con il mondo: la sola che siapropria dell’orizzonte del soggetto. Lo strumento di questa ope-razione di ritrovamento è, come tutti sanno, la riduzione fenome-32
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 32 (Nero/Process Black pellicola)
nologica o epoché. Essa, scrive Paci abbandonando il calco del les-sico husserliano, è «simile al gesto di quando non se ne può più»:le somiglianze stabiliscono appartenenze e il circoscrivere uncampo di omologie è una intellezione. Invitare a sapere per somi-glianza e invitare a circoscrivere, e a non immaginare oltre. Einfatti la parola «gesto» non solo non va perduta, ma viene riba-dita in una equivalenza semantica poiché Paci ripete che la ridu-zione non è una teoria, ma è piuttosto un fare. «Fare» è una paro-la il cui spettro di significato è estremamente vasto: occorre trova-re i suoi omologi nel linguaggio filosofico per comprendere conchiarezza l’orizzonte filosofico che vi è implicato. Nella tradizio-ne filosofica vi sono parole che appartengono alla medesimafamiglia di significato del fare: ascesi, purificazione, spaccio,emendazione, dubbio, ma quella che mi pare si avvicini di più aquello che vuol dire Paci è «decisione».
Non poterne più, dunque, è prendere la decisione di ricomin-ciare in uno scenario filosofico che mostra l’io lontano dal suopossibile. La riduzione fenomenologica spezza l’incanto malignodel mondano e consente che si realizzi una rivelazione: «Io rina-sco nel presente in un senso nuovo, nel senso teleologico dell’av-venire». È come se qualcuno pensasse: «sono tutta la filosofia pos-sibile nell’ora attuale»: l’io esorbita di possibilità di senso nelladimensione temporale che gli è data. II suo senso non è, si capi-sce quello di un’essenza, un angelo per esempio, esso è sempre inrelazione alla particolare stratificazione mondana della tempora-lità. Non si diviene la prassi, ma una prassi e si ritrova l’intenzio-nalità in un orizzonte delimitato. La riduzione ridà la vita comecompito che appare in «prima persona» e come una «presenzavivente». Non un dover essere che trae fuori da sé il compitomorale a fronte del sensibile inerte è quasi in timore della gran-dezza lontana degli ideali, ma in questo ritrovamento è la realiz-zazione del proprio essere, inscritto nel proprio corpo, una finali-tà nascosta, ma già vivente, che fa emergere nell’ora del presentela relazione felice tra passato e futuro. «Ora del presente» vuoldire che «questo è il momento», con una forte riminescenza dellalinea Kierkegaard-Tillich: dove il momento non appartiene a unalinea evolutiva, a un punto della linea, ma a una chiamata dellapropria evidente autenticità. Vi è dunque una forte teatralizzazio-ne emotiva e rappresentativa nell’uso della riduzione fenomeno-logica: la riscoperta dell’origine, nell’estasi temporale, assegna alsenso stesso il compito della sua realizzazione.
33
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamento
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 33 (Nero/Process Black pellicola)
Non c’è un senso che possa essere contemplato, non si offre maicome alternativa immaginaria all’esistenza; quando esso è rivelato,è già nella decisione poiché la struttura fondamentale che la epochédisocculta è l’intenzionalità. Un enigma — dice Huslserl: un enig-ma il perché la coscienza si diriga all’oggetto e si stabilisca una rela-zione tra strutture noetiche e noematiche; ciò che si può fare èdescrivere le corrispondenze di questo processo. Ma anche qui ilvero interesse di Paci è nel contenuto teleologico dell’intenzionali-tà: la coscienza si dirige verso essenze che il soggetto ha in sè e checostituiscono, come finalità, direzioni di senso.
L’intenzionalità è senso strutturante, rimemorazione del passa-to e apertura verso il futuro. La vita evita lo sfaldamento, il sensocementa, in una composizione, i tempi. Decisione, tuttavia, sempreda rifare quella della riduzione fenomenologica, quindi un conflit-to permanente per il senso. Ma quando il rumore del mondanotace, allora posso ascoltare la voce del mondo della vita che è ritro-vamento, salvezza, rinascita, possibilità di riconoscermi come futu-ro. II mio interesse al mondo muta, un interesse intenzionale misottrae alle forme mondane della costituzione dell’io dal calcolo,dall’utile, dalla razionalità astratta, dalla competizione aggressiva— e mi colloca nell’io dell’intersoggettività, corporeo e collettivoregno dei fini o «idea teleologica dell’umanità», come dice la gran-de retorica dell’universale, propria dell’ultimo Husserl, umanistaeuropeo. E, come si sa, la «rinascita della ragione», in forma teleo-logica, rispetto all’immagine dominante della razionalità modernadella misura, della previsione, dello scambio, del calcolo, dellaquantificazione, della democrazia politica.
8. II «fondo» rivelato e l’analitica marxista
L’inizio del percorso sul senso partecipato, che conduce sullasoglia di una situazione in cui l’esserci nel senso, è un’esperienzache può essere costituita, è ancora una volta un «sentirsi». II sentir-si non è un sentimento banale proprio perché non è l’introspezioneche conduce a una nozione, ma una certezza coinvolgente, unostato d’essere nella certezza. Paci aveva detto «occorre sentire laverità». II sentirsi non è banale perché nella percezione di sa non viè l’occasionalità di una immagine ma è la presenza della storia nelsoggetto, come carne, sangue, dolore, e il sentirsi è l’aprire unadimensione del soggetto che è in grado di elaborare spontanea-34
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 34 (Nero/Process Black pellicola)
mente un intreccio di senso e non senso. II sentirsi mostra sotto unaforma concreta, ma ancora indecisa, il doppio legame del soggettocon la teleologia della propria radice corporea e con le forme dellavita mondana, con le realizzazioni del pratico inerte. È il sentirsiche può condurre a un «non poterne più», a non poter sopportareun mondano che è avvertito come distruttivo.
Non c’è in questa descrizione di Paci una particolare strada, unitinerario o una educazione al «prendere coscienza». Proprio comeavviene in Sartre, dove il riconoscimento del soggetto come libertàè l’unica soluzione possibile che, in un certo momento, si offre difronte alla necessità, a quel pratico inerte che non riesce più a cat-turare il consenso dal soggetto nella dimensione dell’interesse.L’occasione conduce alla soglia di una rottura dei tempi: l’ora delpresente ritrovata, in tutta la sua forza, la vitalità di un nuovo ini-zio, segna il passaggio del tempo dell’oggettività mondana altempo fungente proprio dell’apertura dell’orizzonte di verità.
II fare da capo o, come ho già detto, la decisione che realizzaquesta trasformazione, è la riduzione fenomenologica. Paci consi-dera un errore di Sartre non fondare l’analitica della ragione dialet-tica sulla riduzione, che, per la verità, fin dal 1936 a Sartre parevalo strumento filosofico meno interessante di Husserl, una specie diartificio verbale che non può, di per se stesso che «fingere» un effet-to, non provocarlo. La riduzione appartiene a un lessico che rac-conta filosofia non che costruisce l’esistenza. Invece in Paci è pro-prio la riduzione fenomenologica che esclude tutte le sequenze delmondano, e impedisce il funzionamento di schemi già esistenti, eneutralizza le parole che, in quanto partecipano a discorsi già codi-ficati, a disegni e azioni già esplorati sono parole morte, e conducealla soggettività come coscienza, corpo, irreversibilità, organismo.
Sono queste strutture che costituiscono — dice Paci — «ilfondo» del marxismo. Senza questa radice la descrizione storicadel marxismo è un sapere come altri, la sua azione politica unaabilità tecnica mondana. È da trovare il modo d’essere verità delmarxismo. La parola «fondo» è di Paci, e non mi pare futile lascelta della radice piuttosto che del derivato «fondamento» o«fondazione», poiché indica il privilegiamento di una ragione oquasi di una azione del corpo sulla struttura categoriale. II fondoè come dire una «fondazione fungente» una profondità che inve-ste della sua vita, e quindi della sua verità, ogni possibilità didiscorso. II fondo rivelato dalla riduzione si svela poi in unaermeneutica fenomenologica che, attraverso la mediazione della
35
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamento
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 35 (Nero/Process Black pellicola)
costituzione storica, costituisce per opposizione le figure dell’in-tersoggettività mondana come l’interesse o l’alienazione.
II marxismo diviene così il repertorio delle categorie — l’aliena-zione, la merce, il feticismo — che rendono pensabile il soggettomondanizzato nel suo processo di liberazione e di finalizzazione.Comprendere la merce come lavoro umano è restituire intenziona-lità a un soggetto, disoccultare e, contemporaneamente, connettereil progetto alla totalizzazione. È qui che la problematica del sensodiviene intersoggettività fungente, partecipazione collettiva e, tra-mite il rapporto della verità con l’azione politica, si intravede lafigura difficile (si capisce per il significato che le parole hanno inPaci) dell’«essere nel senso». Ci sono due temporalità che mi pareentrino in collisione: la temporalità del tempo proprio della sogget-tività disoccultante, e la temporalità inevitabilmente mondanizza-ta della azione politica, senza la quale, tutto il precedente discorsoè solo appartenente a un quadro prepolitico. Ancora una volta mipare un’illusione quella di trovare una buona filosofia come garan-zia di una buona politica. Qui lascio ad altri di esaminare questaesperienza «marxista» nella filosofia italiana, e anche nel quadrointernazionale che vedeva, soprattutto all’Est, la rinascita del pro-blema del soggetto e anche della persona del marxismo.
Quanto al marxismo, come analitica della mondanizzazionedel soggetto, credo perda i suoi oggetti teorici fondamentali equindi la sua capacità di intelleggibilità analitica dei macrofeno-meni storici di lunga durata: com’è, per esempio, nella morfologiadel «modo di produzione». La fondazione precategoriale condu-ce il marxismo — in Paci come in Sartre — quasi alla sua infanziaantropologica, alle sue categorie settecentesche e hegeliane anchese contestualizzate in un lessico pieno di seduzione. Questa espe-rienza forse oggi aiuta a comprendere come questa infanzia abbiaavuto innumerevoli ripetizioni. Ma qui il marxismo, per la verità,non appartiene quasi più a se stesso, ma allo scenario di una par-ticolare forma filosofica.
So bene che Paci muterà il discorso ancora una volta perchéquella collisione delle temporalità che indicavo, in realtà, gli cadràproprio sotto gli occhi quando nella fretta panpolitica di queglianni — inizio anni Settanta — la sua interpretazione del marxismogli veniva restituita oggettivata come un sicuro sapere di cose informa schematica ed elementare, una deformazione ideologica chefaceva completamente perdere quella che a Paci appariva come lafondazione di verità dell’analitica marxista dell’esistenza sociale.36
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 36 (Nero/Process Black pellicola)
Di fronte a questi nuovi «feticismi», il filosofo ricordava la relazio-ne tra riduzione e temporalità e quindi la necessità di una continuadecisione che rendesse impossibile ogni processo di oggettivazio-ne, poiché solo a questo modo il problema del senso mantenevaaperta la sua forza di verità. Credo che in questa aporia, solo aparole governabile con uno strumento filosofico, in realtà fossevisibile la più radicale aporia esistente tra filosofia e politica e, nelcaso specifico, tra fenomenologia e marxismo.
Credo di avere già parlato di «filosofia espressiva». Una filoso-fia espressiva considera la sua relazione diretta con il linguaggiocome una messa in scena della verità e tuttavia ritiene che la com-prensione, quasi una forma di educazione da parte del destinata-rio, sia d’obbligo solo se la sua espressività passa per una fondazio-ne e quindi costituisce l’unicità del codice espressivo. Vi è un con-tinuo ambiguo e inevitabile scambio di ruoli tra fondante e fonda-to. In questo caso il filosofo diviene la forma vivente, in altro luogo,della sua stessa filosofia. II disegno filosofico, nel quale l’eros e ilsuo oggetto si approssimano quanto più si può, diviene un’auto-biografia che tende a coincidere non con il suo senso, ma con l’a-pertura in generale al senso.
II linguaggio filosofico di Paci non è affatto univoco, esso è costi-tuito da un insieme di imprestiti semantici che ristrutturano il lorosignificato di volta in volta nelle nuove contestualizzazioni. Tuttoquesto richiederebbe uno studio paziente, ma già ora si può direche, come linguaggio capace di molte trascrizioni, esso ottiene l’ef-fetto implicito di affermare con forza un primato dal filosoficocome espressione delle espressioni, senso dei sensi. È una filosofiache costruisce la sua capacità di verità proprio tramite la massimaapertura all’apprendimento semantico che, a sua volta, comeappartenente al luogo della verità è ricchissimo di possibilità di tra-duzione e di metaforizzazione. Attraverso la trascrizione metafori-ca la riflessione filosofica parla così della conoscenza, della religio-ne, della politica della musica, dell’arte, dell’architettura: tutti i lin-guaggi vengono proiettati sul medesimo spazio linguistico che èsostanzialmente quello di una ermeneutica del senso che ora pre-cede in una dimensione enciclopedica avendo trasfigurato, infine ilsuo desiderio in una tecnica filosofica della fondazione.
Fondazione e temporalità d’altro canto sono un intreccio diffici-le. Ne deriva una filosofia che amando profondamente il propriosenso, non può che costituirlo dirigendosi verso l’Altro, cioè versola scrittura di un oggetto filosofico. Ma, d’altra parte, questa alteri-
37
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamento
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 37 (Nero/Process Black pellicola)
tà non deve mai essere assoluta alterità, disegno obiettivo, perchénel quadro obbiettivato è impossibile rappresentare il desideriodella verità se mai il pregiudizio del suo possesso, quindi la suapietrificazione: le parole perdono l’anima del desiderio e si allonta-nano in una oggettività senza soggetto, mito punitivo di una veri-tà senza senso perché elusiva del tempo. Ma quale può essere ilsegno stabile, quello proprio di una temporalità comunicativa, diuna verità così radicale e così incerta?
Filosofia autobiografica dicevo: tuttavia occorre prestare atten-zione a non cadere in un errore che farebbe perdere di vista il valo-re specificatamente filosofico di questa esperienza. Non ci trovia-mo mai di fronte a un «io» che abbia a che vedere con una delleforme tradizionali della autobiografia. Nella autobiografia di Pacinon c’è il passato perché essa è tutta costruita sul problema delsenso che, comunque ritrovato, apre solo l’illimitata dimensionedel futuro, il tempo come misura ideale. Anche nel Diario fenomeno-logico l’io è sempre messo nella forma di correlato dei fatti da uncontinuo e definitivo suggerimento filosofico che, in quel genereletterario, provoca talora una sensazione di aridità, l’io è sempre ilderivato di una costruzione filosofica. È l’altro che lo mette informa di filosofia. L’io dell’enunciato è dipendente da un io filoso-fico che ne detta il senso e anche la possibilità di enunciazione. Lasoggettività autobiografica è sempre un’altra, ed è quella che parladell’Altro in cui rappresenta il problema del proprio senso: quindiuna soggettività di relazione, dove il perdersi nell’Altro, cioè ildiscorso filosofico, agisce sempre come paideia di un io che conti-nua ad affermarsi e a perdersi.
Si tratta, sempre, di una relazione incompleta, e quindi di unafilosofia necessariamente incompiuta, poiché divenire filosoficamen-te e consumare la fondazione è trasformare l’alterità nella trasforma-zione del senso di Sé. La filosofia è una «ascesi» (esercizio) di valo-rizzazione che, non di meno continua a essere un processo entropi-co, soggetto alla irreversibilità. Noi sappiamo che esistono sensi chenon potranno mai essere presenti in quanto valorizzazione, o, addi-rittura, che il desiderio di un senso autentico è stato un vizio epoca-le, forse ultima luce epigonale di un incrocio tra tradizione cristianae illuminista. E vediamo che la rincorsa e l’avvicinamento al senso, lacoincidenza tra l’io narrativo e l’io filosofico, come talora mi pareavvenga nel Diario fenomenologico, indebolisce la forza della verità,poiché avvicinandola, in realtà la allontana. La domanda di sensogenera incompletezza, la continua frattura del limite.38
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 38 (Nero/Process Black pellicola)
La domanda di senso invece è tanto più viva quanto più è ingrado di trasportare la sua domanda su una pluralità di oggetti. Dimodo che è nel destino più autentico della filosofia di Paci di pre-sentarsi come enciclopedia, o, forse meglio, poiché il significatodella parole è sempre difficile da disancorare dalle modellazionidella tradizione, come una particolare filosofia della cultura nonhegeliana e non neo-kantiana, dove il filtro della intellezione è lastessa ermeneutica del senso. Ogni filosofia della cultura nella suacategoria di comprensione — lo spirito, la legge trascendentale,quivi il senso — provoca le sue illuminazioni e le sue deformazio-ni. L’enciclopedia di Paci ovviamente non ne è priva, ma solo unesame analitico potrebbe mostrare gli effetti di «formazione» e«deformazione» dei vari oggetti simbolici.
La filosofia di Paci, per concludere, è espressiva e vitale: il desti-no che si è assegnato è di essere «espressione e significato dellavita». Sintagma, questo, pieno di parole metaforiche, e quindinecessariamente un poco enigmatico come deve essere una comu-nicazione che, nella forma stessa della sua fondazione - il sentirsi,l’evidenza — , vuole provocare una mimesi nel destinatario, sedot-to alla ripetizione. Certamente, assegnandosi questo scopo la filo-sofia è un oggetto d’amore e se, come dice Paci, riprendendo Freud,«il destino dell’eros è di superarsi», allora l’amore filosofico si fasempre trasceso in quella particolare relazione d’amore che è larappresentazione del Sé nell’Altro, costruito come fondazione,verità e comunicazione. Tuttavia una filosofia espressiva non èripetibile nel suo tema centrale ed è per questo che è una formainsolita di autobiografia.
Credo che questa filosofia, contrariamente a quello che si affer-ma nei più volonterosi e banali rituali di valorizzazione, non lascialcun problema aperto. Né più né meno come nel caso di un quadrodove a nessuno viene in mente di terminarlo, anche se non sa comegiustificare il fatto che sia finito. Si tratta invece di un fortissimomodello di esperienza filosofica. Proprio dei vivi è l’enorme privile-gio, da usare con discrezione, di aggiungere parole alle parole, e dipoter stabilire il termine, almeno provvisorio, del discorso.
Una volta, guardando alle vicende attuali della filosofia italiana,ho scritto che la filosofia poteva dividere i suoi attori tra restaurato-ri o «professionali» e autori. La differenza non va affatto considera-ta come dipendente da una valutazione sugli ingegni degli uomini,ma piuttosto deriva da due figure caratteristiche della comunicazio-ne sociale. L’una ha la sua radice nella tradizione e nelle istituzioni
39
Enzo Paci: le forme del soggetto tra autobiografia e fondamento
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 39 (Nero/Process Black pellicola)
e ne assume le caratteristiche di stile. L’autore, invece, è una figuramolto attenta alla recezione sociale anche nei suoi aspetti, alla fine,conformistici e ripetitivi. La filosofia di Paci non appartiene ne alprimo stile e nemmeno al secondo. È un discorso filosofico che haalla sua origine il tema della verità come possibilità di senso e la filo-sofia come tradizione e strumentazione di questo percorso. Unafilosofia così fatta è sempre incompiuta, eppure sarebbe vano nonriconoscere che oggi essa offre la resistenza aspra delle cose finite.
Paci quando ha scritto su se stesso, almeno da un certo momen-to in poi, ha sempre adottato una prospettiva «contenutistica», haparlato di autori, libri, idee, programmi. Dal canto mio ho cercatodi raccontare la storia di questo filosofo che più facilmenteandrebbe smarrita.
Note al testo
* Il testo è riprodotto per gentile concessione dell'Autore, e compareoriginariamente in Fulvio Papi, Vita e filosofia. La scuola di Milano: Banfi,Cantoni, Paci, Preti, Guerini e Associati, Milano, 1990.
40
Fulvio Papi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 40 (Nero/Process Black pellicola)
Intervista ad AMEDEO VIGORELLI(a cura di Massimiliano Cappuccio e Alessandro Sardi)
IL GIOVANE ENZO PACI:DAL CONFRONTO CON BENEDETTO
CROCE ALL’ESISTENZIALISMO POSITIVO
[Chora] Prof. Vigorelli, è a Lei che dobbiamo i principalistudi storiografici di tipo sistematico sulla vita e sull’opera diEnzo Paci. Per questo motivo abbiamo deciso di rivolgerLel’invito a fornirci una sintetica introduzione al pensiero delfilosofo di Monterado, così come una guida essenziale alleprincipali tappe che la sua vita personale e professionale haattraversato. Riassumere un percorso così complesso richiedecertamente di operare una selezione e delle forti sintesi, ma ilrisultato sarà comunque utilissimo per consentire agli studen-ti di oggi (ma non solo a loro) di comprendere complessiva-mente il progetto filosofico inaugurato da Paci e la caraturadella sua figura umana. Potrebbe esporci la suddivisione infasi del percorso filosofico di Paci, che ha già tracciato nellasua biografia? Potrebbe aiutarci ad orientarci in questa perio-dizzazione indicando per ognuno dei periodi quali sono statele letture, gli incontri e le problematiche filosofiche che più lohanno caratterizzato?
[Vigorelli] È sempre rischioso distinguere in “fasi” il pensierodei filosofi: si rischia di fraintendere il senso unitario della espe-rienza umana e di reificare il nisus finalistico (Paci amava dire iltelos) del suo essere aperta al mondo. Questo pericolo è ancor più
41
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 41 (Nero/Process Black pellicola)
consistente, se si affrontano quegli autori che, nella scia diBergson, hanno voluto affidarsi più alla intuizione che al pensie-ro logico, scegliendo per se stessi la divisa del Lebensphilosophanziché quella del filosofo professionale. Così, in Enzo Paci,abbondano le pagine in cui il pensatore, nel tentativo rinnovato dicostruire la propria autobiografia interiore, accenna a “svolte”,“ritorni”, “sviluppi” (a volte persino a una consapevolezza mora-le di “peccato” e di “pentimento”), che lasciano supporre unavolontà tormentata e sofferta di rispecchiamento nel pensierodella propria singolare durée réelle. Dunque, schematizzando: esi-stenzialismo (1938-1950), relazionismo (1951-1956), fenomomeno-logia (1957-1963), marxismo (1964-1976). Ma ognuna di questestagioni è intimamente fusa con le altre, come lo stesso Paci sotto-linea nelle sue dichiarazioni programmatiche: il suo esistenziali-smo è “storicistico”; il suo relazionismo è “concreto” e non logi-co-astratto: dunque “esistenzialistico”. Il ritorno a Husserl è poitutto giocato sull’ipotesi di una ricomposizione tra “fenomenolo-gia” e “esistenzialismo”, così come il suo marxismo è “fenomeno-logico” e ad un tempo “storicistico” (e dunque, nella sua fasefinale, “dialettico” e persino “negativo”). Anche per questo, neidue saggi che gli ho dedicato (la monografia pubblicata da FrancoAngeli nel 1987 e l’articolo apparso nel “magazzino di filosofia”nel 2001: ma in realtà concepito, in prima stesura, negli anniOttanta), ho preferito la categoria storiografica di “esistenziali-smo positivo”, già utilizzata con una certa fortuna per gli altridue autori che hanno meglio caratterizzato la generazione italia-na degli anni Trenta: Nicola Abbagnano e Luigi Pareyson; indivi-duando poi una svolta, che è più di carattere storico-culturale chenon strettamente teoretico, sul finire degli anni Quaranta, in cuifermentano tutte le esperienze dei decenni successivi. Quanto ai“quattro auttori” di Paci (per riprendere la definizione del predi-letto Giambattista Vico) non è difficile indicarli: Nietzsche,Bergson, Jaspers, Husserl.
Vorremmo chiederle di approfondire in particolare alcuniaspetti della formazione di Enzo Paci, durante il periodo deglistudi liceali, degli anni della formazione universitaria e dellaprima attività di ricerca. Pare che in quel periodo il suo modo disviluppare i temi della filosofia della storia e della vita fossefortemente influenzato da un confronto con lo storicismo asso-luto di Benedetto Croce e con l’idealismo romantico. 42
Amedeo Vigorelli
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 42 (Nero/Process Black pellicola)
La filosofia (ma ancor più la personalità) di Benedetto Croce haavuto un peso difficilmente sottovalutabile sulla maturazione dellavocazione intellettuale di Paci. Va sottolineato che l’influenza diCroce è in un certo senso anteriore a quella del suo maestro ricono-sciuto: Antonio Banfi. In Croce e nel suo antifascismo liberale Paciha precocemente trovato un ancoramento della propria inquietudi-ne morale (la stessa che lo spingeva, giovanissimo, incontro al“mito gobettiano”). Anche se poi l’incontro con l’ambiente milane-se della scuola banfiana lo indirizzerà verso scelte esistenziali ispi-rate a un più smagato “realismo” (da cui l’equivoco del suo “fasci-smo di sinistra”), una segreta fedeltà alla lezione etico-politica diCroce rimarrà in lui costante, motivando la sua ripresa del dialogocon lo storicismo crociano nel secondo dopoguerra. Da Croce Paciattingerà il costante tono “mondano” della propria filosofia, alienada più espliciti accenti metafisici. Alla distinzione crociana tra unromanticismo teorico (sano) e un romanticismo pratico (malato) èispirata anche la indubbia presenza di una Stimmung romanticanell’autore di Esistenza e immagine (forse il libro più rappresentati-vo del Paci-prima maniera). Ma la maggiore apertura del filosofodi Monterado alla letteratura contemporanea (rispetto al gustoancora “carducciano” di un Croce), gli suggerirà un più variegatopercorso estetologico e poetico (che comprenderà tra gli altri Rilkee Proust, così come Eliot e Mann). Per quanto riguarda più diretta-mente la tradizione filosofica, il lascito più evidente del romantici-smo storico si lascia cogliere nel costante e non superficiale interes-se di Paci per la Naturphilosophie, sia nella versione schelinghianache in quella goetheana. Anche se poi il “professionismo” filosofi-co (non certo assente in Paci) gli suggerirà una prudente presa didistanza dalla versione più segnatamente metafisica della scienzanaturale moderna e un avvicinamento alla raffinata cosmologia diautori come Whitehead o lo stesso Husserl.
In che cosa consisteva quella particolare proposta filosoficache Paci ha battezzato “Esistenzialismo positivo”, e che ha carat-terizzato il suo pensiero degli anni ’30 – ‘40? In che modo essapuò essere distinta da analoghe proposte di filosofi esistenziali-sti di quegli anni (o della tradizione ottocentesca) e sotto qualiaspetti invece essa ne prosegue il discorso? È possibile afferma-re che una tensione e una sensibilità esistenzialistica abbia attra-versato tutta la riflessione di Paci, fino alla sua fine, e in chemisura, invece, e per quali motivi, essa col tempo è stata almeno
43
Il giovane Enzo Paci
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 43 (Nero/Process Black pellicola)
parzialmente superata? È possibile mettere in relazione l’esisten-zialismo di Paci con gli eventi del tempo in cui viveva, con leesperienza del regime fascista, della guerra e dei campi di con-centramento?
Se con esistenzialismo si intende (come corretto) una esplicitavolontà di rottura con la tradizione dell’“intellettualismo” dellafilosofia occidentale (si pensi alla invettiva anti-socratica diNietzsche o a quella anti-hegeliana di Kierkegaard), non vi è dub-bio che si possa annoverare Paci tra gli autori esistenzialisti. Se con“positivo” si intende (come programmaticamente affermato datutti i maggiori protagonisti di quella stagione) la scelta di unorientamento “umanistico” della filosofia, contro le sue possibiliderive scettiche o nichilistiche, è ugualmente pacifica l’adesione diPaci a una simile versione di esistenzialismo. Ma se, per un frain-tendimento assai diffuso nella cultura filosofica italiana (e non soloitaliana) di quegli anni, per esistenzialismo si intende la prospetti-va teorica aperta da Sein und Zeit di Heidegger, in contrapposizio-ne al “razionalismo” della fenomenologia di Husserl (una interpre-tazione particolarmente avvalorata, nel nostro paese, dal maestrodi Paci: Antonio Banfi). E se poi di tale filosofia si dà una letturasuperficiale, che ne scontorna i rocciosi profili onto-fenomenologi-ci, per evidenziarne prevalentemente quelli etico-antropologici, cisi condanna a una “commedia degli equivoci”, da cui non fu inden-ne lo stesso Enzo Paci nel corso di più decenni (e che lo costrinse,in una estrema volontà di sincero ripensamento filosofico, ai con-torsionismi verbali del suo “ritorno a Husserl”: autore riletto inuna prospettiva non più escludente, ma inclusiva, rispetto al pro-prio esistenzialismo). Rimane comunque confermata la apparte-nenza (anche biografica) di Paci e la sua condivisione del clima spi-rituale caratteristico dell’epoca entre deux guerres: che della tragediadei totalitarismi novecenteschi e della autodistruzione dello spiritoeuropeo fece materia (sia pur mediata e indiretta) del proprio rin-novamento filosofico. Di quelle esperienze Paci non fu semplicetestimone, ma lucido interprete, particolarmente avvertito della“ambiguità” inseparabile dalla volontà di presenza e fedeltà al pro-prio tempo. Basterebbero a testimoniarlo le dense pagine del suodiario, che riportano il drammatico confronto del 1945 di Paci conil maestro della sua giovinezza, inaspettatamente approdato alcomunismo staliniano, pagine che sono state proposte con finerilettura da Guido Davide Neri, che ha saputo inquadrarle nella44
Amedeo Vigorelli
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 44 (Nero/Process Black pellicola)
loro giusta luce storica (Un confronto teologico-politico tra Paci e Banfi,“aut aut” 214-215, 1986, pp. 57-77: fascicolo speciale, nel decennaledella scomparsa di Enzo Paci).
Cosa resta oggi di Enzo Paci nel panorama della filosofia ita-liana, e in particolare cosa resta ai suoi allievi della sua ereditàintellettuale? Esiste una caratteristica del suo modo di percepireil lavoro filosofico, una connotazione della sua sensibilità chepossa essere riconosciuta come la cifra fondamentale del suoinsegnamento, in grado di avvicinare idealmente tutti coloro chehanno proseguito la sua ricerca?
Che cosa resta oggi di Enzo Paci? È banale dirlo, ma restano isuoi libri, a cui di frequente gli studenti di filosofia di quella che fula sua università ricorrono, per un approccio meno aridamente sco-lastico, dialetticamente più vivo, con la materia filosofica. La suaFilosofia contemporanea ha rappresentato per molti un avviamentoallo studio della problematica contemporanea, migliore di qualsia-si manuale. Della sua eredità filosofica si può dire ciò che con iro-nia Simmel profetizzava della propria fortuna postuma: che sareb-be stata spesa come “denaro contante”, anziché venire accumulatain forma patrimoniale. Paci non ha in effetti fondato una scuola (adifferenza del suo maestro Banfi), ma ha fecondato per mille rivolila discussione filosofica contemporanea. Si può dire che ognunodei suoi allievi ne abbia tratto qualcosa, mescolandolo con altri fer-menti, che hanno finito per rendere irriconoscibile il debito in ori-gine contratto. Questa “fedeltà infedele” non gli sarebbe in fondospiaciuta, legandosi a una idea alta del fare filosofico, mai del tuttoriducibile a sapere professionale. L’omaggio più esplicito è stato, intal senso, quello che ha voluto rivolgergli Mario dal Pra, che non siè limitato ad ospitare nelle collane da lui dirette o ispirate la primabibliografia e la prima biografia sul filosofo da poco scomparso, mache ha inteso anche segnalarne la posizione distinta e del tutto rile-vante - accanto a quella del filosofo, a lui umanamente e teoretica-mente più di Paci vicino: Giulio Preti -, nell’ambito di quella che siandava in quel periodo sempre più di frequente definendo come la“scuola di Milano” (in effetti, la scuola di Antonio Banfi). Se vi èuna cifra riconoscibile del suo insegnamento, essa sta forse nelmodulo “saggistico” della sua meditazione. Dopo i primi giovani-li tentativi (condannati a un inevitabile fallimento) di misurarsi conla sapiente esegesi e il solido metodo filologico del suo maestro
45
Il giovane Enzo Paci
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 45 (Nero/Process Black pellicola)
pavese (Adolfo Levi) o con la forma sistematica di quello milanese(Antonio Banfi), ne Il significato del Parmenide nella filosofia di Platonee nei Principii di una filosofia dell’essere, Paci troverà nel saggio laforma più adatta e a lui più congeniale di scrittura filosofica. Inquesta scelta si esprimeva forse una inconscia attrazione per l’uma-no, quale “forma” intrascendibile della problematicità teoretica(come recita uno dei titoli più fortunati: Il nulla e il problema dell’uo-mo). Ma è soprattutto nella misurata forma stilistica del saggio chel’autore riesce a dare fondo alla propria vocazione congiunta: per lafilosofia e per la musica. È all’esattezza della forma musicale (exer-citium mathematices occultum: come diceva Leibniz) che Paci scegliedi ispirare il proprio “rigore” filosofico, così diverso (pur nella affi-nità di fondo) da quello di Banfi e del suo “razionalismo critico”,ma altrettanto lontano dal pathos irrazionalistico di tanti, che glisono stati forse inconsapevoli epigoni. Se c’è poi un tratto persona-le che resta indimenticabile, per chi ha avuto la ventura di accostar-lo di persona (e non era persona facile da avvicinare), è forse quel-lo della disponibilità assoluta a misurarsi personalmente con quel-la che, con parola desueta, si ostinava a chiamare la “verità”, senzatimore di essere scambiato per un attardato metafisico, o forse conla civetteria di condividere un po’ del candore dell’uomo comune,della sua naiveté filosofica. Un tratto davvero singolare in una per-sonalità, che sulla più raffinata mediazione letteraria e sulla piùintensa frequentazione dei classici aveva saputo costruire il pro-prio “monumento vivente” e anche la propria posizione di potere(fosse pure quel potere, sempre un po’ ambiguo e sfuggente, che siallora diceva “potere accademico”, e che egli sembrò voler gettarealle ortiche, nel fatidico 1968…).
46
Amedeo Vigorelli
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 46 (Nero/Process Black pellicola)
MATTEO BIANCHETTI
PLATONE NELLA RIFLESSIONEDEL GIOVANE PACI:
Il significato del Parmenide nella filosofia di Platone*
O pera prima e nota di Enzo Paci, nata dalla rielaborazione dellasua tesi di laurea discussa a Milano con Antonio Banfi e LuigiCastiglioni come relatori. Il titolo della tesi, smarrita, era Saggio sulsignificato filosofico del Parmenide nella filosofia di Platone e fu presen-tata insieme a due tesine, una ancora in filosofia dedicata a Blondel(relatore: Baratono) e la seconda in pedagogia sul risentimento inMax Scheler (relatore: Morselli)1.
L’argomento è assai arduo e che un giovane, per quanto brillantee, come mostrerò, già nutrito da vaste letture, lo abbia affrontato pro-ponendo, per altro, un titolo largamente ambizioso e, soprattutto,uscendone in maniera più che dignitosa, è cosa davvero notevole.
Opera prima, si è detto, ma non improvvisata ché Paci, fin dalliceo, aveva intrapreso una riflessione personale e sentita che loaveva portato a studiare con impegno diversi autori e momentidella storia del pensiero. Di tutto questo vi è più di un’eco nel libro,e lo si nota, in maniera inequivocabile, fin dalla prefazione.
All’inizio, proprio nel primo capoverso, si trova il richiamo allacrisi della civiltà europea e al suo conseguente bisogno di com-prendersi che la spinge a rivolgersi indietro, verso la sua sorgenteclassica. In tal modo sarà, poi, possibile, si argomenta, vivere que-sta crisi in modo da superarla e renderla creatrice, ma solo dopoaver appreso a non rigettare nessuna delle opposizioni che costi-
47
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 47 (Nero/Process Black pellicola)
tuiscono l’esperienza nella sua concretezza e presenza effettiva.Ecco, allora, perchè la sua attenzione si è rivolta al Parmenide: inquesto dialogo ritiene di poter mostrare come Platone accetti diseguire tutti i sensi dell’essere e, quindi, lungi dal rappresentare ilcrollo del suo sistema e il venir meno della logica (come, invece, ciricorda, vorrebbe la filosofia dell’esistenza e, in particolare,Jaspers), le sue opposizioni creano la vita e il respiro dialettico delpensiero, “l’eterna legge razionale che supera la morte ad essaopponendo senza tregua la potenza creatrice dello spirito”2. Ilprincipio dell’antinomia dell’essere, a partire da Platone per pro-seguire oltre, rende possibile costituire un vero idealismo che nonsi appaghi di un definitivo e dogmatico ottimismo, ma colga evalorizzi la vita e le sue antinomie e, di conseguenza, proprioapprofondendo i motivi dell’esistenzialismo e della meditatio mor-tis, fondi la più pura e libera meditatio vitae.
In queste prime pagine, che recano, in calce, la data del 12 maggio1938, come ho già detto, si condensano gli studi e le riflessioni chetennero occupato il giovane Paci negli anni della sua formazione.
Il riferimento più immediato per il tema della crisi (della culturae della civiltà) è Antonio Banfi, suo maestro all’università di Milano,che, a sua volta rifacendosi ad ulteriori modelli (Simmel, Tillich, l’e-sistenzialismo in generale), si era sforzato di affrontare le oscuritàdel negativo e le asperità dell’irrazionale del tempo presente pertrasfigurarle razionalmente secondo una nozione di cultura ripresadalla tradizione umanistica, ma avvertita delle critiche ai valori ope-rate da Marx, Nietzsche e Kierkegaard, del realismo storico diHegel e dell’eudemonismo di Spinoza. Questi temi non si aggiunse-ro, però, estrinsecamente alla maturazione teoretica di Paci, il quale,invece, aveva già intrapreso per suo conto a polemizzare contro lamorta gora (per così dire, ma l’espressione non si trova nei suoi scrit-ti) della sintesi idealistica, sia crociana sia gentiliana.
Ancora liceale, a Cuneo, si appassionò per Spencer e consideròla filosofia il mezzo per fornire una sintesi delle diverse disciplineoggetto del suo studio, ma si mostrò subito insoddisfatto del diva-rio tra sintesi teorica ed esigenze concrete della vita. Si rivolse, allo-ra, al pragmatismo e ai suoi rappresentanti locali, Papini ePrezzolini, e, poi, a Croce e Gobetti.
Anche nel suo confronto con Croce, ancora, come è ovvio, soloincipiente, tenta di far valere le ragioni del carattere mondanodella vita e della storia contro l’impalcatura teologica della filoso-fia dello spirito (“bisognava spezzare il panlogismo e ciò era pos-48
Matteo Bianchetti
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 48 (Nero/Process Black pellicola)
sibile nello stesso Croce se la forma utilitaria era concepita, sullascorta di Marx, come realtà economica e questa come natura” scri-verà Paci ricordando quelle riflessioni giovanili3). Nel ’29-’30, inun saggio, non pubblicato, intitolato Lineamenti di un’interpretazio-ne crociana della realtà economica4, tornerà sulla questione, propo-nendo un confronto con Gentile, definito “protoesistenzialista”per il suo tentativo di distinguere lo spirito (che, propriamente,non è mai ma sempre si cerca) dal non spirituale, la natura (chesemplicemente esiste di fatto): occorrerebbe correggere Croce conGentile là dove il primo non pensa davvero le forme dello spiritonella loro attualità, ma si limita a presentarle come già realizzatedinanzi allo spirito. Ma anche Gentile, a sua volta, sbaglia nel nonaccettare la forma economica, o utilitaria, dello spirito teorizzatada Croce. Entrambe le proposte potrebbero, poi, emendare i reci-proci limiti sul terreno della filosofia della natura, concependoquesta, la natura, come reale fisicità, cioè non solo attività, maanche passività e, quindi, concretezza (coerentemente con questeassunzioni, Paci intraprese contemporaneamente lo studio dellaNaturphilosophie hegeliana). In uno scritto del ’31, infine, allapovertà della sintesi idealistica che assorbe la natura nello spirito,contrappone la fiducia che Kant, pur criticamente, riponeva nelvalore conoscitivo della scienza, prima questo che si attenuassecon il Romanticismo (ma, nota, non con Hegel).
Verso la concretezza e realtà dell’esistenza si orientano anche leriflessioni intorno a Piero Gobetti5, di cui commenta in particolarmodo il significato dell’eresia come creazione della storia nellafedeltà intransigente alla propria autobiografia opponendosi, diconseguenza, all’annullamento dell’individuo nello Stato e sma-scherando i falsi miti giustificazionisti e deterministi della presun-ta ragione superiore.
Ritornando ora ai maestri più prossimi a Paci negli anni imme-diatamente precedenti la stesura della tesi e la pubblicazione delnostro libro, occorre ricordare Adolfo Levi, studioso di Platone esostenitore di una filosofia scettica basata sul solipsismo in ambi-to gnoseologico e dogmatica in campo morale, di cui il nostro filo-sofo ascoltò i corsi di storia della filosofia all’università di Pavia(dove aveva iniziato i suoi studi, letterari, non filosofici, prima ditrasferirsi a Milano).
Nella sua speculazione e nella sua ricerca storiografica, intima-mente unite, Levi evidenziava l’aporeticità dell’esperienza e deldarsi, in essa, dell’errore e del male di contro alla visione unilatera-
49
Platone nella riflessione del giovane Paci
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 49 (Nero/Process Black pellicola)
le dell’attualismo (si ricordi la presenza della stessa esigenza nelleintuizioni giovanili di Paci) e indicava in Platone l’autore che piùdegli altri aveva affrontato coraggiosamente la sfida della giustifi-cazione razionale dell’esperienza di contro allo scetticismo sofisti-co6. I problemi del giudizio e del tempo (che unificano il moltepli-ce contravvenendo alla tesi eleatica e condizionano la possibilità ditrasporre i nessi ideali al piano reale), però, fanno naufragare il ten-tativo platonico. Il divieto eleatico di confondere uno e molteplicecondanna l’esperienza all’irrazionalità: esperienza e ragione sonoseparate (quasi come idee e cose nell’ultima, e maggiore, difficoltàdella cosiddetta teoria delle idee opposta a Socrate da Parmenidenel nostro dialogo) e nulla possono i tentativi idealistici e neokan-tiani di trovarvi un collegamento7.
Ricordando quello che abbiamo detto delle riflessioni giovanilidel nostro autore, non è difficile capire come questi argomentipotessero interessarlo e si vedrà come riaffioreranno nella suainterpretazione di Platone e del Parmenide.
Prima di affrontare direttamente il contenuto dell’opera pacia-na, occorre tornare a soffermarci, brevemente, sulla figura e l’ope-ra di Antonio Banfi, il suo relatore e maestro negli anni universita-ri milanesi. La sua opera più impegnativa è Principi di una teoriadella ragione, pubblicata nel 19268 e rimeditata da Paci proprio pocoprima di far uscire il suo libro sul Parmenide. Il conoscere, diceBanfi, è problematicismo e può essere giustificato solo a livello tra-scendentale, distinguendo, cioè, l’idea del conoscere (che coincidecon la legge trascendentale della correlazione ideale soggetto-oggetto che, a sua volta, guida la conoscenza attuale in un proces-so infinito) e la conoscenza nella sua reale attualità in cui i due poli,soggetto e oggetto, sono, invece, in antitesi. Scetticismo e solipsi-smo, idealismo e realismo sono solo figure della fenomenologiadella ragione, parziali se divengono indebite fissazioni unilateralidella vita della ragione. In Idealismo e realismo9, del 1931, si sottoli-nea con forza l’opposizione di Hegel al coscienzialismo empiristi-co, da un lato, e al soggettivismo idealistico, dall’altro: “Il raziona-le è [...] il movimento stesso della realtà in quanto si svolge allacoscienza della propria ideale natura”10.
La legge di infinita risoluzione della problematicità dell’espe-rienza, che prima era considerata solo formale rispetto alla realeantinomicità del livello dell’esperienza, diviene, ora, una dimensio-ne razionalmente oggettiva perchè dialetticamente operante nellosviluppo storico e culturale concreto. Riflessione teoretica e rifles-50
Matteo Bianchetti
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 50 (Nero/Process Black pellicola)
sione pragmatica vengono, allora, ad avvicinarsi e non si insistepiù tanto sulla necessaria purificazione dell’esperienza per passareal piano ideale, quanto, piuttosto, alla necessità di un’incarnazionedell’idea nella dimensione della finitezza e determinatezza.
Terminata l’esposizione, breve per le cose da dire, ma lunga nel-l’economia di questo articolo, del contesto in cui il giovane Paci ini-ziò la sua esperienza di pensiero, può finalmente incominciare laparte più strettamente dedicata al nostro libro.
Occorre, innanzi tutto, porre attenzione al titolo e notare comenon si tratti, stricto sensu, di un saggio sul Parmenide, ma, più pro-priamente, sull’intera speculazione di Platone, riguardata dalpunto di vista dei problemi trattati in quel dialogo. A tal scopo,sono utilizzati 23 dialoghi così ordinati: Ippia minore e Alcibiadeprimo, Ippia maggiore, Ione, Carmide e Lachete, Liside, Eutifrone,Protagora e Eutidemo, Gorgia, Menone, Cratilo, Fedone, Simposio, Fedro,Repubblica, Parmenide, Teeteto, Sofista, Politico, Filebo, Timeo.
Le uniche opere di rilievo escluse sono l’Apologia, la VII lettera ele Leggi (ed è comprensibile, almeno per la prima e l’ultima, per iloro interessi non metafisici). Il libro termina, poi, dopo l’analisi delTimeo, con un paragrafo dedicato alle idee-numeri.
Paci rifiuta di suddividere la filosofia di Platone secondo il suopresunto sviluppo (come, al contrario, proponeva Stenzel) e ritieneche essa costituisca un tutto unitario, privo di veri salti evolutivi11.
Fulcro dell’opera è, ovviamente, l’interpretazione del Parmenidee, soprattutto, della seconda parte, in cui l’eleate espone nove tesi(tante ne individua Paci, considerando la celebre sezione sull’istan-te come parte a sé12).
Le nove serie di deduzioni espongono, secondo necessità, lo svi-luppo del primo principio trascendentale della prima tesi nelmondo eidetico e, poi, nel mondo empirico attraversando tuttequelle che potremmo chiamare ontologie regionali fino a giungereal non essere assoluto dell’ultima tesi che, coincidendo con l’essereassoluto dell’inizio, riapre eternamente il ciclo.
La prima ipotesi afferma l’unità assoluta che, in quanto tale,non può né essere né porsi come oggetto del pensiero. È l’ideacome legge delle idee molteplici, il pensiero come legislatore di semedesimo o, che è lo stesso, esigenza ordinatrice assoluta, io tra-scendentale in senso kantiano.
La seconda tesi rappresenta il secondo grado dialettico, quelloin cui si giustifica l’esistenza e la molteplicità delle idee: ora l’uni-tà non si pone più come soggetto, ma come oggetto. Il mondo
51
Platone nella riflessione del giovane Paci
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 51 (Nero/Process Black pellicola)
delle idee è ciò che nasce quando si pensa l’unità ed è reso esi-stente dall’uno superesistente. Di tutto ciò che è positivo dev’es-serci un’idea, ci saranno, quindi, idee di tutte le cose perchè ognicosa è positiva e le idee saranno conoscibili non solo attraverso ilmetodo ascendente e quello discendente, ovvero secondo lascienza, ma anche, si badi, per il tramite della doxa e della sensa-zione perchè anch’esse possono essere vere se unificate dall’idea.Platone, come sempre, parla del mondo ideale trattando dei pro-blemi della conoscenza, ma solo qui lo espone in tutta la sua com-plessa organicità ontologica.
La terza serie deduttiva è quella, particolarmente problematica,dell’istante (exaiphnes) e riveste un ruolo centrale nel tentativoermeneutico paciano. In essa si attua il continuo passaggio dallaprima alla seconda ipotesi e dalla seconda alla prima. “Le duegrandi correnti dell’ideale e del reale, del pensiero e dell’esistente,della sostanza pensante e della sostanza estesa, dell’eternità deltempo e del divenire empirico, non si pongono in un’immobile estatica opposizione, ma si trascendono nel loro continuo correlati-vizzarsi l’una all’altra”13. Paci richiama la conclusionedell’Enciclopedia di Hegel e la sua citazione dell’aristotelico pensie-ro di pensiero: “l’idea, eterna in sé e per sé, si attua e si produce”14
incessantemente. Questo dinamismo trascendentale determina ilsenso delle diverse ipotesi che stiamo esaminando: non dati dog-matici, ma necessarie posizioni del pensiero, la razionalità delmondo in quanto determinazione della legge trascendentale.
Solo così, poi, sarà possibile chiarire il significato filosofico dellostesso metodo socratico che, benché frequentemente utilizzato neidialoghi precedenti il Parmenide, sarà esplicitato solo nel posterioreTeeteto: il pensiero deve continuamente superare quei particolarisensi dell’essere in cui, di volta in volta, si muove mostrando l’im-possibilità di fissarsi, indebitamente ,in uno solo di essi mentretutte le strade, in vario modo, si incontrano in questa terza tesi che,a sua volta, le trascende tutte. Nei dialoghi successivi, Platone tor-nerà a parlare della centralità della mediazione degli opposti (ilgenere misto del Filebo e la chora del Timeo): solo in questo modopuò verificarsi la creazione (e si può, ora, comprendere in tutto ilsuo valore anche la teoria dell’amore esposta nel Simposio: un esse-re fecondo crea, conducendo il non essere all’essere, quando sitrova in vicinanza del bello). Le stesse difficoltà contro la teoriadelle idee sollevate da Parmenide, nella prima parte del dialogo,trovano una spiegazione in quanto ciò che là si puntava a far cade-52
Matteo Bianchetti
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 52 (Nero/Process Black pellicola)
re era solo la sua interpretazione dogmatica (e, in modo analogo, sipossono comprendere anche apparenti ritorni di Platone a posizio-ni che sembravano superate, come la teoria della mimesis ripropo-sta nel Timeo in cui, peraltro, il mito serve a sottolineare la non dog-maticità dell’esposizione).
La quarta ipotesi si collega alla seconda: come quella contenevala descrizione del farsi della molteplicità ideale, così questa presen-ta la determinazione della realtà del mondo da parte del metododiairetico. L’unità e la molteplicità, pur rimanendo estranee l’unaall’altra, incontrandosi, porranno una nuova molteplicità racchiusadall’unità: l’unità dell’idea è pensata tutte le volte che si conosce larealtà. È questa la fondazione del campo ontologico in cui vale ilmetodo diairetico. La logica formale, propria della diairesis, deveessere, allora, distinta dalla dialettica filosofica e ad essa subordi-nata altrimenti non si capirebbe cosa ci guiderebbe nello stabilireun metodo logico.
La quinta catena deduttiva mostra il mondo della doxa quandol’uno è tornato ad occupare la sua posizione superessenziale dellaprima ipotesi: privo della perfezione dell’unità assoluta, il mondo sarà,insieme, organizzabile e non organizzabile, mai vera molteplicità.
Mentre le prime cinque serie di argomentazioni riguardano l’es-sere (se l’uno è), le ultime quattro trattano del problema del nonessere (se l’uno non è).
La sesta ipotesi si oppone alla seconda: in essa risiede un nonessere che rende possibile l’errore in quanto si scambia ciò che ècon ciò che non è. Si è già mostrato che il metodo diairetico puòfunzionare solo se tra le idee sussistono certe relazioni che esso sisforza di conoscere, ma se tra esse si danno anche relazioni false,ponendosi come altri non uniti, bensì opposti all’uno, allora sorgela possibilità dell’errore e del male.
La settima ipotesi, a sua volta, svolge in negativo il ruolo primariservato alla terza. Mentre quella si trovava tra il mondo idealepositivo e il mondo reale, anch’esso positivo, permettendo la crea-zione nel mediarsi della prima e della seconda ipotesi, questa, ora,posta tra il mondo ideale negativo e quello reale negativo, mostral’impossibilità della stessa creazione: nel mondo empirico negativonascere e morire avvengono nella disorganizzazione di un molte-plice che non rimane unito alla sua essenza.
Cosa sarà, allora, il mondo privo della creazione? Nell’otta-vatesi, il rovescio negativo della quinta, non solo la doxa è errore, malo è il mondo stesso che si presenta sì come l’oggetto della diaresis,
53
Platone nella riflessione del giovane Paci
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 53 (Nero/Process Black pellicola)
ma in quanto illimitato e assurdo. Poiché esiste solo ciò che ha un’i-dea, questo mondo non sarà propriamente reale e la sua moltepli-cità assurda potrà apparire unitaria solo a filodoxi tratti in ingannocome da sogni. “Solo a chi lo guarderà da lontano esso potrà sem-brare vero, ma quando “lo si esamini da vicino e con occhio acuto,ciascuna unità non può non sembrare multipla all’infinito, perchéessa è priva dell’uno” (165d)”15.
Nella nona ipotesi si è, ormai, compiuto il processo di allontana-mento dall’uno assoluto e si è così giunti al puro nulla. Non vi sonopiù neppure l’errore e il male, ma solo da questa assoluta opposi-zione alla prima ipotesi è possibile ritornare eternamente al princi-pio e ricominciare, di conseguenza, il ciclo delle ipotesi tornandonuovamente a creare nella perfezione.
“Parmenide alla fine del dialogo riassume la ricerca: “Tanto sel’uno è, quanto se non è, esso stesso e gli altri nei rapporti chehanno con sé e nei rapporti reciproci, sono assolutamente tutto enon sono, sembrano essere tutto e non sembrano”. Questo schema-tico riassunto è anche un’avvertenza: il lettore non rimanga all’ul-tima ipotesi, ma le abbia sempre presenti tutte insieme, perchè seprese tutte insieme le ipotesi sono i termini in cui si muove la leggetrascendentale e, in questo senso, il Parmenide ci offre, come abbia-mo tante volte affermato, la visione totale della razionalità delreale. Totale e quindi anche il non essere troverà, come abbiamovisto, la sua funzione e la sua necessità”16.
Tutte le altre opere di Platone sono esaminate nel tentativo dirilevare la coerenza e l’importanza del tema della relazione uno-molti, sia in ambito metafisico sia gnoseologico, che sottende tuttele ipotesi del Parmenide interpretate, come abbiamo visto, alla lucedella correlazione trascendentale essere-non essere.
I dialoghi di Platone sono suddivisi, solo metodologicamente, invista dell’obiettivo della trattazione, secondo l’ordine riportatosopra, tra quelli che precedono il Parmenide, culminanti nellaRepubblica, e quelli che lo seguono, distinguendo, però, in modoparticolare, il Teeteto (che mostra la possibilità di interpretare l’artemaieutica di Socrate come una fenomenologia del conoscere guida-ta dalla legge della correlazione essere-non essere) da Sofista,Politico, Filebo, Timeo e la problematica (solo accennata) delle idee-numeri.
Dalla Repubblica ricava le seguenti tesi:1. esiste un’unità, l’idea del bene;2. esiste una molteplicità come oggetto della fantasia;
54
Matteo Bianchetti
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 54 (Nero/Process Black pellicola)
3. esiste una molteplicità reale;4. esiste una molteplicità reale come intelligibile;5. esiste una molteplicità delle idee.La prima posizione sarà poi esposta nella prima ipotesi del
Parmenide e si richiama, a sua volta, a precedenti argomenti delMenone e del Fedone. Dopo aver guadagnato questa tesi con la dia-lettica ascendente, occorre ridiscendere alla molteplicità e lo sipotrà fare solo negando l’unità: questa sarà la seconda ipotesi delParmenide e coincide, nella Repubblica, con l’affermazione della mol-teplicità delle idee (quinta tesi dello schema) e, come si dice nellaterza ipotesi, quella unendosi con la prima ipotesi rende possibilela creazione, analogamente a quanto si era detto nel passo delSimposio precedentemente richiamato. È allora possibile passare almondo degli oggetti reali (terza tesi della Repubblica e quarta ipote-si del Parmenide) e, da qui, al mondo delle ombre (seconda afferma-zione della Repubblica e quinta ipotesi del Parmenide). Poiché, però,il molteplice può essere falso e la repubblica ideale può distrugger-si, anche nel mondo delle idee dovrà darsi il non-essere che per-mette il male e tutto quello che si è detto a proposito dell’esseredovrà ora rideclinarsi in riferimento al non-essere dando così vitaalle ipotesi negative del Parmenide.
Il proposito di questo dialogo sarà proprio quello di eseguire ilcompito affacciatosi nella Repubblica: applicare, dopo l’ascesi filoso-fica, il metodo discendente a tutta la realtà.
Nella sezione che segue la discussione sul Parmenide, poi, l’at-tenzione si concentra soprattutto, sul Teeteto, in cui Platone inten-de dimostrare, come già anticipato, che il metodo di indaginesocratico è un’applicazione, relativa al sapere e al non sapere,della correlazione trascendentale essere-non essere. La conclusio-ne aporetica del dialogo, analoga a quella delle opere giovanili,non concede nulla allo scetticismo, ma invita il lettore a compren-dere tutte le conclusioni negative dei dialoghi platonici preceden-ti in rapporto alla maieutica di Socrate, che incarna, appunto, lalegge trascendentale. Il problema del Parmenide si ritrova, qui,riferito alla sfera del giudizio e in tal senso va letta la discussionesul problema dell’errore: come può l’illimitato della sensazionetrovare un limite nell’azione giudicante del pensiero? Il giudiziodella diairesis unifica le rappresentazioni che interessano l’ogget-to della ricerca limitandole nella loro illimitatezza proprio comeil mondo delle idee, moltiplicandosi, raggiunge e giustifica il mol-teplice sensibile. L’errore è possibile perché, come sul piano onto-
55
Platone nella riflessione del giovane Paci
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 55 (Nero/Process Black pellicola)
logico si pone l’esistere negativo, a livello del giudizio si costitui-sce l’illimitato della sensibilità.
Il problema del giudizio e dell’errore non è, allora, risolvibilepsicologicamente: solo la possibilità di passare da ipotesi a ipotesidelineata nel Parmenide giustifica l’elevarsi dalla sensazione al giu-dizio. L’errore nasce dall’indebito fissarsi in un particolare momen-to fenomenologico della verità. Teeteto non riesce, alla fine, a sod-disfare le richieste di Socrate perché, fisso su concezioni dogmati-che di “opinione” e “ragione”, non riesce a comprendere che larazionalità deve esercitarsi attraversando tutti i diversi sensi del-l’essere scoperti nel Parmenide che determinano, per tutto il nostrosapere, ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che può ricollegarsi adun’idea e ciò che, invece, è disorganizzato e al di là del giudizio.
Nel Sofista, si prosegue questa discussione riportandola specifi-camente sul terreno ontologico e Amici della terra e Amici delleidee sono criticati proprio per il loro dogmatico pretendere che ilsenso dell’essere coincida solo con una delle ipotesi del Parmenide.A questo punto Paci si richiama a Husserl, già citato nella prefazio-ne, e alla sua elaborazione della fenomenologia, in Ideen, come“scienza delle strutture razionali della realtà”17 evidenziando chese, in un primo momento, sembrava tendere “a separare le essenzedalla realtà empirica, ad un certo momento sembra negare le essen-ze stesse, per basarsi sull’unico fatto indubitabile da cui le steseessenze finiscono per dipendere, vale a dire la coscienza intenzio-nale risolta in io puro inteso come residuo fenomenologico omeglio, possiamo dire, come io trascendentale: la fenomenologiadescrittiva si trasforma così in fenomenologia trascendentale. (…)La caratteristica fondamentale della fenomenologia sembra dun-que consistere nel porre il concetto di trascendentale da un puntodi vista tale per cui il fondare quel concetto significa nello stessotempo determinare i vari sensi dell’essere a cui il trascendentaledeve adeguarsi. (…) I vari momenti del conoscere non sono soloforme fenomenologiche negative del sapere assoluto e sono quindigradi di sviluppo puramente teoretici che la ragione deve percor-rere per conquistare se stessa, ma diventano anche i vari pianiessenziali, vari sensi di quell’essere che non sono più dati dogma-ticamente, come prima dell’epochizzazione, ma risolti nella strut-tura trascendentale del conoscere”18. La consonanza con la letturadi Platone e la conseguente proposta teoretica è chiara.
Non è, infine, possibile, seguire ulteriormente l’esegesi pacianadei rimanenti dialoghi platonici a cui, in ogni modo, si è fatto56
Matteo Bianchetti
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 56 (Nero/Process Black pellicola)
accenno sopra e, inoltre, descrivendo l’interpretazione degli altridialoghi, è possibile ritrovarne le coordinate fondamentali.
La sua ricerca, benché non ancora del tutto matura, mostra,comunque, la direzione lungo la quale si muoverà successiva-mente cercando di creare le condizioni per un incontro di diversiorizzonti culturali che, in questo caso, sono, principalmente, idea-lismo, esistenzialismo e filosofia dei valori. Nessuno si imponesopra gli altri, ma tutti sono posti in comunicazione reciproca perraggiungere quella che lui stesso chiama una filosofia dell’essere (ePrincipi di una filosofia dell’essere, con evidente richiamo al titolodella principale opera banfiana, sarà il titolo del suo successivolavoro del 1939).
Note al testo
* Enzo Paci, Il significato del Parmenide nella filosofia di Platone, Principato,Messina-Milano, 1938 (rist. nelle Opere di Enzo Paci, intr. di C. Sini,Bompiani, Milano 1988).1. A. Vigorelli, L’esistenzialismo positivo di Enzo Paci. Una biografia intellet-tuale (1929-1950), Collana di Filosofia, Franco Angeli, 1987, p. 124, nota102. Il libro di Vigorelli è molto documentato e vi farò ricorso più volte.2. E. Paci, , Il significato del Parmenide nella filosofia di Platone, intr. di C. Sini,Bompiani, Milano 1988, p 2.3. Enzo Paci, Itinerarium philosophicum, cit. in A. Vigorelli, op. cit., p. 58. Sitratta di un breve inedito databile al 1955, incompiuto, in cui l’autore deli-nea, in modo sommario, la propria biografia intellettuale.4. Cfr. A. Vigorelli, op. cit., pp. 58-74.5 Cfr. A. Vigorelli, op. cit., pp. 74-89.6 Di Levi occorre ricordare Il concetto di tempo nei suoi rapporti coi problemidel divenire e dell’essere nella filosofia di Platone, Paravia, Torino 1920 e Sulleinterpretazioni immanentistiche della filosofia di Platone, Paravia, Torino 1920,e Sceptica, Paravia, Torino 1921.7. “All’attualismo di Gentile che concepisce ‘l’intima natura del reale comedivenire logico e non temporale’, si può obiettare: ‘se tutto è intimamenterazionale e lo sviluppo è fuori del tempo, che si riduce a una visione sog-gettiva della mente individuale la quale non coglie sotto questo aspetto lavera natura del reale, come e perchè, in un mondo completamente razio-nale, è possibile tale visione unilaterale e quindi errata? Come si possonogiustificare l’errore e il male?. D’altro canto, al metodologismo marbur-ghiano (a cui si può accostare [...] la stessa posizione di Banfi) che ‘con-
57
Platone nella riflessione del giovane Paci
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 57 (Nero/Process Black pellicola)
dannando ogni metafisica, rivolge la propria attenzione alla ricerca delladeterminazione dei fondamenti razionali della conoscenza, da cui si sfor-za di derivare la logicizzazione progressiva della esperienza’, giova ricor-dare che ‘se tali fondamenti non sono nel tempo, se valgono all’infuori diogni successione come è possibile ridurre ad essi quell’esperienza chenecessariamente assume l’aspetto del divenire temporale?’” (A. Vigorelli,op. cit., pp. 105-6).8. A. Banfi, Principi di una teoria della ragione (1926), Parenti, Novara 1960. 9. A. Banfi, Idealismo e realismo, Archivio di filosofia, a. I, 1931.10. Ivi, p. 206, cit. in A. Vigorelli, op.cit., p. 113.11. E. Paci, op. cit., p. 37.12. Gli studiosi, oggi, tendono, per lo più, a considerare il passo 155e3-157b4 come un’appendice alla seconda serie di deduzioni, ma non cosìfecero i neoplatonici che lo considerarono, appunto, la terza tesi su novetotali nelle quali, poi, credettero di ritrovare l'intera struttura metafisicadel reale.13. E. Paci, op. cit., p. 104.14. Ivi, p. 104-5.15. Ivi, p. 121.16. Ibidem.17. Ibidem, p. 175.18. Ibidem, pp. 175-6.
58
Matteo Bianchetti
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 58 (Nero/Process Black pellicola)
SANDRO MANCINI
PRINCIPII DI UNA FILOSOFIA DELL’ESSERE, OVVERO
DA PLATONE A JASPERS: L’ACCORDO TRAIDEALISMO E ONTOLOGISMO*
Lo scopo di questa rivisitazione è di focalizzare l’ispirazioneplatonica che plasma, tra la fine degli anni ’30 e gli inizi degli anni’40, la prima fase della teoresi paciana, attraverso un’analisi del suotesto teoreticamente più consistente, e finora trascurato: Principii diuna Filosofia dell’Essere, del 1939. Si tratta del secondo libro di Paci,che segue la prima e più nota monografia, Il significato delParmenide nella filosofia di Platone, pubblicata nel ’38.
Come nel suo primo studio platonico, anche nell’opera del ’39 lacornice teorica della trattazione è data dalla nozione banfiana di“legge trascendentale”. Questa, così come la teorizzava Banfi e laripropone il suo giovane allievo, estende l’ambito della sua norma-tività all’intero campo fenomenico dell’esperienza: il suo contenu-to, eminentemente gnoseologico, è dato dal principio della correla-tività di soggetto e oggetto, esplicantesi antinomicamente, nelritmo di complementarità e antitesi che scandisce il processo dellaconoscenza, nella quale, posta una determinazione categoriale delpensiero, è con ciò stesso posta anche la sua determinazione antite-tica e, appunto, correlativa1. Ora, la legge trascendentale non ponesoltanto la correlazione come struttura universale del conoscere,ma afferma che essa costituisce l’essenza della conoscenza: “Questorapporto puro di correlazione soggetto-oggetto, questa sintesi tra-scendentale dei due termini – puntualizzava Banfi – costituisce la
59
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 59 (Nero/Process Black pellicola)
forma essenziale o l’idea del conoscere” 2, portando a espressionela problematicità come carattere costitutivo del pensiero, e affer-mando così la sua natura antidogmatica3.
Nel suo esordio ufficiale, Paci assume dunque la legge trascen-dentale a cornice della sua ricerca, ma le imprime una originalecurvatura, che le fa svolgere una differente funzione. Mentre infat-ti Banfi propone la legge trascendentale come metodologia per unafilosofia della cultura, sulla base dell’assunto della separazione delconoscere dall’essere, che connota appunto il suo ‘razionalismo cri-tico’, Paci coglie la deriva logicistica e relativistica di un tale proble-maticismo teoretico, di ispirazione neokantiana, e le contrapponela vigorosa riaffermazione della coappartenenza di pensiero edessere, rifiutando così di seguire le orme del maestro nella contrap-posizione di gnoseologia e ontologia, senza timore di venire con ciòaccusato di dogmatismo. Pertanto, nella primigenia intuizionedualista di Paci la correlazione è accolta sì nella sua universalità,dunque anche come correlazione di essere e non essere, ma essa ètale in quanto si pone come l’espressione dell’assoluta e intempora-le identità di pensiero ed essere.
Questa intuizione trova la sua organica formulazione nel libroche ci proponiamo di analizzare: l’unico, tra i numerosi libri del-l’autore, che presenti un carattere sistematico4. Certo, il secondocimento filosofico di un Paci ventottenne mostra la stessa acerbitàdel primo; non per questo tuttavia va sottovalutato il suo ruolo nel-l’itinerario paciano, né la sua ingenuità ne fa un’opera infelice,come è stato da qualcuno affermato.
La Prefazione palesa subito l’intenzione del libro, e della prece-dente monografia platonica: riaffermare l’identità di pensiero edessere, in implicita contrapposizione alle derive gnoseologistiche eal relativismo empirista, e in esplicita continuità con l’idealismoitaliano e con l’ontologi1smo di Pantaleo Carabellese e di NicolaiHartmann. Sullo sfondo di questa operazione, si delinea la ricercadi una nuova idea di fenomenologia, in cui converga sia quelladell’Hegel della Fenomenologia dello spirito sia quella husserliana.Certo, l’Husserl chiamato in gioco è quello appreso alla scuola diBanfi, non è ancora il suo Husserl, che incontrerà alla metà deglianni ’50; anche l’approccio a Hegel è abbastanza sommario, giac-ché un attento confronto con la Fenomenologia dello spirito avverràsolo a partire dalla seconda metà degli anni ‘60. Ma tale carenzastoriografica rende ancora più acuta e lungimirante l’intuizione diquesta convergenza; essa sorge in Paci indipendentemente da60
Sandro Mancini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 60 (Nero/Process Black pellicola)
Sartre e da Merleau-Ponty, che proprio allora stanno componendole loro due grandi opere, L’essere e il nulla e Fenomenologia della per-cezione, nelle quali pure si vanno intrecciando l’eredità hegeliana equella husserliana, che invece in Germania sono e rimarrannoseparate e anzi contrapposte.
È invece già operante, nel libro del ‘39, la lezione tratta da JeanWahl, promotore in quegli anni sia della Kierkegaard renaissanceche della convergente Hegel renaissance, ossia di un’interpretazio-ne della dialettica hegeliana mirante a valorizzarne le sporgenzeesistenzialistiche, come l’inquietudine del negativo, la coscienzainfelice e il rapporto servo – signore. Facendo reagire sul pensie-ro hegeliano sia la lezione tratta dall’ontologismo, sia quella enu-cleata da Kierkegaard, nella Prefazione Paci addita “i due proble-mi lasciati aperti, in tutta la loro vastità, dall’idealismo hegeliano:la personalità e la natura” (PFE, 12). Egli individua la radicecomune di queste due debolezze, all’interno del sistema hegelia-no, nel primato dell’autocoscienza, scorgendo nell’attualismogentiliano una possibile risorsa per l’eliminazione del retaggiocoscienzialistico presente nell’idealismo; è infatti a motivo di ciòche Hegel finisce per schiacciare il piano fenomenologico su quel-lo logico, confondendo così i gradi del conoscere con lo svolgi-mento storico (cfr. PFE, p. 69).
Ritengo che sia proprio la dialettica tra pensiero pensante e pen-siero pensato elaborata da Gentile a dischiudere a Paci la via – inquesto libro appena abbozzata, e nel dopoguerra lasciata definiti-vamente cadere – per tentare di liberare l’idealismo dalle secchecoscienzialistiche e panlogiste in cui è finito per incagliarsi, giànella stessa navigazione hegeliana: nel suo rapportarsi all’ideali-smo hegeliano per il tramite dell’attualismo, il giovane Paci mira arecusare il primato dell’attività rappresentativa dell’io cosciente,senza revocare la centralità della soggettività trascendentale, eaffermandone per converso la sua densità ontologica. Con ciò egliapre un’interessante prospettiva per l’interpretazione dell’attuali-smo, che è ancor oggi tutta da percorrere: mantenere il primato delpensiero pensante sul pensiero pensato, revocando la sua formula-zione coscienzialistica5. Insomma, la lezione che il giovane Pacipare trarre da Gentile, seppure con una certa elusività, è che nel-l’autoctisi, ossia nell’atto in cui si dà il pensiero pensante, il decisi-vo non sta nell’io cosciente che pensa, nella sua volontà di afferma-re la sua legislazione sull’esperienza, ma nel pensare stesso, che hanel suo stesso irrecusabile porsi la propria incontrovertibilità. In
61
Da Platone a Jaspers: l’accordo tra idealismo e ontologismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 61 (Nero/Process Black pellicola)
quest’ultima risiede il senso della verità: un senso che precede latematizzazione della verità, e che è conficcato nell’atto, concreto evivente, del pensare stesso. Esso non è dunque in alcun modo infe-ribile dal radicarsi del pensiero nel mondo; per questo motivo Paciintende, platonicamente, l’esplicarsi del pensiero nel mondo comel’accadere della sua “caduta” nel mondo. Per attingere la sua irre-cusabile assolutezza, occorre prescindere dall’estrinsecazione delpensiero nel sistema delle forme dello spirito e coglierlo in un’ap-prensione intuitiva, “nella propria pura solitudine”, attraversando ildeserto mondano della menzogna e del male:
Ora, non è forse raggiunta, tale solitudine, attraverso la profon-da discesa della dialettica in quelle forme dell’essere che viola-no l’esistenza, la falsano, costringendola ad essere quella chenon è? Attraverso la discesa del pensiero in un mondo che nonpuò essere per esso che falso, più falso dell’esistente? Ma pro-prio in questa discesa è la conquista assoluta della libertà delpensiero stesso che non si confonde né con la fantasia dell’arte,né con la mitologia della religione, né con il dover essere dellamorale (PFE, 66-67).
Il convincimento che l’orizzonte del senso si dischiuda all’uomosolo attraverso un esercizio di purificazione dalle ovvietà monda-ne rimarrà un caposaldo anche della successiva fase, nella quale l’i-spirazione platonica lascerà il posto all’intuizione dell’emergeredel senso dalle profondità del mondo della vita: proprio come áske-sis Paci interpreterà la tematica husserliana dell’epoché6. La conti-nuazione del passo citato mostra come l’assolutezza del pensierodiventi, incontrando l’uomo, una “spiritualità assoluta […] che nontende che a a se stessa, alla propria colma e gelida purezza” (PFE,67). Si incontra qui “il punto più alto” dell’ascesa del pensiero, cuiquesto giunge lungo i gradi ascensivi della “dialettica della feno-menologia”, alla quale corrisponde, specularmente, la discensiva“dialettica dell’essere”. Paci delinea il loro nesso in pagine un po’oscure, per l’acerbità della teoresi, ma preziose7. Proviamo a segui-re con pazienza i passaggi del discorso.
Il punto di partenza è costituito dall’impossibilità per la coscien-za di eguagliare l’assolutezza del pensiero. La critica di questa pre-tesa, ossia del coscienzialismo, si snoda in un percorso in cui lacoscienza mira a superare la sua costitutiva unilateralità e ad ele-varsi all’autentica libertà, che però non può mai essere la sua, ma62
Sandro Mancini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 62 (Nero/Process Black pellicola)
solo quella del pensiero assoluto. Ora, “il superamento del coscien-zialismo” non consente solo di affermare l’assolutezza del pensie-ro, nel contrasto con la parzialità della coscienza, ma pervieneanche alla “identificazione dell’essere del pensiero con l’esseredella sua dialettica e quindi con l’essere del mondo” (PFE, 54 e 55).Infatti nell’identità assoluta dell’essere e del pensiero risiede anche“l’idealità del mondo”. Questa medesimezza, tuttavia, nel proces-so della sua espressione deve inesorabilmente incrinarsi, e l’imma-nenza ruotarsi in trascendenza. La prima articolazione di tale dia-lettica trascendentale conduce da quell’identità al ‘mondo ideale’,ossia alla sfera eidetica, cui si contrappone dapprima ‘l’esistente’,cioè la finitezza di tutto ciò che alle idealità è irriducibile, e poi il‘mondo dello spirito’, ovvero l’ambito in cui le due polarità simediano prassicamente.
Non ci soffermiano su ciò, perché incontreremo nell’ultima partedei Principii la triade di pensiero, esistenza e valore, qui abbozzata;va detto però fin d’ora che essa costituisce la griglia redazionaleentro cui Paci dispone la trattazione contenuta nel libro del ‘398. Perora ci preme di focalizzare la dualità che risulta dall’espressione diquella identità assoluta, determinante la relazione che oppone daun lato la libertà assoluta del pensiero, la sua dialettica ideale edeterna, dall’altro lato l’essere del mondo, l’esistente. La difficoltà èche tra i due ambiti vi è sia reciprocità sia dissimmetria. Infatti perun verso ciascuno di essi è tutto l’essere, per cui si può dire cheognuno dei due è nell’altro, contiene l’altro, ma, per un altro verso,vi è una fondamentale differenza: mentre il mondo delle idee, ilmondo esistente e il mondo dello spirito sono tali soltanto essendotutt’uno con l’essere del pensiero, quale sua manifestazione, ciò nonvale per l’essere del pensiero, il quale è sia in altro, ossia in quellamanifestazione tripartita, che in se stesso. Ne consegue che da unlato la dialettica della fenomenologia, quale percorso di negazionecontinua delle unilateralità delle espressioni finite, dunque qualecritica del dogmatismo di “ogni forma del conoscere”, e dall’altrolato la dialettica dell’essere, in cui il pensiero assoluto si esprimeidealmente nelle essenze eterne, sono sì indisgiungibili, ma nonsono sullo stesso piano, perché non presentano la medesima pre-gnanza veritativa. La verità contenuta nella “posizione fenomenolo-gica del pensiero” (PFE, 56) consiste nella critica di tutte le formelimitate del conoscere, è dunque una verità negativa che, nel pale-sare le unilateralità da deporre, elimina progressivamente le incro-stazioni dogmatiche che bloccano il processo di elevazione all’asso-
63
Da Platone a Jaspers: l’accordo tra idealismo e ontologismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 63 (Nero/Process Black pellicola)
luto. Di contro, la dialettica dell’essere si attua al di fuori dei limitientro cui si esercita la dialettica della fenomenologia:
Per la fenomenologia il reale è negativo e solo è valido in quan-to, con la sua negazione, indica il pensiero puro; per la dialetticadell’essere le varie forme dell’essere sono tutte possibili, anzitutte necessarie: la dialettica da cui sorgono non esclude nessu-na di esse ma anzi tutte le fonda. La dialettica fenomenologicaoppone ogni sua forma ad una forma superiore e, man mano,tutte le sue forme diventano errori poste in rapporto al pensieropuro e tutte quindi vengono negate. La dialettica dell’essere […]è appunto dialettica di posizioni che si determinano nello stessotempo che il pensiero si conquista la sua libertà negandosi eaffermandosi (PFE, 62).
Paci mostra inoltre che, se la dialettica fenomenologica è in fun-zione della dialettica dell’essere, è comunque a questa indispensa-bile; infatti, senza il processo ascensivo di purificazione dalle uni-lateralità dogmatiche, il pensiero, una volta spogliatosi dei limitidella coscienza, ritornerebbe all’incosciente; ma ciò non avviene, eil pensiero può attuarsi nella “sua pura libertà”, proprio perchéquesta “viene sempre fondata da una fenomenologia” (PFE, 57).
Il termine ‘fenomenologia’, ricorrente in questa opera, è usatoprincipalmente in riferimento alla hegeliana Fenomenologia dello spi-rito, ma – come si è detto – intravedendo la sua compossibilità conla fenomenologia di Husserl, sulla base del comune convergere nel-l’identità assoluta di essere e pensiero (cfr. PFE, 85-86). Ora, oltreche per la convergenza con la ricezione di Hegel in Francia, giàsegnalata, ciò è significativo per altri due motivi: mostra, anzitutto,che nel primo Paci non si dà incompatibilità tra la prospettiva diHusserl e quella di Heidegger, il quale – come è noto – svolge lafenomenologia in ontologia; attesta, inoltre, l’originalità del giovanePaci nei confronti di Banfi, che pure è stato il tramite dell’incontrocon la filosofia husserliana, poiché egli non segue il suo maestronella limitante lettura neokantiana di Husserl. Paci scorge infatti cheproprio lo sforzo di Husserl, rivolto ad attingere il residuo fenome-nologico di assolutezza dell’attività pensante, lumeggia il principiotrascendentale nel suo operare non come esclusivamente gnoseolo-gico, perché esso raccorda il piano fenomenologico con quello eide-tico, platonicamente inteso (cfr. PFE, 88). Il contributo di Husserl,qui posto in risalto, è proprio il guadagno di una “eidetica catego-64
Sandro Mancini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 64 (Nero/Process Black pellicola)
riale”, che dunque Paci accoglie, platonicamente, nella sua intrinse-ca portata veritativa, e non come un piano di mera virtualità.
Oltre che un’esplicita intersezione con la prospettiva husserlia-na, il filo della meditazione contenuta nel secondo capitolo dellaprima parte del libro (Il problema della fenomenologia) affronta daultimo, senza riferimenti diretti a Husserl, un nodo centrale dellafenomenologia e della problematica del senso: lo statuto veritativodell’intuizione. L’intenzione fondamentale è qui di riconoscere talestatuto, togliendo l’incompatibilità tra intuizione e concetto, ope-rando così un allargamento stesso dell’ambito della ragione. Pacipersegue questo obiettivo riannodando i fili dell’intreccio tra dia-lettica dell’essere, in cui il pensiero è posto per se stesso, nella suapurezza, e dialettica della fenomenologia, nella quale il pensiero èposto per altro, ossia si esplica nel medio della coscienza. Ora, l’in-tuizione è proprio l’attuarsi fenomenologico del pensiero nellacoscienza, indica cioè il pensiero che non è ancora giunto a se stes-so, alla quiete della sua pienezza: “[…] l’intuizione non è una formadel conoscere da distinguersi dal pensiero ma bensì rappresenta il pensie-ro stesso nel suo farsi fenomenologico” (PFE, 99). In tal modo non vi èincompatibilità tra concetto e intuizione, poiché l’intuizione desi-gna l’apprensione del vero nel processo fenomenologico dellacoscienza. Questo significa che l’intuizione non è fuori dal concet-to e, correlativamente, il concetto “non è affatto una negazione del-l’intuizione, anzi non è nulla senza di essa” (PFE, 98). Vi è dunque“un’intuizione delle idee o delle essenze, come si può parlare diun’intuizione delle categorie”; infatti “le idee non vengono conqui-state dalla fenomenologia con una deduzione trascendentale maproprio invece intuite” (PFE, 100). Così l’intuizione, se è esclusadalla dialettica dell’essere, accompagna di converso l’intero proces-so fenomenologico della conoscenza, fino al suo vertice supremo;coerentemente, Paci si spinge fino a riconoscere la legittimità del-l’intuizione intellettuale, già bandita da Kant e invece riconferma-ta da Fichte e da Schelling.
L’intuizione fa dunque tutt’uno col processo fenomenologicocon cui la coscienza ascende verso la verità del pensiero, processoche dunque in ogni grado raggiunto è sempre accompagnato daun’apprensione intuitiva. Sotto questo profilo, Paci parla di una“fenomenologia dell’intuizione” come di un “vedere il mondo” (PFE,101), che non si arresta ai gradi della conoscenza sensibile, ma vafino in fondo, culminando nella “intuizione pura del mondo”9. Nelsuo vertice, nel punto in cui la dialettica della fenomenologia assur-
65
Da Platone a Jaspers: l’accordo tra idealismo e ontologismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 65 (Nero/Process Black pellicola)
ge ai bagliori dell’assoluta coincidenza di essere e pensiero, l’intui-zione supera se stessa, perché in essa non vi è più scarto tra l’impli-cito e l’esplicito, e dunque l’intuizione non può più porsi comeun’apprensione contratta del vero; e come la coscienza deve perde-re se stessa, deve deporre la sua costituiva limitazione, per giunge-re alla pienezza dell’essere, così pure, nel suo illuminare l’interez-za del mondo, l’intuizione deve venir meno, perché il pensieropossa compiersi nella sua assolutezza:
[…] l’intuizione perde a poco a poco tutta la sua verità nascosta fino aperdere se stessa analogamente a quanto avviene per la coscienza. Inquel momento l’intuizione trascende se stessa, diventa intuizio-ne pura e vede tutto il mondo come lo pensa il pensiero e cioècome coincidenza tra pensiero ed essere e dialettica tra essere enon essere (PFE, 103).
Il sacrificio dell’intuizione, e della coscienza che ne è l’ambien-te, è necessario, perché consente al pensiero di attivarsi proprionel punto di incontro con l’intuizione, e grazie a ciò di vedere ilmondo nella propria autotrasparenza, di “farsi” mondo. E questonon una volta per tutte, ma sempre di nuovo, in una “conquistaperenne”. Incontriamo qui il Leitmotiv dell’immer wieder come ope-rante già in questo esordio speculativo; Paci lo rimarcherà moltianni dopo, onde evidenziare il carattere antidogmatico di questosuo giovanile cimento speculativo. Così continua il passo citato,che conclude il paragrafo:
In conclusione la dialettica fenomenologica dell’intuizione fa sìche questa si uguagli al pensiero, fa sì che intuizione e pensiero siidentifichino. Questa identificazione è il massimo risultato delprocesso fenomenologico. Trovato il suo punto di contatto con l’intui-zione, il pensiero, pensando se stesso, sarà il mondo e vedrà se stesso farsicome mondo e questo suo vedersi è proprio la conseguenza dellapurificazione dell’intuizione che si è compiuta nel suo seno, nellostesso modo che il suo muoversi come dialettica dell’essere e comepensiero puro sono il resultato della critica fenomenologica dellacoscienza. Pensando a quel suo vedersi infinito, che non conoscealtro orizzonte che quello che da se stesso si crea, potremmo anchedefinire il pensiero assoluto come la conquista perenne della pura,assoluta e libera intuizione del mondo o come il mondo stesso chesi vede nella trasparente visione di sé (PFE, 103-4).
66
Sandro Mancini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 66 (Nero/Process Black pellicola)
Il farsi mondo del pensiero, ossia la sua esplicazione discensiva,trova la prima obiettivazione nella sfera eidetica delle idee, ‘ilmondo ideale’, ove il pensiero, ponendosi come essenza, si mediacol suo stesso essere, dando luogo alla correlazione di essere e nonessere e a quella dell’unità e della molteplicità; queste due coppieformano “le due categorie fondamentali che si sviluppano dall’i-dea e cioè dal concetto stesso di categoria” (PFE, 119). Qui Paci faconfluire l’esito della sua lettura della dialettica platonica elabora-ta nel libro precedente (ora prolungata in un sintetico confrontocon Fichte e Gentile), esplicitandone la finalità: mostrare il circolodel “molteplice che si unifica”, e della “unità che si moltiplica”,significa squadernare “il senso fondamentale dell’idealità delmondo, il momento caratteristico della sua essenzialità” (PFE, 121);proprio ciò consente di allestire il registro teoretico in cui poi tema-tizzare “tutti gli aspetti ideali del reale”. È quanto fa Paci nel capi-tolo seguente (il quarto della prima parte), affrontando la secondamediazione del pensiero col suo essere, la quale dopo l’idea dàluogo alla posizione categoriale della natura.
Qui l’antinomia dell’essere e del non essere lascia il posto allanuova antinomia, irrisolta nel panlogismo hegeliano come pure inogni prospettiva coscienzialista, cui fa da salutare contraltare la filo-sofia della natura di Schelling, riattualizzata alla luce degli sviluppisuccessivi della scienza: essa consiste nel fatto che la natura, da unlato, può essere categorizzata solo come scienza – per questo “l’ideadi una filosofia della natura non ha oggi più ragione di essere se nonsi risolve in una filosofia della scienza” (PFE, 125) – ma, dall’altrolato, la natura resiste alla sua risoluzione scientifica, nella quale ilpensiero nega se stesso nel porsi come scienza. In particolare, la dif-ficoltà è data dalla finalità presente nella natura, da cui invece lascienza prescinde. Incontriamo così, per la prima volta, il grandetema che Paci più di vent’anni dopo accoglierà dalla Krisis diHusserl: l’impossibilità di quantificare i plena qualitativi, secondo icanoni della scienza galileiana, e la necessità di accogliere nellascienza anche il qualitativo, riconfigurando lo statuto epistemologi-co delle stesse scienze esatte. Proprio in queste pagine Paci mette indiscussione l’espulsione della finalità dalla categorizzazione dellanatura in chiave scientifica, avvertendo comunque che “il finalismoscientifico non dovrebbe avere nulla di antropomorfico” (PFE, 139).
Non seguiamo gli altri snodi dell’attraversamento delle tema-tiche di filosofia della scienza, che Paci assume entro il suo sche-ma ideale: questo presenta l’antinomicità dell’opporsi, unificarsi e
67
Da Platone a Jaspers: l’accordo tra idealismo e ontologismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 67 (Nero/Process Black pellicola)
rilanciarsi da un lato del pensiero come razionalità scientifica, incui la filosofia della natura “si fonde con la filosofia della scienzasenza lasciare residui”, e dall’altro degli ‘irrazionali’, che impedi-scono il completo risolversi della natura nella sua categorizzazio-ne scientifica.
In questo percorso il pensiero, autonegandosi e dando luogoall’ambito delle essenze e a quello della natura nella sua determi-nazione categoriale, ha esperimentato l’irriducibilità, nella natura,di un opaco residuo di alogicità. La meditazione paciana si insediaallora in esso, nel tentativo di dare espressione a questa dimensio-ne alogica o ‘irrazionale’, che in seguito chiamerà ‘precategoriale’,e che nella tripartizione di pensiero, esistenza e valore, si specificacome il momento dell’esistenza. Siamo così giunti alla secondaparte del libro (L’esistenza dell’essere), in cui l’autore accoglie la filo-sofia esistenzialista di Heidegger e di Jaspers, sullo sfondo diKierkegaard, entro l’impianto concettuale così allestito.
Il punto di partenza di questo nuovo svolgimento rimane l’as-serto fondamentale dell’identità di essere e pensiero. Ora, se l’esse-re è razionalità, “tutto quello che non è razionale non è” (PFE, 158); l’e-sistenza sarà quindi il nulla: a ciò si approda mediante quell’auto-negazione del pensiero che sfocia nel suo altro, nell’elemento irri-ducibile all’essere del pensiero, che è appunto l’esistenza comenulla. Il nulla è l’apertura di uno spazio di interrogazione dell’esse-re, diversa da quella propria della scienza. Mentre infatti quest’ul-tima si configura come un procedere che problematizza in funzio-ne delle risposte che vuole ottenere, la domanda che sorge dall’in-terno dell’esistenza, e si interroga su se stessa, chiedendosi cos’è ilnulla, ovvero si interroga sull’essere del non razionale, dell’irridu-cibile alla razionalità, è destinata a rimanere senza una risposta chesia essa stessa razionale. Ma poiché l’esistenza non è altro che l’es-sere stesso che si porta nel suo altro da sé, dalla sua intima razio-nalità, questo interrogare senza risposta deve essere esso stesso ildisvelamento del senso dell’essere:
[…] l’essere non vuole una risposta: rispondere è spiegare, razio-nalizzare, e quindi tornare alla scienza. L’essere si svela nel suochiedere se stesso. Il pensiero, perciò, che con l’essere coincide,scopre un altro senso di sé. Questo senso è quello che si esprimenel domandare senza risposta, nel farsi avanti del problema fon-damentale: se l’essere razionale non è tutto l’essere, che cos’è l’es-sere non razionale? (PFE, 160).
68
Sandro Mancini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 68 (Nero/Process Black pellicola)
Seguendo Heidegger, Paci intende questa nuova dimensione disenso come onticità, entro cui si attiva l’interrogazione che prendeil profilo della comprensione, la quale a sua volta si pone come“l’ontologia inerente all’esistenza” (PFE, 161). Paci segue Heideggerpure nel riconoscere la circolarità tra il momento ontico e quelloontologico, ma nella sua semantizzazione di tale circolo se nedistacca, ponendosi nella scia di Kierkegaard e di Jaspers: la lezio-ne che egli trae dal filosofo danese è che il comprendersi è lo sve-larsi dell’essere nello “spezzarsi nell’intimo di sé”, mentre intendeanalogamente allo scacco di Jaspers la rinuncia del pensiero a risol-vere in razionalità l’interrogazione del senso. Riportata al logo,quell’esperienza intima dello spezzarsi è ‘l’assurdo’, che si dipanacome peccato e colpa: è l’oscurità insensata di
un essere che si getta in un limite e si costringe al finito. La nasci-ta dell’essere nel mondo è legata ad una fondamentale colpa, alpeccato originale che fa parte dell’esistente come tale in quanto l’e-sistente nasce solo da una negazione del razionale e del perfetto(PFE, 163-4).
Eppure questa caduta nel mondo da parte dell’essere, ancorchéoscura, è necessaria, affinché l’identità dell’essere e del pensieronon si chiuda nella “infinita dialetticità” propria della razionalità,cioè affinché non si risolva nel gioco di specchi delle antinomie incui si esplica la correlazione; se così fosse, il pensiero “si fermereb-be nel suo cammino dogmatizzandosi nel razionale e perdendoquindi la propria interiore razionalità” (PFE, 164). La caduta nelmondo consente invece di attivare una nuova interrogazione disenso, che può condurre a un allargamento della ragione, non piùseparata dalla sfera dell’irrazionale. Ma per tale impresa occorrevolgersi al confronto con i volti oscuri del negativo: il male, il pec-cato, la colpa. È quanto fa ora Paci, procedendo alla deduzione del-l’uomo, cioè muovendo dal dato ontologico per illuminare poi quel-lo antropologico, anziché fare il contrario, come Heidegger, che perquesto Paci qui critica, assimilandolo in ciò a Kierkegaard, inveroarbitrariamente. Comunque, al di là della fragilità di questo rilievo,quel che conta è che in questo tornante del discorso l’ispirazioneplatonica si fa agostiniana, nell’affermazione della pregnanza onto-logica del peccato originale, che non è affatto assunto a rivestimen-to mitico del negativo, e tanto meno antropologizzato. Paci lo affer-ma a chiare lettere: “non è con l’uomo che si spiega il peccato, ma
69
Da Platone a Jaspers: l’accordo tra idealismo e ontologismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 69 (Nero/Process Black pellicola)
con il peccato, con la caduta, che si spiega l’uomo” (PFE, 165).Ricondotto alla prospettiva delineata in questo libro, la vicendadell’uomo è compresa come conseguente alla vicenda dell’essere, sistaglia sullo sfondo enigmatico dell’esistere nel mondo, originatodall’autonegarsi del pensiero: “il concetto di peccato è quindi ante-riore all’uomo stesso, esso è determinato dall’essere razionale chesalta nella negazione di sé” (ibid.).
Il lettore che abbia una qualche familiarità con la fenomenolo-gia del negativo delineata da Paci anni dopo, nell’intersezione difenomenologia e dialettica, ma che ignori questo testo, rimarràsorpreso di fronte a questo incipit platonico e agostiniano: essoattesta che Paci trova il suo ambito elettivo di meditazione, ilnegativo, non muovendo in prima battuta dal rilievo del vissuto,ma da questa complessa elaborazione ontologica che, come unfiume carsico, accennerà a riaffiorare proprio alla fine del suo iti-nerario filosofico.
Riprendiamo ora il filo di questa riflessione, che dal rilievo del-l’ontologicità del peccato giunge alla fondazione della libertà del-l’uomo, nel solco di Kierkegaard. Infatti, nell’identità di pensieroed essere non ci può essere spazio per il peccato, ma neppure perla misura umana della libertà, la quale “non è concepibile nellaperfezione: non si sceglie nel perfetto” (PFE, 166). Ma se la libertàimplica che l’uomo si trovi già immerso nel male, a sua volta lascelta del riscatto da tale condizione rivela che il peccato è in fun-zione della redenzione; quest’ultima è resa possibile dalla libertà.Tale libertà è per l’uomo anche una necessità, perché a essa èinscindibilmente legata “l’essenza della personalità dell’uomo”(PFE, 167): nell’arco che va dal peccato, quale conseguenza dellacaduta dell’essere nel mondo, alla libertà, e da questa alla possibi-le redenzione, si distende la vicenda umana, e qui pertanto ne vadell’essenza dell’uomo, l’essere personale. A Paci preme di rimar-care l’inscrizione di tale problematica nel registro ontologico, ilche evita che questa risulti curvata in chiave antropocentrica, eanzi pone l’ontologia stessa come la risposta filosofica al peccato:
[…] come il peccato è il ponte di passaggio tra l’esistere degrada-to e l’umanità, così l’ontologia è il ponte tra lo svelarsi della natu-ra e la coscienza dell’uomo che si sa come domanda totale sul-l’essere. L’uomo rappresenta il punto d’arrivo dell’ontologia, nonil punto di partenza. Non possiamo partire, in altre parole, dal-l’uomo per fissare l’esistere del mondo, ma dalla dialettica del
70
Sandro Mancini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 70 (Nero/Process Black pellicola)
pensiero che si fissa come esistenza dobbiamo dedurre, comemomento massimo dell’esistenza che si svela a se stessa, l’uma-nità. L’uomo è così dedotto a priori come un momento della dia-lettica dell’essere (PFE, 167).
La chiusa del passo non deve sviare: questa ‘deduzione a prio-ri’ dell’uomo intende inscrivere l’interrogazione del senso dellavicenda umana nella prospettiva ontologica, ma nient’affattoesaurirla in ciò. Si è appena visto, infatti, che col portarsi dalladialettica eterna dell’essere alla sfera precategoriale dell’esisten-za, si attiva un interrogare senza risposta che, lungi dal lasciarsialle spalle il mistero, conduce a inoltrarsi sempre più in esso, ascorgervi la latenza e la fonte inesauribile del vero. Su ciò si veri-fica il punto di massima convergenza con la concezione heidegge-riana della verità; nel seguito dell’itinerario paciano, dopo la svol-ta relazionista, questa vicinanza lascerà posto a una frontale con-trapposizione alla semantizzazione heideggeriana dell’essere, chesarà tacciata di oscurantismo reazionario. Lo scotto di questoripudio sarà una limitazione e fragilità della seconda fenomeno-logia paciana: separatasi dall’ontologia, essa cercherà di darsi unanuova fondazione nella logica modale, nel solco della legge tra-scendentale di Banfi, senza tuttavia riuscire a ricomprendere nelnuovo registro modalistico le implicazioni metafisiche giovanili,che stiamo ripercorrendo.
Torniamo dunque all’analisi del nostro testo. La deduzione apriori dell’uomo concerne anche la natura: se l’uomo è la naturache si rivela a se stessa nella libertà, quale suo culmine, è perché giàin essa accade lo spezzarsi dell’assolutezza dell’essere, è dunqueperché anch’essa è affetta dal mistero di una colpa; e come nell’uo-mo la colpa prelude alla volontà di riscatto, così pure nella natural’essere, che si è spezzato facendosi mondo, “anela a se stesso senzariconquistarsi mai. La colpa della natura è il suo risvegliarsi” nellaprimitività del desiderio, nella “ansia primordiale dell’esistenza”(PFE, 171). Uomo e natura si ricongiungono proprio nel mistero delpeccato originale, giacché entrambi sorgono dalla “caduta dellarazionalità” che determina “la nascita del mondo” (PFE, 172). Ilpasso successivo è compiuto sulle orme di Kierkegaard e diJaspers: giunto alle soglie del “segreto indecifrabile” che avvolge,nella natura come nell’uomo, l’autonegarsi dell’essere razionale e lacaduta nel mondo, e lascia sospesa l’alternativa tra senso e nonsenso, Paci opta per il senso, sceglie per la redenzione:
71
Da Platone a Jaspers: l’accordo tra idealismo e ontologismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 71 (Nero/Process Black pellicola)
È nell’essenza dell’esistere di essere un segreto ed i veri segretinon si scoprono mai: sorride, dietro di essi, il volto sconosciutodella trascendenza (PFE, 172).
Per rilanciare l’interrogazione del senso, a partire dal mistero incui la natura cerca di ritrovarsi nell’uomo, nel capitolo successivo(il secondo della seconda parte: L’esistenza dell’uomo) la meditazio-ne si volge a focalizzare il nucleo essenziale della condizioneumana, che già si è palesato come tale, pur nella sua enigmaticità:la personalità. Con questo allargamento dell’ambito di indagine, siinfittiscono anche le fonti storiografiche del discorso: oltre aKierkegaard e a Nietzsche, nel novero dei contemporanei già accol-ti nella trattazione (in particolare Carabellese, Jaspers e Heidegger)si aggiunge ora Scheler, di cui è recepita la considerazione del sen-timento come esistenzialità, a sua volta in funzione del “passaggiodall’esistenziale psicologico al valore” (PFE, 179). Senza entrare nelmerito storiografico di questi confronti, ci limitiamo a indicare l’e-sito speculativo degli imprestiti presenti in questo capitolo riguar-do al concetto di persona.
La personalità si origina nell’attivarsi di “una relazione antino-mica tra il tutto, uguale a se stesso, e l’io che non riesce mai aritrovarsi” (PFE, 196). Si tratta del rapporto tra il macrocosmo,ossia il tutto della natura generato dallo spezzarsi dell’essererazionale come sua caduta nel mondo, che desidera ritrovare sestesso nella consapevolezza del microcosmo, e quest’ultimo,ovvero l’io singolare che tende all’universalità dell’essere razio-nale, e si sforza di raggiungere tale meta raccordandosi al macro-cosmo, ponendosi come sua espressione10; un rapporto che dun-que si dispiega nell’elemento dell’esistenza, ed in cui consiste loscopo stesso di questa: “tutto il processo esistenziale rimanda allapersonalità” (PFE, 199).
Il terzo capitolo, che conclude la seconda parte del libro, mostracome nel medio della personalità si attivi prassicamente la relazio-ne antinomica tra particolare e universale, attraverso un’assunzio-ne di responsabilità che apre, insieme agli altri io personali, lo spa-zio dinamico della libertà, della scelta pro o contro il peccato, proo contro la trascendenza. Qui l’assunto da cui parte la riflessione èla constatazione dell’inevitabilità del peccato, perché questo, comesi è visto, precede la stessa condizione umana, la quale si trova giàsempre immersa in esso. In questa tesi rinveniamo l’eco del temakierkegaardiano dell’esistenza come malattia mortale, sulla cui72
Sandro Mancini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 72 (Nero/Process Black pellicola)
scia si situa la trattazione paciana. Per il solo fatto di volersi attua-re, l’uomo pecca; né, d’altronde, è possibile ritrarsi dall’azione. Mal’io può prendere consapevolezza dell’assurdità dell’esistenza,della sua intrinseca mancanza di senso, e fare la sua scelta, assu-mendosi le conseguenti responsabilità. La libertà non sta dunquenell’alternativa illusoria del peccare o meno; essa sta nella sceltadell’assumere la propria responsabilità a fronte del peccato11, discegliere e di agire per la redenzione dal peccato, dunque di tra-sformare la situazione iniziale di non libertà, costituita dal pecca-to originale, nella costruzione della libertà, che è appunto il com-pito che fa dell’io una persona tra altre persone, unite nella comu-ne assunzione di responsabilità.
Ora, la scelta e l’azione pongono come ineludibile la questionedella temporalità, anch’essa affrontata nel solco di Kierkegaard,ma tenendo presente anche il principio antinomico insito nellalegge trascendentale. “Il dramma della scelta e del peccato” sidispiega infatti, parallelamente, sia sul piano della simultaneità,sia su quello della successione: è un dramma eterno, perché è ildramma dell’eterno, della caduta originaria, che rivive nell’uomo“con tutta la sua violenza” (PFE, 213); eppure è anche un dram-ma situato nella finitezza della persona, giacché è nella contin-genza dell’evento che si apre la possibilità di scegliere e agire. Inconsonanza con l’impianto generale della trattazione, Paci conce-pisce il tempo come “lo spezzarsi dell’eterno nell’esistenza” (PFE,215), e segue Kierkegaard nel ravvisare nell’istante la cerniera tral’eterno e il divenire: è l’istante che, sospendendo la continuità delflusso temporale, fa irrompere l’eternità del dramma nella finitez-za, e rivela la nascosta dimensione qualitativa di quel flusso: ilpassato si palesa infatti come il peccato già sempre avvenuto; ilpresente si propone come “la misura della mia libertà”, e il futu-ro come lo spazio della possibile redenzione, intramato di speran-za, azione, volontà e “fede nella personalità umana e nell’eternitàdell’anima umana che si proietta nell’avvenire” (PFE, 214).
Tuttavia la scelta non estingue il dramma, perché nel tempopermane il segreto che abbiamo già trovato custodito nella natu-ra e nella condizione umana: la scelta e l’azione interpersonaleper la redenzione non possono togliere la definitività di ciò che èstato. Nell’anteriorità del peccato, e nella colpa che ciò suscitanell’uomo, si radica quindi il mistero dell’esistenza. La rispostapuò venire allora soltanto da ciò che è oltre l’esistenza, da un’as-soluta trascendenza che nella sfera irrazionale dell’esistenza
73
Da Platone a Jaspers: l’accordo tra idealismo e ontologismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 73 (Nero/Process Black pellicola)
“non esisterà mai”, per cui dunque da questa in via di principionon potrà mai essere attinta. La risposta, che nell’esistenza lasciaessere il mistero della caduta e del peccato, viene solo dall’alto,da un senso assoluto oltremondano, ineffabile e inesprimibile,eppure operante nella finitezza come ciò che sospinge la personaa non acquietarsi mai nel traguardo raggiunto. La trascendenzaentra così in scena, nella meditazione paciana, con gli stessicaratteri con cui ce la presenta Jaspers: l’irrimediabile assenza diun Totalmente Altro, che pure nella sua distanza suscita inquie-tudine e spinge all’incessante trascendimento di ogni finitezza.Paci scorge la presenza di tale assenza operosa nella natura,come “la domanda senza pace che la natura rivolge a se stessa”e che nell’uomo non trova risposta, ma si rilancia nell’avvertirel’inappagabilità di ogni traguardo finitito. Ma la trascendenzanon opera solo in negativo: è essa che ci fa intendere l’indistrut-tibilità di ciò che abbiamo vissuto, come eternità dell’istante, checi annuncia che ciò che abbiamo vissuto, pur nella sua caducità,è per sempre; è ancora da essa che giunge a noi la notizia dellosplendere delle idee sotto un altro sole, sotto un’altra luce; ma,soprattutto, è essa che fonda la speranza della redenzione, dellabuona riuscita del cammino individuale e collettivo, cui è inscin-dibilmente congiunto “il senso della nostra personalità”, come diquella degli altri:
La trascendenza è ciò che non esisterà mai, ma che pure io esperi-mento, esistendo, come condizione dell’esistenza. Essa è presente nel-l’uomo perché l’uomo è caduto, perché l’uomo si moltiplicanegli uomini. È presente nella natura perché quando l’uomo sache la domanda senza pace che la natura rivolge a se stessa in luinon troverà risposta, dietro ogni forma della natura sentirà ilsegreto del trascendente. È presente in ogni opera umana perchéogni opera umana è limitata. Ma principalmente è presentequando l’uomo comprende che la sua vita è legata a quella deglialtri uomini per la comune origine dalla caduta nel mondo, perla comune coscienza del peccato, per la comune speranza delfuturo e della redenzione. È presente come l’eterno che coincidecon l’istante nel momento supremo dell’esistenzialità, della scel-ta. È presente, infine, come idealità. Noi sentiamo la sua presen-za nella nostra vita, nel nostro peccato, nella nostra redenzione:eppure l’idea non può esistere nel mondo perché è trascenden-za. Ma è necessaria (PFE, 219).
74
Sandro Mancini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 74 (Nero/Process Black pellicola)
Nella volontà di redenzione dal male, che si attua come perso-nalità, culmina dunque il processo ascensivo suscitato dallospezzarsi dell’essere, e dalla conseguente caduta dell’assolutezzadel senso nel mondo. Nella persona avviene così il salto decisivodi questo processo: la metamorfosi dell’esistenza stessa in vitaspirituale. Ora, il tramite che consente questo superamento dia-lettico è il valore, enucleato sulla scorta di Rickert12. Sulla ‘spiri-tualità dell’essere’ e sul valore si incentra appunto la terza e con-clusiva parte del libro.
L’ingresso in scena del valore, a fianco del pensiero, assoluto eintemporale, e a fianco dell’esistenza, opaca, assurda e irriducibilealla purezza cristallina e solitaria del pensiero, delinea il terzo polo,cui è affidato il cruciale compito di tentare di mediare tra i primidue, di provare a togliere la drammaticità della loro antitesi. Ilvalore opera come medio tra l’assoluto e il relativo, tra l’eterno, incui si dà coincidenza di pensiero ed essere, e il divenire spazio-tem-porale, in cui quell’identità si frange, lasciando luogo alla cadutadel logo nella fatticità dell’irrazionale, nella nullità dell’esistenza dicontro alla pienezza d’essere propria del pensiero.
Sappiamo che la dimensione mondana dell’esistenza è conno-tata dall’impossibilità, per l’essere razionale, di ricongiungersicon se stesso nell’elemento di quella. Tuttavia, allorché l’esisten-za dalla natura si porta alla condizione umana, e in questa ruotala sua passività nella volontà della persona di scegliere per laredenzione dal peccato, dunque per il senso della verità secon-do la misura della libertà, affiora, sull’orlo di quella radicaleimpossibilità ontologica, un sottile margine di pregnante possi-bilità, che emerge appunto come il tendere intersoggettivo versoi valori. Ora, il valore rimarrà un cardine dell’intero itinerariomeditativo paciano; ma mentre con la successiva svolta relazio-nista, in cui si consumerà il divorzio tra essere e pensiero, alvalore rimarrà riconosciuta unicamente una funzione regolati-va, nell’accezione kantiana del termine, e in consonanza con latematizzazione banfiana della legge trascendentale, in questoesordio speculativo del giovane Paci al valore è riconosciuta nonsolo una funzione pratico-regolativa, ma è attribuito anche unpreciso statuto ontologico. Così, l’intuizione dualista da cui sca-turisce la prima filosofia di Paci conduce a vedere nei valori chevivono nel mondo il riverbero della sfera inviolabile e separatadelle essenze; e l’antinomia tra esistenza e valore, pur ricono-sciuta e anzi dispiegata in tutta la sua estensione, è posta come
75
Da Platone a Jaspers: l’accordo tra idealismo e ontologismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 75 (Nero/Process Black pellicola)
l’altro lato di una perdurante identità tra il primo e il terzo polo,cioè tra l’identità assoluta di essere e pensiero da un lato e lasfera dei valori dall’altro. Infatti in quest’opera ciò che fonda ilvalore, che rende possibile la sua funzione peculiare di suscita-re nell’uomo la comprensione della finitezza e caducità propriedell’esistenza, è l’essere:
Il valore è solo possibile per lo sviluppo della dialettica dell’essere che,sentendosi ridotto ad un senso particolare, l’esistente, tenta di liberarsidall’esistenza ponendo l’esistente stesso come qualcosa di differente daciò che realmente è (PFE, 227)13.
Potremmo sintetizzare questa prima fondazione del valore,nell’asserto che è perché il valore è, che vale, e si esprime in noicome guida dell’azione; di contro, dopo la sua Kehre, Paci porràla verità del valore nel suo fungere da schema trascendentale diuna verità che non è mai essere, che anzi è opposta a un esserediventato sinonimo del deposito inerte accumulato nella dialetti-ca dell’espressione, insomma della rigidità e pesantezza dell’ac-quisito. Ora invece, in questo esordio platonico, il piano dei valo-ri è inteso come il frutto più prezioso dello “slancio dell’essereche cerca nel particolare e nel determinato l’eternità, e che al par-ticolare ed al determinato vuol dare una perfezione ideale e far-gli esprimere un significato assoluto”: in tale slancio “si rivela ilprimo palpito della vita spirituale, il primo apparire della tensio-ne ardente da cui nasce lo spirito” (PFE, 228). È appunto il trasfi-gurarsi di tale slancio nella scelta e nella conquista della perso-nalità, che conduce alla creazione dei valori, i quali sono dunquel’esito di quella originaria potenza d’affermazione insita nell’es-sere stesso. I valori non sono dunque solo schemi della prassi,ma in tanto adempiono la loro peculiare funzione di orientamen-to finalistico dell’agire, in quanto sono la rivelazione, pur nellafinitezza del loro storico configurarsi, dell’infinità e assolutezzadell’idea, la quale, a sua volta, “nell’espressione cerca la vita. El’espressione è il disporsi dell’esistente come un mezzo che serva a rea-lizzare il fine voluto dai valori” (PFE, 229). Ora, il senso di questadialettica dell’espressione, in cui la potenza affermativa insitanell’essere, attuandosi come valore, dà luogo alla negazione del-l’esistente, è la trascendenza: il valore deve esprimersi, per vale-re, ma può farlo solo trascendendo l’esistente. Il valore diventacosì “cifra della trascendenza” (PFE, 231), nell’accezione jaspersia-76
Sandro Mancini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 76 (Nero/Process Black pellicola)
na qui esplicitamente menzionata, realizzando la sua vocazioneuniversalistica come comunicazione (anch’essa intesa nel solco diJaspers), nell’incontro della mia personalità con quella degli altri.
Il discorso approda così all’antinomia, in cui l’universalità deivalori, e il nucleo di eternità che la anima, entra in tensione con lastoricità della loro attuazione entro la sfera dell’esistente. La rela-zione antinomica si riconfigura pertanto come l’antinomicità pro-pria della storia, che è quella di porsi insieme come identità, comeil “valore eterno della storia” (PFE, 233), e come differenza, come lapluralità dei modi in cui i valori si esprimono, nel medio dellacomunicazione, intesa quale spazio di dialogo ma anche di conflit-to. Ma se i valori “mutano nella storia”, non varia il principio pro-pulsivo della loro attuazione, che è la morale, intesa come “vita spi-rituale” (PFE, 244), atto sempre rinnovantesi, e sempre uguale,della creazione del valore. La moralità della vita spirituale, perso-nale e interpersonale, è sia fonte che fine del valore, giacché scopodel valore, sua precipua funzione, è di suscitare la creatività, porsicome strumento di espressione del senso, in consonanza con laprospettiva sia di Banfi sia di Gentile14.
All’interno della dialettica tra esistenza e valore, la prima sidispone nel segno dell’immanenza e il secondo in quello della tra-scendenza: creare il valore significa scegliere per la trascendenza,riporre in essa la ricerca del senso. Infatti, se è ben vero che non sidà né pura esistenza né puro valore, ma solo la loro drammaticatensione, che li sospinge a portarsi reciprocamente uno nell’altro, èaltrettanto vero che il senso di questa dialettica è nell’incessantetrascendimento di ogni equilibrio raggiunto, di ogni traguardo delcammino entro cui si articolano le forme della vita spirituale. Allatematizzazione di queste, raccolte nei registri della morale, dell’ar-te e della religione, sono dedicati gli ultimi capitoli del libro. Noiperò non li ripercorreremo analiticamente, perché Paci avrà mododi riprendere questi temi in sviluppi più maturi, e con un maggio-re retroterra culturale alle spalle. Ci basta indicare solo l’idea difilosofia che è delineata all’inizio della loro trattazione, nel secon-do capitolo della terza parte.
In consonanza con l’ispirazione platonica che permea la primaelaborazione paciana, “l’ideale della filosofia” è ravvisato nella“purificazione assoluta del pensiero e nello svolgersi quindidella dialettica dell’essere” (PFE, 250): un ideale che prendeforma nel percorso per “cerchi concentrici” (PFE, 259) tipicodella storia della filosofia, poiché la purificazione completa è
77
Da Platone a Jaspers: l’accordo tra idealismo e ontologismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 77 (Nero/Process Black pellicola)
impossibile da ottenere, e la permanenza di un residuo dogmati-co rilancia la filosofia verso sempre rinnovati circoli riflessivi.Ora, se l’impossibilità di chiudere qualsiasi cerchio esplicativodisegnato dalla ragione fa sperimentare alla filosofia il proprio‘scacco’, nell’accezione jaspersiana del termine qui menzionata(PFE, 253), non per questo consegna il sapere filosofico alla merarelatività delle pluralità delle opinioni che vi si affastellano. Alladeriva scettica la filosofia è sottratta, perché essa è creazione divalore; perché, in ultima istanza, è nelle peculiari antinomie “diessere e non essere, di pensiero e non pensiero, di sapere e nonsapere”, che costituiscono la specificità della filosofia, che “l’es-sere raggiunge la sua più alta tensione”, di modo che la filosofiaè tanto “non sapere assoluto”, condannata allo scacco, quanto“sapere assoluto” (PFE, 254).
La medesima tensione innerva la filosofia, se la si guarda dallato dell’esistente; qui essa si presenta come l’antinomia tra il“punto di partenza esistenziale” e il “punto di arrivo trascenden-te” (PFE, 263). Il punto di partenza è lo scontro che viene a deter-minarsi tra l’essere, che ponendosi come filosofia “scende in bat-taglia contro l’esistenza”, (PFE, 264) e la sua necessità di “negarese medesimo” e realizzarsi come una determinata filosofia, “comeun momento del pensiero e un momento dell’essere. Questa nega-zione conduce alla scelta, e la scelta a sua volta alla creazione deivalori ed al porsi dell’essere come essere spirituale” (ibid.); sigenera così il vettore intenzionale che sospinge la ricerca dellaverità, squadernantesi entro il sapere filosofico, verso la trascen-denza, in una “lotta implacabile tra la scelta che obbliga il pensie-ro ad una sola direzione ed il valore che tende all’universalità”(PFE, 262). Come la persona è costretta alla drammaticità laceran-te della scelta, per esercitare la sua costitutiva libertà, altrettantoavviene per la filosofia, che deve scegliere la propria direzione disviluppo, senza potere mai ricapitolare in alcun orientamento l’u-niversalità inscritta nel valore.
Gli ultimi capitoli del libro sono dedicati a illustrare le sceltedell’autore in campo morale, artistico, religioso. Noi però non lianalizzeremo, sia perché verranno formulate meglio nei suoisuccessivi scritti, sia perché in questa sede ci interessava focaliz-zare soltanto il perno su cui ruota la prima filosofia di Paci, lacoappartenenza di pensiero ed essere come coincidenza nell'eter-no, come relazione antinomica nel divenire, come svolgimentoteleologico nel valore.78
Sandro Mancini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 78 (Nero/Process Black pellicola)
Note al testo
* Il testo qui proposto è tratto dal primo paragrafo di Sentire la verità. Enzo Pacitrent’anni dopo, che a sua volta costituisce la terza parte del libro L’orizzonte delsenso. Verità e mondo in Bloch, Merleau-Ponty, Paci, Mimesis, Milano 2005.1. Così Banfi si esprime in Princípi di una teoria della ragione, la cui prima edi-zione risale al ’26: “Questo è stato precisamente l’indirizzo delle nostre ricer-che: esse sono essenzialmente fondate sulla distinzione degli aspetti fenome-nologici del conoscere […] dalla legge trascendentale che li domina – la sin-tesi correlativa soggetto-oggetto – come espressione della pura esigenza teo-retica” (A. Banfi, op. cit., Editori Riuniti, Roma 1967, p. 235). La funzione domi-natrice della legge trascendentale è ribadita anche in altri passi (cfr., ad es., ivi,p. 159). Per l’inquadramento storico-critico della posizione di Banfi, e ancheper la tematizzazione del suo rapporto con Paci, è importante la monografiadi G.D. Neri, Crisi e costruzione della storia. Sviluppi del pensiero di Antonio Banfi,Bibliopolis, Napoli 1988 (I ediz. Verona 1984). Ricordo con nostalgia le appas-sionate discussioni con Guido su questo nodo, e anche su Bloch.2. A. Banfi, op. cit., p. 19.3. Riassumendo quanto esposto al riguardo, Banfi sottolineava questodecisivo aspetto: “La pura sintesi correlativa soggetto-oggetto rappresen-tava la forma secondo cui l’universale problematicità teoretica si pone nelconoscere, come espressione della esigenza essenziale” (Ivi, p. 76).4. E. Paci, Principii di una Filosofia dell’Essere, Guanda, Modena 1939 (d’orain poi abbreviato PFE). L’unico altro scritto sistematico del Nostro èFondamenti di una sintesi filosofica, ma esso non ha una veste monografica,essendo pubblicato nella prima annata di “aut aut”, suddiviso in tre pun-tate. Vi è comunque una simmetria tra le due trattazioni sistematiche:entrambe fissano le coordinate teoretiche delle due grandi fasi dell’itine-rario paciano, quella esistenzialista prima e quella relazionista poi.5. Il testo gentiliano di riferimento per questa problematica è La logica delconcreto, terza parte del Sistema di Logica come teoria del conoscere (Laterza,Bari 1923, t. II, pp. 3-149). Per un confronto con la sua ripresa paciana, èimportante anche il terzo capitolo (Essere e pensare) della quarta parte (Lafilosofia), pp. 188-202. In tutt’altro registro, e in una mutata situazione filo-sofica, Salvatore Natoli ha proposto una lettura di Gentile che mira a sal-vare l’atto disarticolandolo dal Cogito. La fondamentale divaricazionedalla prospettiva paciana è data dal fatto che Natoli non propone unadiversa fondazione trascendentale, ma una revoca stessa del principio tra-scendentale. Cfr. S. Natoli, Giovanni Gentile filosofo europeo, BollatiBoringhieri, Torino 1989. Ho discusso l’interpretazione natoliana diGentile in L’eredità di Gentile, “Critica marxista”, 1990, pp. 151-60.6. Già in Principii di una Filosofia dell’Essere l’autore si misura con l’epoché.
79
Da Platone a Jaspers: l’accordo tra idealismo e ontologismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 79 (Nero/Process Black pellicola)
Cfr. ivi, pp. 83 sgg.7. In un passo più chiaro di altri, così si presenta il circolo ascensivo-discensivo: “Il processo fenomenologico è dunque un processo di ascesain quanto, risolvendo il dogmatismo del pensiero, fa salire quest’ultimoalla sua massima altezza; il processo della dialettica dell’essere è inveceun processo discendente che parte dalla libertà del pensiero e che […]svolge, dall’altezza massima, di questa posizione, tutti i sensi dell’essereche già la fenomenologia aveva considerati negativi nella sua ansia di rag-giungere la pura legge” (Ivi, p. 65).8. Principii di una Filosofia dell’Essere è strutturato in tre parti: la prima (Larazionalità dell’essere) costituisce il momento fondativo, in cui è affrontatal’identità di essere e pensiero; la seconda (L’esistenza dell’essere) introduceil momento dell’esistenza, ovvero la ‘caduta’ dell’essere nel mondo, che dàluogo alla natura e all’uomo; infine la terza (La spiritualità dell’essere) enu-clea le vie lungo cui l’uomo risale verso l’Uno.9. “In altre parole la dialettica fenomenologica si illumina di luce intuiti-va man mano che procede il suo movimento; essa, mentre nega i varigradi del conoscere come imperfetti, purifica nello stesso tempo quell’alo-ne di luce che finisce per intuire solo ciò che è il vero contenuto del reale,nella coscienza che le varie forme fenomenologiche non sono valide senon nella loro limitazione e che nessuna di esse è realtà, mentre l’intuizio-ne che mai le abbandona, nutrendosi del loro continuo morire, si ponecome intuizione pura del mondo” (PFE, 102-3).10. “L’antinomia unità e molteplicità si presenta dunque per la caratterio-logia in questo modo: il microcosmo tende al microcosmo, il macrocosmo tendeal microcosmo; il limite di questa doppia tensione è l’uomo come persona-lità” (PFE, 198).11. “Io non posso non peccare: ecco il principio che domina nella perso-nalità. principio solo apparentemente assurdo in quanto io pecco anche senon accetto liberamente il mio peccato. Ma se io lo accetto sono responsa-bile, divento io di fronte a me stesso” (PFE, 210).12. Alla filosofia dei valori di Rickert, che era morto tre anni prima dellapubblicazione di Principii di una Filosofia dell’Essere, è dedicato un brevecapitolo del successivo libro di Paci, Pensiero, esistenza e valore. Studi sulpensiero contemporaneo, cit., pp. 47-53.13. Qui, come in seguito, quando non esplicitamente dichiarato, il corsivoè nel testo originale dell’autore.14. “Ma io non sono morale in quanto realizzo un valore dogmaticamentedato, ma solo in quanto, nei limiti della mia scelta, creo un valore. In quantoil valore è creato è buono, in quanto è accettato dogmaticamente è cattivo,anche se la gerarchia formale dei valori lo impone come buono […] Il nonvalore, da questo punto di vista, è la non creazione del valore” (PFE, 245).
80
Sandro Mancini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 80 (Nero/Process Black pellicola)
STEFANO ZECCHI
PRESENZA DI ENZO PACI NELLA CRISIDELLA CULTURA CONTEMPORANEA*
T ra le esigenze più sentite di Enzo Paci c’era quella di evitare dicostruire o di inserirsi in qualsiasi tipo di struttura organizzata chein un modo o nell’altro lo imprigionasse in scelte definitive. Questonon gli impediva la passione polemica per difendere le proprie tesi,ma sempre però rivelando, soprattutto a chi gli stava vicino, unaprofonda ansia e insicurezza. L’ansia del dubbio era forse alla basedel suo modo di conoscere, di comunicare, anche di scrivere; eraattento al significato delle cose, diffidente delle definizioni e deigiudizi assertori. L’ assoluta mancanza di sistematicità delle sueopere e una grande apertura e disponibilità di fronte ai fatti delmondo segnano la storia dell’uomo e della sua filosofia.
Il 24 ottobre 1962 Paci tiene all’ Accademia Filosofica di Pragauna conferenza su “il significato dell’uomo in Marx e in Husserl”.L’ arco del suo pensiero con la lettura di Marx raggiunge un puntonodale che sarà oggetto di continui arricchimenti e chiarificazioni.Il senso di questo itinerario filosofico è più comprensibile ritor-nando al lavoro di Antonio Banfi, alla sua forza di penetrazionenella chiusura dogmatica della cultura italiana durante il fasci-smo, al suo impegno di militante comunista nella lotta contro ilsoffocamento della democrazia. Nella scuola di Banfi era rimastoaperto senza nessuna enfasi retorica il dibattito culturale di un’Europa in crisi, attraversata dallo scontro tra il nazifascismo, ledemocrazie occidentali, il socialismo sovietico. Paci si forma aquesta scuola, la sua tesi di laurea (poi pubblicata: Il significato del
81
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 81 (Nero/Process Black pellicola)
“Parmenide” nella filosofia di Platone, 1938) è sulla dialettica diPlatone interpretata secondo una prospettiva neokantiana (in sin-tonia con la filosofia di Banfi) che rimarrà un filo sotterraneo delsuo pensiero. In questo lavoro sono messi in luce significati affininella relazione, anzichè nella separazione, tra divenire ed essere,tra il mondo dell’esistenza e quello dell’essenza. Questa ricerca dipossibilità ideali della ragione operanti nell’esistenza come pro-blema per la comprensione della complessità del mondo dellaesperienza e della continuità storica della ragione, sottolinea laprima matrice neokantiana e banfiana di Paci, una traccia che siritroverà fondamentalmente accresciuta, nella sua interpretazionedella fenomenologia di Husserl.
Gli anni della guerra pongono Paci di fronte al problema del-l’impegno, del ruolo dell’intellettuale nella società che egli affron-terà all’interno del suo lavoro, iniziando ad allargare per sé e pergli altri l’orizzonte della cultura italiana. Procedeva per larghemediazioni, sintetizzando ciò che riteneva più valido nelle corren-ti del pensiero contemporaneo. La facilità dell’eccletismo che hacaratterizzato soprattutto il decennio precedente al “ritorno” aHusserl (1956-’57), si spega da un lato in quest’esigenza di dissoda-mento culturale, dall’altro nel suo grande e mai esaurito interesseper forme di vita e pensiero diverse: quello che leggeva o espone-va di altri diventava un mondo che riviveva nel suo dibattito, nellasua adesione, nella sua polemica. Spesso non si scorgeva più il con-fine tra Paci e il suo autore. Così l’ avventura di Paci nell’ esisten-zialismo riflette questa continua mediazione che egli operava nellacultura contemporanea. La filosofia di Heidegger e di Kierkegaardperde, nella sua lettura, i contorni, si sfuma delle tinte nichiliste conl’ introduzione del pensiero di Dewey e di Whitehead, con l’ inte-resse per Thomas Mann e Marcel Proust. Tempo e relazione eDall’esistenzialismo al relazionismo (1957) sono i libri che raccolgo-no l’ esperienza filosofica di Paci nel primo decennio del dopoguer-ra. Preferirà ricordare questo periodo come quello del “relazioni-smo”: un suo modo autonomo di interpretare i problemi dell’ esi-stenzialismo sul piano dell’ impegno culturale e della responsabili-tà soggettiva di fronte all’ evento storico. Ma continuare a risolverein una direzione “positiva” la filosofia di Heidegger gli sembreràdifficile: questi gli apparirà sempre più legato teoricamente al pro-cesso di crisi della ragione, alla distruzione della conoscenza sog-gettiva e collettiva operata dal nazifascismo. Paci parlava piùvolentieri con un interlocutore a cui aderiva, sia pure nelle sue tesi82
Stefano Zecchi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 82 (Nero/Process Black pellicola)
esistenziali. La tendenza all’irrazionalismo della filosofia heideg-geriana lo allontana dal filosofo tedesco: non è cuale che il saggiopiù bello e teoreticamente più importante, presente nei libri oraricordati, è su Kant. Nello schematismo trascendentale kantianoPaci rintraccia la risposta ai problemi tra filosofia e scienza, allarelazione tra il piano logico e quello empirico.
Insieme prende spessore il problema della soggettività: lo sche-matismo trascendentale è l’ angolatura in cui sintetizzare le moda-lità dell’intuizione sensibile e il piano delle raffigurazioni catego-riali, e quindi rideterminare il rapporto tra l’operare soggettivo e ilmondo esistente: “la filosofia e le scienze sono vere, il discorso logi-co è vero, se vedono possibilità che vanno oltre la realtà data”: latrascendentalità diventa superamento del dato già realizzato, del-l’oggettività conclusa, è apertura verso nuovi orizzonti di significa-to presenti come possibilità reali. La ricerca del fondamento esteti-co-sensibile all’analitica esistenziale riporterà Paci verso la fenome-nologia di Husserl e, in un certo senso, di nuovo verso Banfi.
Banfi aveva continuato a considerare con non celata diffidenzala filosofia esistenziale, sostenendo invece che “la fenomenologiaappare come la scienza della generale costituzione dell’oggettivitànella coscienza trascendentale o, in altre parole, nella struttura sin-tetico-trascendentale della realtà. Essa si riferisce ad ogni tipo dioggetti di ordine superiore, teoretici, valutativi e pratici, alleoggettività culturali, stato, diritto, chiesa, ecc. Si svelano così ipiani di costituzione del reale”. È interessante notare come Paciabbia messo l’accento su questo modo critico-culturale di com-prendere la ricerca fenomenologica: “ che Banfi abbia scritto que-ste cose nel 1926 ha qualcosa di miracoloso. Soltanto in Idee II°(pubblicato nel 1952) la fenomenologia appare così come la descri-ve Banfi nei Principi di una teoria della ragione”. Anche se decisa-mente attratto dagli scritti dell’ultimo Husserl, questa direzionecritica che propone una valutazione complessiva dell’opera hus-serliana come metodo di fondazione unitaria dei diversi campiculturali, non verrà mai abbandonata da Paci. A partire dal 1956-57 il suo lavoro cerca continuamente di connettere l’interpretazio-ne di Husserl con le prospettive ancora aperte della fenomenolo-gia, trasformando spesso, con rapide sequenze, la propria letturadi Husserl in una più ampia prospettiva filosofica. Le Meditazionicartesiane di Husserl rappresentano il primo passo, il primo studiosistematico dei problemi della fenomenologia (Tempo e verità nellafenomenologia di Husserl, 1961). E proprio su questo testo il ricordo
83
Presenza di Enzo Paci nella crisi della cultura contemporanea
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 83 (Nero/Process Black pellicola)
di Paci va a Banfi: “Quando, dopo aver letto senza sufficiente com-prensione le Meditazioni cartesiane, nel 1933, ho chiesto a Banfi diaiutarmi, non mi parlò del contenuto di quel libro. Questo fatto èsignificativo. I libri per la fenomenologia sono mezzi per la vivacomunicazione orale. Le parole scritte hanno il loro lato negativose non riproducono un discorso nuovo, se non vengono ridestatee rese presenti”. Banfi diceva qualcosa di molto semplice. Invitavaall’esame diretto delle cose, alla descrizione fenomenologica comeproblema che coinvolge il significato di chi la compie nel contestoin cui è inserito.
La descrizione, la soggettività, l’intersoggettività, la riduzionefenomenologica, il tempo sono temi che nelle analisi di Paci si rela-zionano, delineando un’interpretazione del pensiero husserlianonon insterilita nelle questioni dell’idealismo e dell’ontologismo, maprotesa nella dimensione del soggetto concreto, nel suo incontrocon l’ “altro” nella dinamica degli istinti e dei bisogni. Sono gli anniin cui si pubblicano le opere inedite di Husserl e in cui si matura lariflessione di Paci sul filosofo tedesco. La fenomenologia incomin-cia a rappresentare per lui un grande disegno di critica culturalecon il quale è possibile riprendere e sviluppare tematiche filosofi-che presenti nell’estetica, nella psicologia, nella psichiatria, nell’an-tropologia, nelle “altre” scienze insomma. La vitalità delle suelezioni è suggestiva. Mette in discussione se stesso attraverso ilsignificato delle sue parole, attraverso mediazioni culturali chelasciano spesso sorpresi. In queste “mediazioni” Paci scompaginail testo che ha davanti coinvolgendo chi lo ascolta in un gioco didomande piene di paradossi. E mentre parla si accorge di cancella-re “il lato negativo delle parole scritte” e che intanto il suo pensie-ro prende corpo. Allora amava continuare a discutere, le lezioninon finivano nell’aula. Lo aspettavamo, si continuava a parlarefuori, nei giardini dell’Università. Sentiva di avere un “discorso”da verificare, da sostenere, da proteggere. Il suo libro Funzione dellescienze e significato dell’uomo (1963), i saggi su “Aut Aut” (la sua rivi-sta) che ne continuano le questioni lasciate aperte sono lo specchiodel modo di pensare di Paci in quegli anni.
Funzione delle scienze doveva originariamente essere un com-mento alla Crisi delle scienze europee di Husserl: l’interpretazionehusserliana della crisi non è metafisica ma storica, nel senso cheHusserl ne ricerca le origini e le manifestazioni oggettive; essa èun’analisi dei processi attraverso i quali la soggettività viene ridot-ta a semplice cosa; è la richiesta di modificare i rapporti tra le84
Stefano Zecchi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 84 (Nero/Process Black pellicola)
forme di sviluppo tecnico-scientifico e l’esistenza umana. La Crisiera stata scritta da Husserl negli ultimi anni di vita (muore nel1938) e l’opera rimane incompiuta), ormai da tempo allontanatodall’insegnamento dalle leggi naziste. In queste pagine Paci ritro-va il senso e il fondamento teorico più convincente di quell’impe-gno culturale, di quella definizione del ruolo dell’intellettualenella lotta contro le tendenze involutive e reazionarie della socie-tà che aveva vissuto negli anni giovanili attraverso la figura diAntonio Banfi, che aveva sofferto durante la guerra e il campo diconcentramento e che aveva cercato nell’impazienza filosofica delprimo decennio del dopoguerra.
Scrivendo nel ‘57 sulla Crisi di Husserl, Banfi osservava:“L’infaticato lavoro speculativo di tutta una vita si raccoglie qui,contro le forze apparentemente soverchianti di corruzione e di dis-soluzione, in un impegno di coscienza e di responsabilità storica ein un compito di rinnovamento. È l’eroismo socratico della ragio-ne che ancora e sempre sveglia gli uomini dal torpore dell’abitudi-ne quotidiana, purifica e universalizza ogni volontà di rivoluzionecostruttiva, e l’inserisce operante come volontà collettiva degliuomini all’interno della realtà”. La ricomposizione di una linea dicontinuità della coscienza critica della ragione di fronte all’insor-gere del dogmatismo e dell’irrazionalismo, la storia del saperecome concreto autoriconoscersi della ragione che Banfi esaltacome testamento spirituale di Husserl, costituiscono già l’orienta-mento di fondo del pensiero di Paci. In questo senso per Paci ilmodo di sviluppare i temi della Crisi non andrà mai in una dire-zione irrazionalista o antiscientifica. Piuttosto si tratta di affronta-re la questione della fondazione del valore razionale e umanodelle scienze: è un compito pedagogico e scientifico che coinvolgela funzione stessa del filosofo davanti alla storia. Paci allora facapire come la fenomenologia sia una continua messa in questio-ne di ciò che è raggiunto, di tutto ciò che si presume concluso edesaustivo, come essa non possa diventare sistema definito, maricerca che l’uomo compie riflettendo sulla propria storia e suimodi stessi di attuare questa riflessione: e questo voleva dire perPaci lasciar sempre disponibile il filosofo alla problematica infini-ta della ricerca della verità e del significato.
“Restituire all’uomo la propria soggettività”; “Riportare l’uomoa se stesso, cioè alla sua autodefinizione liberata da ogni feticizza-zione, da ogni maschera che cela il vero volto dell’uomo”; “La“crisi’ non coinvolge le scienze in quanto tali, ma la loro scientifici-
85
Presenza di Enzo Paci nella crisi della cultura contemporanea
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 85 (Nero/Process Black pellicola)
tà intesa come orizzonte della vita, come senso e scopo della vita”;“Il fondamento delle scienze è nelle operazioni che i soggetti com-piono nel tempo, in quella dimensione dell’esperienza diretta, nonancora definita e strutturata che è “il mondo della vita”. InFunzione delle scienze questi sono alcuni dei temi che sottendono eguidano l’interpretazione della fenomenologia husserliana e chehanno per Paci la loro essenziale espressione e più coerente deter-minazione storica nel marxismo. La lettura di Marx diventa perPaci il piano della verifica storica della sua fenomenologia nelsenso di una dottrina, non porta Marx a scuola di Husserl - o vice-versa. Non va dimenticato (si pensi all’argomento della conferenzatenuta a Praga) che è il significato dell’uomo che fa convergere l’in-teresse di Paci su Marx e Husserl, e neppure va dimenticato che nelmodo di determinare questo significato (immancabilmente al cen-tro della sua tematica) Paci ha sempre messo in gioco il propriorapporto con la cultura contemporanea e il proprio ruolo di intel-lettuale nella società.
Certamente il suo stile così ricettivo all’attualità dei problemi eattento a cogliere il significato delle inquietudini culturali e delle tra-sformazioni sociali, e d’altra parte il suo carattere poco incline e disin-teressato a gestire le reali dinamiche di potere che inevitabilmenteoperano insieme a questi processi, lasciavano problematicamenteaperto il rapporto tra cultura e potere politico. Il marxismo di Pacinon entra nel merito dei temi specifici del’economia politica o, peresempio, della dottrina dello stato. Sono questioni che la sua forma-zione filosofica e il modo in cui è cresciuto il suo spessore teoreticolascia comunue in secondo piano. Nonostante il modo di scriverespesso complesso e difficile, le pagine di Paci su Marx e Husserl sonotra le più chiare: il significato dell’uomo si determina nella prasi sog-gettiva, nella sfera dei bisogni che fonda la dinamica dei rapportisociali in un modo dove scienza e tecnica non sono forme di sopraf-fazione dei bisogni dell’uomo ma il risultato di consapevoli operazio-ni compiute in funzione della società civile. I movimenti studenteschie operai del 1968-69 rappresentano per Paci l’esplosione nel socialedei bisogni, dei desideri, delle speranze di cambiamento dell’uomo.Aderisce con entusiasmo a questo periodo di tensioni innovatrici che,con matrici diverse, percorrono il mondo, sollecitato come sempredalla ricerca del significato dell’“uomo nuovo” e della “scienzanuova”. I tempi successivi di ricomposizione politica, di ridefinimen-to della strategia delle forze in movimento, lo renderanno per lomeno un po’ più distaccato dalla diversa fase dell’iniziativa politica.86
Stefano Zecchi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 86 (Nero/Process Black pellicola)
Il suo lavoro continua ad approfondire il problema del saperenella complessità della vita che si trascende sempre verso i nuovifini, “perché ciò a cui l’uomo tende, anche nel segreto del suo io oancora inconsciamente, è la soddisfazione dei bisogni che solo puòrenderlo felice”. Il disegno di un’interna unità dialettica tra lo svi-luppo storico dell’uomo e le sue produzioni scientifico-culturali sirintraccia nell’ultimo libro pubblicato da Paci, Idee per una enciclo-pedia fenomenologica (1973). La razionalità critica deve saper coglie-re il significato della fondazione delle scienze come sintesi dinami-che in sviluppo delle attività umane, delle operazioni che le fon-dano nel loro commisurarsi alle necessità sociali. In questa pro-spettiva c’ è il senso della diffidenza che Paci recentemente mani-festava sul modo in cui è ripreso da qualche anno in Francia il pen-siero di Nietzsche per interpretare la crisi della ragione e della sto-ria. E ancora in questa prospettiva c’è il motivo del suo più recen-te interesse a ricercare anche attraverso il problema religioso ilsignificato dell’intersoggettività della coscienza che, contro le ten-tazioni nichiliste della ragione e contro le tendenze affossatricidella libertà, trova la forza razionale di un significato della vitasempre rinnovabile.
Note al testo
* Il testo viene qui riprodotto per gentile concessionedell’Autore. Esso compariva originariamente in Il Verri, rivista diletteratura diretta da Luciano Anceschi (1977, numero 7).
87
Presenza di Enzo Paci nella crisi della cultura contemporanea
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 87 (Nero/Process Black pellicola)
GIUSEPPE MOSCATI
L’ESISTENZA CHE DIVENTA FILOSOFIAPer una rilettura dell’opera di Enzo Paci
D ialogare oggi con Enzo Paci porta con sé un frutto estrema-mente prezioso a patto che se ne sappia cogliere appieno ed in unsenso autentico la bontà.
Se ci rifacciamo in particolare agli scritti della prima metàdegli anni Quaranta, infatti, l’opera di Paci ci appare in tutta lasua attualità e vivacità intellettuale e non è un caso, invece, che lesue riflessioni del decennio successivo – quello caratterizzato dauna sorta di allontanamento dalle posizioni strettamente esisten-zialiste – rimangano in buona parte meno pregnanti. Ciò vale,naturalmente, in riferimento al panorama di pensiero attuale o,meglio, ad una discussione sul ruolo della filosofia e sulla figuradel filosofo oggi. Se possiamo individuare, a grandi linee, unaprima fase esplicitamente e pienamente esistenzialista, in unsecondo momento incontriamo il Paci del relazionismo, ma anchequello dell’approccio fenomenologico e dell’accostamento ad unaforma di neomarxismo.
L’oggetto delle pagine che Paci dedicava, per esempio, nel 1950alla formulazione e definizione dell’esistenzialismo positivo(parallelamente ad Abbagnano e altri della scuola torinese), oppu-re nel ’56 al lavoro di corretta collocazione della filosofia dell’esi-stenza in generale all’interno dell’orizzonte filosofico a lui contem-poraneo, in ultima analisi, resta legato ad una sorta di ‘nicchia spe-culativa’ che può stimolarci solo pensando ad un lavoro di ricogni-zione di storia della filosofia1.
89
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 89 (Nero/Process Black pellicola)
Volendo, però, tentare una riflessione a partire dall’istanza eticadegli scritti di Paci, non possiamo che rivolgere la nostra attenzio-ne soprattutto a quella produzione che interessa il triennio 1840-43 e che è in qualche modo inaugurata da Pensiero, esistenza e valo-re2, guardando in modo privilegiato alle tematiche della trascen-denza, del rapporto tra esistenza e pensiero, della dialettica e deltempo (queste ultime due tematiche, peraltro, tutt’altro che mera-mente teoretiche).
1. Tra Heidegger e Jaspers: la lettura di Nietzsche e la cifrakierkegaardiana
Proviamo ad indagare alcuni passaggi fondamentali del notosaggio dal titolo L’esistenzialismo3, pubblicato per la prima volta nelgiugno del ’42, nel quale l’autore esamina in chiave critica il pensie-ro hegeliano. Ma proviamo a farlo tenendo presenti anche altri fat-tori decisivi della formazione del filosofo marchigiano: l’interesseper il già citato relazionismo; l’interpretazione in chiave originaledella filosofia fenomenologica di matrice husserliana; lo stessodesiderio di riformulare una sorta di teoria politica socialista,l’“intersocialismo” del Sui rapporti tra fenomenologia e marxismoscritto nel ’71.
Della filosofia dell’esistenza cui guarda l’Autore bisogna evi-denziare la cosiddetta funzione storica, che sarebbe quella di avercontestato efficacemente il dogmatismo di Hegel riabilitando laquestione della personalità e con essa quella dell’individualità;quella del nulla e quelle della storia, del tempo, del destino e delfuturo dell’uomo su cui torneremo più avanti. Questi, che puresono tutti temi hegeliani, trovano solo nell’esistenzialismo la lorogiusta dignità speculativa, riconquistano degli spazi e delle vociche il panlogismo della visione di Hegel aveva via via cancellatodel tutto o annichilito.
Ne L’esistenzialismo, la filosofia dell’esistenza per come laintende Paci ci riporta al vero Hegel, vale a dire allo Hegel che puòdare molto anche al pensiero filosofico contemporaneo, rigettan-do invece tutti quegli elementi dogmatici del pensatore tedescoche all’uomo farebbero perdere di vista il suo compito fonda-mentale: fare dell’esistenza una filosofia, come vedremo meglioin seguito. La filosofia dell’esistenza, da parte sua, si impegna ariproporre il piano dell’irrazionale stimolandoci ed anzi obbli-90
Giuseppe Moscati
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 90 (Nero/Process Black pellicola)
gandoci «alla ricerca di un metodo di comprensione dell’irrazio-nale che sia tale da non trasformare l’irrazionale in razionale»4,come appunto vorrebbe Hegel. Il confronto critico con quest’ul-timo è ricco di mille spunti e, se intanto offre l’occasione di ragio-nare sul rapporto esistenza-ragione (autonomia dell’una e del-l’altra o separazione?), ci suggerisce anche in cosa Paci è e rima-ne in fondo hegeliano.
La ricerca di cui si diceva, che abbiamo visto essere anchericerca di un metodo gnoseologico-esistenziale – l’irrazionalecomprende anche le nostre paure ed i nostri sogni – fa sì che laragione dell’uomo fuoriesca dai canoni ortodossi in cui il pensie-ro della tradizione l’ha relegata. Paci torna comunque ad indaga-re lo “svolgimento storico del pensiero umano”, eppure lo faattribuendo a quella ricerca da cui parte una coloritura fenome-nologica nuova. Non fermandosi certo ad una semplice identifi-cazione di essere e logos, Paci affronta ed in un certo senso ‘risol-ve’ in chiave dialettica la relazione logos-natura-spirito.L’esistenza non è un dato dogmatico, ma è sempre raggiunta permezzo della ragione anche se, per essere raggiunta, deve obbliga-re la ragione alla contraddizione logica (non all’illogicità) (…).Compito del pensiero contemporaneo – ribadisce Paci ‘attraversoe oltre Hegel’ anche grazie a Kierkegaard – è di ripensare critica-mente la posizione hegeliana, spezzata e rinnovata dall’esisten-zialismo, sostituendo al dogmatico concetto di natura la libertà ela personalità dell’esistenza»5.
È bene rimarcare il fatto che ad interessarci da vicino, proprioda un punto di vista filosofico-morale, è la stesso modo di perce-pire, da parte di Paci, la funzione storica della filosofia dell’esi-stenza. L’esistenzialismo, anche se preso come determinatomomento del pensiero filosofico e della cultura dell’uomo ingenerale, ha un portato tale che fuoriesce dalla sua stessa dimen-sione storicamente data. E, d’altra parte, una simile riflessione èalla base anche di tutta quella elaborazione filosofica successivadi Paci che riguarda Il nulla e il problema dell’uomo (’50)6. Non solo:richiamandosi a Platone, Paci fa sua l’interpretazione del pensie-ro filosofico come un qualcosa di estremamente libero che non sifa imprigionare in una formula e che quasi ci tormenta finché nonne cogliamo la carica vivificatrice.
L’idea di esistenza, in Paci, richiama comunque un binomio con-cettuale decisivo quale è quello personalità-trascendenza, categorieviste dall’Autore come coincidenti con i due veri e propri poli della
91
L’esistenza che diventa filosofia
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 91 (Nero/Process Black pellicola)
filosofia esistenziale. La personalità si definisce, in realtà, attraver-so la trascendenza, attraverso il percorso di trascendimento chel’uomo vive su se stesso a partire dal riconoscimento e dalla corag-giosa assunzione dei propri limiti. È andando al di là di sé, infatti,che egli può riappropriarsi della dimensione più genuina del pro-prio essere, della sua più intima ed autentica esistenza.
Ma torniamo alla lettura che Paci dà di Nietzsche, lettura che,nonostante le possibili critiche cui essa inevitabilmente si espo-ne, ha tuttavia dei pregi evidentissimi. Si pensi innanzituttoall’importanza della sottolineatura del carattere anti-intellettua-listico della filosofia nietzschiana; non si dimentichi l’elementodell’accettazione, o meglio proprio del riconoscimento dei limiticostitutivi dell’uomo – al di là di facili fraintendimenti del signi-ficato della dottrina superomistica –; ma non si trascuri nemme-no quell’altro elemento apparentemente contraddittorio rispettoal precedente, quello della volontà di trascendere ciò che Pacichiama “umanità”.
«Nietzsche non voleva restare all’uomo – afferma Paci nel ’43 –ed indicava alla nostra umanità qualcosa che era al di là di essa. (…)è solo tramontando che l’uomo realizza se stesso. (…) L’equivocoromantico ha interpretato il mito del superuomo in senso realisti-co: ma mai l’uomo realmente esistente potrà diventare il superuo-mo»7. Questo, peraltro, porta il nostro autore a ribadire che alcun-ché «di ciò che esiste può pretendere un valore assoluto: ogni illu-sione di realizzare la superumanità è tragica e, nello stesso tempo,grottesca»8. Ecco allora perché il filosofo insiste sul trascendimen-to, momento della fuoriuscita dalla propria egoità, dalle propriecertezze conoscitivo-esperienziali e quindi dalle proprie abitudinie tendenze a ripiegarsi su se stessi. «Dobbiamo darci a noi stessi»9
è la bella e forte espressione che usa il Paci del ’43: siamo portati a“farci”, realizzandoci appieno nel mentre neghiamo e contempora-neamente riaffermiamo la nostra umanità, ovvero nello stesso“movimento” per il quale mettiamo in crisi la nostra vita per poiriconquistarla a noi.
Un movimento, questo, che l’Autore definisce significativa-mente “di andata e ritorno” e che egli fa coincidere, in tal senso,con la struttura che è a fondamento della personalità di cui sidiceva. Con il coinvolgimento della tematica della libertà, pertan-to, Paci sembra chiamare in causa proprio Kierkegaard quandoafferma che l’uomo è libero di costituirsi in quel fondamento,arrivando a fondare egli stesso la propria realtà esistenziale; ma –92
Giuseppe Moscati
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 92 (Nero/Process Black pellicola)
non possiamo non sottolinearlo con forza – tale conquista avvie-ne solo ed esclusivamente grazie all’apertura che il trascendimen-to porta con sé, cioè all’andare oltre il proprio io per tornarci poisensibilmente arricchiti e rinnovati.
L’uomo, insomma, «si nega come immediatezza, come dato,come fatto e, trascendendosi, fonda se stesso come personalità»10.La sua, però, è una negazione riferita alla solitudine del proprioessere (da cui, aggiungerei, le ansie, le fobie, la disistima ed ilsenso di inadeguatezza che troppo spesso colgono l’uomo con-temporaneo) in favore della condivisione e, ancora una volta, del-l’apertura; la preoccupazione di Paci, del resto, non può che esse-re quella di tutelare e promuovere il confronto, il dialogo, la ver-sione migliore della ragione dialettica, mettendo in guardia rispet-to alle derive di un vivere secondo la logica parcellizzante dellapeggiore autoreferenzialità.
Se quello kierkegaardiano è sicuramente un riferimento impre-scindibile per la lettura della produzione di Paci, non a caso altret-tanto decisiva è la presenza, nella sua opera, di alcune categoriebasilari della filosofia jaspersiana, tutte imperniate attorno alnesso tra ragione, libertà ed esistenza. È ne L’esistenzialismo chePaci scrive di quello filosofico come di un pensiero che «ha recla-mato il diritto di liberare la concreta esistenza dell’uomo da ognischematica astrazione della ragione filosofica [la quale] cerca in sestessa l’irrazionale e l’arazionale, pur accorgendosi tuttavia dellaloro assoluta inafferrabilità poiché, ogni volta che la ragione riescead afferrarli, essi si dissolvono nel mito e nel dogma»11. E pocodopo, infatti, Paci tenta di sintetizzare il problema principale dellaricerca di Jaspers con la formulazione di un unico, cruciale inter-rogativo: «in che senso l’irrazionale e l’arazionale sono possibili difronte al razionale?»12.
Tutto lo spirito della filosofia dell’esistenza, nota così Paci, èracchiuso nel profondo significato di questo interrogativo che cispinge alla ricerca di una alogicità in qualche modo coerente o diuna logicità propria di ciò che consideriamo irrazionale. Un pro-blema filosofico, questo, ma al tempo stesso un problema genui-namente esistenziale, avverte il Nostro, il quale parla del vero eproprio “problema della vita moderna” per cui «si tratta di fare sìche tutte le esperienze negative che abbiamo sofferto acquistinoun valore positivo e rivelino il senso dell’esistenza»13.
Confrontando queste riflessioni con lo scritto apparso su“Primato”, d’altra parte, possiamo cogliere un nesso fondamenta-
93
L’esistenza che diventa filosofia
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 93 (Nero/Process Black pellicola)
le. E non si faticherà ad individuare proprio il timbro jaspersianodel passo in cui Paci torna sul fatto che l’uomo è “la sua umani-tà” e riconosce il senso più proprio del suo esistere “nel silenziodella propria intimità” e “di fronte al nulla”. Un nulla che, in defi-nitiva, corrisponde alla scoperta della “libertà infinita del mondodello spirito”14, dove Kierkegaard e Jaspers tornano insieme, marivissuti dalla sensibilità di un Paci filosofo dell’intimo e dell’in-teriorizzazione della vicenda esistenziale.
Eppure Paci va a collocarsi anche tra Jaspers e Heidegger nelsuo riconoscere che ogni esistenza si svela finita, precaria e costret-ta ad abbandonare illusioni di onnipotenza o di assolutizzazione disé come mere tentazioni solipsistiche. In questo contesto si inseri-sce la difesa della filosofia dell’esistenza che egli elabora rispettoalle accuse di nihilismo: accuse che risultano con evidenza superfi-ciali, secondo Paci, in quanto la visione del mondo promossa dal-l’esistenzialismo ruota attorno all’idea fondamentale di un proces-so interiore che fa sì che l’essere degli uomini si vada a costituire“nella sua vera unità e sostanzialità”15.
2. Paci e Feuerbach: vicinanza e distanza
Credo meriti senza dubbio di essere ricordata l’immagine evo-cata dall’Autore a proposito della natura “antinihilista” della filo-sofia dell’esistenza: «Soltanto quando il grano di frumento moriràpotrà rinascere e moltiplicare se stesso. Così la morte non è che illimite accettato sul quale si costituisce la mia vita. È una conqui-sta, e ognuno, come deve conquistarsi la propria esistenza, cosìdeve conquistarsi la propria morte»16. In realtà una simile citazio-ne richiama alla mente, a mio avviso, se non altro lo spirito di alcu-ni luoghi fondamentali della filosofia della morte del giovaneFeuerbach, in particolare del saggio dedicato ai Pensieri sulla mortee sull’immortalità dell’anima del 1830; ma la questione richiedereb-be una ben più ampia trattazione nonché un ulteriore approfondi-mento a partire dalla rilettura di un autore, quale è Feuerbach,troppo spesso etichettato proprio come nichilista! Ci possiamo sol-tanto limitare, in questa sede, ad indicare brevemente alcuni puntidi vicinanza e di distanza tra il pensatore tedesco ed Enzo Paci.
In primo luogo credo dobbiamo notare come sia sorprendente lavicinanza tra le posizioni dei due filosofi proprio riguardo allatematica della relazione vita-morte. Dopo aver letto, attraverso94
Giuseppe Moscati
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 94 (Nero/Process Black pellicola)
l’immagine del grano, quanto scriva Paci in proposito, proviamo ariflettere sulle parole di Feuerbach: quantunque la morte ci appaiacome un qualcosa che non deve essere (Nichtseinsollenders), siamotutti chiamati a riconoscerne la vera essenza, che non può che esse-re – paradossalmente – vitale, anch’essa facente parte del percorsodi vita che ci è proprio e solo così, «dopo che sia riconosciuta, [lamorte] illumina nel più profondo di ogni esistenza e di ogni cono-scenza»17. Ecco perché il compito dell’uomo, in ultima istanza,coincide con «l’essere con volontà e coscienza, con libertà, quelloche alla fine sarà costretto ad essere»18. A chi conosce da vicinol’autentica prospettiva filosofico-morale del Feuerbach, del resto,apparirà chiaro come abbia un ruolo fondamentale questo riferi-mento alla volontà, alla coscienza e soprattutto alla libertà: l’uomofeuerbachiano non accetta passivamente una sorta di condannaimpostagli dalla natura, bensì si sente responsabilmente coinvoltoin un’assunzione consapevole dei propri limiti proprio in vista diun continuo tentativo di superamento di essi; l’Ich stesso di cuiparla Feuerbach trascende ogni volta se stesso, la propria identità,il proprio Sé tendenzialmente divinizzabile, per aprirsi alla diver-sità del Du.
Ma torniamo a Paci: anche secondo il filosofo italiano l’uomodeve superare se stesso, ma nel senso di oltrepassarsi senza fermar-si alla propria mera datità, che potremmo anche dire ‘banale’. InFeuerbach un simile oltrepassamento non è possibile; in lui c’è latensione ad un superamento dei vincoli che incatenano il soggettoalla propria egoità, ma non può esserci un abbandono dei limiticostitutivi, anche biologici, dell’esistenza umana. Paci scrive che«l’esistenza può scoprirsi nel movimento per cui essa si nega comedato nel porsi nel suo farsi, nel suo continuo morire per rinascere ase medesima; nel suo realizzarsi come struttura dell’essere, comesostanza dell’essere»19. E questa “struttura dell’essere”, questa“sostanza dell’essere” chi qui appare strettamente legata alla liber-tà, ci permette di pensare all’essenza di feuerbachiana memoria, laWesen; non solo: nell’espressione di Paci in cui egli definisce il“movimento dell’esistenza” che va a negarsi come dato per “porsinel suo farsi”, lì ravviserei la presenza di alcuni elementi vagamen-te dialettici, che potrebbero chiamare in causa la stessa formazionehegeliana del giovane Feuerbach.
Ma subito notiamo la distanza di Paci da Feuerbach quando lostesso saggio su L’esistenzialismo in Italia afferma che l’uomo «nonsarà Dio, ma per Dio costruirà la propria vita e la propria storia; è
95
L’esistenza che diventa filosofia
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 95 (Nero/Process Black pellicola)
questo il senso della autentica storicità che in ogni personalità edin ogni epoca è sempre rinnovata conquista della verità»20.Feuerbach, in realtà, tematizza piuttosto la divinità del rapportoio-tu, specie quando insiste sul carattere divino della volontà del-l’individuo di ‘essere e fare con l’altro’; egli, inoltre, definisce laverità (ancor più decisamente nel biennio 1842-43) come verità dia-logica tra me e l’‘altro da me’, ma quest’ultimo non coincide maicon Dio, se non nel senso di una relazione tra l’uomo e la sfera deisuoi desideri e delle sue attese dalla componente misteriosa dellapropria esistenza.
Lo stesso Paci, però, lo riscopriamo nuovamente feuerbachia-no quando ammette che siamo quello che siamo, cioè esseri finitie determinati, in maniera indissolubile legati alla prima delle pro-prie limitazioni, quella che ci è data loro dall’essere nati ed insie-me dal dover morire. Il che, poi, si accompagna al fatto di esserenati “in un modo o in un altro”, con determinate caratteristichemorfologiche e fisiologiche e con determinate “possibilità di azio-ne e di produzione”21.
Volendo un po’ sintetizzare, senza peraltro cadere in facilibanalizzazioni, credo si possa dire che in Paci l’uomo deve supe-rarsi come essere (semplicemente) fattuale, negandosi comeimmediatezza in virtù della costruzione della propria piena per-sonalità, mentre in Feuerbach l’uomo può tutt’al più aprire la pro-pria essenza a quella dell’altro in un movimento che, semmai, è ditrascendenza orizzontale, ma che mai può tradursi in un oltrepas-samento dei confini naturali, al di là di ciò che l’uomo stesso è, eche assolutamente non può e non deve dimenticare la propriasensibilità e corporeità.
3. La concezione del tempo e il futuro dell’uomo
Particolarmente interessante risulta pure, in chiave di rico-gnizione di ciò che del pensiero di Paci è attuale, l’idea deltempo e della temporalità. Incontriamo, in una prospettivaall’interno della quale permangono tracce heideggeriane, dauna parte una stretta connessione tra la concezione del tempointeriore e quella che per Paci è la legge morale costitutiva del-l’esistenza, e dall’altra un legame altrettanto significativo tra talelegge morale e l’elemento dell’arte, visto quale “ritorno alla veranatura dell’uomo”22.96
Giuseppe Moscati
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 96 (Nero/Process Black pellicola)
La versione paciana dell’esistenzialismo, allora, coniuga iltempo come una “forma costitutiva” non solo dell’essere, ma anchedella persona stessa; ed in quanto tale esso corrisponde ad unmovimento che torna al passato dopo essersi spinto fino alladimensione dell’avvenire. Il futuro dell’uomo, così, è «l’orizzonteaperto che apre tutti gli orizzonti»23: per questo l’uomo deve riap-propriarsi del tempo come luogo di libertà, in un processo che, direi,risulta squisitamente emancipativo.
La libertà torna qui con tutta la sua valenza o, se si preferisce, plu-rivalenza esistenzialista, anche perché Paci – il quale vede la filosofiadell’esistenza come una forma di decadentismo romantico ed allostesso tempo di deciso antiromanticismo – tematizza la libertà ‘perla morte’ cui facevamo riferimento sopra in termini di coerente lettu-ra psicologica. Parlando di destino e di pensabilità del nulla, di ango-scia e di senso/non-senso della mortalità e della finitezza dell’esisten-za, egli ci presenta ed illustra così un mirabile paradosso.L’esistenzialismo, scrive infatti con malcelato entusiasmo il Paci deiprimi anni Quaranta, «ha trasformato quello che era un atteggia-mento in un problema filosofico. L’esistenza (…) ha ora trovato l’e-spressione tecnica per rivelarsi come problema filosofico»24, conclu-dendo con estrema efficacia che «l’esistenza è diventata filosofia»25.
Volendo individuare un limite della filosofia di Paci, potremmodire che l’allievo di Banfi, proprio nel mentre va definendo quellasua teoria relazionistica secondo la quale mi conosco e ri-conoscosoltanto nel mio rapportarmi agli altri (alle altrui esistenze edesperienze di vita oltreché alle altrui conoscenze), fa discendereun po’ forzatamente – ma poi neanche troppo, per la verità – lostesso esistenzialismo, quale negazione dell’Essere parmenideo,dal pensiero nietzschiano26.
Ma che significato assume la legge morale di cui ci parla Paci? Sitratta di un’istanza da intendere, sostanzialmente, come sottolinea-tura dell’urgenza di denunciare il reale (Aldo Capitini parlava di“insufficienza dell’esistente”) ed oltrepassarne le brutture – distru-zione, violenza, indifferenza e, potremmo dire, non-cura in sensolato – senza negarle tout court o ignorarle come invece arriva a farel’accezione peggiore del liberalismo più sfrenato. Se è vero questo,però, e se trasportiamo le argomentazioni di Paci nello scenariodell’era contemporanea in cui sembrano accavallarsi senza sosta gliechi di guerre e guerriglie più o meno seguite dai mass-media, allo-ra siamo tutti chiamati a tendere l’orecchio per ascoltare la voceprofetica dell’esistenzialista italiano.
97
L’esistenza che diventa filosofia
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 97 (Nero/Process Black pellicola)
Note al testo
1. Imprescindibile, da questo punto di vista, lo studio di A. Vigorelli,L’esistenzialismo positivo di Enzo Paci. Una biografia intellettuale (1929-1950),Franco Angeli, Milano 1987.2. Cfr. E. Paci, Persona, esistenza e valore, Principato, Milano 1940.3. Cfr. Id., L’esistenzialismo, prima La Garangola, Padova 1942, poi Cedam,sempre Padova, ma 1943 (da cui citeremo).4. Ivi, cit., p. 58.5. Ivi, p. 63.6. Cfr. Id., Il nulla e il problema dell’uomo, Taylor, Torino 1950.7. Id., L’esistenzialismo in Italia, “Primato”, IV, n. 1 (1 gennaio) 1943, inAntologia di “Primato”, a cura di V. Vettori, De Luca, Roma 1968, poi in B.Maiorca (a cura di), L’esistenzialismo in Italia, Paravia, Torino 1993, p. 98.8. Ivi, p. 98.9. Ibidem. 10. Ibid.11. E. Paci, L’esistenzialismo, cit., p. 7 (corsivo mio)12. Ibid.13. Ibid.14. Cfr. E. Paci, L’esistenzialismo in Italia, cit., p. 98.15. Cfr. ibid. 16. Ibid.17. L. Feuerbach, Gedanken über Tod and Unsterblichkeit, aus den Papiereneines Denkers, nebst einem Anhang theologisch-satyrischer Xenien, hrsg.[herausgegeben] von einem seiner Freunde, bei Johann Adam Stein, Nürnberg1830; trad. it. di F. Bazzani, Pensieri sulla morte e sull’immortalità, a curadello stesso Bazzani, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 33.18. Ivi, p. 32.19. E. Paci, L’esistenzialismo in Italia, cit., p. 98 (corsivi miei).20. Ibid.21. Cfr. ivi, p. 99.22. Cfr. ivi, p. 100.23. Ibid.24. Id., L’esistenzialismo, cit., p. 5.25. Ibid.26. Cfr. B. Maiorca, Percorsi dell’esistenzialismo in Italia e filosofia dell’esisten-za, in , cit., p. 13.
98
Giuseppe Moscati
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 98 (Nero/Process Black pellicola)
Intervista a SALVATORE VECA(a cura di Massimiliano Cappuccio)
ENZO PACI E LA POLIS:DALLA NASCITA DI AUT AUT ALLA FINE DEL COMUNISMO
[Chora] Professor Veca, vorremmo chiederLe di parlarci diEnzo Paci raccontandoci degli esordi della sua esperienza edito-riale più significativa: la creazione della rivista Aut Aut, che fuguidata da Paci fino ai primi anni Settanta e che è stata da Lei co-diretta per un certo periodo. Quali istanze filosofiche e qualimotivazioni spinsero Paci a creare la rivista, nel ‘51, e quale pro-getto culturale perseguiva sulle sue pagine?
[Veca] Ho seguito Aut Aut fin da giovane studente, come peraltro Pier Aldo Rovatti, e come lui ho cominciato a scrivere sullarivista da quando non ero ancora laureato. Sono convinto che Paciavesse in mente un progetto editoriale incentrato sulla sua ricercafilosofica, che nel ‘51 non era ancora entrata nella fase fenomenolo-gica, ma era in una fase che io ho sempre considerato la più fecon-da, cioè quella di tipo relazionistico, situata tra esistenzialismo efenomenologia. L’idea era che la ricerca filosofica potesse far inte-ragire tra loro e dare senso alle diverse “versioni del mondo”, comemi piace dire: quelle musicali, quelle poetiche… Aut Aut è semprestata una rivista appunto di filosofia e cultura, non era una rivistafilosofica nel senso standard ma non era neanche un sempliceperiodico culturale. Espressa dallo stile di Paci vi era questa voca-zione all’esplorazione e alla costruzione all’interno dei diversi
99
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 99 (Nero/Process Black pellicola)
campi di attività intellettuale, con il filo rosso della ricerca filosofi-ca che andava esplicitando il senso di quelle diverse ontologieregionali – diremmo con lessico husserliano – di cui si compone ilnostro landscape culturale. Questa era l’idea di fondo di Paci, l’ideache ha perseguito in maniera perfettamente riconoscibile tra lametà degli anni Cinquanta e la fine degli anni Sessanta. Si può tro-vare lì il DNA allo stato puro di Aut Aut.
Si sente dire a volte che Aut Aut è stata una rivista “studente-sca”, nel senso che molti giovani studiosi erano invitati a scrive-re sulle sue pagine e a prendere parte alla sua realizzazione, coor-dinati dall’autorevole guida di Enzo Paci. In quanto ex-direttoredi Aut Aut, e in base alla sua esperienza professionale nell’ambi-to dell’editoria, che consigli si sentirebbe di dare oggi alla reda-zione di una rivista specializzata in filosofia che, come la nostra,e stata originariamente creata dagli studenti e vive seguendoanche le loro proposte? II problema più complicato sembra esse-re sempre quello di riuscire a equilibrare la freschezza e l’origi-nalità delle proposte più creative con la serietà del lavoro accade-mico e con il rigore di un registro scientifico; per altro verso ildilemma di chi dirige una rivista di filosofia é quello di riuscirea coniugare la riflessione sui temi eterni del pensiero filosoficocon le contingenze del tempo presente e le necessità dell’attuali-tà. Vorremmo chiederLe di darci qualche suggerimento, esponen-do a noi e a nostri lettori le Sue riflessioni in merito.
Vorrei anzitutto sottolineare l’atteggiamento liberale e proposi-tivo che Paci ha sempre tenuto nei confronti dei giovani, non solonei confronti di quelli che facevano ricerca con lui ma anche deinuovi studenti. Paci ha sempre avuto una straordinaria attenzionenei confronti della capacità delle giovani generazioni di mettere “inagenda” e di mettere a fuoco temi, questioni e modi di sentire i pro-blemi, spesso in modo non ortodosso rispetto alle tradizioni disci-plinari. Le tradizioni disciplinari hanno la caratteristica di irregi-mentare in qualche modo ciò che può costituire un problema, e inqualche modo lavorano nel cono di luce di ciò che è già definitocome problema, così che il loro intorno è opaco e resta nellapenombra: Paci, che amava il gergo husserliano, avrebbe detto cheesse stanno nel nucleo, nel Kern, delimitate dalle Abschattungen.Ora ci sono virtù e vizi nel fare una rivista filosofica di tipo profes-sionale e accademico: la virtù è che vi saranno filtri selettivi nei100
Salvatore Veca
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 100 (Nero/Process Black pellicola)
confronti della qualità dei contenuti, dipendenti dalle regole disci-plinari, le quali possono anche cambiare nel tempo; il vizio puòscaturire dal fatto che spesso si scrivono articoli non perché un pro-blema sia percepito realmente come una questione che fa tremare ipolsi, ma per il fatto che altri hanno scritto su quel tema e che biso-gna quindi rispondere ai loro articoli, e questo è tipico delle pub-blicazioni specialistiche della comunità scientifica. Una rivistacome la vostra dovrebbe mantenere un curioso e difficile equilibrio– certamente instabile – tra quanto è già stato classificato come pro-blema nella tradizione e quanto invece viene percepito indipen-dentemente dall’irregimentazione tipica dell’impostazione profes-sionale. Fare una rivista indipendentemente dalla tradizione sem-brerebbe bizzarro, però anche fare una rivista unicamente internaalle regole della produzione e della scrittura filosofica mi sembre-rebbe altrettanto poco interessante; è un equilibrio difficile ma pro-babilmente è proprio ciò che rende conto della motivazione e dellapassione per questa navigazione incerta.
II dibattito politico italiano è stato per lungo tempo monopo-lizzato dalla contrapposizione tra idealisti e marxisti. Il lavoro difilosofi come Lei ha consentito negli anni ‘70 di iniziare a pren-dere in considerazione anche prospettive filosofiche diverse, sututte quella di John Rawls. Che tipo di effetto ha avuto sullascena filosofica l’ingresso della filosofia politica normativa dimatrice analitica? E che effetti ha sortito sulla sinistra italiana, diderivazione marxista, il liberalismo di sinistra?
Ho lavorato su Marx (nell’ambito di uno dei vari marxismi, per-ché ce n’erano tanti) durante il corso dei primi anni Settanta: sen’era discusso con Paci già da anni, in quanto il marxismo era lakoiné nella quale si riconosceva una sinistra che per altri aspetti eramolto frammentata. Nel ‘77 pubblicai un libro che si chiama Saggiosul programma scientifico di Marx (Milano, il Saggiatore), un saggioche riconosceva un’enorme importanza del pensatore tedesco per ilpensiero moderno e al tempo stesso indicava anche i suoi limiti;Marx era uno dei giganti di cui eravamo eredi, in mezzo a Spinozaed Hegel, ma restava un terminus a quo e non ci dava alcun terminusad quem. Questo era il senso del mio libro che suscitò molta discus-sione. Alcuni di noi in quel periodo decisero che Marx era morto eche quindi tutto era permesso; altri invece, come me, furono con-vinti del fatto che l’esperienza dell’attraversamento del pensiero di
101
Enzo Paci e la polis: dalla nascita di Aut Aut alla fine del comunismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 101 (Nero/Process Black pellicola)
Marx, che pure è molto complicato e complesso, richiedesse di nonmollare, cioè di ritrovare un criterio di giudizio della politica, dellescelte politiche, delle prospettive di riforma della società e delleistituzioni, che avesse sullo sfondo ciò da cui veniva ma che intan-to si attrezzasse con strumenti che fossero capaci di orientare nellavalutazione politica delle scelte collettive.
E fu qui che io incontrai quel capolavoro della filosofia politicadella seconda metà del ventesimo secolo che è Per una teoria dellagiustizia di John Rawls, il quale era completamente assente da noi,provenendo da una tradizione assolutamente minoritarianell’Europa continentale e, a fortiori, in Italia. Feci molta fatica all’i-nizio perché dovetti misurarmi con una tradizione di studi e conun modo di vedere le cose di tipo molto diverso, era come impara-re una lingua nuova: fu un lavoro di lungo periodo, pubblicai Laverità giusta nel ‘82 e seguì oltre un decennio di lavori nell’ambitodella teoria normativa della politica. In quel periodo ero impegna-to anche in una militanza politica, allora nel Partito ComunistaItaliano, dove per una decina d’anni fui anche committed nel tenta-tivo, per dir così, “di rinominare le cose”: con Michele Salvati nel1989 proponevo al Partito Comunista di cambiare nome e di chia-marsi Partito Democratico della Sinistra; il PDS è nato in seguitoanche sulla base di proposte come la nostra, le quali, insomma,ebbero una discussione molto ampia. Era il periodo in cui collassa-va l’impero sovietico e cominciava il grande disordine mondiale dicui siamo ancora oggi eredi e pienamente pasticciati. Quale effettoabbia prodotto il mio lavoro non spetta a me dirlo, ma certamentedi fatto si può fare una constatazione molto semplice: se oggi unodiscute con un socialdemocratico tedesco o con un new labour bri-tannico o un liberal americano o con i socialisti francesi o spagnoli,tutti quanti utilizzano il nostro lessico, quel lessico che io e altricome me, abbiamo introdotto circa vent’anni fa. Naturalmentelimitarsi a cambiare il lessico a volte può essere nient’altro che unamanovra opportunistica, se si cambia solo il modo di riferirsi allecose ma se rimangono i tic ereditati da una vecchia tradizione poli-tica e da una consolidata produzione ideologica; ma di fatto cam-biare il lessico ha fatto in modo che si potesse aggiornare il catalo-go degli strumenti concettuali della sinistra, inclusa quella radica-le, così che oggi tutto lo spettro dell’opposizione fa capo grossomodo ad una certa prospettiva e ad una precisa idea di giustizia –sia essa distributiva o commutativa. Nel prodursi del puzzle com-plicato di questo cambiamento io ho messo una piccola tessera.102
Salvatore Veca
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 102 (Nero/Process Black pellicola)
Nella concezione relazionistica di Enzo Paci, come in quella dialtri maitre a penser continentali, i grandi temi dell’impegno edel pensiero politico non avrebbero potuto essere in alcun modoseparati dalla considerazione dei problemi filosofici di naturapiù speculativa, dalla riflessione sulla condizione di crisi dellescienze europee, dalla meditazione sull’esistenza umana, né daqualsiasi altro aspetto della cultura intesa come vita di una veri-ta in cammino; per converso anche gli interessi più specialisticidel filosofo devono svilupparsi nella considerazione delladimensione intersoggettiva, pubblica, sociale e politica dellaverità. Questa visione, per la quale i vari rami del sapere filoso-fico devono costantemente ed immediatamente tenersi insiemecome un tutto organico, non sembra appartenere ai pensatoridella tradizione analitica. Crede che questa sia un’immagine cor-retta della filosofia analitica? E, in particolare, quale pensa chedebba essere il ruolo della filosofia politica analitica all’internodella discussione pubblica e/o all’interno degli altri rami dellaricerca filosofica?
Il problema che viene posto con questa domanda è lo stesso cheviene affrontato nel mio prossimo libro, che uscirà presto (metàGiugno 2005, NdR), e in particolare in un capitolo intitolato“L’offerta filosofica e i soggetti della politica”: si tratta di un tenta-tivo che io faccio di ricostruire e render conto dei notevoli rappor-ti tra il fare politica e il fare teoria politica – impegnata quest’ultimanell’offerta filosofica di credenze. Ho trovato un po’ bizzarro chemolti di noi – intendo quelli che sono stati fino ad ora a sinistra –abbiano avuto problemi teorici come ad esempio quello celebre delrapporto tra teoria e prassi, ma poi come tanti reduci nessuno si siaposto il problema di fare i conti con il suo passato... Ma per cerca-re di capire quale sono le circostanze che generano e che definisco-no la natura di un certo tipo di discorso filosofico rivolto al pubbli-co, bisogna prender atto che vi sono due grandi modelli di impe-gno, che rispettivamente possiamo riferire grosso modo ad una tra-dizione continentale e ad una analitica, quest’ultima provenienteper lo più dall’ambito accademico tra Oxford a Cambridge. Comeper la maggior parte delle faccende della filosofia del ventesimosecolo, se vogliamo risalire all’origine della nostra modernità, tro-viamo questa distinzione. Come ha mostrato Michael Dummett èuna distinzione da prendere con tutto il beneficio del dubbio,soprattutto se uno pensa che la filosofia analitica, che si vuole esse-
103
Enzo Paci e la polis: dalla nascita di Aut Aut alla fine del comunismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 103 (Nero/Process Black pellicola)
re di matrice anglosassone, nasce da pensatori di lingua tedescacome Frege e Wittgenstein. Accettiamo però la distinzione. Inbuona sostanza questa distinzione coincide con quella tra pensato-ri che hanno rapporti con il potere politico e pensatori che hannorapporti con il potere religioso: gli intellettuali continentali sonoquelli che fanno “i preti” in certo modo, nel senso che si assumonola “missione del dotto” di Fichte, guidato dall’idea della formazio-ne dell’élite politica, (lo stesso problema era avvertito da Hegel neiconfronti della formazione dei leader dello stato prussiano, e poiancora da Croce, da Gentile…)
Sartre è forse la figura più rappresentativa dell’intellettuale con-tinentale. Lui e gli altri come lui hanno in mente che il loro lavorofilosofico determini e fissi il fine dell’azione politica. Prendiamo ildiscorso filosofico di Sartre, o di Paci appunto, o di Merleau Ponty,Horkheimer, Adorno o Marcuse: essi hanno sempre a che fare conil fine e si propongono di determinare i fini dell’azione collettivaparlando di un’ideale di società che si emancipa dalla schiavitù divarie cose, una società al di là della scarsità, al di là del principio diprestazione, al di là dello sviluppo libidico unilaterale... Si propon-gono cioè di legare strettamente una visione della politica, dellaistituzioni, e dei modi della convivenza ad una visione coerente ditipo speculativo. Facendo questo cercano di costituire comunità dicondivisione, uditori non già dati ma alternativi rispetto a quelligià costituiti. I filosofi continentali hanno in mente di essere imaneggiatori dei fini (del partito, della classe sociale, della nazio-ne… o della razza, nei casi più infelici); sono coloro che secernonoi discorsi di identificazione collettiva degli altri, ovvero dispensanobeni d’identità (come Marcuse, che ai giovani figli dei fiori delperiodo dell’ondata contestativa offre modi per riconoscersi comegenerazione): essi offrono la ragione dello stare insieme in quantospecificano le modalità del riconoscimento.
Diverso è il caso in cui trovo che il mio lavoro filosofico disponedi fini già dati, e quello che devo fare è quindi saggiare la lorocoerenza reciproca, la loro giustificabilità, la loro compossibilitàcon altri fini; quindi non miro a generare comunità di condivisio-ne, né beni di identità, perché questi sono già dati indipendente-mente dal mio discorso filosofico. Il filosofo analitico, per questomotivo, molto spesso è uno che assume che certi fini siano dati equindi si interroga sulla loro giustificazione, oppure sulle tecnolo-gie che consentono di perseguirli al meglio. Ci sono due grandieroi della filosofia, le cui figure sono emblematiche di questo modo104
Salvatore Veca
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 104 (Nero/Process Black pellicola)
di sganciare il lavoro teorico rispetto all’impegno civico: BertrandRussell e Noam Chomsky, due figure che io ammiro moltissimo.Quando Russell va in tribunale, quando si batte contro la bombaatomica, quel che afferma è del tutto indipendente dalla sua filoso-fia, così come quando Chomsky emette i suoi atti di accusa controla politiche imperiali dell’amministrazione statunitense non lo fa inquanto studioso di linguistica trasformazionale o di grammaticagenerativa, ma lo fa in quanto cittadino insieme ad altri cittadini afavore di una prospettiva egualitarista. Quando invece Sartre vadavanti ai cancelli della Renault di Billancourt lui va come funzio-nario dell’umanità, come funzionario dell’universale.
Queste due figure, Sartre (o Paci) da una parte e dall’altraChomsky (o Russell), effettivamente rappresentano le polaritàestreme di due modi di intendere il rapporto tra il lavoro filosoficoe l’attività politica. Si tratta di una distinzione netta e facile, e natu-ralmente poi ci sono molti casi border-line tra i due estremi; oggipoi le cose sono molto più opache e più mobili di quanto siamoportati a riconoscere guardando attraverso gli occhiali ereditati dalpassato, e le nuove generazioni hanno la possibilità di vedere lecose in maniera differente, anche solo perché hanno vissuto menoanni, e avvertono meno la pressione dell’eredità del passato.
Vorremmo domandarLe del volume Il filosofo e la città, da Leicurato, che raccoglie vari scritti di Paci dedicati ai temi dellacomunità politica, intesa in senso ampio, e che attraversa lariflessione di pensatori come Platone, Whitehead, Husserl, Marx.Nell’introduzione Lei ha elaborato una critica abbastanza severaallo stile del discorso paciano, il quale, nello stabilire parallelirelazionistici, non si muoverebbe al di là del semplice livello del-l’analogia e della similitudine, con la conseguenza che la da luiauspicata sintesi tra fenomenologia e marxismo risulta essereun’idea superficiale e poco prudente. Rimane valida, nonostantequesta critica, una qualche utilità nello stabilire una continuitàtra Marx e Husserl? Nei confronti del relazionismo paciano, crea-tivo e talvolta imprevedibile, deve essere emessa una condannanetta, o pensa che al suo interno permangano elementi interes-santi e tuttora utilizzabili?
Riscriverei quello che scrissi allora, nel ‘78, nell’introduzione aquell’antologia, senza cambiare nulla – salvo forse che lo stile, cheora mi sembra un po’ ampolloso, ma era per via della passione
105
Enzo Paci e la polis: dalla nascita di Aut Aut alla fine del comunismo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 105 (Nero/Process Black pellicola)
che nutrivo nei confronti di Paci, una persona alla quale devomolto. Paci mi ha insegnato soprattutto a innamorarmi della filo-sofia, e non è poco: non mi ha insegnato il metodo, né il rigore,ma invece ha consentito che io apprendessi in che modo una per-sona può veramente dedicarsi con devozione alla ricerca. Di que-sto gli sono molto grato, anche se poi la mia ricerca si è sviluppa-ta autonomamente.
Il programma di Paci è stato progressivo fino alla sua fase rela-zionistica, ed è in seguito diventato regressivo: non tanto con il suotentativo generale di importazione e di re-interpretazione dellafenomenologia husserliana, quanto con il suo tentativo di applica-re lo Husserl della Crisi delle scienze europee in maniera analoga allacritica di Marx dell’economia politica. Questo tentativo di commi-stione è tutto sommato molto canonico nella tradizione intellettua-le italiana, essendo una situazione tipica del rapporto che sussisteda noi tra ceti intellettuali e soggetti della politica (cioè i partiti).Questa fase è contrassegnata dalla conferenza di Praga e dalla pub-blicazione di Funzione delle scienze e significato dell’uomo; questodiscorso viene però poi abbandonato da Paci, ed ecco che la faseconclusiva della sua ricerca vede, con l’ultimo suo libro, il ritornoad un progetto enciclopedico aperto: tornano quindi i temi che ave-vano generato il DNA di Aut Aut. Sosterrei esattamente la tesi chedifesi allora: mentre l’esercizio di una prospettiva relazionistica haun notevole valore “suggestivo”, in senso letterale, perché è ingrado di suggerire e stimolare idee nuove, la logica meramenteecceterativa (“c’è anche questo, e questo e questo”), applicata neltentativo di tenere insieme Marx e Husserl, era destinata a rimane-re sterile, perché avrebbe potuto generare solo il tedio verso unacertezza che non si sa come spendere. Sono convinto che il puntodi forza e di maggior interesse del relazionismo paciano sta pro-prio nella sua imprevedibilità e nella sua capacità di cogliere lega-mi inaspettati: esso è il promemoria della possibilità euristica diavanzamento della ricerca. Penso che questa sia una delle migliorieredità che Paci ci ha lasciato.
106
Salvatore Veca
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 106 (Nero/Process Black pellicola)
LUCA VANZAGO
PACI E WHITEHEAD: LA PROCESSUALITÀ RELAZIONALE
DELLA NATURA E IL PROBLEMA DELLASOGGETTIVITÀ EMERGENTE*
L’appropriazione da parte di Enzo Paci della filosofia relazioni-stica e processuale di A. N. Whitehead non rappresenta soltantouna tappa, certo decisiva, del personale cammino di pensiero che ilfilosofo di Monterado ha compiuto nella sua ricerca della concretez-za della realtà. A distanza di cinquant’anni dalla genesi del relazio-nismo di Paci,1 si può ora sostenere che questo approccio costituiscaanche, per un verso, una delle più originali interpretazioni dellafilosofia di Whitehead, tale da offrire prospettive inedite e moltofeconde entro un quadro interpretativo che, da qualche anno, siviene allargando ad aree geofilosofiche importanti ma inizialmentequasi non scalfite dalla meditazione whiteheadiana, come Francia eGermania. Ma per altro verso, e soprattutto, la ricezione paciana diWhitehead e l’impostazione relazionistica che ne scaturisce consen-tono di apportare un contributo di prima importanza al dibattito incorso sulla natura della soggettività e sulla “naturalizzazione” del-l’esperienza e della coscienza. È cioè dal punto di vista della piùstretta contemporaneità che si rende possibile apprezzare realmen-te l’importanza della prospettiva filosofica relazionistica e in parti-colare della visione enciclopedica di essa che Paci ha realizzato. Inquesto lavoro intendo quindi esaminare, in modo necessariamentesintetico, sia il modo con cui Paci ha letto Whitehead, sia il signifi-cato che tale lettura assume per il dibattito contemporaneo. È allafilosofia di oggi che il relazionismo di Paci parla, e questo mio lavo-ro spera di apportare un contributo in questa direzione.
107
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 107 (Nero/Process Black pellicola)
Paci interprete di Whitehead
Se si considerano gli anni in cui Paci scrive su Whitehead, ossiasostanzialmente gli anni Cinquanta del secolo scorso, il primoaspetto che uno studioso del pensiero di Whitehead deve notare èil fatto che Paci si sofferma in modo autonomo e maturo su proble-matiche che, dopo un’iniziale apertura, saranno sostanzialmentetralasciate da parte degli interpreti anglosassoni, per riemergeresoltanto recentemente e comunque sempre sporadicamente. Paciscrive in anni che seguono di poco la morte del filosofo inglese,avvenuta nel 1947. In quell’epoca la ricezione e la stessa compren-sione del significato della posizione di Whitehead sono ancora ingestazione. In vita Whitehead ha avuto un destino filosofico pecu-liare, cioè quello di diventare estremamente noto per la sua parte-cipazione al progetto dei Principia Mathematica con il suo allievoBertrand Russell, salvo poi cadere in sospetto presso la comunitàfilosofica anglosassone, egemonizzata dai neo-positivisti, a causadella svolta metafisica operata con le opere del periodo americano.Questa vicenda produce l’effetto di oscurare sostanzialmente ilnome di Whitehead e di toglierlo dalla ribalta filosofica del tempo.
Quando poi, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, comin-ciano a comparire i primi studi organici sulla filosofia speculativawhiteheadiana,2 essi condizionano pesantemente la rappresenta-zione del pensiero di Whitehead e contribuiscono ad una ulterioremarginalizzazione. In un clima di divisione tra sostenitori del pri-mato della prassi e della necessità dell’impegno e cultori dell’ana-lisi linguistica a fini di terapia dalle patologie metafisiche, la stessaipotesi di una riflessione speculativa sulla realtà come totalità orga-nica e processuale non può che risultare sospetta e irricevibile.
Questa discorde concordia nei confronti del significato filosofi-co dell’opera di Whitehead non tocca Paci, il quale sa al contrariomettere a frutto i lavori fondamentali e pionieristici di V. Lowe,3trasfondendoli entro la propria ricerca che, in quegli anni, si muovein direzione di una comprensione non sostanzialistica della natura,nei confronti della quale il lavoro complessivo di Whiteheadapporta un contributo decisivo. Ma questa confluenza non sarebbeavvenuta se Paci non avesse avuto una sua propria esigenza specu-lativa, cioè il problema di una comprensione complessiva del signi-ficato filosofico del relazionismo, che si specifica in lui in unapproccio di tipo processuale e temporale. Tempo e relazione sonoperciò per Paci non termini di una prospettiva che egli apprenda da108
Luca Vanzago
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 108 (Nero/Process Black pellicola)
Whitehead, ma problemi generali che trovano nella ricerca filosofi-ca whiteheadiana una articolazione insuperata e con la quale farenecessariamente in conti.
L’avvicinamento di Paci a Whitehead è complesso e articolato, esicuramente non specialistico nel senso deteriore del termine: Pacipunta ad una visione filosofica complessiva in cui la varietà di temie la pluralità di approcci presenti nel pensiero di Whitehead trovila sua adeguata espressione e il suo giusto riconoscimento. Nella“Presentazione di Whitehead”4 non deve ad esempio essere trascu-rato il modo con cui Paci dà una raffigurazione quasi “proustiana”di Whitehead che però al contempo non si riduce a qualche trattoimpressionistico ma cerca subito il contatto con il tema fondamen-tale. Il quale tema potrebbe essere caratterizzato, con un’espressio-ne che in Paci ricorre poco in questo periodo ma è comunque pre-sente, come il progetto di una nuova estetica trascendentale, inquesta fase essenzialmente di tipo processuale e relazionistico, eche poi si evolverà in direzione della fenomenologia. Questo sensodell’estetica va naturalmente inteso nel suo significato più ampio: èil mondo del senso, ma anche dei sensi, delle affezioni,del piacere,dell’eros che si fa valore.
Ora, questo approccio trova un’immediata traduzione nellemodalità di analisi, raffronto e appropriazione della filosofia diWhitehead. Il mondo estetico è il mondo al di qua degli errori pro-dotti dalla “concretizzazione mal posta” di cu Whitehead parlanelle opere di filosofia della natura.5 Paci vede in questo tipo diprospettiva soprattutto una concezione critica della filosofia, checonsente di approntare uno sguardo impregiudicato e non “meta-fisico” sul reale.6
Questo modo di leggere Whitehead evidentemente non è ingiu-stificato, ma non è certamente quello prevalente tra gli studiosianglo-americani, per i quali vale invece soprattutto la portata meta-fisica della filosofia del processo. Neppure Paci nega puramente esemplicemente qualsiasi valore alla ricerca metafisica, in polemicacon l’atteggiamento sterilmente riduzionistico dei neo-positivisti.Ma la “metafisica” di cui Paci è sulle tracce si basa su di un ruolodecisivo della natura, che a sua volta è intesa come irreversibilità,resistenza alla totalizzazione del pensiero, superamento della pro-spettiva sistematica chiusa. Sono perciò elementi squisitamentefilosofici a muovere Paci e a indirizzarne la ricerca. In particolarequi si attua sicuramente lo sbocco di quel processo di fuoriuscitadall’idealismo che era già passato per la rilettura “esistenzialistica”
109
Paci e Whitehead
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 109 (Nero/Process Black pellicola)
di Platone, la critica di Croce e gli studi su Vico, e l’esistenzialismopositivo. Ma ciò non toglie che, come argomenterò più avanti, nelpercorrere questa strada filosofica Paci incontri delle tematiche diconfine tra la filosofia e le scienze che oggi riemergono in tutta laloro pregnanza e urgenza.
Paci si trova in questo snodo in ragione della sua concezionedella natura come processo a suo modo storico, che si riflette nella“naturalizzazione” della storia e porta al superamento della con-trapposizione tra scienze della natura e scienze dello spirito.Questa tesi è ampiamente argomentata in tutti i saggi di questianni, e se la lettura di Whitehead consegna a Paci uno strumenta-rio logico-epistemologico particolarmente efficace, essa si inscrivein un panorama ben più ampio. In Whitehead Paci trova in parti-colare una lucida critica al sostanzialismo come sistema logico-metafisico, e correlativamente l’analisi del concetto di relazionecome unica reale alternativa razionale a tale sistema. Whiteheadnon sostiene mai una qualche forma di primato dell’intuizione dicontro alla razionalità concettuale, come invece a volte capita divedere in Bergson. Al contrario, in Whitehead è per motivi logici,matematici ed epistemologici che al sostanzialismo va preferito ilrelazionismo. Ed è in questa prospettiva che la lettura di Paci risul-ta particolarmente originale ed autonoma, non soltanto se conside-rata nel contesto di quegli anni, ma perfino oggi. Si può sostenerecioè che l’elaborazione data da Paci al relazionismo non costituiscasoltanto un’esplicitazione delle tesi di Whitehead, ma anche un suosviluppo fecondo.
Paci enfatizza in modo molto netto la critica della concezionequantitativa della matematica presente nelle prime opere diWhitehead, che configura una apertura allo strutturalismo mate-matico (la prospettiva bourbakista inconsapevole di Whitehead,ossia una visione “universale” delle strutture matematiche chesarebbe stata elaborata dal gruppo Bourbaki soltanto vari decennidopo). Egli sottolinea il valore “metafisico” implicito di questericerche, considerando in particolare il ruolo delle geometrie noneuclidee e della topologia,7 l’analysis situs,8 il nesso strutturale spa-zio-tempo.9 Paci ne fa derivare anche una critica della concezioneassiomatico-deduttiva della filosofia e un’attenzione particolareper il ruolo dei modelli. La storicità dei modelli non significa rela-tivismo nichilistico ma l’unica reale apertura alla possibilità di unacomprensione più ampia della realtà.
In questo contesto trova il proprio significato la forte sottolinea-110
Luca Vanzago
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 110 (Nero/Process Black pellicola)
tura del peculiare ruolo dell’empiria. L’esistenza non è deducibiledalla logica. Questo è un motivo esistenzialistico reinterpretatorelazionisticamente. Come tale esso costituisce la connessione conle origini della filosofia di Paci e contrassegna tutti i suoi lavori suWhitehead, sia quelli sul primo periodo che quelli sulla filosofiaspeculativa. Di qui si giunge al superamento della concezioneverofunzionale della filosofia e all’apertura all’indeterminazione,al processo, alla problematica dell’entropia, alla probabilità, all’ir-reversibilità. Il grande sviluppo di questa concezione si attua neidue libri di questi anni, Tempo e relazione e Dall’esistenzialismo alrelazionismo.
Ma prima di passare ad una più ravvicinata discussione di que-sti aspetti, va anche ricordato un altro tema fondamentale per Paci:il ruolo dell’ideale, inteso come un eros naturale, una tensioneverso la bellezza che Whitehead ha sottolineato ripetutamentenelle sue opere più tarde.10 La connessione tra questi due aspettidella filosofia di Whitehead non è evidente e si presta ad equivocie banalizzazioni “new age”. Ma non sorprende la particolareattenzione portata da Paci a tale nesso, che in fondo non fa cheesplicitare il senso delle intuizioni platoniche a suo tempo indica-te nell’opera giovanile. Il problema è di saper coniugare rigorosa-mente il concetto e il valore. Per valutare il modo con cui Paci hatrattato tale problema si può allora compiere una traversata delleopere relazionistiche.
Il relazionismo di Paci e le sue origini whiteheadiane
Tempo e relazione si apre con la programmatica critica del prin-cipio di identità aristotelico, critica intesa come necessaria opera-zione di fondazione e base logica dell’irreversibilità. Paci istituisceuna proporzione: il principio di identità sta al meccanicismo comeil principio di relazione sta all’organicismo, cioè alla filosofia delprocesso irreversibile.11 Qual è il significato filosofico di questatesi dell’irreversibilità come cifra della propria posizione?Certamente essa assume una valenza molto ampia, più ampia chenon in un’accezione esclusivamente scientifica. Per Paci l’irreversi-bilità vale innanzi tutto come rottura del mondo chiuso, sistemati-co, senza storia. È in questa connessione che Paci introduce la filo-sofia di Whitehead come filosofia trascendentale del processo.12
Questa mossa implica degli effetti cruciali che Paci lucidamente111
Paci e Whitehead
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 111 (Nero/Process Black pellicola)
indica immediatamente ma che poi devono essere sviluppaticoerentemente in un lavoro di analisi critica. In particolare, Paci sisofferma sul rifiuto della sostanzializzazione dell’io13 e sullanecessità di una filosofia pluralistica rispetto a cui quella diWhitehead funge da esempio.14
Il sostanzialismo quindi è subito inteso da Paci in tutta la suaampiezza e non concerne soltanto, come invece accade in areaanglo-americana, la “realtà esterna”. Il concetto di evento inWhitehead è la nozione chiave per la critica del sostanzialismo,15
ma tale concetto va connesso col tema della possibilità16 e con lacritica della versione idealistica della filosofia della relazione.17
Paci introduce qui, per poi sviluppare più avanti, una considera-zione sull’importanza della statistica e sul ruolo dell’osservatoreper una prospettiva indeterministica.18 Si delinea così anche ilproblema dello statuto della soggettività in un’ottica processuale-relazionistica.
In connessione con quest’ultima questione è molto importanteosservare come Paci declini subito in modo peculiare tale proble-ma. Di contro all’interpretazione “ottimistica” e tutto sommatoingenua che prevale in area americana, dove la questione concer-nente lo statuto della soggettività non emerge che in data recente esenza nessi con la riflessione filosofica novecentesca, in Paci sifanno sentire le influenze esistenzialistiche che caratterizzano losfondo della sua riflessione: in particolare il problema del rappor-to tra angoscia dell’io e il concetto di relazione. La relazione è mol-teplicità, possibilità, scelta, e quindi angoscia e tentativo di rifugionell’irrelativo.19 Paci abbozza anche una possibile relazione conFreud, che andrebbe certamente sviluppata.20 Qui si può al propo-sito soltanto notare un possibile problema: in questa ottica proces-suale va posto il tema dello statuto della ripetizione, che non paresufficientemente analizzata o forse sottostimata. È però vero cheper Paci la relazione è sempre, soprattutto, possibilità nel senso dinon-necessità, e quindi libertà.21
In ogni caso l’acquisizione che mi pare più rilevante è quella diuna concezione dell’individualità non come sostanza ma come pro-cesso e compito.22 Sicuramente si fanno qui sentire ascendenze hei-deggeriane, ma in realtà Paci si muove già al di là dell’esistenziali-smo, in direzione di una filosofia della vita come equilibrio dinami-co tra forze opposte.23 Un ruolo fondamentale allora viene a gioca-re la nuova fisica, che insegna che già la materia è ritmo e periodi-cità.24 Si pone perciò, da una parte, il problema di valutare l’impat-112
Luca Vanzago
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 112 (Nero/Process Black pellicola)
to di questa prospettiva sulla domanda fondamentale per la filoso-fia, cioè la questione del fondamento. E d’altra parte, in connessio-ne con la risposta trovata a questo primo, cruciale quesito, si trattaanche di valutare il senso filosofico delle ricerche scientifiche.
Per quanto riguarda il primo tema, Paci opera una critica nettadella filosofia fondazionale: il tempo non è fondamento. Anche laversione hegeliana del concetto di processo va rifiutata, così comequella logicistica.25 Unica costante logica del relazionismo è l’irre-versibilità (solo il passaggio non passa).26 Vale la pena di citare unpassaggio particolarmente istruttivo al proposito. Paci scrive:
La nostra posizione si differenzia nettamente da quella diRussell in quanto ammette che l’enunciato logico fondamentale,l’unica cosa che resta costante quando tutto il resto può mutare,non è altro che la direzione irreversibile della relazione. Il presup-porre che la costante logica fondamentale sia a priori è privo disignificato per la relazione irreversibile, in quanto essa è l’unicarelazione che può essere, insieme, logica e empirica.L’irreversibilità è l’esperienza perché è la logica dell’esperienzaed è la logica dell’esperienza perché è la necessaria e inviolabiledirezione del processo. È chiaro che in questa posizione lacostante logica fondamentale non potrà mai essere, come vuoleRussell, la tautologia, e, in sostanza, per le stesse ragioni per cuiil secondo principio della termodinamica non può essere ridot-to al primo.27
Ora, questa posizione teorica è cruciale per poter operare l’uni-ca, effettivamente realizzabile fondazione delle scienze senza ope-rare al contempo una prevaricazione filosofica di esse. È sulla basedi questa posizione che Paci può allora aprire la propria riflessionead una valutazione della cibernetica,28 e quindi mostrare come ilrelazionismo processuale si configuri come la prospettiva filosofi-ca adeguata alla comprensione delle prospettive aperte da questadisciplina, allora ai suoi primi passi. Con il che Paci ha prodotto unrisultato che soltanto oggi, con la terza fase, cosiddetta emergenti-stica, delle scienze cognitive, comincia a farsi strada nelle opere deiricercatori anglo-americani, e non per caso alla luce dell’incontrotra neuroscienze e fenomenologia merleau-pontyana.29 La ciberne-tica non è soltanto una disciplina scientifica tra le altre, perché essapone un problema fondamentale alla filosofia: quello del supera-mento dell’opposizione organismo/macchina,30 che le moderne
113
Paci e Whitehead
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 113 (Nero/Process Black pellicola)
biotecnologie stanno realizzando e che richiedono un pensieroall’altezza della situazione. Tale pensiero deve abbandonare le cate-gorie “sostanzialistiche” ereditate dalla tradizione e aprirsi allasfida concettuale che lo sviluppo tecnologico pone. Paci aveva giàindicato chiaramente alla metà degli anni Cinquanta alcuni deicapisaldi teorici di tale questione: in TR, come si è detto, dove inparticolare sono messi in luce i temi della retroazione e del rappor-to tra qualità e quantità, che prefigurano le concezioni contempo-ranee soprattutto nella fisica dei processi complessi e nella biolo-gia; il nesso tra irreversibilità, processo e scambio; lo sviluppo vistocome progressiva stabilizzazione rispetto all’ambiente;31 il fonda-mentale ruolo del concetto di libertà “condizionata”, ossia dellecondizioni di libertà come problema generale di una filosofia pro-cessuale del campo. Ma l’intera problematica è poi ripresa e appro-fondita nell’opera successiva, Dall’esistenzialismo al relazionismo, cheriparte da dove la precedente si era conclusa e pone alcune doman-de teoriche fondamentali.
3. Processo relazionistico ed emergenza della soggettività
In ER Paci pone una serie di questioni la cui ricchezza e com-plessità non possono certo essere esaurite in questo spazio. Milimiterò pertanto a discutere un solo aspetto di quanto si trova inquest’opera, che ritengo però decisivo: quello dell’emergenza diuna soggettività dalla e nella natura, cioè una soggettività non anti-naturale.
Paci inquadra immediatamente tale tematica entro una prospet-tiva che rispetti l’esigenza di uno sguardo plurale ma non disperso:un’enciclopedia filosofica aperta, segnata dal rifiuto per qualsiasisistema chiuso (anche quello che per certi aspetti contraddistinguela posizione di Kant).32 In quest’ottica ritornano i temi, già elabora-ti in TR, dell’entropia e della dissipazione, ma anche l’importanteintuizione della tematica dell’emergenza di fenomeni complessi.33
All’interno di questa ottica, l’individuazione soggettiva può esserecompresa come finitizzazione mai compiuta dell’infinito.34 Il rela-zionismo allora si presenta come rinnovato umanismo ma noncome antropomorfismo,35 il che consente una reimpostazione delproblema dei valori.36
A questo punto viene introdotta la considerazione del ruolo fon-damentale della natura come impossibilità della chiusura sistema-114
Luca Vanzago
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 114 (Nero/Process Black pellicola)
tica (secondo l’eredità vichiana di Paci).37 La temporalità dellanatura è intrinseca alla processualità storica.38 Questo modo diconsiderare la temporalità consente di superare la contrapposizio-ne di natura e storia in vista di una prospettiva unificata anche senon astrattamente sincretistica. Sono emergenza e permanenza acostituire i due assi centrali del processo storico-naturale. Qui si fasentire chiaramente l’ascendenza di Whitehead: l’evento è sintesi diemergenza e permanenza, quindi scelta. La causa diventa genesi.39
La causalità così ricompresa, cioè come incidenza della struttu-ra di campo sull’evenienza processuale, che ne guida le direttricisenza predeterminarle in modo meccanicamente assoluto, faposto ad un ruolo della nozione di istante (secondo una ascen-denza platonica e poi kierkegaardiana) come sintesi di passato epresente nell’apertura al futuro. L’evento di Whitehead è letto inquesta prospettiva, cioè sviluppando le analisi effettivamentecompiute da Whitehead in una direzione per certi versi inedita. Inparticolare, non più soltanto whiteheadiana è l’idea che il fonda-mento non sia autogenerazione ma eterogenerazione. Sta nelfuturo e non nel passato.40 Qui trova la sua realizzazione quellanozione di possibilità che viene dallo Heidegger di Essere e tempo,riletto in chiave naturalistico-processuale. E questo è anche unodei contributi più importanti della rilettura compiuta da Pacidella filosofia del processo.
È allora alla confluenza tra filosofia dell’esistenza e filosofia delprocesso che diventa possibile comprendere l’esperienza comebisogno, opacità, resistenza. Emerge in questo modo la “negativi-tà” della realtà processuale.41 L’esistenza viene vista come bisognoche produce consumo che richiede lavoro: questa è la temporalitàdella natura e dell’uomo naturale.42 Agli occhi di Paci ciò conduceal rovesciamento della filosofia classica nel relazionismo.43 Vale lapena di citare un passaggio particolarmente esplicito al proposito.Paci scrive:
È importante, e vorrei dire decisivo, rendersi conto che sia i mod-elli scientifici che il modello sintetico della filosofia, in tanto pos-sono assolvere la loro funzione, in quanto viene riconosciuta larealtà necessaria del processo temporale, quella realtà, dunque,per la quale, come sappiamo, valgono il principio di ragion suf-ficiente, il principio dell’irreversibilità, il principio di relatività.La metafisica classica si è rovesciata: il vero principio metafisiconon è l’ontologizzazione di una forma logica, l’essere che
115
Paci e Whitehead
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 115 (Nero/Process Black pellicola)
dovrebbe corrispondere al principio logico di identità, ma è,invece, la realtà del processo temporale, l’inevitabilità del con-sumo, l’entropia, l’impossibilità del moto perpetuo.44
Nelle pagine da cui è tratta questa citazione, Paci sta rileggen-do lo schematismo trascendentale kantiano alla luce della propriaprospettiva, per mostrare il senso che l’intuizione kantiana relati-va all’immaginazione, come arte segreta, può avere in un’ottica diricomprensione della soggettività entro la processualità emergen-te-permanente della natura.45 Come è noto, lo schematismo asse-gna alla temporalità un ruolo diverso e più ampio rispetto a quel-lo individuato nell’Estetica trascendentale. Paci si rifà a Kant persostenere che «di fatto è questa la realtà del tempo. Ciò che deltempo “permane”, in altre parole, è il suo consumarsi, l’inviolabi-lità dell’irreversibile. In tal modo potrebbe avere un senso la pro-posizione paradossale di Kant secondo la quale ciò che permane èproprio tutto ciò che muta. La necessità del mutare è la sua irre-versibilità: la sostanza come substrato delle modificazioni e dellepermanenze relative si risolve allora nell’irreversibilità, non inqualcosa di compiuto, in un permanere statico e sostanzializzato,ma in una realtà di fatto fondamentalmente di carattere negativo,in un consumo e, in ultima analisi, se il bisogno continua, in unbisogno che può essere soddisfatto o non soddisfatto.»46 L’interocapitolo sullo schematismo trascendentale kantiano è volto amostrare, attraverso una lunga riflessione sull’Analitica dei prin-cipi, come lì si attui una svolta che consente di portare la contin-genza empirica nel cuore delle categorie del pensiero trascenden-tale, attraverso una lettura contingentistica del principio di ragionsufficiente.47 Paci sostiene il contingentismo degli stessi a priori edelle forme come risposta al problema della permanenza nellaprospettiva processuale.48 Oppone un netto rifiuto della cesura traintuizione sensibile e comprensione intellettuale. Offre elementiper una nuova estetica trascendentale alla luce del ruolo dellaragion sufficiente. Ne deriva una interpretazione processuale manon hegeliana delle categorie.49 Illustra il ruolo della logica moda-le in questa prospettiva.50
La conclusione delle analisi di quest’opera è anche l’aperturaagli sviluppi successivi della meditazione di Paci: essa consistenella delineazione di una concezione della natura che si fa immagi-ne operando inconsciamente,51 prospettiva elaborata non seguen-do suggestioni neo-schellinghiane, ma operando una commistione116
Luca Vanzago
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 116 (Nero/Process Black pellicola)
tra schematismo kantiano e Lebenswelt husserliana. Il ruolo piùimportante in questo quadro viene assunto dalla nozione di Gestaltcome Gestaltung,52 cioè come processo di figurazione. Il che con-sente una reinterpretazione dell’intenzionalità in chiave di prassivitale e di eros:53 una prospettiva che oggi riemerge in alcuni stu-diosi di Husserl e di fenomenologia post-husserliana.54 La conce-zione elaborata da Paci della soggettività come struttura emergen-te all’interno della processualità naturale e come interazione sem-bra così offrire notevoli elementi di elaborazione filosofica per l’at-tuale problematica relativa alla naturalizzazione della coscienza eanche per la questione della “natura” umana in connessione con larivoluzione bio-tecnologica.55
Note al testo
* Il testo compare originariamente in Materiali di Estetica, n. 13, Cuem,Milano.1. Peraltro, come è noto, la prospettiva relazionistica non deriva a Paci daWhitehead ma dal suo iniziale lavoro su Platone, a cui poi le ricerche sullafilosofia dell’organismo apportano un contributo sostanziale ma nonesclusivo. I testi su cui baso questa ricostruzione sono innanzi tutto isaggi, pubblicati su varie riviste, dedicati al pensiero di Whitehead; insecondo luogo le opere più esplicitamente relazionistiche, come Tempo erelazione, Taylor, Torino 1954 (d’ora in avanti citato come TR) eDall’esistenzialismo al relazionismo, D’Anna, Messina-Firenze 1957 (d’ora inpoi citato come ER). Mi sono potuto molto giovare, per il primo periododella riflessione filosofica di Paci, del lavoro di Amedeo Vigorelli,L’esistenzialismo positivo di E. Paci, Franco Angeli, Milano 1987 e dell’intro-duzione di Carlo Sini al Significato del Parmenide nella filosofia di Platone,Bompiani, Milano 1989. Importanti considerazioni sulle tematiche quiaffrontate e in generale sul pensiero di Paci si trovano nella tesi di laurea,inedita, di Alessandro Sardi (relatore Carlo Sini, correlatore AmedeoVigorelli): Enzo Paci: dal relazionismo alla fenomenologia (a.a. 2002-03). Lasezione dedicata a Paci del lavoro di F. Papi, Vita e filosofia, Guerini e asso-ciati, Milano 1990, offre una suggestiva interpretazione complessiva delsignificato filosofico del suo pensiero.2. I due lavori monografici che uscirono a distanza di breve tempo e cheinfluenzarono profondamente gli studiosi di Whitehead sono quelli di I.Leclerc, Whitehead’s Metaphysics, George Allen & Unwin, London 1958 e diW. Christian, An Interpretation of Whitehead’s Metaphysics, Yale UniversityPress, New Haven (Conn.) 1959. In entrambi, al di là della diversa inter-
117
Paci e Whitehead
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 117 (Nero/Process Black pellicola)
pretazione data alla metafisica di Whitehead, si sostiene essenzialmenteche essa non dipende dai lavori matematici ed epistemologici iniziali.Questa cesura tra il Whitehead matematico e il Whitehead filosofo specu-lativo ripete e inverte il giudizio dato dai neo-positivisti, e fornendo aglistudiosi una chiave di lettura favorevole della metafisica consente loro dinon doversi più occupare delle ricerche matematiche, logiche e di filoso-fia della natura. Per quanto si siano dati ripetutamente sforzi di revisionedi questa immotivata e dannosa separazione, il “mainstream”, prevalen-temente americano, persevera tuttora nell’aderire a tale visione dualistica.Credo che questo sia uno dei motivi per cui Whitehead in America oggi èstudiato soprattutto come teologo.3. Gli studi di Lowe si caratterizzano per l’approccio continuistico nellavalutazione dello sviluppo del pensiero di Whitehead. Lowe, insieme a W.Mays che è anche uno studioso di fenomenologia, mette in risalto il signi-ficato filosofico essenziale dei lavori matematici (A Treatise on UniversalAlgebra), logico-epistemologici (On Mathematical Concepts of the MaterialWorld, La théorie rélationniste de l’espace, Anatomy of Some Scientific Ideas) edi filosofia della natura(An Enquiry Concernine the Principles of NaturalKnowledge, concepì of Nature, The Principe of Relatività) che Whitehead pub-blica in un arco molto ampio della sua vita professionale, dal 1897 al 1922,e che preparano la svolta, o meglio la generalizzazione, delle opere spe-culative, ossia in particolare di Science and the Modern World e di Processand Reality. Di Lowe sono da vedere il suo contributo (The Development ofWhitehead’s Philosophy) alla Philosophy of A.N. Whitehead curata da P. A.Schilpp, (Open Court, La Salle (Ill.) 1941, second edition 1951), che Pacicita ripetutamente, e poi l’importante monografia UnderstandingWhitehead, Johns Hopkins University Press, Baltimore (Md.) 1962, cheperò esce dopo la conclusione del periodo più strettamente whiteheadia-no di Paci.4. Se ne può vedere il testo ristampato con il titolo Il significato di Whiteheadin Relazioni e significati II, Lampugnani Nigri, Milano 1966, pp. 28-39. Iltesto risale al 1952.5. In particolare The Concept of Nature ma poi anche Science and theModern World.6. Cfr. Definizione e funzione della filosofia speculativa in Whitehead, Giornalecritico della filosofia italiana, 1953, pp. 304-334.7. Definizione e funzione, cit., p. 405.8. Ibidem, p. 406.9. Ibidem, p. 407. Cfr. anche Prospettive empiristiche e relazionistiche nelWhitehead prespeculativo, Aut Aut 16, 1953, pp. 279-297, in particolare pp.281 e seguenti.10. Si veda la conclusione del saggio Definizione e funzione della filosofia
118
Luca Vanzago
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 118 (Nero/Process Black pellicola)
speculativa in Whitehead, cit., che si riferisce in particolare a Process andReality e a Adventures of Ideas.11. Cfr. TR 3.12. Cfr. TR 14.13. Cfr. TR 20-21.14. Cfr. TR 33-34.15. Cfr. TR 35.16. Cfr. TR 38-39.17. Cfr. TR 41.18. Cfr. TR 41-42 e 108-110.19. Cfr. TR 47 e seguenti.20. Cfr. TR 52. Si veda anche TR 92 e seguenti.21. Cfr. TR 111 e seguenti, in particolare 119-120.22. Cfr. TR 54.23. Cfr. TR 96.24. Cfr. TR 97. Si deve notare che anche M. Merleau-Ponty avvia in queglianni una riflessione sulla natura, in cui però il ruolo della filosofia diWhitehead, pur presente, appare di minore portata, ma che mostra carat-teri per più aspetti affini a quelli della posizione di Paci. Questa vicinan-za sia temporale che tematica tra i due filosofi dovrebbe a mio parere esse-re approfondita. Di Merleau-Ponty su questo tema si veda La natura.Lezioni al Collège de France, trad. it. a cura di M. Carbone, Raffaello Cortina,Milano 1996.25. Cfr. TR 237-9.26. Cfr. TR 259.27. TR 259. I corsivi sono di Paci.28. Cfr. TR 264.29. Qui non posso entrare nei dettagli. Si veda innanzi tutto il dibattito traalcuni dei più importanti ricercatori operanti attualmente, racchiuso inNaturalizing Phenomenology. Issues in Contemporary Phenomenology andCognitive Science, edited by J. Petitot, F. Varela, B. Pachoud, J.-M. Roy,Stanford U.P., Stanford (Ca.) 1999. Ho sviluppato alcune considerazioni, acui mi permetto di rinviare, sul problema di una fenomenologia dellanatura e dello statuto della soggettività in connessione con tale problema-tica in La fenomenologia della natura. Prospettive husserliane e sviluppi contem-poranei, Oltrecorrente 11, Mimesis, Milano 2005.30. Su cui cfr. TR 284-9 per le prefigurazioni compiute da Paci.31. Cfr. TR 299.32. Cfr. ER 22.33. Cfr. ER 25.34. Cfr. ER 30.35. Cfr. ER 37.
119
Paci e Whitehead
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 119 (Nero/Process Black pellicola)
36. Cfr. ER 41.37. Cfr. ER 47.38. Cfr. ER 48.39. Sulla scelta cfr. ER 50, sulla trasformazione della causalità meccanici-stica in genesi ER 51. Whitehead ha elaborato questa prospettiva in modosistematico nella terza parte di Process and Reality.40. Cfr. ER 62-64.41. Cfr. ER 81.42. Cfr. ER 155.43. Cfr. ER 169.44. ER 169. Il corsivo è di Paci.45. Cfr. in particolare ER 182.46. Cfr. ER 197.47. Di contro, si potrebbe osservare, a certi sviluppi dati da Heidegger allatematica, che infatti portano verso una concezione della tecnica lontanada quella qui elaborata da Paci, con tutte le conseguenze per la compren-sione del nesso tecnica-soggettività. Cfr. ER 200-201 e 210-14.48. Cfr. ER 219-221.49. Cfr. ER 222-23.50. Cfr. ER 224 e seguenti.51. Cfr. ER 361-2.52. Cfr. ER 364.53. Cfr. ER 364-5.54. Si vedano ad esempio i contributi di R. Barbaras e di R. Bernet alnumero 324 (novembre-dicembre 2004) di Aut-Aut, nella sezione dedica-ta a “Percezione e fenomenologia”.55. Si vedano, su quest'ultimo tema, le importanti considerazioni di M. DeCarolis svolte in La vita nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, BollatiBoringhieri, Torino 2004.
120
Luca Vanzago
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 120 (Nero/Process Black pellicola)
GUIDO DAVIDE NERI
PACI E MERLEAU-PONTYUna testimonianza e qualche riflessione*
N egli anni l955-l957 ho seguito i corsi di Enzo Paciall’Università di Pavia e ho potuto assistere da vicino all’inizio diquel suo profondo coinvolgimento nel movimento fenomenologi-co che avrebbe in seguito lasciato delle tracce importanti nella vitaculturale italiana. Venivo dall’Università di Milano, dove intorno aBanfi e Dal Pra si stava coagulando un gruppo di allievi (l’ultimadelle generazioni banfiane) che sarebbero poi stati tra i primi allie-vi milanesi dello stesso Paci.
Paci viveva uno dei momenti più intensi e fertili della sua attivi-tà filosofica1. Le lezioni che ascoltavamo si depositavano, proprioin quegli anni, in una serie di testi di grande spessore: la filosofiapresocratica, lo schematismo kantiano, la visione panoramica delpensiero contemporaneo. In un contesto di interessi così ampio earticolato si inseriva la ripresa della fenomenologia husserliana.
Si trattava, appunto, di una ripresa. Di Husserl, che il suo (eanche mio) maestro Antonio Banfi aveva fatto conoscere perprimo in Italia, Paci si era già occupato fin dagli anni Trenta. Conspirito simpatetico, ma anche con distacco. L’intransigenza razio-nalistica di Husserl, la sua concezione della filosofia come “scien-za rigorosa”, legittimava agli occhi di Paci la “fatale reazione”heideggeriana, generando l’esistenzialismo dal seno stesso dellafenomenologia2. Un’analoga motivazione era alla base della suapresa di distanza, in quegli anni, dal razionalismo trascendentaledi Banfi. Ma ora, verso la metà degli anni Cinquanta, la rilettura
121
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 121 (Nero/Process Black pellicola)
di Husserl avveniva in una nuova chiave. Al centro non era più il“disperato razionalismo” del fondatore della fenomenologia: ilfuoco della rilettura era diventato il “mondo della vita” e la criti-ca dell’obiettivismo moderno condotta nelle pagine della Crisidelle scienze europee. Il senso dell’intera fenomenologia husserlia-na gli appariva trasformato.
Lo stimolo decisivo verso questa nuova interpretazione, per Pacisempre più appassionante, del pensiero di Husserl, veniva daMerleau-Ponty. Aggiornando, nel l956, un suo scritto divulgativosull’esistenzialismo, Paci scriveva che questa filosofia aveva ormaiacquistato “un carattere decisamente fenomenologico conMerleau-Ponty, il quale da un lato ci riconduce a una più positivavalutazione dell’eredità filosofica di Husserl e dall’altro caratteriz-za l’esistenzialismo come una filosofia della relazione”3.Relazionismo era il nome e la sostanza della filosofia maturata daPaci in quegli anni, in stretto rapporto con l’organicismo diWhitehead, cioè con “una filosofia del processo organico, fondatosulla realtà ineliminabile del tempo e sulla interdipendenza deglieventi”4. Citando la Fenomenologia della percezione (“je devrais direqu’on perçoit en moi et non pas que je perçois”) Paci scriveva: “Ilmondo si percepisce in me perchè il suo livello si differenzia, si tra-scende, in me si apre, perchè il processo del mondo in me emerge.”Così Paci integrava la percezione di Merleau-Ponty e la Lebensweltdi Husserl in una vasta concezione naturalistica, per la quale per-cepire significava “sentire il consumo del processo cosmico”, “larealtà cosmica che preme nella percezione come bisogno ed esigen-za di soddisfazione e di lavoro”5. E anche nell’Introduzione alla edi-zione italiana dell’Elogio della filosofia ribadiva l’affinità tra l’”orga-nicismo” di Merleau-Ponty e quello di Whitehead6. Per questa viaPaci trovava in Merleau-Ponty motivi di grande affinità col propriopensiero, anche se non di totale identificazione. Rileggeva intensa-mente la Fenomenologia della percezione, che nelle lezioni di Paviaritornava con insistenza, magari nel contesto dell’interpretazionedella critica kantiana.
Come è noto, i testi destinati a diventare canonici per la nuovalettura di Husserl - in primo luogo la III parte della Crisi, ma ancheIdee II e altri - erano rimasti a lungo inediti. Fin dagli anni di guer-ra, tuttavia, pochi appassionati avevano potuto consultarli pressogli archivi di Lovanio. Tra questi Merleau-Ponty, che partendodalla centralità del discorso sul Leib era stato motivato a mettereHusserl in contrasto con il suo idealismo, fino a sviluppare quella122
Guido Davide Neri
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 122 (Nero/Process Black pellicola)
versione esistenzialista della fenomenologia in cui anche Paci“riconobbe ciò che attendeva” (per usare un’espressione dell’Elogiodella filosofia). Anzi, Paci radicalizzava il punto di vista di Merleau-Ponty, arrivando ormai a considerare Husserl “più esistenzialistadi Heidegger”7.
Agli occhi di chi, come me, veniva dalla lettura di Idee I e dallanotevole ma ormai stagionata interpretazione banfiana, ne uscivaun’immagine della fenomenologia completamente trasfigurata, atutta prima quasi irriconoscibile, sia nel senso che alla coscienzapura husserliana subentrava la nuova soggettività incarnata, gra-vata di tutta la passività e l’opacità della percezione corporea, siaper le suggestioni cui la versatilità culturale di Paci apriva in dire-zione della psicoanalisi, della letteratura e delle varie forme dell’ar-te contemporanea. La fenomenologia diventava veramente ancheper Paci - e secondo uno stile del tutto originale - quel movimentoche “è in cammino da molto tempo”, che i suoi discepoli “ritrova-no ovunque, certamente in Hegel e in Kierkegaard, ma anche inMarx, Nietzsche e Freud” e che “si confonde con lo sforzo del pen-siero moderno”8.
Attraverso Merleau-Ponty Paci si ricollegava indirettamente aquella profonda svolta cui la fenomenologia era andata incontronel periodo di Friburgo, con il passaggio delle consegne traHusserl e Heidegger. Benché Paci abbia sempre manifestato indi-sponibilità per gli sviluppi di quello che chiamava l’”ontologi-smo” heideggeriano, non c’è dubbio che la matrice della nuovainterpretazione husserliana risalisse a quell’ascendente.Nonostante l’autonomia sempre maggiore che le posizioni diHeidegger avevano preso dal pensiero di Husserl, la continuitàdel movimento era stata garantita da alcuni allievi di entrambi,come Eugen Fink. Nel corso degli anni Trenta Fink aveva mante-nuto viva la mediazione tra le due filosofie, verso la fine deldecennio consegnando una versione del pensiero di Husserl cheandava dichiaratamente al di là delle sue intenzioni originarie,anche se sulla strada da lui tracciata. Lo stesso Merleau-Pontyaveva tratto il massimo frutto da questa mediazione, durante glianni della guerra e le sue visite a Lovanio9.
Il rapporto tra Paci e Merleau-Ponty mi fa pensare anche a unaltro tema, quello della storia e di quel presente storico che era rap-presentato in tutti quegli anni dalla guerra fredda e dal confronto-scontro tra i due “massimi sistemi”.
Il periodo che si apre con la fine della seconda guerra mondiale123
Paci e Merleau-Ponty
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 123 (Nero/Process Black pellicola)
è stato caratterizzato in filosofia, soprattutto in Italia e in Francia -oltre naturalmente ai paesi “oltre cortina” - da una presenza con-dizionante del marxismo nelle sue diverse correnti. Fin dagli annidi guerra Banfi aveva innestato la propria decisione per il comuni-smo sull’impianto razionalistico del suo pensiero degli anni Trenta.A Milano si era formato così un ambiente filosofico-politico netta-mente dominato dalla figura di Banfi e dal suo orientamento poli-tico-culturale. Ma la scelta partitica aveva convinto solo limitata-mente i suoi più anziani allievi, che infatti ne presero prima o poile distanze. Paci era stato il primo e più deciso contestatore dellascelta comunista di Banfi, che considerava come un salto irraziona-le e come il frutto di un ottimismo storico scarsamente credibile10.Penso che Merleau-Ponty, con la sua travagliata esperienza del“marxismo d’attesa” e poi con la definitiva presa di distanza dalmovimento negli anni Cinquanta, dovesse riuscirgli convincenteanche per quanto si riferiva alla dialettica storica del presente. APavia, quando se ne parlava indugiando sotto gli antichi porticidell’università, Paci era ancora nettamente polemico verso Banfi eil suo “salto” nel comunismo.
Contemporaneamente, tuttavia, stava maturando proprio alloraquel processo che sarebbe continuato fino allo sbocco sessantotte-sco, con un ricambio generazionale. Con il XX congresso del Partitocomunista sovietico, la condanna dello stalinismo, il sorgere neipaesi socialisti di voci di marxisti dissidenti (che Paci fu semprepronto ad ascoltare), infine con Questions de méthode - testo in cuiSartre dipingeva il marxismo come la filosofia della nostra epoca -anche in Italia si delineava una nuova atmosfera di marxismo criti-co, aperto alle correnti filosofiche contemporanee. Ciò implicavaanche un rinnovato coinvolgimento nel movimento delle classisociali e una nuova analisi socio-politica, spesso in contrasto con lalinea culturale tenuta fino allora dal PCI. Con il suo arrivo all’uni-versità di Milano nel l957-58, Paci incontrava un’atmosfera giovani-le molto più dilatata e movimentata di quella che aveva conosciu-to a Pavia. Essendogli rimasto vicino per qualche anno come “assi-stente volontario”, credo di aver fatto un po’ da tramite - insieme aun altro allievo del periodo pavese: Renato Rozzi - tra Paci e alcu-ni ex allievi di Banfi (scomparso nel l957) ai quali se ne unironomolti nuovi. Per evitare elenchi che sarebbero necessariamenteincompleti, ne nomino uno solo, che non è più tra noi e che Paciaveva subito individuato per quell’essere straordinario che era:Enrico Filippini11. A lui affidò la traduzione di un vasto corpus hus-124
Guido Davide Neri
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 124 (Nero/Process Black pellicola)
serliano. Diversi altri allievi ben noti hanno continuato, ciascunosecondo un suo stile personale, l’impegno di Paci con la fenomeno-logia, completando la cura delle opere husserliane e di quelle diMerleau-Ponty12. In quegli anni si è formata intorno a Paci (e - miviene da aggiungere - intorno a Husserl e Merleau-Ponty) unacomunità di giovani fenomenologi (i “giovani amici”milanesiricordati nel Diario fenomenologico) che trovavano i loro interlocuto-ri ideali anche in Marx, nel giovane Lukács e in Sartre.
Per parte propria Paci, sempre estremamente ricettivo all’at-mosfera dei tempi, ricuperava il suo Marx, filosofo e teologo allarovescia, quello del feticismo delle merci, cercando le linee di con-tatto con Storia e coscienza di classe e - come dirò subito - con i ten-tativi (poi ridimensionati) di Merleau-Ponty all’epoca di Senso enon senso. (Tra le mie testimonanze che riguardano questo nuovocoinvolgimento di Paci, ricordo di avere assistito a Praga,nell’Istituto di filosofia presso il quale avevo soggiornato per unanno, alla sua conferenza su Il significato dell’uomo in Marx e inHusserl, alla presenza di Karel Kosik e di Jan Patocka, che assolsesplendidamente l’incarico di traduttore dal francese al ceco per ilpubblico presente).
Nel Diario fenomenologico, alla data 22 luglio l957, c’è un’annota-zione che si riferisce alla morte di Banfi. “Tutta la sua opera, da ora,cambia significato e sento che esige una nuova valutazione.” OraPaci se ne sentiva di nuovo erede, sia pure nella nuova versione cuimarxismo e fenomenologia stavano andando incontro. Con lanuova interpretazione - nel corso degli anni Sessanta e in parte deiSettanta - Paci riprendeva di fatto il tentativo già sperimentato daMerleau-Ponty di ripensare la prassi marxista alla luce della nozio-ne di esistenza. Si sottraeva invece alle conclusioni critiche verso ilmovimento comunista internazionale e la sua filosofia della storiacui lo stesso Merleau-Ponty era arrivato successivamente; conclu-sioni che - bisogna aggiungere - in quegli anni apparivano allamaggior parte di noi troppo pessimistiche. Sul terreno della politi-ca culturale era piuttosto Sartre a fungere da punto di riferimento,anche per i rapporti che si stavano stabilendo con un PCI che apri-va spiragli di rinnovamento.
Qui chiudo le mie testimonianze e le mie riflessioni. Voglio soloaggiungere che negli ultimi anni Paci, messo di fronte alle rinnova-te prove di chiusura e irriformabilità del movimento comunistainternazionale e alla stessa degenerazione del movimento sessan-tottesco in Italia, a cui aveva preso parte con grande entusiasmo e
125
Paci e Merleau-Ponty
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 125 (Nero/Process Black pellicola)
non senza una certa ingenuità “filosofica”, si sarà forse domanda-to se la sottovalutazione (almeno in linea di fatto) del Merleau-Ponty delle Avventure della dialettica, della sua diagnosi impietosadel movimento comunista e della sua concezione della storia nonfosse stato un passo troppo affrettato. Come Merleau-Ponty avevaanticipato nella Prefazione a Segni, l’epoca storica era sul punto dicambiare e di fatto il cambiamento si sarebbe fatto sentire già conla primavera di Praga e il suo affossamento, con la “Solidarnosz”polacca e con tutto quello che ne è seguito.
Note al testo
* Articolo riprodotto per gentile concessione della rivista Chiasmi interna-tional, sul cui n. 2 (2000) era originariamente comparso.1. Cfr. A. Vigorelli, L’esistenzialismo positivo di Enzo Paci. Una biografiaintellettuale (l929-l950), Milano, F.Angeli, l987. Le pagine introduttivedanno una visione d’insieme dell’opera di Paci nel contesto della filoso-fia italiana. 2. Cfr. E. Paci, Pensiero esistenza e valore, Milano-Messina, Principato, l940,pp. 30 sgg. 3. E. Paci, Ancora sull’esistenzialismo, Torino, Edizioni Radio Italiana, l956,pp. 5-6. Cfr. anche la Prefazione a Dall’esistenzialismo al relazionismo,Messina-Firenze, G. D’Anna, l957, pp. 5-6, dove Paci afferma che la suaprecedente concezione filosofica doveva correggersi “non solo per quan-to riguarda il concetto dell’essere, ma anche secondo un’interpretazionedi Husserl aderente agli ultimi scritti del grande filosofo e per molti aspet-ti assai vicina a quella di Merleau-Ponty di cui l’opera filosofica credo cheabbia una notevole importanza nel pensiero contemporaneo”. (Si vedanonello stesso volume i saggi Prospettive relazionistiche, Senso esistenza e natu-ra, Tempo e natura e altri. L’accendersi del nuovo interesse di Paci per lafenomenologia si può verificare anche dai contenuti delle tesi di laureadiscusse in quel periodo: una sola tesi su Merleau-Ponty nel l956 a Pavia;una serie consistente di tesi su Husserl, Merleau-Ponty ecc. a Milano dall959/60 (cfr. A. Civita, Bibliografia degli scritti di E. Paci, Firenze, La NuovaItalia, l983). 4. E. Paci, Dall’esistenzialismo al relazionismo, cit., p. l5.5. Le citazioni sono tratte da Dall’esistenzialismo al relazionismo, cit., rispet-tivamente alle pp. 358, 385 e 387. Il relazionismo di Paci implicava “uncerto naturalismo, una certa valutazione positiva del ‘naturale’ contro il‘non naturale’”, e “la tendenza del processo all’armonia” (cfr.Dall’esistenzialismo al relazionismo, cit., pp. 35-36), aspetti che Paci cercava126
Guido Davide Neri
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 126 (Nero/Process Black pellicola)
di leggere sia in Whitehead che in Merleau-Ponty.6. E. Paci, Introduzione a: M. Merleau-Ponty, Elogio della filosofia (a c. di E.Paci), Torino, Paravia, l958, pp. XVII-XVIII. In questo contesto Paci consta-ta la vicinanza tra i due pensatori nonostante che Merleau-Ponty non siriferisca mai a Whitehead. È interessante notare come in realtà Merleau-Ponty abbia manifestato notevole interesse per Whitehead nei corsi tenu-ti al Collège de France tra il l956 e il l960 e pubblicati in Francia solo nell995 (cfr. Merleau-Ponty, La natura, ed. it. a c. di M. Carbone, Milano,Cortina, l996, pp. l67-182)7. E. Paci, Introduzione citata a: M. Merleau-Ponty, Elogio della filosofia , p. XI. 8. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Milano, Il Saggiatore,l965, p. 16, cit. da Paci nell’Introduz. cit. all’Elogio della filosofia. 9. Cfr. i testi raccolti in E. Fink, Studien zur Phaenomenologie (l930-l939).10. Si vedano le pagine di diario di E. Paci, Colloqui con Banfi , in “Aut aut”,n. 214-215, l986, pp. 72-77 e sullo stesso numero G. D. Neri, Un confrontoteologico-politico tra Paci e Banfi. 11. Filippini, tra i primi a “ricordarsi” di Merleau-Ponty in Italia in un suoarticolo pubblicato su “Repubblica” il 20.5.l981, ha lasciato anche ungustoso Ricordo di Enzo Paci, in “Nuovi Argomenti”, luglio-settembre l986,pp. 114-124. 12. Nel presente contesto non posso non nominare almeno AndreaBonomi, per i suoi scritti su Merleau-Ponty e la cura delle sue opere.
127
Paci e Merleau-Ponty
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 127 (Nero/Process Black pellicola)
INTERVISTA AD ALFREDO MARINI(a cura di Massimiliano Cappuccio, Alessandro Sardi,
Erasmo Silvio Storace)
ENZO PACI, LA FENOMENOLOGIAE IL PENSIERO POLITICO
[Chora] Vorremmo chiederLe di parlare degli interessi di Paciverso la fenomenologia, anche in relazione all’esperienzaumana del Suo incontro con il filosofo di Monterado. Qualimotivi spinsero Enzo Paci ad avvicinarsi al metodo fenomenolo-gico e al progetto husserliano di fondazione di una scienza tra-scendentale dei vissuti di coscienza? Quali istanze filosofiche equale missione intellettuale spinsero Paci a prefiggersi diimportare la fenomenologia in Italia, mettendola a confrontocon correnti come il neo-idealismo e lo storicismo, che all’epocaerano nettamente più influenti?
[Marini] Risponderò liberamente seguendo un filo autobiografi-co della memoria, sperando di riuscire a rispondere direttamente oindirettamente alle vostre bellissime domande, che meriterebberodi esser sviluppate in modo sistematico.
Lei si chiede quali motivi abbiano spinto Paci ad approfondirelo studio della fenomenologia husserliana. Un motivo di fondo,credo, che coincideva con la sua stessa vita di filosofo. Paci era pro-fondamente impegnato a comprendere la filosofia contemporaneae aveva una percezione vivissima della presenza e attualità dellamatrice greca (particolarmente di quella platonica) del pensierooccidentale. La sua conoscenza della filosofia tedesca, e della feno-
129
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 129 (Nero/Process Black pellicola)
menologia in particolare, fu mediata da maestri importanti, comel’amato Antonio Banfi e la rispettata Sofia Vanni Rovighi. Del resto,al seguito della filosofia tedesca postkantiana, era impossibile sfug-gire alla suggestione di esplorare le radici stesse della nostra cultu-ra. Naturalmente il Banfi che Paci sempre amò non è stato quelloche nell’età d’oro di Achille Starace distraeva i giovani inquietidella “borghesia milanese anni ‘30” dal fascismo giovanilista,diportivo e dopolavoristico per coltivare la maliconia e la solitudi-ne di una romantica disperazione individuale, ma il Banfi deiPrincipi di una teoria della ragione: una sintesi in grande stile di quel-la che era stata la filosofia postkantiana di fine-secolo, la cuiimpronta “razionalista” liberava intorno a sé l’interesse e il pathosper una moralità, una pedagogia, un’estetica e una religiosità pro-blematicamente “autonome”. Rispetto a Croce o a Gentile, Banfioffriva una filosofia dello spirito da un lato più “critica” ma dall’al-tro anche più “irrazionalistica”. Paci e la scuola di Banfi produsse-ro filosofi assai brillanti, aperti all’esperienza e alla sua fenomeno-logia (e non amanti di un’astratta “sistematicità”, ma neppure di unmistico “concretismo”) del tutto paragonabili a filosofi come pote-vano essere, nella scuole idealistiche meridionali, gli Ugo Spirito oi Raffaello Franchini. Paci fu sempre molto interessato al fenomenodella decadentismo europeo, ma non fu mai incline a celebrare ladecadenza della ragione. Era guidato da un sicuro istinto raziona-le (era uno spiritualista moderato) e mentre demoliva la presunzionecalcificata di un razionalismo dogmatico, indicando un diritto ori-ginario delle passioni, del sentimento e della vitalità, tendeva adefinire uno spazio e un tenore concettuale della “razionalità” piùcritico ma anche più concreto, più rigoroso ma anche più ampiodella razionalità neokantiana. Anche in sede ideologica e politicaPaci, contrariamente alla scelta di Banfi a fine guerra, non avrebbemai abbracciato un’idea di prassi (e di rovesciamento della prassi)come “presente assoluto”, eroico e rivoluzionario perno delmondo, e meno che mai avrebbe affidato questa mistica vocazionealla burocrazia dello stalinismo (una burocrazia nella quale Lukacs– acquistato il suo “biglietto d’ingresso” al banchetto della nomen-klatura sovietica <così si esprime con estetizzante cinismo nellaprefazione alla tarda ristampa di Storia e coscienza di classe> – avevaidentificato “quella ragione”, la cui “distruzione” aveva poi lamen-tato nel libro della guerra fredda La distruzione della ragione).
Paci, che conosceva Dilthey e Weber, ritenne utile indicare nellafilosofia dello spirito di Croce una difficoltà teorica centrale che non130
Alfredo Marini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 130 (Nero/Process Black pellicola)
demoliva Croce ma lo arricchiva. Non trovò – viceversa! – chevalesse la pena di imporre alla “cosmicità” della categorie gentilia-ne una maggiore definizione e lasciò questa “via di ricerca”, percosì dire, al suo destino, preferendo estrarre elementi di razionali-tà da scrittori e artisti (come Marcel Proust, Thomas Mann o PietMondrian) che introdurne di nuovi nei filosofi.
Perché scoprì Husserl? Ma perché era negli anni ’50 un trendvistosissimo della filosofia europea, collegato alla edizione dellesue opere che partiva dalla sia pure discussa filologia di Lovanio.Banfi aveva letto Husserl col paraocchi marburghese e, – comeGeymonat negli anni Trenta aveva fatto per ragioni opposte (logi-ciste e non trascendentaliste) –, aveva frainteso come “intuizionisti-co” il metodo e il concetto della visione d’essenza. Banfi aveva lettoHusserl come ancora Sartre continuerà a intenderlo vent’annidopo, negli ultimi capitoli di L’Essere e il nulla. Paci lo comprendemeglio di Banfi e di Sartre, perché meglio di entrambi si distaccadal formalismo kantiano e capisce a fondo il senso materialista el’estensione trascendentalista della visione d’essenza (Wesensschau).Ma neppure Paci riesce a cogliere il senso della riduzione fenome-nologica, che concepiva all’incirca alla maniera (al secolo, la menopeggiore) di Merleau-Ponty, come un presa di distanza critica,mentre era in Husserl un residuo drammaticamente ineliminabiledel metodologismo scientifico moderno e neokantiano. Io penso,benché possa sembrare paradossale date le sue prese di posizioneesplicite contro Husserl (che considera uno psicologo), che l’unicoad aver meditato a fondo questo punto husserliano sia stato pro-prio Heidegger. Che non a caso Paci considerava invece un antro-pologo della necessità, del destino e della morte. Ma ahimé, diHeidegger, Paci aveva conosciuto a malapena Essere e tempo, comeuna falsificazione della fenomenologia (come del resto ancheHusserl lo aveva giudicato) e ritengo che non avesse percepito inmodo adeguato neppure il senso della differenza ontologica.Husserl faceva piazza pulita con semplice gesto geniale (che siespresse però in un lavoro da certosino durato lunghi decenni!) ditutte le antinomie “costitutive” della filosofia postkantiana, daquelle dialettiche, a quelle analitiche, a quelle metodologiche insenso stretto. Husserl era un profeta ebraico e la sua parola aprivaun’epoca nuova: ma quello che non si capiva, come non si capisceancor’oggi, è la dimensione possibile di questa nuova epoca (anchei primi discepoli del Cristo si aspettavano o che “tornasse” in gior-nata, o che gli si ritirasse la licenza di padreterno!).
131
Enzo Paci la fenomenologia e il pensiero politico
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 131 (Nero/Process Black pellicola)
Ho incontrato Paci in sede politica. In via della Cerva 25 (un’an-tica via che, sopravvissuta agli sventramenti fascisti, congiunge viaMascagni e Largo Augusto) c’era un vasto e luminoso seminterra-to in cui aveva la propria sede “Unità Popolare” e Paci ne facevaparte. Questo movimento d’opinione era nato nel 1953, per appog-giare l’opposizione parlamentare di sinistra, socialista e comunista(o, come per poco tempo ancora si dirà, “socialcomunista”) all’ul-timo governo De Gasperi, nella sua campagna contro la propostadi istituire un premio di maggioranza capace di garantire ai futurigoverni italiani una maggioranza sufficiente a governare per unalegislatura (evitando frequenti elezioni anticipate o il consolidarsidi prassi parlamentari di sottogoverno, come quella garantita piùtardi dai cosiddetti “franchi tiratori” che votavano in segreto con-tro la propria parte politica). Anche se i comunisti nel movimentoerano pochi, eravamo tutti “simpatizzanti” del Partito ComunistaItaliano di osservanza sovietica, l’unico che, non avendo per la fer-rea legge di Yalta alcuna possibilità di andare legalmente al gover-no in Italia e per altro verso, coltivando un’interpretazione non for-male ma materiale della democrazia, sapeva di non avere interesseal consolidamento “democratico-borghese” di questa classica isti-tuzione anglo-europea. Vi partecipavano una grande varietà dipersonaggi specialmente ex-azionisti, profughi di svariate micro-scissioni, più o meno pilotate, del Partito Socialista Italiano e distri-buiti in tutta Italia (si vedevano spesso il suo presidente, FerruccioParri, e uomini come Leopoldo Piccardi o Luciano Codignola ealtre personalità di grande notorietà e prestigio nella Milano deldopoguerra, sia per le loro posizioni che per la loro opera profes-sionale, come Paci, Camera, Giacomo Noventa, Riccardo Bauer(che operava nell’antica Istituzione socialista milanese della“Società Umanitaria”), Leo Valiani, Piero Caleffi (l’autore di Si fapresto a dire fame).
Io avevo sedici anni e frequentavo il Liceo “Parini”, gli altrierano tutti più più anziani, come Merzagora e Morganti, che eraun ghislieriano studente di ingegneria. Coi miei coetanei DiegoLanza e Mario Vegetti (liceali del “Berchet”), e spesso coi consiglidel più esperto Franco Morganti portavamo avanti in qualchemodo il “gruppo giovanile” di UP. Vi fu anche, nell’estate del 1954,un corso residenziale di informazione e discussione politica conuna trentina di partecipanti da tutta Italia (da Genova, Costantini;da Padova, Pincin, da Palermo Modica) che si tenne a Brunate l’e-state dell’anno del grande Congresso Internazionale di Ginevra132
Alfredo Marini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 132 (Nero/Process Black pellicola)
(ricordo il titolo che spuntava dalla tasca della giacca di Parri,quando sbucò fuori dalla Funicolare e lo accompagnammo allasede del corso, curiosi di cosa pensasse della situazione interna-zionale e della pace.
Ho frequentato quel “circolo”, credo fino alla sua chiusura. Perqualche anno della mia vita, e durante il ginnasio e il liceo, io eroquasi ogni sera qui, in centro, e giravo dall’una all’altra di questesedi di pubblico dibattito: dalla sede dei mazziniani del prof.Tramarollo, che organizzava anche dei concorsi con un tema dasvolgere tra i giovani delle scuole milanesi; a quella dei francesca-ni (la Rotonda dei Pellegrini dove ascoltai un interessante ciclosulla teologia dopo Kierkegaard); al Circolo Filologico (di viaFilodrammatici); alla Casa della Cultura di via Mascagni (doveparlava tutta la cultura politica “antifascista” e dove ascoltai alcu-ni interventi memorabili di Antonio Banfi sulla filosofia tedesca delprimo Novecento; di Norberto Bobbio sul “rapporto tra liberali-smo, democrazia, socialismo e comunismo”; di Enzo Paci e CesareCases sul nuovo libro di György Lukàcs, La distruzione della ragioneche Paci giudicò “un brutto libro” (ancor più memorabile la suaconferenza magistrale su Thomas Mann in contradditorio con unprofessore dell’Italia centrale di cui non ricordo il nome); a sedi piùlaiche e più politiciennes dove però si discuteva di teoria, di storiae di attualità politica e culturale (ricordo ancora un intervento delgiovane Paolo Calzini (oggi esperto di politica russa) allora, credo,repubblicano in difesa della democrazia: egli definì appassionata-mente comunque preferibile “questa difficile democrazia” (l’accentosulla parola “difficile” mi colpì molto, e confesso che mi sentivoassai fiero di essere d’accordo su una cosa così… difficile!).
Paci lo ricordo qualche anno più tardi con le persone che l’han-no conosciuto, come Fulvio Papi, il quale ha sviluppato in questiultimi vent’anni, anche con Sini, una moderna concezione filosofi-ca della “prassi”. Già Dal Pra aveva individuato molto bene questetematiche (nel suo stradimenticato “trascendentalismo della pras-si” che, da quell’uomo di spirito che era, non esibì mai e lasciòignorare alla pedestre amministrazione accademica alla quale,peraltro, si era dedicato): neppure lui si riferiva certo a Heideggerma, se mai, al giovane Marx. Nessuno aveva la minima idea diquella rivoluzionaria lettura fenomenologica heideggeriana diAristotele, che aveva colpito il mondo universitario tedesco deglianni ‘20/‘30, né si capiva nulla della sua descrizione della “mondi-tà”, come suonava la Weltlichkeit nella traduzione appena apparsa
133
Enzo Paci la fenomenologia e il pensiero politico
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 133 (Nero/Process Black pellicola)
di Sein und Zeit ad opera di Pietro Chiodi. E ancora lontani erano itempi della tedesca “Rehabilitierung” della filosofia pratica.
A dirla franca, se Remo Cantoni dovette stare attento a comeparlava (dopo la sua presa di posizione su Vittorini, il distacco daBanfi e la cessazione della rivista “Studi Filosofici”), così, e con unapunta di maggiore astio, si era creato una sorta di disprezzo neiriguardi di Paci, che era considerato “giallo”, perché comunistanon era mai stato e quel termine era tradizionalmente riservato ai“rifomisti” e ai “socialisti (specialmente in riferimento alle posizio-ni sindacali) o anche uno “sporco socialdemocratico” (frasi queste– intendiamoci – che hanno nome e cognome!). Tale era, presumi-bilmente, lo stato d’animo della media di coloro che andavano adascoltare Paci alla Casa della Cultura. Io ero allora molto “lenini-sta” e Paci mi guardava sgomento quando parlavo di politica consentimenti socialisti e argomenti leninisti, e forse capiva che miaspettavo da lui un nuovo linguaggio. Lì Paci parlava a un pubbli-co che era orientato non solo in senso anti-fascista e magari marxi-sta, ma soprattutto in senso comunista. E con questo termine inten-do riferirmi all’“egemonismo” gramsciano che allora diventava(con la pubblicazione, sia pure purgata, dei Quaderni del carcere)linguaggio corrente. Il senso autentico di “antifascismo”, “libertà”,“democrazia”, “socialdemocrazia”, “socialismo”, “verità”, “giusti-zia” e “moralità” era autentico solo se si dimostrava o almeno sisuggeriva che esso si “inverasse” (termine idealistico d’uso già piùche secolare) come “propriamente” comunista. Il giudizio politico-ideologico (in senso tanto più volgare, data la semplificazione arti-ficosa delle alternative italiane), gravava dunque in quegli anni sul-l’attività dell’insegnamento in maniera molto netta.
Se penso a Paci e alla sua parabola, essa finisce con e dentro la“contestazione” studentesca degli anni ‘60, subito sepolta daglianni di piombo. Nei suoi ultimi anni Paci tentava, con La funzionedelle scienze e il significato dell’uomo, di costruire un “marxismo occi-dentale”, allora si diceva così perché era ovvio che il marxismo oera “diamat” o non era. Per questo lato, egli si affiancava, anche sein modo più positivo e costruttivo, alle esperienze ormai classiche,ma anche classicamente fallimentari, della Scuola di Parigi col suoesistenzialismo borghese e marxismo antiborghese che si esprime-va anche come collateralismo (o “sputnikismo”!) insieme anti- efilo-sovietizzante. E qui Paci aveva trovato il suo corrispondentepiù affine nella posizione di Merleau-Ponty, di cui condivideva 1)la critica dell’“ultrabolscevismo” sartiano (più nevroticamente134
Alfredo Marini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 134 (Nero/Process Black pellicola)
antiborghese che sinceramente socialista) e, come ho accennato,anche 2) l’interpretazione dell’importo non radicale ma moderatodell’epoché-riduzione di Husserl!
Queste “filosofie” erano il “grido” di non poter essere e di nonpoter pensare ed erano appena scusabili nel Paesi dell’Est (nellaVarsavia di Adam Schaff e Leszek Kolakowski, nella Praga di Kosik,nella Zagabria della rivista “Praxis”), dove costituivano un eserciziosicuramente audace. Come disse con esattezza Sartre, e anche Banfi,nonostante il suo Uomo copernicano, lo sapeva benissimo, queste“filosofie” erano operazioni “ideologiche”, meri rompicapo intellet-tuali, all’interno di un ampio, epocale pregiudizio “marxista”.
Quello che non si voleva ammettere allora, e in Europa neppu-re ora, era ed è che l’altra metà del mondo occidentale, quella anglo-sassone, quella che aveva inventato il capitalismo, era tranquilla-mente immune da tale “epocale” pregiudizio teologico chedall’Uno plotiniano, all’Idea hegeliana era approdato alla Mercemarxiana e che, quindi, tutto questo lavorìo attendeva soltanto diessere spazzato via non da un approfondimento di pensiero, ecomunque non da un’esperienza di libertà (perché credevamo diessere in cima al mondo!) ma da una variante “tecnica”: i carriarmati di Breshev che da “oltre cortina” attendevano l’“ora X” emagari, qui da noi, gli “anni di piombo” (una “radicalità” quest’ul-tima che richiama come parente stretta quella del camerata Richarddi Giarabub: “camerata, non voglio pane / voglio il piombo del miomoschetto…”). Altrimenti non si spiegherebbe perché solo e pro-prio il crollo del muro di Berlino, abbia reso vergognosa anche lamemoria e il nome di quel passato e di quelle “passioni”. Questadifficoltà storica, e incarnata nel senso comune, ad ammettere i fattie a riconoscere la verità è certo legata, in Italia, a una mitologia del-l’impossibile che non ha eguali nella storia e che ha tolto agliItaliani il gusto della fede spontanea e del buon senso: dalla para-dossalità del credo cattolico (con l’estetismo della religione bella),al rovesciamento autoritario e deduttivo del giure romano (con labarbarie aggiuntiva delle leggi ad hoc), alla cancellazione radicaledel riscontro ebraico dovuta alla secolare e capillare assimilazioneromana (sconosciuta in Germania, in Polonia, in Russia).
Enzo Paci Le propose di realizzare una traduzione in italianode La fenomenologia della coscienza interna del tempo. Nel volu-me che ospita questa traduzione (pubblicato da Franco Angeli)sono compendiati anche molti altri testi husserliani sul tema
135
Enzo Paci la fenomenologia e il pensiero politico
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 135 (Nero/Process Black pellicola)
della temporalità, che coprono complessivamente un arco moltolungo della ricerca del padre della fenomenologia. Quale rile-vanza particolare assunse questo tema per Paci, e come venne dalui sviluppato? Intendiamo riferirci principalmente alla caratte-rizzazione di irreversibilità data da Paci alla temporalità, e cheforse consentiva a quest’ultima di essere tematizzata in chiaveesistenzialistica.
Paci trovò nella fenomenologia, nell’esistenzialismo e nello sto-ricismo marxista tre principali varianti di un sentimento profondodella sua personalità, che potremmo chiamare una nostalgia schil-leriana di incarnazione della filosofia e di illuminazione dellacarne, secondo lo schema classico e hölderliniano dell’eros e delladialettica platonica, ma col presente segnato dalla dissonanza dil-theyana, o dalla sigla kierkegaardiana dell’aut aut. Il suo tema per-manente dell’irreversibilità del tempo ha il doppio volto dell’entro-pia e dell’intenzionalità, che insieme descrivono il senso positivodella finitudine umana. Quella finitudine che ci rende amica e teo-reticamente trasparente sia la democrazia formale di Eschilo cheammette Atena nell’assemblea, sia la carità cristiana di Paolo che simagnifica nell’attesa della parousia.
Dal punto di vista teorico della filosofia politica Paci si affianca-va anche, e veniva facilmente accomunato, alla posizione di Sartre:anche lui aveva il problema di emendare lo schema organicista o diriformare la psicoanalisi “stalinista” di Freud (confinante con l’usodell’elettroshock e simili) in direzione di un tipo di psicoanalisi piùumana, più spiritualistica (per es. quella di C. G. Jung) e quindimoderata; e così anche di riformare il marxismo e in particolare ilmaterialismo dialettico tecnico e dittatoriale di derivazione lenini-sta (diamat) in direzione di un marxismo di tipo occidentale “dalvolto umano”. Dal punto di vista teoretico in senso stretto, invece,Paci viene fuori dalla grande lezione di Antonio Banfi versioneanni ‘20/ ’30 e dalla meditazione dell’esistenzialismo e della storici-smo europeo; e se “meditazione” significa accettazione e liberoapprofondimento, non distruzione polemica da posizioni precon-cette, Paci fu uno, certo il più grande, di quell’ampio gruppo diallievi che si formò allora sotto il magistero milanese di Banfi chein quell’epoca di chiusura civile e morale, in un eroismo mediaticoe posticcio, tenne alcuni corsi di lezioni (come quello sullo spinozi-smo romantico) che lasciarono il segno. E bisogna rileggere sul suoinsegnamento degli anni ’30, il saggio di Guido Davide Neri, suo136
Alfredo Marini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 136 (Nero/Process Black pellicola)
ultimo assistente a Milano, oltre all’ampio studio di Filvio Papi, cheè proprio una storia di quel gruppo (Paci, Cantoni, Preti,Formaggio, Anceschi, Faggin e molti altri). Fu una irradiazione cul-turale notevole. Banfi aveva una formazione kantiana ma anche difilosofia della religione. Portò in Italia un’impostazione totalmentediversa rispetto a quella dell’idealismo di Croce e Gentile. Quindiera una voce abbastanza atipica. Fu collega di Martinetti, che fondòqui quest’istituto ed era un neokantiamo anche lui, una persona digrande rilievo morale, teneva lezioni serali per chi usciva dal lavo-ro ed era molto seguito da operai e impiegati che passavano e lopreferivano alla radio del regime.
Paci cominciò con una tesi sul Parmenide di Platone che fu unaricostruzione dell’ontologia platonica e del suo “necessario parrici-dio” nei confronti del vecchio maestro di Magna Grecia: partivacon problemi e discussioni critiche che erano all’ordine del giornonegli anni ‘20 e ’30 (il testo di riferimento sui dialoghi platonicitardi è quello di J. Stenzel), ma il tema è quello della mobilitazionedelle idee, della diairesis e symplokè eidòn, e della dialettica deimisti (una tesi giudicata molto male da Adolfo Levi). Paci era ungrande professore anche perché era in grado di mostrare collega-menti inaspettati tra cose tra loro anche molto diverse: un’inclina-zione a collegamenti culturali di ampio respiro appresa alla scuoladi Banfi, al quale lo accomunò una concezione della vita della cul-tura come qualcosa di armonico, organico, poliedrico e libero. Unaconcezione della filosofia della cultura capace di dominare e coor-dinare campi fenomenologici diversi e insperati, una sorta di voca-zione regia di dominio e di aperta totalizzazione. Rilevante in que-sto senso l’idea di enciclopedia che concepì sotto forma fenomeno-logica, ma per questo bisogna aspettare il suo periodo husserliano:compie allora una serie di interessanti riflessioni teoriche che neiprimi anni del dopoguerra si depositano in alcuni libri che furonofondamentali per la mia generazione come ad esempioEsistenzialismo e storicismo, o il saggio su Vico Ingens sylva che misein un rapporto essenziale posizioni esistenzialistiche, marxiste eidealistiche, che erano quelle che andavano per la maggiore.
Lui lo fece rifacendosi all’orizzonte italiano e alla tradizionecrociana, che riprende, la critica e la sfronda di una serie di aspet-ti, con riferimento a Vico, da una serie di aspetti che lui preferiscechiamare dogmatici, che sono l’eredità della critica a Croce com-piuta da Banfi, dal primo Banfi, quello dei Principî di una teoriadella ragione, che risaliva a molto prima della guerra. Dopo la
137
Enzo Paci la fenomenologia e il pensiero politico
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 137 (Nero/Process Black pellicola)
guerra Banfi diventa marxista in senso proprio e anche senatoredel Pci e non è più seguito nel suo marxismo rigido, vicino a quel-lo stalinista luckaciano da nessuno degli allievi. Ad esempio,Giulio Preti che pure fu comunista e neopositivista (ma chiunquelegga i suoi studi sull’etica empiristica vi sentirà il segno fortissi-mo di una formazione umanistica di prima qualità) seguì unastrada completamente diversa.
In Esistenzialismo e storicismo Paci riscopriva che nelle quattrocategorie dello spirito crociano, la quarta, quella dell’economico odel vitale (di cui Croce andava fiero perché ogni sedia ha quattrogambe!) non era una categoria come le altre ma, come insegna lastruttura delle forme di produzione, in Marx o l’esistenza negli esi-stenzialisti, era qualcosa di “più” drammatico, quasi una indebitaipostasi della presenza della dialettica dei contrari in ogni formadistinta dello spirito. Anche nella filosofia dello spirito di Crocec’era questa drammaticità, riscontrabile nella dialettica degli oppo-sti, ma Croce chiudeva la dialettica degli opposti dentro ciascunodei distinti, i quali avevano poi tra loro anche una relazione dialet-tica, che non era quella violenta degli opposti, già intimamentedomati, ma di una dialetticità “diversa” e superiore, quella appun-to debole e fungibile dei distinti: una sorta di cooriginarietà che liavvicinava ai trascendentali scolastici. Circa la circolarità dellecategorie dello spirito, quella di Croce non era quella di Gentile,che restava hegeliano e che Banfi considerava teoreticamente piùrigoroso di Croce. Su questo punto sia Banfi che Paci criticaronoCroce: ma la critica di Paci era, almeno virtualmente, di segnoopposto rispetto a quella banfiana. Non si trattava di difendere ilnumero tre o il numero quattro, ma di capire il valore delle distin-zioni crociane, che non era puramente convenzionale, mentre ladistinzione tra dialettica degli opposti e dialettica dei distinti era labase stessa di una concezione liberale (e aggiungerei volentieri:democratica) della storia. Personalmente, considero i concetti diordine, che non sono concetti teoretici, un fatto metodologico la cuidignità non dev’essere considerata una défaillance teoretica.
Fu da Paci che ricevetti l’incarico di tradurre la Fenomenologiadella coscienza interna del tempo. Che verrà pubblicata dieci annidopo da Mario Dal Pra nella grande collana de La Nuova Italia,che la RCS ha poi mandato al macero. Fece allora il giro delmondo una battuta di Umberto Eco, persona spiritosa che si chie-deva, in sostanza, chi glie lo fa fare? (“Perché Paci si dà tanto dafare per difendere la causa di Husserl?”). Ma in effetti fu Paci a138
Alfredo Marini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 138 (Nero/Process Black pellicola)
scoprire Husserl in Italia. Tempo e verità è del ‘61, Tempo e relazionedel ‘54. “Relazionismo” è stata l’ultima parola prima che Paci,riempito di spirito fenomenologico, decidesse più impegnativisviluppi in partibus infidelium (voleva dimostrare ai cosiddettimarxisti quanto la fenomenologia potesse “giovare” anche aloro...). Finalità non propriamente filosofica, gli esiti (Funzionedelle scienze e significato dell’uomo) non furono molto brillanti. Dicoi “cosiddetti” marxisti per ragioni ovvie: da decenni in Italia nes-suno sembrò ricordarsi che, se come sognatore aveva sognato ilfantasma del comunismo, come pensatore e teorico Marx avevaindagato la realtà del capitalismo e del liberalismo. In Engels ave-vano coabitato un pensiero dialettico burocratico-speculativo euno spirito social-utopistico: due cose estranee a Marx. Non par-liamo di Lenin e della Terza internazionale: tutti i socialisti hannosempre saputo che se Carlo Marx, vissuto per metà della sua vitaal British Museum, fosse stato vivo nella Russia sovietica, il suoposto sarebbe stato in Siberia.
Enzo Paci intrattenne un dialogo diretto, lungo e intenso coni grandi pensatori della tradizione fenomenologica francese, ein particolare con Maurice Merleau-Ponty e con Jean-PaulSartre. In particolare è a quest’ultimo che talvolta viene parago-nata la sua figura di filosofo della cultura, soprattutto per il suoimpegno operato nella direzione di un avvicinamento dellafenomenologia e dell’esistenzialismo ai temi dell’impegnopolitico e alle dottrine marxiste. Vorremmo chiederle di appro-fondire per noi il legame che univa Paci a questa tradizione sar-triana, ma anche la distanza che lo separava da essa, eventual-mente raccontandoci quello che sa sul rapporto personale cheesisteva tra il filosofo teoretico di Milano e il maitre à penserParigino. E inoltre come possiamo collocare rispetto ad una ana-loga ricerca sartriana, la trattazione rivolta da Paci ai temi delnulla, del rapporto essere-esistere, dell’esserci come condizioneantropologica fondamentale?
L’esistenzialismo, schematizzando, è una visione del mondofondata sulla constatazione di qualcosa di irriducibile, che è l’esi-stenza rispetto alle relazioni: qualcosa di chiuso e compatto e irra-zionale, irriducibile come l’irreversibilità del tempo, che non si puòrecuperare. Ne deriva una situazione di degradazione dell’energiache Paci chiamava entropica e riconduceva al secondo principio
139
Enzo Paci la fenomenologia e il pensiero politico
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 139 (Nero/Process Black pellicola)
della termodinamica. Paci utilizzava questi aspetti ideali o di idea-zione globale contenuti in teoremi scientifici positivi precisi, tra-sformandoli in una sorta di segnaletica che serviva sulla strada diuna meditazione da percorrere.
Ora, la dissoluzione di questo nucleo esistenziale in un insiemedi relazioni, come dice il titolo del libro prima citato, fu unmomento di passaggio. Husserl, l’avevano studiato soltanto Banfie Sofia Vanni Rovighi, una professoressa molto brava dellaCattolica, una filosofa originale, all’avanguardia culturalmente edi grande lucidità. Paci scoprì Husserl perché Husserl non eraancora stato scoperto, perché la maniera in cui era stato letto daBanfi era una interpretazione neokantiana e quella della VanniRovighi era un rendiconto circa l’origine scolastica di alcuni con-cetti fenomenologici. Banfi non comprese l’aspetto più originaledella fenomenologia husserliana. Per Banfi, nella sua visione teo-rica, la questione era la formalità kantiana, un residuo di formali-smo kantiano, rispetto al quale restava una sorta di abisso nei con-fronti della dimensione emotiva, dell’esperienza sensibile, dell’in-teriorità esistenziale; morale o religiosa che fosse. Anche per que-sto, Banfi fu più esistenzialista e marxista che idealista: per lui ladimensione della ragione, ridotta a una aspirazione infinita, rima-neva sempre qualcosa di piuttosto astratto. Ma fu anche un teori-co della religione capace di coniugare aspetti pedagogici e religio-si molto interessanti che provenivano dalla tedesca “filosofia dellavita”, da Simmel e da Eucken. A mio avviso, le sue “conversioni”,non solo nella religione ma anche nella politica, non furono cedi-menti ideologici ma oscillazioni che la sua tarda e decaduta razio-nalità neokantiana non sapeva governare.
In Paci vi era una sorta di scissione tra il momento esistenziale,che poteva essere marxisticamente sociale ed esistenzialisticamen-te individuale. Questa situazione dicotomica non era possibile inHusserl, che raccoglieva tutto il suo dualismo sulla soglia dell’i-naugurazione metodologica. Questo salto, non c’è in Paci che, comeMerleau Ponty, Fink, Landgrebe, Gadamer, Jonas, Patocka e altrifenomenologi della terza gnerazione europea (dopo quella di Lask,Scheler e Banfi e quella di Heidegger, Levinas e Ricoeur), scopre lafenomenologia a prescindere dall’epoché fenomenologica conside-rata come una semplice raccomandazione circa la moralità dellascienza. C’è invece un relazionismo che, senza diventare realista,esprimeva il bisogno di uscire dall’esistenzialismo, ma, senzadiventare mai un idealismo. 140
Alfredo Marini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 140 (Nero/Process Black pellicola)
Paci non poteva fermarsi ad una posizione così indefinita. c’eraquesta tendenza di Paci a rifarsi a quello che aveva scritto prima,come a voler segnare una strada che portasse alla scoperta di qual-che cosa... e questo fu proprio la riscoperta di Husserl! E “scoper-ta” vuol dire che lo lesse, davvero, per la prima volta in relazionead altri pensatori e commentatori di Husserl: dalla Fenomenologiadella percezione di Merleau-Ponty, all’Essere e il nulla di Sartre, anchese quest’ultimo, ripeto, ebbe come altri una comprensione non filo-logica ma intuitiva e criticamente irresponsabile di Husserl, checonsiderava un idealista. Queste sono le stesse posizioni dell’esi-stenzialismo francese del dopoguerra. Anche loro consideranoHusserl un idealista, che va letto sul problema della comunicazio-ne, della solitudine, del silenzio, tutti problemi legati all’esistenzache, però, non verrebbero mai risolti dall’idealismo di Husserl.Banfi non fu all’altezza di individuare la specificità di Husserl per-ché considerò kantianamente l’intuitività di Husserl come un difet-to teorico, una carenza teorica. Questo era una tipico pregiudizioneokantiano che permaneva.
Quando invece Paci scopre Husserl, scopre che si trattava ditutt’altra cosa, ossia: scopre l’importanza di Husserl, la sua lettu-ra lo aiuta a mandare in soffitta tutta la filosofia neokantiana, esi-stenzialista, marxista e idealista. La scoperta di Husserl diede aPaci un nuovo modo per rileggere anche Platone e la propria tesisul Parmenide di Platone, e i classici. Insomma una “malattia” (edEco non aveva intuito male la verità psicologica del collega mila-nese): la stessa che aveva preso anche Heidegger, il quale noncapì Husserl pur leggendolo finché non lo conobbe di persona, esolo allora iniziò a capire la ricchezza, la novità, sul piano teorico,della fenomenologia, ma via via che progrediva nella compren-sione, credette di essersi sempre più allontanato da Husserl e diaver trovato se stesso. Per ragioni generazionali, Paci non puòconoscere Husserl, morto quando lui si laureava a Milano conBanfi. Paci dovette accontentarsi del contatto con gli inediti, magli bastò: e, naturalmente, assaggiato il frutto della fenomenolo-gia (che forse era davvero il segreto di tutta la filosofia moderna)per lui è una rivoluzione.
Questo è un po’ lo stato di intempestività in cui si trova Paci inquella fase di approccio. Van Breda, invitato da Paci, fece una seriedi conferenze a Pavia credo nel 1958 e lo conobbi anch’io allora. Lacosa sorprendente è che questa novità ha cambiato il modo di pen-sare di quasi tutti i filosofi europei dalla prima metà del 900, i quali
141
Enzo Paci la fenomenologia e il pensiero politico
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 141 (Nero/Process Black pellicola)
anche a distanza di trent’anni, scoprono effettivamente cosa voles-se dire la fenomenologia husserliana: una filosofia descrittiva dellacosa stessa dove le prove le trovi dentro di te. Se hai la fortuna diavere un fenomenologo, che ha già fatto quest’esperienza, capiscialla svelta, Paci invece non l’aveva, la scoprì da solo e la comunicòin giro. Gli equivoci e le deformazioni ideologiche dell’opinionecomune si rivolgono allora contro chi le aveva diffuse, in buona omala fede che fosse.
Ebbi subito la sensazione che questa scoperta e l’entusiasmoche gli stava intorno fosse una vera novità. Io mi sono laureato suMerleau-Ponty, ma la mia era una critica distruttiva di Merleau-Ponty dal punto di vista dal metodo fenomenologico e questa cri-tica investiva indirettamente anche Paci. L’approccio paciano,come quello di Merleau-Ponty non era nella corretta impostazionedella fenomenologia husserliana: entrambi trasformavano la feno-menologia husserliana in una antropologia filosofica e rifiutavanoquella che dopo la Crisis si chiamò la seconda epoché fenomenolo-gica (dopo quella diretta alla Lebenswelt e sulla quale si impostal’intiera fenomenologia che in Essere e tempo produce l’ontologiafondamentale dell’esserci) quella diretta all’io trascendentale ulti-mo e veramente fungente.
Merleau-Ponty (morto improvvisamente, ancora giovane, nel1960, anno della mia tesi di laurea) metteva in riga una serie note-vole di fisiologi, neuroscienziati organicisti di formazione tedescacome Gelb e Goldstein, oppure psicologi associazionisti inglesi,filosofi dogmatici cartesiani razionalisti o idealisti campioni di unapensée de survol e falsi materialisti ed empiristi vittime del tipicocontrosenso induttivistico per spostare la descrizione fenomenolo-gica tutta fuori della critica di quest’ontologia sia organicistica cheatomistico-associazionistica. Grazie a Husserl sembra possibilecreare un piano e un livello di discorso completamente nuovo.Questo è lo stato d’animo di tutti coloro che ad un certo puntocominciano a capire qualcosa di questo Husserl, “frainteso e diffa-mato”, e diventano “creativi”. Tutti nel ‘900 fanno quest’esperienzae anche Paci. La sua prima esperienza e il suo primo tentativo dicambiare il mondo valendosi di questo nuovo linguaggio, si vedein La funzione delle scienze e il significato dell’uomo, in cui dopo averapprofondito questo concetto di fenomenologia autentica cheaveva finalmente “scoperto”, si propone di immettere Gramsci inuna prospettiva fenomenologica. Il libro dell’accertamento e dellascoperta è Tempo e verità, del ‘61, contenente dei saggi che aveva già142
Alfredo Marini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 142 (Nero/Process Black pellicola)
pubblicato in diverse riviste. Il tempo del divenire e la verità sonol’essere del pensiero. Paci ha imparato la fenomenologia abbastan-za bene per utilizzarne i concetti, che si trasformano in scheggefenomenologiche che consentono di aprire problematiche all’epocanuove. La formula è il “sempre di nuovo” (immer wieder). Subitodopo questo tentativo, esplode a Milano la contestazione studente-sca, seguita da vent’anni di “gambizzazioni”: gli anni di piombo.Dopo varie peregrinazioni tornai in Italia nel 1964-65. Paci siammala nel “68” e, probabilmente mal curato, muore in pochi annidi effimeri trionfi di massa e di profonde delusioni personali. Ineffetti non rimane quasi niente di quel tentativo “politico-cultura-le”: il quadro politico crolla e precipita in un passato in cui qualcu-no aveva potuto pensare di sorreggere la prassi con qualche anali-si teorica. Sartre scompare, era un suo riferimento: anche se nonerano d’accordo dal punto di vista tecnico filosofico era comunqueun riferimento politico e un modello per quegli anni, fino al ‘70,quando comincia a imporsi in Francia un tipo di pensiero comple-tamente opposto: lo strutturalismo, cresciuto nel lavorio intensodella ricerca storica, etnologica e morale.
Ciò che più influenzò Paci, nella sua interpretazione di Essere etempo, fu la traduzione italiana di P. Chiodi, che ne fu a sua voltainfluenzato sul piano filosofico-ideologico. Non fu una sindromefortunata né per l’uno né per l’altro. Paci non capì niente diHeidegger. Chiodi pensava che Heidegger potesse essere interpre-tato alla maniera di Pietro Rossi, cioè partendo da Max Weber, cheinvece non c’entra per nulla. Chiodi scrive una serie impressionan-te di saggi caratterizzati dalla vacuità e dal carattere ipotetico con-getturale in base ad estrapolazioni da una lettura totalmente insuf-ficiente. Il concetto dominante è: “Chissà cosa vorrà direHeidegger…!” Entrambi fuorviati dal pregiudizio esistenzialista edall’etichetta nazista, a Chiodi mancava il vocabolario, oltre alleconoscenze filosofiche per capire il testo di Heidegger, e Paci, chene aveva abbastanza, non fa in tempo a raccogliere gli elementiessenziali per leggere Heidegger (che sono Dilthey, Kant, Husserl eAristotele). Risultato: non riesce a capirne di più e si basa suChiodi. Pensa anche lui che le tesi di Essere e tempo fossero tesiantropologiche. Non ha colto come il problema si presentasse daun’altra angolazione, intorno al senso dell’essere e della verità,un’angolazione capace di dare una valenza diversa alle precedentianalisi. Sarà così anche per tutta la posterità di Levinas, Derridacompreso. Ma questi non hanno le attenuanti di Paci. Così Tempo e
143
Enzo Paci la fenomenologia e il pensiero politico
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 143 (Nero/Process Black pellicola)
verità è il grande libro in cui Paci compie il primo autentico e indi-spensabile passo per la comprensione di Husserl e quindi ancheper la comprensione di Essere e tempo. Il libro successivo, quello“gramsciano”, fu una deviazione dal compito essenziale. Un ricu-pero fu impedito dalla morte prematura.
144
Alfredo Marini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 144 (Nero/Process Black pellicola)
ALESSANDRO SARDI
LA FENOMENOLOGIA DEI PROCESSI IN RELAZIONE
“Le torri. Il passato. Sentire il loro senso, la loro ragione.La loro storia nel mondo nel quale hanno vissuto e vivono,
nelle relazioni che le costituiscono e mi costituiscono.Lasciare che diventino documenti,
che il loro silenzio maturi in un nome.Risvegliarle, risvegliarsi.
(E. Paci, Diario fenomenologico, 2 aprile 1956)
“Se infatti tutto è in tutto e tutto da tutto si stacca,anche da quel che appare minimo si staccherà qualcosa
più piccolo di esso e quel che appare massimo si è staccato da qualcosa più grande di esso.”
(Anassagora, Sulla natura)
Raramente il calendario dei fatti coincide con quello dei senti-menti: “lo sanno i protagonisti delle avventure del cuore.” Paci haavuto la ‘fortuna’ di annotare le proprie giornate salienti negli annidecisivi del suo itinerario di pensatore. Il risultato è stato il Diariofenomenologico, opera che più di ogni altra mette in risalto le quali-tà letterarie dell’autore e il suo talento teoretico, in una complessavicenda di vita e pensiero.
“Il calendario dei fatti, nel suo intreccio con quello dei pensieri,è all’incirca il seguente. 1956: l’approfondimento di alcuni punticruciali della filosofia contemporanea indirizza il Paci verso unarevisione e autocritica delle proprie posizioni. Egli si avvede che itemi fondamentali della filosofia d’oggi ripresentano i problemi di
145
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 145 (Nero/Process Black pellicola)
Husserl e della fenomenologia. Le idee che già si delineavano inTempo e relazione (1954) maturano negli scritti raccolti sotto il titoloDall’esistenzialismo al relazionismo (1957): la necessità di un ritorno aHusserl vi è energicamente profilata, insieme con la riduzione del-l’esistenzialismo a un episodio minore e superato nell’interno dellagrande corrente fenomenologica.”1
In quegli anni stavano venendo alla luce diversi inediti diHusserl: Ideen II, Ideen III e Krisis, quest’ultimo tradotto e pubblica-to da Il Saggiatore, nella collana “La Cultura”. È proprio a partiredallo studio di questi testi e di altri scritti husserliani che Paci con-tinuerà la propria ricerca all’Archivio Husserl di Lovanio, grazieall’amicizia e alla collaborazione del curatore del corpus husserlia-no, padre Van Breda. Scrive Paci nel Diario in data 10 giugno 1961:
“Padre Van Breda è arrivato il 29 maggio ed è rimasto in Italiafino ad oggi. Ha notato che in Italia la fenomenologia, dal febbraiodel 1958, dall’ultima volta che è stato qui, ha percorso ormai moltocammino. Van Breda, nella conferenza di Milano, e in un modo deltutto speciale in quella di Torino, è stato molto felice nel sottolinea-re l’importanza della fenomenologia genetica.”2
La fenomenologia genetica sarà l’ultima frontiera della teoresidi Paci prima della svolta ‘marxista’: nel testo ‘chiave’ Tempo everità nella fenomenologia di Husserl emergeranno i temi decisividell’esistenzialismo ‘positivo’, umanistico e storicistico, implicitinella fenomenologia stessa. Tale umanismo fu anche il ‘limite’,come disse Veca, della fenomenologia paciana e della sua ricezio-ne di Husserl.3
Possiamo dire che la fase relazionistica di Paci si pone in sostan-ziale continuità con il successivo ritorno a Husserl: la ripresa deitemi fenomenologici non costituisce uno ‘slittamento’ dei problemiche si ripresentano irrisolti, come ebbe a dire Veca, bensì come una‘radicalizzazione’ dei temi dell’esistenzialismo positivo, “intorno acui si raccoglie la riflessione unitaria del filosofo di Monterado.”4
“Ogni realtà è qualcosa di più dell’astratta universalità e qual-cosa di meno della realtà assoluta singolare o totale. Il fatto primosono io, il soggetto. Non il soggetto dell’idealismo, non l’assoluto,ma l’incontro concreto del finito e dell’infinito, della luce e del-l’ombra. Io, come uomo, come l’uomo che ha in sé il mondo, ancheil mondo che ignora. (...) Non da solo – ma con tutti gli altri, vivie morti: in relazione con tutti, con tutti i soggetti. Può scegliere perla ragione che è vita, può scegliere per la morte, per l’autodistru-zione atomica. Ma è dignum omni admiratione perché porta con146
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 146 (Nero/Process Black pellicola)
sé la verità, perché ha in sé l’evidenza della verità, perché per par-lare del male deve avere in sé il bene, la vita del bene, una vita chenon può negare perché è la sua vita intenzionale in prima perso-na, il suo essere soggetto, il suo emergere come soggetto. Ma que-sto è Husserl.”
Nella stessa pagina del Diario. Paci si domanda: “il mio relazio-nismo sarà possibile senza la ripresa della fenomenologia?”5 Epoco oltre, con tono husserliano afferma: “bisogna ancora una volta,con tenacia e con pazienza, ricominciare, riprendere la ricerca, cor-reggersi, bruciare la coscienza impura per ritrovare in se stessi ilsenso della verità, il telos del mondo. Appena si riflette sul propriocammino si è gettati brutalmente nella strettezza della propriaincapacità: si sente che l’errore, l’oscurità, la vanità, la superficiali-tà, sono in noi, li portiamo in noi stessi. Ma in noi stessi c’è la veri-tà e la vita. Il mondo greco.”6
È in questa primavera del 1956 che a nostro avviso Paci iniziaa riflettere consapevolmente (testimoni sono le pagine del Diario)sulla necessità di ‘ritornare’ ad Husserl, per inverare (e non percorreggere o svoltare) la prospettiva relazionistica e gli esisti‘positivi’ del suo esistenzialismo (mai abbandonati nel ‘rinne-go’).7 Fin dagli anni Trenta, il periodo influenzato dalla riflessio-ne sul Parmenide platonico che Paci presenta come il “problemadella filosofia contemporanea”, si ‘reclamava’ la reciproca com-plementarietà di due modelli: il trascendentalismo e l’ontologismo.Entrambi avevano la ‘funzione’ di mostrare, dal punto di vistametodologico, la nuova ‘via’ aperta dall’interpretazione delloStenzel per una corretta comprensione del platonismo secondouna prospettiva ‘relazionistica’. Paci esplicitava tale posizionerinvenendo l’essenza del platonismo nella correlatività tra l’uno eil molteplice (o tra l’essere e il non essere) e applicando in seguito lamedesima ‘lente’ teoretica alla filosofia presocratica.
Nel rileggere quei testi si possono facilmente rintracciare isegnali della necessità di collocare la “questione della verità” in unorizzonte più ampio e complesso, relazionato e ricomposto nelle suescissioni, come indispensabile punto di partenza per la riunifica-zione dei ‘saperi’ in una nuova forma di ‘ricomposizione’ enciclope-dica. In fondo, la coerenza del pensiero paciano è espressa in que-ste righe, che possono essere assunte come sintesi della prospettivarelazionistica, nata come un fiume carsico ed emersa nelle vasteacque di un progetto ‘infinito’ (almeno per l’ambizioso titolo cheesprime tutte le possibilità sempre aperte della ‘ricerca’, secondo i
147
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 147 (Nero/Process Black pellicola)
fondamenti della filosofia della relazione): Idee per una enciclopediafenomenologica; leggiamo infatti:
“Se l’unificazione è possibile è perché nessuna forma è isolata eperché nessuna forma viene assolutizzata e oggettivata. Nessunaoperazione e nessun soggetto sono l’operazione totale o il soggettoche ha compiuto tutte le operazioni e che coincide con la veritàfinale. Se è vero che il soggetto non può negare in sé un centro, siapure infinitesimale, di vita della verità, è anche vero che nessunsoggetto e nessuna comunità di soggetti possono mai pretendere dipossedere e tanto meno di essere la verità.”8
Attraverso il relazionismo Paci ha delineato una filosofia sensi-bile ai problemi dell’esistenza, aperta ai molteplici significati del-l’esperienza, sempre incompiuta e in ‘corso’, capace di accoglierele problematiche della scienza, consapevole dei propri limiti teo-retici ma diffidente dalla ‘verità’ assoluta. Permangono in questafilosofia le tematiche legate all’esistenzialismo, anche se l’orizzon-te si è notevolmente ampliato: “lavorando oltre le stanchezze e ipregiudizi che gli sembravano caratteristici di una civiltà al tra-monto, (...) s’avvia a riscoprire l’esistenzialismo nella Lebensweltdell’ultimo Husserl.”9
È ora opportuno riassumere alcuni sviluppi della “fenomeno-logia relazionistica” di Paci, al fine di mostrare i punti di contat-to tra esistenzialismo “positivo”, relazionismo e fenomenologia,in quell’itinerario di pensiero che, dagli anni Cinquanta ai primianni Sessanta, attinge le sue risorse dalla lezione fenomenologicaeuropea.
La fenomenologia era per Husserl il ritorno alle “cose stesse” –spiega Paci in un fondamentale articolo di “Aut Aut” del 1957 – manon è facile comprendere cosa intendesse Husserl per la “cosa stes-sa”. La ‘cosa’ non consegue al giudizio: è anteriore al giudizio sulmondo, alla separazione ‘giudicativa’ tra soggetto e oggetto.10 Nellaprima delle sue Ricerche logiche, Husserl studia l’espressione: il signi-ficato di una espressione, ossia di una proposizione del linguaggio,sta nella permanenza di ciò che è significato ed espresso. Ma ciò che èespresso è anche intuito. Significa che la ‘forma’ di un’espressionedeve essere ‘riempita’ da una intuizione, da un “atto intuitivo” chesia in grado di cogliere qualcosa di permanente. “Ciò che preme adHusserl è di far vedere che l’espressione non ha significato se nonvengono intuiti degli oggetti permanenti, delle figure, delle ‘essen-148
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 148 (Nero/Process Black pellicola)
ze’. Senza la visione delle figure essenziali il discorso logico, oscientifico, sarebbe vuoto e privo di significato.”11 Non è dunquepossibile affrontare un discorso logico senza l’intuizione che dàsignificato all’espressione. La vita, commenta Paci, si ‘esprime’ e intale espressione “intuisce, vede, coglie degli oggetti ‘visti’, dellefigure ideali.”12 Paci sottolinea l’evoluzione del concetto di ‘inten-zionalità’, approfondendo i rapporti tra esperienza vissuta e “veri-tà logica che pone inconsapevolmente Husserl sul piano problema-tico dello ‘schematismo’ kantiano, uno dei nodi decisivi del pensie-ro contemporaneo.”13
La ‘coscienza’ intenziona, ovvero, nel linguaggio fenomenologi-co, vede, delle essenze permanenti. Possiamo riassumere così: l’in-tenzionalità è la visione di oggetti intuiti ideali. Ma cosa significavedere oggetti ‘ideali’? “Gli oggetti, appunto in quanto sono figure,sono irreali, o, come si potrebbe anche dire, immaginari. Concepitacome attività che vede le essenze la coscienza è ciò che, vedendo,dà un significato al discorso logico.”14
In questo senso si può intendere il significato di ‘coscienza’come “esperienza vitale”, la cui ‘funzione’ è di dare un significato(Erlebnis des Bedeuten), ossia inverare l’esperienza nel significato. Ilsoggetto o “Io trascendentale” è dunque il ‘portatore’ di senso nel‘mondo’, già presente, prima di ogni ‘giudizio’ e di ogni ‘significato’,nel ‘mondo’. È come se qualcosa dapprima fosse sentito senza com-prensione (come già intendeva Vico nella Scienza nuova) e in segui-to, le ‘figure’, le ‘immagini’ di mondo che si stagliano sempre dinuovo in “assemblaggi significativi”, operano da ‘medio’ nel pro-cesso della conoscenza (‘medio’ che si esprime nelle relazioni costi-tutive tra Io e mondo, nell’incanto che costituisce la relazione simboli-ca, ma anche nello “schematismo trascendentale” kantiano, alquale Paci dedica un lungo e fondamentale saggio).15
“Ogni cosa è quello che è – scrive Paci – ma è anche l’indice dellealtre. (...) La correlazione – che spiega perché il ‘relazionismo’ dichi scrive queste righe ha dovuto rifarsi alla fenomenologia cheproprio nei testi inediti di Husserl si è dichiarata relazionisticaanche se tale era fin dall’inizio – significa in altre parole: se ritor-no all’io nell’io trovo tutto il resto e lo trovo fondato sull’esperien-za mia ed altrui.”16
Le ‘figure’, intese come contenuto delle visioni, sono distintedalla vita psicologica della coscienza e in quanto ‘distaccate’, levisioni hanno una loro autonomia: per questo la loro ‘natura’ nonè psicologica. La coscienza, in quanto le vede e le ‘distacca’ da sé “in
149
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 149 (Nero/Process Black pellicola)
uno schermo che non è la coscienza stessa”, compie l’azione diporre qualcosa che “non è se medesima, che non è la sua realtà psi-cofisica, il suo essere psicologico e naturale.” La coscienza dunqueopera ‘proiezioni’, spiega Paci commentando le Ricerche logiche, eciò che proietta (immaginando) sono “le visioni, senza le quali nes-sun discorso scientifico ha significato e senza le quali non ha signi-ficato la stessa filosofia. La filosofia sarà allora lo studio delle visio-ni proiettate dalla coscienza, dalla vita fluente, concreta, dellacoscienza, visioni permanenti nel flusso della vita stessa e, cometali, chiare e vere.”17
La coscienza è, in quanto proiettante, intenzionale: vede e si raf-figura ‘cose’ che non esistono ma che attraverso le “figure possibili”(possibilità sempre aperta e in relazione ad altre possibilità) dà unsignificato al discorso, alla scienza e alla vita. Risulta evidente chesenza l’intenzionalità della coscienza, la vita degli uomini risulterebbepriva di significato, che, nell’universo del discorso paciano, signifi-ca, anzitutto, senza un valore.
La filosofia, secondo questa rinnovata prospettiva, sarà allorauna “fenomenologia delle essenze”, spiega Paci, “distaccate dallastruttura psicologica e naturale, proiettate nel possibile visto,immaginato, raffigurato, dunque oltre l’esistenza data.Intenzionare significa andare oltre, vedere qualcosa, vedere qualco-sa oltre la realtà vissuta, vedere una possibilità, intuire nelle figurel’essenza e il senso del mondo.”18
L’essenza è ciò che dà obbiettività alla conoscenza e quest’ulti-ma non può che trovare il proprio fondamento su essenze obbietti-vamente valide. La filosofia acquista valore, afferma Paci, nelmomento in cui diviene “scienza delle essenze”: alla fenomenolo-gia interessa della coscienza solo ciò che la coscienza intenziona inquanto obiettivo. Quindi, “cogliere nell’attività della coscienza glioggetti obbiettati, le essenze, è compiere un’analisi fenomenologi-ca.”19 La ‘verità’ della logica (ma ogni verità filosofica) è condizio-nata alle visioni, ossia alle idee: la cecità rispetto alle idee, affermaHusserl in Ideen I, è una sorta di ‘cecità’ dell’anima che, a causa dipregiudizi, rende incapaci di trasferire sul piano giudicativo quel-lo che si possiede nella sfera della visione. In verità, tutti vedono,per così dire ininterrottamente idee o essenze, operano con esse nelpensare e compiono dei giudizi essenziali. Il punto è proprio que-sto: senza visioni, senza schemi visivi e senza ‘figure’ (senza le‘immagini’) non c’è fenomenologia e, di conseguenza, non è possi-bile fondare in senso rigoroso alcuna ‘filosofia’. 150
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 150 (Nero/Process Black pellicola)
La filosofia è allora “descrizione delle essenze intenzionate”dalla ‘coscienza’ e della sua vita, dell’esperienza vissuta,dell’Erlebnis che, essendo attività intenzionale libera, nel suoproiettare da ogni oscurità psicologica, è trascendentale. Per que-sto, spiga Paci, Husserl può dire che la fenomenologia vuole esse-re una scienza descrittiva degli Erlebnisse trascendentalmente purie cioè “delle essenze pure presenti nella vita intenzionale in quan-to si proietta in figure chiare e rigorose.”20
In questa direzione, Paci può interpretare la coscienza trascen-dentale non semplicemente come “atto teoretico o una formulaconoscitiva”, bensì come un atto totale, ‘organico’.21 L’atto è una‘tensione’ che tende a realizzare qualcosa e tutti gli atti sono rela-zionati: nessuno di essi è ‘isolabile’ in un essere chiuso: “il proces-so dell’esperienza è formato da una corrente di Erlebnisse intenzio-nali. È una relazione di momenti intenzionali e mai una somma disostanze o di esseri. Ciò che si conclude in un essere chiuso esostanzializzato è ‘morto’. Al contrario l’esperienza in quantoLebenswelt è, appunto, viva: non è mai qualcosa di cui si possa dire,in modo definitivo, “è questo” o “è quello” come, parafrasando iVangeli (sempre cari a Paci) non si potrebbe dire del Regno deiCieli che è qui o è là. La caratteristica della Lebenswelt è proprio dinon essere mai quella che è, di proiettarsi sempre al di là di se stes-sa, di trascendersi. Noi pretendiamo di arrestare l’esperienza nelgiudizio; l’esperienza, invece, sorpassa sempre il giudizio nel qualevogliamo arrestarla.”22
Questa considerazione di Paci esprime la necessità di mantene-re aperta la ricerca. Ogni esperienza (o vissuto esperienziale,Erlebnis), che è sempre in relazione con le altre, è in realtà un ‘pro-cesso’ che tende (la tensione dell’atto) a trascendersi e a re-interpretar-si, perché non ha mai in sé ciò che le è sufficiente: ossia, ciò che le ènecessario per esistere. Fenomenologia trascendentale, relazioni-smo ed esistenzialismo si implicano a vicenda e si inverano l’unanell’altro, apportando un contributo alla analisi esistenziale della‘vita’ (come ricerca continua). In questo senso, la sua ricerca non siconclude mai in una ‘formula’ riassuntiva e definitiva. LaLebenswelt è il concetto che tutte le questioni abbraccia, nel ri-trova-to ‘inizio’ alla meditatio vitae:
“Non qualcosa ‘dietro’, ma qualcosa che si è occultata o che si èsedimentata e che bisogna disoccultare, nel presente per l’avvenire.Tutta la nostra vita, come presenza evidente, è il risvegliarsi e ilchiarirsi del passato: è temps retrouvé. La verità che dormiva si tra-
151
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 151 (Nero/Process Black pellicola)
sforma, diventa verità tipica, figura essenziale. Ma continua, risve-gliandosi, a cercarsi, a correggersi nelle reciproche relazioni che lacostituiscono, a cercare un compimento, un telos.”23
Per Paci, Husserl ha avuto dal destino la missione di difende-re, in un mondo che stava sperimentando il crollo di tutte le mito-logie razionalistiche, il valore supremo e i diritti eterni della chia-rezza della ragione. In questo senso, la fenomenologia di Paci siinserisce nell’arco complessivo del pensiero husserliano, cercandodi mettere in luce la ‘continuità’ piuttosto che le differenze, e lo svi-luppo, piuttosto che i mutamenti. La fenomenologia paciana èdunque il frutto di una “appassionata lettura del testo di Husserl”,poco attenta alle periodizzazioni, ma estremamente sensibile all’at-tualizzazione e alla problematizzazione del pensiero del filosofotedesco. In questa prospettiva la fenomenologia di Paci appartienesoltanto a Paci e sarebbe uno sbaglio valutarla mettendola in rela-zione ad una ‘corretta’ lettura dell’opera di Husserl.
La fenomenologia è dunque per Paci un metodo di analisi impe-gnata nei processi storico-temporali, secondo quella ‘personale’prospettiva che chiamiamo ‘relazionismo’. In questo senso, si puòdire che Paci attua la propria fenomenologia come una “filosofiadella relazione” (intesa come metodo dell’analisi teoretica): tale filo-sofia è una fenomenologia dei processi in relazione, in quanto con-tiene in sé la “prospettiva esistenzialistica” che è essenzialmente“analisi dell’esistenza” come processo, sviluppo nell’irreversibilità enel bisogno, ricerca e possibilità, intenzionalità e quindi telos (assaidistante dall’impostazione ontico-ontologica di Heidegger, inquanto in Paci è sempre preminente l’urgenze di intendere l’ideacome valore). Tali ‘categorie’ si trasformano sempre nel pensieropaciano in ‘qualità’ e ‘attributi’ della vita, capaci di ‘denotare’ (masenza definire nell’assolutezza) il significato di verità dell’esistenza.La ricerca viene così integrata secondo un’organica visione, e secon-do il senso di tale visione, ricondotta alla sua fonte: l’esperienza pre-categoriale, ossia la Lebenswelt. “La filosofia non è qui deduzioneda principi prestabiliti ma sentimento”, pre-sentimento e azione perun ‘fine’ che si pone alla prova nel ‘rischio’ e nel ‘compito’. “Unafilosofia relazionistica non è soltanto un modo di pensare ma unmodo di vedere (proprio nel senso husserliano, nel senso “eideti-co”) e di sentire” (il feeling di Whitehead o l’empatia nella “situazio-ne emotiva” esistenziale). “Ed una filosofia così concepita, nelmomento stesso nel quale si pone come fenomenologia, si poneanche come pedagogia e come paideia.”24
152
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 152 (Nero/Process Black pellicola)
La fenomenologia dei processi in relazione vuole anzitutto esse-re l’inserzione di fatto della filosofia nella realtà dei processi stori-ci, del lavoro e della cultura. La filosofia del tempo e della relazio-ne deve agire nel tempo (nella prospettiva genetica delle husserlia-ne Lezioni sulla coscienza interna del tempo), per attuare ‘nuove’ rela-zioni possibili, orientata verso un telos, che possiamo dire esserequello dell’ideale organico della vita, che ai ‘problemi’ della vitapossa concedere una soddisfazione e un significato. Potremmoanche dire: una nuova consapevolezza genealogica che svela icaratteri dell’esistere senza scioglierli da quella fitta trama di even-ti in relazione (l’espressione è di Paci) che ne costituisce rigorosa-mente il fondo (inesauribile) di senso.
Il ‘rigoroso’ per Husserl non è qualcosa che riguarda le scienzedella natura o la logica formale, e in questo senso, gli scritti piùsignificativi di Paci dei primi anni sessanta, cercano scrupolosa-mente di dimostrare come la fenomenologia possa essere conside-rata una “scienza nuova” e ‘rigorosa’, capace di scardinare la filo-sofia tradizionale, portatrice della crisi contemporanea del ‘senso’e dei ‘valori’, ossia della perdita del significato di ‘verità’ dell’uomoe della storia. La fenomenologia è la guida alla ricerca, all’analisi eal superamento della prospettiva nichilistica e per questo richiedeun impegno supplementare da parte del filosofo, capace di mette-re in gioco se stesso e le sue ‘convinzioni’ in vista del telos dell’uma-nità: la lotta contro l’uso alienante delle ‘scienze’ per la riconquistadel significato dell’uomo, della sua società, della sua storia. Lottaper una rinnovata ‘funzione’ delle scienze, dove la crisi delle scien-ze europee è “la crisi della teleologia, della comunità monadica,della storia dell’umanità nella situazione attuale.”25
“Rigorosa è per Husserl l’evidenza e cioè la presenza delle cosestesse. Rigoroso non è il linguaggio predicativo o discorsivo maciò su cui ogni discorso deve alla fine fondarsi e cioè, appunto, l’e-videnza, discorsivamente indimostrabile, nella quale la verità sirivela per ciò che è ed è presente in modo apodittico, anche se ina-deguato.”26
Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl costituisce l’aspettopiù ‘tecnico’ della filosofia paciana: il libro nasce da un faticosolavoro di studio sui manoscritti husserliani conservati a Lovanio,‘raccontato’, in presa diretta, nel Diario fenomenologico, che rappre-senta il laboratorio della fenomenologia paciana, in cui i punti di
153
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 153 (Nero/Process Black pellicola)
vista – quello teoretico e quello riflessivo-autobiografico – si con-fondono in una efficace relazione di vita e pensiero, espressione del-l’ideale fenomenologico tout court. Scrive Paci nel Diario:
“Lovanio, 7 aprile 1960.Sono completamente preso dallo slancio dell’analisi husserliana.Le cose mi si mutano tra le mani, il mondo rivela volti nuovi,prima mai visti. Io stesso mi trasformo, mi faccio un altro. E tut-tavia c’è in tutto ciò qualcosa che non controllo: un’affinità pro-fonda, una Einfühlung tra me e questi Manoscritti, che è poi laEinfühlung tra me e Husserl che ritorna vivo, in un modo che mistupisce e un po’ spaura.”27
In un manoscritto contrassegnato C 3 VI (ottobre 1931), Husserlparla del ritorno alla hyle. Ciò che è vissuto nella “vita della coscien-za”, vita del “corporeo percepire”, “la vita della vivente materia dicui vivo (...) vivo nel mondo veramente esperito, il mondo delleessenze che a me si rivelano, il mondo dei fenomeni.” Le ‘cose’ nonsono più quello che erano prima dell’epoché, ma si danno comevisioni da me esperite.28
Ogni cosa, spiega Paci, è un collegamento di ‘percezioni’: l’og-getto è un polo di relazioni intenzionali che non si finisce mai didescrivere e di percepire e, in quest’ottica, il ‘mondo’ costituiscel’orizzonte degli orizzonti. Per meglio descrivere la relazione costitu-tiva delle percezioni, Paci riprende la Terza ricerca logica di Husserle si chiede (come anche Husserl si chiese) che cosa si deve inten-dere per ‘dipendenza’. Se si considerano a e b, dipenderanno unodall’altro se hanno qualcosa in comune, se dato a possiamo dire cheb ha un carattere che posso vedere già in a. Ecco: proprio il “qual-cosa di comune”, la ‘parte’ in comune, possiamo dire, è una relazio-ne. In questo senso possiamo considerare che dato a abbiamo rela-tivamente anche b e che nella relazione si rivela qualcosa di essen-ziale, un’essenza che congiunge a e b “in modo che l’essenza di apermane in b.”29
A questo punto, Paci chiarisce cosa si deve intendere per ‘essen-za’, ossia: qualcosa che permane solo quando a è “un punto deltempo” e b è il “punto del tempo” che segue ad a, ma “mantenendolo stile di a”. La “stessa essenza” è così ‘fondata’ sulla relazione tem-porale, ovvero sul concreto fluire del tempo. Permane solo ciò che èessenziale, possiamo aggiungere, e, in questo senso, l’essenza è unostare insieme. La dipendenza, spiega Paci sulla scorta di Husserl, è154
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 154 (Nero/Process Black pellicola)
“un necessario stare insieme nel tempo, è una relazione coesisten-ziale o una coesistenza relazionale”30 (beziehende Koexistenz).
In un successivo inedito (il C 7 I, giugno-luglio 1932), Husserldirà che nel tempo ‘originario’ (Urzeit) si trova il tempo come coesi-stenza (Zeit als Koexistenzform), nel quale l’intersoggettività, il noi,ossia la “relazione intermonadica”, è sempre una relazione tempo-rale. Paci si stupisce di trovare nei manoscritti di Husserl un chia-rimento così esplicito del suo relazionismo che ha coltivato per undecennio, prima di approfondire le tematiche fenomenologiche.31
Le ‘cose’ nel tempo si individuano e hanno uno ‘stile’, qualcosa chepermette di riconoscerle: “nel tempo si dividono in parti, nei loroorizzonti, ma le parti fanno parte dell’orizzonte degli orizzonti cheè il mondo. Il mondo, a sua volta, è nell’orizzonte del tempo.”32
Il tempo è relazione, è viva relazione intenzionale. La relazione,scrive Paci, per essere possibile deve essere “tempo che si tempora-lizza”. Il relazionismo si ritrova e si approfondisce nella fenomeno-logia husserliana e, per questa ragione, invera le proprie ipotesiinterpretative che non mirano ad “astratte comprensioni” marichiedono di essere ‘sperimentate’ come “esercizi fenomenologiciche permettano nuovi esercizi”. La fenomenologia trascendentaleintesa come vita che esperisce il mondo, come intenzionalità fungen-te, esprime l’intenzionalità nella relazione temporale e come “formaoriginaria” della vita nel mondo.33
Il ‘mondo’ è sempre implicato nella percezione presente origina-ria ed evidente attraverso la quale ‘noi’ torniamo alle cose stesse.Tornare alla percezione è tornare all’io e nell’io è implicato ilmondo, secondo la prospettiva relazionistica paciana. Ma ora Pacipuò aggiungere che il ‘mondo’ è il terreno ‘concreto’ e il ‘fine’ nelquale l’io può muoversi (e ‘costituirsi’), vivere e agire secondo un‘senso’, secondo la “vita intenzionale” che sempre si trascende per-ché è nel mondo sperimentato come ‘terreno’ e orizzonte infinito.
In un paragrafo del fondamentale Mondo, Io e tempo dell’olande-se Brand si legge:
“Ciò che noi, sulle tracce di Husserl, abbiamo indicato come l’es-senza del mondo e dell’io, il mondo come esperienza-dell’io el’io come esperienza-del-mondo, è ciò che Husserl chiama inten-zionalità della coscienza. (...) Husserl chiama intenzionalità laproprietà essenziale della coscienza di essere coscienza-di-qual-che-cosa. (...) In ogni esperienza l’intenzionalità funge come pro-getto implicito e insieme come sguardo retrospettivo. (...) Ma come
155
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 155 (Nero/Process Black pellicola)
progetto (Vor-wurft) è già intriso dell’eredità di percezioni prece-denti, che sono, per così dire, sedimentate nella percezione attua-le. La coscienza non è una tabula rasa su cui si imprimono sem-pre nuovi segni; in quanto essa procede ad un continuo supera-mento degli orizzonti, ha sempre anche una coscienza alle suespalle. L’oggetto è colto nel pro-getto delle sue possibili esplicita-zioni e insieme nella storia che vi è sedimentata.”34
Il ‘mondo’ funge anonimamente in ogni esperienza, fornendolesenso ed ‘essere’. Ogni ‘progetto’ in avanti, per Husserl è semprelegato alla percezioni passate che si sedimentano nella percezioneattuale, proprio come diceva Paci, quando indicava nell’irreversibi-lità temporale l’unica ‘possibilità’ teoretica di vedere aperto il ‘pro-getto’ vitale del trascendersi: ogni trascendersi-verso implica sempreun aver già esperito qualcosa di significativo, ossia qualcosa di cuisi è già fatta esperienza, si è già riconosciuto un ‘significato’ (“Eccolodi nuovo!” come diceva Whitehead e come Paci aveva ben compre-so leggendo Processo e Realtà). Tale è la ‘condizione’ (diciamo noi)entro la quale si può abdurre che qualcosa accade (e come accade).
Nell’esplicitarsi, o meglio, nell’espandersi del ‘presente’ verso il‘futuro’, resta implicito (nel senso di implicato, relazionato) unespandersi verso il ‘passato’ che costituisce, come il ‘futuro’, il‘presente’. Questo ‘presente’ così vissuto è la lebendige Gegenwart,la presenza vivente che abbiamo visto essere riferita da Paci, findai primi scritti fenomenologici, al concetto fondamentale diLebenswelt.35
L’io è così costituito nel “flusso temporale originario precatego-riale”, come io-originario. E’ proprio questa vita temporale che si faio, che si fa verità, nel senso di evidenza, di emergenza dall’anonimo,di staglio come presenza, come Kern di ‘luce’ nel cono d’ombra, nellosfondo (relazionale) circo-stante (il mondo ambiente, la Umwelt husser-liana). In questi termini Paci recupera i temi dell’esistenzialismolegati alla progettualità dell’esperienza, al soggetto che ne incarnai ‘modi’ e costruisce attraverso il ‘medio’ dell’immagine (ossia leproprie proiezioni figurate), dell’attesa, dell’aspettativa, il fine e ilsenso della propria azione (quel fare la verità che costituisce la radiceetica di tutto l’itinerario filosofico di Paci).
Presentificare il passato nel presente, osserva Paci, come adesempio, nell’attività storiografica e nel farsi, nell’accadere storico,non è annullare il passato ma è “far rivivere il passato per quelloche veramente è e far avvenire il futuro: ci avviciniamo all’azio-156
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 156 (Nero/Process Black pellicola)
ne.” Il ‘mondo’ si costituisce così nel tempo e il tempo è il costi-tuirsi del ‘mondo’, perché il ‘mondo’ si costituisce come “passatouniversale” e come “storicità che si apre sempre all’avvenire e fal’avvenire.”36 In tal modo è possibile intendere il significato dellafilosofia dell’esistenza di Paci come un’etica, che mira a costruireuna storia dell’uomo e del mondo. Significativa risulta un’osserva-zione di Sini contenuta nel libro Introduzione alla fenomenologiacome scienza (1965):
“Non si obbietti che il mondo ha un tempo precedente l’uomo,perché ciò è di nuovo calcolato dall’uomo sulla base di preciseesperienze che egli trova nel cogito; il che non significa che l’uomo‘crei’ il tempo, ma che il mondo avente un tempo prima dell’uomoè il significato intenzionale trascendente che si costituisce all’inter-no di ben determinate operazioni soggettive. In altre parole: io‘trovo’ in me non solo il significato “mondo avente ieri, oggi edomani una temporalità oggettiva variamente distanziata rispettoal mio quando”, ma anche il significato “mondo che ha avuto unatemporalità, una successione di avvenimenti, che per essenza sonorimasti estranei al quando dell’uomo”, il quale li riscopre dunquenon come facenti parte della propria storia – delle proprie presenzepassate – ma della propria preistoria.”37
Solo qui, scrive Paci commentando Brand e gli inediti husserliani,“e cioè nella presenza vivente che si estatizza di volta in volta, la rela-zione intenzionale attua se stessa e si attua nel tempo come ritenzio-ne e come protenzione.” Protenzione e ritenzione costituiscono la “pre-senza vivente” come Gegenwärtigung e tale presenza sempre si ‘allar-ga’ (il movimento di espansione), trapassa e, pur restando “nella pre-senza”, come ha osservato anche Fink, “tiene a distanza”.38
È proprio alla luce di questa considerazione che possiamo inten-dere come Paci, preoccupato della ‘crisi’ culturale dissociativa dellanostra epoca, intenda ricostituire una relazione originaria, sul ter-reno della Lebenswelt come intenzionalità, al fine di esplicare il telosdell’umanità che la preservi dal ritorno della barbarie: la fenomeno-logia è scienza nuova che ‘mostra’ la via verso la verità dell’uomo, laconquista sempre progressiva (e mai conclusa) della ragione, lariflessione sulle operazioni che (da sempre) costruiscono il‘mondo’ della vita. Non l’oggetto ‘mondo’ contrapposto al ‘sogget-to’, bensì le relazione io-mondo (o anche la relazione io-tu) che sipone come unica base teoretica di un’autentica ‘funzione’ delle
157
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 157 (Nero/Process Black pellicola)
scienze. In questo consiste l’aspetto pregnante dell’umanismo pacia-no. “L’associarsi delle temporalità comuni in un mondo temporal-mente oggettivo e intersoggettivo rende possibile in concreto lacollaborazione operativa tra i soggetti: l’operare ‘insieme’, nellostesso tempo, o anche in tempi diversi, ma secondo connessioni esuccessioni prestabilite e concorrenti a fini determinati. Il che d’al-tra parte rende possibile per il formarsi di un fondo di esperienzeattraverso le quali vengono colte le prime tipicità del mondo della vita, leprime strutture del modo di fluire del mondo nel cogito, che vengonofissate, rimemorate e fantasticamente proiettate nel futuro.”39
Paci poteva affermare lo stesso in quanto ‘vivere’, per lui, signi-ficava anzitutto realizzare se stessi in azioni diverse e distinguersinella propria storia, formando con se stessi una comunità: una comuni-tà di eventi in relazione. In un breve saggio, commentando il con-cetto di intermonadicità della Mediazioni cartesiane, osserva che ildubbio (da cui l’epoché husserliano) pone l’uomo nel nulla (delleopinioni), e proprio questa ‘mancanza’ costituisce il “ritorno all’o-riginario”. Il vero problema, dice Paci, è se questo ritorno all’origi-nario sia veramente possibile, attuabile. Il nulla delle opinioni hauna precisa funzione: la funzione di ritornare al principio per rico-minciare e per ricostruire. In questo senso si deve intendere il ‘ritor-no’: come ‘funzione’. “Si noti che si parla di ricostruire e non dicostruire. In realtà io mi sono sempre fatto delle opinioni perché èinevitabile che io abbia avuto un passato. Perciò accade che nel pre-sente io debba disfarmi del passato e ricostruire in modo nuovo,dal principio. Il ‘fondare’ è appunto il ricostruire dal principio, ecioè il “ricostruire dalle fondamenta”. La radicalità del dubbio haquindi per fine di ricostruire dalle fondamenta, di fondare il sape-re secondo il principio.”40
La relazione intenzionale, in quanto temporale, offre un senso‘concreto’ alla libertà, alla volontà e al dovere. Paci, riprendendo ilcommento di Brand agli inediti husserliani, osserva che in quanto“io vivente fluente”, io sono la possibilità di me stesso, possibilitàmolteplice, che significa “io sono libero”. All’io, che è originariamen-te temporale, spettano dunque una volontà e un dovere. Il presentevivente è fluente perché si fa passato e si protende al futuro: in quan-to futuro, esso non è mai finito e così, anche il passato “che trae dalpresente il proprio senso, non è mai finito, non è mai concluso.”41 Lalibertà, possiamo anche dire, è determinata dal mio essere ‘passato’,158
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 158 (Nero/Process Black pellicola)
ma mai completamente: essendo in continua sintesi con il ‘futuro’,solo da quest’ultimo, ovvero dalla ‘possibilità’, riceve sempre il pro-prio ‘contenuto’. L’io è libero in quanto già determinato e insiemecome io che deve ancora essere. In questa libertà ‘costretta’ si ravvisaquella dolorosità che Husserl chiama ‘fatticità’ e che Paci ha sempreriscontrato come il problema del ‘negativo’. Il ‘dovere’ è quello dinon arrestare il cammino, la ricerca – come diceva Dewey – è il ‘dove-re’ di una vita personale e sociale che abbia senso, che recuperi nel-l’intenzionalità fungente il senso genuino come ‘possibilità’. È il futu-ro come telos della Crisi delle scienze europee – scrive Paci – è il futurodella mia vita nello scopo universale della ‘vita’. “Il vero significatodell’anticipazione memorativa è nel suo essere una prefigurazione diuno scopo universale della storia.” 42 L’intenzionalità vivente e vis-suta come temporalizzazione è dunque il concetto chiave della feno-menologia relazionistica: è il solo metodo capace di influenzare,come dichiara Paci, la cultura attuale. Essa costituisce la donazionedi senso alla quale la riflessione ritorna come all’origine, ossia alla vitadella verità come fine della storicità temporale. “La vita ha senso se inme, nella mia comunità personale e nella comunità intermonadicauniversale, l’intenzionalità vive come quella storicità temporale nellaquale (...) si “attua l’essere”, nella quale l’essere si costituisce secondoverità nell’orizzonte del tempo.”43
Abbiamo parlato di via intenzionale come vita che fluisce, comeuna “corrente di vita” che esperisce fluendo (Erlebnisstrom) e chevive ‘localizzata’ in orizzonti parziali (ma relazionati, con-fusi) di unorizzonte degli orizzonti, e che tali orizzonti parziali hanno uno‘stile’, ossia una permanenza nel loro fluire. Abbiamo inoltre riscon-trato che questo ‘stile’, come dice Paci, come “orizzonte coesisten-ziale”, è anzitutto un “dilatarsi nel tempo”, un trovarsi nella formatemporale che pur succedendosi sotto differenti aspetti, mantieneuna “relazione essenziale”. Il tempo acquista una ‘sua’ forma, hauna ‘sua’ storia: è il tempo degli orizzonti individuali che affioranocome ‘isole’ dal “continente sommerso” del tempo originario, dallaUrzeit che è radice di tutte le forme temporali. Nel ‘presente’, si èanche detto, il ‘passato’ permane – viene ‘ritenuto’ – nella vitaintenzionale, e dall’avvenire si attende che non cancelli ciò che è ora,ossia che non si ‘distrugga’ quello che nel presente si mantiene: è laterza ipotesi di Parmenide contrapposta alla settima, l’istante tem-porale e la creazione in antinomia (non risolta e perciò ‘dialettica’,sempre aperta) con la distruzione, la meditatio vitae contrapposta allameditatio mortis, la via teleologica della ragione opposta alla barba-
159
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 159 (Nero/Process Black pellicola)
rie, la ‘possibilità’ della ricerca che è esistenza (e per questo bisogno,consumo e azione) contro la chiusura dogmatica del ‘definitivo’: è ilrelazionismo (come umanismo e storicismo) contro l’idealismo.44
La ‘dipendenza’ della relazione è dunque necessaria in quantoè temporale, in quanto si presenta come relazione del ‘passato’ edel ‘futuro’ nel ‘presente’, nella lebendige Gegenwart. Tutto questoHusserl lo spiega nella Terza ricerca, concludendo che il tempo – alquale si riferisce anche Paci – è la forma del tempo immanente, deltempo che appartiene al flusso stesso della coscienza fenomenolo-gica: die zum phaenomenologischen Bewusstseinsfluss selbst gehörigeimmanente Zeit.45
Cogito e cogitatum, io e mondo, immanenza e trascendenza, si riferi-scono ad una vita trascendentale primordiale e la temporalità origina-ria di tale vita è al contempo immanente e trascendente. La feno-menologia, a differenza dell’idealismo e del realismo, si preoccupadi ‘costituire’ l’Io trascendentale e di non accettarlo come già costi-tuto, vuole accettare la vita trascendentale originaria in cui il realesi ‘dona’ all’Io come leibhaft. Nella vita trascendentale originaria‘soggetto’ e ‘oggetto’ sono una sola cosa, un’unità non separata,dalla quale, sorgendo le categorie, i ‘concetti’, inizia il processo didistanziazione dei poli (concettuali) che creano i dualismi metafisici.Ma ritornare alla Lebenswelt, per noi soggetti alla pratica della scrit-tura concettuale, per noi pensatori logici, è impossibile: è solo unideale di ‘ritorno’ e una disponibilità a raffigurarsi l’idea come telos.46
La ragione, scrive Paci in un paragrafo di Tempo e verità nellafenomenologia di Husserl intitolato Tempo e riduzione, “è la trasforma-zione dell’originario in fine razionale, è razionalizzazione della vitafin dalla sua più profonda origine: la vita vera è appunto questavita nella ragione e per la ragione.”47
Nel tempo originario, commenta Paci, si “individualizzano ifiniti”, dove le ‘epoche’ non sono “epoche di Ego astratti ma di“persone incarnate, di monadi concrete” alle quali è affidato il ‘com-pito’ di trasformare nel loro rapporto relazionale, ovvero nell’in-termonadicità (come dice Husserl nella V delle Meditazioni cartesia-ne), il tempo originario “in vita per la ragione”, dove il ‘futuro’ (l’e-vento che avviene che (da) sempre si dona) è orizzonte e compitorazionale “a cui deve avvicinarsi la materia temporale, la hyle, lavita più profonda che deve essere sempre esplicitata, trasformatada potenziale in attuale.”48
La fenomenologia si pone, nell’umanismo paciano, come ricer-ca che fonda (o vuol fondare, proponendosi sempre di nuovo nel160
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 160 (Nero/Process Black pellicola)
suo infinito compito) un mondo di evidenze attuali nelle qualipure sono presenti altre evidenze di diverso grado, “evidenze vir-tuali”, che attendono di essere trasformate in attuali. Lo scopo èdunque l’azione che ‘scopre’ e agisce nel fondamento della vita, vitache è ‘corrente’ incessante, intenzionalità fungente, che da fonda-mento rimanda, nuovamente (immer wieder), all’atto operante (Iooperante o fondativo).
Aggiungiamo una ‘nostra’ considerazione: in ‘noi’ avviene la‘costituzione’ della realtà finita,49 ma avviene perché in ‘noi’ vivel’infinito come intenzionalità fungente: il ‘noi’ è il limite (peras) dell’a-perto di tutti gli orizzonti possibili, del mondo come campo di scelte,come il ‘supporto’ “sempre disponibile” a ‘fungere’, a supportarela prassi umana, il mondo è in questo senso interpretabile comeun’infinità di “fogli-mondo” che si costituiscono sulle tracce delsegno (delle presenze evidenti in quanto lasciano traccia e rimandano adaltre relazioni, portatrici dei significati incarnati nei loro abiti transi-tanti attraverso le pratiche e i saperi). In questo senso consideriamol’evento del ‘mondo’ come il segreto del mondo: non è un segno enon è un significato perché è appunto sempre l’evento del segno, cosìcome la Lebenswelt è l’evento della ‘vita’, del mondo e del ‘monda-no’: anch’essa è irrafigurabile ed è il segreto, l’imperscrutabile proprioperché è pre-categoriale, ossia accade prima di ogni categoria che laraffiguri in un ‘prima’ che non può stare tra un’ora ed un ‘poi’ mache è la condizione di possibilità della ‘fondazione’ del ‘prima’ e del‘poi’. “Siamo nella gabbia della raffigurazione, non ne usciremomai (uscirne sarebbe un raffigurare l’evento)” – o un riabbracciarecon un solo sguardo la ‘totalità’ della relazione simbolica annullan-do per questo la relazione, decretandone la fine, facendo trionfarela meditatio mortis. “Il mondo, possiamo dire infine, non è da ren-der noto: il mondo è da porre in esercizio” (come l’epoché husserlia-no e la meditazione fenomenologica, direbbero Husserl e Paci): sitratta – avverte Sini – di praticare il suo evento, entrando nel “circo-lo non vizioso della prassi”.50 Si tratta, dirà Paci, di praticare l’eser-cizio fenomenologico.
Paci conclude ricordando di non considerare gli Ego come un’i-deale astrazione. Gli Ego sono concreti: Paci si sta riferendo ai corpi(e pensa soprattutto alla Fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty), alle ‘monadi’ incarnate, al Leib (presenza vivente della mona-de radicata nella Lebenswelt) che si distingue dal Körper (corpo
161
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 161 (Nero/Process Black pellicola)
oggettivato, feticizzato, alienato). Husserl, osserva Paci, parla di unadirezione temporale, “l’irreversibile temporale nel quale le monadiconcrete agiscono e patiscono, nascono e muoiono. Ma non sidimentichi – conclude il filosofo di Monterado – che ciò è possibileper la lebendige Gegenwart e per l’evidenza attuale, e che le monadidanno un senso a se stesse solo se trasformano la direzione irrever-sibile in direzione razionale di una intermonadicità, di una ‘società’razionale che si oppone all’alienazione e alla barbarie.”51
Note al testo
1. E. Paci, Diario fenomenologico, (14 marzo 1956 – 30 giugno 1961), IlSaggiatore, Milano 1961, pag. 8 (da qui in avanti indicheremo il testo conla sigla DF). La Nota introduttiva costituisce un importante documentodel ritorno a Husserl: “pochi dei documenti di questo genere dichiaranole ragioni per cui si sono persuasi a diventare pubblici. Eppure il diarioparrebbe proprio il testimone più adatto a ricevere anche questa confiden-za: come il monologo arrivi a sentirsi colloquio. Tanto adatto che anche iltenerglielo sottinteso fa già diario. Il sottinteso di Enzo Paci è probabil-mente che queste sue pagine risulteranno, come difatti risultano, ancheuna introduzione alla fenomenologia” (pag. 9).
2. DF, pag. 117.3. Salvatore Veca aveva polemicamente preso congedo dal maestro,
come spiega Santucci nel saggio Esistenzialismo positivo ed empirismo nellafilosofia italiana del dopoguerra (in AA.VV., Fenomenologia ed esistenzialismoin Italia, Adriatica Editrice Salentina, Lecce 1981, pp. 11-27), considerando“la svolta impressa da Enzo Paci, sul finire degli anni Cinquanta, al pro-prio relazionismo con la ripresa delle tematiche del tardo Husserl (in par-ticolare di Krisis)”, come “un sostanziale passo falso, un semplice ‘slitta-mento’ di problemi che, attraverso un mero travestimento retorico, siripresenterebbero irrisolti, anzi irretiti in una più rigida veste metafisicache ne precluderebbe l’ulteriore sviluppo, essendovi contraddizione tra ilcarattere aperto del programma relazionistico e il carattere chiuso dell’e-sigenza husserliana di fondazione delle scienze. (...) Rispetto a Veca, chedistingueva tra l’universo ‘retorico’ e quello ‘logico’ della teoresi di Paci,la valutazione di Santucci suona ancora più impietosa, sollevando ladomanda “se tra il relazionismo e la ripresa di Husserl” ci sia un effettivo‘slittamento’ o se il primo non contenga già “il secondo con le sue poten-zialità metafisiche” (...) A Santucci rispondeva indirettamente Carlo Sini,che ribadiva con nettezza l’attualità della prospettiva fenomenologica di162
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 162 (Nero/Process Black pellicola)
Paci” (cfr. A. Vigorelli, La fenomenologia husserliana nell’opera di Enzo Paci,in “Magazzino di filosofia”, n. 5, a. II, 2001/B2, pp. 169-170).
4. Ibidem. “Nella sua relazione Sini individua con acutezza lagenealogia della filosofia di Paci in quella che, con una metafora ardita,potremmo definire la “corrente calda” del platonismo moderno,materialistico e storicistico: la linea Vico-Croce-Husserl-Marx. La strutturaleincapacità di questa tradizione nel rispondere al problema del nichilismo,posto con estrema radicalità da pensatori come Nietzsche e Heidegger, èun’obiezione che non tocca evidentemente solo il programmafenomenologico paciano, ma investe l’intera metafisica dell’occidente. Difronte alla gravità della crisi che minaccerebbe l’intero pensieroscientifico-metafisico su basi umanistico-storicistiche, i “neorazionalisti oneoweberiani dei nostri giorni” non sanno opporre altro che la trivialevisione del “disincanto” del mondo, ossia la visione secondo cui “tuttol’universo è caso e insignificanza (assenza di valore); resta però all’uomola facoltà di decidere se vivere un po’ meglio o un po’ peggio”. Se questo“programma minimo” fosse ormai l’unico cui la filosofia può oggiaspirare, la posizione di Paci conserverebbe paradossalmente una suavitalità. Se l’idea di Paci, di una rinascita della fenomenologia dopol’esistenzialismo, era un’illusione, non si può invece escludere l’idea di unarinascita del pensiero di Paci dopo l’esistenzialismo positivo, che si muovanella direzione, paradossale e estrema, di quella “fenomenologia delnegativo”, parzialmente adombrata nei tardi esiti della sua riflessione”(pag. 171).
5. DF, pag. 12.6. Ibidem.7. “Una delle principali caratteristiche dello stile filosofico di Paci è lo
scrupolo autobiografico con cui egli tende a una continua autostoricizza-zione del proprio pensiero”: le pagine diaristiche e i margini dei suoi librisono fitti di annotazioni che consentono di seguire gli sviluppi della suariflessione. In una nota scritta (a posteriori) in margine al saggio suHusserl di Pensiero, esistenza e valore si legge: “Data del mio ritorno aHusserl dopo il relazionismo: 14 marzo 1956 (risulta dal mio Diario): dallepagine del Diario in questa data nascono i miei due articoli di ritorno allafenomenologia, che sono: 1) Sul senso e sull’essenza, in “Aut Aut”, n. 33,maggio 1956; 2) La natura e il culto dell’Io, in “Aut Aut”, n. 34, luglio 1956(cfr. A. Vigorelli, La fenomenologia husserliana nell’opera di Enzo Paci, cit.,pag.184).
8. E. Paci, Idee per una enciclopedia fenomenologica, Bompiani, Milano1973, pag. 479.
9. A. Santucci, Esistenzialismo e filosofia in Italia, Il Mulino, Bologna1959, pag. 76.
163
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 163 (Nero/Process Black pellicola)
10. E. Paci, Fenomenologia dei processi in relazione, in “Aut Aut”, n. 38,1957, pag. 105. “Su queste indicazioni Merleau-Ponty ha potuto sviluppa-re il suo concetto di ‘ambiguità’: la concretezza antepredicativa, l’espe-rienza non falsata da nessuna formula precostituita, da nessuna teoriadella realtà come fatto o come pensiero, è anteriore sia alle costruzioni delrealismo che a quelle dell’idealismo, è qualcosa che è, nello stesso tempo,soggettivo e oggettivo, e, in tal senso, ambiguo” (ibidem).
11. E. Paci, La fenomenologia e il mondo della vita, in E. Paci, La filosofiacontemporanea, Garzanti, Milano 1974, pp. 162-163.
12. Ibidem. Per Croce, ricorda Paci, non c’è logica se prima non c’è‘intuizione’; ma l’intuizione di Croce non riesce a cogliere le figure essen-ziali, bensì si limita ad essere conoscenza del particolare. “Per Husserlinvece, l’intuizione è diretta verso essenze permanenti, verso figure chedanno contenuto e senso al discorso logico” (pag. 163).
13. C. Sini, La fenomenologia, Garzanti, Milano 1965, pag. 35.14. Ivi, pag. 163.15. Cfr. E Paci, Critica dello schematismo trascendentale (I & II parte), in
“Rivista di filosofia”, 1955.16. E. Paci, Il senso delle parole, (1963-1974), a cura di P.A. Rovatti,
Bompiani, Milano 1987, pag. 33. Nelle pagine di “Aut Aut” intitolate Ilsenso delle parole, scritte tra il 1963 e il 1974 e in seguito raccolte in un libroa cura di Pier Aldo Rovatti (Bompiani 1987), Paci chiarisce i termini usatinei suoi saggi fenomenologici, fornendo al tempo stesso la propria ‘intro-duzione’ a Husserl.
17. Ivi, pag. 164.18. Ibidem. Questo passaggio rimanda ad un altro importante scritto di
Paci del 1957 dal titolo Sul significato del platonismo in Husserl, in “ACME”,nn. 1-3, pp. 135-151, che riprende sostanzialmente la validità dell’intuizio-ne eidetica che permette una lettura platonica della fenomenologia relazio-nistica, dove però il platonismo non è da intendersi nel senso tradiziona-le, bensì come esplicitazione di una essenziale capacità, o meglio, disponi-bilità alla visione di ciò che costituisce l’essenza delle “cose stesse”, al finedi ricomprendere il ‘reale’ secondo una prospettiva teleologica, a partiredall’esistenza dell’uomo che di ogni significato è ‘portatore’: gli eidos assu-mono la valenza di ideali eterni (sepolti nella Lebenswelt occultata) cui ten-dere attraverso un’etica del soggetto da riscoprire attraverso la ricerca feno-menologica, che sia in grado di rifondare la ‘vita’ e quindi ogni ‘scienza’(che dalla vita nasce). Scrive Paci: “La mia filosofia è ancora oggi condizio-nata da quella tesi di laurea. Come nel 1934 il problema, il Rätsel, perusare un termine caro a Husserl, è il problema della relazione, il proble-ma del tempo e della verità, il problema della terza ipotesi del Parmenide.(...) Ideen I sarebbe la conferma in senso ‘eidetico’ del primo Husserl,
164
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 164 (Nero/Process Black pellicola)
l’Husserl platonico. Il secondo Husserl, di cui il pensiero si esprime nellaforma più matura in Die Krisis der europäischen Wissenschaften, sarebbel’Husserl filosofo dell’esperienza, della Lebenswelt, della storia. Il duali-smo che domina l’opera husserliana sarebbe, in fondo, una nuova emoderna edizione del dualismo platonico” (pag. 135).
19. E. Paci, La filosofia contemporanea, cit., pag. 165.20. Nel Paragrafo 49 della parte prima delle Idee, Husserl dice che la
coscienza, in quanto si trascende ma rimane immanente, è ‘trascendenta-le’: “il mondo della res trascendente è assolutamente relativo alla coscien-za, non come logicamente immaginata, ma come attuale.”
21. La coscienza ‘attuale’, potremmo dire, che si ‘sorpassa’ nelle figureproiettate come trascendenti, è la vita stessa nella sua concreta e semprepresente realtà: “la vita che vive sorpassandosi nella direzione di possibi-lità intuite, raffigurate, logicamente immaginate. La coscienza, in quantovita trascendentale, non è dunque un principio astratto, un’attività mera-mente psicologica, ma è l’atto della vita nella sua concreta pienezza: è,direbbe Whitehead, una realtà ‘ultima’” (E. Paci, La filosofia contemporanea,cit., pag. 167).
22. E. Paci, Fenomenologia dei processi in relazione, in “Aut Aut”, cit., pag.106.
23. DF, pag. 13.24. Cfr. E. Paci, Fenomenologia dei processi in relazione, in “Aut Aut”, cit.,
pag. 113.25. E. Paci, Commento al manoscritto E III 5, in “Archivio di filosofia”, n.
2, 1960, pag. 22.26. E. Paci, Bilancio della fenomenologia, in E. Garin, E. Paci, P. Prini,
Bilancio della fenomenologia e dell’esistenzialismo, Liviana, Padova 1960, pag.75. L’evento, potremmo aggiungere, è ciò che non è mai esprimibile nel lin-guaggio discorsivo, nella logica proposizionale: esso appartiene alla logi-ca del che, ossia del ciò che accade perché accade. Ogni ‘discorso’ inveceesprime un significato e pertanto ‘rappresenta’ la soglia entro cui si ‘confi-gura’ l’evento (della verità, la ‘condizione’ prospettica): si tratta quindi diuna ‘logica’ del come (ossia del come accade ciò che accade). La fenomeno-logia restituisce all’evento, attraverso la sospensione del giudizio, ossia diogni ‘significato’, la sua rigorosa ab-solutezza. Le “cose stesse” ci sono, “masempre nel loro modo d’essere in una pratica; ovvero che non ci sono coseil cui modo d’essere non sia relativo a una pratica. Ma non è che ci sianoin quanto sono relative a una pratica; diciamo che sono così: relative a una pra-tica, non che la pratica sia la causa del loro esserci; piuttosto è la ‘modali-tà’” (C. Sini, Idoli della conoscenza, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000,pag. 241).
27. DF, pag. 101.
165
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 165 (Nero/Process Black pellicola)
28. Cfr. E. Paci, Tempo e relazione intenzionale in Husserl, in “Archivio difilosofia”, n. 1, 1960, pag. 23. Il saggio è in seguito confluito in Tempo e veri-tà nella fenomenologia di Husserl, Laterza, Bari 1961 (da qui in poi indicatocon TVF), andando a costituire il fondamentale capitolo VII: Il tempo e ilsenso dell’essere.
29. Ivi, pp. 24-25.30. Ibidem.31. “La dipendenza (...) è una relazione coesistenziale (...). Dice proprio
così (lo ripeto perché potrebbe sembrare troppo d’accordo, questo punto,con il mio relazionismo): beziehende Koexistenz” (ivi, pag. 25).
32. Ibidem.33. Cfr. G. Brand, Mondo, Io e tempo nei manoscritti inediti di Husserl, tra-
duz. di E. Filippini, prefaz. di E. Paci, Bompiani, Milano 1960, pp. 85-112.“L’Io è nella vita che esperisce il mondo ma questa non si riduce all’Io:resta sempre più vasta. (...) La ‘fungenza’ della vita che esperisce il mondoè più vasta del Selbst” il quale risulta da qualcosa di più originario dellavita individuata. “La vita che esperisce il mondo ha una sua forma, laforma egologica. Questa forma è un momento particolare del fluire dellavita fungente originaria. (...) Il Selbst è qualcosa che si fa, che “avvienenella vita fluente diffluente: è una modalità strutturale del fluire origina-rio. (Husserl C II 1, p. 7)” C’è sempre dunque un relazione vivente costi-tuita dalla vita fungente ed esperiente e dal suo fluire come Selbst. La vitafungente e il Selbst sono in una koinonia che è poi l’implicazione dell’infi-nito fluire del fungere nei momenti egologici finiti in cui defluisce, la pre-senza della vita stessa nel percepire del Selbst, il rivelarsi della vita stessanella percezione presente e cioè nell’evidenza della percezione” (TVF, pp.125-126).
34. Ivi, pp. 68-69 passim; (il corsivo nel testo è nostro). Lo “sguardoretrospettivo” si presta molto bene a descrivere in altri termini il ‘movi-mento’ di retroflessione e anteflessione attraverso il quale possiamo rav-visare l’origine di ogni esperienza interpretativa, l’evento del significato.In altri termini, riferendosi soprattutto a Dewey e a Whitehead, anchePaci aveva, fin dai primi saggi di “Aut Aut”, descritto fenomenologica-mente le ‘modalità’ temporali dell’esperienza: le medesime modalità chenei termini husserliani vengono svolte dal ‘movimento’ delle protenzionie ritenzioni.
35. In proposito è sufficiente citare il fascicolo monografico di “AutAut” (n. 54, 1959) dedicato interamente a Husserl, dove Paci, nel saggiointitolato Sul significato dello spirito in Husserl, afferma che “fondare tra-scendentalmente è fondare sull’originario e, in ultima analisi, sull’ante-predicativo, sulla Lebenswelt. Lo Spirito, in quanto si incarna ha in sé laLebenswelt che è, in un certo senso, il suo reciproco potenziale, la matrice
166
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 166 (Nero/Process Black pellicola)
che lo contiene in forma latente, così come contiene potenzialmente tuttele categorie logiche e le stesse categorie scientifiche” (pag. 352). Lo ‘spiri-to’ è nient’altro che la relazione intenzionale: “il Geist, per molti aspetti,non è altro che l’intenzionalità, soprattutto nel senso nel quale si può direche l’atto intenzionale intenziona una visione teleologica, un’idea infinita,che è poi l’idea dell’umanità immanente nella storia ed eminentementerappresentata dall’Europa. Il telos spirituale è l’idea della ragione che vivenella storia che dà un senso alla storia” (pp. 345-346).
36. Cfr. l’Introduzione di Paci a G. Brand, op. cit., pag. 21.37. C. Sini, Temporalità del mondo e temporalità degli ego, in Introduzione
alla fenomenologia come scienza, Lampugnani Nigri, Milano 1965, pag. 198.38. Il tenere a distanza è anche e soprattutto ciò che costituisce la “rela-
zione simbolica” come la relazione originaria in analogia con la Lebenswelt,nel senso di dimensione simbolica originaria. Possiamo ora aggiungere che la‘presenza’ stessa dell’io che esiste solo in relazione ad un ‘mondo’ (“oriz-zonte di tutti gli orizzonti”) è da considerarsi come symbolon (rapportosimballico): “la relazione simbolica non è altro che l’accadere della distan-za come segno (o nel segno); essa, si potrebbe dire, è la fessura del segno(ciò che lo determina nel suo essere segno, cioè rimando). La fessura è unassumere la presenza (ogni presenza) come aver-da-essere l’assenza chenel segno si annunzia (nella presenza l’assenza si fa segno). Ciò equivalead assumere la presenza come rinvio, in base al quale l’Altro, l’assente, èassunto come Oggetto del segno (ciò a cui il segno rinvia). Per la relazio-ne simbolica, però, l’assente, l’Altro, è ancora lo Stesso, donde si è prodot-ta la distanza” (C. Sini, Immagini di verità, Spirali, Milano 1985, pag. 148).
39. C. Sini, Introduzione alla fenomenologia come scienza, cit., pag. 199. 40. E. Paci, Osservazioni preliminari allo studio della fenomenologia, in “Aut
Aut”, n. 50, 1959, pag. 80.41. Cfr. il § 24 di G. Brand, op. cit., pp. 214-221 passim.42. G. Brand, op. cit., pag. 23.43. Ivi, pp. 23-24.44. Whitehead direbbe la lotta contro ogni “concretezza mal posta”.
L’orizzonte filosofico del relazionismo è caratterizzato da due punti divista fondamentali: il tempo e la relazione. Anche il problema della liber-tà e il problema del valore devono essere esaminati in rapporto a tempo erelazione. Il relazionismo non è né idealistico né realistico: esso si appellaad una ‘struttura’ di fondo anteriore ad ogni distinzione categoriale. La‘struttura’ cui si fa appello è analoga alla Lebenswelt di Husserl ed è rag-giungibile solo mediante la riduzione fenomenologica (per questo si dice cheè originaria ed elementare): “L’originario non è la teoria dell’originario mala nostra inserzione nell’originario stesso resa possibile dalla riduzione edalla intenzionalità. La nostra percezione si inserisce nell’originario.
167
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 167 (Nero/Process Black pellicola)
Nell’originario l’alterità si presenta come percezione e la percezione stes-sa è nell’alterità” (TVF, pag. 202).
45. E. Husserl, Logische Untersuchungen, Halle 1928, II, 1, pag. 259.Questa è l’edizione che cita Paci in Tempo e verità. Riportiamo la citazionedal saggio di Paci Tempo e relazione intenzionale (pag. 26). In riferimento aquanto si è detto sul tempo in relazione al cogito, Paci, poco più avantiaggiunge: “se Io sono il cogito, le altre isole sono i cogitata. Ma può acca-dere che un cogitatum sia cogito ed Io, per lui, il cogitatum. Così il tempo siapprofondisce come relazione e la relazione vive come tempo” (pag. 29).Sarebbe inoltre interessante approfondire l’analogia di questa ‘struttura’relazionale della fenomenologia husserliana con la ‘struttura’ relazionale-circolare del “triangolo semiotico” nella faneroscopia di Peirce, nellaquale il rinvio del segno è inteso come “essere per altro” e il perfetto carat-tere significante del segno sta in una sorta di circolarità ellittica (nellaquale l’interpretante è sempre anche segno e oggetto per un altro inter-pretante), dove il significato stesso si trova nelle ‘pieghe’, nelle distanze,nei ‘transiti’ (nelle tipiche modalità temporali) più che in uno dei tre poli.Questo fa inoltre pensare a due autori che Paci conosceva a fondo: Goethee Leibniz. Pensiamo soprattutto alla metamorfosi goethiana e alle continui-tà leibneziane. Paci si occupa della ‘monade’ in riferimento a Leibniz e aHusserl (E. Paci, Il problema della monadologia da Leibniz a Husserl), anche se,seguendo Leibniz e la lezione relazionistica di Paci, non si dovrebbe par-lare di ‘monade’ ma di monadare: espressione efficace e analoga al “simbo-lo formante” di Klee, alla ricerca deweyana o al processo di Whitehead.
46. Possiamo approfondire quanto si è detto sintetizzando la parte cen-trale del saggio di Paci: La concezione relazionistica della libertà e del valore (inTVF, pp. 202-207). La struttura del mondo presente nella percezione èstruttura come bisogno, come esigenza, come finitezza. Ciò che non è per-cepito è paradossalmente percepito come mancanza: “il non percepito pre-sente come mancanza nella percezione è collegabile a ciò che non so diaver percepito ieri e che pure oggi mi costituisce, così come oggi sonocostituito da percezioni che soltanto nel futuro saprò di aver percepito”(p. 203) Questa concezione è riferita da Paci come uno sviluppo delleVorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. La temporali-tà è secondo Paci “consumo e bisogno” e l’irreversibilità è condizionante:costringe al lavoro per la soddisfazione del bisogno e per questo, ‘costrin-ge’ ogni forma vivente, per agire, operare e lavorare, ad uscire da sé, ossiaa “riconoscersi di fatto nell’altro e riconoscere l’altro in sé, ponendosi inconcreta ed effettiva reazione con tutti i processi della natura”. Inoltre,l’irreversibilità pone “la conclusione di ogni processo finito nell’inevitabi-lità della morte” (...). La struttura come bisogno ed eros è una ‘domanda’,dice Paci, è il problema della ‘domanda’.
168
Alessandro Sardi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 168 (Nero/Process Black pellicola)
47. TVF, pag. 71.48. Cfr. TVF, pp. 71-72.49. “L’infinità del tutto si presenta in ogni percezione finita. La perce-
zione non è mai dunque atomica come pretende il neopositivismo, ma èsempre relazionata. In essa l’infinito è presente nella parte finita anche seè assente in quanto la parte è appunto finita” (TVF, pag. 202).
50. Cfr. C. Sini, Il segreto del mondo e il senso del foglio-mondo, in , Laterza,Bari 1997, pp. 184-198 passim.
51. TVF, pag. 72.
169
La fenomenologia dei processi in relazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 169 (Nero/Process Black pellicola)
INTERVISTA A EMILIO RENZI(a cura di Massimiliano Cappuccio)
EDITORIA, PERIODICI E CONFERENZE:ENZO PACI FUORI DALL’UNIVERSITÀ
[Chora] Il lavoro di Paci come filosofo teoretico è ben notoperché tuttora studiato e perché facilmente documentabile dal-l’ampia mole dei suoi saggi, delle sue curatele e delle sue tradu-zioni. Ma Paci fu protagonista anche di un altro tipo di impegnointellettuale, oltre a quello propriamente accademico: ci riferia-mo alla sua intensa attività di editore ed organizzatore culturale,che si espresse non solo attraverso la conduzione della rivista“aut aut”, ma anche nel corso degli anni della collaborazionecon la casa editrice Il Saggiatore, per la quale pianificò la pub-blicazione di alcune importanti collane (come “La cultura”) edove ebbe modo di operare al fianco di personaggi influenti,come Remo Cantoni, Giacomo Debenedetti, Alberto Mondadorie molti altri. Vorremmo chiederLe di approfondire, a partiredalla Sua esperienza diretta di collaborazione, questi aspettidella progettualità paciana e della sua aspirazione più autentica,eventualmente permettendoci di comprendere meglio anche lasua vocazione all’impegno e il suo profilo personale dal puntodi vista professionale.
[Renzi] “Ecco il mio professore”, esclamavo quando Enzo Pacilo vedevo arrivare puntuale alle riunioni del Saggiatore, in viaBianca di Savoia e più tardi in corso Europa, la borsa piena dischede di lettura, bozze e “sedicesimi”, testi per le “quarte di
171
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 171 (Nero/Process Black pellicola)
copertina”. E quanto ad “aut aut”, che fondò nel 1951 e diressesino alla morte nel ’76, lo “faceva” lui, anche se in redazione peralcuni anni vi fu una personalità del calibro di Giovanni Raboni.Scri-veva lettere, faceva telefonate di sollecito – naturalmente, svi-luppava la linea culturale che aveva presieduto alla sua nascita earmonizzava un nu-cleo di collaboratori di vaglia – Gillo Dorfles,Glauco Cambon, Roberto Sanesi, Marco Forti, Aldo Tagliaferro. Inseguito e man mano, i giovani allievi: Guido Davide Neri, EnricoFilippini, Andrea Bonomi, Giovanni Piana, sino a Salvatore Veca ea Pieraldo Rovatti con cui si ebbe una breve direzione “a tre” (oracom’è noto la dirige Rovatti).
Da questi primi cenni si capirà che l’editoria non era per Paci un“di più” rispetto al suo lavoro di docente né alla sua personalericerca in filosofia. Era l’altro lato dello stesso impegno, quello“pubblico”. Una tensione verso un pubblico più ampio di quellodelle aule universitarie milanesi e dei “colleghi” della sua e dellealtre Facoltà. Un pubblico di persone colte, in tutta Italia, e di per-sone, specie giovani, in cerca di cultura. Quale cultura?
Beh, in quegli anni a partire dal 1959 proprio quella che la col-lana “La Cultura” del Saggiatore avrebbe costruito nelle intenzio-ni del suo fondatore, Alberto Mondadori, figlio grande e inquietodel grande Arnoldo Mondadori. Una cultura europea (Sartre,Mann, Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Karl Jaspers), una cultura cherileggeva la storia profonda d’Italia (Ernesto de Martino) , la clas-sicità greca (Ranuccio Bianchi Bandinelli) – e indivisibilmente l’ar-te (Giulio Carlo Argan), l’architettura, l’antropologia (RemoCantoni), la storia (Bruno Maffi), la critica letteraria (GiacominoDebenedetti), l’estetica (Guido Morpurgo Tagliabue). Saggisticainsomma a tutto spettro. Una lettera di Alberto a Sartre: “nasceràuna nuova Casa editrice, una casa cui ho dato il mio nome, e cheavrà come suo principale impegno quello di diffondere libri digrande importanza nella storia della cultura, delle arti, delle dot-trine e del costume”.
Tenacemente Alberto intendeva anche riavviare una collanadella Mondadori che si chiamava “Il pensiero critico” e che inapparenza non aveva un direttore proprio ma che sappiamo pen-sata e voluta da Alberto. Una ventina di titoli di saggistica alta, percerti versi distante dal modello generale delle collane Mondadori edi conseguenza poco considerata e poco valutata dai vertici azien-dali. È in quella collana che Paci aveva pubblicato Ingens Sylva, ilsuo saggio su Vico, e raccolti gli scritti degli anni ‘50 su storicismo172
Emilio Renzi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 172 (Nero/Process Black pellicola)
ed esistenzialismo. In quella stessa collana erano apparsi La coscien-za inquieta di Remo Cantoni, il Baudelaire di Sartre, I problemi di tuttidi John Dewey – un libro importante oggi dimenticato – e ancoraEupalinos di Paul Valéry, prefazione di Paci.
In che modo l’esperienza e lo stile di Paci accompagnaronoconcretamente la crescita del Saggiatore, influenzandone lo svi-luppo, e quali contributi specifici possiamo ascrivere al suointervento nell’ambito editoriale?
Certo, quando nei cataloghi del Saggiatore di allora e di oggi, enegli scaffali di tante librerie, vediamo e continuiamo a vedere laCrisi delle scienze europee di Husserl, la Critica della ragione dialetticadi Sartre, e i Merleau-Ponty… insomma gli imprescindibili titolidella filosofia moderna che più tardi sarebbe stata detta “continen-tale”, l’associazione al nome di Paci è automatica. Ma credo chequesto – che pure è tanto! – non sia che una parte del discorso.
Se prendiamo tra le mani il catalogo n. 3 (autunno-inverno 1959-‘60) del Saggiatore troviamo uno scritto di Paci intitolato Nulla dinuovo tutto di nuovo. È la presentazione della collana “La Cultura”– non solo i titoli di filosofia che graficamente si distinguevanodagli altri per un filetto di colore arancio. “Per la collana de IlSaggiatore – scrive Paci – la parola cultura indica, nello stessotempo, la relazione dei vari campi e la specializzazione. Non siperde nella scienza per dimenticare l’arte, o nella storia per dimen-ticare la letteratura… Nulla di nuovo per l’uomo, e d’altra parte enello stesso tempo, tutto di nuovo, se davvero la cultura è ripresadella vita del passato e rinnovamento del presente per il futuro.”Come non sentire l’eco dell’husserliano immer wieder, “sempre dinuovo”? In quelle cinque pagine Paci scriveva di libri che riguarda-vano l’etnoantropologia e la cibernetica, le origini del monoteismocristiano e la grande letteratura tedesca, la Crisi di Husserl e i Diaridi Paul Klee. Nel Catalogo generale 1958-1965 apparve unaInchiesta su strutturalismo e critica, a cura di Cesare Segre, che era inrealtà un vero e proprio libro di una settantina di pagine: Paci viaveva contribuito con una Nota su de Saussure.
Quello che voglio dire è che Paci nell’editoria non fu uomo disettore ma di cultura vasta, curiosa e “interdisciplinare” (comeallora non si diceva ma si faceva – o quanto meno gli allievi di Banfifacevano…). Larghezza di letture classiche e spirito di ricerca nellesopravvenienti, senza obbligati entusiasmi verso il nuovo in quan-
173
Editoria, periodici e conferenze: Enzo Paci fuori dall’università
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 173 (Nero/Process Black pellicola)
to tale, il “novismo”. Erano del resto tratti fondamentali della suapersonalità ed era la nuova cultura della “scuola milanese”, perusare la felice espressione di Fulvio Papi. Non dimentichiamo chePaci non perse i contatti con la collana di filosofia che AntonioBanfi aveva fondato presso Bompiani, “Idee Nuove”: ne sonoprova le traduzioni di Mondo io e tempo nei manoscritti inediti diHusserl di Gerd Brand, altre traduzioni da Husserl.
E per quanto riguarda le altre attività culturali di Paci al difuori dell’università?
“Rivista di filosofia e di cultura”, era la dizione che campeggia-va sulla copertina di “aut aut”, dalla fondazione sino alla svoltaintorno al 1968 (e al Sessantotto). La parola “cultura” va sottolinea-ta. Si può dire che, “ a vista”, ogni numero era fatto a metà: unametà delle pagine dedicata alla filosofia, l’altra alla letteratura,all’arte, alla critica letteraria, alla psicologia, alla psicanalisi, allacritica d’arte, a quelle che poi saranno chiamate le scienze umane.Meno, alla filosofia della scienza. Questo è un dato di fatto che misembra oggi obliato. Quelli erano anni (anche) di riviste. In parti-colare “aut aut” veniva comprata e letta da pittori, da poeti, damedici umanisti, dalle persone di cultura che sapevano anche difilosofia oppure che di filosofia non sapevano niente ma che coglie-vano il respiro, gli intrecci e gli slarghi di una rivista che al tempostesso snidava e formava i propri lettori. Qualcosa di quella fortu-na “aut aut” se la porta dietro ancora oggi, a distanza di tanti anni!,è venduta in libreria, non è “per pochi intimi”… ristretti nel cerchioaccademico. Si pensi per contro che sfogliando le annate si trovanoun numero speciale dedicato a Mann di fianco a quello dedicato aHusserl e poi uno monografico su Carlo Cattaneo… il passo didebutto della rivista fu uno scambio epistolare tra Mann e Paci.
Un’altra rilevante attività “mondana” di Paci, nel senso di undiscorso pubblico extra moenia, era parlare come conferenziere. Fuil curatore di un ciclo di trasmissioni radiofoniche per quello cheallora era il Terzo Programma, oggi RadioRai Tre: nel corso del-l’anno 1960 tenne un ciclo di letture intitolato proprio La fenomeno-logia nella cultura contemporanea. Se ne ripercorriamo i contenutinotiamo che naturalmente Husserl si prendeva metà delle trasmis-sioni, ma non c’era solo Husserl, perché si parlava anche diScheler, Sartre, Merleau-Ponty, Heidegger, e poi di fenomenologianell’arte e nella letteratura. Questo era l’aspetto più evidente di174
Emilio Renzi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 174 (Nero/Process Black pellicola)
Paci fenomenologo, che era filosofo dell’enciclopedia del saperefino al punto di esser capace di ribaltare il baricentro del suo stes-so discorso per far comprendere quale poteva essere la chiave dilettura più proficua e quali vantaggi avrebbe dato la fenomenolo-gia negli altri campi di sapere.
Quando tenne conferenze su Les mots, Le parole di Sartre appenauscito in italiano (per il Saggiatore, ça va sans dire…) Paci scandiva ilsuo lavoro con una formula di questo genere: lunedì a Torino, mar-tedì a Milano, mercoledì a Firenze, giovedì a Roma e così via. Qui aMilano la conferenza ebbe luogo al Piccolo Teatro, in via Rovelloallora sede unica, e c’era tanta gente. Paci parlava calmo e chiaro.
Un altro aspetto ancora del Paci extra moenia è quello della suacollaborazione a giornali e riviste. Non mi riferisco alle riviste spe-cialistiche di filosofia o tra letteratura e filosofia come “Questo ealtro” nella seconda età dei Sessanta. Parlo invece in maniera pre-cisa a una rubrica che tenne nei primi Settanta per un settimanaleillustrato oggi dimenticato, “Tempo”. Era un settimanale vivace inbattaglie su una linea, come dire, “radicale di sinistra”, che cercavadi aprirsi la strada tra i settimanali allora fortissimi, come“l’Espresso”, “Panorama”, (all’epoca sodi in cultura e battagliepolitiche), l’”Europeo”. Per dire il tono: l’ultima pagina del“Tempo” ospitava gli scritti di Pier Paolo Pasolini che sarebbero poiconfluiti nella raccolta Scritti corsari.
Ecco i titoli di alcuni articoli che Enzo Paci pubblicò in quel con-testo: Sartre: amore e morte, Freud e la rivoluzione dell’uomo, L’enigmaLudwig Visconti e Thomas Mann, Ateismo nel cristianesimo e cristiane-simo nell’ateismo, Husserl e Marx a Praga, La situazione limite diBataille. È il Paci che ha portato alle estreme conseguenze la sceltadel Sessantotto, guidata dal trinomio Husserl-Marx-Gramsci,orientata in un senso antioggettivistico e anticapitalistico. Unavisione che potremmo definire radicale, se usiamo la parola sullaspinta del suo significato originale – Marx si autodefiniva un radi-cale e la parola in America vuol dire libertario di sinistra. Quellodegli ultimi anni dunque è un Paci che a tratti torna su se stesso ea tratti ascolta le voci dell’oltremondano, un Paci homme qui cerche.Questo fa sì che a un certo punto, parlando del telos dell’umanità,arrivi a sostenere che in questo telos c’è il cristianesimo apocalitticodel Vangelo di Giovanni. Evidentemente si tratta del cristianesimodi Cristo spogliato di ogni sua possibile valenza terrena, storico-ecclesiastica. Mi pare di dover concludere che in questa sua attivi-tà pubblicistica alquanto dimenticata Paci fosse tornato ad applica-
175
Editoria, periodici e conferenze: Enzo Paci fuori dall’università
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 175 (Nero/Process Black pellicola)
re a se stesso lo stimolo del “sempre di nuovo”, sia pure conmovenze non distese. Cominciava del resto ad avere problemi disalute, era stanco e febbrile insieme, la malattia della moglie loaveva gravemente ferito.
Se li si rileggono oggi, quegli interventi – peraltro brevi – sul“Tempo”, attraverso e dopo la radicalizzazione del Sessantotto edella prima metà dei Settanta, forse non sono tra le sue cose miglio-ri, le ripetizioni si alternano alle illuminazioni, ma ne vien fuorianche un’idea del filosofo che non è nella torre d’avorio e non èsolo un didatta, ma elabora strumenti teorici capaci di misurarsi siacon i grandi problemi del pensiero – ovvero con l’ontologia, la filo-sofia prima – sia con i problemi che il tempo non ti manda a direma che ti fanno resistenza attiva e per i quali occorre intervenire. Èla figura quindi di un filosofo poliedrico, se vogliamo anche unuomo di errori – che d’altronde sempre si rischia di commetterequando si decide di non stare al caldo della serra.
Come possiamo valutare complessivamente il contributo for-nito da Enzo Paci alla crescita della cultura italiana nei duedecenni che seguirono la fine della guerra?
Che il contributo fornito da Paci sia stato essenziale alla ripropo-sizione della filosofia classica europea del primo Novecento, allosviluppo autonomo dell’esistenzialismo di marca tedesca e france-se e così via, è giudizio assolutamente fuori discussione – ma iovorrei far notare piuttosto che di tutti gli allievi di Banfi, Paci èstato l’unico a dialogare con Benedetto Croce ossia con la filosofiaclassica italiana (a sua volta connessa alla filosofia classica tedescadel primo Ottocento…). Croce come si sa accettò di buon grado loscambio culturale con uno studioso di due generazioni più giova-ne di lui. Paci aveva quindi una sua idea e una sua “politica” dellosviluppo culturale italiano. La sua posizione, a differenza di quel-la di un Giulio Preti, non era accanitamente anti-idealistica. Era laposizione di un filosofo della cultura per il quale tutto è dialogabi-le e verificabile.
Le proponiamo anche di esprimere un’opinione sullo statoattuale dell’editoria italiana e delle sue politiche culturali,attraverso una fantasia controfattuale, che ci aiuta a misurare ladifferenza tra la nostra realtà e il clima di quegli anni: che ruolopotrebbe essere assolto oggi da una figura come quella di Enzo176
Emilio Renzi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 176 (Nero/Process Black pellicola)
Paci nel contesto della nostra cultura, e come giudicherebbeegli la situazione odierna?
È una domanda molto difficile. Si potrebbe notare che un tempoc’erano collane di filosofia molto chiare, molto scandite. Primadella Grande Guerra e negli anni ’20-’30, c’era Bocca, ci fu soprat-tutto la Laterza di Croce e Gentile, poi solo Croce mentre Gentileacquisiva e rilanciava la Sansoni. Verso la fine degli anni ‘30 iniziaIdee nuove di Banfi, con Valentino Bompiani. Vedono quindi la lucenel dopoguerra la collana “gialla” Einaudi (Biblioteca di cultura filo-sofica) e la “verde” della Nuova Italia: inizia dunque la storia dellecollane di filosofia come strumenti, come contenuti… Storie note, eabbiamo visto che “La cultura” del Saggiatore non era una collanasolo filosofica per quanto articolata al proprio interno. Coeva è lacollana “gialla” di Geymonat per la Feltrinelli, specifica per logicae filosofia delle scienze. Oggi non ci sono più queste colonne “ver-ticali”, dai “colori” così distinti; collana di filosofia per antonoma-sia, oggi, è quella diretta da Giovanni Reale, “Il pensiero occiden-tale”, dove sono pubblicati classici che arrivano fino alla moderni-tà, con Gadamer. La UTET prosegue imperterrita i suoi “Classici”,cartonatissimi… Una collana che riprende certi spunti delSaggiatore è quella di Giulio Giorello presso Cortina, che si articolain maniera vivace – libera e libertina…
La situazione dell’editoria italiana oggi è una situazione dimeticciato: c’è tutto e il contrario di tutto, e questo qualche voltaconsente che nuove iniziative sorgano, mentre altre volte lo impe-disce. Oggi pubblicare un libro è meno complicato di una volta dalpunto di vista tecnico, anche se lo è molto di più dal punto di vistadistributivo. Dal punto di vista tecnico basta essere in due: unapersona e un computer, più una terza che finanzia. Una volta nonera così, ci voleva un’industria, impianti enormi. Viceversa ladistribuzione impone strozzature rilevanti poiché è quasi comple-tamente monopolizzata, con un 30% a Feltrinelli che seleziona concriteri economici rigorosi. Ma arrivo al punto che credo interessi dipiù voi e i lettori.
Bene, io credo che Paci, nel mondo di oggi, continuerebbe adessere disperatamente, pertinacemente ottimista, pur portandosidietro tutte le angosce, il male dell’esistenza e i fantasmi dellaguerra che lui visse in prima persona, nei ranghi di quella “Armatadel no” che furono i 700mila militari internati negli stalag germa-nici (dove non perse battuta: ai commilitoni, anzi “Agli amici delle
177
Editoria, periodici e conferenze: Enzo Paci fuori dall’università
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 177 (Nero/Process Black pellicola)
‘sere’ di Beniaminowo”, come suona la pudica dedica dei saggiraccolti in Esistenza e immagine, parlava di Mann, Eliot, Rilke,Valéry, Proust…)
Credo questo perché Paci diceva e direbbe che il telos dell’uma-nità è un orizzonte che si sposta sempre. Abbandonata l’illusionedella rivoluzione “lunedì mattina”, cioè a brevissimo, il senso dimarcia è quello di un’intenzionalità di cui deve farsi carico l’enci-clopedia del sapere, orientata sempre verso la progettualità dotatadi senso. Forse la migliore risposta viene data proprio dal pro-gramma di “aut aut”, che si richiamava ad una scelta radicale, a unbivio: un famoso movimento politico in Francia aveva coniato l’e-spressione secondo cui l’umanità era al bivio tra la barbarie e ilsocialismo. Definire il socialismo – oggi – è difficile, ma è un con-cetto che viene da socius. Vuol dire ricostruire una comunità di soci,in cui si vive e si lavora e si configge e si coopera nel dialogo davicino e tra vicini.
178
Emilio Renzi
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 178 (Nero/Process Black pellicola)
MASSIMILIANO LUCE
ENZO PACI E L’AMERICA
N egli anni successivi alla seconda guerra mondiale, furononumerosi gli intellettuali italiani che si confrontarono con la cul-tura americana. Tra questi vi fu anche Enzo Paci. Sul secondonumero di Aut Aut, il filosofo italiano pubblicò nel 1951 l’articoloMoby Dick e la filosofia americana. L’anno successivo, nel 1952, suldecimo numero fu la volta di un articolo intitolato Sull’estetica diDewey1. Entrambi questi interventi risultano fondamentali percomprendere sia gli sviluppi e gli esiti della fondazione di unnuovo individualismo dopo l’esperienza del Lager tedesco sia alcu-ni termini dello slittamento concettuale della filosofia paciana dal-l’esistenzialismo positivo degli anni ’30 e ’40 al relazionismo deglianni ’50. I due argomenti rappresentano due momenti dellamedesima riflessione. In Paci, difatti, l’analisi teoretica non si sepa-ra mai dal desiderio di dire qualcosa di concreto sul mondo.
1. Moby Dick, ovvero la possibilità del bene
L’interesse per la letteratura e la filosofia americana ha, per Paci,prima di tutto motivi autobiografici: “È nei campi di concentra-mento tedeschi che per me, e per alcuni amici e lettori di questa riv-ista, la letteratura, e poi la filosofia americana, diventarono unanuova scoperta”2.
La lettura della Lettera scarlatta di Hawthorne e di Moby Dick diMelville suscitarono, nel Paci prigioniero del Lager, un senso di
179
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 179 (Nero/Process Black pellicola)
“rivelazione” e di “stupore mitologico”. La prova del fronte fudecisiva per “sciogliere definitivamente certi ambigui nodi colpassato fascista”3: “Si ha la sensazione, da principio, e in seguitola certezza, che qualcosa è finito, che un periodo si è concluso; sicerca di ricostruire la propria vita per denunciarne gli errori, siripensa ai nostri atti di scelta di fronte agli avvenimenti che cihanno costretti ad una decisione, si conquista infine la fede che sipuò e deve ricominciare. Potrebbe essere un ritorno alla storiacome azione dopo la riflessione, il pensiero, la ricostruzione storicadel passato nel presente”4.
Paci riafferma così un’esigenza etica e personale dell’impegno,una serie di scelte esistenziali che si identificano con la respons-abilità dell’individuo di fronte agli avvenimenti, “perché laresponsabilità è sempre del singolo ed è in questa esperienza chesi scopre, e si deve scoprire, l’unica vera ed autentica solitudine”5.Solo attraverso questa esperienza radicale è possibile ritrovare sestessi, “e i singoli che hanno ritrovato se stessi si riaprono allacomunicazione e ricostruiscono dall’interno un nuovo rapportocon gli altri”6 Ecco, al centro della filosofia di Paci si pone il tenta-tivo di comprendere i rapporti tra i singoli, un’analisi che sulpiano metafisico si pone come indagine sulle relazioni tra l’uno eil molteplice, sull’identico e la diversità, sul bene e il male. Di quil’interesse di Paci per la letteratura e la filosofia americana: “Comeha notato Paul Valery l’enigmantico di Poe era il punto metafisiconel quale si fondono la diversità e l’identico, l’unità e la molteplic-ità: egli lo risolve annullando i due termini. Era un nuovo modo diidentificare il bene e il male. Per Hawthorne e Melville si trattavapiuttosto del rapporto tra individui e società in quanto fondatosulla scelta etica. Che questi fossero i problemi più vivi perl’America è più che naturale data la natura composita della popo-lazione, il complesso rapporto con gli indiani e coi negri, il contin-uo rischio della secessione. [...] Ciò che viene posto in discussioneè l’individuo, è la molteplicità degli individui e, insieme, la lorounità. La filosofia americana doveva ben presto chiedersi: che cosaè l’io? [...] E plurimis unum, il motto nazionale, diventa l’enunci-azione di un problema filosofico”7.
Ciò che Paci condivide con gli scrittori e i filosofi americani è,dunque, un bisogno di società che si fondi sulle scelte etiche deisingoli. La letteratura e la filosofia statunitense hanno il merito dirichiedere un atteggiamento pragmatico anziché contemplativo.Ma per il Paci che ha attraversato la prova del Lager tedesco: “La180
Massimiliano Luce
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 180 (Nero/Process Black pellicola)
situazione del presente, se vogliamo esprimerci con il linguaggiodi Arnold S. Toynbee, può essere una sfida che provoca una rispos-ta. Il male, in noi e intorno a noi, ma per la coscienza morale soloin noi, ha trionfato”8.
Alla prospettiva di Toynbee rinviano proprio due importantifilosofi americani: James e Dewey, il primo con il concettodell’”azione riflessa”, il secondo con il concetto di ricerca suscitatada una situazione problematica. “La ricerca è dovuta all’attività delpensiero, alla logica, alla “coscienza”, costituita proprio dall’affio-rare di una situazione negativa che esige un mutamento, da unacrisi che esige una soluzione e la scelta di un nuovo cammino”9.
La lettura di Dewey pare in linea con il paradigma esistenzial-ista che interpreta in modo negativo l’esistenza, che ne rivendica ilmomento oscuro, di crisi, contro ogni pretesa del panlogismo ide-alistico che cerca di risolverla nella pura razionalità del pensiero.Dunque: “Dal passato che preme nel presente per un’azione futuranasce il mito e nasce il pensiero, nasce cioè la nuova filosofia checonsegue alla storia che è stata rivissuta, e quindi espressa narratae compresa. [...] La totale comprensione del passato equivarrebbealla totale confessione e purificazione: l’uomo rinascerebbe nuovoe la storia ricomincerebbe dal nulla. Tuttavia la possibilità di questoinizio assoluto è chimerica, come sarebbe chimerico richiedere allafilosofia la garanzia di una verità perfetta e alla scienza non unaprevisione probabile, ma una certezza completa”10.
La filosofia di Paci si conferma aperta e problematica. Del pas-sato resta sempre un residuo che non può essere convertito in pen-siero o, in termini deweyani, una situazione problematica che sus-cita una ricerca.
“C’è sempre un passato ed è soltanto l’astrazione dell’intellettoche ci fa credere ad un prima del passato, ad un inizio non tempo-rale del tempo: la struttura della nostra esistenza è infatti costitui-ta da un passato che nel presente si fa futuro: al principio, all’orig-ine, non si può tornare, il vero principio ci viene indicato dall’irre-versabilità del tempo e si proietta nel futuro, nel dovere da com-piere, nell’azione che del passato correggerà gli errori etrasformerà le conseguenze”11.
Se le conseguenze del passato non possono essere negate, pos-sono però essere trasformate. È proprio in questa possibilità cherisiede la libertà dell’uomo e per questo Paci definisce la libertàtrasformazione. La libertà è sempre possibile perché del passatoresta sempre un quid irriducibile alla comprensione dell’uomo, un
181
Enzo Paci e l’America
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 181 (Nero/Process Black pellicola)
quid negativo su cui si innesta l’azione. A differenza di Sartre, per-ciò, la libertà non è mai totale e, dunque, impossibile e vana. Secompresa, la struttura irreversibile dell’esistenza “convince l’uomodella sua finitezza e dei suoi limiti”12. La filosofia di Paci è unafilosofia della prassi, ciò che la muove è un’esigenza etica di trasfor-mazione del negativo (il passato che nel presente si fa futuro) inpositivo e non il pensiero astratto che presuppone un iniziorazionale prima del tempo. L’esigenza etica reagisce alle astrazionidel pensiero e parla “”a proposito di quell’inizio che sembra porsiprima di noi, di un inizio negativo, di un male da redimere, di unpeccato originale di cui l’individuo deve riconoscersi responsabile,anche se era prima di lui, anche se lo ha ereditato. Questoriconoscimento trasformerà tutta la vita in una redenzione”13.Tuttavia, è necessario essere consapevoli che il passato non puòessere completamente redento, altrimenti non ci sarebbe più nullada trasformare e la vita non sarebbe più possibile.
“Bisogna dunque riconoscere questo passato, quest’eredità ine-liminabile del negativo, e bisogna riconoscerla perché la libertà siapossibilità e trasformazione. Soltanto se c’è il riconoscimento di unlimite la libertà è possibile”14.
Se le cose stanno così, “la struttura dell’esistenza umana si pre-senta come scandalo, paradosso ed enigma; proprio il riconosci-mento della predestinazione [dell’eredità ineliminabile del negati-vo come peccato originale] diventa libertà e proprio la libertà esigeil riconoscimento della predestinazione”15. Senza questo riconosci-mento del male in sé anziché nell’altro si giungerebbe al dogmadella libertà, “sempre pronto, in quanto dogma, a diventare ildogma dell’autorità e dell’assolutismo. È questa la tragedia delcalvinismo”16 e dei Padri Pellegrini che lasciarono “l’Inghilterraper adorare Dio in libertà di coscienza, ma anche per imporre aglialtri, come presto si disse, la loro libertà”17. Questo avvenne, per iPadri Pellegrini, perché una volta in America si imposero benpresto, affianco alle esigenze spirituali, quelle materiali: il lavoro, lalotta, le iniziative economiche, il commercio, quella serie di attivitàtraducibili nell’irrazionalità esistenzialistica. Se il destino del teolo-go puritano Jonathan Edwards, straziato dal dogma della libertà,fu quello di abbandonare i suoi fedeli per convertire gli indiani,Hawthorne e Melville si salvarono - “per virtù del mito e dell’arte”- da quel furore perché il loro bisogno di società andava nelladirezione di un rapporto scelto, conquistato, non imposto, conl’essere sociale e gli altri uomini. 182
Massimiliano Luce
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 182 (Nero/Process Black pellicola)
“Hawthorne ha capito che una società è possibile solo se fonda-ta sul riconoscimento del peccato, sulla possibilità di una sceltaetica dei singoli, ed ha capito che questa scelta non solo giustifica,ma contiene implicitamente in sé il lavoro e l’attività economica.L’uomo non dovrà trovare nell’altro il male ma riconoscerlo in sé.In Melville poi la lotta furiosa contro Moby Dick è l’autodis-truzione del dogmatismo che, in nome della libertà, diventanegazione della libertà e di ogni rapporto umano, trasformandosi,quindi, in violenza verso chi si crede che rappresenti il male, ilpeccato. Il male, però, è solo nel singolo e dentro il singolo, non èmai fuori, negli altri uomini, negli altri popoli, nella natura, nellecose, nei fatti”18.
La chiave del romanzo di Melville è, allora, secondo Paci, il dis-corso di Padre Mapple nel capitolo nono, dove si ricorda la figuradi Giona il quale “fece orazione dalle interiora del pesce” ericonobbe che il male era in lui. Solo a partire da questo riconosci-mento, la balena bianca non rappresenta più la fatalità del male -come per Achab che identificando il male con Moby Dick dava almale una realtà esteriore -, “ma la possibilità del bene, la possibil-ità di trasformare il negativo in positivo”19. La balena, allora, “è lostrumento di Dio, Dio stesso”20, o ancora è Dio e insieme ilDiavolo. È questa la convinzione etica di Melville, che si basa suuna “evidenza estetica che sorpassa la falsa dialettica dell’intellet-to”21, che ponendo il dogma intellettuale della libertà pone altempo stesso la distruzione di ogni libertà.
L’insegnamento della letteratura e della filosofia americana, cheesige un atteggiamento sostanzialmente caratterizzato dal pragma-tismo, allora è, come ha affermato Dewey, che “di fronte alla scien-za e alla tecnica che sono forze cosmiche impersonali, l’individuodeve assumersi la responsabilità delle conseguenze che derivanodalle sue invenzioni e dagli usi che ne fa”22: “Come Hawthorne eMelville avevano intuito, il singolo, come soggetto di responsabil-ità, si pone al fondamento dell’organizzazione tecnica: è il singoloe non la società per azioni che deve decidere”23.
Alla logica del profitto privato e individuale che disgrega lasocietà e distrugge le individualità che la compongono, il singolodeve preferire “la possibilità di imparare dal passato”. Soltantocosì il singolo, in quanto soggetto etico e possibilità di scelta, puòriconoscere l’errore e mutare la propria vita. Egli può decidere edeve decidere da solo, le scelte degli altri non esistono. Le con-dizioni di scelta sono difficili, devono esserlo, non si hanno
183
Enzo Paci e l’America
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 183 (Nero/Process Black pellicola)
garanzie, il rischio che corre il singolo è di essere una vana protes-ta. Egli sa di avere questa possibilità, perché essa è proprio la strut-tura della sua esistenza, ma può agire per negarla. “Solo così i sin-goli costituiscono una società. Dal singolo, dai singoli, dai pochi,nasce il nucleo che sarà una civiltà, una risposta”24.
2. La scoperta dell’America, ovvero rotta verso il relazionismo
Come detto in precedenza, la domanda principale posta dallafilosofia americana è stata: che cosa è l’io? Intorno a questo tema,c’è una lezione che il pensiero americano non dimenticherà mai,dice Paci, ed è la lezione di Beniamino Franklin. Di fronte al mira-coloso progredire della scienza e della tecnica, Franklin definival’io un rapporto, l’io “è l’individuo nelle sue possibilità d’azione, inun dato ambiente, con mezzi determinabili”25.
La filosofia americana, dunque, è la filosofia dell’azione e dellasocietà, in una parola del pragmatismo: “ciò che conta è l’umanapossibilità che, mentre sceglie, mentre vive lavora e organizza, dis-tingue il bene dal male”26. Il reale non è razionale, altrimenti nonvi sarebbe nulla di negativo e di finito, non vi sarebbero scelte dafare. Per questo, la filosofia americana nega le pretese conclusivedella metafisica. Perciò, come ha insegnato James, anche la coscien-za teoretica si dissolve come unità sostanziale perché è “costituitadi operazioni tecnico-pratiche”27 e il soggetto “non è dunque nésostanza né pura forma teoretica: è piuttosto un principio diazione, un centro di operazioni pratiche”28.
Non solo pragmatismo, però. Per James conta anche “il proble-ma della temporalità, della struttura dell’esperienza aperta alnuovo e al possibile, struttura che risolve i paradossi di Zenone e leantinomie di Kant”29. In fin dei conti, come ha spiegato A. W.Moore, “il vero fondamento del pragmatismo è la rivendicazionedella realtà del tempo”30. Il singolo, quindi, è possibilità, unsoggetto di libertà che opera, sceglie, in un universo concepito plu-ralisticamente, dove ci sarà sempre qualcosa di non compiuto e,perciò, la possibilità di un’altra azione. Avendo scoperto la tempo-ralità, James “sa che la temporalità esclude l’assolutizzazione delfinito; sa che il senso della vita è la conversione del passato nelfuturo e del male nel bene; sa che il progresso non è il misconosci-mento del male, ma la trasposizione nell’irreversibilità della con-tinua vittoria sul negativo”31.184
Massimiliano Luce
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 184 (Nero/Process Black pellicola)
Non solo. Secondo l’insegnamento di Dewey, la storia è l’espe-rienza in quanto temporalità32. La storicità è possibile perché latemporalità contiene la ricerca che ha origine in relazione a unproblema. È questa la possibilità relazionale, che esclude comepunto di partenza della ricerca un’astrazione logica atemporale.
“L’inizio, nella struttura relazionale, e cioè nel possibile, è unostimolo spazio-temporale determinato, un bisogno reale, un prob-lema posto al presente perchè il presente possa operare per unasoluzione”33.
La struttura relazionale-temporale della ricerca conferma unospirito antidogmatico. La filosofia di Dewey è “una filosofia dellavita, dell’esperienza, della storia. È una filosofia del ritmo, dell’in-terdipendenza, della relazione. In ogni caso non è una filosofiadella sostanza, una filosofia che deduce il mondo da un principiounico, sia esso materia o spirito”34. Il grande insegnamento diDewey è il concetto di “interdipendenza”, di “relazione”, di “espe-rienza”. Anziché di “esperienza come storia”, avverte Paci, potrem-mo anche parlare di “spirito”, ricordando però che non dobbiamoconcepirlo come “sostanza” o “unico”, “ma come una interazionedi eventi, come una relazionalità universale di funzioni”35.
Al centro del relazionismo, dunque, si pongono gli eventi, iquali avvengono sempre in forme, “sono sempre un’unità formaledi molteplici, nuove unità formali di forme, e così via: “ogni esserevivente [qui Paci riprende anche Goethe] non è una cosa singola,ma una pluralità, e anche presentandosi come individuo, esso è uncomplesso di esseri viventi”. “E lo studio della forma è lo studiodel processo, della funzionalità, della relazionalità naturale e stori-ca, che sono la stessa cosa. Forma è metamorfosi poiché ciò che èstato formato subisce subito una nuova metamorfosi”36.
In Dewey, è presente l’immortale lezione di Beniamino Franklin:anche per lui “la vita è relazione e quindi è ambiente e l’ambiente èuna serie di relazioni. [...] Vita e ambiente sono interazione e svilup-po di eventi”37. Oltre al tramonto del concetto di sostanza, assisti-amo al canto del cigno dei concetti di soggetto e oggetto. Lo “spiri-to”, ora, può essere concepito solo come relazione e in quanto taleesso “è storia ed esperienza, è vitalità e natura, così come è arte, pen-siero, valore morale”38. Ma una relazione di eventi, per essere tale,“non può che essere temporale e come tale irreversibile, altrimentinon sarebbe una relazione”39. Se il processo è irreversibile, allora lamera ripetizione è impossibile: questo significa che alla relazionenon può mai sostituirsi il nunc stans dell’identico, ossia la sostanza.
185
Enzo Paci e l’America
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 185 (Nero/Process Black pellicola)
Riteniamo di poter individuare in queste riflessioni intorno allafilosofia di Dewey il passaggio di Paci dagli esiti criticisti e circolaridel precedente esistenzialismo al paradigma del relazionismo. Lafilosofia americana, infatti, consente a Paci di superare il dualismoantinomico di uno e molteplice, la separazione di pensiero edesistenza, di storia e natura. Queste antinomie potevano essererisolte, per il Paci degli anni ‘40, solo assumendo l’idea di umanitàcome “idea regolativa e principio ermeneutico di una antropologiastorica e di un esistenzialismo critico e trascendentale: “”La verarealtà è al di là dell’uomo ma deve valere nei limiti dell’umanità, èqualcosa di eterno che deve essere vivo nella storia: è perciòtrascendentale””. Da questo andamento circolare della riflessioneteorica di Paci si può ricavare un senso di insoddisfazione: le cate-gorie sembrano muoversi in circolo, senza vero sviluppo, maattuando piuttosto una visione infinitamente concentrica dei prob-lemi”40. Il relazionismo di Dewey consente di risolvere l’antinomiadi uno e molteplice in un paradigma scientifico e interazionistico.Esso afferma che il processo è temporale e irreversibile, fatto diequilibri perduti e riconquistati, non solo diversi dai precedenti maanche più armonici; si potrebbe dire, afferma Paci, che ogni nuovoequilibrio ha più valore dei precedenti. Ogni equilibrio perduto,infatti, nascendo da un bisogno, da un problema, è la richiesta diun passo avanti nel processo, che non è mai determinabile a priori.Tuttavia, nella serie di equilibri perduti e riconquistati rimane ilsenso di un’armonia profonda. Questo significa che il processo, equindi la natura, e quindi la storia, non sarebbero possibili “se ladiscontinuità non fosse stata anche continuità, se ciò che muorenon fosse conservato in una nuova vita per procedere versol’avvenire”41. Di qui, in una prospettiva relazionistica, l’importan-za dell’arte, l’importanza di qualcuno che sopravviva per dire“Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, non importa quanti esatta-mente...”: “Ciò che permane e si rinnova, ciò che muore e rivive,che si spezza per ricongiungersi, che è passato perché conservan-dosi nel presente procede nell’avvenire, è l’armonia dell’arte. L’artenon ha mai dimenticato, nella sua inconscia profondità, il mitodella morte e della rinascita, la riconquista del passato, nel pre-sente, per il futuro”42.
Il relazionismo, tuttavia, oltre a dirci che il processo avviene neltempo, ci dice anche che la coscienza è costitutiva del processo stes-so. Anziché ridursi alla contemplazione di un oggetto o alla auto-coscenza statica, essa “è un momento che esige trasformazione, che186
Massimiliano Luce
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 186 (Nero/Process Black pellicola)
costringe ad una nuova disciplina e a un nuovo metodo dilavoro”43. La fiamma della coscienza deweyana arde finché ilmondo presenta i caratteri dell’instabilità e dell’incertezza, ciò chela costituisce è il dubbio. Il fine della ricerca scientifica è la trasfor-mazione sociale, in un eterno processo di superamento di situ-azioni indeterminate che di volta in volta pongono nuove sfide allaciviltà. Per perpetuare la democrazia, insegna Dewey, nell’era in cuila scienza e la tecnica che la fondano sono divenute “forze cos-miche impersonali”, è necessario togliere i mezzi di distribuzione eproduzione a coloro che li utilizzano a vantaggio di ristretti inter-essi individuali. All’etica del pioniere e del conquistatore mossi daldogma della libertà, che si traduce sul piano economico nel dogmadell’utile privato che distrugge la società e le individualità che lacompongono, e alla sfida lanciata dalla tecnica, non è necessariorispondere, dice Paci, “con la volontà apocalittica del rinnovamen-to, della rivoluzione, della redenzione tecnicizzata e comandata”44.In questo caso, la civiltà verrebbe stretta nella dialettica calvinistadella libertà assoluta e della predestinazione assoluta. I dueopposti conducono allo stesso risultato. Qual è, allora, lasoluzione? La risposta di Paci è che: “la soluzione non è mai data,è in noi, nella nostra scelta. Alla fine tutte le contraddizioni restano.Debbono restare. Perché non possono e non debbono sostituirsialla grazia della libertà [del singolo soggetto etico]”45.
Come non esiste un inizio prima del tempo, una civiltà positivain cui è entrato un elemento negativo, non esiste neppure un futuropalingenetico in cui le contraddizioni saranno definitivamenterisolte. Nel rifiuto di dogmatizzare la storia in una qualsivoglia teo-ria metafisica della ragione o del pensiero, nel rifiuto di vedererealizzata la filosofia nell’attuarsi concreto della storia, in una qual-siasi teologia idealistica o materialistica, la filosofia della prassi diPaci, immersa nella tradizione speculativa occidentale, non puòessere altrimenti che impegnata a fondare un nuovo individualis-mo, dove il soggetto etico finito sia libero e personalmente respon-sabile delle proprie azioni.
3. Conclusione
La filosofia americana, abbiamo visto, è centrale per compren-dere il passaggio dall’esistenzialismo positivo al relazionismo. Ilconfronto, in questi articoli, soprattutto con autori come James,
187
Enzo Paci e l’America
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 187 (Nero/Process Black pellicola)
Moore e Dewey ha consentito a Paci di dissolvere l’unità sostanzialedell’io, del soggetto e dell’oggetto e, soprattutto, della coscienza nelpiù vasto tema dell’irreversibilità temporale e dell’esperienza intesacome processo, e quindi come storia e natura. Ogni aspirazione ide-alistica della metafisica occidentale, qui definitivamente tramonta.Ciò che resta è, in una prospettiva affatto antropocentrica, un inces-sante processo dialettico costituito da equilibri perduti in virtù diun problema e riconquistati in seguito a una ricerca, da armoniecontinuamente sostituite da altre armonie dotate tuttavia di più val-ore, dove non permane alcun nucleo identico, dove la mera ripe-tizione del passato è impossibile e il futuro è sempre aperto e prob-lematico, in una parola è possibile. In una tale filosofia della vita, mairiducibile a una filosofia della storia, l’individuo stesso si definiscecome esigenza etica e possibilità di scelta, sempre posto di fronte aun aut aut. Il limite di tale impostazione pare la non problematiciz-zazione del concetto di invididuo, che pare ancora una volta ilsoggetto cristiano-borghese ispirato dall’etica kantiana del dovere etuttavia incapace - in linea con la tradizione metafisica occidentale -di conciliare l’esistenza con il significato, l’evento con il senso.L’individuo del Paci relazionista, così, è ancora l’individuo scissodella metafisica e della morale occidentale, che può dare senso(senza mai riuscirci pienamente) a un’esistenza priva di significatosolo sulla scorta di un imperativo personale del dovere orientato dalvalore di un bene comune fondamentalmente irrealizzabile. Il dual-ismo metafisico essere-non essere, da cui discendono le altre scis-sioni (essenza/apparenza, significato/esistenza, senso/ evento,uno/molteplice, essere/divenire, bene/ male), non solo si confermainsuperato e non problematizzato nelle sue ragioni, ma una voltaassunto dalla tradizione si conferma anche in Paci l’unico motoredella storia.
Note al testo
1. Entrambi questi articoli sono raccolti nell’opuscolo Moby Dick e lafilosofia americana, a cura di Agostino Lombardo e pubblicato dagli EditoriRiuniti.2. Ivi, pag. 203. A. Vigorelli, L’esistenzialismo positivo di Enzo Paci, Franco Angeli,pag. 191.4. Moby Dick e la filosofia americana, pag. 20-21.
188
Massimiliano Luce
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 188 (Nero/Process Black pellicola)
5. Ivi, pag. 20. 6. Ivi, pag. 20.7. Ivi, pag. 30-31.8. Ivi, pag. 21.9. Ivi, pag. 21-22.10. Ivi, pag. 22.11. Ivi, pag. 23.12. Ivi, pag. 23.13. Ivi, pag. 23.14. Ivi, pag. 24.15. Ivi, pag. 24.16. Ivi, pag. 24.17. Ivi, pag. 2518. Ivi, pag. 26.19. Ivi, pag. 26.20. Ivi, pag. 26-27.21. Ivi, pag. 27.22. Ivi, pag. 47.23. Ivi, pag. 47.24. Ivi, pag. 48.25. Ivi, pag. 32.26. Ivi, pag. 34.27. Ivi, pag. 35.28. Ivi, pag. 37.29. Ivi, pag. 35.30. Ivi, pag. 38-39.31. Ivi, pag. 38.32. J. Dewey, Experience and nature, Chicago, 1925, p. 275.33. Moby Dick e la filosofia americana, pag. 43.34. Ivi, pag. 51.35. Ivi, pag. 54.36. Ivi, pag. 64.37. Ivi, pag. 57.38. Ivi, pag. 53.39. Ivi, pag. 57.40. A. Vigorelli, pag. 250.41. Moby Dick e la filosofia americana, pag. 67.42. Ivi, pag. 68.43. Ivi, pag. 44.44. Ivi, pag. 48.45. Ivi, pag. 116.
189
Enzo Paci e l’America
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 189 (Nero/Process Black pellicola)
IL FILOSOFO E IL DRAMMATURGO: ENZO PACI E THOMAS MANN,
STORIA DI UNA CORRISPONDENZA
Riproduciamo alcune lettere tra quelle che il celebre romanzie-re e drammaturgo tedesco scrisse a Paci nel 1950. La seconda, del12 Agosto, in particolare, è la più nota perché fu pubblicata in aper-tura al primo numero di Aut Aut (Gennaio 1951, ristampato nelnumero 305-306 di Settembre-Dicembre 2001). I testi vengonoriprodotti da Thomas Mann, Lettere a italiani, introduzione e com-mento di Lavinia Mazzucchetti, Il Saggiatore, Milano, 1962 (pp.80-86); le brevi introduzioni in corsivo sono trascrizioni delle testimo-nianze fornite da Paci alla curatrice [NdC].
«Nel luglio del 1950 scrissi a Thomas Mann annunziando l’iniziodella pubblicazione della rivista “Aut Aut”. Gli inviai intanto il miolibro Esistenza ed immagine che conteneva due saggi su di lui.Nella mia lettera gli ponevo alcune domande di tono soprattutto filo-sofico a proposito della genesi e del significato del Doktor Faustus.Mi rispose con una lettera cominciata a St. Moritz e finita a Zurigo.In realtà le domande avevano un carattere troppo accentuatamenteteorico. Gli ultimi miei saggi si riferivano da un lato all’interpretazio-ne da me tentata in uno scritto del 1935 (cfr. L’ultimo Th. M., “Lanuova Italia”, agosto-ottobre 1935) delle prime due parti delGiuseppe, ma dall’altro sviluppavano tale interpretazione per i rap-porti dell’opera manniana con la filosofia e con la musica.»
191
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 191 (Nero/Process Black pellicola)
Saint Moritz, Suvretta, 8 agosto 1950
Egregio signor Paci,ho ricevuto la Sua gentile lettera e il Suo libro Esistenza ed immagi-
ne. La notizia che Lei sta iniziando la pubblicazione di una rivista miha molto interessato. Certo, data la situazione attuale, è un rischio,ma rischio meritorio, al quale si deve di cuore augurare il successo.
Quanto al Suo libro, non potrà ammirare abbastanza la vastaconoscenza delle correnti letterarie moderne e delle personalitàeuropee che esso rivela. Mi fa un po’ vergognare, perché il mio zeloe la mia cautela nell’affrontarle sono molto minori, specialmentequando si tratta di testi in lingua straniera, il che però non si oppo-ne al nesso interiore che forse sussiste fra la mia opera e tutto que-sto mondo che Lei domina in modo cosl compiuto. Joyce, per esem-pio, mi è inaccessibile direttamente, ma su di lui ho letto molto ininglese, traendone l’impressione di avere con lui una certa affinitàdi destino artistico. Le Storie di Giuseppe non sono tanto lontanedall’Ulisse come si potrebbe credere osservando il modo più con-servatore dei mezzi espressivi, il loro più forte legame con la tradi-zione e la conseguente maggiore leggibilità.
Superfluo dire che Le sono sinceramente grato per il profondo esottile esame in ambedue i Suoi saggi dei miei rapporti con la musi-ca e la filosofia. Leggendo io provavo un’alta gioia al pensiero chein Italia vengono diffuse idee così acute e penetranti sulla mia esi-stenza spirituale. Senza dubbio Lei avrebbe saputo dire cose nonmeno buone e precise intorno al Faustus se già fosse esistito -meglio di quanto io non sappia rispondere alle domande da Leiproposte. Non posso impegnarmi nella replica punto per punto,specie perché non capisco in modo perfetto il senso di alcune diqueste domande. Bisogna prima di tutto tener presente che trattan-do di questo libro, col quale si chiude un circolo iniziato con iBuddenbrook, si discute un’opera di poesia, difficile da scomporreconcettualmente per trarne un discorso puramente filosofico.
Zurigo, 12 agosto 1950
Fui interrotto da un mutamento di luogo e poiché il mio viaggioproseguirà presto dovrò essere conciso.
La prima idea del Faustus fu quella di un’arte che, minacciatadi frigidità e sterilità, cerca di liberarsi dalle inibizioni. L’ebbrezza192
Enzo Paci e Thomas Mann
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 192 (Nero/Process Black pellicola)
potenziale necessaria a tal fine (il concetto di potenziamento risa-le alla Montagna incantata) mi si presentò subito come patto con ildiavolo. La inibizione era, ben inteso, di natura intellettuale. Sitrattava di un tipo di artista che, a rigore, è troppo intellettualeper l’arte, come risulta chiaro dalla lettera che Adrian scrive daHalle al suo maestro Kretzschmar a Lipsia, in cui la sua attitudi-ne al riso si presenta non solo quale acuta intuizione del come sifa, ma anche nella confessata tendenza a sentire ogni arte soltan-to come parodia di se stessa.
Qui l’inibizione intellettuale acquista un significato ultraperso-nale: l’individuale diventa una caratteristica dell’epoca. Si tratta dellogoramento, dell’esaurimento dei mezzi artistici, e del vicolo ciecoin cui oggi una mente acuta vede l’arte e in primo luogo la musica;della crisi in cui si trova non soltanto la musica ma la civiltà intera;della grande incertezza di un mondo nel quale «tutto è diventatotroppo difficile » ed è quindi ovvia la tentazione di stringere unpatto con il diavolo per arrivare a sfondare.
Il periodo di formazione del romanzo portò con sé l’ampliarsidella sua idea fondamentale alla politica. L’ebbrezza necessaria perliberarsi dalle inibizioni appare come intossicazione fascista deipopoli; il destino di Adrian diventa sino ad un certo punto il desti-no della Germania - del resto, fin dall’inizio, e molto caricato il ger-manesimo del romanzo (quasi come nei Maestri cantori) e il librotiene sempre, per cosl dire, un piede nel ‘500 tedesco. In molti par-ticolari (l’ingegno svelto di Adrian, la Oratio ad studiosos, ecc.), deri-va dal libro popolare tedesco del Doktor Faust e ad esso allude. Nelsuo aspetto linguistico l’episodio dell’epifania e della morte del pic-colo Echo risale, per approfondire la prospettiva, al di là del tede-sco di Lutero, sino al medio-alto-tedesco.
In complesso non mi piace che si prenda genericamente AdrianLeverkuhn come un’allegoria della Germania. Perché possa esserloè troppo individuo, sia pure rappresentativo, è troppo « eroe delnostro tempo », un uomo che regge sulle spalle la sofferenza dell’e-poca. Certo anche Nietzsche è un momento del destino tedesco e ilromanzo è in gran parte un romanzo su Nietzsche. I particolaridesunti, inscenati, citati, sono evidenti. Tutta l’idea di sfondare conl’aiuto del diavolo, e cioè con l’aiuto dell’infezione, della malattiache rende geniali, proviene dalla leggenda nietzscheiana.
Che però nemmeno la definizione di romanzo nietzscheianoesaurisca l’essenza del libro, sta nel suo ca-rattere di opera auto-biografica, nell’essere una confessione religiosa così profonda-
193
Il filosofo e il drammaturgo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 193 (Nero/Process Black pellicola)
mente conturbante da costarmi quasi la vita - l’autobiografismopoi, molto metaforicamente, viene complicato dalla mistificazio-ne per cui l’autore si scinde nel protagonista e nel narratore: duediverse persone che sono tuttavia una sola. Lei ha ben ragione didire che l’umanesimo di Zeitblom non è interamente il mio. Unacerta parte di esso è pura comicità - l’umorista che è in me ha delresto inventato il trucco di personificare il demoniaco medianteuna figura tutt’altro che demoniaca, facendone interprete un pro-fessore sconvolto e commosso.
Io sono infatti umorista anche in questo tenebrosissimo libro, ilcui pessimismo è imposto dai tempi e in cui l’antiumanesimo èdolore per lo sviamento e la rovina dell’Homo Dei. Oppure, potreidire come più volte si dice nel Sogno di Strindberg: « È un peccatoproprio per l’uomo! »
Basta. Voglio dire: troppo e troppo poco. Perdoni il troppo e siaccontenti del troppo poco! La ringrazio della Sua partecipazione spi-rituale e Le faccio i più cordiali auguri per la prosperità di «Aut Aut».
SuoThomas Mann
«Ai primi di novembre del 1950 scrissi di nuovo a ThomasMann su vari argomenti. Nella lettera accennavo alle letturemie e dei miei compagni ai tempi dell’università, e ricordavol’amico Gian Antonio Manzi, suicidatosi il 17 maggio 1935,mentre preparava il suo lavoro di laurea dedicato a Mann. Tragli altri argomenti toccava il problema della difficoltà dellaricerca filosofica e della facilità con la quale essa si trasforma inposizioni contingenti e dogmatiche. II racconto che ThomasMann dice di avere appena terminato è l’Eletto. Parlavo anchedi un saggio sul Faustus che, nella forma promessa a ThomasMann, non ho ancora portato a termine.»
Pacific Palisades, 15 novembre 1950
Egregio signor Paci,La ringrazio di cuore per la lunga lettera tanto ricca di idee che
Lei mi ha scritto. Volesse Iddio che avessi tempo ed energie in ecce-denza, bastanti a replicare in modo degno a tutte le lettere buone enotevoli che ricevo da ogni parte! (il mondo è diventato piccolo e194
Enzo Paci e Thomas Mann
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 194 (Nero/Process Black pellicola)
nella mia corrispondenza figurano ormai anche l’India e ilGiappone). Ho appena terminato un romanzo breve, leggendario,che si svolge nel Medioevo, e non sono soddisfatto dell’ultimascena che dovrei rifare. Ma non lo posso perché prima debbo pre-parare una conferenza su Bernard Shaw, che dovrò leggere nelTerzo Programma della British Broadcasting Corporation. È unasituazione davvero penosa e senza volerlo casco a parlarne a Leiinvece di riferirmi alla Sua lettera, le cui considerazioni mi toccanocosì da vicino. Credo però che Lei anticipi qualcosa che vorrà svi-luppare ulteriormente nel progettato saggio sul Faustus: possodirLe soltanto che attendo con gioia questo Suo lavoro. Molto pro-babilmente sarà scritto in italiano, ma non importa. In verità nonparlo più la Sua lingua (a vent’anni la parlavo altrettanto bene, oaltrettanto male, di come oggi parlo l’inglese): ma non mi riescedifficile leggere l’italiano - specialmente quando si tratta di coseche mi riguardano.
Mi sono annotato molti punti della Sua lettera, specie dove Leiparla del giovane amico che le regalò la Melancolia di Durer e che sisottrasse alla vita. Divido il Suo dolore per lui. Non sono passatiancora due anni da quando perdetti il mio figlio maggiore Klaus,uno scrittore molto dotato che si e dato volontariamente la morte.Non poteva vivere in un mondo come quello di cui Lei parla nellaSua lettera dicendo cose molto vere.
Ho anche notato ciò che Lei dice di una vita senza l’illuminazio-ne del pensiero, del riscatto della libertà e della costrizione di unsistema filosofico definitivo, in breve del dogmatismo, che è adattoper tutti coloro che temono lo sforzo della liberta . . .
SuoThomas Mann
195
Il filosofo e il drammaturgo
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 195 (Nero/Process Black pellicola)
INTERVISTA A CARLO SINI(a cura di Federico Leoni)
ENZO PACI E LA SCUOLA DI MILANOI maestri, i colleghi, gli allievi*
[Federico Leoni] Ho incontrato Carlo Sini chiedendogli unatestimonianza e una riflessione sull’avventura della fenomenolo-gia italiana, sul suo percorso storico, sulle sue poste in gioco, pas-sate e attuali. Sini è stato allievo e poi assistente di Enzo Paci, chefu tra i maggiori esponenti dell’esistenzialismo italiano e, più tardi,fu protagonista della “rinascita”, italiana e non solo italiana, dellafenomenologia. Proprio dal maestro del suo maestro, il milaneseAntonio Banfi (Vimercate 1886 – Milano 1957), prendo le mossediscutendo con Sini. Ho con me lo splendido Diario fenomenologi-co di Paci, scelta di vere e proprie pagine di diario, specchio fedeledi una molteplicità di scoperte e interessi filosofici e culturali, diincontri, letture, spunti di pensiero. Esemplare per più motivi è, traquesti incontri, quello avvenuto nei primi anni Trenta tra il giova-nissimo Paci e il già affermato Banfi, che queste pagine rievocanovividamente trent’anni più tardi. Paci aveva chiesto a Banfi, silegge nel Diario, che cosa fosse la fenomenologia, e per tutta rispo-sta Banfi aveva chiesto a Paci di descrivere il vaso di fiori che stavalì, davanti ai loro occhi. Ecco allora che Paci abbozzava una primadescrizione del vaso, Banfi dubitava che davvero nulla di essenzia-le fosse stato dimenticato, che nulla di troppo fosse invece statoinavvertitamente aggiunto, Paci quindi ritentava... Insomma, unvero e proprio “esercizio fenomenologico” in atto.
Ora, in questo passo, in questo “inizio” che Paci tanti anni più197
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 197 (Nero/Process Black pellicola)
tardi assegna a sé come filosofo, come fenomenologo, e alla filo-sofia e alla fenomenologia così come egli le vive e le pratica, trecose almeno mi sembrano importanti e meritevoli di un commen-to. La prima, la più diretta ed evidente, è la questione biograficae, attraverso la questione biografica, quella storica: il clima dellacosiddetta “scuola di Milano”, la figura del suo fondatore Banfi,il suo bagaglio intellettuale in gran parte tedesco; le sue frequen-tazioni di inizio secolo, i rapporti con Georg Simmel e la filosofiadella vita, la vicinanza a Husserl; e poi una serie di altre vicendeche non saranno prive di conseguenze sulla fenomenologia diPaci e sul panorama culturale italiano dei decenni successivi: ladiffidenza riguardo a Heidegger, l’incontro con il marxismo…
[Carlo Sini] Antonio Banfi ha avuto il merito, che tutti gli rico-noscono, di portare in Italia in modo profondo, non come sempli-ce fatto di trasmissione culturale ma come rielaborazione ancheoriginale, alcune correnti della filosofia tedesca, muovendo da unaposizione sua personale che si potrebbe definire neokantiana. Banfiera allievo di Piero Martinetti, come pure Emanuele Barié, che inse-gnava a sua volta a Milano. Barié conobbe una sua evoluzione insenso neoidealistico, assumendo una posizione molto autonoma einteressante, anche se rimasta un po’ in ombra nel panorama suc-cessivo della filosofia, mentre Banfi proseguì l’ispirazione diMartinetti in direzione di una filosofia della cultura. Tra i suoi inte-ressi – il neokantismo, Simmel… – ebbe modo di incontrarsi anchepersonalmente con Husserl, negli anni in cui la fenomenologiaviveva un momento di grande successo. Quella incontrata da Banfiè quindi la fenomenologia del primo Husserl, quello delle Ideen, edè questa fenomenologia che anzitutto trasmise in Italia, pur senzaaderire mai personalmente ad essa in maniera tematica, pur senzamai sviluppare una prospettiva propriamente fenomenologica.Non fu lontano, però, da posizioni in qualche modo poi raggiunteda Paci, che coniugò anni più tardi marxismo e fenomenologia.Banfi si avviò sempre più chiaramente verso il marxismo, fu unsenatore del Partito comunista, e in questo Paci e Banfi furonoabbastanza vicini. Ora, quello che Banfi ha inteso della fenomeno-logia di Husserl è complicato a dirsi e forse, quanto alla fenomeno-logia, non decisivo. Più interessante e decisivo è quello che ne hatratto Paci. Il quale veniva però, questo va detto, sostanzialmenteda una formazione basata su studi platonici. A Platone era dedica-ta la sua tesi di laurea, incentrata in particolare sul Parmenide, e a198
Carlo Sini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 198 (Nero/Process Black pellicola)
partire da Platone, direi, avviene il suo incontro con la fenomeno-logia. C’è, in Paci, sin dalla giovinezza, l’idea di una filosofia alta-mente problematica, incentrata sulla domanda più che sulla rispo-sta. Una filosofia socratica, aporetica. È il Platone socratico che inte-ressa a Paci. Una filosofia che da un lato si faccia carico dell’interacomplessità dei problemi della società, della politica, dell’arte,della vita… In questo, Paci era buon discepolo di Banfi. Mira a unafilosofia fortemente asistematica, fortemente antiintellettualistica,che rampolli, diciamo così, dall’esperienza della vita, e che facciadella verità, per usare una formula che Paci usò dal tempo della suagiovinezza sino alla conclusione del suo itinerario speculativo, unavita della verità. Direi quindi che l’insegnamento di Adolfo Levi,che Paci seguì a Pavia, è il fondamento nascosto della sua compren-sione della fenomenologia, in quanto ritorno alle radici della filoso-fia: alle radici socratico-platoniche della domanda filosofica, amonte della sua caduta nel sistema, nella dialettica del sistema.Paci era un platonico e non un aristotelico, se si può dire così. Eraun husserliano e non un hegeliano, anche se dedicò studi moltointeressanti ad alcuni aspetti di Hegel.
La seconda questione che mi sembra interessante, in questopasso del Diario, e che ne fa appunto qualcosa di emblematicodella fenomenologia, e della fenomenologia di Paci in particolare,è quella della descrizione. Forse proprio questo carattere di pro-blematicità della domanda filosofica, questo platonismo anzichéaristotelismo, come lei diceva poco fa, hanno a che vedere con tuttoquesto. Nel momento in cui Paci racconta questo “inizio” della suafenomenologia, lo situa in quella dimensione, in quell’esercizioche è l’esercizio o la dimensione descrittiva. Di che si tratta? Certodi qualcosa che non è così comune, così ovvio, così scontato in filo-sofia. La filosofia fa molte cose: teorizza, deduce, analizza, dimo-stra, argomenta, confuta… Perché, invece, descrivere?
La questione della descrizione, direi anzitutto, la questione cheè molto felicemente esposta nell’episodio che citavi dal Diario, rap-presenta in qualche modo il ritorno all’impatto dell’esperienza. Ladescrizione gioca in Paci, e probabilmente anche in Banfi, almenoper certi aspetti, quel ruolo che Husserl stesso aveva indicato quan-do sosteneva che “i veri positivisti siamo noi”. Che significa infattiquesta rivendicazione di positivismo? Che noi, noi fenomenologi,dice Husserl, non costruiamo una teoria dell’esperienza, ma, dicia-
199
Enzo Paci e la Scuola di Milano
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 199 (Nero/Process Black pellicola)
mo così, andiamo direttamente all’esperienza, andiamo diretta-mente all’impatto con la cosa stessa, ci esponiamo all’incontro conessa. Naturalmente, come Heidegger faceva notare in Essere etempo, non si tratta, qui, di una descrizione empirica. Non si trattadi descrivere al modo di una scienza empirica come la biologia o lazoologia. La descrizione dell’impatto del fenomeno e col fenomenodeve mirare alla forma, all’essenza, a quello che è costitutivo delfenomeno.
E qui, in questo ritorno ai fenomeni, cominciano, mi pare,tutti i problemi...
Incominciano tutti i problemi, certo, perché questo tornareall’ingenuità dei fatti è un tornare tutt’altro che ingenuo. È anzi gra-vato di teoria, gravato sostanzialmente di una serie di paradossiche peraltro accompagnano Husserl per tutta la vita – come è statodetto, tutte le sue opere sono delle “introduzioni” alla fenomenolo-gia, a cui quindi non si arriva propriamente mai... Husserl riformu-la continuamente il suo metodo, proprio perché il metodo, che èquello della descrizione, pone una quantità di problemi stermina-ta. È celeberrima la dichiarazione di Husserl morente, che, parlan-do della sua ultima opera destinata a rimanere incompiuta, laKrisis, dice di avere finalmente trovato “un piccolo inizio”, di esser-si finalmente rifatto “interamente a se stesso”. Ora, Paci ha insisti-to continuamente su questo aspetto della fenomenologia, e questoè uno dei suoi apporti più fecondi alla scuola fenomenologica,anche perché non ha mai ritenuto che la descrizione fosse un meto-do da assumere in forme canoniche, e la stessa esposizione che Pacine faceva, nelle lezioni come nei suoi scritti, non era affatto canoni-ca, era molto libera, molto inventiva, non si sarebbe mai potutaridurre a delle regole fondamentali.
Vengo alla terza questione che, mi pare, si radica nel passo delDiario di Paci che prima ricordavo. È la questione, provo a dire così,con un termine cui lei ricorre spesso, della fenomenologia comeesercizio, come pratica. C’è, in queste pagine, il gesto “esemplare”di Banfi, esemplare in ogni senso: Banfi non si mette a fare undiscorso su che cos’è la fenomenologia, ma mette in atto e mostra inatto, invita Paci a fare altrettanto: a compiere un certo gesto, uncerto esercizio, una certa pratica teorica, come Husserl ripeteva, cheè, e che deve sempre essere, consapevolmente, la fenomenologia. 200
Carlo Sini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 200 (Nero/Process Black pellicola)
Sì, Paci era convinto che la descrizione dovesse essere un eser-cizio, una pratica. Insisteva molto sulla questione della descrizio-ne come esercizio fenomenologico, come anche Husserl ribadiscenel modo più eloquente nella Krisis. La descrizione è da rifaresempre da capo, immer wieder, come Paci ripeteva sempre. Si trat-ta di riprendere sempre da capo la descrizione perché quello checonta, della descrizione fenomenologica, non è raggiungere un’on-tologia fondamentale, secondo il progetto che sarà di Heidegger inEssere e tempo, o anche dello stesso Husserl nei tre libri della Ideen,che tentano appunto di delineare la fenomenologia come scienzarigorosa, come strenge Wissenschaft. In Paci di strenge c’è solo que-sto perenne ricominciare da capo come esercizio autoformativodel soggetto, è questo ciò che conta per lui. Alle obiezioni heideg-geriane, che ovviamente Paci conosceva molto bene, contro ilcoscienzialismo di Husserl, e alle obiezioni che sorsero in Italia dapiù parti, circa un certo soggettivismo o idealismo della fenome-nologia, Paci rispondeva sempre alla stessa maniera. Ripetendo,cioè, che non si tratta di una fondazione soggettiva alla Fichte, nonsi tratta di tornare al soggetto-sostanza, non si tratta di pensare aqualcosa come una coscienza, un luogo metafisicamente salva-guardato dall’errore, dall’empiria, dal naturalismo. Non si tratta diquesto, ma della costituzione dello stesso soggetto operante, delsoggetto che diventa filosofico in quanto frequenta la descrizionecome esercizio sempre di nuovo ritornante sul problema mai risol-to. Era una convinzione fondamentale di Paci, che la verità fosseuna intenzionalità di verità, un’idea guida. Non un risultato mauna teleologia, una vita della verità appunto. Questo Paci lo haripetuto moltissime volte, nelle sue lezioni, nei suoi interventi su“aut aut”, in particolare in quegli interventi che faceva in ognifascicolo analizzando “Il senso delle parole”, come quella rubricapoi diventata famosa si chiamava.
Ha parlato di obiezioni mosse a Paci. Quali erano i suoi con-tatti, i suoi interlocutori più vicini, quali i suoi dissensi rispettoagli altri filosofi, agli altri intellettuali del tempo, agli altri inter-preti e prosecutori della fenomenologia?
Paci non era il solo che si fosse rivolto alla fenomenologia inItalia. Ai primordi della diffusione della fenomenologia ci furonoapporti molto diversi. Quello di Sofia Vanni Rovighi,dell’Università Cattolica di Milano, ad esempio, che leggeva la
201
Enzo Paci e la Scuola di Milano
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 201 (Nero/Process Black pellicola)
fenomenologia husserliana degli anni Venti in termini, appunto,cristiano-cattolici, come un’ala della scuola husserliana fece aGöttingen, cioè come ritorno alla filosofia prima aristotelica, comepossibilità moderna di ricostituire una ontologia, o un insieme diontologie regionali, un sistema di essenze, che avvalorasse il pro-getto di una fondazione metafisica dell’esperienza e della verità.Paci era molto lontano, naturalmente, da questo orizzonte, anchese aveva molta stima personale per Sofia Vanni Rovighi e anche seci fu, tra loro, una sincera amicizia filosofica. Un’altra via fu quellabattuta da Norberto Bobbio, che più tardi abbandonò questo gene-re di studi, ma che fu uno dei primi testimoni della fecondità delmetodo fenomenologico, soprattutto nella sua applicazione allescienze giuridiche. Un’altra via ancora fu quella di Filiasi Carcanoa Roma: anche Filiasi Carcano fu tra i primi, in Italia, a interessarsia Husserl, benché avviandosi poi ad una complessa vicenda che loallontanò via via dalla fenomenologia, portandolo ad interessarsidi psicoanalisi. Furono esperienze diverse, ciascuna delle qualirispecchiava una possibile lettura di Husserl, una differente opzio-ne interna a Husserl stesso. Nessuna di esse ebbe però, teoretica-mente, grande rilievo, e nessuna ha, oggi, interesse se non in sensostoriografico, anche perché vennero tutte sormontate, in qualchemodo anche cancellate, dall’onda dell’esistenzialismo, dall’imporsidella versione esistenzialistica della fenomenologia. Cioè, insostanza, da Heidegger, o dall’interpretazione di Heidegger cheper un certo periodo fu corrente. Lo stesso Paci, dopo questo primospunto fenomenologico vissuto alla scuola di Banfi e in relazionealla visione platonico-socratica della filosofia, si interessò ad altro,divenendo anzi uno dei tre grandi esponenti dell’esistenzialismoitaliano, con Luigi Pareyson e Nicola Abbagnano. La differenza traPaci e queste due altre figure è che sin dall’inizio Paci aveva avutoun confronto importante con la fenomenologia, che fin dall’iniziola fenomenologia si era intrecciata alla sua riflessione. Cosa chenon si può assolutamente dire né di Pareyson né di Abbagnano.Abbagnano veniva da studi di filosofia della scienza, e in quell’am-bito si mosse per tutta la vita, tendendo ad abbracciare una pro-spettiva anche sociologica, e allontanandosi via via dall’esistenzia-lismo, che cercò di declinare in una versione positiva, come la defi-nì, oggi difficile da accogliere perché derivata da un sostanzialefraintendimento dell’esistenzialismo di Heidegger. Pareyson, inve-ce, molto più solido teoreticamente, veniva a sua volta da un’espe-rienza filosofica delimitata in modo molto preciso, fondamental-202
Carlo Sini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 202 (Nero/Process Black pellicola)
mente segnata dalla sua fede cristiana e dai suoi studi idealistici.Pareyson ha sempre pensato l’esistenzialismo di Heidegger piutto-sto in rapporto a Kierkegaard, piuttosto in rapporto a Schelling.Non ha mai colto l’esistenzialismo nel suo nesso con la fenomeno-logia in senso husserliano, non ha mai compreso davvero cheHeidegger era, ed è rimasto, per tutta la vita, un allievo di Husserl.Con ciò direi che Pareyson si è reso responsabile – con molti altri,naturalmente – di una lettura heideggeriana tutta spostata sul côtéreligioso, diciamo così, mistico-religioso: lettura che trova ovvia-mente più di uno spunto, in Heidegger, ma che non aiuta, a mioavviso, a comprendere il problema profondo di Heidegger, a com-prenderlo nella sua matrice originaria. Matrice che è fenomenolo-gica, e che tutta la scuola di Torino – Pareyson e i suoi allievi,Gianni Vattimo ad esempio – sostanzialmente ignorano. Avviene ilmedesimo in Gadamer, d’altra parte. Gadamer ha scritto cose inat-tendibili, sulla fenomenologia, a testimonianza di una completanon familiarità con i testi, ma soprattutto con le domande dellafenomenologia, che invece Heidegger conosceva benissimo puravendole, da un certo momento della sua vita in avanti, gradual-mente messe in ombra.
Come si pone Paci di fronte a tutto questo?
Alla fine degli anni Cinquanta, di fronte alla crisi dell’esistenzia-lismo italiano ed europeo, di fronte all’incalzare della questionemarxista, della questione sociale o politico sociale, e di fronte, peraltro verso, al diffondersi del neopositivismo, che giudicava forte-mente dogmatico, e quindi totalmente estraneo allo spirito dell’au-tentica filosofia, Paci ebbe l’idea di un ritorno alla fenomenologia.Fu l’avventura di pensiero più grande della sua vita. Ricordò, perdire così, qualcosa che d’altra parte non aveva mai dimenticato, ilgiovanile interesse verso Husserl che Banfi gli aveva trasmesso, eoperò una sorta di meditazione sul destino della fenomenologiavedendo nell’esistenzialismo che lui stesso aveva frequentato nontanto un superamento della fenomenologia o un cammino alterna-tivo alla fenomenologia, ma un episodio del tutto interno e deltutto insufficiente della fenomenologia stessa. Qualcosa, cioè, cheveniva dalla fenomenologia, ma che per molti aspetti ne tradival’intenzionalità profonda; qualcosa che, soprattutto, ignorava trop-po di quello che si suole definire lo Husserl inedito. Fu decisivo,per Paci, l’impatto con i manoscritti di Husserl, attraverso i contat-
203
Enzo Paci e la Scuola di Milano
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 203 (Nero/Process Black pellicola)
ti con Padre van Breda degli archivi di Lovanio, con cui stabilì unacollaborazione e un’amicizia molto importanti. Lo invitò a Milano,ricordo, per una conferenza rimasta famosa, in cui van Breda ci rac-contò, in sostanza, cosa c’era in quella sterminata raccolta di mano-scritti, che Paci iniziò a studiare e a fare studiare inviando aLovanio alcuni suoi allievi: uno di questi era Giovanni Piana, unaltro Alfredo Marini… Iniziò un ampio lavoro di ripensamento, dirielaborazione. Vi fu il grande episodio della riflessione sulla Krisis,l’ampio lavoro di traduzione in italiano di quest’ultimo testoincompiuto di Husserl, l’edizione del libro di Brand su Mondo, io etempo nei manoscritti inediti di Husserl, a cui Paci scrisse una prefa-zione diventata famosa… L’idea era quindi quella di vedere nellafenomenologia la filosofia del nostro tempo, fraintesa daHeidegger con alcuni risultati molto importanti, naturalmente, maanche con alcuni esiti infelici, e di fare della fenomenologia larisposta alle filosofie borghesi “alienate”, come allora si sarebbedetto: l’empirismo, il neopositivismo… La fenomenologia diventa-va così, allo stesso tempo, il possibile raccordo con il marxismo, chea sua volta rinasceva, in Italia, dopo la sua prima fioritura dell’ini-zio Novecento. Intorno a Paci emersero molti giovani, e molti altri,giovani e non giovani, entrarono in contatto con lui. Ad esempiol’altra linea nata dalla scuola di Banfi, il gruppo bolognese, legato astudi di estetica: vi fu una collaborazione feconda con tutta la neoa-vanguardia italiana degli anni Sessanta, che aveva appunto aBologna il suo centro più importante e la sua rivista, “il Verri”. Vifurono anche dissensi molto netti, naturalmente. Spesso i condisce-poli non vanno d’accordo tra loro, e Paci, ad esempio, non andavaaffatto d’accordo con l’altro discepolo di Banfi, Remo Cantoni. NéCantoni andava d’accordo con lui, del resto. C’erano divisioni pro-fondissime, anzi. E ancor più profonde diffidenze rispetto ad unaltro banfiano come Giulio Preti, anche lui studioso di Husserl,anche lui orientato al marxismo, ma influenzato dal pragmatismoamericano, da Dewey ad esempio… Vi furono anche alleanze eaffinità inattese, a Bari con Giuseppe Semerari, ad esempio.Semerari non era un allievo di Paci, anche solo per ragioni di età,ma aveva avvicinato la fenomenologia autonomamente, venendoda studi schellinghiani, ad esempio, e ad un certo punto si era auto-dichiarato, diciamo così, discepolo di Paci. Era entrato nella suaorbita, e aveva collaborato a lungo con lui, con qualche momentodi dissenso ma, sostanzialmente, svolgendo un lavoro parallelo,poi proseguito lungo la stessa linea anche quando Paci propose, in204
Carlo Sini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 204 (Nero/Process Black pellicola)
modo abbastanza clamoroso, grosso modo dal 1963 in avanti, l’e-quazione fenomenologia-marxismo. L’atmosfera fu, nonostantetutto, però, di forte opposizione generale alla rinascita della feno-menologia. Tutti quei rapporti furono difficili: Banfi, Abbagnano,Geymonat, Preti, Cantoni, Paci… Tutti assunsero posizioni indi-pendenti e autonome, ma alla fin fine Paci si trovò sostanzialmen-te solo a difendere un’idea di filosofia intesa in senso teoreticopuro, in senso metafisico tra virgolette. Anche a me, ricordo, rivol-sero delle critiche di metafisicismo, come a chiunque avesse l’ariadel filosofo in un panorama in cui da più parti si ripeteva che leopzioni disponibili erano invece soltanto quelle della scienza dauna parte e della storiografia dall’altra. Per altro verso, è chiaro chePaci non poteva trovare grande ascolto in area cattolica: non condi-videva le interpretazioni cattoliche dell’esistenzialismo, meno chemeno condivideva quelle cattoliche di Husserl. Fu una situazionedi sostanziale isolamento, accompagnato però da un innegabilesuccesso. Negli anni Sessanta in Italia non si parlava d’altro che difenomenologia, dappertutto la questione tornava su Husserl, dap-pertutto la polemica si riferiva a questo progetto di Paci. Il qualequindi non poté vantare vittoria sul campo, ma poté vantare diavere costretto tutti a parlare di fenomenologia…
L’ultima stagione del pensiero di Paci è segnata da un libroche si intitola Idee per un’enciclopedia fenomenologica. Vi sonoraccolti scritti di Paci di diversa provenienza, e soprattutto didiverso argomento, nati da un confronto in qualche modo onni-voro con il dibattito suo contemporaneo: pagine su Galileo, suKeynes, su Lévi-Strauss, su Freud… Proprio questo aspetto enci-clopedico, che il progetto fenomenologico di Paci assume esplici-tamente nella sua ultima fase, mi pare meriti qualche riflessione.Mi verrebbe da notare che la sua radice più ovvia sta nei tre libridelle Ideen di Husserl, nel terzo soprattutto, dove Husserl tentauna sistemazione di quelle che chiama ontologie regionali, e unasistematizzazione dei nessi tra le “essenze” che ciascuna regioneontologica incarna. Ma è altrettanto chiaro che lo Husserl delleIdeen, con tutto che è lo Husserl del corpo proprio, nel secondolibro, lo Husserl che in qualche modo prelude ai temi dellaLebenswelt, non è, però, lo Husserl di Paci, lo Husserl dellaKrisis, lo Husserl della Lebenswelt, appunto, compiutamentesituata al centro della ricerca fenomenologica. Dunque, che cosasignifica in ultimo questa intenzione enciclopedica?
205
Enzo Paci e la Scuola di Milano
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 205 (Nero/Process Black pellicola)
Questa vocazione enciclopedica in Paci è stata costante, dallagiovinezza alla maturità – anche se è emersa più nettamente,appunto, nell’ultimo periodo – perché lui stesso era un uomo enci-clopedico. Paci accompagnava molte altre passioni all’interessefondamentale per la filosofia, alla sua immensa cultura filosofica –una cultura filosofica molto superiore a quella di Sartre, per esem-pio: poteva citare tranquillamente Giordano Bruno come Platone,la sua era una visione a tutto campo. A tutto questo Paci accompa-gnò sin dall’inizio una passione per la letteratura o per la musica,ad esempio. Conosceva anche molto bene l’architettura. Avevainsomma una molteplicità di interessi, che si ritrova espressa anzi-tutto in “aut aut”, e che, alla fine, si coagula appunto in questo ten-tativo, in questa raccolta di “idee” per una fenomenologia enciclo-pedicamente articolata. È vero che, volendo cercare una radice diquesto progetto, la si può trovare nel disegno husserliano delleontologie regionali. Curiosamente, le cose vanno però, credo, inte-se diversamente. Paci considerava effettivamente le Ideen come laparte “superata” di Husserl, superata da Husserl stesso. Il grandeproblema Paci lo individuava, e questo è un suo contributo impor-tante, nella svolta trascendentale. Quella che da molte parti veni-va rimproverata a Husserl come una ricaduta nella metafisica, nel-l’idealismo, era invece per Paci la risoluzione di un problema cheal livello delle Ideen non si sarebbe mai potuto risolvere. Ideen I inparticolare era ancora un progetto sostanzialmente metafisico, opsicologistico se lo si vuol leggere in quest’altro modo. La svoltatrascendentale per Paci valeva invece come tentativo di dare rilie-vo alla descrittiva delle essenze. Che cosa sono, però, le essenze?Che cosa sono questi fantasmi metafisici che compaiono a un certopunto nel discorso di Husserl, necessari per tante ragioni, adesempio per affrancarsi dallo psicologismo di Brentano, ma inultimo infondati, almeno in questa loro formulazione? Il fatto èche non si tratta di una semplice descrittiva delle essenze, ma diuna descrittiva che pone inoltre delle questioni, degli interrogati-vi sulla natura e sul senso di queste stesse essenze. Si tratta diquell’altro aspetto della fenomenologia, che Paci ha sempre privi-legiato, che è la fenomenologia genetica. Si tratta cioè di una rico-struzione delle operazioni precategoriali fondanti, che a un certopunto si coagulano in forme, certo, ma in forme che non sono maiimmobili, ma sono temporalmente in movimento. Uno dei temicostanti, in Paci, è quello della temporalità. Temporalità che cogliedapprima in Husserl, poi in Heidegger, che sviluppa più tardi in206
Carlo Sini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 206 (Nero/Process Black pellicola)
senso esistenzialistico, e che affronta, infine, riprendendo loHusserl dei primi del Novecento. Una delle obiezioni di Paci aHeidegger è di non avere tenuto conto, proprio lui che ne era statoil curatore (o, se si vuole, di avere fatto un saccheggio, senza tut-tavia trarne tutto il possibile), dei manoscritti husserliani sultempo, le Lezioni sulla coscienza interna del tempo. Per Paci è fonda-mentale questa acquisizione, che l’essenza non è una forma stati-ca, non è un’idea nel senso del Platone sistematico, ma, caso mai,è un’idea nel senso del Platone aporetico: la temporalità dellaforma dell’esperienza si trova costituita entro una genesi che èperaltro da ricostituire sempre di nuovo, sempre in cammino. Lasua enciclopedia non è allora un’enciclopedia delle categorie sepa-rate, ma un’enciclopedia del dialogo continuo tra vita e forma. Èpoi questo il problema profondo di Paci, anche in questo buonerede del simmeliano Banfi: il rapporto tra vita e forme, tra vita everità. La sua enciclopedia non è tanto una sistematizzazione delsapere, quanto un dialogo continuo che il filosofo deve istituirecon la prassi umana, con prassi di ogni genere, con prassi artisti-che, economiche… Non a caso Paci era un buon lettore di Croce.Io saprei, diceva spesso, come tradurre Croce in una maniera piùattuale, mostrando che Croce è un grande pensatore, che si è inqualche modo arenato sulla questione delle forme dello spirito,ma che, proseguito in quella direzione, avrebbe potuto forse ricon-giungersi con Husserl e con i nostri problemi più attuali.
Mi chiedo se non sia stato il comune retroterra marxiano a ren-dere possibile un incontro, o un’affinità, come questa… AncheCroce veniva ovviamente da Marx, oltre che da Hegel. E sia loHusserl della Lebenswelt, che Paci poteva vedere convergere conCroce, sia appunto il Croce teorico dell’“economico” tematizza-vano in fondo una stessa cosa, anche se ciascuno a suo modo…
Sì, l’economico di Croce è il precategoriale di Husserl, nellaprospettiva paciana. Ci fu anche uno scambio molto interessantetra i due: Paci era allora sui trent’anni, e tentò questa interpretazio-ne del vitale di Croce in alcuni saggi, poi studiati da Santucci, aBologna, e da Antonino Bruno, che sulla questione ha scritto unlibro. Croce era, naturalmente, ormai vecchio, era il grande eammirato filosofo. Paci era molto giovane, dicevo, ma tentò ugual-mente questa proposta. Croce non stima l’esistenzialismo, ma selasciamo da parte l’esistenzialismo in generale, se pensiamo all’e-
207
Enzo Paci e la Scuola di Milano
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 207 (Nero/Process Black pellicola)
sistenzialismo come lo intendeva io, Paci, allora l’esistenzialismopoteva fare comodo a Croce. In sostanza, l’esistenzialismo avvalo-ra la categoria dell’economico. Con questa differenza: primo, chela categoria dell’economico non è una categoria dello spirito, per-ché è la categoria della vita che precede lo spirito; secondo, che l’e-conomico è il fondamento di tutte le altre categorie dello spirito.Se Croce accettasse questo, concludeva Paci, Croce sarebbe un esi-stenzialista, e lui stesso, Paci, sarebbe un crociano… E, appunto,tutti e due marxisti, dicevi tu. Marxisti come Croce infatti, in uncerto modo, era stato da giovane, studiando Marx tra i primi dastorico, in Italia, insieme all’amico, allora, Gentile. Croce, natural-mente, non addivenne a questa idea. La criticò anche, da par suo,obiettando che quando si dice “il precategoriale”, “l’economico”,queste sono già categorie… Era ovvio che facesse un discorso diquesto genere, ma allo stesso tempo fu talmente impressionato daquesta prospettiva che fino alle ultime schede della “Critica” citornò sopra. Ne fu colpito. La cosa lo disturbava parecchio, eanche lo stuzzicava parecchio… Sostanzialmente, quindi, per Pacil’idea dell’enciclopedia doveva restituire alla filosofia la funzionedi philosophia prima, non nel senso, tuttavia, di un fondamento,diciamo così, metafisico, bensì nel senso di un tentativo continua-mente rinnovato di riportare nel flusso della vita, e della descritti-va originaria della vita, le categorie dell’operare umano. Categorieche quindi sono da assumersi come realizzazioni parziali e prov-visorie, come cammini della verità ai quali il filosofo garantisce,diciamo così, la non chiusura. Si tratta di riaprire sempre di nuovola verità alla vita della verità. In questo senso allora c’è un preca-tegoriale dell’economia, c’è un precategoriale della biologia, c’è unprecategoriale dell’arte… Anche il marxismo, che appunto ricor-davi, rientra esattamente in questo modo di vedere. Il marxismointeso in questo senso, pensava Paci, pensava anche Sartre, non è“una” filosofia, è “la” filosofia del nostro tempo: il marxismo, o uncerto marxismo, parla della vita umana degli uomini, tiene politi-camente aperta la strada alle continue realizzazioni di una veritàteleologica, che non potrà mai irrigidirsi in forme definitive, e chequindi in questo senso è vita storica profonda. È, questa, ancheuna risposta a Heidegger: la vita storica profonda non è quella del-l’essere che si nasconde e si manifesta, non è il poetico, non è nien-te di tutto questo. La vita storica profonda è la vita quotidiana,sempre di nuovo da portare all’espressione, alla forma, alla cate-goria, per poi disattenderla, per poi oltrepassarla.208
Carlo Sini
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 208 (Nero/Process Black pellicola)
Che cosa resta oggi di questo progetto? Cosa resta, in partico-lare, non solo di Paci, ma del suo progetto fenomenologico edella sua scuola filosofica?
Restano certamente alcune traduzioni di Husserl e della suascuola, per cominciare. Traduzioni fatte da Paci e, soprattutto, dagliallievi di Paci: Enrico Filippini, Giovanni Piana, Alfredo Marini,Guido Davide Neri... Non Costa, che veniva da tutt’altro ambiente.Si confrontò anche con Paci, naturalmente, ma tra loro ci fu sempreun po’ di ruggine, nel senso che in queste traduzioni, peraltroimpeccabili, ricorreva però una terminologia che non era quella dei“milanesi”, diciamo così. E questo creava in Paci qualche imbaraz-zo. Dalla scuola di Milano venne quest’opera di traduzione e di tra-smissione, e poi un prezioso lavoro di approfondimento, svoltoattraverso tutta una serie di studi specifici, che saggiavano lepotenzialità dell’approccio fenomenologico in varie direzioni.Quanto alla logica, ad esempio, ci furono studi interessanti diBosio, che poi si spostò prevalentemente sul côté di Hartmann, deifenomenologi non ortodossi, diciamo così, di Max Scheler…Quindi, apporti volti soprattutto a commentare e fare comprende-re la riflessione di Husserl, contributi usciti sulla rivista “aut aut” enella collana di Lampugnani e Nigri, che pubblicava molti di que-sti lavori della scuola di Paci. Che ci sia stato poi uno sviluppo teo-retico autonomo di questo grande lavoro, questo è forse più diffici-le da testimoniare. È indubbio che Guido Neri, scomparso da poco,tentò a sua volta, ad esempio, approfondimenti interessanti sullalinea fenomenologia-marxismo, insieme a Gambazzi. E moltoimportante è l’elaborazione da parte di Piana di alcuni temi feno-menologici, quello dell’immagine, per esempio, o della musica…
Note al testo
* L’intervista compare originariamente in “Le Cercle herméneutique”,n. 1, Paris 2003, e viene qui riprodotta in forma ridotta per gentile conces-sione dell’autore, del curatore e del direttore della rivista, GeorgesCharbonneau, che la redazione di Chora ringrazia sentitamente. Il titolodell’intervista qui proposto non corrisponde all’originale.
209
Enzo Paci e la Scuola di Milano
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 209 (Nero/Process Black pellicola)
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
Dal computazionalismo alla fenomenologiaENZO PACI, ALAN TURING
E L’IMPOSSIBILE GIOCO DELL’IMITAZIONE
“L’irreversibilità sgretola l’edificio del meccanicismo newtoniano, l’universo pensato come una macchina classica idealizzata. Questa
macchina, sia concepita come modello fisico che come modello logico,non esiste. E dicendo che non esiste, diciamo, appunto, che
è semplicemente un ideale, un ideale di perfezione.”
“Se [...] le filosofie dell’identità e le filosofie della sostanza sono ingenere filosofie dell’atemporale e dell’astorico, le filosofie che si ispirano
non più a un modello di macchina perfetta, ma se mai, alle macchineeffettivamente esistenti, sanno che ogni macchina è imperfetta.
Se proprio si vuol costruire una visione dell’universo su un modello ese questo modello deve essere una macchina, bisognerà basarsi sulle
macchine reali e non su quelle mai costruite e non costruibili, come, appunto, la macchina ideale.”
Enzo Paci, Tempo e relazione (1954, pp. 4-5).
0. Informatica e cibernetica nell’Enciclopedia fenomenologi-ca di Paci
L’enorme mole degli scritti lasciati da Enzo Paci e la notevoleeterogeneità dei loro argomenti testimonia come la sua ricercaabbia attraversato un novero sorprendentemente ampio di temati-che e di ambiti disciplinari. Tra questi si segnalano alcune paginedella sua enciclopedia fenomenologica1 dedicate all’informatica (“teo-ria dell’informazione”) e più in particolare all’idea di “intelligenzaartificiale” e alle correlate implicazioni filosofiche. La riflessione di
211
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 211 (Nero/Process Black pellicola)
Paci sull’intelligenza artificiale e sulla cibernetica assume un valo-re particolare all’interno del suo progetto se si considera che questitemi si collocano in un punto nodale fondamentale per la coscien-za della nostra epoca, situato all’incrocio tra i grandi temi della tec-nica (ultima espressione nichilistica delle scienze europee e dellaloro crisi) e della meditazione esistenzialistica e relazionistica sullacondizione dell’umanità occidentale (rispetto alla quale l’idea dimacchina si impone come metafora fondamentale dei rapporti diproduzione capitalistici e come paradigma emblematico della con-temporaneità positivistica); problematiche che, per Paci, devononecessariamente essere ricondotte alla considerazione del mondo-della-vita husserliano e alle strutture intenzionali situate al fondodi ogni possibile operazione intersoggettiva di validazione scienti-fica e sperimentale. La discussione del gioco dell’imitazione diTuring, in particolare, contiene degli elementi di forte interessetanto per gli epistemologi quanto per gli ermeneuti di formazionefenomenologica, e utilizza alcuni argomenti che non è azzardatodefinire unici in tutta la letteratura dedicata a questi temi. Per que-sto motivo ad essa le seguenti riflessioni.
1. L’Imitation Game, ovvero il “Test di Turing”
La questione filosofica dell’intelligenza “artificiale”, o “mecca-nica”, investiga la possibilità che la mente umana funzioni in basea un meccanismo ricorsivo e che sia di principio realizzabile unautomatismo in grado di riprodurre sotto il profilo funzionale lasua complessità. Per affrontare questo tema Paci si rivolge adAlan Turing, il geniale costruttore dei primissimi elaboratori digi-tali, nonché padre e patrono della computer science. In particolarePaci prende in considerazione il suo scritto del 1950, Computingmachinery and intelligence2, il primo e il più importante manifestodell’intelligenza artificiale. In un altro celebre articolo, del 19363,che costituisce l’atto fondativo più importante della teoria dellacomputabilità, Turing aveva già sostenuto la tesi secondo cui ognioperazione computazionale (cioè ogni procedura di calcolo) con-dotta da un uomo in carne ed ossa con metodi finitari è in linea diprincipio eseguibile da una “macchina a stati discreti”, ovverouna macchina di Turing, debitamente programmata. Il presuppostoinespresso di questa tesi risiede nel principio secondo cui ogniattività inferenziale umana condotta con mezzi logico-simbolici212
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 212 (Nero/Process Black pellicola)
sarebbe nella sua più intima natura meccanica, cioè deterministi-ca e interamente formalizzabile.
Con l’articolo del 1950 Turing sostiene una tesi che per certi versirappresenta il completamento e il coronamento necessario dellaprima, ma che è ancora più scandalosa di questa e, sotto moltiaspetti, perfino più controversa: si tratta della tesi secondo cui, inlinea di principio, deve essere possibile costruire una macchinatanto raffinata e complessa da riuscire a simulare qualsiasi funzio-ne mentale umana. Un super-computer, in altre parole, capace dicomportamenti intelligenti paragonabili a quelli umani: dimostra-re teoremi, giocare a scacchi, scrivere poesie, sostenere conversa-zioni sugli argomenti più disparati, imparare relazionandosi agliuomini e al mondo circostante ecc. Anche questa seconda tesi,secondo alcuni4, nasconde un presupposto inespresso: se una mac-china è in grado di funzionare come un cervello, ciò dipende, infondo, dal fatto che lo stesso cervello umano agisce attraverso laricorsione di operazioni logico-simboliche di tipo meccanico. Inaltre parole, se questo assunto si scoprisse essere corretto, alloratanto le operazioni fondamentali eseguite dalla macchina, quanto iprocessi elementari che avvengono all’interno della mente umana,avrebbero la medesima natura computazionale e consisterebberoin nient’altro che azioni ricorsive di spostamento e sostituzione dielementi simbolici atomici5.
Tuttavia, proprio come non è per nulla facile programmareun’intelligenza artificiale capace di emulare l’intelletto umano,non è semplice neanche immaginare un criterio per valutare se unprogramma è effettivamente riuscito a raggiungere un tale mera-viglioso obbiettivo. Come deve intendersi, infatti, il concetto diintelligenza, e quali strumenti di verifica possiamo elaborare permisurare in sede sperimentale il suo grado di sviluppo? Si com-prende bene che tali interrogativi costituiscono una sfida difficilis-sima tanto per la psicologia quanto per la filosofia. Nel suo celebrescritto del ’50 Turing propose di sottrarre la definizione dell’intel-ligenza sia all’una che all’altra disciplina, e di sostituirla ex abrup-to con un criterio di verifica empirico immediatamente applicabi-le, che non richiedesse alcun assunto teorico e nessuna conoscen-za preliminare: una macchina può legittimamente esser definita“intelligente” se il suo comportamento risulta sostanzialmenteindiscernibile da quello di un essere umano; o, in altri termini,un’elaborazione logico-simbolica esprimente informazioni (adesempio un insieme di lettere scritte) può essere riconosciuta come
213
Enzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 213 (Nero/Process Black pellicola)
la testimonianza di un comportamento “intelligente” se non cisono dubbi plausibili sul fatto che essa possa provenire da un esse-re umano, e se quindi essa non manifesta l’aspetto di un prodottodi un automatismo naturale o artificiale.
Con un sorprendente esperimento mentale Turing immaginauna situazione nella quale un tale criterio di verifica sia facile damettere in pratica. La situazione proposta è quella di una conver-sazione che avviene attraverso lo scambio di brevi messaggi scrit-ti tra due individui che si trovano in comunicazione per mezzo diun dispositivo che consenta loro di mantenere il reciproco anoni-mato: un essere umano, diremmo oggi, sta chattando con un indi-viduo sconosciuto. Il nostro uomo, infatti, si trova seduto al termi-nale di una telescrivente, può leggere il testo che gli viene inviatodall’altro capo della telescrivente e può rispondere digitando conla sua tastiera qualsiasi messaggio. Entrambi possono fare doman-de e rispondere a piacimento, anche se sono vietate le domandedirette sull’identità dell’interlocutore. L’altro capo del collegamen-to, però, è nascosto - perché si trova in un’altra stanza - così che ilnostro uomo non può sapere se sta dialogando con un altro esse-re umano o con una macchina incredibilmente sviluppata e intel-ligente. L’esperimento prende la forma del gioco, perché l’uomo haappunto il compito di riuscire a indovinare se all’altro capo dellatelescrivente si trova un umano o una macchina. E, inoltre, si trat-ta di un gioco di imitazione, perché - posto che all’altro capo dellatelescrivente ci sia una macchina - quest’ultima ha il compito direcitare così bene la sua parte di “umano” da riuscire a non farsiscoprire. Quindi, per Turing, è lecito affermare che una macchinaha raggiunto un comportamento intelligente se l’uomo dell’espe-rimento sarà perfettamente ingannato dalle capacità recitativedella macchina, e commetterà statisticamente la stessa quantità dierrori nel cercare di indovinare la natura del suo interlocutore, siaquando quest’ultimo è effettivamente un uomo, sia quando, inve-ce, è una macchina.
2. La critica di Paci
Per molto tempo un simile metodo di verifica ha rappresentatoil paradigma metodologico-concettuale irrinunciabile per la valu-tazione dell’efficienza delle intelligenze artificiali (più teoricamen-te che concretamente, in realtà, anche perché non esistono ancora214
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 214 (Nero/Process Black pellicola)
macchine in grado di ingannare un uomo, attraverso la conversa-zione, per più di pochi minuti6). Sebbene esso non abbia mai smes-so di esercitare la sua autorevole influenza, molte critiche sonostate tuttavia mosse a questo approccio e alla proposta di Turing diescludere qualsiasi considerazione concreta e contenutistica delconcetto di intelligenza, riducendo quest’ultima, in effetti, a unmero fenomeno estrinseco e statistico. Anche le considerazioni diEnzo Paci si rivolgono a questi aspetti del test di Turing, ma la suacritica si distingue nettamente da quelle rivolte dagli epistemologie dai teorici dell’intelligenza artificiale: il punto di osservazione dalui proposto è del tutto alternativo rispetto sia a quello degli apo-logeti che a quello dei detrattori dell’IA. Per questi ultimi la previ-sione di Turing secondo la quale entro cinquant’anni gli informati-ci sarebbero stati in grado di imitare qualsiasi capacità intellettua-le umana per mezzo di potenti algoritmi si è rivelata in buona partefallimentare, soprattutto perché le competenze manifestate dallemacchine sono limitate ad alcuni ambiti molto circoscritti (adesempio ad attività prettamente formali, come il gioco degli scac-chi) e non raggiungono ambiti che richiedano il ricorso di facoltàcome l’abduzione e l’improvvisazione (come nella conversazionelibera, che è appunto l’attività presa in considerazione dal test diTuring, e che sembra refrattaria ai tentativi di formalizzazione).
La critica di Paci è totalmente differente perché non si riferiscealle modalità di realizzazione attuali o potenziali dell’imitationgame, né al presumibile grado di perfettibilità dell’intelligenza arti-ficiale, ma costituisce invece un’asserzione dell’impossibilità diprincipio di giocare il gioco stesso. Il senso dell’argomento di Paciè dunque questo: quand’anche si disponesse del computer piùpotente e meglio programmato possibile, il test di Turing non solonon sortirebbe alcun effetto utile ma, a ben vedere, non potrebbeneanche avere luogo. Ciò che Paci intende mostrare non è che “nonsi possano costruire macchine pensanti, contro la tesi di Turing”(un tale compito, infatti, probabilmente spetta all’epistemologo oall’informatico, più che al filosofo teoretico), “ma che dal punto divista di Turing [...] il giuoco che egli propone non è logicamentepossibile e non è di fatto, anche idealmente, eseguibile”. Perché?
Paci considera la situazione descritta dal test di Turing (uomo inuna stanza + macchina in un’altra stanza nascosta + telescriventeche li mette in comunicazione) sotto il profilo del sistema comples-sivo di scambio delle informazioni che tale situazione realizza:tanto l’uomo quanto la macchina iniziano il gioco provvisti di certe
215
Enzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 215 (Nero/Process Black pellicola)
informazioni, una base di dati di partenza che costituisce la corni-ce entro la quale saranno elaborate tutte le informazioni di cuientreranno in possesso successivamente. I vari passaggi del gioco,le battute che i due interlocutori si scambiano, vengono dedottiognuno dal precedente, sulla base di una dialettica tra il saputo e ilnon saputo, tra l’informazione e la non-informazione, così che l’e-laborazione di ogni informazione deriva non solo da ciò che già sisa ma anche “dal dubbio o dall’ignoranza”, cioè da un’assenza diinformazione imputabile alla condizione di “isolamento” in cuientrambi i giocatori si trovano inscritti. Ciascuno dei due protago-nisti del gioco, per svolgere al meglio il suo compito, dovrà “pro-curasi delle informazioni”, scegliendo le domande più appropriatee interpretando le risposte che otterrà. Tanto la macchina quantol’uomo, però, sono “isolati”, appunto, e per questo ognuno rappre-senta un centro di elaborazione degli input che agisce a partire dauna base di dati specifica e che opera analogamente a quello che,nelle scienze cognitive, viene definito un “modulo cognitivo incap-sulato informazionalmente”7, cioè sostanzialmente isolato e ingrado di interagire con l’esterno solo attraverso la ricezione/produ-zione di informazioni espresse come input/output.
Il sistema così definito da Paci sulla base della proposta diTuring sembra isolato e autonomo, privo di interrelazioni, ma Paciosserva che questo non può essere interamente vero. Esiste almenouna caratteristica del gioco dell’imitazione che richiede ai parteci-panti di osservare quest’ultimo dal suo esterno, per dir così, e disuperare la situazione di chiusura in cui essi si trovano inscritti.Tale caratteristica avviene al termine del gioco e decide del suoesito, determinando se è stato l’uomo o piuttosto la macchina a ese-guire in maniera vincente il proprio compito. Si tenga in conside-razione, infatti, che in ogni fase del gioco (per come esso è statodescritto in precedenza, cioè come un sistema di elaborazione-datitra due moduli incapsulati) la produzione di un output derivadalla ricezione e dall’elaborazione dell’input appena ricevuto. Ciòè vero fino al penultimo passaggio del gioco, ma non può esserevero per l’ultimissimo passaggio, che deve necessariamente pro-tendersi verso un’uscita dal gioco stesso e verso la sua definitivachiusura. Cosa succede dunque in quest’ultima fase? È molto sem-plice (ma quanti, a parte Enzo Paci, ci avevano pensato?): l’uomo sialza dalla sua sedia, lascia la postazione della sua telescrivente e si dirigenell’altra stanza, per verificare se fino a quel momento ha conversato conun altro essere umano o con una macchina. 216
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 216 (Nero/Process Black pellicola)
Il gioco ha termine quando l’uomo si accorge che la sua previ-sione si è dimostrata corretta o errata. E questo non può accadereattraverso una prova a priori, prodotta all’interno del gioco, masoltanto al momento di una constatazione empirica che avvenga aldi fuori di esso. Solo in quel momento egli potrà stabilire se la mac-china con cui ha avuto a che fare fino a quel momento era davverointelligente. Il termine del gioco, la sua risoluzione, si ottiene sol-tanto quando una regola del gioco viene infranta, cioè quando l’uo-mo si decide a uscire dal contesto artificiale in cui era immerso pertornare nella concretezza della realtà vivente che costitutivamentesi trova ad abitare.
La chiusura del gioco avviene solo quando si realizza un’aper-tura che dischiude e orienta il gioco oltre la fissità delle sue regole,verso la dimensione precategoriale dell’esperienza incarnata: “l’in-formazione finale, l’‘uscita’ dal processo iniziato con l’informazio-ne iniziale, potrà averla solo oltrepassando una regola del giuoco,e cioè la condizione di isolamento che gli permette di interrogare inbase ad una informazione ed in base ad una non informazione, adignoranza, ad un dubbio”. Questa considerazione, per quanto cosìmanifestamente evidente, consente alcune osservazioni molto inte-ressanti e per nulla scontate.
3. La posizione ontologico-esistenziale della macchina e ilFrame Problem
Benché non sia insensato, mentre viene giocato, il gioco dell’imi-tazione può avere un significato vero e proprio solo quando finisce,esattamente allo stesso modo in cui l’uomo ha una vita unicamen-te perché si trova fin da sempre consegnato, dal linguaggio, allaconsapevolezza che egli non è vita e che per questo lo attende unineluttabile destino di morte. Al contrario della macchina, la quale- non potendo morire - non può dirsi neanche viva, l’uomo vive peril fatto stesso di contemplare il confine ultimo della propria esisten-za, dovendosi confrontare con esso. Si deve osservare, anche perquesto motivo, che la situazione in cui si trova la macchina, nelgioco, è fin dall’inizio strutturalmente diversa da quella dell’uomo,e non riconducibile a quest’ultima. L’unica cosa che la macchinapuò fare è giocare il gioco dall’interno, domandando e risponden-do, mentre l’uomo può (e anzi deve) anche eseguire l’ultima mossadel gioco, che consiste nel percorrere il suo perimetro estremo e
217
Enzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 217 (Nero/Process Black pellicola)
valicarlo, ponendo fine al gioco stesso. Con questa operazione l’in-formazione finale proietta la sua influenza all’indietro su tutte leinformazioni precedenti, decidendone il senso oltre che il valore diverità. Solo l’uomo, il vivente già da sempre assegnato alla morte,può compiere questo passaggio, assumendo distanza dalla propriavita nella raffigurazione anticipatrice del morire8.
Mentre l’universo della macchina è interamente circoscritto dalsistema di regole formali che definiscono il gioco, l’universo del-l’uomo – sebbene sia anch’esso interamente formalizzato all’inter-no della rappresentazione ludica - comprende però anche quellaregola che prescrive di contraddire tutte le regole e di lacerare la scor-za del formalismo. È proprio il seme di questa paradossale con-traddizione che consente al gioco di possedere senso e coerenza.Mentre la macchina elabora le sue domande all’interno della suacornice prestabilita, l’uomo può aprire il suo domandare su di unadomanda più radicale che interroga appunto del senso di quellacornice che dà senso a ogni interrogazione formulata all’interno delgioco. È lo svolgimento stesso del gioco che suggerisce e richiede lapresenza di un soggetto fenomenologico per il quale il gioco assu-ma senso, un io-concreto che può contemplare la cornice comples-siva entro cui il gioco prende vita, e che per questo può disporre ilsuo sguardo all’“esterno” di esso, pur continuando a farne parte.Enzo Paci, seguendo una proposta fortunata tra alcuni logici e filo-sofi della matematica, riteneva che fosse appunto questo il signifi-cato complessivo del secondo teorema di incompletezza diGoedel9, un importante risultato della logica matematica che hainfluenzato profondamente l’intera concezione novecentesca delsapere e che, in particolare, ha giocato un ruolo cruciale nell’elabo-razione della teoria della computabilità e delle varie tesi sulla pos-sibilità dell’intelligenza artificiale. “Il teorema di Goedel”, scrivePaci nelle prime pagine della sua enciclopedia10, “rimanda a qual-cosa che non si lascia chiudere ed esprimere in un sistema comple-to di assiomi. Questo qualcosa ci fa sospettare che il fondamentodell’assiomatica sia fuori dell’assiomatica stessa, per esempio nellasoggettività costitutiva e nell’esperienza o, in altri termini, nelleoperazioni precategoriali che costituiscono ogni categoria [...]”.
Ma tralasciamo per ora il cruciale risultato di Goedel, che inseguito tornerà utile richiamare per proporre una sintesi comples-siva, e torniamo all’imitation game di Turing. Mentre l’attività dellamacchina si riduce a considerare il significato delle informazionilogico-simboliche da essa elaborate, l’attività dell’uomo deve com-218
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 218 (Nero/Process Black pellicola)
prendere anche la considerazione dell’evento di questo significato,l’hic et nunc in cui esso si trova ad accadere. Ossia l’intorno-di-mondo che lambisce i margini estremi di quello spazio formalizza-to nel quale il gioco viene giocato e dove ha luogo la raffigurazio-ne di un mondo formalizzato, le cui fattezze sono intessute dicomunicazioni telegrafiche e di scambi di informazioni logico-sim-boliche. Posta in questi termini, la questione della circoscrizionedei limiti entro cui avviene l’elaborazione delle informazionipotrebbe svolgersi nella direzione di una indagine di analitica esi-stenziale attinente alle modalità specifiche dell’essere, nel suoesserci, della condizione umana, piuttosto che verso un’epistemo-logia analitica attinente al campo dell’intelligenza artificiale.
Eppure i due ambiti, quello ontologico-esistenziale e quello epi-stemologico-formale, non sono così distanti come in superficieappare, e anzi proprio la riflessione svolta nell’ambito delle scienzeinformatiche disvela la centralità di questa problematica nel campodella programmazione dei software intelligenti11, dove essa pren-de il nome di frame problem (problema della cornice). Quest’ultimosembra indicare il limite costitutivo di qualsiasi sistema automatiz-zato che agisca sulla base di una rappresentazione formalizzata delmondo. Un computer - o, diciamo, un robot - agisce sempre sullabase di un’attività computazionale condotta sulle informazioni chericeve dall’esterno. La ragione per cui tutti i robot eseguono inmaniera rigida, ripetitiva e quindi, molto spesso, inaffidabile, queicompiti che sono invece considerati intuitivi e banali dagli esseriumani, non risiede tanto nel fatto che le macchine non abbiano adisposizione, potenzialmente, tutte le informazioni di cui hannobisogno, ma semmai proprio dal fatto che sono troppe le informa-zioni che ricevono dal mondo circostante, visto che le I.A. nondispongono di una cornice interpretativa che consenta sempre diselezionare quali sono le informazioni più utili o rilevanti, con ilrisultato manifesto che un’intelligenza artificiale può agire solo permezzo di approssimazioni e interventi stupidamente ripetitivi.
Per poter attuare una selezione dei dati paragonabile a quelladegli esseri umani, la macchina dovrebbe disporre di un criteriointerpretativo per decidere della loro importanza in base al signifi-cato; ma per far questo dovrebbe disporre di un criterio interpreta-tivo per eleggere il criterio interpretativo giusto tra i molti possibi-li, e così via. Ma ciò implica un regresso infinito e, nel computazio-nalismo classico, i processi di ermeneutica formalizzata devonosempre disporre di una condizione iniziale esplicitabile in maniera
219
Enzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 219 (Nero/Process Black pellicola)
positiva e definitiva12, perché la cornice interpretativa in cui leinformazioni della macchina vengono elaborate è sempre fornita aquest’ultima dal suo programmatore al momento della costruzione(ammesso che il costruttore sia in grado di esplicitare efficacemen-te in termini formali quale debba essere la cornice di riferimentopiù adeguata per il compito che la macchina deve eseguire).Insomma si potrebbe dire che il limite costitutivo dell’I.A. consisteproprio in quella situazione di precomprensione ermeneutica chel’uomo si trova costitutivamente ad abitare, essendo costretto que-st’ultimo nell’impossibilità di esperire il momento zero, l’incipitdella sua attività di interpretazione. E mentre l’uomo, stando nel-l’apertura chiaroscurale del linguaggio, può almeno porsi (anche seprobabilmente invano) il problema di fuoriuscire dal circolo erme-neutico in cui si trova già da sempre precompreso, il problema fon-damentale della programmazione delle macchine consiste al con-trario nell’incapacità di queste ultime di riuscire a entrarvi, essen-dovi già da sempre escluse.
Seguendo un importante indirizzo del cognitivismo contempo-raneo, quello “enattivo” e incarnato proposto da Francisco Varela edalla sua neurofenomenologia, potremmo dire oggi che una tale dif-ferenza costitutiva deriva essenzialmente dal fatto che soltantol’uomo, a differenza della macchina, è consegnato all’esperienza inprima persona di un corpo vivente, che abita frequentando il suospazio cognitivo come una soglia sulla quale si disegnano, corri-spondendosi nelle articolazioni delle cinestesi, concostituendosinel gioco delle ritenzioni e delle protensioni, gli schemi comple-mentari dell’interno e dell’esterno. È questo forse il presuppostopiù importante su cui si basa quella distinzione fondamentale tral’uomo e la macchina che Paci intende mettere in luce con il suoargomento. Essa consentirà di sviluppare alcune osservazionimolto importanti circa la valenza teoretica e la possibilità concet-tuale medesima del test di Turing.
4. Gli automi di Cartesio
In primo luogo bisogna osservare che Turing ha elevato l’indi-scernibilità a condizione di equivalenza tra l’uomo e la macchina.Una tale scelta richiama alla memoria dei filosofi quella, forse piùcelebre, di Renato Cartesio, sebbene quest’ultima abbia raggiuntoesiti almeno in parte differenti13. Nella seconda delle Meditazioni220
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 220 (Nero/Process Black pellicola)
metafisiche14, Cartesio ipotizza che le figure ammantate che egli,dalla sua finestra, osserva muoversi lungo la strada, potrebberoessere niente di più che automi, dispositivi meccanici simili a orolo-gi estremamente complicati e camuffati in modo tale da offrire auno sguardo distratto la percezione delle fattezze e del portamen-to umano. Se ciò fosse vero, se il demone ingannatore fosse diven-tato un abile costruttore di automi antropomorfi e avesse sviluppa-to il desiderio di giocare un perverso gioco dell’imitazione, alloracome sarebbe possibile distinguere (e si intende distinguere anchesolo concettualmente, attraverso giudizi a priori) il genere degliuomini da quello delle macchine, visto che le azioni svolte dagliuni sono esattamente identiche a quelle eseguite dalle altre?
Tutti conoscono quale soluzione Cartesio elabori a partire dal-l’indubitabile constatazione della presenza inalienabile ed autoe-vidente del cogito: quest’ultimo accompagna necessariamente l’at-tività degli uomini come una sostanza pensante aggiunta alcorpo, un supplemento di coscienza che è responsabile dellafacoltà del libero arbitrio, della capacità di espressione linguisticae concettuale; una res cogitans che si aggiunge alla compagineestesa, e meccanica, del corpo umano e che comunica con que-st’ultimo attraverso la ghiandola pineale. Meccanico l’uomo emeccanica la macchina, dunque, ma il primo possiede qualcosa inpiù della seconda, mentre la seconda agisce unicamente perchémossa da un principio deterministico di causalità efficiente, per ilquale gli eventi fisici si concatenano meccanicamente gli uni congli altri. In questo modo, in estrema sintesi, Cartesio intende sal-vare la distinzione sostanziale tra uomo e macchina, pur ricono-scendo la possibilità di una loro indiscernibilità sotto il profilofunzionale. Turing non tematizza invece alcuna res cogitanssostanzialmente indipendente dal suo supporto materiale; èanche per questo motivo che l’indiscernibilità funzionale trauomo e macchina viene di necessità a coincidere con un’equiva-lenza più profonda, strutturale, tra l’intelligenza umana e quellameccanica, e conduce direttamente all’affermazione della loroconsustanzialità, continuità e totale interscambiabilità. La condi-zione necessaria e sufficiente dell’equivalenza uomo-macchina,della loro equiparabilità e analogia strutturale, è infatti, perTuring, la loro mera indiscernibilità sotto il profilo funzionale. Inpoche parole: l’indiscernibilità a posteriori (fenomenica e funzio-nale) coincide, per Turing, con un’indiscernibilità a priori (concet-tuale o ontologica).
221
Enzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 221 (Nero/Process Black pellicola)
Eppure, lo si è appena visto, proprio perché una tale equivalen-za possa essere formulata, essa deve essere resa impossibile. Perchél’imitation game possa aver luogo un uomo deve essere capace dellafunzione che gli consente di uscire dal gioco e di osservarlo dall’e-sterno. La macchina è costitutivamente impossibilitata a uscire dalsuo gioco e questo rappresenta un primo motivo di non equiparabi-lità funzionale con l’uomo. Ma c’è di più. Uomo e macchina potreb-bero anche essere indiscernibili, ma il fatto stesso che una loro pre-sunta indiscernibilità possa essere formulata (da un uomo) contrad-dice, e quindi distrugge, la validità della formulazione stessa. Ilgioco dell’imitazione, in altri termini, può aver luogo soltanto quan-do la possibilità stessa del gioco dell’imitazione è stata annientata.Presi un uomo e una macchina qualsiasi, siano essi reali o immagi-nari, essi non saranno mai in grado di giocare in maniera pura ilgioco dell’imitazione. “Il giuoco dell’imitazione sarebbe completo”dice Paci (e si osservi il riferimento implicito alla completezza,oggetto del teorema di Goedel) “solo se A B C”, (cioè le variabili cherappresentano gli elementi protagonisti del gioco), “fossero X Y eZ” (cioè delle totali incognite, prive di qualsiasi caratterizzazione),“e nessuno sapesse se è un uomo o se è una macchina”.Effettivamente, in questo modo, se si negasse ai giocatori l’accessoalla consapevolezza della propria identità e quindi se si sradicassetanto l’uomo quanto la macchina dalla cognizione dei propri parag-gi corporei, della propria circostanzialità temporale, e della propriasituazione ambientale spaziale, allora il gioco dell’imitazione sareb-be effettuabile in maniera perfetta e rigorosa. Peccato, osserva Paci,che “in questo caso il giuoco non sarebbe possibile o, se si vuole, l’i-gnoranza totale coinciderebbe con l’informazione totale: ho l’im-pressione che solo in questo caso la macchina di Turing sarebbe unamacchina universale o l’uomo di Turing sarebbe un uomo universa-le”. Cosa intende Paci con queste ultime osservazioni sulla coinci-denza tra ignoranza totale e informazione totale?
5. Il gioco impossibile
Come si è già osservato in precedenza ogni fase del gioco dell’i-mitazione muove da un’interrogazione che scaturisce dal confron-to dialettico tra un’informazione (la base di dati di cui ogni gioca-tore dispone in partenza) e una non-informazione circa l’interlocu-tore. Sottraendo ad ogni interlocutore la conoscenza della propria222
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 222 (Nero/Process Black pellicola)
collocazione nei confronti della propria base di dati (cioè negandoall’uomo e alla macchina la consapevolezza di esser tali) vienenegata anche l’informazione relativa alla propria posizione all’in-terno del gioco stesso. Tutto ciò che l’uomo e la macchina potreb-bero sapere del gioco è che non se ne sa nulla e, anzi, probabilmen-te essi non potrebbero neanche comprendere di trovarsi all’internodi un gioco. La realtà simulata all’interno della conversazionediventerebbe l’unica realtà conosciuta dai giocatori, con il risultatoche non avrebbe neanche senso per loro la domanda su come uscir-ne per osservarla dall’esterno. Siccome non potrebbe esser interrot-to, il gioco smetterebbe di esser tale, e diverrebbe una meccanicaconcatenazione di scambi di stringhe di informazione, un disposi-tivo fintamente dialogico, che in realtà attua deterministicamenteuna serie lineare infinita di passaggi logici necessari e coatti: ilgioco non finirebbe mai e, non potendo finire, non si potrebbeneanche dire che esso sia iniziato, perché - come si è detto - è solola fuoriuscita dal gioco che fornisce a quest’ultimo un senso inquanto tale e, in sintesi, nessuno sarebbe legittimato ad affermareche un gioco dell’imitazione abbia mai avuto luogo.
“Turing parla della sua macchina ideale come la coincidenzadella macchina e dell’uomo” afferma Paci, una coincidenza checomporta però “l’equivalenza tra l’informazione e la non informa-zione”. L’indiscernibilità totale conduce alla totale inconsistenza eassurdità del tentativo di stabilire criteri di equivalenza, funzionalio sostanziali, tra l’uomo e la macchina, essendo divenuti entrambi ilmedesimo e unico evento di una comunicazione formalizzata entrocui non trova spazio la pratica del domandare e del rispondere,essendo stato annullato il senso di qualsiasi interrogativo. A questopunto si capisce che, come dice Paci, “dal punto di vista di Turingsono soppressi sia il termine uomo che il termine macchina”15.Come d’altra parte era immaginabile fin dall’inizio, l’acquisizione diuna perfetta, cioè assoluta, capacità imitativa, dovrà tradursi in unaassoluta indistinzione, con-fusione, che renda di principio impossi-bile comprendere di cosa si stia parlando, se di un uomo che imitauna macchina o viceversa di una macchina che imita l’uomo, essen-do entrambi nient’altro che i due frammenti combacianti di quell’u-nico - e perciò vuoto - evento di significato da cui essi provengono;due volti di una medesima paradossale facoltà mimetica: un giocodi specchi che può raffigurare ogni figura tranne quella dei duespecchi reali e concreti entro cui il gioco infinito dei rispecchiamen-ti ha preso vita. Cosa accadrebbe a questo punto, si chiede Paci?
223
Enzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 223 (Nero/Process Black pellicola)
“Ne deriverebbe proprio l’impossibilità della macchina diTuring e resterebbe di fatto che la macchina è davvero l’uomo nelsenso in cui l’uomo Turing stesso è macchina in quanto scienziato.”L’obbiettivo del gioco - valutare il grado di intelligenza della mac-china - deve quindi fallire perché lo scienziato che esegue l’esperi-mento, decidendo di eseguirlo, ha già deciso anche di annullare ladifferenza esistenziale che lo distingueva dalla macchina ideale16.Lo scienziato nega se stesso trovando negato ogni possibile accessoad una nozione concreta di macchina, a una macchina unicamentereale perché consegnata al movimento irreversibile del decorsotemporale. Chiaramente eseguire il gioco avrebbe ancora un signi-ficato, seppur completamente astratto, quand’anche al gioco venis-se sottratto il carattere dell’accadimento temporale: quando cioè,per pura ipotesi, da esso venisse interamente esclusa la considera-zione dell’evento significante del gioco stesso, cioè del fatto che essoè accaduto, manifestandosi, in un certo luogo e un certo tempo. Eperò, spiega Paci, “ovviamente, così inteso, il giuoco non sarebbetale: mancherebbe il tempo del domandare e il legame temporale trale domande, così come mancherebbe lo spazio e cioè il luogo deidialoganti che non dovrebbero trovarsi nello stesso luogo.”L’attività dell’uomo sarebbe allora disincarnata rispetto al Leib chefornisce il supporto della sua capacità comunicativa incarnata,espressiva (nel senso trascendentale husserliano); esso sarebbe sradi-cato dalla dimensione irreversibile della temporalità che abita, con-segnato ad una dimensione senza luogo e senza tempo, ipotizzabi-le in astratto, appunto, soltanto come orizzonte dell’esperienza diuna macchina ideale.
Per escludere definitivamente ogni legame tra il significato delgioco (cioè il suo risultato, l’informazione finale che esso produ-ce) e l’evento di tale significato (cioè l’occasione in cui accade lasua elaborazione) occorrerebbe isolare un significato privo dicarattere evenemenziale. Ma, solo per esser stato formulato, que-sto requisito produce una curiosa conseguenza: se all’imitationgame accadesse di significare, l’evento di tale accadimento smen-tirebbe il significato del gioco stesso, annientandolo; quindi, peresser veramente tale, il significato del test di Turing, il valore fina-le cui esso mette capo, non dovrebbe mai accadere e perciò, difatto, il gioco dell’imitazione non potrebbe esistere mai.
Alla luce di queste ultime considerazioni è possibile ricapitola-re il cammino fin qui seguito ispirandosi ad una suggestione spe-culativa il cui senso è conforme a quello dei più celebri paradossi224
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 224 (Nero/Process Black pellicola)
della logica matematica: considerato che tanto l’uomo quanto lamacchina, nella prospettiva turingiana ricostruita da Enzo Paci,non sono null’altro che operatori logico-meccanici che produconodeterminati output a partire da determinati input e sulla base dideterminate regole sintattiche di manipolazioni simbolica, allorala conversazione che si svolge tra i due giocatori per mezzo dellatelescrivente è paragonabile ad un sistema formale dell’aritmeticache produce meccanicamente i suoi teoremi (i messaggi che ven-gono scambiati dall’uomo e dalla macchina) a partire da un insie-me iniziale di assiomi (la base di dati incarnata dai giocatori). Se siaccetta questo, allora lo svolgimento del gioco dell’imitazione,come Paci aveva forse intuito, produce esiti paragonabili, per ana-logia, al celebre teorema di incompletezza di Goedel. Si osserviinfatti quanto segue. Il gioco dell’imitazione può dirsi riuscito solose è completo (cioè se viene giocato fino al suo ultimo passaggio,la verifica finale) e se, inoltre, è coerente (cioè se le regole vengo-no rispettate sempre). Il gioco dell’imitazione potrebbe essere dav-vero coerente, però, solo se il gioco non fosse completo (cioè sel’uomo non uscisse mai dal gioco, con la conseguenza che non sitratterebbe propriamente di un gioco, né l’uomo sarebbe veramen-te un uomo); una situazione di questo genere produrrebbe sempreun risultato indecidibile (non si potrebbe più verificare se l’inter-locutore è un uomo o una macchina). L’alternativa è che il gioco siacompleto, ma anche incoerente (perché l’uomo contravverrebbealle sue regole, fuoriuscendo da esso); ma in tal caso non si tratte-rebbe di un gioco ben giocato, e non si potrebbe dire che il test diTuring abbia mai avuto luogo. E inoltre, anche in questo caso, ci sipotrebbe trovare comunque di fronte a situazioni indecidibili (per-ché sarebbe raggiunta la totale indiscernibilità dei giocatori) e inquesto caso il gioco non perverrebbe mai davvero a un esito defi-nitivo (non sarebbe più formulabile alcuna domanda, né asserzio-ne, sull’uomo o sulla macchina).
Ecco l’evento impossibile di una fantasia che si scopre assurdaproprio nel momento in cui si riesce a farla diventare reale.
6. Computazione, determinismo, temporalità
Ma qual è la valenza autentica del test di Turing, allora, e qualeutilità resta di esso? “La macchina ideale di Turing è dunque unacongettura e suggerisce una linea di ricerca: potremmo quasi dire
225
Enzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 225 (Nero/Process Black pellicola)
che è un’idea kantiana. Un’idea del giuoco perfetto, così perfettoche non è più giuocato”. Si comprende adesso l’identità segretadella macchina di Turing, che coincide con la natura formalistica eideale del suo funzionamento algoritmico razionale e ricorsivo. Lamacchina di Turing nasce infatti come esplicitazione rigorosa eformale del concetto intuitivo di algoritmo, e la sua essenza non ènull’altro che la struttura sintattica e razionale che cerca di cattu-rare l’essenza concreta delle operazioni di calcolo umane cosiddet-te “effettive”. L’essenza della macchina è sempre al di là delle suerealizzazioni contingenti; e la macchina ideale si identifica con lafunzione astratta della macchina stessa, l’algoritmo. La genesidella macchina di Turing può solo essere intesa, quindi, come isti-tuzione di un ideale tipico, e ogni sua realizzazione/riproduzionediventa di conseguenza un tentativo di approssimazione all’essen-za della funzione pura. Ma anche la struttura di una macchinareale – proprio come un corpo umano che si ricopre di rughe e diacciacchi, invecchiando - è consegnata al decorso irreversibile deltempo che la impolvera, e ne fulmina i circuiti; e al ritmo del bat-tito dei suoi movimenti automatici, che determina i tempi di ese-cuzione delle sue operazioni. Anche il calcolo possiede una suatemporalità, e viene consumato dallo scorrere degli istanti: nessu-na macchina reale produrrà mai le sequenze infinite di 0 e di 1prodotte dalla macchina ideale e, con il volgere dei millenni, men-tre le stelle si spengono una ad una, perfino il congegno più resi-stente e affidabile dovrà esaurire le sue energie, e arrestare il pro-prio funzionamento (per questo, dal punto di vista dell’esperienzaconcreta, il teorema di Turing, la cui dimostrazione è basata sulproblema della fermata, sottintende una tesi errata, perché sappia-mo con esattezza infallibile che ogni macchina di Turing realedovrà arrestarsi prima o poi).
Ogni macchina reale deve tradire l’ideale della macchina diTuring, pur cercando di replicarne fedelmente la funzione, e purriuscendo ad approssimarvisi; e anzi proprio quando riesce a imi-tarla meglio ne tradisce l’ideale, realizzandolo - cioè sconfessando-lo mentre lo riduce a fatto di esperienza17. Ci si accorge ora che ilgioco dell’imitazione, cioè la formulazione della possibilità di un’e-quivalenza funzionale, non si rivolge mai propriamente ai due ter-mini rappresentati dall’uomo e dalla macchina, che a posteriorivorremmo isolare come oggetti sussistenti in quanto tali e mera-mente presenti; dobbiamo riconoscere piuttosto che il luogo speci-fico in cui essa avviene – replicandosi indefinitamente, nel tentati-226
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 226 (Nero/Process Black pellicola)
vo di raggiungere lo statuto di completa mimesi – è nella dialetticatra un originale-eidos (la macchina di Turing intesa come idealenormativo delle macchine universali e dell’uomo inteso come siste-ma cognitivo) e una copia-eidolon (la realizzazione storica di unamacchina computazionale alla mano, correlata ad una rete di usi nelcontesto dell’esperienza incarnata).
Questo assume un’enorme importanza, secondo Paci, per valu-tare il senso dell’immagine della macchina pensata come model-lo generale di spiegazione della natura e della sua prevedibilitàmatematica: “La realizzazione della macchina di Turing neghe-rebbe la macchina di Turing come idea e alla fine anche l’idealepossibile di una spiegazione meccanicistica totale nel senso diLaplace, una spiegazione che annullerebbe la predizione, nellatotalità della predizione nel senso, secondo le parole di Turing,‘che dallo stato completo dell’universo in un momento dato,descritto mediante la posizione e la velocità di ogni particella, siapossibile predire tutti gli stati futuri’. Potremmo esprimere l’opi-nione che, in una informazione o in una predizione così comple-ta, non avrebbe forse più senso il parlare dell’universo in unmomento dato e di stati futuri”.
Se fosse confermata l’ipotesi di una perfetta equivalenza traconosciuto e conoscibile, tra imitante (i modelli scientifici mecca-nicistici) e imitato (le leggi naturali del cosmo), allora i momentipassati e futuri, considerati come possibilità logica pura (nellaforma del concetto di “condizione oggettiva dell’universo nell’i-stante t”) non sarebbero più discernibili dallo stato attuale dell’u-niverso così come viene esperito in presa diretta da un uomoincarnato qui ed ora. La sua prospettiva conoscitiva non sarebbepiù uno sguardo aperto sul particolare, ma si estenderebbe inmodo atemporale su di una totale (e perciò irrelata) simultaneitàdi ogni possibile prospettiva della realtà; non si tratterebbe nean-che più, quindi, di una prospettiva di osservazione. La promessapositivista di una prevedibilità interamente deterministica annul-lerebbe l’osservatore come protagonista di tale conoscenza equindi, di fatto, annienterebbe la conoscenza stessa. Il tempo pre-sente non sarebbe più un punto luminoso che pulsa seguendo ilritmo degli adombramenti dei momenti passati e futuri, ma siaccenderebbe di un’unica luce accecante nella quale scomparireb-bero, bruciando, il ricordo e l’aspettazione, la capacità di ricostru-zione rimemorante o di previsione anticipante. Attuale e poten-ziale collasserebbero come un buco nero, schiacciati nella singola-
227
Enzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 227 (Nero/Process Black pellicola)
rità indistinta del determinismo laplaciano più rigoroso. “[...] Talicongetture identificherebbero la logica con l’esperienza, ma a suavolta tale identificazione si presenterebbe come un’esperienzaideale o un’esistenza ideale: in Kant la dialettica può essere inter-pretata come generata da una simile idea nella quale, al limite, lalogica più altamente formalizzata coincida con i suoi valori e ivalori con la logica.” (si consideri come, alla luce di queste consi-derazioni, le citazioni riportate in esergo acquistino un nuovosignificato).
7. L’uomo, la macchina e la soglia della scrittura
Concludiamo queste riflessioni ritornando alla relazione uomo-macchina studiata nella prospettiva del gioco dell’imitazione.L’ideale di una misurazione oggettiva dell’intelligenza di una mac-china, e il corrispondente miraggio di un congegno indiscernibiledal suo creatore, rappresentano una situazione impossibile cheperò, in quanto tale, può proporsi – per Paci - come guida regolati-va della ricerca umana e come suo orizzonte teleologico. Ma è irri-nunciabile che sia pienamente maturata la consapevolezza dell’eva-nescenza di ogni fondazione metafisica o positiva di questo proget-to, per scongiurare l’epilogo tecnicistico dell’evoluzione delle scien-ze informatiche e della loro crisi; crisi che era già cominciata neglianni in cui Paci e Turing scrivevano, essendo già stata innescata laperdita del fondamento esperienziale di quell’“operare concreto”che attiene al “soggetto umano intero”18, insieme all’oblio del radi-camento intenzionale di queste operazioni. Per tale motivo è dariscoprire la situazione esistenziale specifica, la provenienza conte-stuale-relazionale concreta e, infine, l’autentica destinazione inten-zionale e teleologica (comunitaria, politica) di ogni progetto di intel-ligenza artificiale. Intendeva probabilmente questo, Enzo Paci,quando nel 1964 scriveva su Aut Aut, in relazione alle vicende futu-ribili della cibernetica19: “[…] in questa società unificata l’uomo nonsarà ridotto a macchina soltanto se le macchine serviranno per eli-minare l’oggettivazione e quindi lo sfruttamento dell’uomo sull’uo-mo”. Proseguendo in questa direzione, ipotizziamo oggi che sipotrebbe forse integrare efficacemente l’ideale della “macchinaintelligente” nell’esperienza dell’uomo e nella logica della sua scien-za solo allargando fino ai suoi margini estremi la nozione di umano,in maniera tale che il senso del suo esserci includa anche l’essenza228
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 228 (Nero/Process Black pellicola)
della macchina come propria estensione corporea in senso post-umano, e – parallelamente – solo riconsiderando la macchina comeespressione storico-epocale dell’irrinunciabile propensione(auto)poietica che caratterizza la naturale artificialità dell’umano ela tensione ec-statica, erotica, che intenziona di volta in volta leforme del suo spirito. A quel punto la visione futuribile di un’iden-tità-interscambiabilità uomo/macchina non assumerebbe più ilsenso di un ideale positivo di perfettibilità formalistica e oggettivi-stica, ma potrebbe essere inteso come quel concreto momento dellavita intermonadica in cui avviene la attuale compenetrazione e lareciproca presupposizione dei due termini in gioco.
Si può provare, da ultimo, ad affrontare la domanda più emble-matica tra quelle che lo stesso Enzo Paci avrebbe potuto porci:quali operazioni concrete rendono possibile l’istituzione del giocodell’imitazione? E quale produzione di soggettività esse comporta-no? La possibilità dell’identità o equivalenza uomo-macchina nonè soltanto misurata dal gioco dall’imitazione, perché proprio nelmomento in cui essa è soppesata e scoperta per mezzo del giocoessa viene anche intenzionata e costituita, cioè resa accessibile efruibile come oggetto naturale autonomamente sussistente e per-tanto già da sempre antecedente lo sguardo scientifico che lo sco-pre e che lo mette in gioco. Eppure uomo e macchina non potreb-bero esser ritrovati come oggetti autonomi, e quindi obbiettiva-mente equiparabili, all’esterno (o prima dello svolgimento) di quelgioco che ne aveva descritto l’equiparabilità delle intelligenze pro-prio nel momento in cui inscriveva queste ultime in un’unica emedesima procedura sperimentale; è infatti solo stando inscritti nelgioco dell’imitazione che essi possono essere equiparati e identifi-cati come soggetti in relazione, reciprocamente imitantisi e pertantointelligenti. È proprio il battesimo della scrittura che consenteall’uomo e alla macchina di scambiarsi i ruoli – e i nomi - esploran-dosi reciprocamente nel medium della telescrivente, comunicandoanonimamente in quanto estranei, e scoprendosi perciò costitutiva-mente appartenenti alla nominabilità di una comunicazione lingui-stica grammaticamente e sintatticamente organizzata, terreno sulquale si rende effettiva la loro mimesi.
E, infatti, esaminando di nuovo lo svolgimento del gioco dell’i-mitazione, si può scorgere come esso possa aver luogo solo attra-verso il supporto della comunicazione scritta: cioè una comunica-zione anonima, spersonalizzata, convenzionalistica, formale, seria-le, infinitamente riproducibile e per sua stessa natura meccanizza-
229
Enzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 229 (Nero/Process Black pellicola)
bile e linearmente deterministica, perché operante attraversooggetti massimamente impalpabili e perfettamente iterabili, leinformazioni; oggetti che costituiscono la trasfigurazione più recen-te delle antiche lettere inventate dal popolo greco, e che da questeultime sono state dedotte, nell’esercizio millenario dell’astrazionelogica e dal consolidarsi di sofisticati abiti teorici evolutisi insiemealla civiltà della parola scritta. Si comprende che soltanto accettan-do di essere ridotti a messaggio scritto, a struttura formale, a pac-chetti di informazioni inviati in sequenza, l’uomo e la macchinaavrebbero raggiunto nella figure di un simbolismo insignificante lapropria consustanzialità, potendosi finalmente identificare inmoduli isolati all’interno di un processo di elaborazione di stringhelogico-simboliche20. La codifica operata dalla scrittura riduce ilpensiero dell’uomo all’attività della macchina, e l’attività dellamacchina ad una combinatoria di elementi atomici insignificanti econvenzionali; è appunto questa procedura, erede di un’antichissi-ma pratica cominciata in Grecia circa ventisette secoli fa, che pari-fica l’uomo alla macchina e che rende indifferenti alle loro differen-ze esistenziali, uniformandole nella superiore isonomia della logi-ca alfabetica. Alle soglie dell’epoca di Turing e delle prime macchi-ne computazionali, saranno proprio gli antichi abiti concettualialfanumerici, espressi nelle procedure di codifica formalistica del-l’aritmetizzazione di Goedel, a definire quella griglia di traducibi-lità sulla quale le figure dell’uomo e della macchina potranno sta-gliarsi come reciprocamente (del)imitantisi.
Note al testo
1. (Paci, 1973, pp. 522-540). Tutte le citazioni di Paci riportate nel presentearticolo provengono da queste poche pagine, salvo indicato diversamente.2. Turing (1950); molti dei temi di questo lavoro sono anticipati in Turing(1948). Per una loro discussione: Longo (2002b).3. Turing (1936)4. In realtà Turing non ritenne mai opportuno sostenere una tesi cosìimprudente, almeno non in sede pubblica o nei suoi scritti. È ragionevolesupporre, però, che la sua riflessione si muovesse all’interno di una corni-ce teorica meccanicistica e che, almeno in qualche misura, egli desse perscontato che l’attività cognitiva umana, al livello delle sue operazioni logi-co-simboliche fondamentali, funzionasse in maniera paragonabile (anchese non riducibile) a quella di un dispositivo computazionale.
230
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 230 (Nero/Process Black pellicola)
5. Ciò che per Turing rappresentava un’ipotesi solo in parte esplicitata enon necessariamente da assumersi come vera, è divenuta in seguito la tesifondamentale della psicologia cognitiva di marca computazionalista e diuna certa corrente funzionalista della filosofia della mente che a Turing eal suo lavoro, appunto, si richiamano (per una sintesi si veda Fodor, 2001). 6. Anche se, bisogna ammettere, in alcuni casi le macchine sono in gradodi stupirci per le loro apparenti capacità di sostenere una conversazione.Il test di Turing ha stimolato iniziative davvero folklorisitche: ogni announ importante premio viene consegnato al programmatore che è statocapace di elaborare il programma più versato nell’arte della “conversazio-ne” e maggiormente abile nel trarre in inganno un interlocutore umano.Navigando su Internet è possibile incontrare alcune di queste pseudo-intelligenze artificiali e dialogare con loro: http://cogsci.ucsd.edu/~asaygin/tt/ttest.html#onlineref. Oltre che diverti-re, questi prototipi consentono di misurare lo stato dell’arte nello svilup-po delle capacità linguistiche dei software più recenti (capacità inveromolto in ritardo rispetto alle ottimistiche previsioni di Turing).7. Per una guida schematica a questi concetti si faccia riferimento a Fodor(2001).8. Il problema di una caratterizzazione esistenziale della macchina intelli-gente rimane però aperto e, almeno nella sua fisionomia più astratta, con-tinua a manifestare una forte complessità: se è vero che ciò che caratteriz-za l’esistenza umana è la capacità di istituire la morte nel nome, e se èvero, come si deve qui ipotizzare, che le macchine potranno un giorno svi-luppare capacità linguistiche analoghe a quelle umane, allora quale carat-teristica dell’ontologia del macchinico consentirà di distinguere la vitadella macchina da quella umana?9. Il teorema è contenuto in Goedel (1931). Per un’introduzione sintetica eaccessibile si veda Odifreddi (2000). Alcune considerazioni di Paci suGoedel - considerazioni panoramiche e certamente propositive in sensospeculativo - si trovano in Paci (1964b), dove il risultato di incompletezzaviene messo in relazione con la condizione esistentiva peculiare dell’esse-re umano relativa alle specifiche posture conoscitive attuate dallo sguardoscientifico occidentale: “il significato più profondo della prova di Goedel èinfatti proprio la riscoperta del soggetto, del soggetto-uomo, dell’uomomatematico, dell’uomo che compie le operazioni matematiche” (p. 31). Leconsiderazioni del filosofo di Monterado si appoggiano al lavoro di Nagele Newman (1961), e ne forniscono un’interpretazione originale. 10. Paci (1973, p. 11).11. Un approfondimento degli aspetti ermeneutici ed esistenziali dellapragmatica dei processi informazionali computerizzati è sviluppato neifondamentali lavori di Winograd e Flores (1987, pp. 27-37, 70-83) e di
231
Enzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 231 (Nero/Process Black pellicola)
Andy Clark (1997, pp.143-150), che per certi aspetti il contributo di Pacisembra anticipare in maniera stupefacente.12. Per “condizione iniziale” si intende qui l’insieme di operazioni logico-simboliche previste dalla “tavola comportamentale” di una macchina diTuring (si veda Turing, 1936).13. È lo stesso Paci (1973) a suggerire che la proposta di Turing sia soloapparentemente alternativa rispetto a quella di Cartesio: “[...] si potrebbeconcludere che è in qualche modo superato il dualismo cartesiano tracogito e macchina, così come Turing, nel ‘giuoco dell’imitazione’, pensa dieliminare l’equivocità del termine ‘pensare’. Ma è importante notare cheanche la macchina di Turing si trova di fronte allo spazio e al tempo”, equindi, si potrebbe aggiungere, alla dinamica irreversibile dell’esperienzae al suo carattere incarnato e corporeo; un aspetto, questo, che essendosottovalutato tanto dalla prospettiva cartesiana quanto da quella turingia-na, le accomuna, e suggerisce l’esistenza di una profonda radice metafisi-ca dalla quale fioriscono le loro rispettive aporie. 14. “Che cosa vedo”, si chiede Cartesio (1998, p. 177), “se non dei cappel-li e degli abiti, sotto i quali potrebbero essere nascosti degli automi?”L’attribuzione di una soggettività cosciente al corpo dell’altro si inserisceper Cartesio in una riflessione generale sull’interazione delle facoltà delsenso e dell’intelletto, e sulla loro reciproca capacità di completarsi perrealizzare un progressivo riempimento materiale-esperienziale delleforme della conoscenza concettuale (si tratta delle stesse pagine in cui ilfilosofo francese si interroga sull’ipotetica conoscibilità a priori di unmateriale semplice e privo di forma come la cera). 15. Paci aveva già toccato la questione della confusione tra uomo e mac-china in Aut Aut (Paci, 1964, p. 135), dove esprime la sua tesi attraverso leautorevoli parole di Norbert Wiener, padre della cibernetica: “Allorché lepersone umane sono organizzate in un sistema che le impiega non secon-do le loro piene facoltà di esseri umani e responsabili, ma come altrettan-ti ingranaggi, leve e connessioni, non ha molta importanza il fatto che laloro materia sia costituita da carne e sangue” (Wiener, 1952, p. 33).16. Giuseppe Longo (2002a, 2002b), commentando l’articolo del 1950, haosservato che Turing era perfettamente al corrente di questo ordine diproblemi, e che proprio per tale motivo egli stesso aveva escluso la possi-bilità di una totale identificazione strutturale della mente umana con unamacchina a stati discreti laplaciana. L’utilizzo del test di Turing assume inquesta prospettiva la valenza di un’approssimazione descrittiva euristicanon priva di una certa utilità: nel test di Turing si manifestano i sintomicorrelati ai processi di costituzione di quella “oggettività costruita” che lamatematica e le scienze informatiche tendono costantemente a presup-porre come naturalmente e perfettamente acquisita.
232
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 232 (Nero/Process Black pellicola)
17. Le dinamiche caotiche studiate dalla fisica matematica (sensibilità allecondizioni al contorno e fluttuazioni al di sotto del livello di osservabili-tà) esibiscono l’inadeguatezza di una cornice rigidamente deterministicain senso laplaciano se applicata al mondo naturale, e permettono per con-verso di intravedere la specificità dei processi computazionali di una mac-china a stati discreti: solo una macchina di Turing ideale, in quanto pen-siero formale astratto sottratto alla concretezza dello spazio-tempo, puòrealizzare un determinismo laplaciano rigoroso; e per converso solo l’ipo-tesi intellettuale di un determinismo laplaciano rigoroso avrebbe potutofondare l’idea astratta e pura di un meccanismo ideale come quello inven-tato da Turing. Giuseppe Longo (2002a), esplicitando questi punti, ha dinuovo sottolineato come lo stesso Turing non fosse affatto sprovvedutorispetto a quest’ordine di problemi (si considerino il tema dell’exponentialdrift e il problema del continuo nella modellistica morfogenetica).18. Paci (1964, p. 30).19. Ibidem.20. Per un approfondimento si rimanda a Cappuccio (2004).
Nota bibliografica
Biuso Alberto Giovanni, (2004), Cyborgsofia, Il pozzo di Giacobbe, Trapani. Bolter David J., (1986), Turing’s Man, Penguin Books, Aylesbury.-, (1993), Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesti e storia della scrittura,Vita e Pensiero.Cappuccio Massimiliano, (2003), “L’enigma delle bolle elamite e la genesiremota della scrittura numerica”, in Chora n° 7, Settembre, pp. 67-76.-, (2004), “Traces of a computational mind. From wax tablet to Turingmachine”, in Revue de Synthese, Tomo 124, Marzo.Cartesio Renato, (1998, cura e traduzione di Luciana Urbani Ulivi),Meditazioni metafisiche, Rusconi, Milano.Clark Andy, (1997), Being There: Putting Brain, Body And World TogetherAgain, MIT Press, Cambridge.D’Alessandro Paolo, (2002), Critica della ragione telematica. Il pensiero in retee le reti del pensiero, LED, Milano.Fodor Jerry A., (1983), The modularity of Mind, MIT Press, Cambridge.-, (2001), La mente non funziona così, Laterza, Roma-Bari. Goedel Kurt, (1931), “Über formal unentscheidbare Sätze der PrincipiaMathematica und verwandter Systeme I”, in Monatshefte für Math. und Phys.Hamkins David Joel, (2002), “Infinite time Turing Machines”, in Mindsand Machines, 12, pp. 521-539.Husserl Edmund, (1961), La crisi delle scienze europee e la fenomenologia tra-
233
Enzo Paci, Alan Turing e l’impossibile gioco dell’imitazione
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 233 (Nero/Process Black pellicola)
scendentale, Il Saggiatore, Milano.Ince Darrel, (1992, a cura di), Collected works of A.M. Turing Vol. I -Mechanical Intelligence, North-Holland, Amsterdam-London.Longo Giuseppe, (2002 a), “Laplace, Turing and the ‘imitation game’impossible geometry: randomness, determinism and programs inTuring’s test”, in Intellectica, n. 35, Giugno, pp. 131-162.-, (2002 b), “Lo spazio, i fondamenti della matematica e la resistibile asce-sa della metafora: il cervello è un calcolatore digitale”, in M. BrescianiCalifano, Leo S. Olschki (a cura di) L’uomo e le macchine, Firenze.Minsky Marvin L., (1967), Computation: Finite and Infinite Machines,Prentice-Hall.Nagel Ernest e Newman James R., (1961), La prova di Goedel, BollatiBoringhieri, Torino. Odifreddi Piergiorgio, (2000), La matematica del Novecento. Dagli insiemi allacomplessità, Einaudi.Paci Enzo, (1954), Tempo e relazione, Taylor, Torino.-, (1963), Funzione delle scienze e significato dell’uomo, Il Saggiatore, Milano.-, (1964), “Logica formale e linguaggio ordinario”, in Aut Aut 73, Maggio,pp. 93-96.-, (1965), “Entropia e informazione”, in Aut Aut 79-80, Gennaio-Marzo,pp. 135-137.-, (1965), “Fenomenologia e cibernetica”, in Aut Aut 83, Settembre, pp. 25-32.-, (1973), Idee per un’enciclopedia fenomenologica, Valentino Bompiani,Milano.Sini Carlo, (1965), Introduzione alla fenomenologia come scienza, LampugnaniNigri, Milano-, (1991), Il simbolo e l’uomo, Egea, Milano.-, (1994), Filosofia e scrittura, Laterza, Roma-Bari.Turing Alan Mathison, (1936), “On Computable Numbers, with an appli-cation to the Entscheidungs-problem”, testo originario in Proceedings ofLondon Mathematical Society (2), 42, pp. 230-265 (1936-7); ristampato inMartin Davis, (a cura di), The Undecidable, Raven, New York.-, (1948), “Intelligent machinery”, ristampato in Ince (1992).-, (1950), “Computing Machinery and Intelligence”, in Mind 49, ristampa-to in Ince (1992).Varela Francisco, (1998), La via di mezzo della conoscenza, Feltrinelli.Wiener Norbert, (1952), Introduzione alla cibernetica, Einaudi, Torino.Winograd T. & Flores F., (1987), Understanding computer and cognition. Anew foundation for design, Addison-Wesley.
234
Massimiliano Cappuccio
PACI£.qxp 17/11/2005 9.19 Pagina 234 (Nero/Process Black pellicola)















































































































































































































































![Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6320d02c00d668140c0d32b3/asculum-cultura-architettonica-e-figurativa-di-eta-romana-in-g-paci-a-cura.jpg)