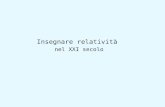L’universo concentrazionario e gli audiovisivi prodotti nelle scuole: una straordinaria occasione...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of L’universo concentrazionario e gli audiovisivi prodotti nelle scuole: una straordinaria occasione...
Insegnare AuschwitzQuestioni etiche, storiografiche, educative della deportazione
e dello sterminio
A cura di Enzo Traverso
Bollati Boringhieri
Prima edizione aprile 1995
© 1995 Bollati Boringhieri editore s.r.l., Torino, corso Vittorio Emanuele 86 I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservatiStampato in Italia dalla Stampatre di Torino ISBN 88- 339- 0916-6
La traduzione dei saggi di Yannis Thanassekos c di Jean-Michel Chaumont è di Claudio Rosso
In copertina, Enrico Baj, Incontro tra veterani di fanteria (part.)
L’universo concentrazionario e gli audiovisivi prodotti nelle scuole: una straordinaria occasione didattica con qualche precauzioneChiara Ottaviano
L ’occasione e il disagio
La richiesta degli amici dell’Istituto storico della Resistenza di Torino era stata quella di esaminare alcuni video realizzati nelle scuole, e presentati in vari concorsi regionali sul tema della Shoah e della deportazione, in vista del convegno di Torino dell’aprile ’93: ben volentieri avevo accettato l’invito. Quando però è arrivato il momento di comunicare le mie riflessioni in merito, ho scoperto che il compito non era dei più agevoli. La platea era infatti gremita di studenti, gli stessi che in molti casi avevano prodotto quegli audiovisivi, che attendevano, per la fatica fatta, per l’impegno civile dimostrato, per l’originalità del mezzo con cui si erano misurati, una meritata gratificazione pubblica. E io invece, tranne che per uno o due casi isolati, quella gratificazione non ero assolutamente in grado di darla. Anzi, l’esame di quei prodotti in alcuni casi mi aveva suscitato vera irritazione, per la totale inconsapevolezza del mezzo usato e per gli effetti comunicativi prodotti.
Gli studenti, com’era giusto, non mi hanno fatto grandi sorrisi. Piuttosto si sono avvicinati con aria compiaciuta alcuni insegnanti dichiarandosi soddisfatti per le mie «bacchettate» e chiarendomi che loro, del resto, non erano mai stati d’accordo con l’uso del televisore a scuola, da cui, come dimostrato, nulla di buono poteva discendere. Se l’opinione generale dell’auditorio è stata quella di questi insegnanti, ma io mi auguro proprio di no, allora, ahinoi, vuol dire che anche la mia comunicazione è risultata del tutto fallimentare.
Di una cosa infatti sono convinta - e so in questo di non essere granché originale - e cioè della centralità della comunicazione audiovisiva oggi: è dai telegiornali più che dai quotidiani che la maggior parte della
L ’universo concentrazionario c gli audiovisivi prodotti nelle scuole 179
popolazione riceve informazioni, è il varietà televisivo e non il varietà del palcoscenico teatrale a divertire le platee, è attraverso la televisione, in vario modo, e attraverso l’invenzione cinematografica, più che dai libri di testo o dalla saggistica, che alcune idee e alcune certezze sulla storia di ieri e di oggi diventano patrimonio comune; è attraverso il mezzo televisivo e quello cinematografico, più che attraverso la trasmissione da persona a persona, che si forma la tradizione culturale di una comunità o, se si vuole, si dà alimento alla cosiddetta memoria collettiva. Quella comunicazione appare più facile, perché non sembra porre ostacoli alla comprensione, più universale, perché non esclude nessuno ed è accessibile a tutti, e contemporaneamente più ricca, coinvolgendo buona parte dei nostri sensi.
Ciò che è emerso con evidenza dagli audiovisivi presentati in concorso dai ragazzi è la voglia, anzi, l’urgenza di misurarsi con quel mezzo non solo come recettori ma anche come produttori. Questo desiderio di confrontarsi è più che legittimo, anche se può coniugarsi con un fraintendimento di fondo: di quella comunicazione, che appare come la più «naturale», non si intuisce la complessità.
E gli insegnanti? Tranne nei casi degli insegnanti appassionati (che a volte avevano finito per sostituirsi ai ragazzi stessi), la maggior parte sembra alla fine aver deciso di astenersi da quel confronto, di deresponsabilizzarsi rispetto al «mezzo tecnico», di abbandonare gli studenti al loro destino di autodidatti.
I risultati sono quelli che sono: la visione eli alcuni video, non a caso quelli più ambiziosi nella forma, può suscitare forti sensazioni di disagio. La causa di tale disagio non va però individuata nell’imperizia nell’uso degli strumenti tecnici, da cui quindi un audio poco regolato, un montaggio imperfetto, una messa a fuoco incerta, ma proprio nel fatto che quelle «forme» influiscono inevitabilmente sulla comunicazione di «quel tema». Quel tema, la Shoah e l’esperienza della deportazione, non consente indulgenza. In parole povere, faceva male vedere l’uso improprio, nonostante le supposte migliori intenzioni, di parole e di immagini di dolore e orrore. Fornirò più avanti alcuni esempi, nella convinzione che la messa a fuoco di errori e incongruenze non risulti operazione inutile o puramente distruttiva.
Non è comunque difficile comprendere il motivo per cui proprio su un argomento così delicato e difficile ci si sia lanciati nella sperimentazione e sia stata così forte la tentazione di usare mezzi «extrascolastici». Di Shoah e deportazione, come sappiamo, poco si parla nei libri di scuola: di per sé, dunque, il tema è argomento extra, fuori dal comune. Esso inoltre, nell’esperienza di quei ragazzi che hanno tentato l’avventura del video,
Chiara Ottaviano1 8 0
è legato a forme inusuali di apprendimento, che ci auguriamo siano sempre più diffuse, e cioè i colloqui con i testimoni, la lettura di pagine di diaristica e letteratura, la visione di documentari televisivi e film cinematografici, la visita nei luoghi dei campi di deportazione e sterminio. Oltre che difficile, può forse dunque apparire tremendamente riduttivo tradurre tutto in parole scritte; il mezzo audiovisivo può quindi sembrare oggettivamente quello più adeguato. Infine, appartiene all’esperienza dei più giovani - oltre che di coloro che non sono ormai proprio giovanissimi - l’acquisizione di nozioni di storia contemporanea (e forse anche di informazioni fondamentali rispetto alle proprie scelte di campo), più che attraverso la parola scritta contenuta nei libri, attraverso la visione di un qualche programma o film andato in onda.
Da tutto ciò mi sembra di poter trarre spunto per riflessioni più generali: l’assunzione della rilevanza e della straordinarietà del tema ha fatto sì che una certa parte di studenti sia stata disponibile a mettere in campo energie, tempo, voglia di sperimentare e lavorare in quantità non comune. Spetta agli insegnanti essere all’altezza di quello che è un severo banco di prova, dimostrando la capacità di essere rigorosi nei contenuti, come nell’analisi degli strumenti utilizzati nel momento dell’apprendimento, oltre che preparati nell’uso e nella conoscenza dei mezzi adottati per la trasmissione.
Non si tratta per gli insegnanti di italiano e storia di frequentare corsi semiprofessionali per acquisire familiarità con centraline di montaggio e mixer audio (su questo terreno è più proficuo trovare le collaborazioni adatte); il problema è non abdicare al proprio ruolo rispetto all’elaborazione dei contenuti e rispetto alla progettazione della comunicazione.
Infine, a prescindere dal fatto che si intenda o meno sperimentare la comunicazione audiovisiva dal punto di vista della produzione, preliminare è studiare e insegnare ad analizzare i modi e le forme di quella comunicazione, per la centralità che ha assunto tra i mass media nella nostra società e per la naturale attrazione che esercita sulle nuove generazioni. Per raggiungere questo obiettivo sarà probabilmente indispensabile sperimentare forme di autoaggiornamento oltre che di lavoro comune in classe, non temere troppo di sbagliare, individuare, se necessario, figure professionali o altri colleghi con cui interloquire. L’obiettivo è acquisire quelle competenze che, a questo punto, nel mondo della scuola dovrebbero considerarsi non opzionali ma obbligatorie.
Nelle pagine che seguono, oltre ad alcune considerazioni a partire dai video esaminati, fornirò qualche suggerimento su possibili esercitazioni in classe rispetto all’analisi della comunicazione audiovisiva e qualche indicazione di merito rispetto al tema della Shoah e della deportazione per ipotetiche produzioni audiovisive scolastiche.
L ’universo concentrazionario e gli audiovisivi prodotti nelle scuole 181
Alcuni esempi, alcuni errori
Non è ovviamente mia intenzione passare in rassegna, uno per uno, tutti i video esaminati. Ne descriverò solo alcuni, che possono essere assunti come rappresentativi di altri, anche a partire dall’ispirazione a un genere, o comunque a un modello di comunicazione televisiva, il più delle volte facilmente riconoscibile.
L’audiovisivo prodotto nel 1990 da un liceo classico sperimentale della provincia di Torino è particolarmente articolato e dunque ricco di possibilità di esemplificazione. Possiamo individuarne quattro differenti parti non particolarmente collegate Luna all’altra.
Prima parte: modello videoclip musicale. Le immagini sono costituite dalle riprese filmate effettuate nel corso della visita a un campo di concentramento. All’inizio, in sottofondo si sente una voce che spiega. Poi la voce scompare e l’audio è totalmente occupato dalla colonna sonora (musica contemporanea, familiare alle generazioni più giovani). L’occhio di chi riprende le immagini punta sui particolari del campo certificando al tempo stesso la presenza della comitiva in quei luoghi.
La godibilità nel complesso è scarsa, regge però l’intenzione di una comunicazione basata sulle sensazioni ispirate da un luogo che si intende carico di significati.
Seconda parte: modello telegiornale. E la ripresa filmata di un convegno. E inquadrato, non proprio dalla postazione ideale, l’oratore di turno. Non esiste alcuna forma di montaggio e la videocamera è usata un po’ come un registratore. Da normale spettatrice non avrei dubbi, se potessi scegliere, nel preferire di gran lunga la disponibilità del testo scritto degli interventi a questo tipo di documentazione visiva che non aggiunge alcuna informazione significativa (a parte la confusione intorno all’oratore) e che in più è aggravata da vari disturbi di tipo tecnico (problemi di audio e immagini traballanti) che scoraggerebbero anche i più dotati di buona volontà.
Terza parte: l’intervista. Anche questa forma di ripresa sembra ispirata dal telegiornale. Tutti insieme i ragazzi si accalcano intorno al testimone incontrato nel corridoio per porgli un certo numero di domande. Alcune delle domande sono come obbligate, nel senso che sono le stesse, quasi di rito, che pongono altri ragazzi in altri video. Il testimone racconta con garbo, senza enfasi, le pratiche dell’orrore. Ci sono anche momenti di commozione.
Quarta parte: la lettura della relazione finale. Non credo ci sia alcun modello a cui i ragazzi si siano ispirati. Molto meglio sarebbe stato ancora
t 82 Chiara Ottaviano
una volta avere a (disposizione la relazione scritta, piuttosto che subire i tempi (lunghi) di una lettura poco accattivante. Il mezzo dunque è stato usato in modo del tutto improprio. In più è da notare raggiunta di un elemento: la musica, assolutamente non pertinente e decisamente disturbante. In questo caso, e in alcuni altri, la musica sembra essere utilizzata come a volte la panna in cucina, nella speranza di aggiustare il tutto. Il risultato, invece, può essere disastroso.
Questa descrizione non ha ovviamente lo scopo di fornire elementi per una valutazione complessiva del prodotto, che poco importa in questa sede, quanto di mettere in luce le occasioni in cui il mezzo, sia pur con difetti, è stato usato in modo pertinente o meno. L’intervista, e questo vale in genere, è sicuramente una delle occasioni in cui le potenzialità del mezzo audiovisivo si esaltano. Non c’è abilità di scrittore che riesca a trasmettere oltre alle parole anche gli sguardi, i sorrisi, i movimenti, le pause, le incertezze che pure sono essenziali per capire chi ci sta di fronte e il suo racconto.
Ma andiamo a un altro esempio, decisamente più infelice, presentato da una quarta classe di un liceo scientifico di Torino nell’anno 1989/90.
Il modello a cui sembrano ispirarsi gli studenti è il documentario di tipo più tradizionale: voce fuori campo, supporto di immagini d ’archivio, contributo di colonna sonora. Nei fatti, però, ci troviamo di fronte a un incredibile miscuglio fra tre elementi totalmente autonomi.
Prima di tutto c’è un testo, diciamo una relazione o un compito scolastico, svolto diligentemente, pieno di date, di dati, citazioni, argomenti. È un testo che vuole essere onnicomprensivo: la storia della Germania, la storia del nazismo, la storia dell’antisemitismo, la storia dei Lager ecc.
Le immagini sono varie: sequenze tratte dal notissimo II trionfo della volontà del 1933 e da II grande dittatore di Chaplin, brani di un documentario trasmesso dalla rubrica RAI Mixer sugli orrori dei campi di sterminio (quelle immagini, per inciso, ricompaiono quasi dappertutto), scene di film sulla seconda guerra mondiale e anche spezzoni di telegiornali sulla guerra in Bosnia.
La colonna sonora è costituita da brani di musica classica particolarmente noti, tra l’altro, per essere stati, in alcuni casi, anche usati in pubblicità.
Il tentativo di amalgamare i tre elementi (testo, musica e immagini) si limita solamente ai minuti iniziali, poi ogni filo si smarrisce e gli spettatori sono abbandonati a un forte senso di disagio ascoltando la lettura (monotona e quindi difficile) della relazione scritta mentre intanto scorrono le immagini estreme del documentario di Mixer - quelle delle mon-
L ’universo concen frazionario e gli audiovisivi prodotti nelle scuole 183
tagne di cadaveri per intenderci - commentate dalle note più trionfali della Carmen di Bizet. Un ulteriore esempio: mentre dal cielo, accompagnati da musica rasserenante, scendono i paracadute durante lo sbarco degli alleati, la voce legge inquietanti documenti su spedizioni di trasporti da un Lager a un altro e su sperimentazioni su donne.
Le immagini, che sono anche documenti storici, non sono dunque minimamente rispettate. L’attenzione di chi ha confezionato quel video era concentrata esclusivamente sulla coerenza interna del testo scritto, senza rendersi conto che, accompagnato così malamente dalle immagini sbagliate, anche quel testo veniva stravolto. Ovviamente non c’è solo questo. Se è vero che una pedagogia che vuole fondarsi sulla memoria dei Lager non può fare dell’orrore il perno di ogni discorso, la totale assenza di quel sentimento però (le trionfali e allegre note della Carmen mentre vediamo le montagne dei morti) per lo meno inquieta. Cosa sarà successo? E noto che l’esposizione ripetuta anche alle immagini più incredibili e toccanti può finire per annullare ogni effetto sull’emotività, sicuramente presente in una prima visione. Proprio per questo si deve essere molto vigili nel trattare l’immagine. Ma questo, come altro, sembra che ai ragazzi nessuno l’abbia mai spiegato.
La registrazione e le sue potenzialità
Fra gli audiovisivi in cui maggiore appare lo sforzo di elaborazione originale (sia nei contenuti che nel montaggio) l’esempio migliore a mio giudizio è quello offerto dal video della scuola media di Orbassano intitolato Visita a Carpi e a Fossoli. Non è un caso che si tratti di una scuola media inferiore, dove da più anni gli insegnanti si misurano con la sperimentazione didattica, in generale, e nei casi più fortunati anche con la didattica degli audiovisivi.
Altri audiovisivi erano invece pura registrazione in video di incontri o conferenze; anche in questo caso, tuttavia, con risultati diversi. Diciamolo subito: la registrazione della conferenza di uno studioso, a prescindere dal valore, che qui non si discute, non suscita di per sé nessuna particolare curiosità. Come si è già rilevato, non si capisce quale accrescimento di informazione possa costituire la visione della registrazione rispetto a una più pratica lettura del testo scritto.
Altra cosa è la registrazione di un incontro quando non si tratti di una pura conferenza. È il caso, per esempio, delle riprese di un incontro con testimoni ex deportati presentate da un liceo di Moncalieri. Le domande
1 8 4 Chiara Ottaviano
poste dai ragazzi erano tu tt’altro che banali e interessante risultava la dinamica dell’intervista sia nella relazione fra Ì due testimoni sia nella relazione fra i testimoni e i loro più giovani interlocutori.
Una registrazione di questo genere, che non contiene alcun tentativo di elaborazione, può avere il valore di promemoria, o potrebbe essere usata come fonte (se le riprese e l’audio fossero di migliore qualità) per successive elaborazioni in video o in audio. Mi auguro, dunque, che registrazioni come queste si riproducano e si conservino. Se è vero che la memoria della deportazione è così centrale nello studio del fenomeno e se è vero che quella memoria, per come si è conservata e per come si è sollecitata, può essere oggetto di studio, allora vale la pena conservarla attraverso gli strumenti che sono più idonei, cioè quelli che oltre alle parole e al timbro della voce consentano di registrare i gesti e le espressioni del volto.
Tra l’altro, tutti i testimoni piemontesi disponibili agli incontri con gli studenti hanno già partecipato alla grande raccolta di testimonianze promossa d a l l ’ANED e dalla Regione Piemonte. A volte, come nel caso del video di Moncalieri, di quella esperienza c’è traccia esplicita. Si riconosce che l’aver avuto di fronte qualcuno disposto ad ascoltarli per ore e ore era stata un’esperienza centrale per decidersi a parlare e a ricordare. Ma quando quegli stessi testimoni si raccontano, sollecitati da una scolaresca, magari in compagnia di altri ex deportati, cosa cambia nel loro racconto? Quali parti della narrazione, già codificate in scrittura per precedenti interviste, vengono ripetute identiche o con minime variazioni? Cosa emerge di nuovo grazie alle domande intelligenti o ingenue, insolite o scontate poste non da un ricercatore e in un ambito protetto o domestico ma da una scolaresca, in un’aula, magari stando seduti dietro una cattedra?
Questo materiale potrebbe essere dunque usato anche oltre l’ambito scolastico, o meglio, potrebbe essere l’occasione per coinvolgere la scuola e quegli insegnanti, che tanta intelligenza ed energia pongono in questi difficili percorsi didattici, in un circuito di riflessione e di studio più allargato.
La manipolazione e le differenze
Ritorniamo agli esempi più ambiziosi. Sono certa che anche nel caso dei risultati più deludenti l’esperienza del produrre un audiovisivo, se non altro, abbia inevitabilmente portato a una maggiore consapevolezza del fatto che quella comunicazione è tutto fuorché «naturale» e «facile». Sia pure in modo imperfetto, quasi sempre sono infatti stati tentati montaggi e manipolazioni. La manipolazione è implicita nel mezzo; il problema è
L ’universo concentrazionario e gli audiovisivi prodotti nelle scuole 185
esserne coscienti e saper fare un corretto uso degli strumenti così da non tradire i contenuti e non fare fallire la comunicazione.
Il percorso per realizzare un buon audiovisivo non è semplice e non è neanche obbligatorio che si raggiunga in tutti i casi l’obiettivo. Irrinunciabile, invece, dovrebbe essere il tentativo di acquisire quelle abilità che consentano di analizzare una comunicazione audiovisiva, anche allo scopo di saper valutare e distinguere aU’interno di un’offerta spesso caotica e non immediatamente riconoscibile nella qualità.
Certo non è questa la sede per un discorso esaustivo sulla didattica dell’uso degli audiovisivi in classe; ugualmente, proprio a partire da alcuni dei limiti più evidenti riscontrati nei video dei ragazzi, non mi sembra inutile suggerire alcune forme di esercitazioni possibili per incominciare ad accostarsi in modo più corretto a questa forma di comunicazione.
Gli studenti nei loro tentativi hanno il più delle volte seguito, consapevolmente o meno, alcuni generi di programmi assunti come modello. Il genere che è apparso più ovvio, ma come si è visto non per questo più facile da seguire, è il documentario classico, caratterizzato dalla presenza di una voce fuori campo e da contributi video di varia provenienza.
Immaginiamo dunque, prima di tutto, forme di esercitazioni che aiutino a meglio individuare gli elementi in gioco in prodotti di questo tipo. Ovviamente il videoregistratore è strumento essenziale senza il quale non è possibile procedere. La visione del materiale deve prevedere infatti la necessità di fermarsi, di ritornare indietro, di rivedere un’immagine al rallentatore, di ritrovare un punto lontano.
Molti e diversi sono i documentari di tipo classico che trattano il tema della deportazione, della Shoah, del nazionalsocialismo ecc. Consiglierei, tuttavia, di non partire da quegli esempi; suggerirei piuttosto di scegliere documenti più vari, più brevi, meno legati a contenuti specifici. I telegiornali offrono una quantità notevole di materiale adatto allo scopo: brevissimi filmati che possono essere esaminati e confrontati se si ha l’opportunità di registrare nello stesso giorno, e sullo stesso tema, servizi provenienti da varie testate.
Il primo rapporto da mettere a fuoco è quello che esiste fra audio, cioè le parole pronunciate da un giornalista o da un anonimo speaker, e le immagini corrispondenti. Ogni servizio dovrebbe essere analizzato non solo complessivamente, ma più utilmente sezionato in segmenti successivi. Le domande dovrebbero tendere a mettere in evidenza se le immagini sono pertinenti o meno rispetto al testo, se sono generiche o precise, se aggiungono informazioni al testo audio completandolo ecc. Dal confronto di vari servizi dovrebbero risultare evidenti le differenze di qualità fra chi usa
Chiara Ottaviano186
le immagini in modo puramente illustrativo, o forse anche deviante, e chi arricchisce la propria comunicazione in modo appropriato, con pari attenzione per l’informazione audio e quella per immagini.
Un altro tipo di esercitazione dovrebbe mettere in evidenza la differenza dei vari contributi video a partire dalla provenienza (si tratta di immagini d ’archivio, di repertorio generico o girate per l’occasione?) e dal tempo a cui risalgono (le immagini che riguardano specificatamente il tema del servizio sono state riprese lo stesso giorno, il giorno prima o in mesi e anni precedenti?). Ancora una volta lo scopo è far riflettere sulla varietà degli ingredienti e sulla diversa qualità dell’informazione; per esempio un filmato è più ricco di informazione se si può contare su risorse d’archivio e su riprese effettuate per la circostanza. Altra cosa ancora è la qualità dell’informazione nel suo complesso, che è la risultante fra il testo scritto e il montaggio delle immagini. Un cattivo o povero montaggio di immagini diminuisce, e a volte annulla, anche la qualità di un eccellente testo scritto.
I modelli e le risorse
La visione e l’analisi di uno dei tanti documentari (di varia qualità) dedicati al tema della Shoah e della deportazione potrebbero avvenire nella fase introduttiva o anche in vista delle conclusioni del percorso di ricerca e di lavoro svolto in classe. Nella fase introduttiva possono aiutare a suscitare interesse (siamo tutti perfettamente consapevoli che la spinta emotiva non è estranea a motivare l’impegno); in fase conclusiva possono aver funzione di verifica delle nozioni acquisite e delle capacità di esercitare senso critico sia rispetto ai contenuti che alla forma dell’esposizione.
Rispetto ai contenuti l’esercizio non è secondario. Non è facile, infatti, trovare un documentario sul tema che sia aggiornato rispetto all’avanzamento della ricerca storiografica, che non contenga errori, che non presenti punti di vista in parte discutibili. Non a caso Marcello Pezzetti, del Centro di documentazione ebraica di Milano, ha indicato nell’opera dell’israeliano Haim Gouri, in versione originaria e di difficile reperimento, l’unico contributo documentario seriamente aggiornato rispetto alla ricerca, corretto nell’esposizione, arricchente nei contenuti. In tutte le altre opere, sempre secondo la seria analisi di Pezzetti, emergono, in varia misura, difetti e manchevolezze.1 Ciò nonostante, discutere intorno a quel che meno
1 Cfr. Marcello Pezzetti, Le immagini della Shoà. Documentari storici per le scuole, in «Sisifo. Idee, ricerche, programmi dell’Istituto Gramsci Piemontese», ottobre 1993.
L'universo concentrazionario e gli audiovisivi prodotti nelle scuole 187
convince, distinguere all’interno di uno stesso prodotto una parte da un’altra, confrontare fra loro prodotti diversi è un’operazione altamente istruttiva: abitua a trattare l’audiovisivo come un testo al pari di altri, eliminando quell’aura di autorevolezza, non fondata, a cui spesso gli insegnanti soggiacciono quando non rifuggono.
Rispetto alla produzione di audiovisivi nelle scuole, l’attento esame di un documentario di buona o discreta fattura è un esercizio preliminare. Aiuta a capire, se non altro, se siano disponibili le risorse anche solo per mutuare i modelli prescelti.
Facciamo solo un paio di esempi.Il nazionalsocialismo e La stagione dei Lager, prodotti e diretti da Julia
Spark per Granada film nel 1984, sono due documentari di 21 minuti, all’interno di una serie di dieci video dedicati alla storia contemporanea, facilmente reperibili. Si tratta di prodotti costruiti in maniera quanto mai tradizionale, i cui elementi sono appunto la voce fuori campo, materiale d’archivio (film in movimento, foto, disegni satirici ecc.), musica pertinente dell’epoca con valore documentario. I testi, non inutili, sono illustrati in modo efficace con immagini non banali, frutto cioè di un’accurata ricerca.
Questo tipo di documentario, che ha ispirato molte delle prove dei ragazzi, è fra i più complessi da imitare. Il problema principale è proprio quello delle ricerche d’archivio relative alle immagini in movimento. Se non si riescono a «rubare» con una qualche registrazione domestica e pirata da un’emittente televisiva, o a copiare da un altro supporto videomagnetico, mi sembra un po’ utopico pretendere che le scuole, già privilegiate per avere evidentemente a disposizione una qualche struttura di montaggio, abbiano anche la possibilità di affrontare le spese di ricerca, di riversamento e infine quelle dei diritti. Ricordiamo infatti che le immagini d ’archivio prima ancora che essere una fonte storica sono una merce, in alcuni casi particolarmente costosa. Detto questo, è bene essere informati su quali documentari esistano sul tema e dove si possano trovare: archivi cinematografici, cineteche provinciali, regionali o comunali, di centri di studio, ma anche negozi di videonoleggio o la stessa cineteca r a i (alla quale è possibile inoltrare richieste e, con un po’ di fortuna, ottenere a volte anche risposta positiva). Non è quindi necessario rassegnarsi a «rubare» solo quello che «passa» la televisione nella settimana in cui si è deciso di provare a montare un video.
Supponendo poi di avere a disposizione risorse d ’archivio e un’adeguata strumentazione tecnica, occorre porsi una serie di domande: Quale progetto di comunicazione si intende fare? Che tipo di testo si prevede? Si
188 Chiara Ottaviano
tratta della relazione finale di una ricerca in cui si tenta di comunicare tutto quello che si è appreso? E sicuro che il mezzo più adatto per far conoscere quel tipo di testo sia proprio quello audiovisivo?
Altro esempio è il documentario di 14 minuti Liberazione del campo di Mauthausen 5 maggio 1945, prodotto dalla Regione Lombardia e dall’ANED. Le immagini sono le note riprese dei cineoperatori al seguito delle truppe alleate; il sonoro è costituito invece dalla lettura di un testo originale che aiuta a capire e a contestualizzare ciò che si vede.
Questo tipo di documentario rappresenta un modello più facile da realizzare e può anche consentire di raggiungere risultati originali eliminando al contempo i rischi di montaggi azzardati e di tentazioni di esaustività rispetto al tema. Registrato un documento significativo, si può scegliere di costruire il testo, anche a più voci, proprio a partire dalle immagini, evidenziando particolari od omissioni, o si possono montare brani di interviste ai testimoni.
Nel video delle studentesse di un liceo valdese di Torre Pellice c’era un piccolissimo esempio, che a me è parso ben riuscito, di quel che efficacemente si potrebbe fare. A commento delle immagini del solito documentario di Mixer era stato inserito un brano di un’intervista a un’ex deportata politica. Il linguaggio semplice e antiretorico della testimone, il senso di verità che era trasmesso da quella voce e da quel modo di parlare, mi è sembrato fra i pochi modi accettabili di accompagnare immagini tanto estreme da apparire irreali, tanto già viste da rischiare di risultare banali.
Quest’esempio «ben riuscito» fa emergere comunque un problema di ordine non formale ma contenutistico. L’universo concentrazionario nei video dei ragazzi (ma anche in alcuni dei video istituzionali e professionali) appare di norma come una realtà omogenea e indistinta: campi di deportazione, campi di sterminio, campi di concentramento per i prigionieri militari sembrano rinviare alla stessa identica realtà. In questo caso il video, con più enfasi rispetto ad altri mezzi, fa emergere una questione che riguarda più in generale tutta la didattica relativa a questa specifica tematica.
Per ultimo vorrei suggerire la visione di una vecchia inchiesta televisiva di una RAI che non c’è più. Mi riferisco a un servizio andato in onda nel 1975, all’interno della rubrica AZ, a cura di Emilio Ravel, dedicato alla Risiera di San Sabba. L’inchiesta, attraverso cui si tentava di ricostruire la storia del Lager italiano denunciando responsabilità individuate e rimaste impunite, è di eccellente qualità. Per molti versi questo prodotto è più efficace di tanti video dichiaratamente storici dedicati al tema, anche perché fa capire quanta complessità sia dietro al fenomeno Lager e quanta
L 'universo concentrazionarìo e gli audiovisivi prodotti nelle scuole 189
connivenza ci sia stata non solo durante i tristi anni della guerra ma anche successivamente.
Ovviamente non è mia intenzione stimolare velleità di alcun tipo o suggerire, dopo tanta prudenza, inchieste avventurose. Se si hanno però a disposizione strumenti di ripresa oltre che centraline di montaggio è possibile progettare anche piccole ma interessanti inchieste. Senza andare oltre il quartiere, potrebbero essere fatte interviste in video a persone di diversa estrazione sociale e di diversa età, chiedendo, per esempio, qual è il significato attribuito a parole come Lager, nazisti, deportati, Olocausto, Shoah ecc. Si scoprirebbe magari attraverso questa strada perché è il caso di continuare a occuparsi del tema.
Esistono naturalmente altre mille idee migliori di questa. L’importante è essere consapevoli dei propri mezzi, usarli con intelligenza, rifuggire da eccessi di genericità o da tentazioni di esaustività.
Per concludere: l’uso di strumenti di ripresa e di montaggio, che deve implicare un precedente lavoro di ricerca, di analisi nonché di progettazione, può rappresentare un’occasione didattica straordinaria per stimolare l’interesse verso un problema, per imporre la scelta e la messa a fuoco di temi e argomenti ben determinati, per impegnare intelligenza, fantasia ed entusiasmo in quell’impresa collettiva che è il «non dimenticare».