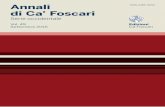Gli audiovisivi e la didattica della storia, in Annali AAMOD, 2, 1999
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Gli audiovisivi e la didattica della storia, in Annali AAMOD, 2, 1999
A r c h i v i o a u d i o v i s i v o
DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO
A n n a l i2
1999
Vent’anni
1
Hanno collaborato alla redazione:Giovanna Boursier, Ansano Giannarelli, Antonio Medici,
Claudia Pistoni, Paola Scarnati
Il volume è stato realizzato con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali
Dipartimento dello spettacolo
© 1999Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico
Fondazione DPR 13 febbraio 1985
Via F. S. Sprovieri, 1 4 - 00152 Roma Tel. 065896698 - 065896508 Fax 0658331365
e-mail: [email protected] [email protected] www.aamod.it
Gli audiovisivi e la didattica della storiaChiara Ottaviano*
Lo scritto che segue prende le mosse da un intervento proposto nel corso residenziale per insegnanti delle scuole medie superiori intitolato “Storiografia, testimonianze, memoria delle generazioni”, organizzato a Cuneo nel marzo i pyy dalla Direzione generale istruzione classica e magistrale del Ministero della pubblica istruzione e dall'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione. I promotori, che qui ringrazio per l'occasione offerta e i molti stimoli ricevuti, mi hanno richiesto di sottoporre all ’attenzione del gruppo di studio dedicato alla “Costruzione della memoria e/o uso pubblico della memoria e della storia ” il programma La memoria inquieta di G. De Luna per la regia di G. Chiesa.
Gli obiettivi e i percorsiObiettivo di questo intervento è suggerire per laboratori di storia con
crete ipotesi di lavoro e stimoli alla ricerca, a partire da un testo audiovisivo dato, in tre principali direzioni, che riguardano la riflessione sul mezzo televisivo, l’utilizzo delle fonti audiovisive nella ricerca storica contemporanea, la riflessione intorno alla pratica sociale delle commemorazioni. Il testo a cui si fa riferimento c il programma curato dallo storico Giovanni De Luna e dal regista Guido Chiesa intitolato La memoria inquieta, trasmesso da Raitre nel 1995 in occasione del cinquantenario della Liberazione. A partire da questo singolo prodotto, per la cui analisi e interpretazione risulterà utile o necessario ricorrere ad altre fonti e a precedenti ricerche storiografiche e sociologiche, sarà possibile avvicinarsi a temi e questioni di diverso grado di complessità.
Il primo percorso di indagine pone al centro dell’attenzione il mezzo di comunicazione utilizzato, ovvero la televisione, come uno dei luoghi principali nella nostra contemporaneità, dove si costruisce e si contratta quel che potremmo, con una certa approssimazione, indicare come “senso comune”, e cioè parte dei sistemi dei valori condivisi dalla collettività di riferimento. Pensare la televisione, partendo dall’analisi dei testi prodotti, dal modo in cui sono prodotti, dal pubblico a cui sono diretti, è uno dei modi per cominciare a riflettere criticamente sul mezzo, superando le poco utili, quanto radicate, visioni manichee che hanno spesso
194
* Dirige Cliomedia Officina.
finito solo per separare sempre più il ceto dei colti (a cui in parte appartiene, o aspira ad appartenere, la classe insegnante) dalla cultura diffusa o, se si preferisce, popolare.
11 secondo percorso pone al centro dell’attenzione i materiali che costituiscono il testo in esame, ovvero i documenti d ’archivio audiovisivi e sonori utilizzati nel montaggio. Il modo in cui può articolarsi l’analisi delle fonti audiovisive è un esercizio propedeutico anche per un approccio critico rispetto a fonti più tradizionali come quelle scritte. L’esercizio consentirà di avvicinarsi al cuore del tema centrale: il senso della celebrazione del 25 aprile.
Per il terzo percorso le indicazioni di lavoro riguarderanno diretta- mente le commemorazioni e celebrazioni pubbliche, in quanto complesse pratiche sociali e politiche. Si entra così nel vivo di questioni che riguardano la nostra contemporaneità e le scelte che in essa possono essere compiute.
i . Pensare la televisioneNon è certo un esercizio facile “pensare la televisione” come un og
getto sociale, in costante divenire, la cui analisi è tutto fuorché univoca e data una volta per tutte. Esiste ormai una consolidata tradizione di studi sui media, e sulla televisione in particolare, che conta migliaia di saggi, volumi e riviste dedicati specificatamente al piccolo schermo. Per un primo orientamento all’interno di un dibattito tanto denso e variegato sono sicuramente di ausilio alcune importanti rassegne di studi che consentono una visione panoramica, più o meno vasta e articolata, e un confronto di dati e di idee. Occorre però prestare attenzione affinché l’entusiasmo degli studenti per il tema “televisione”, che per molti motivi può risultare particolarmente attraente per i più giovani, non si appanni o dissolva del tutto nella sensazione di essere sommersi da teorie e tesi spesso discordanti, i cui contorni non sempre risultano facili a una immediata comprensione. Parlare di televisione a scuola risulta in genere gradito agli studenti perché si fa riferimento a un oggetto familiare, che essi ritengono di norma di conoscere anche molto meglio, e più approfonditamente e particolarmente, di quanto non possano conoscerlo gli insegnanti. In altre parole sulla televisione i ragazzi ritengono di avere delle competenze. Che infatti hanno,
È da quelle competenze che si può avviare una prima riflessione.
la. Manipolazione, contaminazione e lettura negoziata Per cominciare: la televisione costruisce programmi, ovvero testi. La
prima domanda che può essere posta è: a quale tipo di programmi appartiene La memoria inquietai
195
È un programma costituito da immagini d’archivio, registrazioni sonore d’archivio, scritte autoriali. Con ciò non è in alcun modo catalogabile come un programma contenitore di materiali d’archivio, tipo Schegge, giacché la manipolazione che è stata fatta di quei materiali ha fatto sì che il risultato finale sia un testo del tutto nuovo rispetto ai testi di provenienza delle immagini o dei sonori.
La prima importante riflessione sul mezzo può dunque riguardare proprio il concetto di “manipolazione”, che è obbligatorio in quest’ambito utilizzare in modo del tutto neutrale, spogliandolo da qualsiasi significato di tipo negativo. Un testo audiovisivo è infatti costituito da immagini e da suoni, da icone e sonorizzazioni, da testi scritti e testi detti, che vengono selezionati, scelti, “ tagliati”, rispetto a fonti originali, e quindi accostati e montati insieme. Altre scelte, altri montaggi, a partire dalle stesse identiche fonti, siano esse frutto di ricerca d’archivio, come nel caso del programma di De Luna e Chiesa, o frutto di riprese visive e sonore realizzate per la circostanza, possono produrre testi totalmente diversi sia per il messaggio contenuto sia per il risultato estetico. È dunque nella manipolazione dei materiali, e cioè nelle scelte di selezione e di montaggio, che si addensa buona parte del lavoro autoriale.
Ritornando alla domanda iniziale, a quale tipo di programma appartiene La memoria inquieta, è facile rispondere che si tratta di un programma di informazione culturale. A partire da ciò, con gli studenti, si potrà tentare di disegnare una specie di tassonomia dei programmi televisivi, individuando i generi per le loro funzioni.
L’esercizio, accompagnato dall’analisi della collocazione d’orario dei programmi nei palinsesti, potrà stimolare una riflessione sull’audience televisiva, a cui con varie modalità e in orario diverso si rivolgono le varie emittenti, indirizzando spot e messaggi pubblicitari (la pubblicità, non va dimenticato, è la principale risorsa delle televisioni, che sono sistemi produttivi che operano neH’ambito dell’industria culturale e dell’intrattenimento).
Un programma come quello di De Luna e Chiesa consente inoltre di notare come molto spesso i generi televisivi si contaminino. La memoria inquieta, che per il tema trattato e per l’autore coinvolto appartiene alla tradizione dei documentari storici, per lo stile e il montaggio utilizzato è stato sicuramente ispirato da Blob. Questa almeno è la convinzione di chi scrive. A partire da questa considerazione, si ipotizza il fatto che gli autori abbiano privilegiato nella comunicazione coloro che in qualche modo sentono come loro simili, tali anche perché condividono l’apprezzamento per il linguaggio utilizzato da un programma che, come Blob, è stato per qualche verso quasi il simbolo della capacità innovativa di Rai- tre; un canale, quest’ultimo, la cui preferenza ha negli anni passati implicato anche una certa appartenenza di campo ideologica e politica. Ma se
196
chi scrive non avesse mai visto Blob, non avrebbe potuto in alcun modo avanzare questo tipo di ipotesi e probabilmente, a partire dalla propria esperienza precedente, avrebbe notato qualcos’altro.
Allo stesso modo si potrà sperimentare che gli studenti saranno in grado di riconoscere alcuni personaggi, alcune immagini in riferimento a vicende specifiche, alcuni luoghi o anche alcune vecchie canzoni; altri documenti, probabilmente, sarà per loro più difficile collocarli nel tempo e nello spazio; gli insegnanti, anche solo per fattori anagrafici, avranno minori difficoltà. La lettura e l’interpretazione del documento potranno dunque risultare diverse.
Questo tipo di considerazione può aiutare a meglio comprendere che cosa si intenda per testo “aperto” e per “ lettura negoziata” . Il pubblico televisivo è tu tt’altro che passivo e indifferenziato. È infatti costituito da persone che, per età, grado di istruzione, collocazione sociale, genere, posseggono esperienze e prerequisiti molto differenti fra di loro, che influiscono significativamente nel modo in cui si vede e si ascolta un messaggio e se ne interpretano i contenuti. Fra la codificazione di un messaggio televisivo e la sua decodificazione vi è infatti una straordinaria varietà di soluzioni, È stato per questo suggerito il termine di lettura “negoziata” fra chi ha emesso il messaggio e chi lo ha ricevuto. Questo, ovviamente, vale anche per i testi scritti. La differenza non sta solo però nel fatto che nel messaggio audiovisivo la “contrattazione” sul significato si fa più ampia e complessa, perché riguarda non solo le parole, ma anche le immagini, le sonorizzazioni, i toni di voce, i rumori di fondo, etc., ma anche nella natura diversa dei mezzi. La televisione è broadcasting, ovvero il messaggio da un punto si spande verso un pubblico tendenzialmente indifferenziato. Non così la comunicazione scritta, veicolata da mezzi, come i libri o i giornali, diretti verso pubblici più specifici, separati. Se un bambino può trovarsi facilmente ad assistere a un telegiornale o a un talk show , più difficilmente potrà iniziare la lettura di un saggio di storia o anche solo di un romanzo Adelphi, che pure è posato in bella vista sul tavolino del soggiorno; viceversa è improbabile che un docente di filosofia morale sia un lettore abituale di Novella 2000; non è così improbabile però che si trovi ad assistere a un programma destinato a casalinghe o adolescenti.
ih. La Tv come luogo della contrattazione della memoriae come parte del ritoAttraverso i materiali d’archivio gli autori di La memoria inquieta han
no inteso rivisitare, interpretando, i modi in cui il 25 aprile è stato commemorato dalla Liberazione al 1995, anno in cui il programma è andato in onda. In altre parole gli autori, portatori di una propria memoria, che rappresenta comunque una larga parte del paese, si sono confrontati con
197
i modi in cui altri (persone, gruppi, istituzioni), in anni precedenti, avevano voluto celebrare lo stesso avvenimento, così significativo per la storia dell’Italia contemporanea. Le celebrazioni, in fondo, servono anche a questo: a offrire occasioni per le élitcs e i gruppi diversi di “contrattazione” delle diverse memorie. Nelle società contemporanee occidentali la televisione è uno dei luoghi più significativi di questo tipo di contrattazione sociale, che può riguardare la memoria, i valori condivisi, l’interpretazione dei fatti, la creazione di senso comune, etc. In altre parole la Tv è uno dei luoghi in cui si definiscono gli “orizzonti di realtà”, i “valori” della contemporaneità e si negoziano le memorie dei differenti gruppi.
Rispetto alla celebrazione del rito, come dimostra anche la scelta delle immagini di repertorio del documentario, la Tv è ormai da tempo parte costitutiva. Registra e divulga la cerimonia, assolvendo così anche una funzione, che già dalle origini era della fotografia, di “garante” del “rito ” (poco imporra se è solo un ristretto gruppo di autorità e volenterosi a partecipare, se l’evento viene trasmesso a migliaia e migliaia di persone); costruisce testi autonomi, come per esempio il documentario di De Luna e Chiesa o altri documentari sulla Resistenza mandati in onda negli anni precedenti; crea, o partecipa alla creazione di grandi eventi, per i quali i mass-mediologi hanno coniato l’espressione di “grandi cerimonie dei media” . Basti pensare al 25 aprile del 1994, quando centinaia di migliaia di persone sfilarono a Milano. Fu un evento molto significativo nella vita politica del paese, la cui “storicità” fu sanzionata anche dalla presenza del mezzo televisivo, che inviò dalla mattina alla sera le immagini in diretta di quell’enorme massa di popolazione che compatta sfilava per chilometri e chilometri nonostante la pioggia battente.
2. I documenti audiovisivi come fonte storicaUn documento scritto, in quanto fonte storica, può essere interrogato
in modo assai diverso ed essere quindi sottoposto a diversi tipi di analisi. Ciò vale anche per i documenti audiovisivi. Quelli che seguono sono dunque solo alcuni suggerimenti fra i molti possibili.
La prima indicazione è di concentrarsi in tempi diversi sui diversi codici che costituiscono il testo; per semplificare si potranno prima prendere in considerazione le immagini, e cioè il codice iconografico, e successivamente i discorsi contenuti nei vari brani d ’archivio, cioè il codice linguistico.
za. Il rito “flessibile” del 25 aprileSelezioniamo dunque le immagini in movimento, che con certezza so
no riferite alle celebrazioni del 25 aprile, e tentiamo di catalogare i vari elementi che compongono il rito, come per esempio: i discorsi delle au-
198
torità, le parate militari, i cortei di cittadini e combattenti, la presenza dei corazzieri, la deposizione di corone d’alloro sull’altare della patria, la presenza di bandiere, la celebrazione della messa.
Pur nella consapevolezza che il documentario contiene in molti casi solo frammenti della documentazione originaria, si possono porre queste domande: è possibile riconoscere elementi fissi di questo rito? A quali diverse tradizioni, di volta in volta, quella forma di rito si è avvicinata?
Un essenziale contributo per la riflessione in questa direzione può essere costituito dal confronto con altre feste nazionali su cui sono state già svolte approfondite ricerche. Di grande utilità è sotto questo aspetto il volume di Ilaria Porciani1 dedicato alla festa dello Statuto, istituita nel 1851 e divenuta festa nazionale obbligatoria all’indomani dell’unità d’Italia nel 1861. Era per qualche verso il precedente della festa della Repubblica, celebrata in Italia nel secondo dopoguerra. La festa dello Statuto, a differenza di altre feste nazionali, come per esempio quella del 14 luglio in Francia, non era, secondo la ricostruzione dell’autrice, la festa della comunità che celebra se stessa, ma piuttosto la rappresentazione delle istituzioni e del potere. Mai infatti fu concepita dagli organizzatori come festa informale, aperta a tutti; piuttosto era organizzata in spazi chiusi e applicando un ordine rigido delle presenze. L’immancabile rivista militare era la grande metafora del potere, al cui vertice era posto il sovrano.
Ciò che emerge dai materiali relativi alle celebrazioni del 25 aprile è l’assenza di elementi fissi e di rituali definiti. Neanche la deposizione della corona d’alloro sull’altare della patria da parte del capo dello Stato sembra rispettare una preordinata e definitiva scenografia o presenza di attori. L’esercito è significativamente o scarsamente rappresentato. I cortei, che possono essere affollati di giovani e di anziani, possono anche essere, al contrario, del tutto assenti; drappelli numerosi o sparuti di ex partigiani possono fare da cornice alla posa di una lapide o al pronunciamento di un discorso alla presenza, non obbligatoria, di un rappresentante della chiesa cattolica. Si può celebrare all’aperto o al chiuso; le donne possono essere in prima fila o assenti. Nessun elemento, in altri termini, appare inserito in un rituale codificato e rigido.
In conclusione, la festa del 25 aprile, che appartiene all’ampia offerta commemorativa dell’Italia repubblicana, sembra dimostrare una straordinaria “flessibilità”. In alcune occasioni è stata una festa di “popolo”, in cui una significativa parte della comunità si è autocelebrata, in altre una delle occasioni di autorappresentazione della classe politica, ora con prevalenza di quella all’opposizione ora di quella al governo; in altre ancora una specie di obbligo assolto senza che alcuno aspirasse a occupare significativamente la scena. La “flessibilità” appare sia come un’opportunità, per la possibilità offerta a gruppi o istituzioni, di volta in volta, di autorappresentarsi come i migliori interpreti della storia della collettività
199
nazionale in un giorno di massima visibilità, sia come una debolezza: la Resistenza e la sua celebrazione, in quanto miti fondativi della Repubblica, non sembrano appartenere in modo stabile né all’emotività popolare uniformemente diffusa nel paese, né all’area consacrata da un’aurea liturgia sancita da parte delle massime istituzioni.
zb. La “monumentalizzazione” della ResistenzaL’esercizio che segue ha inizio con la trascrizione, o quanto meno la
notazione, dei frammenti dei discorsi contenuti nel programma e pronunciati in occasione di celebrazioni del 25 aprile. Preliminare, ancora una volta, è essere consapevoli che si tratta di sezioni di documenti già selezionati dagli autori di La memoria inquieta a partire dal progetto della loro comunicazione. È giunto dunque il momento di mettere a fuoco le tesi di quel progetto sull’uso della celebrazione della Resistenza e di individuare con chiarezza i punti nodali e i brani selezionati a supporto dell’opinione degli autori, sintetizzata o suggerita in alcune didascalie. Molto utile è a questo proposito la lettura del saggio di Guido Crainz2 che aiuta a evidenziare, integrando con altri documenti d’archivio, i diversi climi politici che hanno, nel corso di cinquantanni, determinato il modo diverso di celebrare il 25 aprile da parte della Tv e degli altri media.
Fatto ciò, è possibile porre nuove domande a quei frammenti di documento integrabili con altri documenti scritti da ricercare a proposito. Possiamo cominciare con il domandarci quale sia l’orizzonte temporale di ogni singolo discorso, ovvero quante volte si fa riferimento al passato (e a quale passato), quante volte al presente, quante volte al futuro.
Sarà facile notare che il passato più lontano che si ricorda nei discorsi è quello del momento della vittoria sui nazifascisti e degli anni della Resistenza; si fa quindi spesso riferimento al tempo presente e frequentemente al tempo futuro. In altre parole l’attenzione non è mai particolarmente focalizzata sul lungo ventennio fascista, quando la grande maggioranza del popolo italiano non si oppose alla leadership di Mussolini, anzi ne fu esaltata sostenitrice.
Questa constatazione ci consente di avvicinarci a una questione complessa e importante che riguarda la cosiddetta “monumentalizzazione” della memoria. Alessandro Cavalli è fra coloro che con più chiarezza hanno evidenziato i termini del problema'. La sua tesi in breve è la seguente: l’antifascismo e la Resistenza hanno funzionato per quasi mezzo secolo come mito fondativo della Repubblica, come cemento del “patto sociale” fra le varie forze in campo all’indomani della caduta del regime. La celebrazione di quel mito, che si concentra nel 25 aprile, ha fatto sì che la Resistenza venisse interpretata come secondo Risorgimento, che il fascismo apparisse solo come una parentesi, una caduta nella storia del popolo italiano, e che in definitiva fosse steso l’oblio sul fatto che molti
200
italiani erano stati fascisti convinti. 11 passato non veniva indagato e una sorta di rimozione collettiva, quasi un rifiuto inconscio di elaborare la memoria, aveva avvolto individui e gruppi, istituzioni e partiti, che pure avevano avuto significative responsabilità nell’affermazione del partito di Mussolini e del suo lungo potere. La celebrazione della Resistenza non ha quindi promosso un processo di costruzione dell’identità collettiva a partire da una necessaria elaborazione della memoria, piuttosto ha finito per produrre “monumenti” della memoria, che restano nel paesaggio come puri reperti archeologici.
3. CommemorareNuove domande, più generali, per le quali è necessario abbandonare il
programma televisivo e rivolgersi a nuove fonti e a nuove ricerche, possono essere a questo punto poste: perché commemorare? Che senso ha la commemorazione? Da quando si è affermata questa pratica sociale?
Per rispondere a queste domande sarà necessario fare più ampi viaggi nel tempo e nello spazio, varcando i confini della penisola e del secolo XX. Ma un’ultima domanda: perché in Italia commemorare ancora il 25 aprile e come commemorarlo, ci riporterà su noi stessi, sul nostro ruolo di cittadini, sulle attuali scelte collettive a cui, anche come singoli individui, inevitabilmente partecipiamo.
3<2. Le feste nazionali, la memoria e l'identità nazionaleL’indagine su questo aspetto potrà essere avviata in modo assai sempli
ce: a partire da una qualsiasi agenda sarà possibile individuare le varie feste nazionali in Europa e nel mondo (e cioè i giorni ufficialmente di vacanza in cui tutti gli uffici pubblici rimangono chiusi e nei quali in genere viene issata la bandiera nazionale), escludendo le date che coincidono con festività religiose o, nel caso di monarchie, con i genetliaci dei regnanti. Si tenterà dunque di capire, di volta in volta, a quale evento, nei vari paesi, quella festa faccia riferimento. La ricerca potrà essere continuata con una ricognizione delle feste nazionali in Europa prima della seconda guerra mondiale. Il confronto sarà inevitabilmente ricco di suggestioni e ipotesi.
Ma quando hanno avuto origine le pratiche di commemorazioni civili negli stati nazionali? L’opera di riferimento obbligatoria è quella diretta dal francese P. Nora4; numerosissimi però sono ormai gli studiosi che, in tutto il mondo, a Est come a Ovest, da anni si occupano del tema.
Riassumo alcune delle tesi maggiormente condivise: l’invenzione delle commemorazioni laiche, intorno a cui riunire il “corpo della nazione” nel ricordo di eventi fondanti della storia del Paese, fu della Rivoluzione francese, che iniziò le celebrazioni del 14 luglio già nel 1790. La commemorazione della presa della Bastiglia non è stata comunque né scontata
201
né univocamente condivisa nel corso degli ultimi due secoli. In America, solo a partire dal 1820 si è identificato nel 4 luglio la data simbolo della Rivoluzione americana, particolarmente enfatizzata come festa nazionale solo dopo la fine della guerra civile. Spesso la celebrazione del 4 luglio fu accompagnata da cortei e manifestazioni contrapposte, che giunsero in alcuni casi anche agli scontri fisici. Ciò che si contendeva era l’interpretazione stessa della rivoluzione quale elemento originario della Confederazione americana.
Gli inglesi non hanno celebrazioni simili alle feste nazionali (francese, americana o italiana). Ciò confermerebbe l’idea secondo cui la memoria, di eventi e luoghi specifici, è coltivata e istituzionalizzata là dove si è verificata una significativa rottura con il passato.
Le feste nazionali sono dunque frutto della modernità: i rivoluzionari francesi, che vollero rigettare il passato e intesero progettare un futuro radicalmente nuovo, inaugurarono, anche attraverso la celebrazione del 14 luglio, la pratica della costruzione di una “memoria nazionale”, e cioè la possibilità che persone, che non si erano mai viste né incontrate prima, pensassero di avere un comune passato, unite nella pratica della dimenticanza come in quella del ricordo.
La costruzione della cosiddetta “memoria nazionale” è dunque intimamente legata, in modo interdipendente, al concetto di identità nazionale. Il concetto di “identità” è un termine quanto mai ambiguo. Esso infatti fa pensare a un qualcosa di unico, ben distinto da altro, oggettivo e fuori dalla storia. L.'identità di cui si parla invece è anch’essa una costruzione storica, e, come la memoria, è frutto, mai definitivo, di una costante negoziazione che si svolge sul piano politico e sociale fra attori diversi: élites, gruppi e classi in concorrenza, portatori di interessi conflittuali o convergenti, in competizione fra loro per il potere e l’egemonia.
Il passato offre a volte uno schermo sul quale i desideri di unità e continuità, e cioè di “identità”, possono essere proiettati, anche in contesti dove sono presenti conflitti insanabili.
3/?. Le politiche del ricordo e l'etica della memoriaLe feste nazionali, come altre pratiche volte alla costruzione di memo
ria collettiva (erezioni di monumenti, posa di lapidi, manifestazioni legate ad anniversari etc.), sono dunque “costruzioni simboliche” elaborate nell’ambito degli stati nazionali. Se corrisponde a vero quello che sostiene Gérard Namer, secondo cui “le politiche di commemorazione hanno successo soltanto se confermano il piacere che la società prova ad abbreviare il ricordo delle sue indegnità e a eternare i suoi brevi istanti di glo- ria”s, le domande che si possono porre sono: nel nuovo millennio abbiamo veramente ancora bisogno di questi “manufatti culturali”, anche in considerazione del fatto che lo stato-nazione (per il quale quei manufatti
202
erano stati inventati) appare avere esaurito il proprio ruolo storico? Ma se si abbandona l’idea di “commemorare”, non si rischia di rinunciare a esercitare quella che lo storico tedesco W. Kaschuba6 indica come una responsabile e irrinunciabile “politica del ricordo”, quel pensare e ricordare in comune che è soprattutto una responsabilità nei confronti del futuro?
Più radicalmente ci si può porre la seguente domanda: in una collettività la necessaria elaborazione del passato è favorita o ostacolata dalla pratica delle commemorazioni, con tutti i suoi riti e con tutti i rischi di monumentalizzazione di cui si è prima detto, oltre che con la certezza che si tratta sempre di una memoria parziale?
La risposta non è fra le più semplici. La riflessione può prendere l’avvio dal confronto fra le politiche del ricordo adottate in Germania e Italia, i due paesi responsabili dell’affermarsi del nazismo e del fascismo.
Nel ricco calendario delle feste nazionali dell’Italia repubblicana il 25 aprile e il 2 giugno ricordano rispettivamente la fine del regime fascista e la vittoria della Repubblica sulla monarchia: entrambi gli eventi segnano una chiara cesura con il periodo precedente. La Germania occidentale compì scelte diverse. Nessuna data di “cesura” con il passato venne presa in considerazione. Piuttosto l’evento simbolico assunto come occasione per la festa nazionale, intitolata “giornata dell’unità tedesca”, faceva riferimento ai disordini scoppiati nella Germania dell’Est il 17 luglio 1953. Si scelse dunque di commemorare una data legata al presente della guerra fredda proiettando nel futuro, nell’auspicata riunificazione, ogni tensione emotiva che la celebrazione dell’anniversario avrebbe potuto sollecitare.
La sociologa di origine tedesca Renate Siebert ha raccontato, con grande generosità, il disagio della sua generazione, che ha vissuto la propria adolescenza avvolta nel silenzio degli adulti intorno al passato e il profondo turbamento nell’apprendere gli orrori di cui si era macchiato il suo paese. Furono i figli, i ragazzi e le ragazze del ’68, a imporre ai padri e alle madri, dolorosamente e anche violentemente, il confronto e il ricordo: “Molti della mia generazione abbiamo sentito la necessità, forse la responsabilità di costringere i più grandi, la generazione precedente, ad avere e ad elaborare una memoria”7. In quel periodo la giovane Siebert guardava alla Germania dell’Est come un punto di riferimento e ascoltava con avidità la radio proibita che trasmetteva oltre confine. Lì sì che il passato veniva ricordato e non era certo trascurata la commemorazione della vittoria sul nazismo. Peccato però che ciò non abbia suscitato quel profondo travaglio e quel lacerante confronto fra le generazioni su cui si è radicata la coscienza democratica di tanti giovani della Germania occidentale: “Quella commemorazione pietrificata non invitava a un’assunzione di responsabilità, ma era autoassolutiva a sua volta”. È il rapporto col lutto, secondo la studiosa tedesca, “ciò che segna il confine tra una
203
memoria storica viva e attiva da una parte, e le forme monumentali di commemorazione che deresponsabilizzano l’individuo, dall’altra”".
Non è dunque il “commemorare” in sé che implica monumentalizza- zione, deresponsabilizzazione, disinteresse per l’elaborazione della memoria; sono il ricordare senza interrogare, il compiacersi dei soli atti nobili, l’escludere la critica degli altri, che rendono quel tipo di memoria una pratica morta. “Ricordare i torti che abbiamo subito è cosa da poco: ma la memoria e la storia mostrano tutta la loro carica etica quando ricordiamo i torti che abbiamo inflitto”1': l’affermazione è di Paolo Jed- lowshi, che condivide con la Siebert e altri il principio di un’etica della responsabilità nei confronti della memoria, che implica anche un rapporto irrinunciabile fra le generazioni.
Forse, è questo l’augurio: l’anniversario del 25 aprile, proprio per la sua “flessibilità”, ha tutte le caratteristiche per poter essere salvato dalla mo- numentalizzazione e dalla pietrificazione, e per poter avere un senso anche al di là dei riti della nazione. Può infatti divenire occasione di vero confronto con il passato e con la storia degli italiani, ma può anche essere, per i valori universali impliciti in quell’anniversario, uno dei riferimenti utili per costruire in Europa una memoria che si fondi sull’unica identità possibile che, come sostiene Victoria Campas, è “un’identità morale”, fondata sul valore della “democrazia e dei diritti dell’uomo e sul progetto di conservare questi universali, migliorandone l’applicazione di fronte a una pratica che li viola costantemente”10. Ciò significa che, se si vuole rivendicare per l’Europa la tradizione dei progetti di democrazia e delle grandi utopie, la nuova memoria non potrà rinunciare, per essere viva, a fare riferimento a quello che Namer indica come il valore dominante della nostra cultura: “la costante messa in questione di sé”11. Occorrerà quindi esplorare un nuovo settore della memoria collettiva: quello delle memorie "negative” e dei tanti grandi fallimenti, di cui gli europei portano la maggiore responsabilità, fuori e dentro i confini del vecchio continente.
Note
1 I. Porcian i, La festa della nazione. Rappresentazione dello Stato e spazi sociali nell'Italia unita, Bologna, Il Mulino, 1997.
2 G. Crainz, / programmi: dalla Liberazione ai primi anni Settanta, in AA.VV, La Resistenza italiana nei programmi della Rai, Roma, Rai-Eri, 1996. Cfr. anche G. Isola, La celebrazione della Resistenza. Cinquantanni di storia alla Rai, in “Italia contemporanea”, marzo 1999, pp. 87-104.
3 A. Cavalli, / giovani e la memoria del fascismo e della Resistenza, “Il M ulino”, 363, 1996, pp. 51-57.
204
4 P. N ora, Entre Mémoire et Histoire. La problematique des lieux, in Les lieux de memoire, 1, “La République”, Gallimard, 1984.
5 G. Namer, Batailles pour la mémoire, la commémoration en France de 1 9 4 5 a nos jours, Parigi, Papyrus, 1983.
6 W. Kaschuba, Gli specchi ciechi dei tedeschi. Memoria collettiva e identità nazionale nella Germania del dopoguerra, in “Intersezioni”, XVIII, 2, 1998, pp. 311-330.
7 R. Siebert, A proposito di memoria e responsabilità, in “Il Mulino”, 363, 1996, p. 62.
8 Ibidem.
9 P. Jedlowski, Introduzione, in A. Rossi-Doria, Memoria e storia: il caso della deportazione, Messina, Rubettino, 1998, p. 6.
10 V. Campas, L’identité europeenne, ime identità morale, in J. Lenoble, H. D ewan- dre (a cura di), L’Europe au soir du siécle: identità et démocratie, Paris, ed. Esprit, 1992, pp. 99-100.
1 I G. N amer, Memorie d ’Europa. Identità europea e memoria collettiva, Messina, Rubettino, 1993, p. 41.
Essenziali riferimenti bibliografici
Per pensare la televisione- Televisione e valori. Lln approccio sociologico, a cura di G. Bechelloni e M. Buo- nanno, Roma, Fondazione Adriano Olivetti, 1993.- D. Dayan e E. Katz, Le grandi cerimonie dei media, la storia in diretta, Bologna, Baskerville, 1993.- G. De Luna, L'occhio e l'orecchio dello storico. Le fonti audiovisive nella ricerca e nella didattica della storia, Firenze, La Nuova Italia, 1993.- A. Grasso, Storia della televisione in Italia, Milano, Garzanti, 1992.- J. M eyrowitz, Oltre il senso del luogo. L'impatto dei media elettronici sul comportamento sociale, Baskerville, 1993.- P. O rtoi.eva, Mediastoria, Parma, Pratiche, 1995.- M. Wolf, Gli effetti sociali dei media, Bompiani, 1992.
Mi permetto inoltre di rinviare a- C. G itavi ano, Mezzi per comunicare. Storia, società e affari dal telegrafo al modem, Torino, Paravia, 1997.- G. O 'itaviano, Vecchi e nuovi discorsi sulla Tv, in AA.VV., Didattica e nuove tecnologie, Torino, 1998.
205
Per le commemorazioni in Tv della Resistenza e del 25 aprile- G. Crainz, A. Farassino, E. Forcella, N. Gallerano, La Resistenza italiana nei programmi della Rai, Roma, Rai-Eri, 1996.- N. Gallerano (a cura di), L'uso pubblico della storia, Milano, Franco Angeli, 1995.- G. Isola, La celebrazione della Resistenza. Cinquant’anni di storia alla Rai, in “Italia contemporanea”, marzo 1999, pp. 87-104.
Per una riflessione intorno alla pratica delle commemorazioni e delle feste nazionali- AA.VV., A Est, la memoria ritrovata, Torino, Einaudi, 1991.- J. R. Gillis (a cura di), Commemoration. The politics of national identity, Princeton University Press, 1994.- P. N ora, Entre Mémoire et Histoire. La proplématique des lieux, in Les lieux de mémoire, I, “La République”, Gallimard, 1984.- G. Namer, Batailles pour la mémoire, la commemoration en Erance de 1947 à nos jours, Parigi, Papyrus, 1983.- G. Namer, Memorie d ’Europa. Identità europea e memoria collettiva, Messina, Rubbettino Editore, 1993 (con una post-fazione di Marita Rampazi).- A. Rossi-Doria, Memoria e storia: il caso della deportazione, (con una introduzione di P. Jedlowski), Messina, Rubbettino, 1998.
Fra i saggi in riviste- nel fascicolo de “Il Mulino”, 363, 1996, intitolato Le radici del presente, gli interventi di A. Cavalli, / giovani e la memoria del fascismo e delta Resistenza, e di R. Sie- bert, A proposito di memoria e responsabilità.- W. Kaschuba, Gli specchi ciechi dei tedeschi. Memoria collettiva e identità nazionale nella Germania deI dopoguerra, in “Intersezioni”, XVIII, 2, 1998.- Ch. S. Maier, Un eccesso di memoria? Riflessioni sulla storia, la malinconia e la negazione, in “Parolechiave”, n. 9, dicembre! 995.
206















![Storia dell'Arco 5 - [Brovelli] - Dispensa didattica Corso OPS Storico parte quinta- Iconografia dell'arco 1](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63203bb018429976e4061c8b/storia-dellarco-5-brovelli-dispensa-didattica-corso-ops-storico-parte-quinta-.jpg)

![Storia dell'Arco 4 - [Brovelli] - Dispensa didattica Corso OPS Storico parte quarta - Archi Basso medievali](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63203c0bc5de3ed8a70da29e/storia-dellarco-4-brovelli-dispensa-didattica-corso-ops-storico-parte-quarta.jpg)

![Storia dell'Arco 2 - [Brovelli] - Dispensa didattica Corso OPS Storico parte seconda- Archi dell'Età del ferro - VI sec.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63203b9100d668140c0ceeb9/storia-dellarco-2-brovelli-dispensa-didattica-corso-ops-storico-parte-seconda-.jpg)


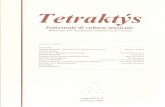







![Storia dell'Arco 7 - [Brovelli] - Dispensa didattica Corso OPS Storico parte settima - Iconografia dell'arco 3](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63203c17c5de3ed8a70da2a3/storia-dellarco-7-brovelli-dispensa-didattica-corso-ops-storico-parte-settima.jpg)