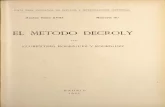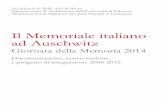Fenomenismo medievale e pensiero eidetico, in Persona, Logos, Relazione. Una fenomenologia plurale....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Fenomenismo medievale e pensiero eidetico, in Persona, Logos, Relazione. Una fenomenologia plurale....
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico
di Giulio d’Onofrio
Nel quarto libro del Periphyseon di Giovanni Scoto Eriugena si incontra, in una pagina di non facile traduzione, una suggestiva celebrazione, tra le più intense scaturite dalla storia del pensiero oc-cidentale, della concordia intellettuale tra due soggetti conoscenti: «Anche noi due, infatti, quando dialoghiamo, veniamo reciproca-mente ad essere l’uno nell’altro (in nobismet invicem effi cimur). Per-ché, in effetti, quando io colgo con l’intelletto ciò che tu cogli con l’intelletto (dum intelligo quod intelligis), io divengo il tuo intelletto (intellectus tuus effi cior), e, in un certo modo che non può essere raccontato, io divengo te (in te factus sum). E similmente, quando tu cogli in modo puro con l’intelletto ciò che io con chiarezza colgo con l’intelletto, tu diventi il mio intelletto, e così i nostri due intelletti diventano un intelletto unico (de duobus intellectibus fi t unus), che prende forma dal fatto stesso che entrambi, sinceramente e senza alcuna incertezza, godiamo della medesima intellezione. Così, pren-dendo come esempio la conoscenza dei numeri, tu cogli con l’intel-letto il fatto che il numero sei è uguale alla somma delle parti che lo compongono; ed anche io colgo con l’intelletto allo stesso modo la stessa cosa, ed ho intelligenza del tuo averne intelligenza, così come anche tu hai intelligenza del mio averne intelligenza; cosicché i nostri due intelletti diventano un unico e solo intelletto, formato dal nume-ro sei, e con questo accade che io vengo creato in te, e tu vieni creato in me. Noi infatti non siamo qualcosa di diverso da ciò che è il no-stro intelletto (non enim aliud sumus, aliud noster intellectus): anzi, il nostro intelletto, reso effettivamente tale dalla contemplazione della verità, è la nostra più vera e più alta essenza (essentia)»1.
1 Giovanni Scoto Eriugena, Periphyseon, IV, PL 122, 780BC, ed. É. Jeauneau, 5 voll., Turnhout 1996-2003 (CCCM, 161-165), IV, p. 57, 1578-1591 (ho corretto la pun-teggiatura): «Nam et nos dum disputamus, in nobismet invicem effi cimur. Siquidem dum intelligo quod intelligis intellectus tuus effi cior et ineffabili quodam modo in te factus sum. Similiter quando pure intelligis quod ego plane intelligo intellectus meus effi ceris ac de duobus intellectibus fi t unus ab eo quod ambo sincere et incunctanter intelligimus formatus. Verbi gratia, ut ex numeris exemplum introducamus, senarium numerum suis
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 27
Nella feconda fusione di intelligenze che condividono la com-prensione dell’unica verità è rilevabile, secondo Giovanni Scoto, una delle più vivide tracce nella vita attuale della perfezione che era propria dell’intelletto umano prima del peccato originale: quando Adamo godeva di una altissima conoscenza di sé e di tutte le altre creature, comprese le intelligenze angeliche («plenissima scientia na-turarum»), in quanto aveva la possibilità (mai attuata, a causa del peccato) di contemplare nel Verbo o Intelletto divino l’eterna verità delle essentiae (o ousiae), archetipi viventi di tutta la realtà (causae primordiales o rationes aeternae), nelle quali veramente sussiste ogni cosa, passata, presente e futura, concepita «ab aeterno» dal Crea-tore quale parte integrante di un perfetto ordine universale. Con il peccato l’uomo ha perso tale capacità; ogni attività particolare della sua anima, teoretica ed etica, può ora solo aspirare a inadeguate e incompiute ricostruzioni dell’ordine cosmico, che solo alla fi ne dei tempi torneranno a perfezionarsi nei redenti, quando sarà restaurata la congiunzione conoscitiva tra natura umana e divina: apparirà allo-ra anche nel loro intelletto creato la «vera et incommutabilis essen-tia» delle cose tutte, formata e eternamente sussistente nel Pensiero creatore2.
La dottrina eriugeniana della condivisione intellettuale della verità è dunque intimamente connessa alla dottrina neoplatonico-cristiana dell’esemplarismo teologico: il Verbo divino è l’immutabile Intelletto, o la Sapienza eterna, in cui il Padre contempla e fa vive-re, imponendo con tale pensiero la forma stessa che le fa sussistere come tali, le essenze originarie di tutte le creature. All’interno di tale quadro dottrinario – che Giovanni Scoto, sostenuto dall’insegna-mento di Massimo il Confessore, sua fonte speculativa prediletta, corregge con un accentuato ricorso alla negatività teologica pseudo-dionisiana –, la verità prima di ogni cosa è percepibile dalla mente creata innanzi tutto come theophania: ossia come il vero manifestarsi, nelle forme conoscitive disposte dall’imperfetta razionalità fi nita, di immagini speculari indirette dell’originaria, in sé inconoscibile sus-sistenza del reale nella mente di Dio; mentre ogni variabile conno-
partibus esse aequalem intellegis, et ego similiter intelligo, et intelligere te intelligo, sicut et me intelligis intelligere; uterque noster intellectus unus fi t senario numero formatus ac per hoc et ego in te creor, et tu in me crearis. Non enim aliud sumus, aliud noster intel-lectus: vera siquidem ac summa nostra essentia est intellectus, contemplatione veritatis specifi catus». I corsivi, in questa e nelle note seguenti, sono miei.
2 Cf. ibid., 777C-779A, pp. 53, 1462 - 55, 1514.
28 Giulio d’Onofrio
tato particolare, che copre e oscura la veridicità delle theophaniae, è solo il falso apparire, nella degradata visione della sensualità, di phantasiae, ombre distorte della verità essenziale. Progettando nel Verbo le essenze immutabili, Dio Padre ne ha fondata infatti anche la capacità di supportare, quale subiectum sostanziale, le alterazio-ni circostanziali – qualitative, quantitative, spazio-temporali – nel-le quali e mediante le quali l’inconoscibile quid del Pensiero divino si manifesta corporalmente alle intelligenze fi nite: le quali possono però errare, lasciandosi infl uenzare e disorientare dalla coltre di tali apparenze, e attribuendo ad esse, ingiustifi catamente, una esteriore sussistenza reale; quanto più invece la creatura intelligente, con il sostegno della fede nella rivelazione del Verbo, si fa capace di risalire da tale ingannevole apparire del sensibile all’originaria stabilità delle essenze e di aderire spiritualmente alla loro verità intelligibile, tanto più ne condivide la capacità di produrre la realtà autentica di ciò che conosce. Il pensare divino è la prima essentia, causa dell’essere e del manifestarsi del vero; il pensiero umano, quando si conforma a quello divino e, quindi, collabora con esso nell’opera di creazione, è la secunda essentia delle cose, poiché ri-conoscendone la primordiale sostanzialità sotto l’apparire condizionante delle nove categorie acci-dentali le fa, in un certo modo, sussistere realmente3.
La concezione fenomenistica platonico-cristiana, giunta in que-sta forma nel sistema eriugeniano ad una fi ne precisazione del fon-damento speculativo che la sostiene, affonda le proprie radici nelle antiche meditazioni patristiche sul prologo del quarto Vangelo, ossia sulla nozione metafi sico-teologica del Logos, o Sapienza eterna, luo-go divino degli archetipi essenziali. Introdotto sulla scorta dell’ebrai-smo alessandrino dai più profondi fra i primi teologi di lingua greca, da Giustino a Origene, questo orientamento dottrinale godette di rapida diffusione nei primi secoli dell’era cristiana anche in ragione del suo utile contrapporsi all’indebolito naturalismo realista del tar-do pensiero pagano (aristotelico e stoico), che già da tempo mostra-va una endemica vulnerabilità alle critiche del relativismo scettico-probabilistico. La rivelazione cristiana – inizialmente accolta come fonte solo di una innovativa codifi cazione della morale, fi nalizzata alla conquista della felicità come habitus – mostrava d’altra parte di poter affi dare la stabilità del vero, non soltanto etico ma anche teo-
3 Cf. ibid., 779AC, p. 55, 1515-1535. Cf. G. d’Onofrio, Vera philosophia. Studies in Late Antique, Early Medieval and Renaissance Christian Thought, Turnhout 2008 (Nu-trix, 1), pp. 168-208.
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 29
retico, all’operatività di un perfetto, incondizionato soggetto divino, la cui volontà e il cui pensiero, coincidenti in una unica e assoluta potenza, diventavano l’unitario criterio costitutivo del reale; e alla cui eterna verità erano riconducibili tutte le acquisizioni particolari di conoscenza, e quindi le forme di progresso scientifi co consentite, nel loro limitato orientarsi, ai soggetti creati.
Anche in ragione della elaborazione teoretica e della diffusione di tale orientamento esemplaristico e fenomenistico è giusto consi-derare Agostino il maestro comune di tutti gli intellettuali del Me-dioevo4. La sua autorità, universalmente riconosciuta, ha favorito la condivisione dell’idea che l’accostamento dell’anima alla verità sia subordinato agli esiti di una totale conversio dall’inautentico mondo del corporeo e del molteplice, assicurata dal concorso di corretta razionalità (ratio superior o vera philosophia) e completamento del sapere determinato dalla fede in Cristo (o vera religio): questo prin-cipio alimenta in effetti nel corso dell’intera speculazione fi losofi co-teologica medievale una condivisa aspirazione al superamento della condizione storica e limitata dell’homo exterior, le cui disarticolate sollecitazioni empiriche determinano l’avviarsi, nella semplicità intel-lettiva dell’homo interior, della ricomposizione degli ordinati fonda-menti intelligibili del vero e del bene, che sussistono «semel et simul et semper» nella Mente e Volontà divina5, fondamento ontologico di ogni cosa, «forma non formata, sed forma omnium formatorum»6. In quanto «intellectus in quo universa sunt», è giusto dire che il Verbo è anche esso stesso l’Essere di tutte le cose: «vel ipse potius universa», poiché «universorum principium»7.
4 Tra innumerevoli testimonianze, cf. Agostino di Ippona, De Genesi ad litteram, I, 5, 10, PL 34, 250, ed. J. Zycha, Praha - Wien - Leipzig 1894 (CSEL 28/1), pp. 8-9; ibid., II, 6, 12-13, 267-268, pp. 40-42; De Trinitate, IX, 6, 9-11, PL 42, 965-967 ed. W. J. Mountain, 2 voll., Turnhout 1968 (CCSL 50-50A), I, pp. 301-303; ibid., XII, 1, 1 - 4, 4, 997-1000, I, p. 356; De diversis quaestionibus octuaginta tres, 46 (De ideis), PL 40, 29-31 ed. A. Mutzenbecher, Turnhout 1975 (CCSL 44A), pp. 70-73.
5 Agostino di Ippona, Confessiones, XII, 15, 18, PL 32, 832, ed. L. Verheijen, Turnhout 1981 (CCSL 27), pp. 224-225.
6 Agostino di Ippona, Sermo 117, 2, 3, PL 38, 662.7 Cf. Agostino di Ippona, De ordine, II, 9, 26, PL 32, 1007, ed. W.M. Green, Turn-
hout 1970 (CCSL 29), p. 122, 12-19: «[Auctoritatis ianuam] quisque ingressus sine ulla dubitatione (…) discet (…) quid sit (…) intellectus, in quo universa sunt, vel ipse potius universa, et quid praeter universa universorum principium». E cf. Giovanni Scoto Eriu-gena, Commentarius in Evangelium Iohannis, I, XXVII, PL 122, 304C, ed. É. Jeauneau, Turnhout 2008 (CCCM 166), p. 60, 72-74: «Animus itaque, id est intellectus omnium Dei fi lius est. Ipse est enim, ut ait sanctus Augustinus, intellectus omnium, immo omnia»;
30 Giulio d’Onofrio
Con un aperto recupero delle origini pitagorico-platoniche del-l’ontologia esemplaristica, Boezio ha avuto il merito di precisarne le implicazioni epistemologiche, prescindendo dal risvolto teologico di matrice cristiana ma elaborando un sistema del sapere pienamente compatibile con esso. Fin dal primo prologo dei suoi scritti giovanili sul quadrivio, egli indica il compito della scienza nella determinazio-ne delle formae o essentiae immutabili, alla cui causalità originaria va ricondotta ogni indagine intellettuale sul variare di gradi e ordini di manifestazione del vero8. Il sapere scientifi co diventa così l’esito nor-mifi cato, e non più soggettivamente modifi cabile, della purifi cazione conoscitiva dell’oggetto da tutte le scorie accidentali, che lo avvolgo-no come un involucro quando esso viene introdotto nel soggetto at-traverso l’esperienza sensibile. Boezio fi ssa in questo modo le condi-zioni fondative per la costruzione di una articolata enciclopedia delle scienze fi losofi che, ciascuna delle quali corrisponde ad una manife-stazione dell’effi cacia formale delle essentiae. E fa corrispondere a tale ripartizione delle scientiae una gerarchia di diverse facoltà dell’a-nima (senso, ragione, intelletto), ciascuna delle quali è responsabile di una diversa metodologia conoscitiva applicata nei vari ambiti di manifestazione del reale. Ogni singolo grado del conoscere circoscri-ve infatti (in armonia con la gnoseologia tardo-neoplatonica, in par-ticolare formalizzata da Proclo) una molteplice tipologia di falso ob-bligato, poiché tutti gli atti fi niti di conoscenza implicano una duttile commistione di falsità e verità: sono falsi in quanto ciascuno di essi elabora sempre e soltanto una manifestazione relativa degli oggetti, e mai la loro ultima realtà essenziale; ma sono veri in quanto, nella stretta coerenza della gerarchizzazione delle corrispondenti sfere di sapere, contribuiscono tutti, in modo ordinato e diverso, a orientare l’anima verso modalità imperfette, ma progressivamente perfettibili, di apparizioni dell’irraggiungibile ultima verità dell’essere9. Nel pri-mo capitolo del De trinitate (il primo dei cinque opuscoli teologici
Periphyseon, II, 545A, ed. Jeauneau, II, p. 210, 1458-1460: «Christus, qui omnia intel-ligit, immo est omnium intellectus».
8 Cf. Severino Boezio, De institutione arithmetica, I, 1, PL 63, 1079D-1080D, ed. G. Friedlein, Leipzig 1867, pp. 7, 26 - 8, 8: «Est enim sapientia rerum, quae sunt suique inmutabilem substantiam sortiuntur, comprehensio veritatis. Esse autem illa dicimus, quae nec intentione crescunt nec retractione minuuntur nec variationibus permutan-tur, sed in propria semper vi suae se naturae subsidiis nixa custodiunt. Haec autem sunt qualitates, quantitates, formae, magnitudines, parvitates, aequalitates, habitudines, actus, dispositiones, loca, tempora et quicquid adunatum quodammodo corporibus in-venitur».
9 Cf. G. d’Onofrio, Vera philosophia, cit., pp. 90-130.
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 31
boeziani) sono così distinte, come parti della fi losofi a teoretica: la fi sica, che studia l’apparire sensibile delle forme in connessione con la corporalità materiale; la matematica, conoscenza delle medesime forme, ma astratte razionalmente dalla mutevolezza corporea; e in-fi ne la teologia, contemplazione non mediata, peculiare della facoltà superiore noetica, intellectus o intelligentia, della unitaria forma di-vina nella quale convergono tutte le forme inferiori. In armonica co-erenza con la teologia esemplaristica agostiniana, anche per Boezio le molteplici essentiae o formae non sono dunque altro che l’apparire limitato e adeguato alle creature intelligenti della unica originaria ve-rità, in sé piena e assoluta, che è quella della Forma prima, l’eterno Intelletto divino10.
Coniugando senza troppe forzature lo schema epistemologico boeziano con la dottrina agostiniana del Logos, molti maestri medie-vali hanno apertamente condiviso l’orientamento fenomenistico che tale sintesi introduce e sostiene. Ne è scaturita una concezione del conoscere inteso come il progressivo consolidarsi della scala che in-nalza le anime verso l’aspirazione ad una fi nale condivisione dell’on-nicomprensiva contemplazione divina della verità formale di tutte le cose, il cui avvio è scandito dal dispersivo affollarsi delle infor-mazioni sensibili nella datità del fl usso fenomenico, e il cui punto di arrivo è intravisto nell’accesso escatologico dei redenti all’unitarietà della visione beatifi ca. E se i più espliciti testimoni di tale concezione gerarchica del conoscere sono stati soprattutto i grandi esponenti della mistica speculativa cristiana, dagli autori monastici (benedet-tini e cisterciensi) ad Alberto Magno e Bonaventura, fi no a Meister Eckhart e Niccolò Cusano, non è d’altra parte diffi cile riconoscere quanto sia stata comunque ampiamente e sottilmente diffusa nell’in-tero Medioevo cristiano una valutazione degli atti conoscitivi come
10 Severino Boezio, De trinitate (Opuscula sacra, I), 2, PL 64, 1250AB, ed. C. Mo-reschini, München - Leipzig 2000, pp. 168, 64 - 169, 83: «Nam cum tres sint specula-tivae partes, naturalis, in motu inabstracta ¢nupexa…retoj (considerat enim corporum formas cum materia, quae a corporibus actu separari non possunt, quae corpora in motu sunt ut cum terra deorsum ignis sursum fertur, habetque motum forma materiae coniuncta), mathematica, sine motu [in]abstracta (haec enim formas corporum specula-tur sine materia ac per hoc sine motu, quae formae cum in materia sint, ab his separari non possunt), theologica, sine motu abstracta atque separabilis (nam dei substantia et materia et motu caret), in naturalibus igitur rationabiliter, in mathematicis disciplinali-ter, in divinis intellectualiter versari oportebit neque diduci ad imaginationes, sed potius ipsam inspicere formam quae vere forma neque imago est et quae esse ipsum est et ex qua esse est».
32 Giulio d’Onofrio
distinti apprezzamenti del vario manifestarsi della realtà, costitutivi di altrettanti ordini o sfere del sapere, nella cui articolazione il sog-getto dispone la propria recezione degli oggetti conosciuti.
L’impianto speculativo di fondo che così emerge dall’imposta-zione gnoseologico-epistemologica di molti autori ‘platonizzanti’ del Medioevo, non è in effetti, a ben vedere, aprioristicamente incom-patibile né inconciliabile con il modello speculativo aristotelico do-minante in molti magistri dei secoli XIII e XIV: che è evidentemente fondato su una percezione dei rapporti tra soggetto e oggetto di tipo più accentuatamente corrispondentista, secondo cui il ‘conoscere’ equivale all’introdursi nelle potenzialità recettive dell’anima di una progressiva e sempre perfettibile riproduzione del modo di essere della cosa, orientata e determinata dalle informazioni che l’esperien-za imprime attualmente sull’intelletto come su una superfi cie molle («intelligere est quoddam pati»)11. Tommaso d’Aquino, in particola-re, ha fondato la propria considerazione della conoscenza scientifi ca sulla valorizzazione del procedimento mentale dell’astrazione come atto di formalizzazione interiore dei dati connotativi della res acqui-siti tramite l’esperienza, il cui esito è la produzione del sapere scienti-fi co come un ‘adeguarsi’ formale dell’intelletto a tali specifi cità este-riori («adaequatio intellectus rei»)12. L’orientamento fenomenistico che accompagna la tradizione agostiniano-boeziana non si risolve però necessariamente in una presunzione ontologistica, degenerabile negli errori panteistici attestati, con esiti diversi, nell’escatologismo materialista degli Amalriciani13 o nel sistema di naturalismo metafi -sico congegnato da Davide di Dinant14. Appunto per fare fronte a tali errori – che scaturiscono a suo parere da una pretesa concezione della conoscenza veridica come condivisione piena, riservata già in questa vita a pochi eletti, dell’assoluta potenza divina produttiva del reale – Tommaso congegna la propria teoria del sapere scientifi co, fondativa di tutte le discipline insegnabili e perfezionabili dall’intel-
11 Aristotele, De anima, III, 4, 429a13-14 e b25-26.12 Cf. Tommaso d’Aquino, Quaestiones disputatae de veritate, q. 1, a. 1, resp.; Sum-
ma Theologiae, I, q. 14, a. 2, arg. 2; q. 56, a. 1, arg. 3; ibid. ad 3. Cf. C. Giacon - C. Di Martino, s.v. Adaequatio rei et intellectus, in Enciclopedia Filosofi ca, 12 voll., Milano 2006, vol. I, p. 77 (con aggiornata bibliografi a).
13 Cf. le recenti messe a punto del compianto P. Lucentini, recentemente scompar-so, oggi raccolte nel suo volume Platonismo, ermetismo, eresia nel Medioevo, Louvain-La-Neuve 2007 (Textes et études du Moyen Âge, 41), pp. 363-469.
14 Cf. E. Casadei, I testi di David di Dinant. Filosofi a della natura e metafi sica a con-fronto col pensiero antico, Spoleto 2008 (Fondazione CISAM, Testi, studi, strumenti).
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 33
letto umano (compresa la theologia o sacra doctrina), operando una mirabile sintesi tra la costruttività costantemente verifi cabile dei cri-teri epistemologici di Aristotele e la convinzione agostiniana del ten-dere, progressivo ed infi nito, del conoscere umano alla perfezione (in sé mai raggiungibile dalle creature, ma determinante per la verità di ogni cosa) degli archetipi eternamente sussistenti nel Logos.
L’ascesa conoscitiva raccomandata da Agostino non può e non deve convertirsi, secondo l’avvertimento esplicito di Tommaso, nella presunzione da parte dell’anima umana, lungo i gradi di una mistica ascesa purifi catoria, di poter condividere attualmente nella tempora-lità esistenziale una pienezza di conoscenza che non può che appar-tenere al solo Intelletto divino, in sé esente dal giogo delle coordina-te spazio-temporali in cui si aggira la fi nitudine creaturale. L’errore di Platone consiste quindi nell’avere concepito le idee, cui tende la conoscenza intellettiva umana, come forme (ossia cause formali) se-paratamente reali, operanti sul fi nito per via di partecipazione ma ontologicamente distinte dalle cose da esse formate. Aristotele ha mostrato chiaramente, invece, che la conoscibilità della forma sca-turisce solo da una operazione disgiuntiva dalla materia, cui natural-mente inerisce, compiuta dall’intelletto15. Se non fosse così, infatti, ogni forma formante dovrebbe essere di natura divina, come hanno preteso i sostenitori del più imbarazzante panteismo, dagli antichi presocratici ai recenti eretici dei primi decenni del secolo XIII16. Il riconoscimento del fatto che la forma conoscibile dall’intelletto è sussistente e percepibile solo nel modo di essere delle cose fi nite non esclude però, come apertamente precisa Tommaso, che gli exempla-ria eterni, eternamente sussistenti in Dio, siano i principi quidditativi effi caci dei modi di essere formali delle cose create. Questa è anzi, a suo parere, la dottrina autenticamente vera che soggiace all’opinione dei platonici. Se la forma inerente a ogni cosa creata è separabile dal-la materia solo mediante un atto dell’intelletto, è proprio perché la forma esemplare che ne è il principio quidditativo effi ciente è reale, anche se non percepibile dall’intelletto fi nito; è in sé separata, come vuole Platone, ed eternamente sussistente nell’Intelletto di Dio, come
15 Cf. Tommaso d’Aquino, Quaestiones disputatae de veritate, q. 21, a. 4, resp.: «Platonici dixerunt, quod omnia sunt bona formaliter bonitate prima non sicut forma coniuncta, sed sicut forma separata. Ad cuius intellectum sciendum est quod Plato ea quae possunt separari secundum intellectum ponebat etiam secundum esse separata. (…) Sed haec opinio a Philosopho improbatur (…) ex hoc quod quidditates et formae rerum insunt ipsis rebus particularibus, et non sunt ab eis separatae».
16 Cf. Tommaso d’Aquino, Scriptum super Sententiis, II, d. 17, q. 1, a. 1, resp.
34 Giulio d’Onofrio
vuole Agostino17. Questo consente a Tommaso tanto di armonizzare il proprio punto di vista sulla verità delle forme con l’esemplarismo teologico agostiniano, perché le idee in Dio sono le cause assoluta-mente effi cienti, prime ed esemplari, di tutto ciò che, nella fi nitudine spazio-temporale è formato e, in quanto tale, è conoscibile18; quanto anche di concordare con la dottrina anselmiana della verità, secondo cui le cose vere sono rese tali dalla Verità divina, non però per ‘par-tecipazione’, ma per ‘causalità creativa’. Il nostro intelligere è effet-tivamente una forma di adaequatio o commensuratio della mente alla veritas che sussiste in Dio, esterna e separata da tutte le particolari verità intelligibili, che scandiscono l’attuarsi nell’effettualità spazio-temporale di ciò che l’onnisciente e provvidente Intelletto divino ha eternamente preconosciuto e preordinato19.
Per Tommaso come per alcuni tra i più sottili spiriti speculativi dei secoli precedenti (come Anselmo o Abelardo), una realtà può in effetti essere defi nita dall’intelletto vera (o falsa) solo in quanto viene conosciuta, ossia in quanto è coinvolta nella dinamica di un rapporto relazionale con il soggetto conoscente. E affi nché tale relazione si produca in maniera oggettiva, non opinabile ma condivisibile fra più soggetti fi niti, l’informazione empirica sulla res esteriore deve essere posta in relazione con un principio formale interiore, l’intelligibile o la species intelligibilis, che è vera nella misura in cui è adeguata a rappresentare l’essenza (o il quid) della cosa, astratta dai condiziona-menti materiali20: l’atto conoscitivo umano risulterà comunque tanto più veridico quanto più la species intelligibilis concepita dall’intel-
17 Cf. Tommaso d’Aquino, Quaestiones disputatae de veritate, q. 21, a. 4, ibidem: «Et quantum ad hoc opinio Platonis sustineri potest. Sic igitur dicimus secundum com-munem opinionem, quod omnia sunt bona creata bonitate formaliter sicut forma inhae-rente, bonitate vero increata sicut forma exemplari».
18 Cf. ibid., ad 3: «Ad tertium dicendum, quod Augustinus in multis opinionem Platonis sequitur, quantum fi eri potest secundum fi dei veritatem; et ideo verba sua sic sunt intelligenda, ut ipsa divina bonitas dicatur esse bonum omnis boni, in quantum est causa effi ciens prima et exemplaris omnis boni, sine hoc quod excludatur bonitas creata, qua creaturae denominantur bonae sicut forma inhaerente».
19 Cf. ibid., ad 5: «Ad quintum dicendum, quod similiter etiam distinguendum est de veritate; scilicet quod omnia sunt vera veritate prima sicut exemplari primo, cum tamen sint vera veritate creata sicut forma inhaerente. (…) Ipsa enim ratio veritatis in quadam adaequatione sive commensuratione consistit. Denominatur autem aliquid mensuratum vel commensuratum ab aliquo exteriori, sicut pannus ab ulna. Et per hunc modum intelligit Anselmus omnia esse vera veritate prima, in quantum scilicet unumquodque est commensuratum divino intellectui, implendo illud ad quod divina providentia ipsum ordinavit vel praescivit».
20 Cf. Tommaso d’Aquino, Quodlibet VIII, q. 2, a. 2, resp.: «Species intelligibilis est similitudo ipsius essentiae rei, et est quodammodo ipsa quidditas et natura rei se-
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 35
letto avrà la capacità di assimilarsi (ossia di adeguarsi) all’essenza eterna originaria, separatamente sussistente nel Pensiero creatore. La verità prima di tutte le cose conosciute e conoscibili, e perciò di tutte le cose in assoluto, è dunque anche per Tommaso nell’operante Pensiero divino21.
Non è estraneo allora al pensiero tommasiano lo sfondo esem-plaristico che assicura la sussistenza originaria e inalterabile di ogni realtà nell’atto relazionale superiore con cui essa è pensata dall’eter-no Intelletto di Dio: se il pensiero cristiano (e in particolare Agosti-no) ha il merito di avere risolto le aporie del platonismo, è proprio perché ha potuto intendere, grazie alla rivelazione, la collocazione eterna delle idee come formae separatae nella Mente divina, dove sono operanti quali primarie species intelligibiles in atto di ogni re-altà creata. Le universali rationes aeternae sussistenti nel Verbo – di cui si parla espressamente nel quinto articolo della quaestio 84 della prima parte della Summa –, così come sono causa creante dell’essere di ogni realtà particolare, sono anche principio trascendente della sua conoscibilità da parte dell’intelletto creato22. L’anima intellettiva, incapace nello stato attuale di cogliere la verità nelle cause eterne (in ragione del fatto che, secondo Tommaso, ogni suo atto di conoscen-za deve essere attivato da una sollecitazione esterna e che, dopo il peccato originale, tale tipo di sollecitazione può provenire esclusi-vamente dall’esperienza sensibile) nell’avvicinarsi alla verità forma-le delle res create realizza comunque una propria assimilazione alla perfezione conoscitiva dell’Intelligenza divina: assimilazione che, come l’accecante luce del sole lo è per la vista corporea, è condizione indispensabile di ogni vero conoscere23. Cosicché anche per Tomma-
cundum esse intelligibile, non secundum esse naturale, prout est in rebus». Cf. inoltre Tommaso d’Aquino, De spiritualibus creaturis, a. 9, ad 6; Contra Gentiles, III, 47, n. 6.
21 Cf. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Ia, q. 14, a. 2, resp.: «Cum igitur Deus nihil potentialitatis habeat, sed sit actus purus, oportet quod in eo intellectus et in-tellectum sint idem omnibus modis, ita scilicet, ut neque careat specie intelligibili (…), sed ipsa species intelligibilis est ipse intellectus divinus».
22 Cf. ibid., q. 84, a. 5, resp.: «Posuit autem Plato (…) formas rerum per se sub-sistere a materia separatas, quas ideas vocabat, per quarum participationem dicebat intellectum nostrum omnia cognoscere. (…) Sed quia videtur esse alienum a fi de quod formae rerum extra res per se subsistant absque materia, sicut Platonici posuerunt, (…) ideo Augustinus (…) posuit loco harum idearum quas Plato ponebat, rationes omnium creaturarum in Mente divina existere, secundum quas omnia formantur, et secundum quas etiam anima humana omnia cognoscit».
23 Cf. ibid.: «Cum ergo quaeritur utrum anima humana in rationibus aeternis omnia cognoscat, dicendum est quod aliquid in aliquo dicitur cognosci dupliciter. Uno modo, sicut in obiecto cognito; sicut aliquis videt in speculo ea quorum imagines in
36 Giulio d’Onofrio
so, in esplicita adesione agli insegnamenti di Agostino e Anselmo, ma anche del Liber de causis, l’intelligenza umana per accostarsi alla vera realtà delle res conosciute (realizzando la più autentica «adaequa-tio intellectus rei») deve sforzarsi, muovendo dagli inferiori stimoli sensoriali, di ascendere alle forme intelligibili ad essi corrispondenti, relazionandosi alla perfezione originaria di cui godono nella stabilità eterna del Verbo24.
Il fenomenismo teologico appare dunque non disgiunto, nella civiltà medievale, da una considerazione accentuatamente realista dell’universo e delle singole realtà che lo costituiscono: la giustifi ca anzi, e la sostiene, all’interno di uno schematismo gnoseologico-epi-stemologico che, mentre risolve gli atti conoscitivi del soggetto uma-no in un manifestarsi sempre incompiuto e frammentario del vero, ne fi ssa una convalida fondativa – evidentemente articolata in una complessa gamma di soluzioni possibili nelle varie angolature dottri-nali sposate dai diversi pensatori medievali – nella sua (maggiore o minore) capacità di porsi in relazione con la contemplazione produt-tiva del cosmo da parte del Pensiero divino. Il principio della pre-nozione di tutte le cose nel divino progetto ordinatore, sostenibile a partire dalla sola fede, è certo di natura non fi losofi ca o comunque pre-fi losofi ca. Ma in quanto viene riconosciuta come indispensabile
speculo resultant. Et hoc modo anima, in statu praesentis vitae, non potest videre omnia in rationibus aeternis; sed sic in rationibus aeternis cognoscunt omnia beati, qui Deum vident et omnia in ipso. Alio modo dicitur aliquid cognosci in aliquo sicut in cogni-tionis principio; sicut si dicamus quod in sole videntur ea quae videntur per solem. Et sic necesse est dicere quod anima humana omnia cognoscat in rationibus aeternis, per quarum participationem omnia cognoscimus. Ipsum enim lumen intellectuale quod est in nobis nihil aliud est quam quaedam participata similitudo luminis increati in quo continentur rationes aeternae». E cf. ibid., q. 12, a. 2, resp.: «Manifestum est autem quod Deus et est auctor intellectivae virtutis, et ab intellectu videri potest. Et cum ipsa intellectiva virtus creaturae non sit Dei essentia, relinquitur quod sit aliqua participata similitudo ipsius, qui est primus intellectus. Unde et virtus intellectualis creaturae lu-men quoddam intelligibile dicitur, quasi a prima luce derivatum, sive hoc intelligatur de virtute naturali, sive de aliqua perfectione superaddita gratiae vel gloriae». Cf. inoltre Tommaso d’Aquino, Scriptum super Sententiis, II, d. 23, q. 2, a. 1, resp.; Quaestiones disputatae de potentia, q. 5, a. 1, ad 18.
24 Cf. Tommaso d’Aquino, Quaestiones disputatae de veritate, q. 1, a. 2, resp.: «Res autem non dicitur vera nisi secundum quod est intellectui adaequata; unde per poste-rius invenitur verum in rebus, per prius autem in intellectu. (…) Res naturales, a qui-bus intellectus noster scientiam accipit, mensurant intellectum nostrum (…): sed sunt mensuratae ab intellectu divino, in quo sunt omnia sicut omnia artifi ciata in intellectu artifi cis. (…) Res ergo naturalis inter duos intellectus constituta, secundum adaequatio-nem ad utrumque vera dicitur; secundum enim adaequationem ad intellectum divinum dicitur vera, in quantum implet hoc ad quod est ordinata per intellectum divinum, ut patet per Anselmum in libro De veritate et per Augustinum in libro De vera religione».
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 37
per la coerenza stessa delle argomentazioni razionali sull’esistenza delle cose conosciute, tale presupposizione fi deistica si traduce in un postulato fi losofi co necessario, che assicura al fenomenismo cri-stiano la possibilità di sfuggire alle assurdità del solipsismo e dello scetticismo.
Scaturisce insomma da queste osservazioni un invito a intendere la fi losofi a medievale – o almeno gran parte di essa – come orientata alla realizzazione di un sapere eidetico: di un sapere, cioè, fondato sul principio dell’originaria latenza (in Dio) delle forme originarie della verità, in sé immutabili e perfette, che si manifestano con esiti e sotto condizioni variabili alle diverse facoltà del soggetto conoscente. In tale contesto speculativo, è ‘fi losofi a’, o meglio – come da Clemente e da Agostino in poi sostengono tutti i sapienti cristiani – è «vera philosophia» la progressiva composizione di un insieme coerente di discipline scientifi che, che devono, per essere tali: a) armonizzare sempre i loro insegnamenti con i dati veritativi assicurati dalla fede; b) ma anche (e in stretta coerenza con il primo requisito) aspira-re continuamente alla componibilità di una superiore scienza degli archetipi formali eterni (essentiae, o causae primordiales, o rationes aeternae, ecc.), cui il soggetto creato ‘tende’ spingendo la propria intentio unifi cante al di là del limite del loro velato manifestarsi nelle singole regioni delle conoscenze particolari e relative. La verità di tale scienza delle essenze è dunque logicamente anteriore all’emer-gere, su base fenomenica, delle scienze dei dati empirici, e non è mai risolubile in esse; inversamente, però, ogni conoscenza particolare trova la sua convalida solo nella possibilità di verifi carne la confor-mità con la verità delle essenze pure o leggi universali della realtà.
L’interpretazione del pensare cristiano come un pensare eideti-co, e della genesi delle scienze particolari come attuazioni, sempre imperfette, dell’unica, piena, e dunque per l’uomo mai compiuta o esaustiva scienza delle forme essenziali, accosta sensibilmente il feno-menismo di molti intellettuali del Medioevo ad alcuni fondamentali aspetti della rifl essione fenomenologica del Novecento sull’idea di scientifi cità e sulla concezione del fi losofare autentico come metodo del sapere. Non sarà quindi di poco interesse sottoporre ora a lettu-ra analitica una pagina di speculazione medievale in cui appaiono, più che altrove, particolarmente accentuate ed evidenti alcune signi-fi cative somiglianze con la moderna fenomenologia, in particolare facendo riferimento ad alcuni passaggi chiave di un’opera basilare
38 Giulio d’Onofrio
del suo fondatore, le Idee per una fenomenologia pura ed una fi losofi a fenomenologica di Edmund Husserl.
Verso la fi ne del secolo XIII il tedesco Teodorico di Freiberg, magister theologiae a Parigi dal 1296, esponente della scuola dome-nicana di area renana e testimone di un orientamento gnoseologi-co e metafi sico dissonante dalla condivisa ‘obbedienza’ tommasiana che caratterizza in quegli anni il suo Ordine, dedica un interessante, non facile scritto, intitolato De origine rerum praedicamentalium, a un esplicito programma di perfezionamento della gnoseologia pla-tonico-cristiana, della quale intende consolidare le istanze metafi si-che di fondo con un ricorso mirato agli strumenti speculativi col-laudati dall’aristotelismo. Con tale operazione egli si fa apertamente difensore, ispirandosi al modello del pensiero tardo-neoplatonico di Proclo, di una effi cace sintesi tra l’esemplarismo agostiniano e il realismo peripatetico, subordinando la conoscibilità della realtà extra-mentale alla capacità da parte del soggetto di recepirne quali connotati rappresentativi le condizioni ontologiche che ne giustifi -cano l’effettiva sussistenza: tali ‘modalità’ ontologiche sono appunto i praedicamentalia o le res praedicamentales, che sussistono soltan-to nell’incontro tra l’io che conosce e l’oggetto conosciuto, e sono dunque le determinazioni intelligibili che caratterizzano l’apparire delle cose nel pensiero25. Scopo dichiarato dell’operetta è indagare e chiarire «origo et ratio» delle res praedicamentales, ossia la fonte che le produce (origo) e la regola o condizione della funzione (ratio) che esse svolgono in quanto caratterizzano il modo di presentarsi delle cose conosciute all’intelletto umano. Sia il tema, sia il tipo di approccio che caratterizza questo intervento, non sono nuovi nel di-battito universitario parigino, ed è stata evidenziata una signifi cativa «familiarità», in particolare, tra la considerazione teodoriciana delle
25 Teodorico di Freiberg, De origine rerum praedicamentalium, ed. a c. di L. Stur-lese in Id. [Dietrich von Freiberg], Opera omnia, III (Corpus Philosophorum Teutoni-corum Medii Aevi), Hamburg 1983, pp. 135-201. Su Teodorico, cf. K. Flasch, Kennt die mittelalterliche Philosophie die konstitutive Funktion des menschlichen Denkens? Eine Untersuchung zu Dietrich von Freiberg, in «Kant Studien», 63 (1972), pp. 182-206; Id., Einleitung, in Dietrich von Freiberg, Opera omnia, cit., III, pp. XV-LXXXV; Id., Be-merkungen zu Dietrich von Freiberg, De origine rerum praedicamentalium, in Von Mei-ster Dietrich zu Meister Eckhart, hrsg. von K. Flasch (Beihefte zum Corpus Philosopho-rum Teutonicorum Medii Aevi, Beih. 2), Hamburg 1984, pp. 34-45; Id., Dietrich von Freiberg. Philosophie, Theologie, Naturforschung um 1300, Frankfurt am Main 2007; Recherches sur Dietrich de Freiberg, éd. J. Biard - D. Calma - R. Imbach, Turnhout 2009 (Studia Artistarum, 19).
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 39
res praedicamentales e l’insegnamento portato avanti su queste tema-tiche negli stessi anni da Enrico di Gand26.
Le res praedicamentales scaturiscono per Teodorico da una con-vergenza sintetica di contenuti empirici, consolidati in dati rappre-sentativi delle informazioni provenienti dall’esterno, e di forme men-tali o determinazioni categoriali poste dall’intelletto conoscente per organizzare tali dati in proiezioni universali. Alla composizione on-tologica tommasiana di essenza ed esistenza – nozioni, a suo parere, astratte e inadeguate a individuare nella res appropriate condizioni di intelligibilità – Teodorico contrappone dunque, richiamandosi al principio agostiniano dell’interiorità del conoscere, una composi-zione di condizioni esteriori e condizioni interiori, che implica una funzionalità produttiva dei modi dell’essere, in quanto conoscibile, da parte dell’intelletto che opera sull’informazione sensibile: nel co-struire i singoli percorsi della conoscenza, l’intelletto creato e parti-colare si fa quindi produttore e giudice della rappresentazione della cosa, reale proprio in quanto dotata di una specifi ca intelligibilità. Agostinismo e areopagitismo convergono con la metafi sica avicen-niana, l’emanazionismo procliano e le distinzioni epistemologiche dell’averroismo in questa che Teodorico presenta come l’autentica dottrina aristotelica della conoscenza: egli non nega il riconoscimen-to di una realtà effettuale delle cose, né rifi uta l’autenticità delle per-cezioni sensitive quali tramite per l’avvio di un contatto conoscitivo tra il soggetto e l’oggetto; attribuisce però alla più intima ed eleva-ta vis conoscitiva dell’anima (l’abditum mentis agostiniano) la fun-zione di accostarsi intenzionalmente alla primaria realtà essenziale (o eidetica) di tutte le cose nel Verbo e di costruire diversi percorsi scientifi ci, codifi cati proprio per essere adeguati a rappresentare tale realtà nel modo più effi cace per una creatura intelligente. Le scienze particolari sono dunque l’esito di una disposizione ancora prepara-
26 Cf. P. Porro, Res praedicamenti e Ratio praedicamenti. Una nota su Teodorico di Freiberg e Enrico di Gand, in Recherches sur Dietrich de Freiberg, cit., pp. 131-145. Pa-squale Porro, che ringrazio per avere generosamente arricchito la mia documentazione sul pensiero di Teodorico e per avermi aiutato a confrontarmi con la dottrina delle res praedicamentales, evidenzia il fatto che, con un preciso riferimento al dibattito teologico parigino sollecitato dalle rifl essioni di Enrico sul tema della predicabilità delle categorie aristoteliche in Dio, oggetto del trattato teodoriciano sono in particolare le determina-zioni categoriali successive a quelle della sostanza (che esprime la «ragione quidditati-va» della res) e della quantità e qualità (che esprimono ciò che «riguarda la sostanza in quanto funge da sostrato»): si tratta dunque, specifi camente, della predicazione di ciò che appartiene «alla categoria della relazione e, mediatamente, agli altri predicamenti relativi» (cf. ibid., pp. 138-139).
40 Giulio d’Onofrio
toria dell’intelletto fi nito (più in particolare dell’intelletto agente), nel suo aspirare a un congiungimento con le forme originarie, che sarà defi nitivo – come Teodorico stesso argomenta in un suo trattato De visione beatifi ca – soltanto nella fi nale partecipazione conoscitiva alla Sapienza divina promessa con la beatitudine27.
In uno degli ultimi capitoli del De origine, Teodorico si sofferma con maggiore insistenza sul tema della costruzione dei distinti saperi scientifi ci. Punto di partenza è la classifi cazione degli esseri («entia») in tre tipologie: 1) res rationis, realtà puramente formali conoscibili mediante operazioni di ordine razionale, e quindi, secondo la termi-nologia in voga nelle scuole a partire dalla fi ne del secolo XIII, res secundae intentionis28; 2) res naturae, puramente attuali nell’ordine fi sico-corporeo, del quale subiscono i condizionamenti e realizzano le potenzialità: sono soggette al moto naturale e contribuiscono a produrlo, e si chiamano res primae intentionis; 3) e infi ne enti inter-medi tra i primi due generi: sostanze o proprietà della sostanza che, pur essendo l’esito di una operazione formale dell’intelletto, sussi-stono però nell’ordine naturale, che esse stesse, venendo conosciute, introducono («important») nell’io: in quanto tali, sono anch’esse res primae intentionis. Dalla stessa defi nizione di questi tre ordini risulta evidente che per Teodorico non si tratta di tre classi ontologicamente distinte, ma di tre modi diversi di considerazione delle medesime en-tità, distinguibili in base al variare dell’approccio con cui il soggetto si accosta ad esse conoscendole («ratio differentiae quae attenditur in diversimode defi niendo»)29.
27 Teodorico di Freiberg, De visione beatifi ca, ed. B. Mojsisch, in Id., Opera omnia, I, Hamburg 1977. Cf. A.-S. Robin, L’antithomisme de Dietrich de Freiberg dans le De visione beatifi ca, in Recherches sur Dietrich de Freiberg, cit., pp. 165-191.
28 Cf. A. De Libera, La problé matique des ‘intentiones primae et secundae’ chez Die-trich de Freiberg, in Von Meister Dietrich zu Meister Eckhart, cit., pp. 68-94; D. Perler, Theorien der Intentionalität im Mittelalter, Frankfurt 2002, pp. 146-183.
29 Cf. Teodorico di Freiberg, De origine rerum praedicamentalium, 5, 59, ed. Stur-lese, p. 199, 618-629: «Patet igitur secundum praedicta, quod quaedam sunt entia, quae pure sunt res rationis, eo quod sunt a ratione, et simul cum hoc sunt formae habentes se ex parte rationis in rerum consideratione; et huiusmodi sunt simpliciter res secundae intentionis. Quaedam autem sunt entia, quae sunt pure res naturae, eo quod secundum id quod sunt, sunt secundum naturam et ab actu naturae, ut ea quae sunt alicuius natu-ralis motionis per se principia, ut substantia, qualitas et cetera. Quaedam autem quasi medio modo se habent: quantum enim ad id quod formaliter et principaliter signifi catur per nomen, sunt ab operatione intellectus, secundum rationem tamen alicuius naturae, quam important in suo intellectu, sive haec natura sit substantia, sive aliquid substantiae concretum; et ideo huiusmodi sunt etiam res primae intentionis ratione praedicta».
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 41
Sulla falsariga della già ricordata dottrina di Boezio nel primo degli opuscoli teologici30, questo variare dà origine per il maestro di Freiberg a tre diverse discipline del conoscere: la metafi sica (che nel catalogo boeziano è la terza, e si chiama ‘teologia’, ma nella quale è riconoscibile l’aristotelica fi losofi a prima), la fi sica e la matematica. 1) La scienza metafi sico-teologica (che Boezio denota come «immu-tabile, astratta e separabile») considera l’ente in quanto tale («ens in-quantum ens»), mirando alle sue caratteristiche essenziali, universali e inalterabili, e dunque alla sola causa formale del suo sussistere («se-cundum rationem suae quidditatis»), a prescindere da altri condizio-namenti causali in esso operanti (effi cienti, fi nali o materiali, secondo la quadripartizione aristotelica delle cause): tali caratteristiche sono dunque le proprietà eidetiche («medium demonstrationis», ossia principio e cuore, delle argomentazioni della metafi sica) che conno-tano la pura essenzialità della cosa («per essentiam»). 2) Nell’ordine delle res naturales, o res primae intentionis, invece, la scienza fi sica (secondo Boezio «non astratta e sempre mutevole») evidenzia, inver-samente, proprio il rapporto di operatività con cui molteplici cau-se naturali, effi cienti e fi nali, agiscono attualmente sulla cosa (intesa quindi come «substantia» cui ineriscono determinazioni accidenta-li), implicando sempre in essa anche l’operare del principio di deter-minazione particolare, ossia della causa materiale. 3) Il sapere mate-matico, infi ne, considera la medesima res che è oggetto del conoscere fi sico e di quello metafi sico-teologico, astraendo dal movimento e dalla materia, proprio come fa anche la metafi sica, ma la defi nisce non indicandone le proprietà formali che la caratterizzano in quanto ente, bensì collocandola all’interno di un genere determinato, che esclude la partecipazione ad altri generi e la sottopone alla dipenden-za dai principi che sono propri di quel genere e non di altri31. Questo
30 Cf. sopra, alla nota 10. 31 Cf. Teodorico di Freiberg, cit., 60-63, pp. 199, 630 - 200, 672: «Patet etiam,
secundum praedicta, ratio differentiae, quae attenditur in diversimode defi niendo apud metaphysicum, naturalem et mathematicum. Quia enim metaphysicus considerat ens in-quantum ens, quae consideratio est entis per essentiam secundum rationem suae quidi-tatis circumscriptis a re suis causis, tam effi cientibus quam fi nalibus, hinc est, quod solum defi nit proprie per causam formalem; quae defi nitio est medium demonstrationis dicens propter quid alicuius modi vel proprietatis non importantis circa substantiam vel generaliter rei essentiam aliquam rem naturae. (…) Non sicut in naturalibus, ubi de sub-stantia demonstratur aliqua res naturae, quam oportet per agens inesse subiecto: agens autem non facit huiusmodi rem in substantiam nisi in ordine ad aliquem fi nem. Igitur in naturalibus ad integritatem defi nitionis oportet concurrere cum forma rei causam effi cientem et fi nem. Et quia agens, quod agit determinatam naturam in determinato
42 Giulio d’Onofrio
signifi ca che mentre la metafi sica è scienza oggettiva delle essentiae in quanto tali, le scienze matematiche (per Boezio «astratte e immu-tabili, ma non separate») studiano le essentiae come esito dell’astra-zione da condizioni particolari ma pur sempre determinate secondo condizioni universali, condivise da altre essentiae dello stesso genere («considerat ens determinatis generis… ex propriis per se principi-is»): condizioni che sono loro imposte dall’intellectus umano, che le produce in quanto è agens su di esse («secundum determinationem intellectus agentis hunc modum essendi in eis»); così per esempio un triangolo è descritto dalla geometria come una fi gura piana compo-sta di tre lati e tre angoli, secondo una considerazione esclusivamente formale ma condivisa da altri esseri sempre classifi cabili in base ad essa; in metafi sica, invece, un triangolo è considerato esclusivamente come un ens caratterizzato in quanto tale da particolari condizioni formali oggettive, che non è necessario subordinare, con un ulteriore intervento dell’intelletto, alla condivisione da parte di altre essenze32.
La tripartizione boeziana è dunque rielaborata da Teodorico in una bipartizione: da una parte (a) le scienze che considerano la res come ens naturae: (a1) o in quanto condizionato dalla relazione con altri enti naturali con i quali condivide caratteri di ordine materiale, agente e fi nale (scienze naturali o fi siche); (a2) o in quanto, prescin-
subiecto ad determinatum fi nem, non agit nisi ex determinato subiecto vel materia, ideo et materia cadit in defi nitione naturali. (…) Mathematicus autem, quia abstrahit a motu et a materia, hinc est, quod nec materiam nec effi cientem nec fi nem in defi niendo concernit. Solum enim ea considerat, quae secundum rationem formae insunt, et defi nit et demonstrat solum per causam formalem».
32 Cf. ibid., 64-67, pp. 200, 676 - 201, 697: «Sed secundum hoc non videtur esse differentia inter metaphysicum et mathematicum. Uterque enim per causam formalem proprie considerat ea, quae insunt proprio subiecto per se. Sed dicendum, quod diffe-rentia est inter metaphysicum et mathematicum quantum ad duo, videlicet quantum ad subiectum et quantum ad modum subiecti. Metaphysicus enim considerat ens in-quantum ens et ea quae sunt entis per se sive secundum rationem partium entis sive secundum rationem proprietatum entis. Mathematicus autem considerat ens determinati generis, quod quidem, quamvis sit pars entis simpliciter, inquantum tamen ipsum con-siderat mathematicus, ratio entis in communi non descendit in ipsum ut partem eius, sed constat ex propriis per se principiis, sicut etiam se habent subiecta aliarum scientia-rum respectu metaphysicae, et ideo sunt scientiae distinctae a scientia metaphysicae. Differunt autem etiam metaphysica et mathematica in modo subiecti. Metaphysicus enim considerat ea quae insunt secundum rationem quiditatis et formae repertae apud naturam et habentis modum naturae. Mathematicus autem considerat ea quae insunt secundum rationem formae abstrahentis ab omni natura et principiis naturae secun-dum determinationem intellectus agentis hunc modum essendi in eis. Numquam enim metaphysicus defi niret triangulum, quod esset fi gura plana, habens unum angulum ex-trinsecum et cetera: non enim haec defi nitio convenit triangulo, secundum quod est ens naturae (…)».
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 43
dendo da tali caratteri, appare determinato da un condizionamen-to formale, ma condiviso con altre realtà appartenenti al suo stes-so genere e subordinate ai medesimi principi organizzativi (scienze matematiche); (b) dall’altra il sapere metafi sico, che considera la res come puro ens rationis, condizionato dal solo originario connotato essenziale (il suo quid). È allora possibile – e quanto mai suggesti-vo – rilevare, a distanza di secoli e senza un diretto rapporto testuale precisabile, il marcato parallelismo teoretico che emerge tra, da una parte, questa classifi cazione teodoriciana di scienze di res naturae e scienze di res rationis e, dall’altra, la distinzione tra (A) ‘scienze di dati di fatto’ (Tatsachenwissenschaften o Erfahrungswissenschaften), e (B) ‘scienze di essenze’ (Wesenswissenschaften), proposta da Hus-serl quale avvio fondativo della fi losofi a fenomenologica fi n dal pri-mo capitolo delle sue Idee.
Teodorico di Freiberg argomenta il ruolo produttivo di realtà svolto dal soggetto pensante attribuendogli una indispensabile ‘con-nessione’ di pensabilità tra la manifestazione individuale ed oggettiva della cosa e l’essenza corrispondente. Husserl presenta la fi losofi a fenomenologica come il criterio epistemologico in base al quale «ad ogni oggetto individuale appartiene uno stato essenziale come sua essenza, mentre ad ogni essenza corrispondono possibili individui, quali sue singolarizzazioni di fatto»: per cui le ‘scienze di essenze’ considerano le medesime realtà di quelle fatte oggetto dalle ‘scienze di dati di fatto’, ma facendo astrazione da ogni condizionamento le-gato all’ordine delle modifi cazioni esistenziali e sperimentabile attra-verso la sensibilità33. Quando Teodorico affi da la fondazione scien-tifi ca del sapere al conoscere metafi sico, che contempla la cosa in sé come essenza (ratio essentiae o ratio quidditatis), sembra dunque apertamente anticipare la considerazione delle ideale Möglichkeiten o Wesenverhalte (situazioni essenziali) che fonda per Husserl, al di là dell’esperienza che ne è pura causa occasionale, la conoscenza essen-
33 Cf. E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una fi losofi a fenomenolo-gica, I, I, 1, § 7, nuova ed. a c. di V. Costa, 2 voll., Torino 2002, vol. I, p. 23 [16]: «La connessione (essa stessa eidetica) che ha luogo tra un oggetto individuale e l’essenza (secondo la quale a ogni oggetto individuale appartiene una compagine essenziale come sua essenza, come viceversa a ogni essenza corrispondono possibili individui, quali sue singolarizzazioni di fatto) fonda un analogo rapporto tra le scienze di dati di fatto e le scienze di essenze. Ci sono scienze puramente eidetiche, come la logica pura, la matema-tica pura, le teorie pure del tempo, dello spazio, del moto, ecc. Esse, in tutti i loro pas-saggi, sono libere da qualunque posizione di dati di fatto; ovvero, che è lo stesso, in esse nessuna esperienza in quanto esperienza, cioè in quanto coscienza che afferra e quindi pone una realtà, un’esistenza, può avere una funzione fondamentale».
44 Giulio d’Onofrio
ziale (die Wesenserschauung)34. Husserl distingue inoltre le situazioni essenziali immediatamente afferrabili sulla base di un’intuizione intel-lettuale dei principi immediati corrispondenti (o «assiomi eidetici») da quelle che si producono attraverso una percezione intellettuale mediata, cioè per via apodittica, come «eideticamente necessarie»35: e quindi introduce una differenza tra la scienza puramente eidetica (B1), che appare corrispondere alla metafi sica di Teodorico (b), e le scienze eidetiche deduttive (B2), risultanti da «rapporti assiomatici», argomentativi e apoditticamente dedotti a partire da verità origina-riamente intuitive, come le scienze matematiche del maestro di Frei-berg (a2)
36. È infi ne anticipata nel De origine anche la subordinazione epistemica husserliana delle scienze di dati di fatto a quelle eidetiche, fondata sul fatto che solo le seconde offrono alle prime i fondamenti, sia formali, sia materiali, sui quali è organizzabile il sapere relativo ai dati in cui l’esperienza congela i caratteri prioritari dell’essere nella costrizione dell’esteriorità spazio-temporale37.
Di particolare interesse, una volta avviato tale confronto, appare soprattutto la possibilità, riservata allo storico della fi losofi a che leg-
34 Signifi cativo è che Husserl (ibid., pp. 23-24 [17]) abbia illustrato la sua distin-zione con l’esempio, simile a quello utilizzato da Teodorico, del «geometra» che disegna «delle linee esistenti di fatto sulla lavagna pure esistente di fatto», per portare l’intelli-genza a trarre da esse, una considerazione ‘puramente eidetica’ delle entità geometri-che, la cui produzione come fi gure implica una attività organizzativa dell’intelletto (che dunque, come in Teodorico, è agens nella misura in cui il conoscere è per esso, come si esprime Husserl, un «atto fondante»).
35 Cf. ibid., p. 24 [17]: «Gli stati di essenze che possono essere afferrati in maniera immediatamente evidente (gli assiomi eidetici) costituiscono il fondamento per afferrare quelli mediati, che si offrono al pensiero evidente mediato, e però procedendo secondo principî la cui evidenza è assolutamente immediata». Cf. le parole di Teodorico citate sopra, alla nota 32: «Ratio entis in communi (…) constat ex propriis per se principiis».
36 Cf. ibid., pp. 24-25 [17]: «Con ciò è in relazione l’ideale pratico di una scienza eidetica esatta, che soltanto la recente matematica ha mostrato di realizzare. Si tratta cioè di conferire a ogni scienza eidetica il più alto grado di razionalità riducendo tutti i pas-saggi mediati a semplici sussunzioni sotto gli assiomi del rispettivo territorio eidetico, i quali assiomi formano un sistema ordinato in maniera defi nitiva e sistematica e, qualora non si tratti sin dall’inizio della stessa logica ‘formale’ o ‘pura’ (nel senso latissimo della mathesis universalis), a questi assiomi bisogna aggiungere l’insieme degli assiomi della logica», ovvero, il che è evidentemente lo stesso, della mathesis universalis.
37 Cf. ibid., §9, p. 26 [19]: «Ogni concreta oggettualità empirica è subordinata con la sua essenza materiale a un genere materiale supremo, a una ‘regione’ di oggetti empirici. Alla pura essenza regionale corrisponde poi una scienza eidetica regionale o, come possiamo anche dire, una ontologia regionale. (…) Ogni scienza di dati di fatto (ogni scienza empirica) ha fondamenti teoretici essenziali in ontologie eidetiche». E cf. Teodorico di Freiberg, ancora nel passaggio citato sopra, alla nota 32: «Sicut etiam se habent subiecta aliarum scientiarum respectu metaphysicae».
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 45
ge e interpreta con attenzione nel testo originale le fonti speculative del Medioevo, di assicurare sul fondamento teologico dell’esempla-rismo cristiano il possesso di un utile criterio di certifi cazione per l’oggettività metafi sica degli esiti giudicativi del pensare eidetico: pos-sesso che è in verità più auspicato che assicurato da Husserl quan-do, nel secondo Libro delle Idee, si impegna nell’individuare per la costituzione eidetica del mondo una dimensione veritativa assoluta, che vada al di là dei limiti del solipsismo intellettuale e sia posta a so-stegno di una riconosciuta inter-soggettività dell’esperire conoscitivo autentico38.
Tanto nella prospettiva teologico-fenomenistica cristiana, quan-to in quella fenomenologica, il condiviso intendersi degli uomini sul valore degli enunciati scientifi ci non può in effetti essere affi dato a un insostenibile corrispondentismo tra l’operare della mente e i condi-zionamenti esteriori: la concordia intellettuale scaturisce invece solo dal porsi di una relazione armonica, tra le molteplici intelligenze, che assicuri all’apparire della cosa una connotazione ontologica extra-soggettiva, non subordinata alla singolarità dell’esperienza. In parole povere, il soggetto conosce in modo scientifi co, ossia universale e necessario, quando l’oggetto gli si manifesta come caratterizzato da condizioni che rendono possibile la condivisibilità di tale apprensio-ne; ossia con un riferimento – anche solo ipotetico ma condizionan-te – ad altri soggetti (reali o potenziali) che intendano lo stesso mon-do e si armonizzino tra loro, operando come comunità spirituale39.
È impressionante constatare come tale esigenza del condiziona-mento oggettivo e inter-soggettivo del conoscere, invocato da Hus-serl come presupposto indispensabile della fi losofi a fenomenologica, possa reperire una soluzione esaustiva nel principio dell’unifi cazione
38 Cf. Husserl, Idee, cit., II, I, 3, §18, f), vol II, pp. 81 sgg. [79 sgg.]39 Cf. ibid., p. 84 [82]: «Ciascuno dei soggetti che si intendono intersoggettiva-
mente a proposito dello stesso mondo e quindi a proposito di una stessa cosa, ha pro-prie percezioni di questa stessa cosa, ha proprie manifestazioni percettive, e in esse ha l’unità delle sue manifestazioni, un’unità che è a sua volta manifestazione soltanto in un senso superiore, che ha predicati nell’ordine delle manifestazioni, predicati, che non possono valere senz’altro come predicati della ‘vera cosa’ che si manifesta. (…) La ‘vera cosa’ è ora l’oggetto che si mantiene identico nelle molteplicità di manifestazioni di una pluralità di soggetti, è cioè l’oggetto intuitivo in riferimento con una comunità di soggetti normali». E ancora, ibid.: «Ciò che un soggetto conoscente conosce in modo logicamente obiettivo (…) può essere conosciuto da qualsiasi altro soggetto conoscente, purché siano rispettate quelle condizioni che ciascun soggetto che conosce questi oggetti deve osservare. Ciò signifi ca: questo soggetto deve esperire le cose e le stesse cose; se deve conoscere quest’identità dev’essere in un rapporto entropatico con l’altro soggetto conoscente, e perciò deve avere un corpo proprio e far parte dello stesso mondo, ecc.».
46 Giulio d’Onofrio
del pensiero eidetico, limpidamente indicato nelle parole Giovanni Scoto Eriugena da cui abbiamo preso le mosse quale criterio del co-noscere condivisibile non solo da tutti gli intelletti umani, ma an-che da intelletti diversamente operanti per natura, come l’umano e l’angelico, tanto da farli divenire, operando, un «unus intellectus» guidato dal solo condizionamento causale delle forme essenziali che non mutano. Soltanto nella prospettiva dell’esemplarismo teologico cristiano, tuttavia, è evidente come tale unifi cabilità del conoscere sia assicurata (per i credenti) dal postulato del sussistere della suprema verità eidetica nel Verbo divino, al cui pensare possono e devono ade-rire gli intelletti fi niti: i quali in tanto possono armonizzare e unifi ca-re i loro limitati e potenziali procedimenti, in quanto li assimilano, a seconda delle loro capacità, all’eterna perfezione eidetica in atto del conoscere creativo divino40. Sia rispetto al fenomenismo neoplato-nico classico, sia nei confronti della fenomenologia contemporanea, la teologia cristiana medievale (in base ad un presupposto fi deistico, che in quanto tale è, per chi lo fa proprio, indiscutibile e inconfuta-bile) gode quindi, come di un privilegio, della certezza pregiudiziale del sussistere reale della verità essenziale incontaminata, principio di conoscibilità per ogni cosa che ne è derivata e ne partecipa.
L’ammissione dell’esistenza e della funzione epistemica origina-ria delle realtà-essenze eterne (idee, volontà o ragioni divine, cause, archetipi o forme primordiali), non è mai per la mente medievale un problema da sciogliere. Lo è semmai la questione, variamente risol-vibile e di fatto variamente risolta, su possibilità, entità e modalità di un effettivo ricorso ad esse quali principi della vera conoscenza da parte dell’intelletto creato in questa vita: come sta a dimostrare, nel-le sue tortuose applicazioni e soluzioni, il prolungato e contrastato evolvere nel corso dei secoli della problematica sulla sussistenza e conoscibilità dei cosiddetti ‘universali’. Ed è stato sintomo signifi ca-tivo di tale problematicità il variare continuo, all’interno del comune modello speculativo o paradigma medievale del sapere (che consiste nella preliminare ammissione di veridicità per la religione cristia-na), dei singoli paradigmi particolari a favore dei quali, di scuola in
40 Cf. Agostino di Ippona, Confessiones, XII, 25, 35, PL 32, 840, ed. Verheijen cit. (alla nota 5), p. 235, 33-36 (brano esplicitamente invocato come autorità da Tommaso d’Aquino nel s. c. del già ricordato a. 5 della q. 84 della prima Parte della Summa): «Si ambo videmus verum esse quod dicis, et ambo videmus verum esse quod dico, ubi, quaeso, id videmus? Nec ego utique in te, nec tu in me; sed ambo in ipsa, quae supra mentes nostras est, incommutabili Veritate».
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 47
scuola, di corrente in corrente, fi losofi e teologi hanno optato per attingere le strumentazioni indagative ritenute adeguate per portare a compimento la loro ricerca della verità41.
Ma l’intera civiltà cristiana, la cui compattezza culturale si è ori-ginata sul principio carolingio dell’unanimitas ideologica (a un tem-po religiosa, politica, etico-culturale), è sempre stata caratterizzata, fi no al suo dissolversi nelle spaccature dell’età moderna, dalla certez-za che al di là di confi ni terreni, diversità di abitudini, consuetudini, costumi, razze e tradizioni, leggi etiche e sociali, convinzioni o pre-sunzioni religiose, non ci sia intelletto umano, correttamente operan-te, che sia incapace di ri-conoscere e sapere che uno e uno è due, due e due sono quattro, due e quattro sono sei; oppure di ammettere che se sono vere le due premesse di un sillogismo corretto, è necessaria-mente vera anche la conclusione. Le nozioni elementari della logica ‘pura’ e della matematica ‘pura’ – come il giovane Agostino, in cerca di ragioni appaganti per la sua sete fi losofi ca di sapere, intuisce fi n dalla stagione aurorale dell’era del pensare cristiano42 – assicurano ai sapienti che qualcosa di necessario e di vero sussiste; e questi stessi sapienti informati dalla razionalità, se si lasceranno ammaestrare an-che dalla fede, ammetteranno che, se qualcosa di necessario e di vero sussiste, l’unica spiegazione possibile è che sussista in Dio, e che Dio, conoscendolo, lo faccia sussistere. E, conseguentemente, che non si può, e non si potrà mai negare il titolo di veridicità, a qualsiasi lati-tudine, in qualsiasi momento della storia degli uomini, a un sapere elaborato in modo tale da risultare dotato della stessa universalità e della stessa indubitabilità di tali nozioni.
Il contributo che una attenta rifl essione su queste condizioni del pensare medievale potrebbe recare oggi ad un perfezionamento del pensiero eidetico contemporaneo viene proprio da tale particolare connotazione teoretica che è anche la sua peculiarità storica: l’ave-re fondato solidità e certezza delle indagini scientifi che umane sul
41 Su questo argomento cf. il volume miscellaneo The Mediaeval Paradigm, Reli-gious Thought and Philosophy, Papers of the International Congress (Rome, 29 october - 1 november 2005), ed. by G. d’Onofrio, Brepols, Tournhout 2011 (Nutrix, 4), in corso di stampa.
42 Cf. Agostino di Ippona, Contra Academicos, III, 10, 23 - 13, 29, PL 32, 945-949, ed. W.M. Green, Turnhout 1970 (CCSL 29), pp. 48-52; in partic. cf. ibid., 11, 25, 947, p. 49, 30-32: «Si autem unus et sex mundi sunt, septem mundos esse, quoquo modo affectus sim, manifestum est, et id me scire non impudenter affi rmo»; e ibid., 13, 29, 949, p. 52, 18-20: «Docuit me [dialectica], si cuius eorum quae per connexionem modo proposui pars antecedens assumpta fuerit, trahere necessario id, quod annexum est».
48 Giulio d’Onofrio
presupposto indimostrabile della sussistenza eterna del vero nella perfezione dell’«intellectus omnium», che è tutte le cose43. Assumere come attuale e operante tale postulato teoretico assicurerebbe in ef-fetti, oggi come nel passato, la garanzia della comunicazione e della condivisione inter-soggettiva degli esiti produttivi del conoscere, in quanto la coerenza dei processi intellettuali umani, al di là di tutte le diversifi cazioni e condizioni particolari, ne risulterebbe certifi cata dalla loro specularità velata rispetto al mistero originario dell’essere, che il pensare eidetico è atto a rendere conoscibile anche se, appun-to, solo «per speculum» e «in aenigmate». L’invito al perfezionamen-to della ricerca del vero che può scaturire da tale modello specula-tivo per gli uomini del ventunesimo secolo non si risolve tuttavia in un appello rivolto ai fi losofi perché si affi dino nuovamente – in un modo che risultebbe anacronistico e ascientifi co (unwissenschaft-lich) – alla pregiudiziale regola della concordia tra ragione e fede che accompagna la speculazione cristiana in tutta la sua storia. Si tratta semmai di accertare il potenziale e universale vantaggio che per la mente umana potrebbe discendere da tale presupposto, se assunto, anche solo per ipotesi funzionale, come vero. Una fi losofi a fenome-nologica che accettasse di orientarsi in tutti i suoi percorsi come se fosse collocata all’interno di un quadro speculativo corrispondente a quello universalmente condiviso dai sapienti cristiani del Medioevo, ossia ammettendo, sia pure solo strumentalmente, ma come principio fondativo (e indiscutibile) di ogni sua indagine, la sussistenza eide-tica del vero nella immutabilità onnisciente di un libero e causativo Pensiero divino, potrebbe trovare in questo ‘atteggiamento’ specula-tivo una giustifi cazione e, insieme, una spinta, un impulso risolutivo per la ricerca delle condizioni che il soggetto deve osservare quando si impegna per esperire oggettivamente la realtà delle singole datità empiriche. L’empatia tra i singoli soggetti potrebbe risultare meglio perseguibile presupponendo il fi ssarsi di un rapporto di armonizza-zione della singola intenzionalità non con altre singole soggettività ‘normali’, potenzialmente variabili e non universalmente verifi cabili, ma con l’intendere immediato della totalità del vero e della sua asso-lutezza, quale è ammissibile, anche solo per ipotesi strumentale, in un Intelletto divino.
Un sapere di questo genere sarebbe una autentica «Wesenswis-senschaft», la cui complessa veridicità sarebbe ulteriore rispetto ad
43 Cf. sopra, alla nota 7.
Fenomenismo medievale e pensiero eidetico 49
ogni modalità di conoscere condizionato da connotazioni non essen-ziali. Suo oggetto sarebbe il mondo inteso come totalità dei dati me-diante i quali il fondamento ontologico si manifesta alla limitatezza dello sguardo umano; ma al di sopra della parziale raccolta di dati oc-casionali, affi data al senso comune, e procedendo a partire da essa, il progetto di un sapere eidetico assimilato formalmente al modello della «vera philosophia» cristiana medievale supererebbe le imperfezioni dell’autoreferenzialità dello stile di vita ‘mondano’ (o ‘secolare’), che giustifi ca realtà esteriori con realtà esteriori, avviando un processo di elevazione intenzionale dell’anima dall’ingannevolezza autolimitativa dei fenomeni alla considerazione delle forme più alte del vero.
Come afferma la Filosofi a personifi cata nel quinto libro della Consolatio di Boezio, se l’uomo potesse partecipare dell’intelligenza in modo perfetto, allora capirebbe che la verità di ogni cosa risie-de nella perfezione onnicomprensiva e incondizionata del giudizio divino: alla cui pienezza egli può, e dunque deve tentare di ergersi, aspirando a cogliere con lo sguardo dell’Assoluto l’armonico ordine del reale cui il riduttivo occhio della particolarità non può neanche aspirare44. Nell’impossibilità di assurgere a tale scienza superiore, il fi losofo può tuttavia (e forse deve) ammetterne la possibilità. E sfor-zarsi di immettere i propri percorsi mentali, nella misura in cui ne è capace, nel solco di una metodica ricerca di armonicità con essa (o con quello che essa potrebbe essere). Questo modo di rapportarsi alla verità è possibile non soltanto al credente, ma a qualsiasi uomo dotato di razionalità (quale già presenta se stesso Boezio nella paga-nizzante cornice fi losofi ca della Consolatio): perché per il consegui-mento dell’empatia tra i soggetti del pensare eidetico è indispensabi-le non tanto l’ammissione convinta, di ordine fi deistico-dogmatico (e quindi non fi losofi ca), dell’esistenza di un Dio pensante e provviden-te che assicuri una referenzialità sopra-mondana alle verità particola-ri, quanto l’opportuna e fruttuosa regolamentazione epistemica che segue già ad una pura adesione formale a tale possibilità.
44 Cf. Severino Boezio, Consolatio Philosophiae, V, 5, 11-12, PL 63, 855D-856A, ed. Moreschini (cit. alla nota 10), p. 154, 44-48: «Si igitur, uti rationis participes sumus, ita divinae iudicium mentis habere possemus, sicut imaginationem sensumque ratio-ni cedere oportere iudicavimus sic divinae sese menti humanam submittere rationem iustissimum censeremus. Quare in illius summae intelligentiae cacumen, si possumus, erigamur: illic enim ratio videbit quod in se non potest intueri».