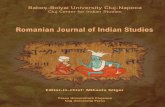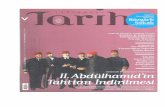Elena nella notte della presa di Troia: dall'Iliupersis all'Eneide
Transcript of Elena nella notte della presa di Troia: dall'Iliupersis all'Eneide
Aevum Antiquum N.S.9 (2009), pp. 109-139
Carlo Brillante
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE
Tra i numerosi episodi che segnarono la presa di Troia da parte degli Achei l’incontro di Elena e Menelao dopo dieci anni di guerra costituiva un episo-dio tradizionale, con il quale ogni poeta che avesse narrato questi fatti doveva misurarsi. Conosciamo da varie testimonianze lo svolgimento generale degli eventi, ma non disponiamo di una versione poetica risalente a età arcaica. Per avere un’idea, anche solo approssimativa, delle versioni più antiche, sarà necessario da un lato integrare i pochi dati pervenutici con quelli ricavabili dalle rappresentazioni figurate, abbastanza numerose per l’età arcaica e classi-ca, dall’altro esaminare la testimonianza di autori più recenti – come Virgilio, Quinto Smirneo e Trifiodoro – che queste composizioni ripresero più o meno liberamente. Le considerazioni che seguono, beninteso, non intendono ripro-porre vecchi problemi e metodi adoperati in passato da una Quellenforschung dagli esiti inevitabilmente dubbi (soprattutto in una materia come quella del mito greco), ma riesaminare i frammenti e le testimonianze in rapporto a quanto sappiamo dall’insieme dei dati giunti fino a noi sui medesimi eventi.
Nella versione che può essere considerata la più antica fra quelle per-venuteci – la Iliupersis di Arctino di Mileto – gli eventi dovevano presentare uno svolgimento abbastanza lineare: conquistata la città, Menelao uccideva Deifobo e riconduceva Elena alle navi: Menevlao de; ajneurw;n Elevnhn ejpi; ta; nau katavgei, Dhi?fobon foneuvsa1. Né la notizia di Proclo né i frammenti permettono di integrare questo dato con altri elementi. Se diamo peso al termine ajneurwvn possiamo ritenere che, dopo l’uccisione di Deifobo, Menelao andasse alla ricerca di Elena e che essa per timore fuggisse2. Questo episodio ricorre, con poche variazioni, in numerose rappresentazioni figurate
1 Ilii Exc. p. 88, 14 s. B. Cf. [Apollod.], Ep. V 22: Menevlao de; Dhivfobon kteivna Elevnhn ejpi; ta; nau a[gei.
2 In tal senso intende, ad esempio, Vian 1959, p. 74. In Quinto Smirneo Elena fugge dopo che Menelao ha ucciso nel suo letto Deifobo appesantito dal vino; essa si nasconde nelle case e qui viene trovata da Menelao (XIII 385 ss.: ojye; de; dh; Menevlao ejni; mucavtoisi dovmoio || eu|ren eJh;n paravkoitin uJpotromevousan oJmoklhvn || ajndro; kouridivoio qrasuvfrono). Nell’Elena di Euripide Teucro afferma di aver visto, nella notte della presa di Troia, Menelao condurre Elena dopo averla afferrata per i capelli: Menevlao aujth;n h\g’ ejpispavsa kovmh (v. 116). Il gesto, che ha il significato di una presa di possesso, ricorre in varie rappresentazioni (Ghali-Kahil 1988, nn. 358, 367, 368, 369, 370, 371) e potrebbe risalire all’Iliupersis (Kannicht 1969, ad loc.), ma per il poema ciclico non abbiamo un’attestazione esplicita.©
201
3 V
ita
e Pe
nsie
ro /
Pub
blic
azio
ni d
ell’U
nive
rsit
à C
atto
lica
del S
acro
Cuo
re
110 CARLO BRILLANTE
(principalmente vascolari), di età arcaica e classica, nelle quali si distinguono tradizionalmente due modelli: nel primo Menelao, con armatura completa, va incontro a Elena minacciandola con la spada; nel secondo l’eroe trascina la donna afferrandola per il polso secondo lo schema tradizionale del ceir ejpi; karpw, mentre con la destra la minaccia con la spada3. Spesso Menelao è accompagnato da un altro guerriero, probabilmente Odisseo, che nella notte della presa di Troia lo accompagnò nell’assalto alle case di Deifobo (Od. VIII 516-520). Un’azione di questo tipo era rappresentata sull’arca di Cipselo: Menevlao de; qwvrakav te ejndedukw; kai; e[cwn xivfo e[peisin Elevnhn ajpokteinai, dhla wJ aJliskomevnh Ilivou4.
In questa versione più antica Elena, dopo la morte di Paride, aveva spo-sato in terze nozze Deifobo. Questo dato è presupposto da alcuni passi dell’Odissea, anche se della loro autenticità dubitavano già gli alessandrini. Nel racconto che Menelao fa a Telemaco in occasione del viaggio a Sparta, Elena è seguita da Deifobo quando si avvicina al cavallo di legno e imita le voci delle spose degli Achei (IV 274-279). Successivamente, nel canto che Demodoco, su richiesta di Odisseo, dedica al cavallo di legno e alla presa di Troia, si afferma che attorno alle case di Deifobo i Troiani opposero una fiera resistenza. Qui si dirigono Odisseo e Menelao nell’assalto finale (VIII 514-520):
h[eiden d wJ a[stu dievpraqon ui|e AcaiwniJppovqen ejkcuvmenoi, koilon lovcon ejkprolipovnte.a[llon d a[llh a[eide povlin kerai>zevmen aijphvn,aujta;r Odussha proti; dwvmata Dhi>fovboiobhvmenai, hju?t Arha, su;n ajntiqevw Menelavw.keiqi dh; aijnovtaton povlemon favto tolmhvsantanikhsai kai; e[peita dia; megavqumon Aqhvnhn.
3 Per questo, come per gli altri episodi che saranno esaminati più avanti, si rinvia al catalogo di Ghali-Kahil 1988; per le rappresentazioni riconducibili all’Iliupersis vd. nn. 291-319. Importante resta anche la precedente accurata rassegna: Ghali-Kahil 1955 (per l’Iliupersis vd. pp. 99-113), per la quale si veda la recensione di Clairmont 1959. Al tema del ricupero di Elena ha dedicato un ampio studio Clement 1958, con vari interventi critici sulla raccolta di Ghali-Kahil. Un’analisi che muove dalla tipologia delle immagini è stata proposta più recentemente da Hedreen 1996. Questo studio pone giustamente in guardia dalla tendenza a riportare episodi noti dall’arte figurata a determinate versioni poetiche (o anche prosastiche), secondo un metodo di cui un tempo si è abusato (anche in ambito filo-logico), anche se oggi appare decisamente superato. Di notevole interesse è il tentativo di valorizzare il contesto e la tipologia delle immagini. Meno persuasivo appare invece il tentativo di riesaminare le versioni di età arcaica e classica privilegiando un criterio essenzialmente classificatorio, con riferimento a un’unica ‘storia di Elena’ (p. 156, passim). Del medesimo autore si veda anche il più recente volume dedicato all’esame delle rappresentazioni figurate di vari episodi della guerra di Troia (Hedreen 2001). Sulla figura di Elena circolavano, già in età arcaica, storie diverse, e per quanto in passato si sia abusato nel ricondurre le rappresentazioni figurate a modelli letterari, non abbiamo motivo di dubitare che esse si ispirassero a versioni diverse del mito. Sul tema vd. anche Dipla 1997, Anderson 1997, pp. 202-206.
4 Paus. V 18, 3. Ghali-Kahil include l’episodio tra quelli ispirati dalla Piccola Iliade (Ghali-Kahil 1955, p. 72, n. 25; ead. 1988, n. 226). Tra le rappresentazioni più antiche dell’episodio va ricordata la stele di Sparta (580-570 a.C.), con la doppia rappresentazione di Menelao che minaccia Elena su un lato e la coppia riappacificata sull’altro: Ghali-Kahil 1955, p. 71, n. 24; ead. 1988, n. 230; Ahlberg-Cornell 1992, p. 80. Eccessive le riserve di Clement 1958, p. 72, nota 144 sull’identità dei personaggi.
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 111
Quale figlio di Priamo e successore di Ettore alla guida dell’esercito troiano, Deifobo svolgeva un ruolo rilevante nell’ultima fase della guerra. La resistenza opposta agli Achei e la sua morte dovevano costituire un episodio importante nella conquista della città; ma su questo punto siamo scarsamente informati, né possiamo integrare i dati letterari con le rappresentazioni figurate, poco significative e modeste di numero. Soprattutto quelle riferibili all’Iliupersis, di particolare importanza per il nostro tema, sono di interpretazione molto dubbia5. Tanto più notevole sarebbe, in tale contesto, la presenza dell’eroe su una metopa del lato settentrionale del Partenone, dove erano rappresentati episodi della presa di Troia. Forse Deifobo era qui rappresentato già morente, dopo il combattimento con Odisseo e Menelao, non lontano dalle due meto-pe raffiguranti l’incontro di Elena con Menelao6.
Alcuni scoli aristarchei all’Odissea negano che in Omero Deifobo fosse lo sposo di Elena e attribuiscono questa versione ai newvteroi. Come già vide Severyns, la critica aristarchea intendeva distinguere la versione omerica da
5 Vd. Ghali-Kahil 1986, nn. 19-25. Rappresentazioni di Deifobo riferibili al momento della presa di Troia sono rare e di incerta interpretazione. In un notevole skyphos a figure rosse del pittore di Triptolemos (n. 24) l’eroe (se questo è il personaggio rappresentato) fugge dinanzi a Elena incalzata da Menelao: vd. Knauer 1973, pp. 14 s.; Hedreen 1996, pp. 173-175; id. 2001, pp. 50-53 (con discussione e ulteriori rinvii); ma l’interpretazione resta dubbia: cf. Ghali-Kahil 1986, n. 24; Robertson 1995, pp. 434-436. Nel noto pithos a rilievi di Micono (675 a.C. circa) Deifobo è stato riconosciuto nel personaggio colto nell’atto di cadere con la sua armatura; ha già indossato l’elmo, ma non ha ancora imbracciato lo scudo, mentre la spada è nel fodero. La vistosa ferita al collo implica una morte violenta: Christiansen 1974. Altri preferiscono vedere in questa figura Echion, il primo degli Achei discesi dal cavallo e che morì nella caduta ([Apollod.], Ep. V 20): vd. Ervin-Caskey 1980; Ghali-Kahil 1986, n. 25. Questo è però un evento secondario, mentre sul vaso sono rappresentati personaggi ed episodi di primo piano nella conquista della città. Cf. Lambrinudakis 1986; Ahlberg-Cornell 1992, p. 78; Anderson 1997, pp. 189 s.; Brillante 2002, p. 104 e nota 81. Per una possibile presenza di Deifobo nelle rappresentazioni vascolari vd. anche Ghali-Kahil 1955, pp. 73 s., Pl. XLIV 2; p. 102, Pl. XLIII bis 2 (giovane con mantello in scene che rappresentano l’incontro di Elena con Menelao); inoltre l’anfora a figure nere di Lydos, con Iliupersis (550 a.C. circa): disteso ai piedi di Neottolemo che aggredisce Priamo seduto su un altare si trova un guerriero caduto; ma l’identificazione con Deifobo è incerta: vd. Robert 1881, pp. 60 s.; Clement 1958, p. 63, n. 88 (favorevoli); Ghali-Kahil 1986, n. 20 (contraria). Una più probabile rappresentazione dell’eroe è quella di una coppa a figure rosse con l’incontro di Elena e Menelao (500 a.C. circa): ai piedi di Menelao che, armato, avanza verso Elena che gli tende le braccia, giace un guerriero caduto: Deifobo? (Ghali-Kahil 1988, n. 228).
6 Deifobo potrebbe essere rappresentato sulla metopa nord n. 21: vd. Berger 1986, p. 33; Ghali-Kahil 1986, p. 366. L’incontro di Elena con Menelao era rappresentato nelle metope nord 24 e 25: Ghali-Kahil 1988, n. 283; ead. 1955, pp. 91 s.; Pl. LXV 2, 3. Il riconoscimento dell’episodio del ritrovamento di Elena risale a Michaelis 1871, p. 139. I due guerrieri della metopa 24 sono verisimilmente Odisseo e Menelao, secondo quanto si afferma nell’Odissea. La metopa 25 rappresenta Elena che fugge dinanzi all’aggressione mentre con la sinistra tocca il Palladio. Tra i due gruppi si frappone Afrodite; la dea reca sulla spalla un piccolo Eros che si volge a Menelao. Come in altre rappresentazioni essa interviene in un momento decisivo a placare la collera dell’eroe. È improbabile che la statua cui si rivolge Elena sia quella di Afrodite armata, secondo quanto propone Berger (1986, pp. 38 s.), il quale esclude una protezione di Elena da parte di una divinità a lei ostile come Athena. Ma anche in altre rappresentazioni Elena è soccorsa da questa divinità (ad esempio Ghali-Kahil 1988, n. 250). Essa di fatto cerca rifugio nel luogo più sicuro, che Menelao non può violare, a prescindere dalla divinità venerata. La presenza del Palladio sembra indicare che gli eventi si svolgevano nel palazzo di Priamo o in quello di Deifobo, secondo quanto si afferma nell’Odissea. Cf. Schwab 2005, pp. 184-186. Hedreen 1996, pp. 171 s. ha fatto notare che un’Afrodite armata non appartiene all’iconografia del secolo V.
112 CARLO BRILLANTE
quella della Piccola Iliade. È in questo poema, infatti, come apprendiamo dal sunto di Proclo, che Elena sposava Deifobo dopo la morte di Paride (meta; de; tauta Dhivfobo Elevnhn gamei)7. Mancando un esplicito richiamo alle nozze, Aristarco riteneva che questa versione fosse da attribuire ai newvteroi e che dopo la morte di Paride Elena fosse solo affidata a Deifobo, per il suo valore e in quanto capo dell’esercito troiano: … ajlla; strathgo; meta; tou Ektoro qavnaton gevgonen oJ Dhi?fobo ajlkimwvtato w]n twn Priamidwn. La versione della Piccola Iliade si distingueva, tuttavia, per un altro elemento destinato a notevole fortuna in età successiva. Da uno scolio alla Lisistrata di Aristofane – nostro unico testimone – apprendiamo che Menelao, dopo la conquista della città, intendeva vendicarsi della sposa, ma che lasciava cadere la spada alla vista del seno della donna8:
oJ gwn Menevlao ta Elevna ta; malav pagumna parauidw;n ejxevbal’, oijw, to; xivfo.
Schol. ad loc.: hJ iJstoriva para; Ibuvkw: ta; de; aujta; kai; Levsch oJ Purraio ejn th mikra Iliavdi: kai; Eujripivdh
ajll, wJ ejseide masto;n, ejkbalw;n xivfofivlhm ejdevxw (Andr. 629 s.).
La versione della Piccola Iliade, giuntaci anch’essa senza ulteriori dettagli, rie-laborava in modo fantasioso il momento dell’incontro degli sposi dopo una separazione almeno decennale. Successivamente fu ripresa in un ditirambo di Ibico. Su questo punto siamo meglio informati da alcuni scoli all’Andromaca di Euripide. Elena si rifugiava nel tempio di Afrodite e da questa posizione protetta intratteneva un dialogo con Menelao; sedotto dalla sua bellezza, que-sti alla fine rinunciava ai suoi fieri propositi e lasciava cadere la spada:
a[meinon wjikonovmhtai toi peri; Ibukon: eij ga;r Afrodivth nao;n katafeuvgei hJ Elevnh kajkeiqen dialevgetai tw Menelavw, oJ d uJp e[rwto ajfivhsi to; xivfo. – MNO ta; paraplhvsia <touvtoi kai; Ibuko oJ suppl. Schwartz> Rhgino ejn diquravmbw fhsivn – M9.
7 Il. Parv., p. 74, 10 B.; schol. Od. VIII 517; Severyns 1928, pp. 334-337; cf. Robert 1923, p. 1263. I newvteroi, che nello scolio sono chiamati metagenevsteroi, avrebbero preso spunto dal v. 517 del canto IV, dove sono menzionati i dwvmata Dhi>fovboio. Le medesime riserve erano espresse dallo scolio a Od. IV 276, dove si fa menzione di Deifobo che accompagna Elena in occasione dell’‘inganno delle voci’ (kai; ei[h a]n ejgkeivmeno uJpo; twn iJstorouvntwn trivton Dhi?fobon gegamhkevnai th;n Elevnhn).
8 Schol. Aristoph. Lys. 155 a (= Il. Parv. fr. 19 B.). La notizia sulla Piccola Iliade è tramandata dal solo codice Laurenziano di Aristofane.
9 Schol. Eur. Andr. 630 (= PMGF fr. 296 D.). L’episodio è riferito più brevemente anche da uno scolio alle Vespe di Aristofane (v. 714). Un riesame dello scolio all’Andromaca nel codice marciano 471 ha permesso di ricuperare parte del nome del poeta: ... Ibu>ko Rhgino (con esclusione dell’articolo integrato da Schwartz): vd. Cingano 1992, pp. 215 s. e n. 91 («le tracce che precedono o sono compatibili con kappa»). In alcune rappresentazioni figurate Elena sembra incontrare Menelao non in un tempio (di Afrodite, Apollo, più raramente Athena), ma all’interno delle case, che possono
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 113
Complessivamente si ricava un quadro abbastanza coerente, pur nella scar-sezza dei dati. In particolare non vi è motivo di dubitare della presenza del motivo erotico già in questa fase più antica. Lo scolio laurenziano alla Lisi-strata lo ammette esplicitamente, mentre quello all’Andromaca euripidea non lo esclude, anche se per brevità non ne fa menzione, limitandosi a osservare che Ibico seguiva la medesima versione euripidea. L’espressione tramandata nel solo codice marciano (ta; paraplhvsia… ejn diquravmbw fhsivn) qualun-que sia la sua origine, non è in dissenso con quanto affermato in precedenza (a[meinon wjkonovmhtai toi peri; Ibukon), come talvolta si è ritenuto, ma ribadisce che il poeta seguiva in linea generale una versione non diversa da quella euripidea10. L’episodio ebbe poi una certa fortuna nel teatro attico, come mostra la ripresa euripidea dell’Andromaca (vv. 629 s.) e quella aristofa-nea della Lisistrata (vv. 155 s.).
Non è agevole, date le notizie pervenuteci, individuare gli elementi del racconto che decretarono la fortuna di questa versione. Il primo degli scoli citati all’Andromaca (MNO) offre un indizio notevole: l’espressione a[meinon wjkonovmhtai toi peri; Ibukon spiega che l’episodio era trattato in forma più compiuta nella poesia di Ibico, che su questo punto doveva co-stituire un modello. Il fatto che Elena trovasse rifugio in un tempio poneva un freno all’irruenza di Menelao, che rispettava la sacralità del luogo. Ciò rendeva l’episodio più elaborato perché imponeva un confronto affidato alla parola (kajkeiqen dialevgetai tw Menelavw)11, quindi il raggiungimento
essere quelle di Deifobo o di Priamo: così probabilmente nello skyphos del pittore di Triptolemos, dove l’episodio era probabilmente ambientato nelle case di Deifobo (Knauer 1973, pp. 14 s.; cf. Hedreen 1996, p. 175; id. 2001, p. 53). Nello skyphos di Makron (Ghali-Kahil 1988, n. 243) l’episodio si svolge probabilmente nel palazzo di Priamo (Hedreen pp. 177 s.; id. 2001, pp. 55-57). Non credo, tuttavia, che queste rappresentazioni siano da riferire a un momento precedente della storia, quando Menelao scopriva Elena per la prima volta. Più probabilmente sono riconducibili a una diversa versione: presuppongono che Elena, non avendo avuto il tempo di mettere in atto la fuga, si trovi ancora nelle case dello sposo o del suocero. Forse questo era lo svolgimento degli eventi nelle versioni più antiche, ad esempio nell’Iliupersis, dove forse si poneva in rilievo il tentativo della donna di nascondersi (supra, nota 2). La fuga e la riappacificazione (nei pressi o all’interno di un tempio) erano invece propri delle versioni di Stesicoro e di Ibico.
10 Si veda l’apparato di Schwartz («ita suppleui ut hoc scholion breuior repetitio sit eius quod praecedit»). Egli valorizzava giustamente il fatto che solo lo scolio del codice marciano dà notizia che la celebre composizione di Ibico era un ditirambo; cf. Cingano 1992, p. 216, con puntuale richiamo a Meijering 1987, p. 187. La testimonianza dello scolio alla Lisistrata fu messa in dubbio da Robert 1881, pp. 77 s., secondo il quale lo scolio intendeva semplicemente affermare che Lesche, Ibico ed Euripide seguivano la medesima versione nel presentare Menelao che lasciava cadere la spada alla vista di Elena; egli trovava conferma a questa tesi nello scolio all’Andromaca, dove non si fa menzione del motivo erotico. Euripide avrebbe quindi ripreso questo motivo dalla Piccola Iliade (cf. tuttavia Robert 1923, pp. 1263 s., dove il giudizio è diverso). Dubbi sulla presenza del motivo erotico in testi anteriori al secolo V sono espressi in vari studi, che valorizzano tra l’altro il presunto contrasto attestato dallo scolio all’Andromaca tra la versione di Ibico e quella di Euripide: vd. Löwy 1912, p. 285; Ghali-Kahil 1955, pp. 31, 42, che ipotizza un’origine del motivo dalla pittura, Clement 1958, pp. 47-51, Hedreen 1996, pp. 158-161; Hedreen 2001, pp. 34-7; Dipla 1997, pp. 125 s.; cf. Cavallini 1997, pp. 150 s. Va considerata, in ogni caso, l’importante testimonianza del pithos di Micono e della coppa del tipo di Siana: vd. infra, pp. 115 s.
11 Il fatto che l’episodio fosse trattato in un ditirambo è indizio che il confronto era affidato a un dialogo tra i coniugi, come avveniva nei ditirambi 17 e 18 di Bacchilide. Resta incerto invece se quanto
114 CARLO BRILLANTE
di un’intesa, cui certo contribuiva il richiamo erotico, che era tratto caratte-rizzante di questa versione.
A proposito della versione della Piccola Iliade è stato osservato che con questa innovazione Lesche andava ben oltre le convenzioni della poesia epica, certamente oltre quanto attesta l’uso omerico12. Credo che questa osservazione sia fondata, anche se il confronto con il colloquio fra Ettore e Adromaca non è decisivo, perché esso non ha nell’Iliade il medesimo significato di un incontro tra coniugi avvenuto dopo dieci anni di conflitto. L’ipotesi più probabile è che Lesche introducesse nel racconto un elemento fantasioso o romanzesco al fine di dare risalto alla narrazione e stimolare l’interesse dell’uditorio. Questo tipo di intervento non stupisce in un poeta che anche su altri punti non esitava a innovare in misura significativa13. Non escluderei che la quantità di frammen-ti della Piccola Iliade giunti fino a noi – di gran lunga più numerosi rispetto ad altri poemi del ciclo – sia dovuta alla singolarità delle versioni adottate. In ogni caso la versione di Lesche dipendeva largamente da altre più antiche che egli rielaborava liberamente. E in queste la violenza esercitata sulla donna da un marito offeso non era affatto assente. Tutti però sapevano che all’ira sareb-be seguita la riconciliazione. Probabilmente il poeta intendeva enfatizzare il mutamento, apparentemente improvviso e immotivato, di Menelao, anche a costo di forzare le norme tradizionali della narrazione epica. Nella violenza che accompagnò la conquista della città poteva in fondo verificarsi un evento come quello descritto e in nessun testo, per quanto ne sappiamo – neppure nella presentazione ostile dell’Andromaca euripidea – si afferma che il gesto della donna fosse volontario.
Per quanto riguarda il passo della Lisistrata (vv. 155 s.: oJ gwn Menevlao ta Elevna ta; malav pa || gumna parauidw;n ejxevbal’, oijw, to; xivfo) si è affermato che Aristofane alluda all’Andromaca di Euripide e che solo in que-sta tragedia fosse presente il richiamo alla nudità. Wilamowitz, ad esempio, riteneva che, nell’interpretazione di Lampito, Menelao gettasse uno sguardo indiscreto sul seno di Elena (parauidwvn); ne concludeva che il personaggio non avesse inteso correttamente la versione epica più tarda (ovvero la Piccola Iliade), dove Elena affascinava Menelao solo con la sua bellezza e non con sollecitazioni esplicitamente erotiche14. Questa interpretazione, che di fatto si
si afferma nel fr. 316 D. (una donna si toglie vesti, veli e fibbie) si riferisse all’episodio di Elena: cf. Cingano 1992, p. 217; Cavallini 1997, p. 151.
12 Vd. in tal senso Rzach 1922, col. 2422; Griffin 1977, p. 45; Davies 1989, p. 72 (che propone un confronto con l’incontro di Ettore e Andromaca, pur scorgendone le differenze).
13 Rzach fondava su questa base, prima che sulle notizie antiche, la tesi della recenziorità della Piccola Iliade rispetto all’Iliupersis di Arctino (1922, col. 2422). Così anche Kullmann 1960, pp. 218-220; 359 s., che distingue la tradizione rappresentata dai Kypria e dai poemi attribuiti ad Arctino da quella più recente (e dipendente da Omero) della Piccola Iliade. Cf. Debiasi 2004, pp. 130 s. e nn. 52 e 53 (con ulteriori rinvii).
14 Wilamowitz 1927, pp. 132 s. (ad loc.). Cf. Henderson 1987, ad loc. («… but the detail about her breasts appears first in Euripides»).
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 115
allontana da quanto afferma lo scolio, è fondamentalmente dettata dalla ne-cessità di salvare una norma, solitamente rispettata nella narrazione epica, che esclude richiami espliciti alla sfera sessuale. Ma, come si è detto, tale norma è più volte disattesa nella Piccola Iliade. Concluderemo pertanto che la Lisistrata di Aristofane fa riferimento a una versione del primo incontro fra gli sposi già presente in un poema epico e che questa fosse portata al successo dalla trat-tazione che ne aveva fatto Ibico in una composizione che doveva distinguersi per il trattamento del tema.
Questa versione dell’incontro è largamente rappresentata nella pittura vascolare. Tra gli episodi ispirati alla Piccola Iliade Ghali-Kahil include una serie di vasi nei quali è rappresentato un guerriero completamente armato (Menelao) che insegue una giovane donna (Elena). Quest’ultima fugge atter-rita (presso un altare o la statua di una divinità) per difendersi dalle intenzioni omicide. Alla vista della donna, Menelao lascia cadere la spada, rinunciando a vendicarsi15. Queste rappresentazioni costituiscono un gruppo abbastanza omogeneo e si concentrano in un arco di tempo limitato. La più antica della serie è su una coppa del pittore Onesimos, risalente al 500 a.C. circa, ora al Paul Getty Museum16. La scena è alquanto originale, perché Elena non è rappresentata nell’atto di fuggire (anche se ciò non esclude una reazione di spavento), ma tende le braccia con foga verso un accorrente Menelao con l’intento di placarlo. Questo è colto nell’atto di far cadere la spada, certo in conseguenza dell’intervento di Eros che si frappone tra i due volgendosi a Me-nelao. Le altre rappresentazioni su vasi a figure rosse risalgono al secolo V e si concentrano negli anni 470-43017. In queste Elena è perfettamente abbigliata con chitone o peplo. Tuttavia la rappresentazione più antica dell’episodio è quella del famoso pithos di Micono con episodi dell’Iliupersis, databile alla prima metà del secolo VII (metopa 7). Elena indossa un peplo e un himation finemente lavorati; sopra di esso un velo sottile copre il capo e le spalle. La donna è colta nel gesto di sollevarlo, lasciando così scoperti il volto e il seno. Menelao avanza minaccioso verso di lei: con la mano sinistra afferra la donna per il polso, secondo lo schema tradizionale del ceir’ ejpi; karpw, mentre con la destra regge un’enorme spada18. Il gesto di Elena può avere il significato
15 Ghali-Kahil 1988, nn. 260-277. Hedreen ha messo in dubbio che la figura di Menelao che lascia cadere la spada sia da riferire a un’opera specifica e ritiene che rifletta una modalità di rappresentare visivamente il mutamento dell’animo di Menelao (Hedreen 1996, pp. 160 s.; id. 2001, pp. 36 s.). Ci troveremmo di fronte a un ulteriore tentativo di stabilire un nesso vincolante fra Bild e Lied, che non tiene conto delle specifiche modalità di espressione della parola e dell’immagine. In questo caso, tuttavia, la pertinenza del confronto appare fondata su una convergenza puntuale fra i testi e le immagini. È im-probabile che debba pensarsi a semplice casualità.
16 Ghali-Kahil 1988, n. 277; Hedreen 1996, pp. 157; 182; id. 2001, pp. 34, 61 s.17 Ghali-Kahil 1955, nn. 58-71; ead. 1988, nn. 260-277; Clement 1958, pp. 55-58.18 Ervin 1963, p. 48, Metope n. 7; Pl. 22; Ghali-Kahil 1988, n. 225. Elena non sembra impres-
sionata dall’aggressione di Menelao. Essa solleva il velo dinanzi allo sposo ritrovato, con un gesto che richiama l’ajnakavluyi, il ‘disvelamento’ che accompagnava vari momenti della cerimonia nuziale: si veda la notevole trattazione di Llewellyn-Jones 2003, pp. 98-104; 227-240. La scena sembra richiamare
116 CARLO BRILLANTE
di una supplica di fronte alla minaccia incombente, ma il personaggio non sembra atterrito e più probabilmente si esibisce in un gesto di seduzione, premessa a una definitiva riconciliazione19. A questo importante documento è da aggiungere la testimonianza di una coppa del tipo di Siana risalente al 560-550 a.C. Qui sono riportati due momenti della storia. Su una faccia del vaso Menelao minaccia Elena con la spada, mentre questa scosta l’himation; sull’al-tra il peplo aperto sul davanti lascia scoperta una parte del seno. Minaccia e riconciliazione sembrano qui associati a ‘narrare’ un’unica storia. Come nota Ghali-Kahil, che segue la Pipili, avremmo qui «l’une des plus anciennes allu-sions, dans l’art figuré, à la séduction de Ménélas par la nudité d’Hélène»20. È notevole che queste rappresentazioni che esaltano la seduzione esercitata dalla donna – che sia o no volontaria – ricorrano in opere di età arcaica; per noi è naturale associarle con quanto è tramandato sulle versioni della Piccola Iliade o di Ibico, anche se ciò non presuppone un rapporto di derivazione. In ogni caso i dati esaminati finora risultano complessivamente omogenei nel rivelare l’antichità di questa versione del mito, che non fu certo invenzione del teatro attico del secolo quinto.
Concluderemo su questo punto ricordando la versione di Quinto Smir-neo, che permette di seguire gli eventi nel loro sviluppo (XIII 385-414). In preda al risentimento, Menelao è deciso a uccidere Elena, ma è fermato da Afrodite, che ne arresta lo slancio e fa cadere la spada dalle sue mani. Il ri-sentimento presto scompare, mentre la vista della donna fa nascere un forte desiderio d’amore. Notevole è qui la figura di Menelao colto da uno stupore che impedisce ogni reazione (vv. 411 s.: mainomevnw d’h[ikto kai; e[drake diplova pavnta || aijna; mavla stenavcwn). Quando, ciononostante, raccoglie la spada e muove verso la sposa con intenti omicidi per compiacere gli Achei presenti, interviene Agamennone, che distoglie un personaggio già esitante. La motivazione che fuga ogni residuo dubbio è quella tradizionale: il solo responsabile di quanto è accaduto è Paride, che ha violato le norme dell’ospi-talità. In questa versione la spada che cade dalle mani di Menelao richiama il racconto di Lesche e di Ibico, ma il motivo erotico è connesso con l’interven-to personale di Afrodite a sostegno di Elena. La dea opera qui non soltanto
un contesto di seduzione, come giustamente osserva Ervin 1963, pp. 61 s.; così pure Ghali-Kahil, loc. cit.; Ahlberg-Cornell 1992, pp. 78-80. Hedreen non attribuisce al gesto un significato unico e propende per una manifestazione di timore dinanzi all’aggressione di Menelao: 1996, pp. 168-170; id. 2001, pp. 44-47. Dipla 1997 (pp. 125 s.), pur riconoscendo un «deliberate display of Helen’s beauty», ritiene questa testimonianza poco significativa in quanto isolata sia tipologicamente che cronologicamente. Ma di fatto il vaso di Micono, offre la più antica rappresentazione dell’incontro di Elena e Menelao, ed essa è signi-ficativamente vicina alla versione di Lesche e di Ibico.
19 Un gesto di supplica non può essere escluso sulla base di quanto attestano altri episodi mitici nei quali personaggi femminili si trovano in situazioni disperate: Clitemestra di fronte a Oreste, Ecuba di fronte a Ettore, forse Cassandra di fronte a Clitemestra: vd. Bonfante 1989, p. 560; Ahlberg-Cornell 1992, p. 79.
20 Pipili 1981, pp. 82 s. e fig. 5; Ghali-Kahil 1988, n. 211, con rinvio al passo della Lisistrata (vv. 155 s.).
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 117
quale protettrice della donna, ma nel suo ruolo di divinità che sovrintende alla sfera erotica. Essa fa nascere in Menelao un desiderio d’amore che esclude ogni altra reazione. Lo stupore esprime efficacemente la nuova condizione indotta dalla dea, che conduce Menelao a una rapida riconciliazione. Que-sto tratto, che pone in evidenza lo smarrimento del personaggio, potrebbe essere antico. Nel citato scolio all’Andromaca di Euripide, che tramanda la versione di Ibico, Menelao «lascia cadere la spada» sotto la spinta di eros (uJp’ e[rwto ajfivhsi to; xivfo), un po’ come accade nel racconto di Quinto, dove l’intervento personale di Afrodite produce il medesimo effetto (v. 390: h{ rJa oiJ ejk ceirwn e[bale xivfo, e[sce d’ejrwhvn). Nella tragedia euripidea, invece, Menelao compie la sua scelta in piena consapevolezza, almeno nel giudizio di Peleo: … wJ ejseide mastovn, ejkbalw;n xivfo || fivlhm’ ejdevxw (vv. 629 s.); così pure nella Lisistrata, almeno nell’interpretazione che ne dà Lampito (vv. 155 s.). Si ravvisa quindi una certa differenza tra l’atto di lasciar cadere l’oggetto quasi meccanicamente, in quanto si è momentaneamente fuori di sé – sotto la spinta di eros o di Afrodite – e l’esito di una decisione consapevole. Dovremmo ritenere, in questo caso, che la ripresa parodica del medesimo episodio nelle Vespe di Aristofane, segnalata dagli scoli, ricalchi da vicino la versione della Piccola Iliade:
(Phil.) oi[moi, tiv pevponq wJ navrkh mou kata; th ceiro; kataceitai,kai; to; xivfo ouj duvnamai katevcein, ajll h[dh malqakov eijmi (vv. 713 s.).
Se questi confronti non ci traggono in inganno dovremo pensare che in una versione epica arcaica e nel ditirambo di Ibico al mutamento d’animo di Menelao contribuisse una sorta di fascinazione erotica, che si compiva – a tutto vantaggio di Elena, ma non necessariamente con la sua volontaria adesione – sotto l’accorta guida di Afrodite21.
La tradizione epica arcaica offriva almeno due versioni dell’incontro di Elena e Menelao, ma i dati ricavabili dall’arte figurata suggeriscono che esistevano numerose altre versioni che non possiamo cogliere nella loro specificità. Il tema non poteva rimanere estraneo alla poesia lirica. Abbiamo ricordato la versione di Ibico. Di notevole interesse doveva essere anche quella di Stesico-ro, che trattò il personaggio di Elena in varie opere: oltre che nell’Elena e nella Palinodia, anche nell’Iliupersis e forse anche in un altro poema che prendeva
21 In una lekythos campana della metà del secolo IV a.C., è rappresentato l’incontro tra Elena e Menelao. L’eroe trascina la sposa afferrandola per i capelli, mentre Afrodite, che regge tra le mani una i[ugx, interviene a sostegno della donna. La fascinazione generata dal ruotare dello strumento è ben nota dal secondo idillio teocriteo. Sulla lekythos vd. Ghali-Kahil 1955, p. 190, n. 160; Pl. LXXI 4; ead. 1988, n. 367. Secondo Gärtner 2005, p. 254 sarebbe stato Quinto Smirneo ad aggiungere il motivo dello stupore a quello della bellezza.
118 CARLO BRILLANTE
nome dal cavallo di Troia, sempre che esso non sia da identificare con l’Iliu-persis. Nulla vieta di ritenere che in ciascuna di queste opere il personaggio presentasse caratteri diversi. Il caso della Palinodia mostra chiaramente questa possibilità. Uno scolio all’Oreste di Euripide riferisce una storia piuttosto sin-golare attribuendola a Stesicoro, senza ulteriori specificazioni:
a\ra eij to; th Elevnh kavllo blevyante oujk ejcrhvsanto toi xivfesin oi|ovn ti kai; Sthsivcoro uJpogravfei peri; twn kataleuvein aujth;n mellovntwn. fhsi; ga;r a{ma tw th;n o[yin aujth ijdein aujtou; ajfeinai tou; livqou ejpi; th;n ghn22.
Nella tragedia euripidea Elettra teme che Oreste e Pilade indugino nel far giu-stizia su Elena perché affascinati dalla sua bellezza. È a questo proposito che lo scolio richiama la storia narrata da Stesicoro: un gruppo di Achei è inten-zionato a lapidare Elena, ma poi, affascinato dalla bellezza della donna, lascia cadere a terra le pietre. L’episodio è stato messo in relazione con i fatti che seguirono la presa di Troia: ricondotta alle navi, Elena si imbatteva nell’ostilità degli Achei che scorgevano in lei la causa prima delle loro sventure e decide-vano di lapidarla. L’episodio non è riferito da altre fonti, ma questa non è una ragione sufficiente per dubitare dell’attribuzione a Stesicoro, la cui opera co-nosciamo così imperfettamente. Una difficoltà maggiore è rappresentata dalla testimonianza della tabula Iliaca Capitolina, la cui parte centrale rappresenta, come è noto, vari episodi della presa di Troia con l’attribuzione a Stesicoro (Ilivou Pevrsi kata; Sthsivcoron)23. Qui l’episodio che vede protagonista Elena era presentato in termini diversi. La donna si trova presso il tempio di Afrodite; in ginocchio e con le vesti cadute dalle spalle, tenta un’estrema difesa dinanzi a un irruente Menelao; questi, armato di tutto punto, la minaccia con la spada, mentre con la sinistra l’afferra per i capelli: un episodio d’indubbia violenza che si concilia bene con quanto sappiamo dalla tradizione epica. Se la versione presente nella tabula risale davvero a Stesicoro diventa inevitabile chiedersi come sia possibile che il poeta presenti due versioni così diverse dell’episodio. Naturalmente è possibile ritenere che non ricorressero nel me-desimo poema, ma a sostegno di questa tesi non possiamo addurre alcun dato obiettivo. La lacunosità e contraddittorietà dei dati segnalano un’obiettiva difficoltà, sulla quale più volte hanno insistito quanti negano l’origine stesi-corea degli episodi rappresentati sulla tabula24. Diversi sono infatti nei due casi i protagonisti dell’aggressione – gli Achei ovvero Menelao – e le modalità
22 PMGF, fr. 201 D. (= schol. Eur. Or. 1287).23 Ghali-Kahil 1988, n. 370; ead. 1955, pp. 247 s., n. 203; Pl. LXXIV 1. L’episodio era
rappresentato anche in un’altra tabula Iliaca: Ghali-Kahil 1988, n. 371 (= ead. 1955, p. 248, n. 204).24 Il trattamento dell’episodio di Elena costituisce uno degli argomenti più forti contro l’origine
stesicorea delle scene rappresentate sulla tabula: vd. ad esempio Vürtheim 1919, pp. 36 s.; Bowra 1961, p. 106; Horsfall 1979a, p. 38; id., 1979b, p. 375. Sul problema, tuttora aperto, dell’attendibilità della tabula Capitolina nel riportare la versione di Stesicoro, si vedano, tra gli studi più recenti, Scafoglio 2005;
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 119
d’intervento. La lapidazione, inoltre, sembra essere estranea alla storia di Ele-na a Troia (vd. infra). Anche le proposte avanzate con il fine di conciliare le due storie non sono soddisfacenti. F.G. Welcker riteneva che fossero entrambe presenti nell’Iliupersis stesicorea e che Elena avesse subito una regolare con-danna da parte degli Achei. O. Jahn spiegava l’aggressione degli Achei con il fatto che essi non accettassero la decisione di Menelao di risparmiare Elena, ma che poi, dinanzi alla bellezza della donna, rimanessero sedotti anch’essi. In tal modo i due episodi diventano compatibili e solidali. Paulcke riteneva che Elena dovesse affrontare prima Menelao e poi la reazione degli Achei, esacerbati dai lutti e dalle fatiche. Essi avrebbero poi lasciato a Menelao la scelta finale sulla sorte della donna. Di questi eventi narrati nell’opera stesi-corea (compresa la minacciata lapidazione di Elena), egli trovava traccia nelle Troiane di Euripide, in luoghi la cui pertinenza in rapporto al contesto era considerata debole. Ciò sarebbe indizio della tendenza euripidea a utilizzare alquanto meccanicamente l’opera di Stesicoro25.
Il rinvio alla versione di Euripide è di notevole interesse e dovremo tenerne conto più avanti nel riesame del problema, ma la tesi che Elena su-bisse due successive aggressioni nella notte della presa di Troia, anche se non può essere esclusa, appare improbabile. Può richiamarsi a confronto solo la versione di Quinto Smirneo. Questa metteva a frutto la tradizione anteriore, epica e tragica, e per il nostro problema non è quindi decisiva26. Sfuggita ai propositi vendicativi di Menelao, Elena teme la vendetta degli Achei. Si co-pre quindi il capo con un velo e segue, rossa in volto, Menelao fino alle navi, dove raggiunge le donne troiane catturate (XIV 41-57). Anche in questa versione Elena suscita l’interesse dei guerrieri che si raccolgono attorno a lei e ne ammirano la bellezza (vv. 57-59: ajmfi; de; laoiv || qavmbeon ajqrhvsante ajmwmhvtoio gunaikov || ajglai?hn kai; kavllo ejphvraton), ma nessuno di essi ha il coraggio di rivolgerle rimproveri né di nascosto né apertamente (vv. 59-61). Non possiamo escludere che questa affermazione di Quinto in-tendesse opporsi a una versione che prevedeva proprio questo sviluppo, ma prudentemente ci limiteremo a osservare che non sappiamo da altri testi che Elena subisse una seconda aggressione dopo quella di Menelao.
Debiasi 2004, pp. 167-174 (con una critica puntuale alle argomentazioni di Horsfall), e ancora lo stesso Horsfall 2008, pp. 587-591.
25 Welcker 1850, p. 193; Jahn 1873, p. 34; Paulcke 1897, pp. 94-96; cf. Eur. Tro. 873-875; 901 s.; 1039 (lapidazione). Vd. anche Seeliger 1886, p. 38, Mancuso 1911, pp. 709 s., secondo il quale Stesicoro raddoppiava il motivo della fascinazione, che avrebbe operato prima su Menelao e successiva-mente, dopo il ritorno alle navi, sugli Achei: un artificio letterario, quindi, che offriva un’occasione ulteriore per esaltare la bellezza della donna.
26 Vian 1959, p. 76 valorizza i timori della donna di subire ingiurie da parte degli Achei (vv. 42 s.: … mh; eJ kiousan || kuaneva ejpi; neva ajeikivsswntai Acaioiv), che egli mette in relazione con le vere e proprie minacce di morte attestate nella tragedia: vd. Eur. Tro. 876-879; 1039; 1055-1057; cf. Or. 57-59. La versione di Quinto era considerata in rapporto a quella di Stesicoro già da Seeliger 1886, p. 38, nell’ambito di una ricostruzione razionalistica che escludeva il motivo erotico; cf. Vürtheim 1919, p. 37.
120 CARLO BRILLANTE
Il divario tra la versione della tabula e quella attestata dal fr. 201 D. resta quindi un dato per il quale non è stata fornita una soluzione soddisfacente. Anche la proposta di Davies che si appella alle necessità dell’artista, trovato-si nella necessità di adattare a un breve spazio un episodio complesso come quello della lapidazione di una donna da parte di un gruppo, appare molto dubbia27. L’artista infatti non si sarebbe limitato a semplificare l’episodio ridu-cendo il numero dei partecipanti, ma, adottando un tipo iconografico codifi-cato, avrebbe di fatto proposto una diversa versione degli eventi, allontanan-dosi dalla versione stesicorea su un punto non secondario. Prima di accogliere soluzioni molto ipotetiche dovremo quindi chiederci se non sia possibile una soluzione più soddisfacente partendo da una riconsiderazione complessiva dei dati pervenutici.
Un’osservazione preliminare ci porta a riflettere sul fatto che le due ver-sioni sono profondamente diverse fra loro. Di fatto sono due racconti che non si interpretano agevolmente come versioni di un’unica storia. Nel primo abbiamo un unico personaggio (Menelao), nel secondo un gruppo; all’aggres-sione con la spada del primo si sostituisce, nel secondo, la minaccia di lapida-zione, una possibilità che non trova confronti nella poesia epica e che appare isolata anche nell’ambito della lirica arcaica. Date queste premesse, è possibile proporre una soluzione diversa partendo non dalla versione della tabula, che nel complesso è abbastanza chiara, ma dalla notizia fornita dal fr. 201 D.
In un recente studio dedicato alle iscrizioni non attiche su vasi Wachter ha proposto di interpretare il frammento stesicoreo riferendolo non all’Iliu-persis ma all’Orestea28. È un’ipotesi che va considerata con attenzione, a favore della quale dovremo considerare alcuni dati che finora non hanno ricevuto la dovuta attenzione. In primo luogo va ricordato che il frammento stesicoreo è citato dallo scolio a proposito di un’affermazione ricorrente nell’Oreste di Eu-ripide. Quando già Oreste e Pilade sono entrati nel palazzo con il progetto di uccidere Elena (e vendicarsi del mancato sostegno di Menelao), Elettra, che at-tende all’esterno, dubita per un momento che i due giovani, presi dalla bellez-za della donna, possano mutare parere e deporre le spade: oujk eijsakouvous’ w\ tavlain’ ejgw; kakwn: || a\r’ ej to; kavllo ejkkekwvfhtai xivfh (vv. 1286 s.). La bellezza di Elena rappresenta costantemente un potenziale pericolo, capace di distogliere dai propositi più fermi. Il verbo ejkkwfevw, riferito alle
27 Davies 1978, pp. 553-555. Lo studioso valorizzava un giudizio di Welcker sulla difficoltà di rappresentare una scena come la lapidazione di una donna (1850, p. 193). Una soluzione affine è prospettata da Debiasi 2004, p. 169, che richiama l’autonomia dell’immagine, che nella rappresentazione di questo episodio ripeterebbe un modulo tradizionale. Ma anche l’arte figurata conosce il modo di rappresentare diversamente il medesimo episodio a seconda della versione prescelta.
28 Wachter 2001, p. 316. L’autore prende spunto dal riesame di un episodio dell’Iliupersis rap-presentato su un vaso corinzio tardo-arcaico del quale si dirà più avanti. Dubbi su un’attribuzione del frammento all’Iliupersis erano stati precedentemente espressi da Davies 1978, pp. 679 s. Horsfall, che precedentemente aveva valorizzato la contraddizione tra la versione della tabula Iliaca del Campidoglio e quella del fr. 201 D., considera favorevolmente la proposta di Wachter 2008, p. 591.
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 121
punte delle spade, che perdono d’efficacia dinanzi alla presenza della donna, richiama icasticamente l’effetto di fascinazione che la vista di Elena esercita sui giovani, secondo un esito che abbiamo già incontrato a proposito di Me-nelao. Il richiamo dello scolio a un episodio ricorrente nell’opera di Stesicoro nel quale la presenza di Elena aveva il medesimo effetto appare quindi piena-mente giustificato. Ma di quale episodio si tratta? In assenza di altri elementi, la risposta più naturale va ricercata in un ambito che sia il più vicino possibile al contesto euripideo, in una direzione che guardi, secondo il suggerimento di Wachter, non all’Iliupersis ma all’Orestea. Dai pochi frammenti pervenutici di quest’opera (210-219 D.) non si ricava tuttavia alcun dato utile. Dovremo quindi rivolgerci ancora all’Oreste euripideo nella ricerca di qualche elemento di confronto. All’inizio della tragedia, Menelao fa ritorno ad Argo, nel palazzo che condivide con il fratello, ma evita di entrare in città insieme con Elena. La donna è infatti odiata dagli Argivi, soprattutto da coloro i cui figli sono caduti nella spedizione troiana. Egli quindi manda innanzi la donna dopo aver atteso la notte, a evitare che qualcuno dei cittadini, incontrandola, non l’aggredisca con lanci di pietre (… mhv ti eijsidw;n || meq hJmevran steivcousan, w|n uJp Ilivw || paide teqnasin, ej pevtrwn e[lqh bolav)29. Una fine analoga si prospetta per Elena nelle Troiane. A conclusione dell’agon fra Elena ed Ecuba Menelao decide che la sposa, per le colpe commesse nei suoi confronti e verso gli Achei, dovrà essere lapidata, ma rinvia l’esecuzione a un momento succes-sivo al ritorno (vv. 1036-1048).
Non sappiamo quali tradizioni Euripide riprendesse in queste tragedie, né gli scoli ci aiutano in questa indagine. Possiamo tuttavia osservare che, in entrambi i luoghi, all’offesa subita dal marito si aggiunge il risentimento degli Achei, che devono sopportare le conseguenze delle sue scelte. In entrambi i casi la progettata lapidazione ha come scenario non la pianura troiana e il mo-mento che segue la presa della città, ma il continente e una fase successiva al ritorno. Soprattutto una situazione come quella che prende forma nell’Oreste darebbe ragione di una reazione di gruppo che richiama la versione stesicorea. Ma se questo è il contesto generale, l’opera nella quale più verisimilmente ricorreva l’episodio sarà stata l’Orestea e non l’Iliupersis; e poiché sappiamo che Stesicoro poneva a Sparta la reggia di Agamennone, come ci informa un altro scolio euripideo (ad Or. 46 = fr. 216 D.), dove egli regnava insieme con il fratello30, dovremo concludere che l’aggressione subita da Elena avvenisse in questa città. Il diverso contesto nel quale probabilmente va inserito l’epi-sodio si riflette anche nel tipo di esecuzione scelto dagli Achei. La lapidazio-ne, infatti, pone in primo piano il gruppo quale agente dell’esecuzione. Può
29 Eur. Or. 57-59; vd. anche vv. 102; 117-119.30 Come è noto, una tradizione diffusa nella poesia lirica arcaica e nella tragedia faceva di Sparta
la sede comune di Agamennone e Menelao: oltre a Stesicoro vd. ad esempio Sim. fr. 549 P.; Pind. Pyth. XI 16; Nem. XI 34 s.; Aesch. Ag. 3, 400, 549, 619; Bowra 1961, pp. 112-115.
122 CARLO BRILLANTE
essere considerata una forma di ‘giustizia popolare’ (Volksjustiz), praticata contro chi ha violato una norma sociale, con il fine di sostenere (e sanziona-re) le norme di convivenza vigenti nella comunità31. Sentendosi gravemente offeso o danneggiato, in tali circostanze il gruppo opera in rappresentanza dell’intera comunità. Possiamo confrontare questa storia con quella di Laide, l’etera tessala lapidata dalle donne della regione quando si trovava nel tempio di Afrodite32, ma anche più significative sono le parole con le quali Ettore riprende Paride che si ritira pavidamente dinanzi a Menelao: i Troiani gli hanno usato troppi riguardi, altrimenti già da tempo avrebbe indossato un «chitone di pietre» (lavi>non... citwna) per le tante disgrazie loro arrecate (III 56 s.). L’osservazione presuppone una reazione ‘giusta’ che coinvolge l’in-tera comunità. Alla luce di queste considerazioni il rischio corso da Elena nell’Oreste appare comprensibile se si pensa alla situazione che si determina all’inizio della tragedia, probabilmente non diversa da quella in cui la don-na veniva a trovarsi a Sparta nell’Orestea di Stesicoro. Anche in quest’opera Menelao doveva presentarsi in città insieme con la sposa dopo una lunga assenza ma privo dei numerosi compagni caduti a Troia. La soluzione qui proposta sulla base del suggerimento di Wachter non soltanto eliminerebbe la contraddizione tra l’episodio rappresentato sulla tabula Iliaca del Campi-doglio e la testimonianza dello scolio euripideo, ma offrirebbe un contesto adeguato nel quale inserire l’episodio stesicoreo della progettata lapidazione di Elena. È improbabile che una situazione di questo tipo fosse presente in un poema epico, dove personaggi secondari o anonimi non prendono iniziative autonome, soprattutto se in contrasto con le decisioni dei capi, mentre la ripresa abbastanza libera di un episodio famoso nell’epos, tra-sferito in un contesto civico, non stupirebbe in un poeta come Stesicoro, soprattutto se gli eventi si svolgevano a Sparta, dove la collettività poteva esprimere apertamente la propria condanna. Trasferita in ambito cittadino, la vendetta ‘privata’ che l’epos affidava a Menelao e che questi esercitava nell’ambito dell’oi\ko assumeva un carattere pubblico che coinvolgeva l’in-tera comunità, chiamata a reagire nelle forme tradizionali nei confronti di chi l’aveva danneggiata e offesa.
31 La trattazione più ampia ed esaustiva è quella di Hirzel 1909, soprattutto pp. 231 s.; 241 s.; 244. L’autore pone bene in luce come originariamente la lapidazione esprimesse, nella forma più decisa, la volontà collettiva di esclusione del soggetto che si intendeva colpire, posto di fronte all’alternativa dell’allontanamento o della morte. Essa ricalca probabilmente usi tradizionali, come suggerisce la comparazione. Più recentemente si è proposto di ridimensionare il carattere istituzionale di questo tipo di esecuzione, valorizzandone i tratti di vendetta collettiva di tipo istintivo (Cantarella 1988, pp. 83-88; ead. 2005, pp. 58 s.; 65 s.). Il suo carattere tradizionale emerge in ogni caso con chiarezza dalla trattazione di Hirzel, che argomenta persuasivamente su questo punto (pp. 232, 250). Sui significati simbolici della lapidazione, che coinvolge in un rito di purificazione l’intera città, vd. Gras 1984.
32 Plut. Amat. 768a; vd. Hirzel 1909, pp. 231, 258; Davies 1978, p. 681. Di Elena la tradizione rodia narrava che, giunta nell’isola dopo la morte di Menelao, fosse impiccata per iniziativa di Polyxo, la sposa di Tlepolemos, l’eroe caduto a Troia: Paus. III 19, 10; cf. Polyaen. I 13.
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 123
Le precedenti considerazioni permettono di guardare con maggior fidu-cia alla tabula Iliaca quale testimonianza, a questo punto unica, della versione seguita da Stesicoro sull’incontro di Elena e Menelao a Troia. La figura semi-nuda della donna che cade in ginocchio di fronte all’aggressione dello sposo ha fatto ritenere che qui fosse riportata una versione vicina a quella di Ibico33. Ma questa interpretazione è molto dubbia. Certo i due poeti operavano nel medesimo ambiente e coltivavano il medesimo genere di poesia e nulla vie-terebbe di pensare che il poeta più giovane seguisse la versione adottata da un predecessore autorevole. Ma dovremmo chiederci allora perché mai una versione presente nella poesia di Stesicoro fosse poi tramandata come propria di Ibico; se poi si cercava un predecessore cui il poeta lirico si sarebbe ispira-to, lo si poteva individuare più agevolmente in Lesche e nella Piccola Iliade. Dovremo ritenere, quindi, che almeno per alcuni aspetti, le versioni fossero diverse. In Stesicoro Menelao afferrava Elena per i capelli e la minacciava con la spada; il tempio di Afrodite rimane sullo sfondo. In Ibico, invece, secondo quanto è tramandato, non c’è contatto: Elena si trova nel tempio di Afrodite e di lì parla a Menelao (... kajkeiqen dialevgetai tw Menelavw). Probabilmen-te abbiamo qui un’innovazione ulteriore: nell’incontro tra i due sposi viene a mancare ogni violenza. Forse proprio questa versione del mito è rappresentata in una coppa di Tarquinia, nello stile del pittore di Brygos, risalente al 490 a. C. circa, come aveva visto Robert34. Qui Elena fugge trafelata verso un tempio all’interno del quale si scorge l’immagine in trono di Afrodite, che sembra ricambiare con un gesto di accoglienza. Menelao, armato di tutto punto e con la spada in pugno, insegue Elena con decisione, ma dovremo intende-re che non varcherà la soglia dell’edificio. La scena riporta il momento che precede l’ingresso della donna nel tempio. Menelao, posto nell’impossibilità di intervenire per non violare la sacralità del luogo, si ferma sulla soglia e di qui stabilisce un dialogo con Elena. In questa versione la presenza del luogo sacro si presenta come motivazione ulteriore, accanto al motivo erotico, per spiegare il ripensamento dell’eroe. Egli è costretto al dialogo dalle particola-ri circostanze che Elena sfrutta a proprio favore. Il motivo erotico segnava il coronamento dell’episodio, che si concludeva con un’intesa. Diversa è la versione della tabula Iliaca e quindi probabilmente di Stesicoro: Elena veniva raggiunta e afferrata con violenza, mentre il tempio, pure rappresentato, non sembra svolgere un ruolo di mediazione35. Qui la figura della donna non è in
33 Ad esempio Mancuso 1911, pp. 709 s.; Debiasi 2004, p. 168.34 Robert 1881, pp. 78 s.; Preller-Robert 1923, p. 1264, n. 3; Clement 1958, p. 53; Ghali-Kahil
1955, pp. 81 s., n. 54; Pl. LVI 2; ead. 1988, n. 244.35 Di un discorso di Elena, forse rivolto a Menelao, nel quale essa lamentava l’assenza di Ermione,
si è voluto scorgere traccia in un papiro di Ossirinco riconducibile all’Iliupersis di Stesicoro (2619, fr. 16 = S 104 D.). È un’ipotesi in realtà assai dubbia a causa dell’estrema frammentarietà del testo: vd. Page 1973, p. 56; Bornmann 1978, pp. 148 s. (con richiamo a Triph. 491-494); Davies 1978, pp. 636 s., 639; Schade 2003, pp. 203 s. Se si accoglie questa ricostruzione, il dialogo fra i due sposi, presente nel
124 CARLO BRILLANTE
fondo diversa da quella che vediamo nella casa del Menandro a Pompei, dove un’Elena seminuda non sembra turbare Menelao, che la trae a sé afferrandola per i capelli36.
Dovremo ora considerare una rappresentazione vascolare che riporta un al-tro incontro di Elena nella notte della presa di Troia. Si compone di quattro frammenti ceramici appartenenti a un grande cratere corinzio a colonnette di età tardo-arcaica (590-570 circa), noto dal mercato antiquario romano. L’origine è incerta, ma si ritiene che provenga dall’Etruria37. I frammenti ri-composti permettono di ricostruire una successione di varie figure, ricondu-cibili a episodi dell’Iliupersis. Gli eventi rappresentati si svolgono all’interno del palazzo di Priamo dopo la conquista di Troia. La presenza di iscrizioni consente di identificare vari personaggi. Procedendo da sinistra verso destra sono rappresentati due cavalli, il secondo dei quali montato da un giovanetto nudo, proteso all’indietro e fornito di una lunga asta. Dietro i cavalli si scor-gono due figure femminili, la seconda delle quali è identificata dall’iscrizione (frammentaria) come Andromaca. Dopo una terza figura femminile, non accompagnata da iscrizione, segue un gruppo di due personaggi affrontati. A sinistra una figura femminile, stante, con i capelli avvolti in una benda e con un lungo mantello volge lo sguardo verso un personaggio maschile armato di tutto punto (elmo corinzio, corazza, lancia, scudo rotondo con immagine della gorgone e schinieri), che muove con decisione verso di lei minacciando-la con una lunga asta. I due personaggi sono identificati dalle iscrizioni come Elena ed Enea38. Procedendo verso destra incontriamo un’altra figura fem-minile «indossante una lunga e stretta veste dalla caratteristica decorazione a rete (o, a squame) e un mantello a tre quarti»39. Con la mano destra sollevata regge un’‘asta’ poggiata sulla spalla, mentre il braccio sinistro fuoriesce dal mantello e la mano aperta è protesa in avanti. A questo personaggio è stata riferita l’iscrizione sulla destra della figura, di cui si dirà più avanti. Segue un’altra figura femminile, che l’iscrizione identifica come Ecuba. La serie è
ditirambo di Ibico (fr. 296 D.), potrebbe avere un precedente nell’opera di Stesicoro, anche se ciò non implica che i due poeti seguissero la medesima versione.
36 Ghali-Kahil 1988, n. 368. Per altre rappresentazioni simili di età romana si vedano anche nn. 369, 371, 372.
37 Staccioli 1973-74, p. 698, cui si deve la segnalazione e la prima pubblicazione dei quattro frammenti rinvenuti, afferma che il vaso è di provenienza etrusca (Tarquinia o Cerveteri) sulla base di informazioni personali ottenute su specifica richiesta. Il vaso fu rinvenuto in cattivo stato di conserva-zione e, per quanto sappia, attende ancora una pubblicazione esauriente. Nel testo seguo le indicazioni di Staccioli, cui rinvio per una presentazione analitica del pezzo. Vd. anche Ghali-Kahil 1988, n. 192 (senza tavola). Le iscrizioni che accompagnano i personaggi sono state edite per la prima volta da Arena 1967, n. 15, quindi da Amyx 1988, n. 76 e da Wachter 2001, COR 76.
38 Staccioli 1973-74, p. 701. Non dubiterei dell’atteggiamento aggressivo di Enea, come invece Ghali-Kahil (loc. cit.).
39 Staccioli 1973-74, pp. 701 s.
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 125
completata da una successione di cavalli, due dei quali montati da giovani nudi, che richiamano il gruppo nella sezione sinistra della medesima scena.
Per quanto riguarda le figure di Elena ed Enea già Arena, nel suo studio sulle iscrizioni su vaso corinzie, scorgeva «la documentazione di una tradi-zione aberrante da quella dell’epos omerico e conservata in alcuni tratti della versione latina di Elena»40. La raccolta di Amyx sulle pitture vascolari corin-zie di età arcaica non registra alcun progresso su questo punto («no specific situation can be identified»41). Successivamente Wachter ha giustamente ri-chiamato l’episodio virgiliano dell’incontro di Elena con Enea narrato nel secondo libro dell’Eneide42. L’assenza di Priamo dalla scena descritta faceva ritenere a Wachter che l’episodio rappresentato fosse successivo alla morte del vecchio re, e ciò forniva un ulteriore elemento di confronto con l’episodio virgiliano: il momento nel quale Enea scorge Elena nel tempio di Vesta segue infatti immediatamente la narrazione della morte di Priamo. È possibile che nell’Eneide gli episodi che segnavano la conquista della città seguissero un or-dine tradizionale, ma è improbabile che nell’episodio rappresentato sul cratere Enea entrasse nel palazzo quando esso era già stato conquistato dagli Achei. In ogni caso difficilmente avrebbe potuto imbattersi in Elena, che – dobbiamo ritenere – si era già allontanata con Menelao. Conquista del palazzo e cattura di Elena non sono infatti, in questa versione, separabili. Il confronto con l’e-pisodio virgiliano su questo punto non è decisivo: in Virgilio Enea assiste alla conquista del palazzo e alla morte di Priamo rimanendo all’esterno, sul tetto (v. 458), ed è poi attratto dalla visione di Elena nel tempio di Vesta43. Ma se dobbiamo pensare a un incontro tra Elena ed Enea nel palazzo di Priamo, come avviene nel cratere corinzio, è naturale collocare l’episodio in una fase che precede l’assalto finale degli Achei.
In Virgilio Enea non si avvicina ad Elena: essa gli appare in lontananza, all’interno del tempio dove ha cercato rifugio dalle vendette di Greci e Troia-ni, a lei ugualmente ostili (vv. 567-576):
Iamque adeo super unus eram, cum limina Vestae seruantem et tacitam secreta in sede latentemTyndarida aspicio; dant clara incendia lucemerranti passimque oculos per cuncta ferenti.
40 Arena 1967, p. 77.41 Amyx 1988, p. 577.42 Wachter 2001, p. 316. Cf. Verg. Aen. II 567-588. Per il problema dell‘autenticità di questi versi
vd. infra, nota 74.43 I movimenti dell’eroe in questa fase concitata non sono molto chiari: al v. 458 Enea si trova sul
tetto del palazzo e da qui osserva quanto avviene all’interno. Solo al v. 632 si afferma che ne discende. È improbabile che osservi Elena dalla medesima posizione dalla quale ha assistito all’uccisione di Pria-mo. Sulla ricostruzione di questo discusso episodio virgiliano, vd. ad esempio Noack 1893, pp. 426-428, Austin 1964, ad vv. 458, 632; Büchner 1986, p. 438 (quando incontra Elena, Enea avrebbe già abbandonato il tetto: cf. vv. 570, 594); Conte 1985, pp. 190 s.; Horsfall 2008, pp. 557 s.; 572.
126 CARLO BRILLANTE
Illa sibi infestos euersa ob Pergama Teucroset Danaum poenam et deserti coniugis iraspraemetuens, Troiae et patriae communis Erinys,abdiderat sese atque aris inuisa sedebat.
Elena non si accorge della presenza di Enea né delle sue intenzioni omicide. La sua immagine, odiosa per l’eroe che attribuisce a lei sola la colpa della rovina attuale, appare in lontananza, appena rischiarata dai fuochi che nella notte devastano la città. Nonostante questi versi abbiano come unico obiet-tivo Elena, essa non entra mai in azione. Il personaggio è visto (e giudicato) con gli occhi dell’osservatore esterno, che riversa su di esso tutto il proprio risentimento per i mali presenti. Nella figura di Elena l’Enea virgiliano scorge il profilo dell’Erinni (v. 573), termine che qui richiama la divinità non quale demone vendicatore dei torti, ma quale portatrice di distruzione e di morte, capace di esercitare il proprio influsso malefico indistintamente sui Greci e sui Troiani. Su questo punto Virgilio poteva attingere a una solida tradizione, che risaliva alla tragedia euripidea e all’Alessandro di Ennio44.
È quindi attraverso la reazione emotiva e i pensieri del protagonista che seguiamo le sorti di Troia e il destino che attende l’eroe. Dinanzi alla catastro-fe che incombe sulla città l’immagine di Elena che si rifugia nel tempio sem-bra svanire nel nulla; con la sola presenza essa evoca un passato di distruzione e di morte che Enea dovrà lasciarsi alle spalle. Il ruolo tradizionale svolto da Afrodite cambia ora di segno. La divinità non sostiene più la donna fedifraga, causa di infiniti lutti per entrambe le parti, ma assume il ruolo, decisamente nuovo, di protettrice premurosa e vigile di Enea. Al tradizionale rapporto che univa la giovane donna alla divinità si sostituisce quello della madre per il figlio. In questa nuova prospettiva dovremo leggere anche la scelta del tempio di Vesta, che viene a sostituire altre divinità come Afrodite e Athena. La scelta è dettata certo dalla volontà di ‘romanizzare’ la città troiana, ma anche dalla necessità di eliminare ogni residuo legame tra Elena e Afrodite: l’odiosa figura della donna non poteva trovare sostegno nella divinità che assumeva tratti e funzioni della madre di Enea45.
Non è questa la sede per indugiare oltre nell’analisi di questo notevole episodio virgiliano. Ci basti constatare che, nella sua rilettura del mito, Vir-
44 Vd. Eur. Or. 1387 s.: Duselevnan Duselevnan xestwn || pergavmwn <twn> Apollwnivwn Erinuvn. Cf. Enn. fr. XVII (d) Joc. (= VIII 69 V2.): … Lacedaemonia mulier Furiarum una adveniet (nella profezia di Cassandra), con il commento ad loc.; Mazzoldi 2001, pp. 157-159. Elena come Erinni era già presente nell’Agamennone di Eschilo (v. 749: numfovklauto Erinuv), anche se qui con ben altro significato: vd. Brillante 2002, pp. 114 s. Per il richiamo all’Oreste di Euripide (vv. 1137-1147) vd. già Heinze 1915, pp. 48 s. e n. 1; Austin 1964, ad v. 573; Conte 2006, pp. 159-161, il quale nota giustamente come nell’Erinys virgiliana dovremo riconoscere la latina Furia «con la concezione romana della Furia come demone di distruzione piuttosto che di vendetta» (p. 160, n. 1). Horsfall 2008, p. 574 non sembra aver colto questo punto.
45 Vd. La Penna 1978, p. 990; Brillante 2002, pp. 159-162.
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 127
gilio poteva utilizzare anche una versione minore, già presente nella Grecia arcaica, che narrava di una minaccia concreta di Enea, anche se di essa non ci è giunta alcuna attestazione letteraria. In assenza di altri dati non è possibi-le approfondire il confronto. Ci limiteremo quindi a constatare che Virgilio diede una nuova collocazione all’evento, trasferendolo dal palazzo di Priamo al tempio dove la donna trovava rifugio, secondo quanto affermava una tradi-zione consolidata, risalente almeno a Ibico, che narrava l’incontro con Mene-lao. E, come in Ibico, non vi è contatto con l’aggressore: Elena continua a trovar rifugio all’interno del tempio, anche se questa volta ‘nascondendosi’ (v. 568: secreta in sede latentem). Ciò consentiva di sostituire la minaccia concreta esercitata sulla donna con il risentimento e il desiderio di rivalsa dell’eroe, colto in un momento particolarmente delicato alla vista della distruzione del-la propria città: un processo psicologico, quindi, orientato interamente sulla figura del protagonista. Il mancato incontro tra Elena ed Enea è soluzione tra le più originali e felici. In tal modo diventava possibile includere nell’Iliupersis un episodio tradizionale, che in omaggio alla tradizione non poteva essere tralasciato; al tempo stesso la minaccia subita da Elena era riproposta in una prospettiva troiana, che era anche quella del protagonista e del narratore.
Altri dati offerti da questa rappresentazione vascolare sono di interpreta-zione più incerta. Come si è detto, alla destra di Enea è rappresentata una figu-ra femminile che indossa una veste a rete (o a squame, secondo la descrizione di Staccioli). Nell’iscrizione che accompagna la figura si legge, nell’alfabeto arcaico corinzio, perilipoi (senza lacune); essendo stato inteso come nome proprio femminile si è preferita l’interpretazione Perilipoi, forma di nominativo ben attestata nelle iscrizioni corinzie. Il termine presenterebbe, nella seconda par-te, una radice verbale (cf. leivpw) o nominale (cf. liparov, perilivparo)47. Nel primo caso avrebbe il significato di ‘superstite’, nel secondo quello di ‘mol-to lucente’ ovvero ‘splendidissima’. In entrambi i casi l’interpretazione come nome proprio è prevalsa, come per gli altri nomi presenti sul vaso, anche se in questo caso dovremmo pensare a un ipocoristico o a invenzione estemporanea del pittore48. Questa ipotesi, tuttavia, non è la più ovvia. Il personaggio così designato non doveva essere oscuro o secondario: la collocazione tra Enea ed Ecuba gli conferisce una posizione di prestigio. Un dato utile all’identificazione è ravvisabile nella veste a rete che indossa e che può essere interpretata come un ajgrhnovn, l’abito portato dagli indovini, che li rappresentava nella loro qualità di mavntei. Come ci informa Polluce, si trattava di un tessuto a forma di rete
46 Arena 1967, p. 76; Amyx 1988, p. 86; Wachter 2001, p. 86. Cf. Buck 1955, p. 92, § 111, 5.47 Per la prima ipotesi si pronuncia, sia pure con riserva, Arena 1967, p. 76, che richiama
periliphv, con rinvio a Il. XIX 230 (o{ssoi d a]n polevmoio peri; stugeroio livpwntai) e a Plat. Leg. 702a (kai; tou; prwvtou dh; tou; perilipei genomevnou th fqora); così anche Wachter 2001, p. 86; per la seconda Staccioli 1973-74, p. 703 e Amyx 1986, p. 577.
48 Vd. in tal senso Wachter 2001, p. 86.
128 CARLO BRILLANTE
che ricopriva l’intera persona49. Se accettiamo questa interpretazione nella fi-gura femminile potremo riconoscere Cassandra, l’indovina inascoltata che, nel momento culminante della rovina della città, si scagliava, al pari di Enea, con-tro Elena. Sembra che qui il personaggio sia identificato dalla funzione svol-ta, che si manifesta nell’abbigliamento proprio degli indovini. L’aggiunta del nome proprio sarebbe quindi superflua. L’iscrizione potrebbe allora essere inte-sa non in riferimento alla persona (nessuna eroina di parte troiana porta questo nome), ma come tratto che accomuna tutte le figure rappresentate: perivlipoi, inteso come nominativo plurale, designerebbe allora i superstiti del conflit-to troiano considerati nel loro insieme. Tutti i personaggi qui rappresenta-ti sopravvissero in fondo alla distruzione di Troia: Andromaca, Elena, Enea, Cassandra (se si accetta l’interpretazione proposta), Ecuba. Anche l’assenza di Priamo, ucciso da Neottolemo, troverebbe su questa base una spiegazione ac-cettabile. Beninteso questa interpretazione resta ipotetica, in considerazione dell’assenza di elementi di confronto, ma mi sembra essere quella che meglio dia ragione del contesto generale e dell’episodio rappresentato.
Anche nella versione attestata dal cratere Enea doveva rinunciare a vendi-carsi, ma non ne conosciamo le motivazioni. Ci limitiamo quindi a constatare che essa non era presente nell’Iliupersis (qui Enea e il suo seguito abbandona-no Troia dopo l’episodio di Laocoonte), e forse neppure nella Piccola Iliade, anche se in questo caso lo svolgimento degli eventi è più incerto51. Ciò sembra confermare che il cratere riportasse un episodio minore o una versione mar-ginale, che non ebbe accesso alle versioni letterarie più autorevoli; come si è detto, le fonti scritte non ne fanno cenno. Esso tuttavia offrì lo spunto a uno degli episodi più notevoli dell’Eneide.
Le versioni esaminate finora presentano un tratto comune: Elena appare del tutto ignara dei piani degli Achei per la conquista di Troia, è sorpresa dagli
49 Poll. IV 116 B.: to; d’ h\n plevgma ejx ejrivwn diktuwde peri; pan to; swma, o} Teiresiva ejpebavlleto h] ti a[llo mavnti. Esichio a 777 L. aggiunge che l’ajgrhnovn era portato anche dai partecipanti a cori bacchici: <e[nduma> diktuoeide; o} peritivqentai oiJ bakceuvonte Dionuvsw. Si conoscono anche statue di sacerdoti che indossano l’ajgrhnovn sopra il chitone: in questi casi sono rap-presentati nell’esercizio della funzione di mavntei: vd. Brillante 2009, pp. 100-102 (con ulteriori rinvii).
50 In questa forma il termine non è attestato, ma possiamo confrontare periliphv, come proponevano Arena e altri studiosi: vd. supra, n. 47.
51 Ilii Exc. p. 88, 8 s. s. B.: ejpi; de; tw tevrati dusforhvsante oiJ peri; Aijneivan uJpexhlqon eij th;n Idhn. È la versione seguita nel Laocoonte di Sofocle: vd. Dion. Hal. Ant. Rom. I 48, 2; cf. fr. 373 R. Per la Piccola Iliade disponiamo della sola testimonianza di Tzetze (schol. Lyc. Alex. 1268 = fr. 21 B.), secondo la quale Enea era presente a Troia nel momento della conquista ed era consegnato come prigioniero a Neottolemo insieme con Andromaca. Su quest’ultimo punto sono stati sollevati dubbi perché la medesima versione ricorreva in una composizione di Simia Rodio (fr. 6 P. = schol. Eur. Andr. 14). È tuttavia probabile che Simia si limitasse a riprendere il racconto presente nella Piccola Iliade (i vv. 6-11 sono linguisticamente affini ai precedenti), e che Tzetze citasse di seguito i versi relativi a Enea, di fatto relativi a due diversi episodi presenti nel poema ciclico. Su questo punto controverso si rinvia agli apparati di Powell e Bernabé; inoltre Davies 1989, p. 72; Burgess 2001, p. 202, n. 73; Debiasi 2004, pp. 279-287 (con discussione e bibliografia).
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 129
eventi non meno dei Troiani. L’intesa con Menelao è raggiunta a fatica dopo un confronto violento che mette a rischio la sua vita. Altri testi, tuttavia, presentano la storia in maniera abbastanza diversa: Elena diventa una col-laboratrice attiva degli Achei, con i quali stabilisce un’intesa già prima della conquista della città. Questo doppio orientamento è presente già nell’Odissea, nei due discorsi che Elena e Menelao tengono di fronte al giovane Telemaco, giunto ospite a Sparta. Nel primo Elena vanta i propri meriti avendo attiva-mente collaborato con Odisseo giunto in incognito a Troia (IV 235-264); nel secondo è Menelao a ricordare il sostegno da lei dato ai Troiani dopo la par-tenza degli Achei. Insieme con Deifobo essa fece per tre volte il giro attorno al cavallo di legno imitando le voci delle spose degli Argivi. Sperava in tal modo che qualcuno rispondesse al richiamo e l’inganno fosse svelato (vv. 265-289). In ogni caso le premesse per tracciare l’immagine di un’Elena fedifraga, la quale, dopo aver abbandonato Menelao, ingannava anche la parte troiana (un mutamento che sembra connesso con la morte di Paride), erano già presenti nell’Odissea. Qui Elena afferma chiaramente che, in occasione della prima missione di Odisseo a Troia (la ptwceiva), apprese da lui l’intero piano degli Achei (v. 256: kai; tovte dhv moi pavnta novon katevlexen Acaiwn); e mentre le donne troiane piangevano gli uomini uccisi da Odisseo, essa si rallegrava, perché il suo animo era mutato e desiderava tornare in patria: ejpei; h[dh moi kradivh tevtrapto nevesqai || a]y oi\kovnd(e) (vv. 260 s.). Questa prima spe-dizione di Odisseo (la seconda si sarebbe conclusa con il ratto del Palladio) era narrata anche nella Piccola Iliade:
Odusseuv te aijkisavmeno eJauto;n katavskopo eij Ilion paragivnetai, kai; ajnagnwrisqei; uJf’ Elevnh peri; th aJlwvsew th povlew suntivqetai kteivna tev tina twn Trwvwn ejpi; ta; nau ajfikneitai52.
Ma se le premesse per il tradimento di Elena sono già nell’Odissea, la tradizio-ne epica greca non ricorda, almeno fino a Trifiodoro, una sua collaborazione attiva con gli Achei nella notte della presa di Troia. La testimonianza più antica è per noi rappresentata dal racconto di Deifobo nel libro VI dell’Eneide. Egli ricorda dapprima i segnali di fuoco con i quali Elena richiamò la flotta achea rifugiatasi nell’isola di Tenedo (vv. 515-519 ), quindi il vile inganno con il quale egli stesso fu consegnato inerme nelle mani di Menelao (vv. 520-530). In entrambi gli episodi Elena è segnata da tratti che ne enfatizzano il carattere fedifrago e omicida, disposto a qualsiasi azione pur di sottrarsi al destino che la minaccia. Conviene considerare separatamente i due momenti del racconto.
Quando il cavallo di legno era stato portato sulla rocca e tutta la città era in festa per la fine della guerra, Elena, simulando una danza, si pose alla testa
52 Il. Parv. pp. 74, 15-17 B. Le due spedizioni di Odisseo a Troia sono condensate in un unico evento dallo Pseudo-Apollodoro (Ep. V 13).
130 CARLO BRILLANTE
delle donne troiane conducendole in processione solenne per la città. Giunta all’acropoli, agitava una grande fiaccola con la quale segnalava ai Greci la riu-scita del piano (vv. 518 s.: flammam media ipsa tenebat || ingentem et summa Danaos ex arce vocabat). Il ruolo che Virgilio assegna a Elena è, nella tradizio-ne più antica a noi giunta, attribuito a Sinone. È quanto possiamo affermare sia per la versione dell’Iliupersis (il personaggio penetrava furtivamente in città e da qui dava i segnali di fuoco), sia per la Piccola Iliade e altri testi più recenti, nei quali Sinone persuadeva i Troiani con l’inganno53. Le testimonianze anti-che non menzionano un ruolo attivo di Elena in tale occasione. Alcuni stu-diosi hanno ritenuto, su questa base, che fosse Virgilio a innovare, nell’intento di fornire quell’immagine negativa della donna che è propria dell’Eneide54. Non sono in verità mancati giudizi contrari, anche se i dati portati a sostegno di questa seconda tesi sono piuttosto incerti. Una testimonianza esplicita in tal senso è fornita da Trifiodoro (vv. 510-513):
aujtivka d Argeivoisin Acillho para; tuvmbonajggelivhn ajnevfaine Sivnwn eujfeggevi dalw.Pannucivh d eJtavroisin uJpe;r qalavmoio kai; aujthveujeidh; Elevnh crusevhn ejpedeivknuto peuvkhn55.
Qui Elena agisce su sollecitazione di Athena (v. 496), ed è associata a Sino-ne nella medesima iniziativa. Probabilmente è da intendere che questi agisse dall’esterno della città, dalla tomba di Achille, come forse avveniva nella Pic-cola Iliade, mentre Elena operava dalle sue case. È possibile che questa inno-vazione, che complicava il racconto e attribuiva un ruolo attivo alla donna, sia da attribuire alla Piccola Iliade, che Trifiodoro seguiva in più punti, ma non disponiamo di argomenti decisivi. Norden richiamava una gemma con
53 Ilii Exc. p. 88, 10 s. B.: Sivnwn tou; pursou; ajnivscei toi Acaioi, provteron eijselhlouqw; prospoivhto. Per la versione della Piccola Iliade vd. schol. Lyc. Alex. 344 (citato da Bernabé in apparato al fr. 9 = fr. 11c Davies). Dalle Bacchides di Plauto si ricava che Sinone operava dal tumulo di Achille (vv. 937 s.: Mnesilochus Sino est || relictus, ellum non in busto Achilli, sed in lecto accubat). Questa era forse la versione della Piccola Iliade, dal momento che nell’Iliupersis Sinone penetrava con l’inganno in città (p. 88, 10 s. B.). Per questa versione vd. anche [Apollod.] Ep. V 19; Quint. Smyrn. XIII 23 s.; Tzetz. Carm. Il. III 721; Dict. V 12. Robert ipotizzava che la versione di Virgilio avesse un precedente in un poeta ellenistico o in un tragico recente, che sarebbe stato il modello anche per il Deifobo di Accio (1923, p. 1253); cf. Heinze 1915, pp. 7 s.; La Penna 1978, p. 991. Un’attenta analisi offrono Vian (1959 pp. 60 s.; 73) e Leone (1968, pp. 80-84; 93). Sinone doveva essere presente anche nell’Iliupersis di Stesicoro: è forse suo il discorso nel quale si sostiene l’opportunità di portare il cavallo sull’acropoli: P. Oxy. 2619, fr. 1 + 47 (= S 88 D.); Page 1973, pp. 49 s. Più incerta la testimonianza di P. Oxy. 2619, fr. 13 (= S 102 D.), per il quale vd. West 1969, p. 139 (che richiama Aen. II 154-156); cf. Horsfall 2008, p. 558. Nulla di preciso può ricavarsi dal Sinone di Sofocle, che doveva narrare la storia rifacendosi al ciclo epico. Come è noto, Aristotele menzionava il tema tra quelli che offrivano argomento per una tragedia (Poet. 1459b, 7). Il problema è complesso e non può essere trattato in questa sede.
54 Vd. ad esempio Welcker 1882, p. 245, n. 17; Knight 1932, p. 184; Leone 1968, pp. 91-93.55 Triph. vv. 510-513. L’Elena con la fiaccola è menzionata anche da Igino (fab. 249: facem…
Helenae quam de muris ostendit et Troiam prodidit); ma in questo caso è agevole presupporre la cono-scenza dell’Eneide.
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 131
la rappresentazione della presa di Troia; qui un personaggio femminile, che è sulle mura della città, alza il braccio avendo tra le mani un oggetto che può essere una fiaccola56. Anche in un affresco di Pompei con la rappresentazione del cavallo di legno trainato in città, si scorge sulle mura una figura femminile che brandisce la torcia. In entrambi i casi è stata proposta l’identificazione con Elena, ma l’interpretazione resta dubbia; si tratterebbe, in ogni caso, di testimonianze posteriori a Virgilio57. Di fronte a tanta incertezza, e soprattut-to nell’assenza di testi che possano essere chiamati a confronto, tanto più interessante è una notizia presente nel cosiddetto ‘romanzo di Simon Mago’, noto principalmente dalla testimonianza dell’Adversus Haereses di Epifanio. Il passo fu segnalato da Schneidewin e successivamente ripreso da Knaack e da Norden58. Trasfigurata nell’ambito di un’interpretazione allegorica, ritrovia-mo ancora l’immagine della donna che dall’alto della torre segnala ai Greci con una fiaccola la riuscita dell’inganno perpetrato ai danni dei Troiani:
au{th gavr ejstin hJ e[nnoia hJ par’ Omhvrw Elevnh kaloumevnh. kai; touvtou e{neken ajnagkavzetai aujth;n diagravfein Omhro ejpi; puvrgou eJsthkevnai kai; dia; lampavdo uJpofaivnein toi Ellhsi th;n kata; twn Frugwn ejpiboulhvn.
L’inattesa attribuzione a Omero faceva ritenere a Schneidewin che il nome del poeta celasse il riferimento a un poema del ciclo epico, da lui individuato nella Piccola Iliade. Questa ipotesi è da considerare tuttora con attenzione; anche in questo caso, infatti, Lesche potrebbe aver innovato rispetto alla precedente versione di Arctino, che affidava il medesimo compito a Sinone. Immisch pro-poneva, invece, un rinvio a Stesicoro, che pure aveva largamente trattato il mito di Elena59. Questa tesi è stata riproposta in tempi più recenti sulla base di un pa-piro di Ossirinco riferibile all’Iliupersis stesicorea. In questo contesto, di indub-bio interesse per il nostro tema, Elena, forse presentata come nuora di Priamo, sembra svolgere un ruolo attivo a fianco degli Achei nella conquista della città, ma il testo eccessivamente lacunoso non consente un ricupero attendibile60.
Su questo punto non è possibile, quindi, giungere a conclusioni certe, anche se vari indizi suggeriscono che Virgilio utilizzasse, come è naturale at-
56 Norden 1927, p. 260 s. v. In tal senso già Furtwängler 1900, vol. I, Taf. XXXVIII 6; vol. II, p. 181; Robert 1923, p. 1253, n. 3.
57 Davreux 1942, pp. 134 s.; n. 56; Pl. XVII, fig. 33 (= Paoletti 1994, n. 37). In una seconda pittura parietale di Pompei si osserva, nella parte superiore, una donna con torcia, identificata come Cassandra; ma potrebbe essere intesa ugualmente bene come Elena: Paoletti 1994, n. 37 (con foto); cf. Gerlaud 1982, pp. 33 s.
58 Vd. Epiphan. Haer. XXI 3, 3 (I 241 Holl); inoltre Hippol. Philosoph. VI 19, 1 (p. 225 Marcovich), con l’analisi di Schneidewin 1852, pp. 99-101. La tesi di questo studioso, con il rinvio ai luoghi di Ippolito e di Epifanio, fu poi ripresa da Knaack 1893, da Heinze 1915, p. 79 e n. 1, e da Norden 1927, pp. 260 s. Cf. Robert 1923, p. 1253.
59 Immisch 1897, p. 128; cf. Heinze 1915, p. 79.60 P. Oxy. 2619, fr. 14 (= S 103 D.); Schade 2003, pp. 150; 197 s. (con ulteriori rinvii).
132 CARLO BRILLANTE
tendersi in un poema come l’Eneide, opere diverse; queste peraltro ci sfug-gono ogniqualvolta tentiamo di definirne con precisione i contorni. La testi-monianza di Trifiodoro – la sola che attesti una convergenza, sia pure parziale con Virgilio – assumerebbe maggior peso qualora fossimo certi che non fosse condizionata dal modello virgiliano, secondo un indirizzo che si è andato af-fermando nella critica più recente61. Il ruolo qui svolto da Elena andrebbe al-lora ricercato in trattazioni più antiche, note eventualmente anche a Virgilio, nelle quali le funzioni tradizionalmente attribuite a Sinone erano condivise da Elena. Anche per questa via il candidato più probabile resta la Piccola Iliade. Dovremmo in tal caso ritenere che il medesimo poema narrasse dapprima il tradimento di Elena e successivamente l’incontro, all’insegna della seduzione, con Menelao. In ogni caso la versione di Virgilio si distingue per originalità e forza espressiva. Come ha osservato Knight, nell’immagine funesta di Elena, che assume tratti bacchici alla testa delle donne troiane, ritroviamo tratti che nella tradizione epica anteriore erano propri di Cassandra62. In Trifiodoro, quando i Troiani conducono il cavallo sull’acropoli, la profetessa, in preda al furore, abbandona le case e corre per la città come una giovenca punta dal tafano (vv. 358-374); ma alle sue parole nessuno crede; ritenuta folle (v. 439: eJterovfrona kouvrhn), è ricondotta nelle case. In Quinto Smirneo, ancora in preda a un’esaltazione incontrollabile, Cassandra afferra dall’altare un tiz-zone e una scure con l’intento di abbattere il cavallo (XII 567-571). Anche nella tabula Iliaca del Campidoglio la sezione che secondo l’iscrizione risa-le alla Piccola Iliade presenta una Cassandra con il corpo riverso all’indietro mentre è sostenuta da una figura maschile63. L’inascoltata profetessa agisce probabilmente in una condizione di follia ispirata, che le consente di vedere chiaramente il destino della città. Questo stato delirante Virgilio ha ripreso, se questo è stato il suo modello, nell’immagine di Elena, che egli dipinge in una condizione di esaltazione quasi mistica, che richiama l’esaltazione bacchi-ca (euhantis… Phrygias), ma naturalmente l’episodio è depotenziato di ogni significato religioso. Se nella Piccola Iliade o in altra composizione anteriore già ricorreva la figura della donna che ‘tradiva’ la parte troiana, essa assume
61 Questa tesi, già sostenuta da Heinze 1915, pp. 78-81, Knight 1932, pp. 182, 188 s. e Vian 1959, pp. 95-101, è quella oggi maggiormente seguita: vd. ad esempio Gerlaud 1982, pp. 46 s.; Leone 1968, pp. 62, 106 s., passim; Dubielzig 1996, pp. 20-26 (con bibliografia).
62 Knight 1932, p. 184; id. 1932a, pp. 91-93, con riferimento a una ‘disintegrazione’ del per-sonaggio, i cui tratti nell’Eneide sono trasferiti da un lato su Laocoonte, dall’altro su Elena e Amata; cf. Gärtner 2005, pp. 222 s. Nell’Eneide all’intervento di Cassandra sono dedicati appena due versi (vv. 246 s.). Da notare che l’Elena di Trifiodoro non prende parte alla festa, né presenta quei tratti ‘bacchici’ che sono propriamente virgiliani.
63 Mancuso 1911, p. 11; Davreux 1942, p. 133; Gärtner 2005, p. 223; vd. anche Tzetz. Carm. Il. III 708-712. È possibile che nella Piccola Iliade Cassandra fosse rappresentata nel momento conclusivo dell’estasi mantica (Mazzoldi 2001, p. 119), secondo un esercizio della divinazione familiare in questa figura e che non sarebbe inatteso in un poeta come Lesche; ma in assenza di dati, l’ipotesi resta dubbia.
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 133
in Virgilio connotati inquietanti, che la rendono simile a un essere demonico (un’Erinni: II 573), atta ad impersonare il modello della sposa scellerata.
Il personaggio funesto di Elena tracciato nell’Eneide manifesta tutta la sua malvagità nell’inganno teso a Deifobo, consegnato senza difese nelle mani di Menelao (VI 515-530). Come abbiamo detto, l’eroe doveva avere un ruolo importante nella tradizione epica arcaica, ma le notizie pervenuteci sono molto parziali e lacunose. Nell’Iliade è il più caro a Ettore tra i suoi fratelli (XXII 233 s.) e Athena prende le sue sembianze per ingannare lo stesso Ettore nel duello con Achille (XXII 226 s., 294), segno indubbio di prestigio e valore indivi-duale; ma l’eroe doveva distinguersi soprattutto nell’ultima fase della guerra, allorché sposava Elena e assumeva la guida dell’esercito troiano64. Nell’Odissea è attorno alle sue case che si organizza l’ultima e più tenace resistenza dei Troia-ni (VIII 514-520). Al medesimo evento fa riferimento un carme di Alceo, nel quale si menziona l’assalto degli Achei e con esso forse la morte dell’eroe (fr. 298, v. 12 V.), mentre in Orazio occupa un posto di tutto rilievo accanto a Ettore (Carm. IV 9, 22: ferox Hector vel acer Deiphobus). Il prestigio di questa figura di guerriero appare tuttavia circoscritto alla poesia epica arcaica – quin-di a opere che non ci sono pervenute – e forse alla poesia lirica, ma in età successiva la sua fama sembra appannarsi. Anche le rappresentazioni vascolari attribuibili al personaggio sono rare e di incerta interpretazione. Secondo La Penna fu la scarsa fortuna avuta nella tragedia a oscurarne la fama65.
A una caduta di Deifobo in difesa di Troia fa riferimento Enea quando incontra l’amico dilaniato in tutto il corpo (VI 500-504):
Deiphobe armipotens, genus alto a sanguine Teucri,quis tam crudelis optauit sumere poenas?quoi tantum de te licuit? mihi fama supremanocte tulit fessum uasta te caede Pelasgumprocubuisse super confusae stragis aceruom.
Qui Virgilio richiama una versione del mito vicina a quella dell’epos omerico, che narrava appunto di una dura lotta scatenatasi attorno alle case dell’eroe (Od. VIII 519: aijnovtaton povlemon), con un’evidente finalità di contrasto rispetto alla versione prescelta, affidata alla voce del personaggio66. Nelle pa-role di Deifobo l’azione di Elena, che consegna lo sposo inerme nelle mani di Menelao, giunge fino a un’efferatezza disumana (vv. 523-527):
Egregia interea coniunx arma omnia tectisamouet et fidum capiti subduxerat ensem;
64 Vd. supra, pp. 111 s.65 La Penna 1978, pp. 987 s.66 Norden 1927, p. 261 riconosceva giustamente la presenza di due tradizioni sulla morte del
personaggio, anche se appare superata la tesi della dipendenza di Virgilio da un manuale mitografico.
134 CARLO BRILLANTE
intra tecta uocat Menelaum et limina pandit,scilicet id magnum sperans fore munus amantiet famam extingui ueterum sic posse malorum.
L‘orrore dell’episodio è accresciuto dal fatto che Elena è qui chiamata coniunx, mentre Menelao è l’amante con il quale ordisce inganni ai danni dello sposo. Anche la presenza di Odisseo, che come in Omero accompagna Menelao, è segnata dall’inganno e dal tradimento: hortator scelerum Aeolides (v. 529). Sia le imprese sia la stirpe (il riferimento è alla tradizione che voleva l’eroe figlio di Sisifo) predispongono il personaggio a conseguire un successo vano, macchia-to dalla scelleratezza. Questa narrazione, singolarmente virgiliana, trae spunto da un’altra versione sulla morte dell’eroe, pure presente nella tradizione epi-ca, che è possibile ricuperare dalla lineare presentazione di Quinto Smirneo: Menelao sorprende Deifobo, appesantito dal vino, nel letto di Elena, mentre questa cerca di salvarsi con la fuga (XIII 354-357):
kai; tovte dh; Menevlao uJpo; xivfei stonoventiDhivfobon katevpefne karhbarevonta kichvsaajmf Elevnh lecevessi, dusavmmoron: hJ d uJpo; fuvzhkeuvqet ejni; megavroisin.
Anche in Trifiodoro Menelao si trova di fronte un avversario che, nell’im-possibilità di difendersi, cerca vanamente di nascondersi (vv. 626-629). Ele-na è ugualmente sorpresa e si decide a seguire il marito ritrovato come una sposa «ottenuta con la lancia» (v. 630: dorukthvth paravkoiti), lieta certo per la fine dei mali, ma anche turbata per la vergogna (v. 632: aijdomevnh). Una versione simile ricorre in Tzetze e in Ditti Cretese. Questi narra una fine anche più atroce dell’eroe, sottoposto ancor vivo all’orribile trattamento del mascalismov, mentre nell’Eneide la medesima mutilazione era inflitta al cor-po del caduto, secondo un uso tradizionale ben attestato67. In altri casi, inve-ce, come nella statua posta nel ginnasio detto di Zeuxippos a Costantinopoli, Deifobo conservava i tratti eroici del fiero combattente di marca odissiaca68.
Virgilio aveva quindi la possibilità di scegliere tra più versioni della sto-ria; e preferì quella che prevedeva l’eroe colto di sorpresa nel sonno, ma con alcune significative modifiche. Presentando un’Elena che tradisce lo sposo e con la sottrazione delle armi gli impedisce ogni difesa, conferisce al racconto
67 Tzetz. Carm. Il. III 729-731; Dict. V 12: … exsectis primo auribus brachiisque ablatis deinde naribus ad postremum truncatum omni ex parte foedatumque summo cruciatu necat. Cf. Aen. VI 494-497; Brillante 2002, p. 163. Seguendo un’indicazione di Pearson, La Penna avanza l’ipotesi che il motivo fosse presente nella Polyxene di Sofocle (1978, p. 988; Soph. fr. 528 P. e il commento ad loc.), ma l’ipotesi è assai dubbia. Per il frammento di Sofocle si è pensato, forse con maggior fondamento, al trattamento inflitto al corpo di Agamennone da Clitemestra (Ahrens, ap. Radt, ad loc.; cf. Aesch. Cho. 439; Soph. El. 445). Credo che avesse ragione Norden nel ritenere che si tratti di invenzione virgiliana «menschlich wahr und schön» (1927, p. 267).
68 Anth. Pal. II 1-12.
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 135
un orientamento profondamente nuovo69. A Deifobo non era dato di mo-strare il suo valore in quello che doveva essere il suo ultimo combattimento, a differenza di quanto affermava la voce giunta ad Enea. Possiamo quindi rite-nere con buon fondamento che Virgilio introducesse due elementi nuovi che distinguevano la nuova versione: il tradimento di Elena, aggravato dalla sot-trazione delle armi, e il trattamento inflitto al corpo di Deifobo. Per il primo punto Knight pensava a un riuso virgiliano dell’episodio odissiaco nel quale Elena imitava la voce degli Achei nascosti nel cavallo70. Ma questo richiamo appare improbabile. I due episodi sono strutturalmente diversi, come diverse sono nei due casi le finalità perseguite. Se consideriamo contestualmente le ‘novità’ virgiliane, potremo invece ricuperare un rapporto con la tragedia e in particolare con la figura della Clitemestra eschilea. Questa sorella di Elena non soltanto tradisce lo sposo (e nell’Eneide il marito di Elena è Deifobo), ma ne provoca la morte con l’inganno e sottopone poi il corpo al trattamento infamante del mascalismov71. In fondo l’Elena virgiliana eredita vari tratti del personaggio tragico, comportandosi come una nuova Clitemestra. In una fabula di Igino, che si ispirava a questo episodio, le due sorelle sono ricor-date tra coloro «che uccisero i loro sposi»72. Questa innovazione distingue la versione virgiliana da quelle epiche anteriori, che pure in Elena e Clite-mestra riconoscevano due modelli diversi di anaideia femminile. Rileggendo in rapporto alla versione tragica i dati offerti dall’epos Virgilio ha dato vita a un personaggio che non solo tradisce la parte con la quale è schierato, ma non indugia a perseguire i propri fini con ogni mezzo. Ne emerge una figura efferata e funesta, priva anche di quella sinistra grandezza che troviamo nel personaggio eschileo.
Probabilmente questa immagine di Elena era destinata a sostituire, nella versione finale del poema, il personaggio del secondo libro, sorpreso dagli eventi e che temeva in egual misura il risentimento dei Troiani e la vendetta degli Achei. In ogni caso le due versioni non sono conciliabili fra loro. Il ruolo di Elena, come la sua caratterizzazione, sono nei due casi diversi, né si può spiegare la differenza sostenendo che Deifobo offra solo un’interpretazio-ne personale dei fatti, in quanto non potrebbe essere informato sui piani di
69 Anche per il tradimento di Elena, che altera un dato costante nella presentazione dell’episodio, si è pensato che Virgilio attingesse a precedenti trattamenti del mito. L’ipotesi che questa versione fosse presente nel Deiphobus di Accio non trova conferma nei frammenti pervenutici della tragedia: cf. La Penna 1978, pp. 989, 991. Non decisivi i riferimenti a un’uccisione di Deifobo da parte di Elena: Hyg. fab. 240; Ps. Acro ad Hor. Sat. I 1, 99 s.: … nam Clytemestra Agamemnonem, Helena Deiphobum interfecit, et ambae Tyndarei filiae. Ugualmente non verificabile, data la lacunosità del testo, è la tesi che individua un precedente alla trattazione di Virgilio nel papiro di Bologna (fol. 5 recto), con catabasi orfica, nonostante il testo presenti elementi in comune con il libro VI dell’Eneide: vd. Treu 1954, pp. 48 s.
70 Od. IV 274-289; Knight 1932, pp. 184 s.; id. 1932a., p. 94. Più probabile invece un richiamo all’episodio odissiaco nel quale Odisseo e Telemaco rimuovono le armi dalla sala del banchetto (Od. XIX 4-40).
71 Aesch. Ag. 1126-1129; 1382-1387; Cho. 439.72 Hyg. fab. 240 (quae coniuges suos occiderunt).
136 CARLO BRILLANTE
Elena73. L’eroe narra certo quanto gli è accaduto, ma nessun indizio testuale fa intendere che il suo racconto sia infondato. Per quanto riguarda l’episodio del secondo libro, le numerose irregolarità, linguistiche e metriche, possono essere spiegate ritenendo che quella a noi giunta non sia la versione definitiva. La notizia secondo la quale a escludere questi versi furono Vario e Tucca, ai quali Augusto affidò l’incarico di curare l’edizione dell’Eneide dopo la morte del poeta, offre una spiegazione soddisfacente sia dell’assenza di questi versi dai codici, sia delle irregolarità menzionate74. Ma indubbiamente virgiliani sono sia l’uso accorto di molteplici tradizioni letterarie, talvolta appartenenti a generi diversi, sia l’attitudine a metterle a confronto fra loro, nella ricerca di situazioni narrative e significati nuovi. Né va dimenticato che, accingendosi a narrare un’Iliupersis, Virgilio, come i suoi predecessori, non poteva tralasciare la figura di Elena, che di tali eventi restava figura centrale. L’Eneide ci conse-gna due potenti immagini dell’eroina, certo diverse fra loro ma ugualmente virgiliane: entrambe si ispirano a versioni più antiche, per noi parzialmente ricuperabili, ed entrambe sono segnate da invenzione e notevole originalità nel ripensamento del mito e nella caratterizzazione dei personaggi.
BIBLIOGRAFIA
Ahlberg-Cornell 1992 = G. Ahlberg-Cornell, Myth and Epos in Early Greek Art: Representa-tion and Interpretation, St. in Med. Arch. 100, Jonsered 1992.
Amyx 1988 = D.A. Amyx, Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period, vol. II. Com-mentary: the Study of the Corinthian Vases, Berkeley-Los Angeles-London 1988.
Anderson 1997 = M.J. Anderson, The Fall of Troy in Early Greek Poetry and Art, Oxford 1997.
Arena 1967-68 = R. Arena, Le iscrizioni corinzie su vasi, Mem. Acc. Naz. Lincei, ser. VIII, vol. XIII (1967-68), pp. 57-142.
Austin 1964 = R.G. Austin, P. Vergili Maronis Aeneidos liber secundus, Oxford 1964.Berger 1986 = E. Berger, Der Parthenon in Basel. Dokumentation zu den Metopen, Text-
band, Basel 1986.Bonfante 1989 = L. Bonfante, Nudity as a Costume in Classical Art, AJA 93 (1989),
pp. 543-570.Bornmann 1978 = F. Bornmann, Note a Stesicoro, SCO 28 (1978), pp. 145-151.Bowra 1961 = C.M. Bowra, Greek Lyric Poetry, Oxford 19612.
73 Vd. in tal senso Noack 1893, pp. 430 s. Questa tesi è stata ripresa da Kinsey 1987.74 Come è noto, i vv. 567-588 sono tramandati solo nella prefazione di Servio (pp. 2 s. Th.-H.) e
negli scoli del Servio Danielino (ad v. 566). Sul problema, molto discusso, dell’autenticità, mi limito qui a suggerire la soluzione che mi sembra più soddisfacente, peraltro generalmente accolta nella critica più recente: vd. ad esempio Büchner 1986, pp. 437 s.; La Penna 1978, pp. 995-997; id. 2005, pp. 334 s.; Conte 1984, pp. 109-119; id. 2006; id. 2009, in apparato ai vv. 567-588. Cf. Austin 1964, pp. 217-219 (con bibliografia precedente). Per una diversa interpretazione, che considera i versi opera di un attento conoscitore dello stile virgiliano, vd. da ultimo Horsfall 2008, pp. 553-567 (cf. p. 565: «too Virgilian to be real»), con bibliografia.
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 137
Brillante 2002 = C. Brillante, Elena di Troia, in Il mito di Elena. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi di M. Bettini e C. Brillante, Torino 2002, pp. 37-232.
Brillante 2009 = C. Brillante, Il cantore e la Musa. Poesia e modelli culturali nella Grecia arcaica, Pisa 2009.
Büchner 1986 = K. Büchner, Virgilio, il poeta dei Romani, Brescia 19862.Buck 1955 = C.D. Buck, The Greek Dialects, Chicago and London 19552.Burgess 2001 = J.S. Burgess, The Tradition of the Trojan War in Homer and the Epic Cycle,
Baltimore 2001.Cantarella 1988 = E. Cantarella, La lapidazione tra rito, vendetta e diritto, in Mélanges
Pierre Lévêque, éd. par M.-M. Mactoux et É. Geny, vol. I, Paris 1988, pp. 83-95.Cantarella 2005 = E. Canterella, I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte
in Grecia e a Roma, Milano 20052.Cavallini 1997 = E. Cavallini, Ibico. Nel giardino delle vergini, Lecce 1997.Christiansen 1974 = J. Christiansen, Et Skår fra Mykonos, Meddelelser fra Ny Carlberg
Glyptotek 31 (1974), pp. 7-21 (sunto in francese alle pp. 19-20).Cingano 1992 = E. Cingano, L’opera di Ibico e di Stesicoro nella classificazione degli anti-
chi e dei moderni, in Lirica greca e latina. Atti del convegno di studi polacco-italiano, Roma 1992, pp. 189-224.
Clairmont 1959 = Chr. Clairmont, recensione a Ghali-Kahil 1955, JHS 79 (1959), pp. 206-212.
Clement 1958 = P.A. Clement, The Recovery of Helen, Hesperia 27 (1958), pp. 47-73.Conte 1984 = G.B. Conte, Il genere e i suoi confini, Milano 1984.Conte 1985 = G.B. Conte, Enciclopedia virgiliana, vol. II, Firenze 1985, pp. 190-193,
s. v. Elena.Conte 2006 = G.B. Conte, Questioni di metodo e critica dell’autenticità: discutendo ancora
l’episodio di Elena, MD 56 (2006), pp. 157-174. Conte 2009 = G.B. Conte, P. Vergilius Maro. Aeneis, Berolini et Novi Ebooraci 2009.Davies 1978 = M. Davies, A Commentary on Stesichorus (D. Phil. thesis), Oxford 1978.Davies 1989 = M. Davies, The Epic Cycle, Bristol 1989.Davreux 1942 = J. Davreux, La légende de la prophétesse Cassandre d’après les textes et les
monuments, Liége-Paris 1942.Debiasi 2004 = A. Debiasi, L’epica perduta, Hesperìa 20, Roma 2004.Dipla 1997 = A. Dipla, Helen, the Seductress? in Greek Offerings. Essays on Greek Art in
honour of John Boardman (Oxbow Monographs 89), ed. by O. Palagia, Oxford 1997, pp. 119-130.
Dubielzig 1996 = U. Dubielzig, Trifiodwvrou Ilivou a{lwsi. Triphiodor: Die Einnahme Ilions (Classica Monacensia 15), Tübingen 1996.
Ervin 1963 = M. Ervin, A Relief Pithos from Mykonos, Arch. Delt. 18 (1963), pp. 37-75.Ervin-Caskey 1980 = M. Ervin-Caskey, Echion on the Mykonos Pithos: the Fulfillment of
Prophecy, Sthvlh. Tovmo eij mnhvmhn N. Kontolevonto, Aqhna 1980, pp. 33-36.Fleck 1977 = M. Fleck, Helena und Venus im zweiten Aeneisbuch, Hermes 105 (1977),
pp. 68-79.Furtwängler 1900 = A. Furtwängler, Die Antiken Gemmen, 3 voll., Leipzig-Berlin 1900.Gärtner 2005 = U. Gärtner, Quintus Smyrnaeus und die Aeneis. Zur Nachwirkung Vergils
in der griechischen Literatur der Kaiserzeit, München 2005.Gerlaud 1982 = B. Gerlaud, Triphiodore. La prise d’Ilion, Paris 1982.
138 CARLO BRILLANTE
Ghali-Kahil 1955 = L.B. Ghali-Kahil, Les enlèvements et le retour d’Hélène dans les textes et les documents figurés. I. Texte. II. Planches, Paris 1955.
Ghali-Kahil 1986 = L.B. Ghali-Kahil, Lexicon iconographicum mythologiae classicae, vol. III 1, Zürich-München 1986, pp. 362-367, s. v. Deiphobos.
Ghali-Kahil 1988 = L.B. Ghali-Kahil, Lexicon iconographicum mythologiae classicae, vol. IV 1, Zürich-München 1988, pp. 498-563, s. v. Helene.
Gras 1984 = M. Gras, Cité grecque et lapidation, in Du Châtiment dans la cité, Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique (Coll. Éc. Française de Rome 79), Rome 1984, pp. 75-88.
Griffin 1977 = J. Griffin, The Epic Cycle and the Uniqueness of Homer, JHS 97 (1977), pp. 39-53.
Hedreen 1996 = G. Hedreen, Image, Text, and Story in the Recovery of Helen, Class. Ant. 15 (1996), pp. 152-184.
Hedreen 2001 = G. Hedreen, Capturing Troy. The Narrative Functions of Landscape in Archaic and Early Classical Art, Ann Arbor 2001.
Heinze 1915 = R. Heinze, Virgils Epische Technik, Leipzig–Berlin 19153.Henderson 1987 = J. Henderson, Aristophanes. Lysistrata, Oxford 1987.Hirzel 1909 = R. Hirzel, Die Strafe der Steinigung, Abh. Kön. Sächsischen Ges. der Wiss.
(Phil.-Hist. Klasse) 27 (1909), pp. 223-266.Horsfall 1979 a = N. Horsfall, Stesichorus at Bovillae?, JHS 99 (1979), pp. 26-48.Horsfall 1979 b = N. Horsfall, Some Problems in the Aeneas Legend, Class. Quart. n.s. 29
(1979), pp. 372-390.Horsfall 2008 = N. Horsfall, Virgil, Aeneid 2 (Mnemosyne Suppl. 299), Leiden-Boston
2008.Immisch 1897 = O. Immisch, Vergiliana, Rhein. Mus., N.F. 52 (1897), pp. 126-129.Jahn 1873 = O. Jahn, Griechische Bilderchroniken, Bonn 1873.Kannicht 1969 = R. Kannicht, Euripides. Helena, Heidelberg 1969.Kinsey 1987 = Th.E. Kinsey, Helen at the Sack of Troy, PdP 42 (1987), pp. 197-198.Knaack 1893 = G. Knaack, Helena bei Virgil, Rhein. Mus. N.F. 48 (1893), pp. 632-634.Knauer 1973 = E.R. Knauer, Ein Skyphos des Triptolemosmalers, Winckelmannspro-
gramm 125 (1973).Knight 1932 = W.F.J. Knight, Iliupersides, Class. Quart. 26 (1932), pp. 178-189.Knight 1932a = W.F.J. Knight, Vergil’s Troy. Essays on the Second Book of the Aeneid,
Oxford 1932.Kullmann 1960 = W. Kullmann, Die Quellen der Ilias (Hermes Einzelschriften 14),
Wiesbaden 1960.La Penna 1978 = A. La Penna, Deifobo ed Enea (Aen. VI 494-547), in Miscellanea di
studi in onore di Marino Barchiesi (Riv. Cult. Class. Med. 20), Roma 1978, pp. 987-1006.
Lambrinudakis 1986 = V. Lambrinudakis, Lexicon iconographicum mythologiae classicae, vol II 1 (1986), p. 679, s. v. Echion.
Leone 1968 = P.L.M. Leone, La “Presa di Troia” di Trifiodoro, Vichiana 5 (1968), pp. 59-108.
Leone 1984 = P.L.M. Leone, Ancora sulla “Presa di Troia” di Trifiodoro, Quaderni catanesi di studi classici e medievali 6 (1984), pp. 5-15.
Löwy 1912 = E. Löwy, Entstehung einer Sagenversion, Wien. St. 34 (1912), pp. 282-287.
ELENA NELLA NOTTE DELLA PRESA DI TROIA: DALL’ILIUPERSIS ALL’ENEIDE 139
Mancuso 1911 = U. Mancuso, La “Tabula Iliaca” del Museo Capitolino, Mem. Acc. Lincei 14 (1911), pp. 662-731.
Mazzoldi 2001 = S. Mazzoldi, Cassandra, la vergine e l’indovina, Pisa-Roma 2001.Meijering 1987 = R. Meijering, Literary and Rhetorical Theories in Greek Scholia,
Groningen 1987.Michaelis 1871 = A. Michaelis, Der Parthenon, hrg. von A. Michaelis, Leipzig 1871.Noack 1893 = F. Noack, Helena bei Vergil, Rh. Mus. 48 (1893), pp. 420-432.Norden 1927 = E. Norden, P. Vergilius Maro. Aeneis Buch VI, Leipzig 19273.Page 1973 = D. Page, Stesichorus: the ‘Sack of Troy’ and the ‘Wooden Horse’ (P. Oxy.
2619 and 2803), Proc. Cambr. Phil. Society n.s. 19 (1973), pp. 47-65.Paoletti 1994 = O. Paoletti, Lexicon iconographicum mythologiae classicae, vol. VII 1
(1994), pp. 956-970.Paulcke 1897 = M. Paulcke, De tabula Iliaca quaestiones Stesichoreae, Regimonti Bo-
russorum 1897.Pipili 1981 = M. Pipili, MIA NEA KULIKA TUPOU SIANAS, AAA 14 (1981), pp.
76-84.Robert 1881 = C. Robert, Bild und Lied. Archäologische Beiträge zur Geschichte der
griechischen Heldensage, Berlin 1881.Robert 1923 = C. Robert, Die Griechische Heldensage III 2, Berlin 1923.Robertson 1995 = M. Robertson, Menelaos and Helen in Troy, in The Ages of Homer.
A Tribute to Emily Townsend Vermeule, edd. J.B. Carter and S.P. Morris, Austin 1995, pp. 431-436.
Rzach 1922 = A. Rzach, Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, XXII (1922), coll. 2347-2435.
Scafoglio 2005 = M. Scafoglio, Virgilio e Stesicoro. Una ricerca sulla Tabula Iliaca Capitolina, Rhein. Mus. 148 (2005), pp. 113-125.
Schade 2003 = G. Schade, Stesichoros. Papyrus Oxyrhynchus 2359, 3876, 2619, 2803 (Mnemosyne Suppl. 237), Leiden-Boston-Köln 2003.
Schneidewin 1852 = F.H. Schneidewin, Profanes aus des Bischofs Hippolytos AiJrevsewn e[legco, Göttinger Nachrichten 1852, pp. 95-108.
Schwab 2005 = K.A. Schwab, Celebration of Victory: the Metopes of the Parthenon, in The Parthenon. From Antiquity to Present, ed. by J. Neils, Cambridge 2005, pp. 159-198.
Seeliger 1886 = F.K. Seeliger, Die Uberlieferung der griechischen Heldensage bei Stesi-choros. I., Meissen 1886.
Severyns 1928 = A. Severyns, Le cycle épique dans l’école d’Aristarque, Liège-Paris 1928.Treu 1954 = M. Treu, Die neue ‘orphische’ Unterweltsbeschreibung und Vergil, Hermes
82 (1954), pp. 24-51.Vian 1959 = F. Vian, Recherches sur les Posthomerica de Quintus de Smyrne, Paris 1959.Vürtheim 1919 = J. Vürtheim, Stesichoros’ Fragmente und Biographie, Leiden 1919.Wachter 2001 = R. Wachter, Non-Attic Greek Vase Inscriptions, Oxford 2001.Welcker 1850 = F.G. Welcker, Alte Denkmäler, II, Göttingen 1850.Welcker 1865 = F.G. Welcker, Der epische Cyclus oder die homerischen Dichter, Zweiter
Teil, Bonn 18822.West 1969 = M.L. West, Stesichorus redivivus, ZPE 4 (1969), pp. 135-149.Wilamowitz 1927 = U. von Wilamowitz-Moellendorff, Aristophanes. Lysistrate, Berlin
1927.