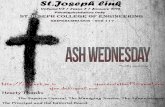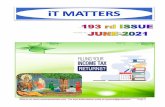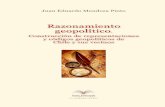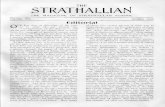Comitato di redazione · Editorial Board BELLEROFONTE: UN Bellerofone:un EROE CORINZIO...
Transcript of Comitato di redazione · Editorial Board BELLEROFONTE: UN Bellerofone:un EROE CORINZIO...
internat ional journal ofclass ical art h i story
4 · 2007
p i s a · ro m afabrizio serra · editore
mmviii
e st r atto
Direttori scientifici · Editors
Irene Favaretto · Francesca Ghedini
Comitato scientifico · Scientific Board
Giorgio Bejor · Università degli Studi, MilanoLuigi Beschi · Università degli Studi, Firenze
Katherine M. D. Dunbabin · MacMaster University, HamiltonValentin Kockel · Klassische Archäologie Universität, AugsburgHenri Lavagne · Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris
François Lissarrague · Centre Louis Gernet, ParisPaolo Moreno · Università degli Studi di Roma iii, RomaMaria Grazia Picozzi · Università «La Sapienza», RomaAngela Pontrandolfo · Università degli Studi, Salerno
François Queyrel · Ecole pratique des Hautes Etudes, ive Section, ParisAgnès Rouveret · Université Paris x, Nanterre
Vincenzo Saladino · Università degli Studi, FirenzeDaniela Scagliarini Corlàita · Università degli Studi, Bologna
Gemma Sena Chiesa · Università degli Studi, MilanoSalvatore Settis · Scuola Normale Superiore, Pisa
Luigi Sperti · Università degli Studi, VeneziaMario Torelli · Università degli Studi, Perugia
Gustavo Traversari · Università degli Studi, VeneziaMonika Verzár-Bass · Università degli Studi, Trieste
Paul Zanker · Scuola Normale Superiore, Pisa
Comitato di redazione · Editorial Board
Giulio Bodon · Università degli Studi, PadovaMonica Salvadori · Università degli Studi del Molise, Campobasso
Segreteria di redazione · Secretary
Isabella Colpo · Università degli Studi, Dipartimento di Archeologia,Piazza Capitaniato 7, i 35139 Padova
BELLEROFONTE: UN EROE CORINZIONELL’IMMAGINARIO DELLE COMUNITÀ ITALICHE*
Eliana Mugione
Riassunto
Lo studio delle immagini del mito di Bellerofonte note dalla ceramica attica e italiota si inseri-sce nel dibattito recente sul significato che le immagini assumono all’interno del loro contesto,ed in particolare nel filone di studi che sottolinea l’opportunità di leggere il mito greco e le im-magini che lo hanno rappresentato seguendo una lettura stratificata e diacronica che tenga con-to dell’ideologia dei produttori e dei destinatari delle immagini. In questa direzione le immagi-ni di Bellerofonte, note dall’età arcaica ed ininterrottamente fino alla fine del iv secolo a.C. intutte le produzioni (ionico, corinzie, attiche, etrusche, italiote), lasciano intravedere come neltempo il mito dell’eroe corinzio di volta in volta abbia messo in scena significati particolari in re-lazione a momenti cronologici diversi e ad ambienti culturali differenziati.
La cesura più importante è quella che si registra nelle produzioni italiote nelle quali, accantoall’episodio dell’uccisione della Chimera, viene messo in scena tutto il racconto mitologico (par-tenza dell’eroe, consegna della lettera a Proeto, arrivo di Bellerofonte dal re Iobate, dopo l’ucci-sione del mostro, che gli concede la figlia e il trono) che tende a sottolineare come attraversol’eroizzazione di Bellerofonte si legittimi una nuova dinastia regale: queste nuove immagini sem-brano create nelle fabbriche coloniali ad uso di una committenza indigena, che le userà per tut-to il iv secolo a.C., per sottolineare l’origine eroica delle nuove aristocrazie italiche.
Abstract
The iconographic studies of Bellerophon’s myth known by Attic and Italiote red figured vasesare part of the recent discussion about the meanings of images in their context; particularly itoffers the possibility of reading Greek myths in a diacronic way and taking into considerationthe ideology of clients, the work of artisans, the point of view of customers.
Therefore we can point out that the images of the Corinthian hero, known beginning fromthe archaic period up to the 4th century b.c. by the main important productions (Ionic, Corinthi-an, Attic, Etruscan and Italiote), show a range of different meanings with respect to chronolog-ical periods and cultural areas.
* Il lavoro, presentato in una prima versionecome intervento al Convegno Il greco, il barbaro ela ceramica attica (Catania-Caltanissetta-Camarina-Ge la-Vittoria-Siracusa, 2001), non è mai stato datoalle stampe in quella sede: i primi due volumi sonoapparsi nelle edizioni Bretschneider (2004 e 2005),ma rimane in preparazione il volume dedicato all’iconografia; esso si è arricchito dei dibattiti successivi che ho avuto modo di intraprendere aParigi nel Seminario di M. Gras, P. Rouillard e A.Schnapp alla Sorbonne nel 2002 ed ancora in occa-sione del Convegno del xliii Convegno di Studisulla Magna Grecia svoltosi a Taranto nel 2003. La
ricerca che si presenta è dunque completamente riformulata e maturata anche sulla base degli ulte-riori confronti e delle discussioni con i colleghi dell’Università di Salerno negli ultimi anni. In par-ticolare i miei più sinceri ringraziamenti vanno al-la Prof.ssa Angela Pontrandolfo con la quale ormaida anni condivido tali riflessioni e agli amici LucaCerchiai e Mauro Menichetti per i continui stimolie confronti. Ringrazio inoltre le Prof.sse FrancescaGhedini e Irene Favaretto che hanno voluto ospi-tare il mio lavoro nella loro prestigiosa rivista el’amica Isabella Colpo per la disponibilità accorda-tami.
«eidola» · 4 · 2007
We can register a new accent regarding the interpretation of this myth through the analysisof the red figured vases of Apulia, Lucania, Campania and Sicily, dating from the second half ofthe 5th century b.c. up to the end of the 4th century b.c.: here together with the scene ofChimera’s murder, we find out other images illustrating the entire mythological story (the departure of Bellerophon, the deliver of the letter to Proitos, the arrival to Iobates, etc.). The development of this new iconography implies the birth of a cultural pattern that uses a royal genealogy to emphasize the heroic status of the indigenous aristocracies.
e immagini del mito di Bellerofonte sono state oggetto di numerosi studi e mono-grafie che hanno portato l’attenzione sull’eroe corinzio, autore di memorabili im-
prese al pari di Teseo, Eracle e Perseo.L’interesse nel corso degli ultimi cinquant’anni si è focalizzato sulla ricca docu-
mentazione iconografica, attestata già dall’epoca arcaica nelle principali produzioni ceramiche come su monumenti ufficiali noti attraverso le fonti letterarie, e sulla fortuna che il mito ha conosciuto nella ceramica italiota fino alla fine del iv secolo.Su questo particolare aspetto si sono concentrati gli studi di K. Schauenburg, K.Schefold e N. Yalouris che hanno giustamente sottolineato il profondo cambiamentotra l’iconografia greca arcaica e classica e quella italiota nel corso del iv secolo.1 L’am-pio arco cronologico ricoperto dalle immagini del mito di Bellerofonte consente, amio parere, di proporne una lettura diacronica, fissando l’attenzione su una puntua-le analisi degli schemi iconografici e del sistema compositivo e mettendo in gioco lamentalità dei produttori come quella dei destinatari di queste immagini, al fine di pre-cisare il significato che questa raffigurazione può avere assunto nei diversi momenticrono logici e nei differenti ambiti di produzione e di recezione, e chiarire la funzio-ne di questo mito nel mondo greco e la sua rifunzionalizzazione in ambiti culturalidifferenziati.2
La saga di Bellerofonte è nota nella sua forma complessiva fin dall’epoca arcaica e lepoche varianti riconoscibili nel tempo non mutano sostanzialmente il racconto origi-nale tramandatoci da Omero e da Esiodo.3 L’eroe, figlio di Poseidone4 e di Eurymedeso Euronome, figlia del re di Megara, Nisos,5 riceve dal dio stesso il dono del cavallo ala-
10 eliana mugione
1 Per l’iconografia in età arcaica e classica cfr.Schauenburg 1956, 1958; Yalouris 1987; Sche-fold, Jung 1988; Moret 1972; limc, s.v. Pegasos, s.v.Proitos, s.v. Iobates, s.v. Steneboia. Un recente puntodel dibattito sul mito in età tardoantica in Puglia-ra 1996.
2 La bibliografia sull’argomento è molto artico-lata, si confrontino i lavori di Giudice 1997, 1998;Mugione 2000; il Convegno in onore di F. Villard,Ceramique et peinture grecque. Modes d’emploi, M. C.Villanueva Puig, F. Lissarrague, P. Rouillard, A.Rouveret (edd.), Paris, 1999; quello su La ceramiqueapulienne. Bilan et perspective, M. Denoyelle, E. Lip-polis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (edd.), Naples,2005; Le vase grec et ses destins, P. Rouillard, A. Ver-banck-Pierard (edd.), Posteach-München, 2003; e ilrecente Atene e l’Occidente. I grandi temi, E. Greco, M.Lombardo (edd.), Atene, 2007. Alle stesse proble-matiche rimandano numerosi contributi su temi
specifici cfr. Pontrandolfo 1988, Mugione 1997,Pontrandolfo 1998, Pontrandolfo, Mugione1999.
In questa direzione anche alcuni convegni tema-tici come quello pubblicato in Cerchiai 2002, equelli dedicati a Images et religion; confronta inoltrel’approccio metodologico e i risultati in Bonaudo2004; da ultimo F. H. Massa-Pairault (ed.) 2006,L’image antique et son interpretation. Fondamentale èinoltre la pubblicazione di volumi sulle ceramicheattiche analizzate in relazione ai loro contesti di rin-venimento, cfr. Reusser 2002, Reusser 2003, Seme-raro 1997, Semeraro 2005, Mannino 2004, 2006.
3 Hom., Il., ii, 6, 152-206; Hes., frg. 43, 70. 81-84Merkelbach-West.
4 Pind., O. xiii, 69; in una versione più recenteè invece figlio di Glauco (Paus., ii, 4, 3; Apollod.,bibl., ii, 3, 1).
5 Hes., frg. 43, 70. 81-84 Merkelbach-West.
L
to Pegaso.6 Giunto a Tirinto per purificarsi dall’uccisione accidentale del fratello Delia-des, Stenebea, moglie del re Proeto, si innamora di lui e gli promette il trono di Tirin-to, ma avendola Bellorofonte rifiutata, ella per vendicarsi lo accusa di averla voluta se-durre. Proeto, per non trasgredire le leggi dell’ospitalità, non lo uccide ma invia Bellerofonte da suo padre Iobates, re di Licia, con una lettera in cui chiede la morte dellatore della missiva. Iobates, per assecondare il volere del figlio, chiede a Bellerofonte dicombattere contro la Chimera, i Solimi, le Amazzoni e alcuni Lici ribelli, sicuro del suofallimento. L’eroe supera però tutte le prove con l’aiuto di Pegaso, così che Iobates, pie-no di ammirazione, gli mostra la lettera, gli dà in sposa sua figlia Philonoe e gli accor-da il suo regno.
Nel racconto mitologico tramandato da Omero e da Esiodo l’impresa contro la Chi-mera è già valorizzata come momento cruciale all’interno della saga dell’eroe;7 essa ap-pare come un evento portentoso avvenuto con il favore degli dei, il superamento di unanimale di stirpe divina, non umana, leone davanti, serpente alle spalle e capra nel mez-zo che sputa alte fiamme dalla bocca. Il favore degli dei nell’impresa di cui si fa cennonella versione di Pindaro sembrerebbe alludere al dono di Pegaso, il cavallo alato cheBellerofonte aveva domato a Corinto con l’aiuto di Poseidone.8 Proprio a questo parti-colare episodio della saga di Bellerofonte si riferiscono le prime attestazioni iconografi-che che mostrano uno schema abbastanza ripetitivo, in cui Bellerofonte è montato suPegaso, affrontato e posto sullo stesso piano della Chimera contro cui sta per scagliarela lancia. L’immagine più antica è su un piatto cicladico dall’Artemision di Taso,9 data-bile alla metà del vii secolo, alla quale va affiancata quella che compare su un dinos diproduzione coloniale dall’Incoronata dello stesso periodo cronologico (Fig. 1).10 L’ana-lisi di questo documento fatta da P. Orlandini11 e ripresa da A. Pontrandolfo12 ha mes-so in evidenza come lo schema iconografico, precocemente recepito in ambito ionico-occidentale, si richiami direttamente alle produzioni alto arcaiche orientali,13 doveBellerofonte è sempre barbato, montato su Pegaso alato, con le zampe anteriori solle-vate, mentre la Chimera è rappresentata sullo stesso piano dell’eroe, con fiamme cheescono dalle narici della testa di capra, che sembrano tradurre in immagini la descri-zione omerica della Chimera.
Lo stesso schema è riconoscibile su vasi protocorinzi coevi, come l’aryballos di Bostone la kotyle al Museo di Egina,14 ed è ripreso su vasi corinzi, ionici e calcidesi, nonché suivasi attici, databili fino alla metà del secolo successivo, con poche varianti.15 L’ultima
bellerofonte: un eroe corinzio 11
6 Nel racconto di Pausania (ii, 4, 1) è invece Ate-na a fare all’eroe il dono del cavallo alato.
7 Hom., Il., ii. 6, 152-206; Hes., Theog., 325, fr. 43Merkelbach-West.
8 Pind., O., xiii, 64-86; Paus., ii, 4, 1; cfr. per ilcommento ad Omero Kirk G. S. 1990, The Iliad: acommentary, vol. ii, books 5-8, Cambridge.
9 Piatto cicladico, Thasos, Mus. 2085 (limc, s.v.Pegasos, n. 152*).
10 Dinos, Museo della Siritide, 298978.11 Orlandini 1988, n. 49, pp. 1-16.12 Pontrandolfo 1998, pp. 97-113.13 Confronti puntuali possono essere istituiti
con i pinakes di Gortina, Hiraklion, Mus. 11509(limc, s.v. Pegasos, n. 108).
14 Aryballos protocorinzio, Boston, Museum ofFine Arts 9510 (limc, s.v. Pegasos, n. 213); kotyle protocorinzia, Egina, Mus. 233 (limc, s.v. Pegasos,n. 212), entrambi databili intorno alla metà del viisecolo.
15 Lo schema di base che prevede Bellerofontemontato su Pegaso nell’atto di scagliare la lancia af-frontato alla Chimera resta invariato, ma l’eroe èrappresentato imberbe e Pegaso non è più impen-nato: cfr. cratere frammentario, Corfù, Mus. EY 385(limc, s.v. Pegasos, n. 214*); situla ionica, Londra,British Museum 88.2-8.II (limc, s.v. Pegasos, n. 215 =Chimaira, n. 24*); hydria calcidese, Bonn, Akademi-sches Kunstmuseum 503 (limc, s.v. Pegasos, n. 216*);cratere attico dal Ceramico, Atene, Museo del Ce-
testimonianza di questa iconografia nella ceramica attica è su una coppa da Camiro, at-tribuita al pittore di Heidelberg e databile alla metà del vi secolo.16 In questa immagi-ne si introducono per la prima volta elementi nuovi, che modificano in parte lo schemacentrale: Bellerofonte non è armato e ai lati della scena sono disposte figure ammanta-te armate di lancia che sembrano mettere l’impresa dell’eroe in rapporto al sistema diclassi di età (Fig. 2).17
La fortuna che questo tema ha avuto in età arcaica ed i significati che esso aveva as-sunto sono chiariti dalla presenza dell’eroe Bellerofonte sui monumenti ufficiali comeil trono di Amicle, opera di Bathykles, noto dalla descrizione di Pausania,18 dove l’im-magine di Bellerofonte in combattimento contro la Chimera è inserita all’interno di unsistema di rappresentazioni che costituiscono un programma figurativo teso alla valo-rizzazione della regalità.19
Il tema sembra essere recepito con questo stesso significato anche nel mondo etru-sco, come suggerisce la presenza di Bellerofonte e la Chimera sull’architrave della pri-
12 eliana mugione
ramico 154, attribuito al pittore della Chimera, finevi secolo a.C. (abv, 3, 3; limc, s.v. Pegasos, n. 197*);anfora da Vari, Atene, Museo Nazionale 16389 e16391, attribuita al pittore di Bellerofonte (abv, 2, 1-2; limc, s.v. Pegasos, n. 98, Chimaira, n. 80a*-b); lou-throphoros dall’Acropoli, Atene, Museo dell’Acropo-li NA-57-Aa71, 560 a.C. (limc, s.v. Pegasos, n. 199).
16 Coppa attica a figure nere, Parigi, LouvreA478 (abv, 66, 54; limc, s.v. Pegasos, n. 209*).
17 Il significato che assumono le figure panneg-giate che affiancano le rappresentazioni di miti, dicaccia e del ritorno del guerriero è stato ben sotto-lineato da Schnapp 1979, 1997; Lissarrague 19891990.
18 Paus., iii, 18, 13. È ancora Pausania (ii, 27, 2) aparlare del trono di Asklepios ad Epidauro, opera diTrasimedes, mentre Euripide (Ion., 201-204) ci tra-manda una pittura del tempio di Apollo a Delfi.
19 Faustoferri 1996.
Fig. 1. Museo della Siritide, 298978. Dinos dall’Incoronata. Metà del vii secolo a.C.(foto Museo, Archivio dell’Università di Salerno).
ma stanza della Tomba dei Tori; l’eroe è rappresentato come un giovane cavaliere vestito all’orientale, privo di armi e montato su cavallo alato mentre affronta la Chi-mera; l’associazione della scena con l’agguato di Achille a Troilo che compare sulla pa-rete di fondo consente di ricostruire l’intero sistema iconologico, caricandolo di valen-ze funerarie.20
Bellerofonte è invece rappresentato nella ceramica attica a figure rosse raramente esolo nella seconda metà del v secolo; lo schema iconografico diffuso in età arcaica si ri-scontra solo su un askòs della fine del v secolo21 e su una pelike attribuita al pittore diBarclay,22 proveniente da Nola o più probabilmente da Caere, come ha suggerito Do-minique Briquel per la presenza dell’iscrizione «suthina».23 In queste immagini, si rico-nosce una significativa variazione: Bellerofonte non è più rappresentato sullo stesso pia-no della Chimera ma assume una posizione predominante, che sembra sottolineare ilsuo statuto eroico (Fig. 3).24
Accanto allo schema di tradizione arcaica, con le variazioni riscontrate, la produ -zione attica elabora sullo scorcio del v secolo una nuova iconografia dove l’impresa di Bellerofonte è associata ai Lici. Tale iconografia sembra un’assoluta invenzione dei ce-ramografi ateniesi dal momento che non vi è alcun riscontro di tale episodio nella tra-
bellerofonte: un eroe corinzio 13
20 Giuliano 1969; Cerchiai 1987; Torelli1997, 2000.
21 Askos attico a figure rosse, Parigi, LouvreG446 (limc, s.v. Pegasos, n. 211).
22 Pelike attica a figure rosse, Parigi, LouvreG535 (arv, 1067, 9; limc, s.v. Pegasos, n. 210*).
23 Briquel, in «ree», 2001, pp. 336-338.24 Lo stesso schema è noto sempre alla fine del
v secolo su due stele funerarie da Tebe, al Museo diTebe (limc, s.v. Pegasos, n. 181* e limc, s.v. Pegasos,n. 157), dove Bellerofonte è presentato completa-mente armato (con corazza ed elmo) e sovrasta laChimera. Tali documenti mi sembrano importantiper descrivere un interesse verso il soggetto mitolo-gico in ambiente peloponnesiaco dal quale sembra-no derivare alcune iconografie italiote.
Fig. 2. Parigi, Louvre A478. Coppa attica a figure nere da Camino.Pittore di Heidelberg, seconda metà del vi secolo a.C. (limc, s.v. Pegasos, n. 209).
dizione letteraria che in-vece narra di un’impresadell’eroe contro i Lici.25Il combattimento controla Chimera assieme ai Lici è riprodotto su vasidatabili tra la fine del v egli inizi del iv secoloa.C.:26 Bellerofonte èpresentato come il capodei Lici, in posizione pre-dominante, ma il com-battimento contro laChimera viene ad assu-mere il valore di una cac-cia collettiva ad opera dipersonaggi di origineorientale (Fig. 4).
Entrambi gli schemiadottati nella ceramicaattica sono attestati suvasi rinvenuti in Occi-dente, in particolare neicentri dell’area tirrenica,ed entrambi sono rap-
presentati anche sui vasi italioti;27 lo schema di tradizione arcaica che mostra Bellero-fonte da solo contro la Chimera, modificato per la posizione predominante dell’eroe co-me sui vasi attici della fine del v secolo, si riscontra infatti su un cratere lucano attribuitoal pittore di Creusa28 ed è rappresentato per tutto il iv secolo (Fig. 5).29
Già nella ceramica protoapula, in particolare nelle officine tarantine, questa imma-gine viene però rielaborata con segni aggiuntivi che precisano il senso della rappresen-
14 eliana mugione
25 Pind., O., xiii, 87-91. All’orizzonte cronologi-co della fine del v secolo rimandano anche i fram-menti della tragedia perduta di Euripide, Bellero-phontes, tgf, 2, frg. 285-315, nella quale è presentatoil destino tragico dell’eroe, che, nel tentare di rag-giungere l’Olimpo sul suo cavallo alato, fu disarcio-nato da Pegaso, punto da un tafano, inviato da Zeus.L’episodio è noto anche da Pind., Ist., 7, 44-46.
26 Cratere attico a figure rosse, Ginevra, MuseoCivico 1911.163, attribuito al pittore di Pronomos(arv, 1337, 6; limc, s.v. Pegasos, n. 190); cratere atti-co a figure rosse, Napoli, Museo Nazionale H3243,da Sant’Agata dei Goti, attribuito al gruppo Buda-pest (arv, 1439, 2; limc, s.v. Pegasos, n. 191a); cratereattico a figure rosse, Lecce, Museo Prov. 4530 (limc,s.v. Pegasos, n. 191b); fr. di cratere attico a figure rosse, Corinto, Mus. C 31-82, da Corinto (limc, s.v.Pegasos, n. 190a).
27 Lo stretto rapporto che lega i centri dell’areatirrenica già dalla fase alto arcaica e per tutto il v secolo è ben delineato in Colonna 2000, che ne evidenzia i legami con l’area peloponnesiaca, in particolare pp. 284 ss.; cfr. anche Mugione 2000, dove è sottolineata la comune identità culturale tirrenica che si evince anche da una simile circola-zione di pittori e temi della ceramica attica.
28 Cratere a figure rosse lucano, Palermo, Mus.Nazionale 1014 (lcs, 95, 499; limc, s.v. Pegasos, n.202*).
29 Lo schema è noto su un piatto apulo, Taran-to, Museo Nazionale 9487, da Altamura, attribuitoal pittore di Baltimora (limc, s.v. Pegasos, n. 154*); suun’anfora campana a figure rosse, New York, Me-tropolitan Museum of Arts 1906.1021.240 attribuitaal pittore di Issione (lcs, 339, 801, tav. 132; limc, s.v.Pegasos, n. 156*).
Fig. 3. Parigi, Louvre G535. Pelike attica a figure rosse.Pittore di Barclay, seconda metà del v secolo a.C.(foto Museo, Archivio dell’Università di Salerno).
tazione. Su un crateredella Collezione Jatta attribuito al pittore di Sisifo (Fig. 6)30 Bellero-fonte è in posizione pre-dominante rispetto allaChimera ma non in at-teggiamento di combat-timento ed è affiancatoda Poseidone e da Atena;questa indossa un elmofrigio ed è presentata co-me colei che dà la metisall’eroe e gli assicura lavittoria, attraverso il gio-co dell’immagine dellaChimera riflessa al cen-tro del suo scudo che interviene in maniera decisiva a neutralizzare ilmostro.31 Su una oino-choe al Museo di Taran -to32 databile al primo quarto del iv secolo (Fig. 7), l’impresa è ancora una volta postasotto la tutela di Atena e l’immagine tende ancora di più ad esplicitare il momento dell’eroizzazione attraverso la presenza della Nike che giunge ad incoronare Bellero-fonte. Anche in questo caso il gesto della mano di Atena ed il suo sguardo rivolto versola Chimera assicurano il buon esito dell’impresa; il mostro è raffigurato nel momentodi una caccia al cerbiatto che si interrompe quando il suo sguardo incontra quello del-la dea. Più difficile è invece la comprensione dell’inserimento della figura di Papposile-no accanto al ramo di alloro che chiude a sinistra la composizione, ma non si può nonsottolineare come l’ambiente dionisiaco ed il richiamo ai suoi culti e misteri comincinoad essere un Leitmotiv diffuso nell’immaginario delle popolazioni italiche.33 Lo stessosegno iconografico compare anche su una hydria campana databile alla metà del iv se-colo attribuita al pittore di Issione (Fig. 8).34 Su questa immagine Bellerofonte, in tut-to assimilato agli eroi greci, con pilos e mantello, assistito da Poseidone e incoronato daNike, combatte accanto a Pegaso la Chimera in fuga; la scena è ambientata in prossi-mità di una fontana dove sono una donna, un Panisco, ed un giovane. L’iconografia èancora più significativa se si considera che essa si inserisce all’interno della produzionedi un’officina campana che sembra privilegiare, contrariamente al resto della produ-
bellerofonte: un eroe corinzio 15
30 Cratere apulo a figure rosse, Ruvo, Collezio-ne Jatta 1091, attribuito al pittore di Sisifo (rvap, i,24, 107; limc, s.v. Pegasos, n. 195*).
31 Per la lettura dell’elmo frigio di Atena e dei significati che assume cfr. Mugione 2002, Cerchiai2002; sulla metis di Atena cfr. Menichetti 2003,2006a, 2007b.
32 Oinochoe, Taranto, Museo Nazionale 711.37, attribuita al pittore di Felton (rvap, i, 174, 1; limc,s.v. Pegasos, n. 192*).
33 Pontrandolfo 1988; Mugione 1996; Pon-trandolfo 1998, 2000; Pouzadoux 2001.
34 Hydria campana a figure rosse, Napoli, colle-zione privata 503 (lcs, suppl. 3, 201, 342a, tav. 23, 6;limc, s.v. Pegasos, n. 226*).
Fig. 4. Ginevra, Museo Civico 1911.163.Cratere attico a figure rosse, attribuito al pittore di Pronomos,
fine del v secolo a.C. (limc, s.v. Pegasos, n. 190).
zione campana, temi asoggetto mitologico,mettendo in campo, at-traverso un immaginariotratto dalla tradizionegreca, l’ideologia dellearistocrazie italiche incerca di un passato glo-rioso che dia lustro alleproprie origini.35
Il mito di Bellerofontetrova quindi fortuna nelmondo occidentale cheelabora già alla fine del vsecolo una propria ico-nografia, da un lato, se-lezionando nuovi segniper sottolineare l’eroiz-zazione di Bellerofontegrazie all’impresa controla Chimera, dall’altrorappresentando anchealtri momenti del mito,mettendo in scena cosìper excerpta l’intera sagadell’eroe. Accanto alcombattimento controla Chimera, i vasi italiotirappresentano, infatti,già dalla fine del v secoloaltri due momenti moltosignificativi della saga: lapartenza di Bellerofontee la consegna della lette-ra da parte di Proeto.
Immagini della par-tenza di Bellerofonte so-no note su un’anfora pa-natenaica del pittore diAmykos da Anzi (Fig. 9),
16 eliana mugione
35 Sulle iconografie del pittore di Issione cfr. M.T. Falivene, Il pittore di Issione, tesi di dottorato,Perugia, 2005; cfr. inoltre M. T. Falivene, Letturaiconografica di un tema mitologico dell’officina del pitto-re di Issione, in Giornate di Studio in onore di G. SenaChiesa, 28-29 ottobre 2004, in c.d.s.
Sui significati specifici di tali iconografie all’in-terno del sistema delle aristocrazie campane cfr.Mugione 2004, Zevi 2004, Pontrandolfo A.c.d.s., Diffusione e recezione dell’immagine di Enea inOccidente, in Il Greco il barbaro e la ceramica attica, At-ti del Convegno (Catania-Caltanissetta-Camarina-Gela-Vittoria-Siracusa, 2001), vol. iii, c.d.s.
Fig. 5. Palermo, Museo Nazionale 1014.Cratere a figure rosse lucano. Pittore di Amykos, 440-420 a.C.
(foto Museo, Archivio dell’Università di Salerno).
Fig. 6. Ruvo, Collezione Jatta 1091.Cratere apulo a figure rosse, da Ruvo.
Pittore di Sisifo, 440-430 a.C. (limc, s.v. Pegasos, n. 195).
su un cratere a calice delpittore di Hearst e su unostamnos del pittore diArianna,36 e, nel corsodel iv secolo, su una hy-dria pestana firmata daAsteas, proveniente daAgropoli e su molti vasidi produzione apula ecampana (Fig. 10).37 Taliimmagini sono semprestate considerate in rela-zione alla tragedia di Eu-ripide, messa in scena do-po il 420;38 esse da un latosembrano spostare l’ac-cento sulla figura femmi-nile, Stenebea, presen-tando il mito in unaversione inedita che sot-tolinea il ruolo femmi -nile all’interno della stir-pe, dall’altro, attraversola presentazione del mo-mento iniziale del rac-conto mitico, sembrano, a mio parere, voler sottolineare il percorso compiuto dall’eroeper la propria legittimazione.39 Mi sembra importante mettere in evidenza come sulloscorcio del v secolo scene con la partenza di Bellerofonte sono attestate su vasi prodot-ti da officine coloniali della costa ionica, che hanno una committenza privilegiata neicentri indigeni.40
La produzione tarantina, che abbiamo visto alla fine del v secolo valorizzare il si-gnificato eroico dell’impresa contro la Chimera attraverso l’intervento di Atena e Po-
bellerofonte: un eroe corinzio 17
36 Anfora panatenaica del pittore di Amykos, daAnzi, Napoli, Museo Nazionale 82263 (H2418) (lcs,44, 218; Pontrandolfo 1996, pp. 47-48, dove attra-verso documenti di archivio è accertata la prove-ninza da Anzi e non da Ruvo; limc, s.v. Proitos, n.1*); cratere a calice attribuito al pittore di Hearst,Bonn, Akademisches KunstMuseum 80 (rvap, i, 14,49; limc, s.v. Proitos, n. 2*); stamnos del pittore diArianna, Boston Museum of Fine Arts 1900.349(rvap, i, 24, 104; limc, s.v. Proitos, n. 3*).
37 Hydria di Asteas, Paestum, Museo Nazionale20202, da Agropoli (rvp, 86, 134, tavv. 55-56; limc,s.v. Proitos, n. 5*); con la stessa iconografia craterea volute apulo, Ruvo, Museo Jatta 1499, da Ruvo,attribuito al gruppo della Pelike di Mosca (rvap, i,169, 33; limc, s.v. Proitos, n. 4*); cratere a campana
campano, Ginevra, collezione privata (lcs, suppl.2, 221, 281a e suppl. 3, 198, 281a, attribuito al grup-po di Napoli 3227; limc, s.v. Proitos, n. 6); hydriacampana, da Capua, Capua, Museo Campano 7459,attribuito al pittore di Caivano (lcs, 308, 571; limc,s.v. Proitos, n. 7*).
38 Eur., Bell., tgf, 2, frg. 285-315.39 Confronta anche il ruolo che viene ad assu-
mere la figura di Medea nella saga degli Argonau-ti, Pontrandolfo, Mugione 1999; Pouzadoux2005; Pouzadoux 2007.
40 Sul vaso vaso del pittore di Amykos, prodottoa Metaponto e rinvenuto ad Anzi, cfr. Pontran-dolfo 1996; sulle produzioni dei pittori di Hearst edi Arianna e sul loro legame con officine della costaionica, cfr. Pontrandolfo 1999, Denoyelle 2005.
Fig. 7. Taranto, Museo Nazionale 7.11.37.Oinochoe apula a figure rosse, attribuita al pittore di Felton.
Inizi del iv secolo a.C. (limc, s.v. Pegasos, n. 192).
seidone, privilegia inve-ce un altro aspetto dellasaga. Sull’anfora attri-buita al pittore di Gravi-na, databile sullo scorciodel v secolo, è rappre-sentata Stenebea che sigetta nel mare dopo il rifiuto di Bellerofonte,mentre l’eroe assiste allascena montato su Pega-so ed affiancato dalle di-vinità: Poseidone e Tri-tone da un lato, Afroditeed Eros dall’altro (Fig.11).41 La scena rappre-sentata sull’altro lato delvaso, dove due giovaniporgono corone a duefanciulle, sembra chiari-re il significato dell’im-magine contrapponen-do un corretto sistemadi sedu zione ad un rap-porto amoroso erratocon conseguenze nefa-ste. In questo caso ilcontesto di rinvenimen-to, una ricca sepoltura asemicamera dell’anticaSilbìon, aiuta a com-prendere il valore chel’immagine assume an-che in relazione agli altrioggetti di corredo; que-sti sembrano ricompor-re un sistema semanticocomplesso che, attra ver -so la rappresentazione dimiti e di temi che valo-rizzano il rapporto amo-roso, mette in scenal’immagine di un’eroiz-
18 eliana mugione
41 Anfora protoitaliota attribuita al pittore diGravina, da Gravina T. 1 prop. Ferrante, Taranto,Museo Nazionale 177005 (ravp, 2, 2, tav. 8, 3; limc,
s.v. Steneboia, n. 3*); la fine tragica dell’eroina dove-va essere raccontata in Eur., Steneb., tgf, 2, frg. 661-672.
Fig. 8. Napoli, collezione privata 503.Hydria campana, attribuita al pittore di Issione. 340-330 a.C.(foto Soprintendenza, Archivio dell’Università di Salerno).
Fig. 9. Napoli, Museo Archeologico Nazionale 82263 (H 2418).Anfora panatenaica lucana a figure rosse del pittore di Amykos,
da Anzi, 420 a.C. (foto Museo, Archivio dell’Università di Salerno).
zazione dove l’elementomaschile e quello fem-minile sembrano gioca-re ruoli diversi e comple-mentari, ma entrambifondanti e costitutivi del-l’aggregazione sociale.42
A partire dalla metàdel iv secolo l’icono -grafia di Bellerofontesem bra subire un’altra significativa variazione,riconoscibile soprattuttonelle produzioni apuledei pittori di Dario e Bal-timora che raffigu ranoimmagini tese a sottoli-nerare il valore eroicodell’impresa di Bellero-fonte. Accanto alla partenza di Bellerofonte e all’uccisione della Chimera, i pittori di Dario e Baltimora rappresentano l’episodio dell’arrivo dell’eroe da Iobate, re dei Lici. Ilracconto così come doveva essere narrato anche nella tragedia di Sofocle,43 descrive ilmomento in cui Iobate riceve la lettera di Proeto, con la quale gli viene detto di mette-re a morte il latore della missiva; Iobate manda Bellerofonte ad affrontare prove diffici-lissime, sicuro che ne avrebbe trovato la morte, ma, dopo il buon esito delle imprese,contro la Chimera, le Amazzoni, i Solimi, e i Lici, riconosce in lui un eroe e gli accordala figlia Philonoe e l’eredità del suo reame. È dunque proprio l’arrivo dal re dei Lici, al-l’interno del percorso compiuto, il momento in cui si concretizza per Bellerofonte lapossibilità di accedere alla regalità, attraverso la prova dell’uccisione del mostro che gligarantisce l’eroizzazione. Sul cratere a calice del pittore di Dario, conservato a ForthWorth (Fig. 12)44 sul registro superiore vi è, alla presenza di Poseidone, Bellerofontemontato su Pegaso con la lettera tra le mani; al centro lo scudo e le ruote di carro so-spesi ambientano la scena nel palazzo reale di Iobate; il re Licio in abiti orientali, conscettro, è semidisteso sulla kline nel registro inferiore, tra un Licio e la figlia Philonoe
bellerofonte: un eroe corinzio 19
42 Il corredo della tomba a semicamera 1 in pro-prietà Ferrante di Gravina di Puglia è costituito daoggetti di produzione attica e protoitaliota che ri-compongono attraverso le immagini un sistemacoerente: un cratere a volute, Taranto, Museo Na-zionale 177001 che rappresenta gli Argonauti a Lem-no e una caccia al cinghiale calidonio; cinque anfo-re panatenaiche (Taranto, Museo Nazionale 177002,177003, 17004, 177005, 17006), tra cui quella con Bel-lerofonte e Stenebea, cui sono associate un’anforacon il mito di Elettra ed Oreste alla tomba di Aga-mennone, una con l’eroizzazione del defunto rap-presentato su un piedistallo, un’altra ancora con
un’offerta al defunto, mentre l’ultima presenta unadonna seduta su diphros attorniata da giovani fan-ciulle. Il corredo è completato da vasi attici: tre ky-likes, un kantharos, tre oinochoai configurate ed unalekanìs, che recano scene significative come il rattodelle Leucippidi e gli eroi dell’Ilioupersis. Per il cor-redo cfr. Ciancio 1997; per una lettura iconograficain sistema Mugione 2002a.
43 Soph., Iob., trgf, iv, F 297-299.44 Cratere a calice apulo, Forth Worth, Kimbell
Art Museum, Hunt Coll. (rvap, ii, 501,64a; limc,s.v. Iobates, n. 1*).
Fig. 10. Paestum, Museo Nazionale 20202.Hydria pestana firmata da Asteas, proveniente da Agropoli
(foto Museo, Archivio dell’Università di Salerno).
raffigurata in fuga verso un louterion.45Tutta la scena sembra acquistare il sensodi un’apparizione: al di sotto della kline sono dipinte phialai mesonfaliche, unaoinochoe e un kantharos che da un lato potrebbero indicare il banchetto interrot-to, dall’altro potrebbero alludere ad unculto eroico, testimoniato del resto daPausania (ii, 2, 4) che ricorda un culto di Bellerofonte a Corinto nel temenos di Afro-dite Melainis e a Tlos in prossimità dellasua tomba.46 Questo diverso significatoche assume il mito di Bellerofonte sembra ripercorrere attraverso altri segni quelloespresso dall’immagine nota da una tomba figurata in Licia, databile alla finedell’arcaismo. Sulla parete di fondo di unatomba a camera, all’interno di un com-plesso sistema di raffigurazioni, l’eroe Bellerofonte è raffigurato accanto allaChimera domata, all’interno di una pro-cessione che giunge fino alla regina sedu-ta in trono.47
Nella stessa produzione del pittore diDario vi è, sul lato secondario del cratereomonimo al Museo di Napoli,48 Belle -rofonte in combattimento contro la Chi-mera, attorniato dai Lici, in un’impresacollettiva, come nello schema attico rico-nosciuto sui vasi della fine del v secolo
a.C. La scena, articolata su tre registri, presenta una serie di segni aggiuntivi, che ten-dono a moltiplicare i livelli di lettura possibili (Fig. 13). Sul registro inferiore sono rap-presentati i Lici; al centro della composizione vi è la Chimera che un Licio sta per col-pire con una pietra; sull’ultimo livello vi è Bellerofonte, che sta per essere incoronatoda una Nike, attorniato da Apollo, Poseidone e Pan. La composizione stessa distinguelo spazio divino da quello umano, ponendo Bellerofonte all’incrocio di due mondi emette in risalto il suo statuto di eroe. L’interessante analisi del programma figurativo
20 eliana mugione
45 Con lo stesso schema: il cratere a calice a Lon-dra, Kusthandel Sothebt 10. dicembre 1984 n. 365º,del pittore di Dario (limc, s.v. Iobates, n. 3*), e la lou-trophoros, collezione privata, attribuita al pittore diBaltimora (limc, s.v. Iobates, n. 4).
46 La notizia è riportata da Q. Smyrn., 10, 162-163; da Tlos proviene anche una lastra tombale inbassorilievo di età ellenistica (Londra, British Mu-seum), che raffigura Bellerofonte che combatte laChimera, sovrastandola, nello schema riscontrato
sulle raffigurazioni della seconda metà del v seco-lo (limc, s.v. Pegasos, n. 204*); lo stesso schema èutilizzato agli inizi del iv secolo sull’Heroon diGolbasi-Trysa (limc, s.v. Pegasos, n. 203*).
47 Si confronti la pubblicazione del complessopittorico in Mellink 1998.
48 Cratere a volute, Napoli, Museo Nazionale81947 (H3253), da Canosa (rvap, ii 495, 38; limc, s.v.Pegasos, n. 187c).
Fig. 11. Taranto, Museo Nazionale 177005.Anfora panatenaica protoapula a figure rosse,
da Gravina T.1 prop. Ferrante. Pittoredi Gravina, 420-400 a.C. (foto Museo,Archivio dell’Università di Salerno).
espresso da questo com-plesso documento e dalsuo contesto di rinve -nimento proposta di re-cente da C. Pouzadouxha sottolineato come suquesti vasi, per i quali èchiara la destinazione funeraria, siano rappre-sentati temi ed iconogra-fie completamente rifun-zionalizzati ad uso di unacommittenza daunia.49Moltiplicando i sensi dilettura, le immagini ten-dono a ricostruire in unsistema unico le diverseparti di un racconto miti-co, anticipando quasi larisistemazione letterariache avverrà con Apollonio Rodio.50 Tali immagini tendono inoltre a sottolineare nuo-ve forme di esaltazione individuale assumendo così il valore di un exemplum, che cometale può essere utilizzato dalle aristocrazie italiche di volta in volta con significati diver-si, sia per dare lustro alla propria origine e legittimare la propria identità politica, sia,come ha sottolineato L. Giuliani, come supporto all’elogio funebre.51 Ancora una voltail senso dell’immagine è precisato dall’intero sistema di segni messo in campo nel riccocorredo canosino che esalta l’eroizzazione del defunto, probabilmente un cavaliere se-polto in un ipogeo a doppia camera con la sua armatura e con i morsi dei cavalli, attra-verso i miti troiani rappresentati sui due crateri a volute, ma valorizza anche il mondofemminile sulle louthrophoroi che presentano immagini di eroine dal tragico destinoquali Europa, Andromeda e Medea.52
Il cratere di Bari della collezione Macinagrossa53 attribuito alla produzione del pitto-re di Baltimora (Fig. 14), che gli studi di M. Mazzei54 hanno giustamente ricollegato inmaniera diretta ad Arpi, è ancora più ridondante di segni: Bellerofonte montato su Pe-gaso, armato del tridente di Poseidon, combatte contro la Chimera attorniato dai Lici;una Nike giunge ad incoronarlo alla presenza di Zeus ed Atena. La dea è seduta accan-to al suo scudo ed ha un elmo frigio tra le mani; questo segno non consueto nell’ico-
bellerofonte: un eroe corinzio 21
49 Pouzadoux 1998; da ultimo Zevi 2004 pro-pone una lettura storicizzata del vaso di Dario, ri-collegandolo alla campagna del Molosso e ai suoirapporti con Roma.
50 La risistemazione del mito di Bellerofonte in-torno alla metà del iv secolo è testimoniata anchedalla versione di Apollod., bibl., ii (30-33), 3, 1-2 cheripropone l’intero racconto mitologico con piccolemodifiche, come ad es. la paternità di Glauco, figliodi Poseidone.
51 Giuliani 1988, 1995 e 1997.52 Sull’ipogeo del Vaso di Dario cfr. Cassano
1992, Pouzadoux 1998; per una rilettura del mito diMedea in stretta relazione con l’iconografia dei PersenVasen, cfr. Pouzadoux 2007.
53 Cratere apulo a figure rosse, Bari, collezioneMacinagrossa, pittore di Baltimora (rvap, ii 865, 22;limc, s.v. Pegasos, n. 187a).
54 Mazzei 1992, 1999, 2005.
Fig. 12. Forth Worth, Kimbell Art Museum.Cratere a calice apulo a figure rosse. Pittore di Dario,
intorno alla metà del iv secolo a.C. (limc, s.v. Iobates, n. 1).
22 eliana mugione
Fig. 13. Napoli, Museo Archeologico Nazionale 81947 (H 3253).Cratere a volute apulo a figure rosse. Pittore di Dario, 340-330 a.C.
(foto Museo, Archivio dell’Università di Salerno).
nografia di Atena sembra assu-mere un doppio valore seman-tico: da un lato è esibito comeproprio dalla divinità che vienead assumere così una connota-zione troiana,55 e si presentacome divinità guerriera che assicura la vittoria, dall’altrosembra essere il premio del-l’eroe vincitore del mostro, in-coronato da Nike, che graziealla sua impresa potrà calzarel’elmo frigio e porsi a capo deiLici, rimettendo in gioco conaltri codici visivi e culturali il si-gnificato di regalità che il mitodi Bellerofonte aveva già avutoin età arcaica. Ancora un altrosegno iconografico interviene,a mio parere, ad indicare che èproprio Atena a dare la metis al-l’eroe e ad assicurargli la vitto-ria: è il gioco dell’immagine delgorgoneion dello scudo che si ri-flette sulla pelta del Licio accor-so in aiuto di Bellero fonte e paralizza il mostro.56 Se questaimmagine attraverso un insie-me di segni significativi rico-struisce un valore semanticocomplesso del mito di Belle -rofonte, lo stesso pittore di Baltimora ricompone in un racconto unico l’iconografia diBellerofonte in combattimentocontro la Chimera assieme aiLici ed il momento dell’arrivoda Iobate, sovrapponendoli suidue registri di un altro cratere avolute (Fig. 15).57 Sul registro superiore Iobate, con lo scettro
bellerofonte: un eroe corinzio 23
55 Il valore dell’Atena troiana è stato analizzatoin Breglia 1998, 2002; Mugione 2002.
56 Stesso schema anche su un cratere da Ruvo alMuseo di Karlsruhe B4, attribuito sempre al pittoredi Dario (limc, s.v. Pegasos, n. 187b*).
57 Cratere a volute, Kunsthandel, attribuito alpittore di Baltimora (limc, s.v. Iobates, n. 12*); stessoschema anche per il cratere a volute da una colle-zione privata (limc, s.v. Iobates, n. 13*).
Fig. 14. Bari, collezione Macinagrossa. Cratere a voluteapulo a figure rosse. Pittore di Baltimora, 340-330 a.C.
(limc, s.v. Pegasos, n. 187a).
Fig. 15. Kusthandel. Cratere a volute apulo a figure rosse.Pittore di Baltimora, 340-330 a.C. (limc, s.v. Iobates, n. 13).
è seduto sul trono accan-to a Philonoe, attorniatodai Lici; nel campo sonosospese le ruote di carro.Bellerofonte è raffigura-to sul registro infe riore,sullo stesso asse compo-sitivo di Iobate, in com-battimento contro laChimera insieme ai Lici,mentre una Nike giungead incoronarlo. In questascena è espresso tuttoil percorso compiuto daBellerofonte, raffiguratosu altri vasi per singoliepisodi, e tutto il sistemadi segni che diventanofondamentali per esplici-tare il racconto mitico.
Attraverso il percorsodelle immagini, contestualizzandole nel tempo e nello spazio, si recupera dunque il va-lore complesso che il mito di Bellerofonte aveva assunto di volta in volta, esemplifican-do attraverso i diversi momenti del racconto aspetti puntuali nel percorso dell’eroeadatti a rappresentare l’ideologia tanto dei produttori quanto dei destinatari del lin-guaggio figurativo. Alla luce dell’uso e della rifunzionalizzazione del mito presso le co-munità italiche nel corso della seconda metà del iv secolo si possono comprendere piùa fondo anche scene che parlano un linguaggio più semplice e solo apparentementepiù banale; l’adozione di uno solo dei segni iconografici riconosciuti sui grandi vasi de-posti nelle sepolture aristocratiche del mondo lucano e dauno sembra immediatamen-te richiamare alla mente il senso di lettura esplicitato più chiaramente dalle immaginipiù complesse. Così la grande lekane, attribuita al pittore di Baltimora,58 sintetizza inun’iconografia brachilogica l’intero percorso compiuto dall’eroe per la propria legitti-mazione: Bellerofonte, calzato di un elmo frigio, combatte e sovrasta, isolato, la Chi-mera (Fig. 16).
24 eliana mugione
58 Lekane apula da una collezione privata tede-sca (limc, s.v. Pegasos, n. 155*); con lo stesso schemama senza l’elmo frigio Bellerofonte è su un piatto
apulo, Taranto, Museo Nazionale 9487, da Altamu-ra, sempre attribuito al pittore di Baltimora (rvap,ii 879, 136; limc, s.v. Pegasos, n. 154*).
Fig. 16. Collezione privata, Germania.Lekane apula a figure rosse, pittore di Baltimora
(limc, s.v. Pegasos, n. 154).
Bibliografia
Bonaudo R. 2004, La culla di Hermes. Iconografia e immaginario delle hydriai ceretane, Roma.Breglia L. 1998, Atena e il mare: problemi e ipotesi sull’Athenaion di Punta della Campanella, in I
culti della Campania antica, Roma, pp. 97-108.Breglia L. 2002, Elmo frigio, Atena Iliàs, Palladio, in Cerchiai 2002, pp. 103-134.Cassano R. 1992, L’ipogeo del vaso di Dario, in Principi imperatori e vescovi. Duemila anni di storia a
Canosa, Venezia, pp. 176-186.Cerchiai L. 1987, Sulle Tombe del Tuffatore e della Caccia e della Pesca. Proposta di lettura iconologica,
«DialA», 5, pp. 113-123.Cerchiai L. 2002 (ed.), L’iconografia di Atena con elmo frigio in Italia Meridionale, Atti della Gior-
nata di Studio (Fisciano, 12 giugno 1998), Napoli («Quaderni di “Ostraka”», 5).Ciancio A. 1997, Silbion, Bari.Colonna G. 2000, Il santuario di Pyrgi dalle origini mitostoriche agli altorilievi frontonali dei Sette e
di Leucotea, in Dei ed eroi greci in Etruria. L’altorilievo di Pyrgi con i Sette contro Tebe, Atti del Col-loquio internazionale (Roma-Santa Severa, 14-16 Aprile 1997), «ScAnt», 10, pp. 251-336.
Denoyelle M. 2005, L’approche stylistique: bilan et perspectives, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M.Mazzei, C. Pouzadoux (edd.), La céramique apulienne. Bilan et perspective, Napoli, pp. 103-112.
Faustoferri A. 1996, Il trono di Amyklai a Sparta. Bathykles al servizio del potere, Napoli.Giudice F. 1997, Le importazioni attiche in Magna Grecia: appunti per una definizione del quadro di
riferimento, «Ostraka», vi, 2, pp. 401-413.Giudice F. 1999, Il viaggio delle immagini da Atene verso l’Occidente ed il fenomeno del rapporto tra
prodigi e fortuna iconografica, in Le mythe grec dans l’Italie antique, F. H. Massa-Pairault ed., Ro-ma, pp. 267-327.
Giuliani L. 1988, Bildervasen aus Apulien, Berlin.Giuliani L. 1995, Tragik, Trauer und Trost. Bildervasen fur eine apulische Totenfeier, Hannover.Giuliani L. 1999, Contenuto narrativo e significato allegorico nella ceramica apula, in Im Spiegel der
Mythos. Bildernwelt und Lebenswelt, Wiesbaden («Palilia», 6), pp. 43-51.Giuliano A. 1969, Osservazioni sulle pitture della tomba dei Tori a Tarquinia, «StEtr», 37, pp. 4-26,
pl. 1-8.lcs, A. D. Trendall 1967, The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford [e Suppl.
1970, 1973, 1983].Lissarrague F. 1989, L’immaginario del simposio greco, Paris.Lissarrague F. 1990, L’autre guerrier. Archers, peltastes cavaliers dans l’imagerie attique, Paris-Rome.Mannino K. 2004, I vasi attici di età classica nella Puglia anellenica: osservazioni sui contesti di
rinvenimento, in L. Braccesi, M. Luni (edd.), I Greci in Adriatico 2, Roma («Hesperìa. Studisulla grecità d’Occidente», 8), pp. 333-355.
Mazzei M. 1999, Committenza e mito. Esempi dalla Puglia settentrionale, in Le mythe grec dans l’Italieantique, F. H. Massa-Pairault ed., Roma, pp. 467-477.
Mazzei M. 2005, La ceramica apula: aspetti e problemi, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Maz-zei, C. Pouzadoux (edd.), La céramique apulienne. Bilan et perspective, Napoli, pp. 11-18.
Mellink M. J. 1998, Kyzilbel. An archaic painted tomb chamber in Lycia, Philadelphia.Menichetti M. 2003, Atena e lo scudo di Diomede ad Argo, «Ostraka», xii, 1, pp. 33-41.Menichetti M. 2006a (con D. Lo Scalzo), Lo sguardo di Medea e l’inganno delle nozze in
Euripide, «Eidola. International Journal of Classical Art History», 3, pp. 29-49.Menichetti M. 2006b, Lo specchio di Hera e gli specchi di Atena su un vaso del pittore di Dolone, in
F. H. Massa-Pairault (ed.), L’image antique et son interpretation, Roma, pp. 261-275.Moret J. M. 1972, Le depart de Bellerophon sur un cratere campanien de Geneve, «AntK», 15, pp. 95-106.Mugione E. 1997, Temi figurativi della ceramica attica in Occidente. Un’esemplificazione: il mito di
Teseo, «Ostraka» vi, 1, pp. 109-128.
bellerofonte: un eroe corinzio 25
Mugione E. 2000, Miti della ceramica attica in occidente. Problemi di trasmissioni iconografiche nelleproduzioni italiote, Taranto.
Mugione E. 2002a, Le immagini di Atena con elmo frigio nella ceramica italiota, in Cerchiai 2002,pp. 63-80.
Mugione E. 2002b, La selezione dei temi figurativi della tomba 1 di Gravina di Puglia, in Iconografia2001. Studi sull’immagine, Atti del Convegno (Padova, 30 maggio-1º giugno 2001), a cura diI. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini, Roma, pp. 91-100.
Mugione E. 2004, L’iconografia del guerriero nelle produzioni tirreniche, in Alessandro il Molosso e icondottieri in Magna Grecia, Atti del xliii Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto,2003), Napoli, pp. 727-756.
Orlandini P. 1988, Due nuovi vasi figurati di stile orientalizzante dagli scavi dell’Incoronata di Meta-ponto, «BdA», 73, 49, pp. 1-16.
Pontrandolfo A. 1988, L’escatologia popolare e i riti funerari greci, in G. Pugliese Carratelli(ed.), Magna Grecia iii. Vita religiosa e cultura letteraria, filosofica e scientifica, Milano, pp. 171-196.
Pontrandolfo A. 1992, Personaggi mascherati nella tradizione figurativa dell’Italia meridionale,«AttiMemMagnaGr», 3, 1, pp. 263-270.
Pontrandolfo A. 1996, La ceramica lucana a figure rosse, in Greci, Enotri e Lucani nella Basilicatameridionale. I Greci in Occidente, Napoli, pp. 206-214.
Pontrandolfo A. 1998 Funzioni e uso dell’immagine mitica nella prospettiva storica, in Mito e storiain Magna Grecia, Atti del xxxvi Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1996), Napoli,pp. 97-113.
Pontrandolfo A. 1999, Artigianato pittorico e luoghi di produzione in Italia meridionale, in Céra-mique et peinture grecques. Modes d’emploi, M. C. Villanueva Puig, F. Lissarrague, P. Rouillard,A. Rouveret edd., Paris, pp. 267-278.
Pontrandolfo A. 2000, Dioniso e personaggi fliacici nelle immagini pestane, «Ostraka», ix, 1, Na-poli, pp. 117-134.
Pontrandolfo A., Mugione E. 1999, La saga degli Argonauti nella ceramica attica e protoitaliota,in Le mythe grec dans l’Italie antique, F. H. Massa-Pairault ed., Roma, pp. 329-353.
Pouzadoux C. 1999, Usage du mythe dans la peinture apulienne de la seconde moitié du ive siècle av.J. C. Mythe et histoire à Canosa, la Tomba des Perses et le peintre de Darius, thése de Doctorat, Parisx Nanterre, 1999.
Pouzadoux C. 2001, La dualité du dieu bouc. L’épiphanies de Pan à la chasse et à la guerre dans la céramique apulienne, «Antroopozologica», 33-34, pp. 11-21.
Pouzadoux C. 2005, L’invention des images dans la seconde moitié du ive siècle: entre peintre et commendataires, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (edd.), La céra-mique apulienne. Bilan et perspective, Napoli, pp. 187-200.
Pouzadoux C. 2007, Médée tragique dans la peinture apulienne, dans B. Bercoff, F. Fix (éds.),Mythes en images : Médée, Orphée, Œdipe, Dijon, pp. 25-40.
Pugliara M. 1996, La fortuna del mito di Bellerofonte in età tardo-antica, «RdA», 20, pp. 83-100.Reusser C. 2002, Vasen für Etrurien. Verbreitung und Funktionen attischer Keramik im Etrurien des
6. und 5. Jahrhunderts vor Christus, Kirchberg.Reusser C. 2003, La céramique attique dans les habitats étrusques, La céramique attique dans le san-
ctuaires étrusques, in P. Rouillard, A. Verbanck-Piérard (edd.), Le vase grec et ses destins,München, pp. 157-165.
rvap i e ii, A. D. Trendall 1978 e 1982, The red figured vases of Apulia, Oxford [e Suppl. i, 1983,ii 1991].
rvp, A. D. Trendall 1987, The red figured vases of Paestum, Oxford.Schauenburg K. 1956, Bellerophon in der Unteritalischen Vasenmalerei, «JdI», 71, pp. 59-96.Schauenburg K. 1958, Neue Darstellungen aus der Bellerophonsage, «aa», pp. 22-38.Schefold K., Jung F. 1988, Die Ürkonige, Perseus, Bellerophon, und Theseus in der klassischen und
hellenischen Kunst, München.
26 eliana mugione
Schnapp A. 1979, Pratiche ed immagini di caccia nella Grecia antica, «DialA», pp. 35-55.Schnapp A. 1997, Le chasseur et la cité, Paris.Semeraro G. 1997, En nhusi. Ceramica greca e società nel Salento arcaico, Lecce-Bari.Semeraro G. 2005, Le necropoli, in Cavallino. Pietre, case e città, Ceglie Messapica, pp. 60-69.Torelli M. 1997, “Limina Averni”. Realtà e rappresentazione nella pittura tarquiniese arcaica, in Il
rango, il rito e l’immagine. Alle origini della rappresentazione storico romana, Milano.Torelli M. 2002, Ideologia e paesaggi della morte in Etruria tra arcaismo ed età ellenistica, in Icono-
grafia 2001. Studi sull’immagine, Atti del Convegno (Padova, 30 maggio-1º giugno 2001), a curadi I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini, Roma, pp. 45-61.
Yalouris N. 1987, Pegasos. Ein Mythos in der Kunst, Mainz am Rhein.Zevi F. 2004, Alessandro il Molosso e Roma, in Alessandro il Molosso e i condottieri in Magna Grecia,
Atti del xliii Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 2003), Napoli, pp. 793-832.
bellerofonte: un eroe corinzio 27
Rivista annuale · A Yearly Journal
*Redazione, amministrazione e abbonamenti
Accademia editorialeCasella postale n. 1, Succursale n. 8, i 56123 Pisa
Tel. +39 050 542332 · Fax +39 050 574888E-mail: [email protected] · www.libraweb.it
Abbonamenti · SubscriptionsItalia: Euro 110,00 (privati) · Euro 245,00 (enti, brossura con edizione Online),
Euro 490,00 (enti, rilegato con edizione Online)Abroad: Euro 195,00 (Individuals) · Euro 295,00 (Institutions, paperback with Online Edition),
Euro 590,00 (Institutions, hardback with Online Edition)Copia singola · Single issue
Euro 380,00 (brossura/paperback) · Euro 760,00 (rilegato/hardback)I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550 o tramite carta
di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)Uffici di Pisa · Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa
Uffici di Roma · Via Ruggiero Bonghi 1/b (Colle Oppio), i 00184 Roma
*La casa editrice garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati
e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione scrivendo al nostro indirizzo.Le informazioni custodite dalla casa editrice verranno utilizzate al solo scopo
di inviare agli abbonati nuove proposte (D. Lgs. 196/2003)
*Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 19 del 15 · 09 · 2004
Direttore responsabile: Fabrizio SerraSono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale oper estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica,
il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazionescritta della Fabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma,
un marchio della Accademia editoriale®, Pisa · Roma.Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
La Accademia editoriale®, Pisa · Roma, pubblica con il marchioFabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma, sia le proprie riviste precedentemente edite con
il marchio Istituti editoriali e poligrafici internazionali®, Pisa · Roma, che i volumidelle proprie collane precedentemente edite con i marchi Edizioni dell’Ateneo®, Roma,
Giardini editori e stampatori in Pisa®, Gruppo editoriale internazionale®, Pisa · Roma,e Istituti editoriali e poligrafici internazionali®, Pisa · Roma.
*Proprietà riservata · All rights reserved
© Copyright 2008 by Fabrizio Serra · Editore®, Pisa · Romaun marchio della Accademia editoriale®, Pisa · Roma.
Stampato in Italia · Printed in Italy
issn 1824-6192issn elettronico 1826-719x
SOMMARIO
Eliana Mugione, Bellerofonte: un eroe corinzio nell’immaginario delle comunità ita-liche 9
Maurizio Harari, Alle origini di Dafne. Donne fogliute, donne fiorite nell’immagina-rio greco-romano 29
Francesca Ghedini, Isabella Colpo, Schema e schema iconografico. Il caso diCiparisso nel repertorio pompeiano 49
Isabella Colpo, Gian Luca Grassigli, Fabio Minotti, Le ragioni di una scelta.Discutendo attorno alle immagini di Narciso a Pompei 73
Marco Podini, Nessi architettonici e decorativi di un settore della domus dei Coiediia Suasa (an): un hospitium? 119
Julia Lenaghan, On the Use of Roman Copies: Two New Examples of the Doryphorosand Westmacott Ephebe 147
Stefano Bruni, Mario Guarnacci e il suo Ercole di Glicone 173Maria Fancelli, Ripensare Winckelmann. Sull’edizione italiana del manoscritto 68 205