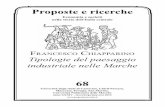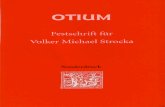Cazzella A., Pignocchi G., Silvestrini M. 2013, Cronologia eneolitica delle Marche
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Cazzella A., Pignocchi G., Silvestrini M. 2013, Cronologia eneolitica delle Marche
PREISTORIA E PROTOSTORIA
Volume primo
a cura diDaniela Cocchi Genick
CRONOLOGIA ASSOLUTA E RELATIVA DELL’ETÀ DEL RAME IN ITALIA
Atti dell’Incontro di StudiUniversità di Verona, 25 giugno 2013
a cura diDaniela Cocchi Genick
CRONOLOGIA ASSOLUTA E RELATIVA DELL’ETÀ DEL RAME IN ITALIA
Atti dell’Incontro di StudiUniversità di Verona, 25 giugno 2013
PREISTORIA E PROTOSTORIA
Volume primo
PREISTORIA E PROTOSTORIA
DIRETTORE
Daniela Cocchi Genick
COmITATO SCIEnTIfICO
Diego Angelucci, Alessandra Aspes, Paolo Bellintani, Maria Bernabò Brea, Paola Cassola Guida, Maurizio Cattani, Angiolo Del Lucchese, Raffaele C. de Marinis, Filippo M. Gambari, Stefano Grimaldi, Alessandro Guidi, Giovanni Leonardi, Roberto Maggi, Franco Marzatico, Emanuela Montagnari, Fabio Negrino, Nuccia Negroni Catacchio, Franco Nicolis, Annaluisa Pedrotti, Marco Peresani, Andrea Pessina, Luciano Salzani, Elisabetta Starnini, Giuliana Steffè, Maurizio Tosi, Marica Venturino
Copyright© by QuiEdit s.n.c.Via S. Francesco, 7 – 37129 Verona, Italywww.quiedit.ite-mail: [email protected] I – Anno 2013ISBN: 978-88-6464-248-2Finito di stampare nel mese di dicembre 2013
La riproduzione per uso personale, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, è con-sentita esclusivamente nei limiti del 15%.
119
AlbERTO CAzzEllA(1) - GAIA PIGnOCChI(2) - mARA SIlvESTRInI(3)
Cronologia eneolitica delle Marche
RIASSunTO
Gli autori prendono in esame i dati relativi alla cronologia eneolitica delle Marche: sono di-sponibili numerose datazioni radiocarboniche per quel che riguarda le necropoli di tombe a grotticella artificiale e alcuni insediamenti, ma restano aperti ancora diversi problemi. Quali caratteri segnarono i passaggi Neolitico-Eneolitico ed Eneolitico-età del Bronzo? Esistevano contemporaneamente più usi funerari o le tombe a fossa furono successive a quelle a grotti-cella artificiale, che sembrano terminare alla fine del IV millennio cal BC? Esistevano contem-poraneamente differenti produzioni ceramiche attestate negli insediamenti? Non è ancora possibile rispondere con certezza a queste domande, ma sembra importante avere presenti quali sono i principali problemi attualmente irrisolti.
AbSTRACT
Authors take into consideration data referring to Copper Age chronology of Marche region. Several 14C dates regarding rock-cut tombs and some settlements are available, but various problems are still to be solved. Which were the features that marked both the passage from Neolithic to Copper Age and from Copper Age to Bronze Age? There were either various coeval funerary customs or trench graves succeeded rock-cut tombs, which ended in the late fourth millennium BC? There were coeval different ceramic productions in various settle-ments? We are not able to answer these questions, but we think the main point is that we keep in mind which are the principal problems to be solved at the moment.
Parole chiave: cronologia, Eneolitico, Marche, necropoli, insediamenti. Keywords: chronology, Copper Age, Marche region, cemeteries, settlements.
InTRODuzIOnE
Prima di entrare nello specifico dell’argomento vorremmo fare un breve richiamo al problema metodologico più generale della cronologia dell’Eneolitico in Italia. Da diversi anni ci si è resi conto che nel caso dell’Eneolitico gli strumenti tradizional-mente utilizzati per costruire “cronologie relative” hanno scarsa efficacia, in assenza di molteplici sequenze di ampia durata e in presenza di ricorrenti fenomeni di coesi-stenza tra contesti riferibili a più “aspetti culturali” a breve distanza tra loro (Cazzella 1994, 2000). L’incremento delle datazioni radiocarboniche disponibili, ovviamente da valutare criticamente, sta fornendo un notevole contributo per affrontare in modo realistico il problema cronologico del periodo in esame, divenendo la base per costrui-re le “cronologie relative” stesse, così come suggerito da C. Renfrew (1973) 40 anni fa. Definiti schemi cronologici attendibili al di là di costruzioni crono-tipologiche de-
(1) Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Università “La Sapienza”, Via dei Volsci 122, 00185 Roma; tel. 06/96040395; e-mail: [email protected](2) Via Cagli 5, 60129 Ancona; e-mail: [email protected](3) Via Torre 17/B, 60020 Offagna; e-mail: [email protected]
120
boli, si liberano inoltre molte energie per affrontare problemi di interpretazione sto-rica delle specifiche situazioni culturali. Lo studio tipologico stesso dei materiali, qua-lora non sia più lo strumento di base per costruire le cronologie, ma un modo per riscontrare gli effetti non solo del tempo, ma anche di quelli delle relazioni spaziali o di altri fattori che ne condizionarono la variabilità, può essere finalizzato ad analizza-re una serie di fenomeni culturali che hanno alla base processi di comunicazione (cfr. Cocchi Genick 2012, pp. 443-585).
Un altro tema affrontato dal medesimo autore inglese (Renfrew 1972, con parti-colare riferimento all’Egeo del IV e III millennio cal BC) ha avuto, invece, meno suc-cesso, ma forse meriterebbe attualmente una maggiore attenzione: le fasce cronolo-giche, espresse attraverso termini come Neolitico, Eneolitico ed età del Bronzo (e le loro divisioni in sottofasi - antico, medio, recente - ed ulteriori sottodivisioni), non hanno senso se applicate ad ampie aree. Tali fasce potrebbero essere sostituite dai se-coli, una volta che i sistemi di datazione assoluta raggiungono un livello soddisfacen-te di approssimazione. In questa griglia si possono collocare “aspetti culturali”, che non siano solo corrispondenti a stili ceramici o a singoli elementi nell’ambito di stili ceramici, ma insiemi funzionalmente correlati di caratteri (cfr. Childe 1956), anche se non è necessario aderire a una concezione “sistemica” della cultura. Come sopra ac-cennato, anche Renfrew non è riuscito a far accogliere questa proposta, per cui ad esempio i suoi termini di cultura Eutresis, Korakou e Tirinto (con possibili sovrappo-sizioni cronologiche reciproche) non hanno soppiantato la tradizionale suddivisione in Antico Elladico I, II e III del Bronzo Antico della Grecia. Nonostante la forte resisten-za a questa impostazione nella mentalità archeologica prevalente, pensiamo che tale obiettivo sia un traguardo cui guardare, soprattutto per un “periodo” (o forse meglio un “fenomeno”, come proposto molti anni fa e ridiscusso recentemente: Cazzella 1972; Cazzella e Guidi 2011; Cocchi Genick 2011) articolato come l’Eneolitico in Italia.
Per tornare in modo più concreto all’Eneolitico delle Marche, si può notare che il quadro cronologico non sembra essere molto mutato rispetto a quello sinteticamente presentato nella XXXVIII Riunione Scientifica dell’IIPP (Cazzella e Silvestrini 2005), anche se si sono aggiunte nuove datazioni radiocarboniche. Restano ancora aperti al-cuni problemi e soprattutto su questi vorremmo soffermarci.
PASSAGGIO nEOlITICO - EnEOlITICO
Per quanto i due termini risultino in gran parte convenzionali, nelle Marche (a dif-ferenza da quello che avviene in altre regioni, come ad esempio la Puglia e la Sarde-gna) la comparsa delle tombe a grotticella artificiale sembra rappresentare ancora la principale innovazione che può aiutare a segnare l’inizio di una nuova fase archeolo-gica. Accanto a questa, si può citare anche l’affermazione dell’uso dei vasi a fiasco (al-meno nei contesti funerari stessi) e forse poco dopo degli askoidi (figg. 2, 3; tab. IV). Questi tratti culturali hanno fatto pensare a possibili contatti (o spostamenti di picco-li gruppi) esterni (Cazzella e Moscoloni 1993; Cazzella 2003; Cultraro 2006), ma non mancano anche elementi di continuità con le precedenti tradizioni, come ad esempio alcune forme (scodella carenata) (fig. 1.1-3) e decorazioni (incisioni) attestate nella ce-
121
ramica della necropoli di Camerano (tt. 17 e 46; tt. 21 e 94, scodelle non decorate: Baroni e Recchia 2005, fig. 3.1; Baroni et alii 2006, fig. 3) e Fontenoce (t. 1: Silvestrini e Pignocchi 1998, fig. 23.3), da cui provengono datazioni piuttosto antiche (Camera-no: t. 94: 3990-3660; t. 33: 3770-3370; t. 21, IV: 3710-3490; t. 21, II: 3640-3330; Fon-tenoce t. 1: 3800-3520; tutte, anche le seguenti, citate cal 2σ BC). Si può ricordare an-che l’uso delle cuspidi in osso a taglio sbiecato (Attiggio 6: Cazzella e Silvestrini 2005, fig. 2a.1) e delle “asce” con foro per l’immanicatura (S. Maria in Selva: Ibid., fig. 4a.1).
Tab. I - Datazioni radiocarboniche in ordine cronologico delle tombe a grotticella artificiale delle Mar-che cal 2σ BC: a sinistra suddivise per necropoli, a destra senza distinzione.
Fontenoce t. 6 liv. inf. (LTL) 4230 3370 Fontenoce t. 6 liv. inf. (LTL) 4230 3370Fontenoce t. 1 (LTL) 3800 3520 Camerano t. 94 (Ua) 3990 3660Fontenoce t. 14 liv. sup. (LTL) 3770 3630 Recanati Cava Kock t. B (LTL) 3820 3640Fontenoce t. 6 liv. sup. (LTL) 3710 3510 Fontenoce t. 1 (LTL) 3800 3520Fontenoce t. 3 ind. 6 (LTL) 3640 3370 Fontenoce t. 14 liv. sup. (LTL) 3770 3630Fontenoce t. 12 ind. 1 (LTL) 3640 3360 Loreto (Ua) 3770 3380Fontenoce t. 14 liv. inf. (LTL) 3640 3340 Camerano t. 33 ind. I (Ua) 3770 3370Fontenoce t. 17 ind. 1 (Ox) 3632 3374 Fontenoce t. 6 liv. sup. (LTL) 3710 3510Fontenoce t. 5 ind. 1 (Ox) 3631 3373 Camerano t. 21 ind. IV (Ua) 3710 3490Fontenoce t. 18 ind. 1 (Ox) 3631 3372 Recanati Via Duomo (Ua) 3660 3360Fontenoce t. 18 ind. 2 (Ox) 3630 3371 Fontenoce t. 3 ind. 6 (LTL) 3640 3370Fontenoce t. 8 ind. 1 (Ox) 3629 3371 Fontenoce t. 12 ind. 1 (LTL) 3640 3360Fontenoce t. 20 ind. 1 (Ox) 3625 3369 Recanati Via Duomo (Ua) 3640 3350Fontenoce t. 11 ind. 1 (Ox) 3520 3365 Fontenoce t. 14 liv. inf. (LTL) 3640 3340Fontenoce t. 11 ind. 3 (Ox) 3520 3365 Camerano t. 21 ind. II (Ua) 3640 3330Fontenoce t. 14 liv. inf. (LTL) 3520 3130 Fontenoce t. 17 ind. 1 (Ox) 3632 3374Fontenoce t. 19 (LTL) 3520 3340 Fontenoce t. 5 ind. 1 (Ox) 3631 3373Fontenoce t. 12 ind. 1 (LTL) 3510 3090 Fontenoce t. 18 ind. 1 (Ox) 3631 3372Fontenoce t. 3 ind. 2 (LTL) 3500 3090 Fontenoce t. 18 ind. 2 (Ox) 3630 3371Fontenoce t. 12 ind. 2 (LTL) 3370 3040 Fontenoce t. 8 ind. 1 (Ox) 3629 3371Fontenoce t. 19 (LTL) 3370 3020 Fontenoce t. 20 ind. 1 (Ox) 3625 3369Fontenoce t. 3 ind. 1 (LTL) 3360 2920 Fontenoce t. 11 ind. 1 (Ox) 3520 3365Recanati Via Duomo (Ua) 3660 3360 Fontenoce t. 11 ind. 3 (Ox) 3520 3365Recanati Via Duomo (Ua) 3640 3350 Fontenoce t. 19 (LTL) 3520 3340Recanati Cava Kock t. B (LTL) 3820 3640 Fontenoce t. 14 liv. inf. (LTL) 3520 3130Loreto (Ua) 3770 3380 Fontenoce t. 12 ind. 1 (LTL) 3510 3090Camerano t. 94 (Ua) 3990 3660 Fontenoce t. 3 ind. 2 (LTL) 3500 3090Camerano t. 33 ind. I (Ua) 3770 3370 Fontenoce t. 12 ind. 2 (LTL) 3370 3040Camerano t. 21 ind. IV (Ua) 3710 3490 Fontenoce t. 19 (LTL) 3370 3020Camerano t. 21 ind. II (Ua) 3640 3330 Fontenoce t. 3 ind. 1 (LTL) 3360 2920
Per i più antichi contesti abitativi eneolitici le datazioni radiocarboniche sono scarse (Fontenoce - area Guzzini, 3690-3105, 3655-3100, 3370-3090; Esanatoglia Crocifisso, 3765-3385, 3665-3365; probabilmente Poggio Sorifa, 3695-3372 e Serra-petrona, 3655-3360: Cazzella e Silvestrini 2005, tab. 1) e non è quindi facile definire precisamente il rapporto cronologico con quelli neolitici più recenti, che appaiono in genere tendenzialmente precedenti (Monte Tinello, 4053-3911; Coppetella di Jesi, 3979-3773: Manfredini et alii 2005b, tab. a p. 199), con qualche eccezione: Pianacci, liv. 1, non solo 4050-3760, ma anche 3640-3370 (Manfredini et alii 2009, fig. 15); S.
122
Maria in Selva, area 2, liv. 2, 3950-3660 (Ibid., fig. 15), che risulta tra l’altro invertita ri-spetto a quella del liv. 1, 4260-3990 (d’altra parte il meccanismo di riempimento delle fosse può aver comportato il recupero di materiali residuali più antichi).
Tab. II - Datazioni radiocarboniche degli insediamenti eneolitici delle Marche cal 2σ BC.
Esanatoglia Crocifisso liv. B 3765 3385 Rome-722Esanatoglia Crocifisso liv. A 3665 3365 Rome-721Pianacci di Genga liv. sup. 3630 3130 Ua-21098Fontenoce abitato 3690 3105 I-Fontenoce abitato 3655 3100 I-Fontenoce abitato 3370 3090 Ua-21098Conelle E 3960 3545 Rome-954Conelle E 3510 3065 Rome-952Conelle E 3500 3040 Rome-953Conelle D 3630 3085 Rome-193Conelle D 3505 2935 Rome-191Conelle D 3495 2920 Rome-192Conelle D 3490 2915 Rome-194Conelle D 3490 2915 Rome-195Conelle C 3335 2885 Rome-185Conelle C 3255 2645 Rome-187Conelle C 3250 2640 Rome-186Conelle B 3505 2940 Rome-196Conelle B 3495 2915 Rome-188Conelle B 3350 2890 Rome-189Conelle B 3335 2885 Rome-190Maddalena di Muccia US43 2880 2490 Ua-18999Maddalena di Muccia fs.9 2/VI 2580 2200 Ua-19000Maddalena di Muccia US105 2490 2230 Ua-21096Maddalena di Muccia US86 3/II 2460 2140 Ua-21095
Per quel che riguarda gli abitati un caso problematico è rappresentato dalla data-zione Rome-954 del gruppo stratigrafico E di Conelle (3960-3545), più antica delle altre ottenute per il medesimo sito: quando fu pubblicata nel 1999 appariva del tutto anomala, ma ora si sovrappone ampiamente con quelle di altri contesti eneolitici, per cui non si può escludere che l’occupazione del sito di Conelle (ed eventualmente lo scavo del fossato, inizialmente tenuto il più possibile pulito) ricada nella prima metà del IV millennio cal BC. Come specificato in Calderoni e Cazzella 1999, p. 177, le ossa usate per la datazione comunque non provengono dai livelli più vicini al fondo del fossato, per cui semmai si dovrebbe pensare a resti ricaduti nel riempimento a di-stanza di tempo dopo la morte degli animali da cui derivarono.
In alcuni abitati sembra esserci continuità nel medesimo luogo, come a Pianacci: tra l’altro la datazione del livello superficiale, attribuito all’Eneolitico (3630-3130) si sovrappone ampiamente con una delle due citate per il liv. 1 (3640-3370), assegnato al Neolitico Finale. Ad Attiggio di Fabriano i tempi della successione tra il livello 6, riferibile al Neolitico Finale (la datazione radiometrica non è utilizzabile), e il livello 4, eneolitico, separati da uno strato considerato relativo a una fase di abbandono del sito, non sono quantificabili. A Fontenoce - area Guzzini (Silvestrini e Pignocchi
123
Tab. III - Diagramma delle datazioni radiometriche disponibili per gli insediamenti eneolitici delle Marche cal 2σ BC.E
sana
togl
ia C
roci
fisso
Esa
nato
glia
Cro
cifis
so
Pian
acci
di G
enga
sup
Font
enoc
e ab
itato
Font
enoc
e ab
itato
Font
enoc
e ab
itato
Con
elle
E
Con
elle
E
Con
elle
E
Con
elle
D
Con
elle
D
Con
elle
D
Con
elle
D
Con
elle
C
Con
elle
C
Con
elle
C
Con
elle
B
Con
elle
B
Con
elle
B
Con
elle
B
Mad
dale
na d
i Muc
cia
Mad
dale
na d
i Muc
cia
Mad
dale
na d
i Muc
cia
Mad
dale
na d
i Muc
cia
4000
3
900
380
0 3
700
360
0 3
500
340
0
3300
3
200
310
0 3
000
290
0 2
800
270
0
2600
25
00
2400
23
00
2200
21
00
124
1998) e a Maddalena di Muccia (Silvestrini et alii 2005a), anche grazie alle datazioni radiocarboniche, a Cava Giacometti (Cazzella e Moscoloni 1994) e a Sassoferrato - area artigianale (Silvestrini et alii 2005b), essenzialmente in base ai caratteri tipologici dei materiali, si può ritenere che la rioccupazione del medesimo sito sia avvenuta a distanza di tempo, anche dopo un periodo di abbandono di molti secoli.
Nelle Marche, dove la metallurgia potrebbe aver avuto inizio già nel Tardo Neoli-tico se è corretta l’interpretazione delle testimonianze da S. Maria in Selva (Martini et alii 2005, p. 306), estremamente limitati sono ancora i dati sulla produzione di manu-fatti in metallo nell’Eneolitico: i rinvenimenti di Conelle (in particolare C4, un manu-fatto in rame con bassa presenza di arsenico, probabilmente riferibile a un residuo di fusione: Palmieri e Cazzella 1999, pp. 205-206, fig. 48.4, tab. 50) risalgono alla fine del IV o agli inizi del III millennio cal BC.
nECROPOlI DI TOmbE A GROTTICEllA ARTIfICIAlE
Le datazioni di ulteriori individui dalla necropoli di Fontenoce - area Guzzini, ef-fettuate a Oxford (Dolfini et alii 2011, tab. I) dopo la pubblicazione degli atti della XXXVIII Riunione Scientifica dell’IIPP (tombe: 5, ind. 1; 8, ind. 1; 11, ind. 1 e 3; 17, ind. 1; 18, ind. 1 e 2; 20, ind. 1), non sembrano modificare il quadro generale a suo tempo presentato. Nessuna datazione raggiunge i valori più alti, ma neanche quelli più bassi della serie di datazioni realizzate a Lecce (cfr. tab. I): tralasciando i valori cro-nologici assoluti dell’inumato inferiore della t. 6, con un errore statistico molto am-pio, si possono comunque citare come particolarmente antichi gli individui delle tt. 1, 6 superiore e 14 superiore (la datazione di quest’ultimo, però, è invertita rispetto a quella dell’individuo inferiore e presenta quindi qualche problema). Tuttavia gli scarti sono modesti, con buoni margini di sovrapposizione in quasi tutti i casi: l’unico ap-parentemente più antico è proprio l’individuo superiore della t. 14 (pre-3630). Più re-centi dell’insieme datato a Oxford risultano invece essere l’individuo 1 della t. 3, l’in-dividuo 2 della t. 12 e uno dei due individui della t. 19 (tutti post-3370), mentre una parziale discrepanza interna mostrano le datazioni dell’individuo 1 della t. 12.
Complessivamente, considerando tutte le datazioni, lo sviluppo della necropoli di Fontenoce - area Guzzini dovrebbe iniziare almeno uno o due secoli prima della metà del IV millennio cal BC e terminare alla fine del millennio o poco prima. Sembra re-stare valida l’ipotesi a suo tempo formulata che diverse parti della necropoli, come il “circolo” e l’“allineamento” (Silvestrini et alii 2005c) (e il relativo uso di forme diffe-renziate, come il vaso a fiasco e l’askoide), abbiano un’ampia sovrapposizione crono-logica e siano quindi almeno in parte contemporanee (cfr. tab. IV).
Come si è accennato sopra la necropoli di Camerano potrebbe essere leggermen-te più antica, iniziando almeno intorno al 3800/3700 e terminando intorno al 3300 (tab. I). Per Loreto (3770-3380: Cazzella e Silvestrini 2005, tab. 1) si ha una sola data-zione che si colloca entro il medesimo arco di tempo. Nell’area di Recanati, oltre area Guzzini, la t. B di Cava Kock (3820-3640: Carboni et alii 2005) dovrebbe ricadere en-tro i primi due secoli del periodo indicato, mentre la tomba di Recanati - via Duomo (3660-3360, 3640-3350: Cazzella e Silvestrini 2005, tab. 1) sembra rientrare nella se-conda parte del medesimo periodo.
125
Tab. IV - Schema cronologico delle tipologie ceramiche delle tombe a grotticella, basato sulle datazioni radiocarboniche.
scodella carenataCa t. 94 3990 3660Fo t. 1 3800 3520Ca t. 21 ind. II 3640 3330
scodella ad orlo svasato con solcature verticali Fo t. 6. inf 4230 3370
Fo t. 3 ind. 6 3640 3370Fo t. 8 ind. 1 3629 3371Fo t. 12 ind. 2 3370 3040
scodella troncoconica con presa orizzontale Ca t. 94 3990 3660
Fo t. 14 sup 3770 3630Fo t. 3 ind. 1 3360 2920
scodella convessa con presa orizzontale Ca t. 21 3710 3330
Fo t. 11 3520 3365vaso a fiasco a corpo schiacciato con alto collo concavo senza prese tubolari
Fo t. 6 inf 4230 3370
Fo t. 3 ind. 6 3640 3370
vaso a fiasco globulare con collo cilindrico e prese tubolari verticali
Fo t. 1 3800 3520Fo t. 8 3629 3371Via Duomo 3660 3360
vaso a fiasco ovoide Fo t. 3 ind. 1 3360 2920
vaso a fiasco biconico Fo t. 19 3370 3020
brocca askoide carenataFo t. 14 sup 3770 3630Fo t. 14 inf 3640 3340Fo t. 18 3631 3372
brocca carenataCa t. 21 3710 3330Fo t. 11 3520 3365Fo t. 3 ind. 1 3360 2920
boccale carenatoFo t. 17 3632 3374Ca=Camerano e Fo=Fontenoce, area Guzzini
È stato a suo tempo notato (Cazzella e Silvestrini 2005, pp. 376-377; Silvestrini et alii 2006, p. 195) che le datazioni delle più antiche tombe a grotticella marchigiane non sono più recenti di quelle delle analoghe tombe eneolitiche del versante tirrenico e questa ipotesi non è stata smentita dalle indicazioni che si sono aggiunte negli ultimi
126
Fig. 1 - 1-3. scodelle carenate; 4-6. scodelle ad orlo svasato con solcature verticali; 7-10. scodelle troncoconiche con presa orizzontale; 11, 12. scodelle a profilo convesso con presa orizzontale (da Baroni e Recchia 2005; Cazzella e Silvestrini 2005; Silvestrini e Pignocchi 1997, 1998, 2000) (ca. 1:4).
anni per quest’ultima area: tra le datazioni più antiche si possono citare quella dell’in-dividuo maschile della t. 21 di Ponte S. Pietro, 3750-3537 (Dolfini et alii 2011, tab. I), quella della t. 4 della Selvicciola, 3780-3640 (Petitti et alii 2011) e quella dell’ind. 1 del-la t. 29 di Osteria del Curato, 3790-3520 (Anzidei et alii 2007, tab. I). In ogni caso le necropoli di tombe a grotticella marchigiane sembrano terminare, sulla base dei dati attualmente disponibili, diversi secoli prima di quelle tosco-laziali.
Le figg. 1-4 e la tab. IV illustrano un tentativo di individuare variazioni cronologi-che (che possono incidere accanto a quelle locali) nella produzione ceramica attestata nelle necropoli di tombe a grotticella artificiale delle Marche. Si notano alcune varia-zioni nella forma dei vasi a fiasco: pur tenendo presente che alcuni di questi, riferibi-
127
li a subadulti (t. 3, ind. 1, fanciullo; t. 19, bambino), risultano essere miniaturizzati e quindi probabilmente rappresentano una reinterpretazione simbolica delle forme uti-lizzate per gli adulti, si rileva una maggiore arcaicità dei tipi con alto collo cilindrico, caratterizzati anche da particolari decorazioni, tra cui quella incisa ricordata all’inizio (Camerano t. 46, purtroppo non datata: Baroni et alii 2006, fig. 3.1).
Fig. 2 - 1, 2. vasi a fiasco con alto collo cilindrico; 3, 4. vasi a fiasco con alto collo concavo; 5-8. vasi a fiasco globulari; 9. vaso a fiasco ovoide; 10. vaso a fiasco biconico (da Baroni e Recchia 2006; Lollini 1968; Silvestrini e Pignocchi 1997, 1998, 2000) (ca. 1:4).
128
Fig. 3 - 1-3. brocche askoidi carenate; 4-6. brocche askoidi ovoidi (da Carboni et alii 2005; Silvestrini e Pignocchi 2000) (ca. 1:4).
lE TOmbE A fOSSA
Le tombe a fossa delle Marche continuano a essere prive di datazioni radiocarbo-niche e non sono facilmente inquadrabili in base agli elementi del corredo. Il tratto più caratteristico è costituito dall’ascia-martello con pomo distinto, presente in una delle tombe a fossa con inumati distesi di Vescovara di Osimo e a Moie di Maiolati (Annibaldi 1951-52; Silvestrini e Lollini 2002, pp. 20-21): la tomba rinaldoniana più antica con tale elemento sembra essere la t. 7 della necropoli di Ponte S. Pietro (3648-3520; di poco più recente è l’arco della datazione della t. 2 di Garavicchio, 3632-3373: Dolfini et alii 2011, tab. 1), ma è ovviamente un indizio debole per datare le tombe a fossa marchigiane a partire da quel momento (sul problema dell’origine esterna di tale elemento, anche da un punto di vista cronologico, una riconsiderazione in Cazzella 2011). È comunque possibile che l’uso dell’ascia-martello con pomo distinto in con-testi funerari sia continuato fino a momenti avanzati dell’Eneolitico.
Un elemento di corredo presente sia in tombe a fossa che in tombe a grotticella è il pugnale bifacciale con incavi sul peduncolo e presso la base delle tombe di Vesco-vara di Osimo (Annibaldi 1951-52), in questo caso in associazione con un’ascia-mar-tello con testa distinta, e di Camerano T. 11 (Baroni et alii 2006, p. 333: unico elemen-to del corredo). Per queste tombe non si dispone di datazioni assolute, ma tenendo conto di quelle disponibili per altre sepolture della necropoli di Camerano da un lato (cfr. anche la datazione alta di una tomba con pugnale con intaccature sul codolo da Olmo di Nogara: Facchin e Leonardi in questo volume), che superano la metà del IV millennio cal BC, e delle datazioni proposte per esemplari simili da Remedello dall’al-
129
tro, tale tipo sembra coprire un lungo arco di tempo (una recente revisione del pro-blema della cronologia dei pugnali in selce in Cocchi Genick 2012, pp. 560-568).
L’unica ascia in metallo che potrebbe riferirsi ad un contesto eneolitico proviene da un rinvenimento del 1873 avvenuto a San Rocco di Monte San Vito (Colini 1898) in seguito a lavori agricoli, ma non si ha la certezza che facesse parte del corredo dell’unica tomba segnalata, il cui individuo era accompagnato, oltre che da lame e punte, da un pugnale di selce con largo peduncolo triangolare.
Anche in questo caso non disponendo delle datazioni assolute non è possibile fornire indicazioni cronologiche certe. L’uso delle asce in metallo, secondo Barfield (1996) e Skeates (1994), potrebbe iniziare in Italia già dal Neolitico avanzato. L’argo-mento è stato recentemente ripreso in esame da de Marinis (2013, pp. 328-330). Dal punto di vista tipologico la presenza sull’ascia di Monte San Vito di margini lievemen-te rialzati potrebbe far pensare a un momento non iniziale della sequenza di tale ca-tegoria di manufatti, ma il tipo può comunque essere durato molto a lungo, fino alla fine dell’Eneolitico.
Nell’ambito delle tombe a fossa un rinvenimento recente ed inedito è quello di Moscano di Fabriano, in un contesto eneolitico con ceramica a squame tipo Attiggio. All’interno di una cavità scavata nel terreno riutilizzata a scopo funerario sono state rinvenute due deposizioni sovrapposte, l’inferiore, uno scheletro incompleto in posi-zione semirannicchiata al quale è da riferire una punta di freccia, e la superiore, com-pleta, di un inumato disteso la cui relazione con un frammento ceramico a squame
Fig. 4 - 1. brocca carenata con alto collo cilindrico; 2. brocca carenata con breve collo cilindrico; 3. brocca carenata con breve collo troncoconico; 4. brocca carenata senza collo; 5. boccale carenato (da Baroni e Recchia 2005; Silvestrini e Pignocchi 1997, 1998, 2000) (ca. 1:4).
130
non è certa. La sepoltura al momento rappresenta un unicum per l’associazione di vari elementi (il rinvenimento in un’area interna delle Marche, la posizione distesa dello scheletro superiore e la probabile relazione con la ceramica a squame). Al momento, in assenza di datazioni e dello studio del contesto, non è possibile fornire un preciso inquadramento cronologico.
lA PRODuzIOnE CERAmICA ATTESTATA nEGlI InSEDIAmEnTI
Uno degli aspetti che caratterizza l’intero corso dell’Eneolitico nelle Marche è dato dai contesti insediativi con ceramica a squame o rusticata che possiamo distin-guere seppur parzialmente sia sulla base delle datazioni radiocarboniche, quando di-sponibili, sia per la presenza di elementi distintivi che possono aiutare ad individuare aspetti meglio definiti nel tentativo di indicare una seriazione cronologica seppure molto indicativa o comunque gruppi diversificati che possono aver scandito in ma-niera fluida i vari momenti e le varie tendenze e che possono aver coesistito in parte tra loro.
La proposta di una scansione dei siti dove compare la ceramica rusticata e a squa-me non vuole basarsi né può basarsi su parametri cronologici ma vuole indicare una suddivisione tra gruppi di rinvenimenti che caratterizzano il corso dell’Eneolitico nel-le Marche contrassegnati da alcuni elementi comuni.
Un primo gruppo di rinvenimenti che non presentano la vera e propria ceramica a squame ma tipi di trattamenti volti a rendere scabra la superficie potrebbe collocar-si, sulla base di alcune datazioni radiocarboniche (Conelle e Pianacci di Genga livello superiore: tabb. II e III), nella seconda metà del IV millennio cal BC, se non prima. Impressioni a scorrimento sono state rinvenute anche a Esanatoglia - Crocifisso (fig. 5.1,2), con datazioni radiocarboniche intorno alla metà del IV millennio cal BC (Sil-vestrini 2000, pp. 33-34). Il gruppo include altri contesti privi di datazioni (Esanato-glia - Case Popolari, Attiggio str. 4, Berbentina di Sassoferrato str. 1, Cava Giacomet-ti: Lollini 1965, 1990, pp. 86-93; Cazzella e Moscoloni 1994, p. 95; Silvestrini 2000, p. 34; Angeli et alii 2005; Leonini e Millemaci 2005) nei quali compaiono le applicazioni irregolari di argilla a colature, a steccature, a rosette, bugne coniche ed emisferiche, decorazioni impresse ad unghiate e ditate con riporto di argilla, a scorrimento. A Esa-natoglia - Case Popolari (fig. 5.3) è attestata anche ceramica che ricorda quella embri-cata, oltre a digitature trascinate (Silvestrini 2000, p. 34).
Le forme sono in genere poco articolate, ad eccezione di askoidi e brocche ben attestati a Conelle (fig. 5.11-14) (Moscoloni 1999). Una brocca con stretto collo tron-coconico e corpo espanso rinvenuta ad Attiggio str. 4 (fig. 5.10) (Lollini 1965) si col-lega ad esemplari da Torrino - Mezzocammino 2, Le Cerquete - Fianello a Maccarese e Le Coste (Anzidei e Carboni 2000; Manfredini et alii 2000; Radi 2000), le cui data-zioni sono in linea con quelle di Conelle D e C, ma anche alle brocche della Panighi-na (Morico 1988), tra le quali una in particolare ha la tipica decorazione metopale pre-sente nella fase C di Conelle (fig. 5.7). Decorazioni a puntini (fig. 5.14) sono docu-mentate, a partire dalla fase D, per tutto il corso dello sviluppo di Conelle, fino agli inizi del III millennio cal BC parallelamente alle bozze cave generalmente sul diame-
131
tro massimo (fig. 5.8) (Moscoloni 1999, p. 118), presenti anche su alcuni recipienti della necropoli di Cava Kock (Carboni et alii 2005, fig. 1). Decorazioni a serie di de-pressioni sulla carena sono attestate nell’abitato di Fontenoce (fig. 5.9) (Silvestrini et alii 2000, p. 56, fig. 8.1), come si è visto indicativamente datato nella seconda metà del IV millennio cal BC.
Non disponendo di datazioni radiocarboniche e tenendo conto dell’insufficienza dei dati non è possibile collocare con certezza i due rinvenimenti di Jesi Palazzo Me-stica (fig. 6.1) e Campograsso di Castelfidardo (Pignocchi e Landolfi 2012), che si ca-ratterizzano per l’uso della tecnica a squame embricate e regolari, che non rappresen-ta un sicuro marcatore cronologico. Per questi due siti che, per le caratteristiche com-plessive della ceramica e per gli elementi di confronto anche se generici con Conelle e Fontenoce, sembrerebbero antecedenti alla fase più avanzata dell’Eneolitico mar-
Fig. 5 - 1, 2. Crocifisso di Esanatoglia; 3. Case Popolari di Esanatoglia; 4. Berbentina di Sassoferrato; 5-8, 11-14. Conelle di Arcevia; 9. Fontenoce di Recanati; 10. Attiggio di Fabriano (da Conelle I; Leonini e Millemaci 2005; Lollini 1965; Silvestrini 2000; Silvestrini et alii 2000) (ca. 1:4; 5, ca. 1:8).
132
chigiano, si può proporre una datazione che va dalla seconda metà del IV alla prima metà del III millennio cal BC.
Nessuna datazione radiocarbonica al momento ricade nella piena prima metà del III millennio, a eccezione di una delle quattro effettuate per Maddalena di Muccia (2880-2490), che si stacca dalle altre tre. Questa è riferibile a uno dei pali di una delle strutture messe in luce (Manfredini et alii 2005a, pp. 441-442): non sono noti i mate-riali ad essa associati. La forma absidata delle strutture abitative non coincide con quella ellissoidale prevalentemente attestata negli insediamenti più o meno contem-poranei del Lazio (Anzidei e Carboni 2007, fig. 2; Anzidei et alii 2007, fig. 3) e della Campania (Fugazzola Delpino et alii 2003, 2007), ma comunque non si staccano ec-cessivamente da quelle più piccole di quei contesti dal punto di vista delle dimensioni (6-8x10-11 m). Dal momento che si tratta di una datazione su carbone non si può del
Fig. 6 - 1. Jesi, Palazzo Mestica; 2, 8. Maddalena di Muccia; 3, 4, 6, 9. Ancona, Piazza Malatesta; 5, 7. Cervidone di Cingoli; 10. Offida, Borgo Cappuccini; 11, 15, 16. Monte Ceti di Novafeltria; 12, 13. Sassoferrato area artigianale; 14. San Severino Marche, Collemontanari (da Baldelli et alii 2005; Landolfi et alii 2005; Lucentini 1996; Manfredini et alii 2005a; Pignocchi e Landolfi 2012; Silvestrini et alii 2005b) (ca. 1:4).
133
tutto escludere che l’apparente precocità rispetto alle altre tre sia dovuta all’effetto old wood, ma potrebbe più semplicemente essere riferibile a una fase dell’insediamento che nell’area indagata precede quella delle fosse, da cui provengono le datazioni che ricadono fra 2500 e 2200 cal BC, e i materiali pubblicati (Manfredini et alii 2005a, pp. 435-439, figg. 2-4).
All’insediamento di Maddalena di Muccia possiamo affiancare altri rinvenimenti marchigiani contraddistinti dalla presenza di anse a nastro con bottone sommitale e di applicazioni a squame più o meno accennate, ma anche di anse a gomito appena accennato (fig. 6.3-7,9,10) (Ancona Piazza Malatesta, Cervidone di Cingoli, Offida Borgo Cappuccini: Lucentini 1996; Pignocchi e Landolfi cds), elementi che hanno un’ampia diffusione sia in termini geografici che cronologici, trovando ampi riscontri in complessi eneolitici italiani dall’Emilia Romagna al Lazio meridionale (Pignocchi e Landolfi cds), le cui datazioni si concentrano soprattutto nella prima metà del III mil-lennio cal BC. In ogni caso ci sembra più opportuno non utilizzare direttamente il termine di facies di Laterza per indicare questo insieme di elementi attestati nelle Marche, mancando al momento i suoi tratti più caratteristici.
Poco consistenti sono i siti con sporadiche rielaborazioni locali di elementi Cetina e campaniformi (fig. 6.12-14) (Sassoferrato - area artigianale e Collemontanari - Sant’Elena di San Severino Marche: Landolfi 2003; Silvestrini et alii 2005b), inseriti talvolta ancora nell’ambito della tradizione della ceramica a squame, per i quali non disponiamo di datazioni e che potrebbero essere stati in parte contemporanei ai siti marchigiani riferibili alla fase più avanzata dell’Eneolitico, presumibilmente collocan-dosi dopo la metà del III millennio cal BC. Non a caso in un’area periferica delle Mar-che molto più aperta a queste influenze troviamo il sito di Monte Ceti (fig. 6.11,15,16) (Baldelli et alii 2005, pp. 543-544, fig. 2) che presenta elementi che ci riportano ad un aspetto tardo eneolitico di transizione al Bronzo Antico, presente soprattutto nella Toscana settentrionale e nell’Emilia Romagna, che copre la seconda metà III millen-nio cal BC.
RIfERImEnTI bIblIOGRAfICI
AnGElI f., bRIllI S., SARTI l., vOlAnTE N. 2005, Attiggio di Fabriano (Ancona): la ceramica, AttiIIPP XXXVIII, II, pp. 918-922.
AnnIbAlDI G. 1951-52, Rinvenimento di tombe eneolitiche in territorio di Osimo, BPI n.s. VIII, 4, pp. 108-111.
AnzIDEI A.P., CARbOnI G. 2000, L’Eneolitico del territorio di Roma: aspetti culturali e ambiti cronologici, in Atti Arcevia, pp. 215-230.
AnzIDEI A. P., CARbOnI G. 2007, Il villaggio neo-eneolitico di Quadrato di Torre Spaccata (Roma): nuovi dati dagli scavi del Giubileo 2000, AttiIIPP XL, II, pp. 421-435.
AnzIDEI A. P., CARbOnI G., CASTAGnA m.A., CElAnT A., CIAnCA m., EGIDI R., fAvORITO S., funICIEllO R., GIORDAnO G., mAlvOnE m., TAGlIACOzzO A. 2007, L’abitato eneolitico di Osteria del Curato - via Cinquefrondi: nuovi dati sulle facies archeologiche di Laterza e Ortucchio nel territorio di Roma, AttiIIPP XL, II, pp. 477-508.
Atti ArceviA - SIlvESTRInI M., a cura di, 2000, Recenti acquisizioni, problemi e prospettive della
134
ricerca sull’Eneolitico dell’Italia centrale, Atti dell’Incontro di Studio, Ancona.bAlDEllI G., bERGOnzI G., CARDAREllI A., DAmIAnI I., luCEnTInI N. 2005, Le Marche dall’antica
alla recente età del Bronzo, AttiIIPP XXXVIII, II, pp. 539-594.bARfIElD L. H. 1996, The Chalcolithic in Italy: considerations of metal typology and cultural interactions,
in bAGOlInI b., lO SChIAvO F., eds., The Copper Age in Near East and Europe, XIX Colloquio del XIII Congresso UISPP, Forlì, pp. 65-74.
bAROnI I, RECChIA G. 2005, Comportamenti funerari durante l’Eneolitico nelle Marche, AttiIIPP XXXVIII, I, pp. 445-456.
bAROnI I., RECChIA G., SIlvESTRInI S. 2006, La necropoli eneolitica di Camerano (Ancona), AttiPPE VII, Milano, pp. 329-339.
CAlDEROnI G., CAzzEllA A. 1999, Le datazioni radiometriche e i rapporti cronologici con altri contesti italiani e transadriatici, in Conelle I, pp. 177-185.
CARbOnI G., COnATI bARbARO C., mAnfREDInI A., SAlvADEI l., SIlvESTRInI M. 2005, La necropoli eneolitica di Fontenoce - Cava Kock (Recanati - Macerata): nuovi dati per l’inquadramento cronologico-culturale, AttiIIPP XXXVIII, II, pp. 949-954.
CAzzEllA A. 1972, Considerazioni su alcuni aspetti eneolitici dell’Italia meridionale e della Sicilia, Origini VI, pp. 171-298.
CAzzEllA A. 1994, Dating the “Copper Age” in Italy and adjacent islands, Journal of European Archaeology 2, pp. 1-19.
CAzzEllA A. 2000, L’Eneolitico dell’Italia centrale: alcuni aspetti problematici, in Atti Arcevia, pp. 21-30.
CAzzEllA A. 2003, Conelle di Arcevia nel panorama culturale della preistoria del Mediterraneo centro-orientale e della penisola balcanica tra quarto e terzo millennio, in CAzzEllA A., mOSCOlOnI m., RECChIA G., a cura di, Conelle di Arcevia II. Tecnologia e contatti culturali, Roma, pp. 541-568.
CAzzEllA A. 2011, The (possible) Tursi tumulus burial near Matera and the relationships between southern Italy and the Aegean-Balkan area in the first half of the 3rd millennium B.C., in bORGnA E., muEllER-CElkA S., eds., Ancestral Landscapes, TMO 58, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, pp. 597-606.
CAzzEllA A., GuIDI A. 2011, Il concetto di Eneolitico in Italia, AttiIIPP XLIII, pp. 25-32.CAzzEllA, mOSCOlOnI 1993, La cultura di Rinaldone e l’Eneolitico delle Marche, AttiPPE I, pp. 45-
52.CAzzEllA A., mOSCOlOnI M. 1994, Il sito stratificato di Cava Giacometti (Arcevia - Ancona) nel
quadro degli sviluppi culturali dell’Italia centro-settentrionale dal Neolitico finale all’età del Bronzo, Quaderni del Museo Archeologico Etnologico di Modena, I, pp. 89-119.
CAzzEllA A., SIlvESTRInI M. 2005, L’Eneolitico delle Marche nel contesto degli sviluppi culturali dell’Italia centrale, AttiIIPP XXXVIII, I, pp. 371-386.
ChIlDE V.G. 1956, Piecing together the Past, London.COCChI GEnICk D. 2011, Problematiche e prospettive della ricerca sull’età del rame in Italia in ricordo di
Gianni Bailo Modesti, AttiIIPP XLIII, Firenze, pp. 13-21.COCChI GEnICk D. 2012, Le potenzialità informative delle ceramiche nell’analisi storica. Le forme
vascolari dell’età del rame dell’Italia settentrionale, Verona.COlInI G.A. 1898, Il sepolcreto di Remedello Sotto nel Bresciano e il periodo eneolitico in Italia, BPI
XXIV, pp. 206-260.conelle I - CAzzEllA A., mOSCOlOnI M., a cura di, 1999, Conelle di Arcevia I. Un insediamento
135
eneolitico nelle Marche, Roma.CulTRARO M. 2006, La cultura di Rinaldone nel quadro delle relazioni con il mondo egeo-balcanico: un
aggiornamento, AttiPPE VII, pp. 405-420.DE mARInIS R.C. 2013, La necropoli di Remedello Sotto e l’età del Rame nella pianura padana a nord del
Po, in DE mARInIS R.C., a cura di, L’età del Rame. La pianura padana e le Alpi al tempo di Ötzi, Roccafranca, pp. 301-351.
DOlfInI A., ARAnGuREn b., SIlvESTRInI M. 2011, La prima metallurgia in Italia centrale alla luce di nuove date radiometriche, AttiIIPP XLIII, pp. 171-179.
fuGAzzOlA DElPInO m.A., SAlERnO A., TAGlIACOzzO A., TInè v., vAnzETTI A. 2003, Una comunità della facies di Laterza nella piana campana: l’area “Forum” di Gricignano - US Navy (CE), AttiIIPP XXXV, I, pp. 199-214.
fuGAzzOlA DElPInO m.A., SAlERnO A., TAGlIACOzzO A., TInè V. 2007, Villaggi e necropoli dell’area “Centro Commerciale” di Gricignano di Aversa - US Navy (CE), AttiIIPP XL, I, pp. 521-537.
lAnDOlfI M. 2003, Il Museo Civico Archeologico di S. Severino Marche, Osimo.lAnDOlfI m., SIlvESTRInI m., CARlInI C., PIGnOCChI G. 2005, La sezione preistorica della collezione
Pascucci di San Severino Marche (Macerata), AttiIIPP XXXVIII, II, pp. 1006-1010.lEOnInI v., mIllEmACI G. 2005, Berbentina di Sassoferrato (Ancona): il complesso ceramico, AttiIIPP
XXXVIII, II, pp. 913-917.lOllInI D. 1965, Il Neolitico nelle Marche alla luce delle recenti scoperte, Atti VI Congresso UISPP,
2, pp. 309-315.lOllInI D. 1968, Tomba eneolitica da Recanati, Studi Maceratesi 4, pp. 51-59.luCEnTInI N. 1996, Prime fasi dell’età del Bronzo nelle Marche, in COCChI GEnICk D., a cura di,
L’antica età del Bronzo in Italia, Firenze, pp. 475-482.mAnfREDInI A., CARbOnI G., COnATI bARbARO C. 2000, Nuovi spunti nello studio dell’Eneolitico
dell’Italia centrale: una comunità di villaggio a nord del Tevere, in Atti Arcevia, pp. 203-214.mAnfREDInI A., CARbOnI G., COnATI bARbARO C., SIlvESTRInI m., fIOREnTInO G., CORRIDI C.
2005a, La frequentazione eneolitica di Maddalena di Muccia (Macerata), AttiIIPP XXXVIII, I, pp. 433-444.
mAnfREDInI A., fuGAzzOlA DElPInO m.A., SARTI l., SIlvESTRInI m., mARTInI f., COnATI bARbARO C., munTOnI I. m., PIzzIOlO G., vOlAnTE N. 2009, Adriatico e Tirreno a confronto: analisi dell’occupazione territoriale tra il Neolitico finale e l’età del Rame in alcune aree campione dell’Italia centrale, RSP LIX, pp. 115-180.
mAnfREDInI A., SARTI l., SIlvESTRInI M. 2005b, Il Neolitico delle Marche, AttiIIPP XXXVIII, I, pp. 197-208.
mARTInI f., SARTI l., SIlvESTRInI m., vOlAnTE N. 2005, L’insediamento di Santa Maria in Selva di Treia: progetti e prospettive di ricerca, AttiIIPP XXXVIII, I, pp. 295-308.
mORICO G. 1988, La Panighina di Bertinoro (Forlì). La fase dell’età del Rame, RassA 7, pp. 610-611.mOSCOlOnI M. 1999, Il patrimonio tipologico esaminato per fasi, in Conelle I, pp. 111-132.PAlmIERI A.m., CAzzEllA A. 1999, Manufatti metallici, in Conelle I, pp. 205-208.PETITTI P., PERSIAnI C., PAllECChI P. 2011, Reperti metallici dalla necropoli della Selvicciola (Ischia di
Castro - Viterbo), AttiIIPP XLIII, pp. 187-194.PIGnOCChI G., lAnDOlfI M. 2012, Indizi di frequentazione eneolitica e dell’età del Bronzo nel centro
storico di Jesi (Palazzo Mestica) (AN), RSP LXII, pp. 147-162.
136
PIGnOCChI G., lAnDOlfI M. cds, I siti con ceramica a squame di Campograsso di Castelfidardo e Piazza Malatesta di Ancona nella sequenza dell’Eneolitico marchigiano, RSP LXIII.
RADI G. 2000, Nuovo aspetto individuato nel Fucino a Le Coste (Ortucchio-AQ), in Atti Arcevia, pp. 293-307.
REnfREw C. 1972, The Emergence of Civilisation, London.REnfREw C. 1973, Before Civilization, London.SIlvESTRInI M. 2000, L’Eneolitico delle Marche alla luce delle recenti acquisizioni, in Atti Arcevia, pp.
31-38.SIlvESTRInI m., CARlInI C., fOGlInI L. 2005b, Recenti acquisizioni da Sassoferrato, area artigianale:
un sito stratificato dal Neolitico all’Eneolitico, AttiIIPP XXXVIII, I, pp. 321-333.SIlvESTRInI m., CARlInI C., PIGnOCChI G. 2000, L’insediamento di Fontenoce di Recanati (MC) alla
luce dei nuovi dati sul complesso ceramico, in Atti Arcevia, pp. 51-72.SIlvESTRInI m., CAzzEllA A., bAROnI I., RECChIA G. 2006, Le necropoli eneolitiche delle Marche e la
facies di Rinaldone, AttiPPE VII, pp. 193-202.SIlvESTRInI m., CAzzEllA A., PIGnOCChI G. 2005c, L’organizzazione interna della necropoli di
Fontenoce area Guzzini, AttiIIPP XXXVIII, I, pp. 457-467.SIlvESTRInI m., lOllInI D., a cura di, 2002, Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Sezione
preistorica. L’Eneolitico, Falconara.SIlvESTRInI m., mAnfREDInI A., RADI G. 2005a, L’abitato di Maddalena di Muccia (Macerata).
Problemi e prospettive di ricerca, AttiIIPP XXXVIII, I, pp. 221-229.SIlvESTRInI m., PIGnOCChI G. 1997, La necropoli eneolitica di Fontenoce di Recanati: lo scavo 1992,
RSP XLVIII, pp. 309-366.SIlvESTRInI m., PIGnOCChI G. 1998, Gli insediamenti preistorici di Fontenoce di Recanati (Macerata) ed
aspetti del Neolitico ed Eneolitico marchigiano, Origini XXII, pp. 135-194.SIlvESTRInI m., PIGnOCChI G. 2000, Recenti dati dalla necropoli eneolitica di Fontenoce di Recanati, in
Atti Arcevia, pp. 39-62.SkEATES R. 1993, Early metal-use in the central Mediterranean region, Accordia Research Papers 4,
pp. 5-48.