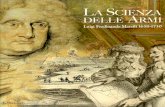Pubblico quotidiano. Beni collettivi a Gela tra azione dal basso e intervento statale
Azione politica e Azione cattolica. Luigi Gedda e Carlo Carretto, in Luigi Gedda nella storia della...
Transcript of Azione politica e Azione cattolica. Luigi Gedda e Carlo Carretto, in Luigi Gedda nella storia della...
375
Enrico Galavotti
Azione politica e Azione cattolica: Luigi Gedda e Carlo Carretto
La storia dell'Azione cattolica italiana, nel passaggio dagli anni Quaranta agli anni Cinquanta, non è solo definita da programmi pluriennali, statuti, «scelte» (religiose anziché politiche o viceversa), «crociate», ma è anche stata determinata, in un modo oggi forse difficile da percepire nella sua rilevanza essenziale, da personaggi. Uomini e donne che hanno incarnato il percorso e segnato gli orientamenti profondi dell'associazione, con una forza, una determinazione e, talora, una drammaticità proprie di una stagione storica in cui l'Italia si stava faticosamente rimettendo in piedi dopo lo sconquasso bellico e scopriva che le sfide del dopoguerra, anche per i pesanti condizionamenti determinati dal contesto internazionale, non sarebbero state meno difficili di quelle sostenute durante il ventennio fascista.
Luigi Gedda e Carlo Carretto sono stati, fuori di ogni dubbio, due protagonisti ·cruciali di questa stagione: al punto da incarnare agli occhi di un'intera generazione di membri di Ac - e nondimeno nelle pagine della storiografia che se ne è occupata con finezza di analisi e abbondanza di documentazione (penso in particolare ai fondamentali lavori di Casella, Formigoni, Giovagnoli, Giuntella, Moro, Trionfini e Piva) - due percorsi possibili e profondamente antitetici di sviluppo del cammino dell' associazione1
. E il fatto che alla fine sia stata, almeno nell'immediato, la linea Gedda a prevalere, non ha tolto forza alle suggestioni introiettate da Carretto nel corso dei suoi mandati da presidente della Giac; ne è riprova l'esito della vicenda, non meno suggestiva per un'intera generazione di associati, del suo successore, Mario Rossi, alla guida della Gioventù di Ac. Il rischio che si corre, però, è quello di ridurre la storia del rapporto tra Gedda e Car:çetto al suo esito conclusivo: che è stato indubbiamente, fuor di metafora, di rottura insanabile. Un esito che non è interessante considerare tanto sul piano del rapporto personale (che comunque ha conosciuto qualche tardivo tentativo di recupero); quanto proprio come riflesso della concezione del ruolo e dei compiti della chiesa in Italia, sviluppati da questi due personaggi: basterebbe in questo senso procedere a una semplice lettura sinottica del volume di memorie di Gedda uscito nel 1998 e della collazione di fonti prodotta da Gian Carlo Sibilia relative a Carretto nel 1991. Ma va anche detto che questa
Mentre di Gedda non disponiamo ancora di un profilo biografico complessivo, nel caso di Carretto si può già fare riferimento a P. TRIONFINI, Carlo Carretto. Il cammino di un «innamorato di Dio», Editrice AVE, Roma 2010; ved. altresì M. CASELLA, Carretto, Carlo, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. Aggiornamento 1980-1995, cit., Marietti, Genova 1997, pp. 265-272.
376 p ARTE IV - IN UN MOVIMENTO CATTOLICO VARIEGATO
rottura era forse, proprio per la logica delle circostanze, l'unico sbocco possibile per due uomini che pure avevano condiviso, con una intimità che non consentiva ipocrisie, ideali, passioni e progetti per un quarto di secolo.
L'incontro: il maestro e il discepolo
In uno dei suoi volumi di meditazioni per i giovani di Ac, pubblicato nel 1944, e che significativamente vorrà dedicare proprio a Gedda, Carretto ricorda con accenti lirici, che ne rimarcano soprattutto la forza carismatica, il suo primo incontro con l'allora presidente della Giac, avvenuto nel 1930 a Torino: «Conobbi un medico di 28 anni», scriverà Carretto nel 1944,
forte, bello, leale, dominatore. Stare con lui era per me un paradiso. Quando guar
dava i miei occhi sentivo il bisogno di essere buono. [ ... ] Mi condusse nella chiesetta
dell'ospedale e la nostra intimità incominciò facendo assieme la Via Crucis. [ ... ] Con
lui il soprannaturale prendeva consistenza nel mio animo. [ .. .] Il giovane medico te
neva sulla mia spalla la sua buona mano e quel contatto mi elettrizzava: sarei andato
in capo al mondo con lui2.
Effettivamente l'incontro con Gedda segna una svolta fondamentale nella vita di Carretto. Gedda è all'epoca il presidente della Giac torinese ed è alla ricerca di validi collaboratori. Non gli sfugge la forte presa che Carretto riesce ad esercitare sui giovani: una qualità che non tarderà a causargli seri problemi con le autorità fasciste3 , ma che è essenziale affinché l'associazione sia in grado di sostenersi ed espandersi. E non è difficile immaginare il peso dell'ascendente di Gedda nella decisione di Carretto di fare il proprio ingresso, nel giugno 193 3, tra i Missionari della regalità, il sodalizio che riunisce uomini votati a una consacrazione personale, impiantato poco più di dieci anni prima da padre Gemelli4• Gedda ne è membro dal 1929 e, nel 1937, ne diventa addirittura «Fratello maggiore», vale a dire il massimo responsabile dopo il padre fondatore Gemelli. Carretto segue fedelmente le orme del suo "mentore", che tra l'altro, nel 1934, viene investito della Presidenza centrale della Giac. Le segue anche quando, nel 1938, scoppia una grave crisi interna ai Missionari, che Gemelli vorrebbe risolvere azzerando tutto e chiedendo a ciascu-
2 C. CARRETTO, Incontro al domani. Orientamenti spirituali, Editrice Ave, Roma 1944, pp. 66-69. 3 Cfr. L. GEDDA, J;Azione cattolica, il deserto, l'eremo. Ricordo di Carlo Carretto, in «L'Osservatore
Romano», 15 ottobre 1988, p. 3; ved. anche M. CASELLA, Carretto, Carlo, cit., pp. 265-266. 4 «Oggi sono entrato nell'Istituto secolare dei Missionari della Regalità. È una grande tappa in cui devo
fare una cosa sola: ringraziare il Signore», scrive Carretto sul suo diario, alla data del 26 maggio 1933: in C. CARRETTO, Innamorato di Dio. Autobiografia, Cittadella, Assisi 1991, p. 50.
E. GALAVOTTI/ AZIONE POLITICA E AZIONE CATTOLICA: LUIGI GEDDA E CARLO CARRETTO 3 77
no dei membri una riassunzione di responsabilità rispetto agli scopi del Sodalizio. _ Ciò che è meno noto è che il rettore della Cattolica è mosso a questo non tanto dalla
irrequietezza del gruppo che si raduna intorno a Giuseppe Lazzati - che comunque sfocia nella scelta cristallina di dare vita a un altro sodalizio, in cui fossero più disinteressate le scelte, soprattutto rispetto alla carriera universitaria, dei membri -, quanto proprio da alcune scelte poste in essere da Gedda durante il suo mandato da «Fratello maggiore».
Il giovane docente di Patologia medica, infatti, al quale Gemelli sogna di affidare la gestione della futura facoltà di Medicina della Cattolica5, se da un lato può accreditare il successo dell'incremento numerico dei Missionari, dall'altro, tuttavia, persegue una finalità del sodalizio significativamente diversa da quella immaginata dal rettore al momento del suo impianto. Gemelli, infatti, vede nell'edificazione in senso lato della Cattolica la finalità ultima dell'Unione dei missionari, mentre Gedda - concedendosi una libertà di movimento che non può che irritare il rettore - ritiene tale obiettivo secondario rispetto a quello di creare quella che definisce «un'alta spiritualità per i laici»6• Nella memoria di chi vede consumarsi il rapporto di fiducia tra Gemelli e Gedda - il rettore si riferirà a quest'ultimo appellandolo in più occasioni come «quell'impostore»7 -, Carretto viene ricordato come totalmente consonante alla linea perseguita dal «Fratello maggiore». Segue dunque Gedda anche nella decisione di abbandonare l'Istituto gemelliano e di fondare, nel settembre 1942, un proprio sodalizio, la «Società operaia». Gedda abbandona il modello di consacrazione gemelliano e propone ai suoi «operai» - che possono essere indistintamente sposati o laici dediti a una forma di consacrazione - il perseguimento di alcune virtù concrete (prudenza, costanza, ottimismo, spirito di povertà, obbedienza, semplicità), tutte collocate sullo sfondo del riferimento permanente al Cristo del Getsemani, riconosciuto come esempio supremo di abbandono alla volontà di Dio. L'idea di fondo, che Gedda ripropone da subito e frequentemente nelle circolari inoltrate ai suoi sodali, è che solamente attraverso la realizzazione di «opere» sarà possibile per i membri della «Società operaia» conseguire pienamente la propria vocazione di cristiani; questo, affermava l'allora presidente della Giac, avrebbe posto gli operai in una condizione personale ottimale, persino sconosciuta, a suo dire, ai membri di Ac. Le opere, scriveva infatti Gedda poco dopo la costituzione del suo sodalizio,
5 Delle aspettative di Gemelli riferisce lo stesso L. GEDDA, 18 aprile 1948. Memorie inedite dell'artefice della sconfitta del Fronte popolare, Mondadori, Milano 1998, p. 32. Sul valore documentario di questo testo, ved. i fondamentali rilievi avanzati da G. ALBERIGO, Gedda ieri ... e anche oggi?, in «Cristianesimo nella Storia», 21 (2000), 3, pp. 687-694.
6 Cfr. E. FRANCESCI-IINI, Documenti per la storia dell'Istituto, pro manuscripto, Roma 1991, p. 178. 7 Ibidem.
378 PARTE IV - IN UN MOVIMENTO CATTOLICO VARIEGATO
hanno il magico potere di non lasciar sfiorire nel benestantismo pseudoascetico la
nostra vita spirituale, ma di ravvivarla a ogni istante sotto la sferza delle necessità im
pellenti, aumentando in noi il sensus Christi, vagliando con assoluta chiarezza ciò che
è mezzo da ciò che è fine, trasformando il nostro apostolato in scuola, e conservando
alla nostra vita interiore, la modestia, la misura, la fecondità8•
È facile quanto anacronistico stabilire un corto-circuito tra le proposte rivolte agli «Operai» e ciò che verrà imputato alla Giac geddiana del Dopoguerra, accusata appunto di ipertrofia attivistica9• D'altro canto queste pagine vengono scritte da Gedda quando la piega assunta dal conflitto sta facendo scemare paurosamente la fiducia riposta dagli italiani nel regime fasdsta e quando si parla di «opere» si fa riferimento a qualcosa che ha una ricaduta molto concreta su una popolazione già gravemente provata. Lo stesso presidente della Giac chiarisce a questo riguardo quale dovrebbe essere lo stile del membro della Società operaia: certamente non quello di un «faccendone», né quello di un «accentratore» o di un «esauritm>10
•
Tutto questo Carretto sembra averlo ben presente da subito, anche senza dover scorrere le circolari inoltrategli da Gedda. Dal novembre 193 7, con la nomina a presidente della Giac torinese, il suo carico di lavoro è aumentato e nel dicembre 1941, nel corso di un ritiro, annota significativamente sul suo diario che una delle cose essenziali per chi svolgeva un'opera educativa era la ricerca dell'equilibrio tra l'opera della Grazia e quella dell'uomo; paventava infatti_il pericolo del <<formalismo», che descriveva come il «metodo della poca cultura unito alla frenesia dei risultati e alla poca umiltà. Dio - concludeva Carretto - rispetta il maturarsi dell'uomo e non la forza» 11
•
Combattere e ricostruire
A dispetto dei propositi sono gli eventi circostanti a imporre tanto a Carretto quanto a Gedda un costante aggiornamento della propria agenda. Nel radiomessaggio natalizio del 1942 - quello in cui il Papa scandisce un monito che diverrà celebre: «non lamento, ma azione è il precetto dell'ora» - Pio XII sprona i cattolici a sacrificarsi «come gli antichi Crociati» e a farsi protagonisti di un'opera di rinnovamento sociale radicale12
: il Papa non lo può ancora rendere esplicito, ma è chiaro a tutti che l'orizzonte delle sue parole va oltre gli equilibri politici determinati dal fascismo, anche se è tutt'altro che evidente o scontato quale piega
8 L. GEDDA, Lettere operaie, Ed. Operaie, Roma 1947, p. 32. 9 Cfr. C. FALCONI, Gedda e l'Azione cattolica, Parenti, Firenze 1958, pp. 79-80. 10 Ivi, p. 76. 11 C. CARRETTO, Innamorato di Dio, cit., p. 72. 12 Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pz'o XII, vol. IV, Vita e Pensiero,'Milano 1943, p. 338.
E. GALAVOTII! AZIONE POLITICA E AZIONE CATTOLICA: LUIGI GEDDA E CARLO CARRETTO 379
possano prendere gli eventi13 • Carretto sente tutta la gravità del momento ed è - convinto che se di crociata si deve trattare, essa va condotta, come scrive sul suo
diario, «fino in fondo» 14 • L'evoluzione del conflitto lo carica ulteriormente di responsabilità, determinate anche dalle scelte di Gedda, che si sta circondando di responsabili associativi provenienti dal Piemonte. La spaccatura in due della penisola dopo l'armistizio fa sì che divenga direttamente sua la responsabilità dei circa 2/3 dei 11?-embri della Giac, che risiedono al di sopra della Linea Gotica: Carretto deve anzitutto garantire la circolazione delle informazioni tra i membri ed è grazie a lui che sorgono nuove testate come «Apostolato» e «Cenacolo»15 .
Colpisce, in una situazione oggettivamente complessa, la sua capacità sdrammatizzante:
non si potranno fare le grandi assemblee diocesane? Le sostituiremo con frequenti
incontri foraniali. Saranno tagliate le vie della propaganda? Le sostituiremo coi fili
delle relazioni epistolari. Non giungeranno i giornali nazionali? Li sostituiremo coi
giornali litografati o ciclostilati diocesani o foraniali di associazione16•
Anche Gedda, che nel corso del triennio precedente ha sperimentato un forzoso immobilismo determinato dal papa in persona - che non ha voluto prestare in alcun modo il destro alle autorità fasciste per colpire come ai tempi di papa Ratti i circoli di Ac e ha perciò costretto l'associazione a un'attività d'ordinaria amministrazione - si rimette in pista. Due settimane dopo il voto di sfiducia a Mussolini da parte del Gran Consiglio, propone a Badoglio che i quadri direttivi di Azione cattolica subentrino a quelli fascisti per la direzione delle organizzazioni giovanili aventi finalità educative, culturali e assistenziali17 • L'ispirazione che lo muove a questo diventa chiara nelle parole indirizzate ai suoi Operai quasi un anno più tardi:
Aprendosi dinanzi ai Cattolici italiani nuove vie di apostolato che rappresentano, nel
tempo stesso, nuovi doveri come la vita politica e la vita sindacale, l'Azione cattolica
incontra il serio pericolo che il suo lavoro sia considerato meno importante e che i
suoi dirigenti, chiamati ad altre responsabilità, lascino il posto a delle menti meno
qualificate. Non sto a ripetere ciò che sapete e cioè che gli scopi dell'Azione cattolica
sono estremamente necessari e che occorre un fondo stradale di solida spiritualità
13 Sul diario, alla data del 6 gennaio 1943, Carretto annota «i cinque punti della crociata del Papa»: C. CARRETTO, Innamorato di Dio, cit., p. 84.
14 Ivi., p. 86. 15 Ivi., p. 78. 16 M. CASELLA, Carretto, Carlo, cit., p. 267. 17 Cfr. T. SALA, Un'offerta di collaborazione dell'Aci al governo Badoglio (agosto 1943), in «Rivista di
storia contemporanea», 1(1972),4, pp. 517-533. Ved. anche GEDDA, 18aprile1948, cit., pp. 85-86.
380 PARTE IV - IN UN MOVIMENTO CATTOLICO VARIEGATO
com'è quello che l'Azione cattolica ha dimostrato di saper preparare, per consentire
al carro trionfale di Cristo Re, il passaggio verso la società del domani18•
Carretto è, da questo punto di vista, pienamente ricettivo e, dopotutto, non avrebbe ragione di non esserlo: come la quasi totalità dei cattolici che stanno riflettendo sui doveri del momento è portatore di un preciso giudizio sulla società contemporanea: un giudizio tanto più drasticamente negativo quanto più essa viene giudicata colpevole di essersi allontanata dall'idealtipo della christianitas medievale. Conviene così con l'amico Giorgio La Pira, col quale si incontra a Firenze nel gennaio 1943, che il primo dovere dei cattolici sia a questo punto quello di «imprimere la loro fede sulle civili istituzioni»19
•
Negli incontri con i membri di Azione cattolica, Pio XII esterna più volte le aspettative che ripone nell'associazione. Ma è anche cosciente che la fluidità della congiuntura politica impone circospezione. Nella primavera del 1943 scrive così a Gedda, che l'Azione cattolica, proprio per la sua natura, non doveva «lasciarsi trascinare nel vortice dei partiti politici» o autoimprigionarsi negli «angusti confini delle fazioni»20
.
Ma sia il Papa, che il presidente della Giac non possono certo dissimulare come l' azzeramento dei quadri politici prodotto da vent'anni di fascismo renda inevitabile il ricorso a quei bacini d' energie e intellettualità cattoliche -vuoi la stessa Ac, vuoi l'Università Cattolica di Gemelli - che possono garantire risorse per una immediata rimessa in piedi del paese. Tanto più che il collasso finale del regime fascista lascia aperto il problema di come rapportarsi al comunismo: ovvero di chi possa contrastarlo.
Sta di fatto che sarebbe improprio ipotizzare, già in questo momento, l' elaborazione di una vera e propria strategia politica vaticana di cui Gedda e la sua Ac sarebbero uno dei bracci secolari. Il presidente della Giac insiste piuttosto sull'importanza che la politica della neonata democrazia italiana sia permeata di valori religiosi: <<al cattolico d'azione - scrive Gedda nell'estate del 1944 - deve importare moltissimo che la vita cattolica italiana non solamente sia rispettosa del patrimonio religioso del nostro popolo, ma che dia realizzazione a quei principi che i Papi additano come particolarmente favorevoli perché il patrimonio religioso sia conservato e accresciuto»21
•
Svolte e strategie
Questo ritorno alla normalità democratica implica per Gedda e Carretto una nuova svolta, anzitutto nel senso di un'ancora più ampia responsabilizzazione n~lla
18 C. FALCONI, Gedda e l'Azione cattolica, cit., p. 111. 19 C. CARRETTO, Innamorato di Dio, cit., p. 88. 20 C. FALCONI, Gedda e l'Azione cattolica, cit., p. 108. 21 L. GEDDA, !!Azione cattolica non è un partito, in «Gioventù nova», 12 agosto 1944, cit. in G.
FORMICONI, La gioventù cattolica maschile: associazionismo e modelli educativi (1943-1958), in Chiesa e progetto educativo nell'Italia del secondo dopoguerra (1945-1958), La Scuola, Brescia 1988, p. 243.
E. GALAVOTTII AZIONE POLITICA E AZIONE CATTOLICA: LUIGI GEDDA E CARLO CARRETTO 381
struttura che dirige l' Ac. Nel 1946 Gedda viene infatti nominato presidente centrale _ degli Uomini cattolici, mentre Carretto gli subentra alla guida della Giac22
• Un avvicendamento che per molti è semplicemente la realizzazione di una facile profezia, stante il rapporto che unisce i due da ormai più di un decennio, ma che più profondamente determina anche le condizioni per la svolta qualitativa della relazione tra questi due personaggi; tutto porterebbe infatti, di primo acchito, a condividere il rapido giudizio di un lettore critico della vicenda geddiana quale è Carlo Falconi, che vede in questa tornata di nomine semplicemente un incremento del potere personale di Gedda, che potrà comunque continuare a controllare strettamente la Giac, pur non essendone più il presidente, proprio in virtù del rapporto di sudditanza che Carretto vivrebbe nei suoi confronti23 .
Ma un'analisi più attenta rivela come in realtà questo passaggio determini una svolta fondamentale per entrambi. Per Gedda significa svincolarsi da un ambito che è divenuto sempre più costringente rispetto alle ambizioni nutrite per sé e per il ruolo dell'Azione cattolica italiana. Molto infatti è cambiato dalla caduta dal regime: la Democrazia cristiana è ormai a tutti gli effetti - anche a dispetto delle iniziali perplessità di alcuni autorevoli esponenti della Segreteria di Stato - il referente politico per i cattolici italiani e Gedda ha visto sfumare, ma questo ancora pochi lo sanno o lo intuiscono, il suo progetto di fare della Giac l'ombrello onnicomprensivo delle attività giovanili cattoliche: un tentativo che alla fine aveva ottenuto l'unico risultato di far emergere l'irritazione della Fuci e dello scautismo cattolico24
• Questo incidente non ha però diminuito il peso di Gedda, anzi. Ciò che infatti accade a partire dalle elezioni per la Costituente è il radicarsi di un rapporto di fiducia diretto tra il papa e l'alto dirigente di Azione cattolica. Pio XII stabilisce con Gedda un contatto la cui intensità replica in qualche modo quella già in essere con altri personaggi esterni alla Curia romana: basti pensare a padre Lombardi o al cardinale Siri, che come Gedda diventano quasi i ministri-ombra del papa rispetto ad un esecutivo di cui pure il pontefice rimane, sia pure sui generis, il premier. E proprio come nel caso del «microfono di Dio» o dell'arcivescovo di Genova resta difficile capire sino in fondo quanto, dei resoconti che essi fanno delle udienze col pontefice, appartenga agli auspici o alle premure di Pio XII e quanto a quelle dei suoi interlocutori. A questo riguardo un personaggio chiave della curia romana di questo periodo come monsignor Dell'Acqua riferirà riservatamente a nemmeno un anno dalla morte di Pio XII come Gedda fosse
22 Su questa fase dell'impegno associativo di Carretto ved. P. TRIONFINI, «La grande chiamata». Carlo Carretto alla guida della Gioventù italiana di Azione cattolica, in Carlo Carretto nella Chiesa del Novecento, a cura di V. De Cesaris, Cittadella, Assisi 2009, pp. 31-54.
23 C. FALCONI, Gedda e l'Azione cattolica, cit., p. 116. 24 G. FoRMIGONI, La gioventù cattolica maschile, cit., pp. 245-246.
382 PARTE IV -IN UN MOVIMENTO CATTOLICO VARIEGATO
persona molto intelligente, abile, generosa, ma non sempre leale. Per questo parlando
con lui ci si trova un poco a disagio perché non si è sicuri: occorre prudenza e riser
vatezza. Le sue informazioni non sempre sono risultate esatte: sono adattate al suo
modo di vedere25•
Nel caso considerato è evidente come Gedda non avesse dismesso l'idea di fare sentire il peso dell' Ac e della sua imponente ramificazione territoriale per vincolare la Dc a una linea politica di durissima opposizione alle sinistre. Il Papa, scrive dunque Gedda nel dicembre 1946, sarebbe «deluso della Democrazia cristiana»; e poi «vedrebbe bene un impegno dell'Azione cattolica per le elezioni, cosa che però non è possibile perché in contrasto con il Concordato del 1929»;.Pacelli apprezzerebbe persino il «metodo polemico» del qualunquista Giannini e si preoccupa di dire al presidente dell'Unione uomini di Ac che gli è dispiaciuto non riceverlo insieme ai suoi colleghi di partito; ma d'altra parte - pare giustificarsi Pio XII - egli nemmeno «riceve De Gas peri e gli altri» ... 26• I resoconti delle udienze dei mesi successivi si muovono tutti s,u questa falsariga, evidenziando soprattutto come il Papa stia già guardando - oltre la Costituente, dove la Dc sta conquistando faticosamente l'appoggio dei comunisti per la menzione costituzionale dei Patti lateranensi - al prossimo appuntamento elettorale.
Nulla di sorprendente, perciò, nei toni che anche Carretto impiega sin dal suo esordio alla presidenza della Giac, che trasmettono a chiunque scorga i suoi articoli sulla stampa associativa l'impressione che davvero il passaggio rispetto a Gedda viene concepito e realizzato all'insegna di una stringente continuità. Pio XII prospetta l'appuntamento elettorale del 1948 come una scelta «tra la vita e la morte, la benedizione e la maledizione»27 e il nuovo presidente della Gioventù di Azione cattolica impiega toni conseguenti: «Forse», scrive Carretto su «Gioventù» nel novembre 1947, «si sta preparando l'ultima grande battaglia di questa morente civiltà di peccato ... Da questo scontro dipenderà la salvezza o la rovina dell'Italia. Se la gioventù si ridesterà al richiamo di Dio e trascinerà con l'esempio i pavidi, sarà la salvezza»28
•
Ma è possibile altresì registrare sin dall'inizio del suo nuovo incarico una sensibilità, che per comodità si può definire «istituzionale», che lo porta a distinguere sempre più i mezzi dai fini con i quali raggiungerli: un atteggiamento sul quale è possibile comunque già misurare una sensibile divaricazione rispetto al «maestro» Gedda. Anche la
25 Memorandum di A. Dell'Acqua per L.F Capovilla, 23 giugno 1959, in Archivio della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (Bologna), Fondo Giovanni XXIII-Camaitino, 86.8.5. Sul prelato lombardo ved. Angelo Dell'Acqua. Prete, diplomatico e cardinale al cuore della poli'tica vaticana (1903-1972), a cura di A. Melloni, il Mulino, Bologna 2004.
26 Cfr. L. GEDDA, 18 aprile 1948, cit., pp. 103-104. 27 G. FORMIGONI, La gioventù cattolica maschile, cit., p. 247. 28 C. CARRETTO, Dio con noi, in «Gioventù», 16novembre1947, p. 1, ora in P. TRIONFINI, Carlo Carretto,
cit., p. 113.
E. GALAVOTTII AZIONE POLITICA E AZIONE CATTOLICA: LUIGI GEDDA E CARLO CARRETTO 383
strumentazione spirituale di Carretto si fa via via più articolata: il suo Diario testimonia _ sì una inesausta ma tutto sommato ordinaria determinazione a verificarsi, scoprendosi
in questo sempre manchevole; ma accanto agli impulsi determinati dalle esperienze
interne alla Società operaia e alla meditazione getsemanica cresce un altro elemento che per lui ha un vero e proprio valore fondativo, vale a dire la lettura della Bibbia29 •
Azione cattolica e azione politica
Non è però in una sfera più intimistica che si può vagliare l'attitudine peculiare di Carretto nella guida della Giac, quanto su una questione estremamente concreta quale
quella dell'atteggiamento che deve mantenere l' Ac di fronte alla congiuntura politica. Gedda, in questo senso, ha già compiuto da tempo una scelta netta, che dice essere ispirata da Pio XII e che, in un certo modo, reputa vincolante anche per l' associazio
ne: ritiene infatti che la sua missione non sia quella di un impegno diretto nell'agone
politico - è stata viceversa l'opzione, tra gli altri, di un altro storico esponente di Ac quale Giuseppe Lazzati - quanto quella di restare in un ambito esterno a garanzia della «stessa libertà ecclesiale»30• Non possiamo sapere se compiendo questa afferma
zione Gedda stia alludendo al concetto della Libertas ecclesiae che nei secoli passati aveva ispirato la rivendicazione della Chiesa romana di un primato sullo Stato; sta di
fatto che Gedda ricorre a questa libertà anzitutto per incalzare la Dc31• E sono proprio
le perplessità che Pio XII avrebbe manifestato in più occasioni sulla linea politica del partito a convincere Gedda della legittimità della dialettica che inizia nei confronti
della Dc. Carretto, da questo punto di vista, rivela un'attitudine più articolata e, talora,
contraddittoria. Negli interventi pubblici mostra di condividere il giudizio geddiano
e ancor prima papale - sulla gravità del momento; ma non pare sempre propenso, su
un piano pratico più personale, a esporsi o a tirare le medesime conclusioni. Gedda
è invece in questo senso estremamente tempestivo e intraprendente. Nel marzo 1947
viene nuovamente ricevuto dal Papa in udienza, e stando al resoconto da lui prodotto successivamente, i due avevano parlato «soprattutto» del
piano di azione per la prossima consultazione elettorale della Repubblica italiana e
di come superare gli oltre quattro milioni di voti raccolti dai comunisti alle elezioni
29 Cfr. C. CARRETTO, Ho cercato e ho trovato. La mia esperienza di Dio e di Chiesa, Cittadella-Queriniana Assisi-Brescia 1983, p. 49.
30 Cfr. F. MANDILLO, Luigi Gedda, un senatore mancato, in «Jesus», 10 (1988), 12, p. 7: secondo la testimonianza resa da Gedda, De Gasperi gli aveva offerto la candidatura al Senato nel blindatissimo collegio di Viterbo.
31 Su questo aspetto si veda il riccamente documentato articolo di M. CASELLA, Religione e politica nell'Azione cattolica di Luigi Gedda (1952-1959), in «Bollettino dell'archivio per la storia del movimento cattolico in Italia», 44 (2009), 2, pp. 191-252.
384 PARTE IV - IN UN MOVIMENTO CATTOLICO VARIEGATO
per l'Assemblea costituente. Poiché sembra che i comunisti vogliano «bloccare» con
i socialisti, si potrebbe indurre la Democrazia cristiana a fare blocco con altri partiti
[ ... ]. Il Santo Padre menziona «Civiltà Italica», una iniziativa politica di monsignor
Ronca, e io obietto che meglio sarebbe riprendere l'Unione elettorale cattolica nomi
nata dai vescovi32 •
L'idea di quelli che saranno i Comitati civici prende corpo definitivamente, dopo una fase interlocutoria di alcuni mesi, all'inizio del 1948. Gedda riscuote dal Pontefice - che si intratterrebbe con lui anche per discutere della formazione delle liste elettorali33 - fiducia e risorse: soprattutto ottiene il riconoscimento di un ruolo di supervisione assoluta, ulteriormente rafforzato dalla totale assenza per i Comitati di norme statutarie. Il ruolo fondamentale gi9cato dalle strutture e dal personale di Ac all'interno dei Comitati non sfugge a nessuno, tantomeno a chi l'ha teorizzato e realizzato: Pio XII pare, a questo punto, «molto preoccupato» di ciò che potrebbe accadere all'associazione se fosse invocato dalle sinistre il rispetto dei Patti lateranensi - che proprio con il loro consenso sono stati menzionati dalla nuova Costituzione - circa la politicizzazione di Ac. Gedda vuole essere rassicurante e col papa concorda una dichiarazione ufficiale che recita che i Comitati «operano al di fuori e al di sopra di ogni partito politico», dal momento che la loro struttura è diocesana e parrocchiale34 • Ma è evidente che Gedda - in questo certamente contrastato da De Gasperi e non ostacolato da Pio XII - guarda sempre più ai Comitati non come a una struttura liquida ed effimera, creata ad hoc per la scadenza elettorale e destinata a svaporare col 18 aprile, bensì come a un elemento necessario e permanente del quadro politico italiano.
In questo modo Gedda lascia anche emergere una precisa concezione della neonata democrazia italiana nonché del ruolo della Democrazia cristiana rispetto ad essa: manifestando infatti ripetutamente i suoi dubbi sulla capacità strutturale del partito guidato da De Gasperi di tutelare e promuovere gli interessi dei cattolici italiani - e in primis di contrastare il comunismo-, Gedda lascia intendere che i Comitati civici, pur non essendo strutture assimilabili ai partiti ai quali la neonata Costituzione ita-
32 L. GEDDA, 18 aprile 1948, cit., p. 104. 33 Ivi, p. 116. Da questo punto di vista, il passaggio di pontilicato segnerà una svolta definitiva: il
sostituto Dell'Acqua, sospettato di abboccamenti politici con Fanfani nell'inverno 1961, si vedrà improvvisamente privato del saluto da parte di Giovanni XXIII; una volta chiarita la natura dell'incontro con il politico, il Papa riprenderà i suoi consueti rapporti cordiali con il sostituto: «Abbia pazienza», dirà papa Roncalli a Dell'Acqua, «mi avevano detto altrimenti e mi dispiace! Noi non possiamo occuparci in questioni che riguardano esclusivamente lo Stato italiano; non siamo noi che dobbiamo intervenire in questa materia, compilare la lista [dei ministri]! Ero però pronto a toglierle l'amicizia»: Papa Giovanni alla luce dei processi canonici', a cura di G. CAPRTLE, in «La Civiltà Cattolica», 134 (1983), 3190, p. 376.
34 L. GEDDA, 18 aprile 1948, cit., p. 120.
E. GALAVOTTI/ AZIONE POLITICA E AZIONE CATTOLICA: LUIGI GEDDA E CARLO CARRETTO 385
liana ha assegnato un ruolo centrale nella dialettica politica, svolgono una funzione _ essenziale e infungibile rispetto al funzionamento della vita democratica del paese.
All'interno della Dc emerge quindi trasversalmente una certa insofferenza verso la linea impressa all' Ac da Gedda e Carretto. De Gas peri soffre per i condizionamenti che ne derivano all'azione di governo e per l'ulteriore e certo indesiderato filtro che si frappone tra lui e la Santa Sede, con la quale i rapporti, com'è noto, sono tutt'altro che scorrevoli; altri, all'interno del partito, deplorano piuttosto la confusione che si sta causando in un'intera generazione di associati ed è nel gruppo che fa riferimento a Giuseppe Dossetti che trovano finalmente espressione alcune importanti critiche. Nel novembre 1946, in una riunione a porte chiuse destinata ai membri dell'associazione Civitas Humana, nell'ambito di una riflessione sulla realtà politica ed ecclesiale italiana che finisce per toccare anche la situazione dell'Azione cattolica, il politico reggiano dedica così uno spazio ad hoc all'Unione donne e alla Gioventù maschile, constatando, a dispetto
dell'impegno interiore e dell'ansia di soprannatura le facili distorsioni e le deforma
zioni in inaridimenti formalisti, in settarismi di conventicola, in un angelismo anti
storico, in una incomprensione o disinteresse per le vicende sociali e politiche, cui
oggi, per eccesso opposto, si aggiunge la nuova pretesa di inserirci direttamente nel
sociale e nel politico in nome di una visione apostolica che non si concreta però in
un determinato programma politico, mortificando così ancora una volta la natura e
dimenticando l'ambito proprio della prudenza politica35•
Due anni più tardi, nel numero datato novembre 1948 di «Cronache Sociali», è invece uno storico antagonista di Gedda quale è Giuseppe Lazzati a dare alle stampe un articolo dal titolo emblematico - Azione cattolica e azione politica - che rappresenta una precisa censura dell'esuberanza politica dei Comitati geddiani36•
L'assunto di Lazzati è semplice quanto sferzante per la direzione di Ac: esistono due campi d'azione per il cristiano, quello soprannaturale e quello naturale. L' Ac deve mantenersi nel primo, giacché il secondo si realizza nell'azione politica, che è per se stessa indipendente «dalla Chiesa in quanto gerarchia, la quale non può, senza contraddire all'ordine suo naturale, scendere alla determinazione concreta delle singole mete che l'azione politica deve di volta in volta proporsi»37 •
Dossetti rilancia questo messaggio poche settimane più tardi, e proprio di fronte ai Laureati di Ac, afferma che se la mobilitazione dell'associazione giustificata ec-
35 Cfr. P. POMBENI, Alle origini della proposta culturale di Giuseppe Dossetti (1 novembre 1946), in «Cristianesimo nella Storia», 1 (1980), 1, p. 265.
36 Su questo ved. ora G. FoRMIGONI, La lezione di Maritain e l'esperienza di Lazzati. Azione cattolica e azione politica, in «Humanitas», 66 (2011), 2-3, pp. 429-460.
37 G. LAZZATI, Azione cattolica e azi"one politica, in «Cronache Sociali», 2 (1948), 20, pp. 1-3.
386 p ARTE IV - IN UN MOVIMENTO CATTOLICO VARIEGATO
cezionalmente dall'appuntamento elettorale fosse divenuta permanente, si sarebbe commesso un «errore capitale»38
• Gedda accusa il colpo, non può e non vuole far finta di nulla e a strettissimo giro, cogliendo l'occasione di un intervento all'Università Gregoriana, ribadisce la liceità della linea seguita sino a questo momento, accusando i suoi critici di aver ceduto alle sirene del pensiero maritainiano, tenuto sotto mira dal Sant'Uffìzio sin dal 193639• Gedda asseriva dunque che
alla scuola di questo divino Magistero e non di certe filosofie d'oltre alpe che non
sono buona merce d'importazione, noi affermiamo che, dove giunge il cristiano, giun
ge la coscienza cristiana e dove giunge la coscienza cristiana giunge, come Maestra,
la Chiesa, e ivi può giungere l'Azione cattolica. E questo vale anche per la politica40•
Carretto lo segue a ruota con un duro articolo su ,«Il Quotidiano» il cui titolo, giusto perché ogni dubbio fosse immediatamente fugato, ~ esattamente lo stesso di quello dato da Lazzati al suo pezzo su «Cronache Sociali». Esso veniva nondimeno accompagnato da un inciso che, riletto ex post, acquista un certo interesse: per Carretto, infatti, non era realistico immaginare una Chiesa confinata nella trattazione dei soli problemi soprannaturali: essa sarebbe dovuta intervenire
in tutti i problemi che riguardano l'uomo come individuo e come membro di una
società famigliare e politica. Tutte le volte che lo crederà necessario senza che nessuno
di noi possa darle delle lezioni proprio perché tale è la sua missione. E se questo fa la
Chiesa, questo farà l'A.C. che ne è l'espressione più qualificata in campo laicale, senza
aspettarsi che ogni estraneo venga ad insegnarle la via.
L'inciso rispetto a tutto questo, messo curiosamente da Carretto tra parentesi, era che l' «interesse» della Chiesa per tutto ciò che non era sovranatura non doveva implicare ipso facto il fare «la politica di partito» 41 •
38 Cfr. M. CASELLA, Per una storia dei rapporti tra Azione cattolica e Democrazia cristiana nel!' età del centrismo (1947-1953), in De Gasperi e l'età del centrismo (1947-1953), a cura di G. ROSSINI, Cinque Lune, Roma 1984, p. 286.
39 Cfr. P. DORIA, La condanna della "dottrina Maritain", Aracne, Roma 2008. Arturo Paoli ricorderà più tardi come nel 1951 avesse accompagnato Carretto in udienza dal cardinal Pizzardo, segretario del Sant'Uffizio, e come quest'ultimo avesse esclusivamente parlato della necessità di «combattere il maritainismo, considerato una "vera eresia'', della quale erano affetti la Fuci e gli intellettuali cattolici»: G. ZIZOLA, Carlo Carretto nella storia della Chiesa, «Fratello universale». III Convegno fratel Carlo Carretto, (Spello, 9-10 dicembre 1994) Spello 1995, p. 24.
40 Cfr. M. CASELLA, Per una storia dei rapporti tra Azione cattolica e Democrazia cristiana nell'età del centrismo (1947-1953), cit., p. 286.
41 C. CARRETTO, Azione cattolica e azione politica, in «Il Quotidiano», 2 febbraio 1949, ora in P. TRIONFlNI, Carlo Carretto, cit., p. 145.
E. GALAVOTTII AZIONE POLITICA E AZIONE CATTOLICA: LUIGI GEDDA E CARLO CARRETTO 387
Linea Gedda/linea Carretto
Carretto, quindi, seppur con riferimenti che solo gli orecchi più attenti riescono a percepire con tutte le loro implicazioni, lascia occasionalmente emergere delle perplessità. È stato Mario Casella a ricordare che già nel verbale della riunione dei presidenti e assistenti di Azione cattolica del 10-11 gennaio 1947 - sono dunque passati tre mesi dall'avvicendamento al vertice della Giac - si parla di una «linea Gedda» e di una «linea Carretto» proprio sul tema degli spazi d'azione da concedere e garantire alla Democrazia cristiana42 • Il presidente della Giac è spietatamente critico verso l'anticlericalismo del Pci, ma non è meno perplesso rispetto all'azione politica di Giannini, nei confronti della quale Gedda si mostra invece meno intransigente: anche perché non ignora che essa gode, in questo momento, di autorevoli sostenitori nei piani più alti del Palazzo apostolico; inoltre Carretto inizierà a palesare una crescente preoccupazione per l'aumento dei voti alle destre43 • Teme sostanzialmente che nel tentativo di influire sul piano politico, l' Ac venga a sua volta risucchiata e strumentalizzata, perdendo di vista la propria vocazione originaria. Una convinzione, quest'ultima, che una volta conclusa la sua esperienza associativa, verrà ribadita con forza e verrà descritta come dirimente rispetto alle scelte da fare per il proprio futuro: «I politici cattolici», dirà infatti più tardi, «hanno capito che forza era l'Azione cattolica e hanno cercato di strumentalizzarla. Devo dirlo: lì è stato il punto in cui non mi sono più trovato. Si servivano di noi, ed io al servizio di un sistema politico non ci sono mai stato»44 •
Dunque più che insistere su concetti come «svolta» o «conversione» di Carretto - che fondamentalmente sottintendono una critica alla linea di governo perseguita da Luigi Gedda e che peraltro non reggono a una seria verifica dell'insieme degli interventi tenuti dal presidente della Giac in questi mesi - è forse più fruttuoso considerare anzitutto la peculiarità oggettiva della condizione in cui Carretto si viene a trovare dall'autunno 1946. Quella, cioè di chi, investito di un ruolo dirigente, aveva maturato una concezione dell'essenza e degli scopi dell'Azione cattolica in un dato contesto sociale e politico marcato dal regime fascista e che si ritrovava ora a farle interagire con una realtà affatto differente, che includeva anzitutto un assetto democratico e un Partito cattolico di massa che la Santa Sede, certo con tanti distinguo, aveva stabilito come interlocutore privilegiato. Al pari di Gedda, Carretto non intende entrare nella Dc: ma mentre il primo compie questa scelta perché realizza rapidamente che dall'esterno del partito, forte di centinaia di migliaia di associati disseminati su tutto il territorio nazionale, può esercitare una dialettica con De Ga-
42 M. CASELLA, Carretto, Carlo, cit., p. 268. 43 Cfr. C. CARRETTO, Scongiurare i pen'coli del fascismo risorgente, in «Gioventù», 10 luglio 1949, p. 1,
ora in P. TRIONFINI, Carlo Carretto, cit., pp. 153-156. 44 M. CASELLA, Carretto, Carlo, cit., p. 269.
388 p ARTE IV - IN UN MOVI1\1ENTO CATTOLICO VARIEGATO
speri che non gli sarebbe mai possibile come quadro del partito, il secondo sembra piuttosto determinato a mantenersi nel solco della tradizione associativa, astenendosi dal confondere o intrecciare i piani d'azione come membro di Ac e come persona interessata alla cosa pubblica.
Negli interventi sulla stampa associativa - mentre il clima politico si fa incandescente - Carretto detta parole d'ordine come «apostolato» o «missionarietà»: a posteriori vengono sovente decrittate come espressione di una fondamentale ingenuità o di un utopismo che non fa i conti con la dura realtà in cui esse vengono calate (ovvero come l'esempio più evidente dei pesanti limiti culturali espressi dall'associazione). Ma è forse più appropriato leggerle alla luce dell'opzione politica fondamentale compiuta da Carretto. Il presidente della Giac, peraltro, è tutt'altro che vago nell'elencare quelle che legge come priorità per il Governo italiano: è anzi concreto al punto da essere irritante per il capo dell'esecutivo. Nel suo celebre intervento in piazza San Pietro per l'LXXX della Giac, tenuto cinque mesi dopo il redde rationem del 18 aprile 1948, Carretto, alla testa dei 300.000 baschi verdi convenuti nell'Urbe, si rivolge direttamente a De Gasperi facendosi latore di due precise richieste: il lavoro e la casa. Formulava quindi un fermo invito ai responsabili dell'esecutivo: «Siate gli iniziatori di una politica sociale coraggiosa, e i giovani vi guarderanno con ammirazione e vi seguiranno. Dietro di voi verrà una valanga di uomini, siatene certi»45
•
Le parole di Carretto, quali che siano le sue intenzioni, possono essere lette in un duplice senso: come una calorosa esortazione oppure - ed è questa seconda possibilità che sappiamo irrita i vertici democristiani - come un avvertimento46
• D'altro canto è sempre lui, nel maggio 194 9, nel corso di una riunione della Giunta centrale, a deplorare la debolezza del governo di fronte al protestantesimo italiano, così come in altri frangenti denuncia i pericoli del comunismo e della massoneria. I suoi interventi rispecchiano in ogni caso i sentimenti che percorrono trasversalmente i rami associativi e rispetto ai quali, com'è noto, non è immune neppure Gedda, quantunque egli sia decisamente più
45 Il discorso di Carlo Carretto, in «Gioventù», 26 settembre 1948, pp. 4-5, ora in P. TRIONFINI, Carlo Carretto, cit., pp. 130-139; la cit. a p. 134. Sulle reazioni a questo intervento, ved. F. PrvA, «La Gioventù cattolica in cammino ... ». Memoria e stona del gruppo dirigente (1946-1954), Franco Angeli, Milano 2003, pp. 27-50 ..
46 Ripensando a decenni di distanza a quell'evento, Carretto scriverà che «quando decidemmo di ritrovarci insieme a Roma, a recitare il nostro Credo in piazza San Pietro, la spinta era autentica ed era l'amore a dominare i nostri pensieri e i nostri sforzi. Nemmeno noi pensavamo di essere così numerosi e posso dire che in quella notte veramente santa, permeata tutta di preghiera e di fede, lo Spirito era presente in tutto il suo splendore e in tutta la sua trasparenza. Non c'era peccato di trionfalismo, non facevamo l'incontro per dimostrare di essere forti. Eravamo come bambini felici di essere in tanti e di dire grazie a Dio. Lo potrei giurare. Ma dove poteva covare il male? Covava in noi e in chi, vedendoci forti, non perdette tempo a trasferire quella realtà religiosa in un progetto politico. [. . .] E così, trovandoci forti, in molti cominciammo a credere a questa forza e questa fu la nostra debolezza e l'inizio del declino»: C. CARRETTO, Ho cercato e ho trovato, cit., p. 154.
E. GALAVOTT:r/ AZIONE POLITICA E AzIONE CATTOLICA: LUIGI GEDDA E CARLO CARRETTO 389
misurato nell'esternarli in pubblico47 • In questo contesto, infatti, l'Ac è realmente deter-- minata a conseguire un nuovo ordine sociale allo scopo di consentire, come insistono i
quadri direttivi, una più efficace diffusione della «Grazia». D'altra parte sono gli stessi sentimenti che un autorevole esponente democristiano - nonché già sottosegretario nel primo governo De Gasperi - come Giorgio La Pira trasfonde nel celeberrimo articolo I.; attesa della povera gente: anche questo pubblicato su «Cronache Sociali»48
•
La crisi
È proprio nel corso del 1949 che la sintonia apparentemente incrollabile tra Gedda e Carretto entra in crisi. Difficile dire se ne sia la causa diretta o, più semplicemente, un fattore scatenante rispetto a perplessità maturate lentamente in silenzio - tra le quali va anche certamente annoverata la popolarità che Carretto ha via via acquisito all'interno dell'associazione -, ma certamente la pubblicazione di Famiglia, piccola chiesa segna una disarticolazione nel rapporto tra i due49•
Il presidente della Giac, già prolifico autore di opuscoli per gli associati, affronta in questo libretto, destinato a un imprevisto successo, un tema apparentemente innocuo come quello del matrimonio. Ma gli accenti e gli strumenti impiegati - tra questi un ingente ricorso al libro-tabù del Cantico dei Cantici e ad altri passi scritturali - fanno capire subito al lettore che si è di fronte a una prospettiva nuova, che guarda al matrimonio non come a un sacramento di serie B o uno strumento per reprimere la sessualità, ma come una realtà in cui il cristiano si può realizzare integralmente. «Ci sono uomini», scriverà Carretto
che senza tanto discutere escludono dalla loro vita il matrimonio [. .. ]. Hanno paura
della donna e questo chiamano «purezza». Sono pigri e non hanno voglia delle grane
di una casa e questo chiamano «rinuncia». Sono malati e non sentono il bisogno di
figli e questo chiamano «verginità»50.
Le reazioni e le critiche, che impediranno una ristampa del volume, non tardano a venire. Gedda recepisce direttamente quelle di Pio XII, che in un'udienza del set-
47 Cfr. M. CASELLA, Per una storia dei rapporti tra Azione cattolica e Democrazia cristiana nell'età del centrismo (1947-1953), cit., pp. 278-279.
48 G. LA PIRA, I: attesa della povera gente, in «Cronache Sociali», 4 (1950), 1, pp. 2-6. 49 Sulle reazioni a questo testo ved. l'Introduzione di G. CAMPANINI alla ristampa di C. CARRETTO,
Famiglia, piccola chiesa, Editrice AVE, Roma 2007, pp. 5-16, e G. VECCHIO, «Famiglia, piccola Chiesa». Lo scandalo di un libro (1949), in Democrazia e coscienza religiosa nella storia del Novecento. Studi in onore di Francesco Malgeri, a cura di A. D'ANGELO, P. TRIONFINI e R.P. V1ou, Editrice AVE, Roma 2010, pp. 229-240.
50 C. CARRETTO, Famiglia, piccola chiesa, cit., p. 128.
390 PARTE IV - IN ON MOVIMENTO CATTOLICO VARIEGATO
tembre 1949 gli consiglia di comunicare a Carretto l'opportunità di «rifare un capitolo togliendovi delle espressioni troppo "sensuali"»51 . Il fatto non ha conseguenze immediate sul ruolo di Carretto all'interno della Giac, dal momento che proprio nel settembre 1949 viene riconfermato per un triennio, ma non arresta il nuovo corso intrapreso da Carretto, contraddistinto da una seria autocritica, che lo porta anche a considerare la congruità della possibilità delle dimissioni. Sul suo Diario, sempre in queste settimane, scrive che l'Azione cattolica
soffre di senilità. C'è per lei il pericolo di anchilosamento dovuto a una sua sistema
zione eccessivamente giuridica. Se continuasse così l'apostolato si rifugerebbe in altre
opere più giovani e meno dotate di statuti, ma più capaci di captare nella semplicità
dell'intuizione il messaggio dello Spirito. È però un peccato che sia così, perché ali' Ac
ho davvero voluto bene come si vuole bene a una innamorata52 •
Dal canto suo Gedda non pare nutrire dubbi sulla validità degli indirizzi seguiti sino a questo momento, anche perché può riscontrare un incremento degli iscritti in tutti i rami associativi53• Nel 1950 lancia la «Crociata del gran ritorno»54, persuaso che il combinato disposto tra i numeri dell'associazione e il clima dell'Anno santo possano sortire un effetto risolutivo per diminuire la forza del comunismo italiano: l'iniziativa si rivela un sostanziale fallimento; ad essa fa da contraltare la campagna per la «vita interiore» lanciata da Carretto,· ulteriore segnale della differenza di approccio che sempre più distanzia i due leader di Ac55• Dai colloqui di Gedda con il papa risalta la sua preoccupazione per la sorte dei Comitati civici, il cui scopo, a suo modo di vedere, non è venuto mai meno: tanto più che le amministrative del 1951 hanno evidenziato un preoccupante calo di voti per la Dc. Nel giugno 1951 Gedda constata così di fronte al Papa che la Democrazia cristiana avrebbe «sprecato i tre anni trascorsi dalla vittoria del '48, in quanto il comunismo è riuscito a diffondersi dalla classe operaia al ceto medio»56; anche la deplorazione dell'attitudine ostile ai Comitati civici mantenuta dal ramo Laureati verrebbe confortata dalla consonanza di vedute di papa Pacelli. Gedda è persuaso in definitiva dell'insuperabile carenza strutturale della Democrazia cristiana di fronte alla sfida posta in essere dalle sinistre, che obbliga il Partito a un'incessante compromissione che potrebbe essere risolta con
51 L. GEDDA, 18 aprile 1948, cit., p. 141. 52 C. CARRETTO, Innamorato di Dio, cit., pp. 114-115. 53 L. GEDDA, 18 aprile 1948, cit., p. 144. 54 M. CASELLA, I:Anno Santo del 1950, l'Azione cattolica e la "Crociata del gran ritorno". Lettere e
relazioni da diocesi e parrocchie dell'Italia settentrionale e centrale, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 37 (2008), 74, pp. 203-248.
55 Cfr. G. Z1ZOLA, Carlo Carretto nella storia della Chiesa, cit., p. 22. 56 L. GEDDA, 18 apri.le 1948, cit., p. 146.
E. GALAVOTTr/ AZIONE POLITICA E AZIONE CATTOLICA: LUIGI GEDDA E CARLO CARRETTO 391
quella che a Pio XII descrive nel luglio 1951 «una più efficiente Azione cattolica»57 .
Forse anche caricato dalla consonanza di vedute con il pontefice, nelle stesse settimane Gedda alza il livello dello scontro con De Gasperi, appena reinvestito del governo dopo una crisi determinata anzitutto dai contrasti di vedute interni al partito sulla politica economica condotta da Pella. Sul Bollettino di collegamento dei Comitati civici, Gedda si faceva così portavoce dell'irritazione dei Comitati per una crisi di governo della quale non comprendeva il costrutto e che per di più, nel suo giudizio, rischiava di vanificare il duro lavoro dei Comitati stessi per contenere la forza comunista; il giudizio viene ribadito alcuni giorni più tardi in un intervento su «Il Quotidiano» di Azione cattolica, dove Gedda finiva soprattutto per fare emergere in modo distinto la sua insofferenza per le più elementari regole del dibattito democratico58. «Noi viviamo in mezzo al popolo», aveva scritto Gedda come portavoce dei Comitati civici,
e sappiamo che questo popolo, chiamato da pochi anni a vivere in un regime de
mocratico, non avverte il fascino delle sottigliezze partitiche come poteva essere in
altri tempi dell'Ottocento o del primo Novecento, ma piuttosto si annoia, e critica
istituzioni e uomini, quando rallentano, o comunque diminuiscono l'efficienza della
cosa pubblica. Il popolo desidera proprio questo: un Governo efficiente che non
complichi ma risolva i problemi della vita quotidiana; e dai frutti giudica la pianta.
Quando si voglia confermare il popolo nell'educazione democratica, bisogna che la
democrazia si presenti ai suoi occhi come un sistema coerente, armonico e autorevole.
Perché non succeda che democrazia diventi sinonimo di demagogia, di compromesso
e di lentezza, la democrazia deve trovare un freno ai suoi virtuosismi e contenere i
processi interni di autocritica nei limiti della pubblica sopportazione. Altrimenti è
vano lamentarsi che altre teorie si facciano strada, o che il popolo si orienti verso so
luzioni eversive che mettono in pericolo i valori della civiltà. Che la libertà di parola,
di stampa e di azione rappresenti un diritto non vi è dubbio, ma è vero altresì che
il delicato punto di passaggio fra verità e calunnia, fra libertà e licenza, fra libertà e
disorganizzazione deve essere attentamente vigilato, altrimenti la libertà diventa un
essere mostruoso che divora se stesso.
Il leader dei Comitati civici giudicava quindi «arbitrario, anzi ridicolo» il pensiero
che i Comitati civici vogliano soppiantare la Democrazia cristiana, quando proprio
si ebbe cura di precisare che i Comitati civici, i quali raccolgono molti elementi non
57 Ivi, p. 148. 58 Un dato che viene debitamente documentato da S. MAROTTA, Luigi Gedda e l'appuntamento elettorale
del 1952, per «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 24 (2011), 1.
392 PARTE IV - IN UN 'MOVIMENTO CATTOLICO VARIEGATO
iscritti a partiti politici, non sono a loro volta un partito politico. Ma fra questa idea
e quell'altra che i Comitati civici non abbiano un proprio pensiero sulla situazione in
atto, oppure che siano condannati al silenzio, molto ci corre e nessuno può, che non
sia democratico, disconoscere questo buon diritto che abbiamo di esprimerci59•
Al di là delle dichiarazioni d'intenti, è comunque l'attivismo anticomunista imposto da Gedda alle strutture associative e ai Comitati civici a rendere evidente un sempre più forte coinvolgimento dei membri di Ac nell'agone politico. Carretto non riesce più a concordare con questa strategia, che giustificata e ammessa anzitempo con l'emergenza elettorale è divenuta strutturale. Così nella riunione di Giunta centrale del 6-7 novembre 1951 esterna nel modo più diretto la sua opposizione, confortata dalla sintonia di vedute di altri quadri direttivi della Giac:
Di fronte a una massa violenta come il comunismo noi non possiamo contrapporre
una forza che abbia un potenziale equivalente; manca a noi la carica di ordine spi
rituale per far scoccare la scintilla. Sentiamo che vi è una carenza. lo mi domando
quanto può durare la parabola ascendente del nostro incremento numerico secondo i
dati posti in evidenza da Gedda. Vi è un problema di idee, una istanza di porgere un
cristianesimo più aderente alla vita moderna60•
I propositi e gli auspici di Gedda, che dal gennaio 1952 è il presidente di Ac, di un rilancio del ruolo dei Comitati civici e di una contestuale mobilitazione politica dell'associazione trovano ad ogni modo possibilità di esprimersi nella tarda primavera del 1952, quando la Santa Sede, in vista del rinnovo dell'amministrazione comunale di Roma che si teme possa essere: conquistata dalle sinistre che cercano la rivincita dopo l'esito delle politiche del 1948, progetta un cartello che unisca la Dc alle destre. «Se i comunisti vincono a Roma», avrebbe detto Pio XII a padre Lombardi, «vincono in Italia, è una tenebra per tutto il mondo: la Francia diverrebbe comunista e poi la Spagna e l'intera Europa»61 • L'operazione Sturzo - che per alcuni non è altro che il colpo di coda del cosiddetto «partito romano» che De Gasperi era riuscito in ogni caso a devitalizzare già quattro anni prima62 - si colloca in quella fase di inizio di lunga agonia del centrismo che segnerà tutti gli anni Cinquanta e che da questo momento impegnerà la Dc in una defatigante ricerca di nuovi equilibri politici: defatigante an-
59 L. GEDDA, Zodiaco d'agosto, in «Il Quotidiano», 7 agosto 1951, p. 1. 60 M. CASELLA, Carretto, Carlo, cit., p. 270; si veda anche P. TRIONFINI, Carlo Carretto, cit., p. 57. 61 Cfr. G. ZIZOLA, Il mzàofono dz' Dio. Pz'o XII, padre Lombardi e i cattolzd italiani, Mondadori, Milano
1992, p. 270. 62 Cfr. A. D'ANGELO, De Gasperz; le destre e !'«operazione Sturzo». Voto amministrativo del 1952 e
progetti di riforma elettorale, Studium, Roma 2002, e ID., Gonella e l' «operazione Sturzo». I documenti inediti del Segretario della Dc, in «Studium», 101 (2005), 5, pp. 687-734.
E. GALAVOTn/ AZIONE POLITICA E AZIONE CATTOLICA: LUIGI GEDDA E CARLO CARRETTO 393
che per la dialettica che la segreteria del partito deve condurre con le autorità vaticane, determinate a forzare la resistenza di De Gasperi a una alleanza con le destre63•
Gedda vede finalmente riconosciutb il suo progetto di un coinvolgimento diretto dell' Ac nello scontro elettorale, ma quando nel giugno 1952 convoca in segreteria di Stato i responsabili dei rami associativi, constata la profonda disparità di vedute di quelli che dovrebbero essere gli esecutori immediati delle sue istruzioni. Alla presenza di monsignor Tardini il presidente di Ac deve prendere atto che Carretto e i responsabili dei Maestri cattolici, della Gioventù femminile, delle Donne cattoliche, della Fuci e dei Laureati cattolici oppongono un secco rifiuto all'operazione proprio «perché coinvolgeva l'elettorato di destra»64 . In una adunanza che si svolge nelle stesse settimane, Carretto, che è più che mai persuaso di non essere una voce isolata nell'ambito dell' associazione65, si dice convinto «che un intervento in politica dal di fuori che supplisca una immaturità, è fatale alla Chiesa. Sarebbe meglio buscarne a modo - conclude il presidente della Giac -, piuttosto che rifare il fascismo»; Gedda replica che «il papa ha la grazia di stato per decidere e raccomandare un certo riguardo con le destre» e che c'è «bisogno del ricorso al principio di verità che è il papa»66. Al di là dei risvolti immediati, tali incontri rendono comunque evidente tanto alla Segreteria di stato che a Gedda come l' Ac stia subendo una preoccupante scomposizione interna dei quadri dirigenti, soprattutto per ciò che concerne l'attitudine da mantenere nella presente congiuntura politica: ciò su cui, sino a questo momento, non si erano ammesse defezioni.
D'altra parte non poteva essere sfuggito a nessuno - tantomeno a Gedda, che pareva esserne il destinatario principale - il messaggio lanciato da Carretto su «Gioventù» tre mesi prima, quando la condanna del comunismo era stata affiancata da un' altrettanto netta presa di posizione contro il fascismo, e contro di esso anzitutto come atteggiamento mentale: «Pare impossibile», aveva scritto Carretto:
c'è una categoria di gente che non è capace di avere spirito democratico, che altro
non significa se non spirito di un uomo che rispetta un altro uomo. Sono i prepotenti,
i fascisti nell'anima, i paternalisti: veri disastri per l'umanità. Lavorano come se tutto
dipendesse da loro; si sentono direttamente investiti da Dio del compito di salvare
il mondo e pensano che tutto ruoti attorno a loro come al perno della salvezza; in
fondo sono dei violenti anche se non adoperano i pugni e non oserebbero sparare.
Nelle associazioni in poco tempo diventano i padroni, e, liquidati tutti quelli che non
la pensano come loro, costruiscono un sistema per cui diventano gli indispensabili.
63 Cfr. P. CRAVERI, De Gasperi, il Mulino, Bologna 2006, pp. 540-551. 64 L. GEDDA, 18 aprile 1948, cit., p. 153. 65 Si veda a questo proposito la lettera del 16 giugno 1952 indirizzata a Domingo Rapallo in
C. CARRETTO, Innamorato di Dio, cit., pp. 160-161. 66 Archivio Carlo Carretto (Spello), verbale del 27 giugno 1952.
394 PARTE IV - IN UN MOVIMENTO CATTOLICO VARIEGATO
Niente si fa senza di loro, guai a muovere un dito senza di loro! Ma volete sapere il risultato? Appena scompaiono da quell'ambiente, da quella associazione, da quella
città, da quella istituzione, tutto crolla; essi non avevano educato degli uomini, ave
vano educato delle pecore; erano dei prepotenti. La prepotenza nel migliore dei casi
lascia dietro di sé il nulia»67 •
Il punto di non ritorno
L'opposizione all'operazione Sturzo segna il punto di non ritorno nei rapporti tra Gedda e Carretto. Il presidente di Ac non si capacita dell'atteggiamento del suo antico allievo e gli è impossibile giustificarlo di fronte al pontefice, che gli chiede se i suoi subordinati gli stiano ancora prestando ascolto: «l'Azione cattolica per la quale sono stati fatti tanti sacrifici, non è più nostra», lamenterebbe papa Pacelli68• Gedda parla a posteriori di un vero e proprio «ribaltamento»69 del pensiero di Carretto e ne individua le cause nella rete di relazioni intrecciate da Carretto negli ultimi anni: in particolare nel rapporto con don Arturo Paoli e negli «uomini della Democrazia cristiana che lavoravano per un'intesa con i comunisti», tra i quali ritiene di poter collocare Dossetti7°.
Nell'ottobre successivo, Carretto viene comunque confermato per la terza volta alla guida della Giac. Non è ipotizzabile, data la delicatezza del momento e le speculazioni che ne deriverebbero, una rimozione d'ufficio, ma è anzitutto il presidente della Giac a prendere atto che il suo percorso all'interno dell'associazione, e ancor prima il suo rapporto con Gedda, si è esaurito: è dunque lui a togliere d'imbarazzo tutti quanti, offrendo le proprie dimissioni, immediatamente accettate. In un'ultima lettera, Gedda gli consiglia di non arrovellarsi intorno alle vicende di questo «dolorosissimo anno» e rinvia al futuro la soluzione delle questioni che lui - e probabilmente solo lui- giudica pendenti: «poi ci troveremo», gli scrive, «e perfezioneremo il nostro programma»71
; ma in un appunto autografo lasciato tra le sue carte, Gedda lascia trasparire la profonda irritazione e il senso di lacerazione provocatogli dalle più recenti scelte operate da Carretto:
67 C. CARRETTO, La tentazione della violenza, in «Gioventù», .30 marzo 1952, p. 1, ora in P. TRIONFINT,
Carlo Carretto, cit., pp., 200-201. Gedda riscontrerà molto più tardi come negli articoli di Carretto apparsi sulla stampa della Giac spiccassero «i problemi sociologici e l'esaltazione della democrazia»: L. GEDDA, 18 aprile 1948, cit., p. 154.
68 Ivi, pp. 15.3-154. 69 Ivi, p. 154. 70 Ibidem. 71 C. CARRETTO, Innamorato di Dio, cit., p. 167.
E. GALAVOTTVAZIONE POLITICA E AZIONE CATTOLICA: LUIGI GEDDA E CARLO CARRETTO 395
Danni provocati da Carretto
- all'Azione cattolica
- allo schieramento dei cattolici sul terreno politico
- ali' azione del Santo Padre
- alla Società Operaia
sono enormi e ogni giorno ne sento le pesanti conseguenze. Perciò non posso e non
devo rimettere Carretto in circolazione prima che passi molto tempo e che avvengano
le necessarie ritrattazioni e riparazioni72 •
Le strade dei due antichi leader dell'Azione cattolica, però, non convergeranno più73 : tantomeno nel 1974, quando Gedda rianimerà i Comitati civici per ottenere l'abrogazione del divorzio e viceversa Carretto interverrà pubblicamente, suscitando violentissime reazioni, per perorare il mantenimento della Legge Baslini-Fortuna. Alla sorella Dolcidia, che gli chiede ragione delle sue posizioni, l'ex presidente della Giac darà una risposta che dimostrava una volta di più il mutamento radicale della prospettiva di lettura della società italiana e del ruolo del cattolicesimo al suo interno maturata in gioventù e alla quale Gedda aveva invece scelto di rimanere fedele sino alla fine: «voi mi direte: qui siamo in Italia», scriverà Carretto a Dolcidia:
Sì, siamo in Italia, ma l'Italia è ancora una cristianità? No. È questo uno dei segni dei
tempi più evidenti che dobbiamo cogliere: l'Italia è un'accozzaglia di ideologie, un paese
di missione, una terra dove i cristiani (non per il battesimo, ma per la fede) stanno
diventando minoranza. E allora, ecco dove sta il vero problema del referendum sul
divorzio: è in gioco l'unità indissolubile del matrimonio o il rispetto di chi non ha la
fede? Io, in coscienza, non ho dubbi in proposito74•
72 Archivio dell'Istituto per la storia dell'Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI, Fg, Serie Azione cattolica italiana, b. 18, fase. 8. Nel già citato appunto per monsignor Capovilla del 1959, il sostituto Dell'Acqua, aveva anche scritto che «Gedda non sa perdonare e dimenticare quando qualcuno gli si mostra contrario: lo vuole vedere a terra completamente!»; così riteneva che non fosse stato neppure «estraneo al passaggio di Montini a Milano. Gedda stimava Montini, ma nello stesso tempo lo temeva, perché non riusciva a farne un suo strumento di governo».
73 Ancora nel 1998 - a dieci anni dalla morte di Carretto -Gedda ribadiva l'accusa a Carretto, nonché a Mario Rossi, della crisi della Giac: L. GEDDA, 18 aprile 1948, cit., p. 47.
74 C. CARRETTO, Lettere a Dolàdia, 1954-1983, Cittadella, Assisi 1989, p. 168.