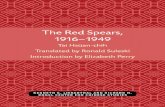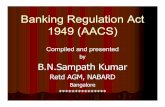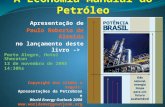Luigi Moretti dal Girasole alla Saracena 1949-70
Transcript of Luigi Moretti dal Girasole alla Saracena 1949-70
Vincenzo Fontana (Università Ca’ Foscari Venezia)
L’architettura di Moretti dall’astratto all’informale: dal girasole alla saracena.
Vincenzo Fontana (Università Ca’ Foscari Venezia) L’architettura di Moretti dall’astratto all’informale: ill girasole e la saracena. Luigi Moretti rivendica la libertà poetica oltre ogni tendenza e ideologia, la fine dell'unità del linguaggio razionalista gli permette un eclettismo individuale ispirato all'informale astratto pittorico. Reyner Banham pubblica il girasole su “Architectural review” del 1954- Su indicazione di Rogers Denis Mac Smith presenta nella mostra Italy Builds al MOMA del 1954 le sue forme dirompenti il contesto del tono sommesso dell'architettura milanese: con la casa albergo di via Corridoni (1948-50) libera rispetto all'isolato con il suo corpo a lama, e poi con il complesso di corso Italia a Milano (1950-53) che ne ripete gli effetti in maniera ancor più drammatica - disposto "di taglio" rispetto alla strada, alla maniera delle figure di Caravaggio, con il prospetto ondulato, tagliato da finestre a nastro, sospeso sulla piastra del basamento (C. Conforti 1994). Dieci anni più tardi Robert Venturi in Complexity and contraddiction in Architecture del 1966 pubblica il timpano spezzato nella palazzina "il girasole" a Roma (1947-50) per farne il simbolo pop della sua architettura ironica che apre la strada al post modern. Ma l’opera romana risulta ben più profonda e complessa delle villette di Venturi; nella palazzina la frattura percorre tutta la facciata enfatizzando l'atrio d'ingresso con un taglio profondo fino al cuore dell’ edificio, le scale e il cavedio. Come nella casa del fascio di Terragni i prospetti sono completamente diversi fra loro: le camere da letto sporgono per aumentare l'insolazione (un accorgimento poi ripetuto da tutti gli alberghi "vista mare" della riviera adriatica); come nella casa Frigerio la facciata continua in aggetto oltre lo spigolo; il bugnato di travertino, su cui si levano in aggetto gli appartamenti, ha la forza dei basamenti d'angolo berniniani di Montecitorio.I volumi curvi dell'ultimo Wright si compongono nella introversa architettura mediterranea della villa "la saracena" (1957) a Santa Marinella, tutta proiettata verso il mare come le antiche ville romane; cilindri e dischi segnati da modanature vengono a illuminare i patii ipogei del garage sotterraneo di Villa Borghese (1970-73), o a far da contrappunto alla architettura internazionale dai brise-soleil bronzei della sede Cariplo a Piazzale Flaminio.Carlo Aymonino trova in lui un maestro quando disegna la palazzina di via Arbia (1960-61 con Maurizio Aymonino e Baldo De Rossi) mantenendo il filo della scuola romana.ROSTAGNI Cecilia, Luigi Moretti 1907-73, Electa, Milano 2008, Scheda 2. Luigi Moretti. Casa del Girasole, ivi, pp. 95-100.
Il pensiero di MorettiSu “Spazio” n.4 del 1951 viene pubblicato il testo “Trasfigurazione di strutture murarie” il cui tema principale è il valore ambiguo della pelle dell’edificio. Partendo da considerazioni sull’architettura medievale dell’area fiorentina, chiarisce il senso del concetto di “Astrazione” come allontanamento. Ciò mette in evidenza il rapporto fra la struttura costruttiva e la figura,lo strato apparente dell’edificio. La questione ruota intorno alla dissociazione fra ciò che Moretti chiama Struttura Reale (cioè la soluzione costruttiva) e la Struttura Ideale, dove conquest’ultima individua il mondo espressivo e formale. E’ un processo tipico dell’architetturaantica questo solidificare alla superficie delle strutture aspetti ideali, o meglio strutture ideali [ sdoppiamento o slittamento di una superficie reale in una certa superficie espressiva.Realtà e rappresentazione sono quei termini su cui si interrogano arte e architettura di ogni tempo. In questo senso il passato per Moretti è considerato un serbatoio di lezioni teoriche. Un tema fondamentale per l’architettura di Moretti progettista è la luce. Il rapporto fra la luce egli spazi architettonici è una delle linee guida del progettare.In “Spazio” n. 5 del 1951 esce il testo “Discontinuitò dello spazio in Caravaggio”. Il discorso è incentrato sulla rappresentazione dello spazio nella cultura architettonica barocca e in particolare nella pittura di Caravaggio. A testimonianza di come le due discipline pittura earchitettura siano connesse, come il significato dello spazio si renda autonomo dalla specificaforma artistica. Dalla continuità dello spazio rinascimentale, dalla intelligibilità in ogni punto della rappresentazione di Boccaccio o Piero della Francesca, Moretti giunge a descrivere lo spazio seicentesco. ネ la luce che diventa definizione ed invenzione dello spazio. Tutto ciò cheesiste nella rappresentazione lo si attribuisce alla luce, come nella Conversione o nel Martirio di S.Matteo. Infatti nell’architettura del seicento romano la luce diventa sinonimo formale di struttura ed energia. Nella fronte di S.Carlino la luce splende ove il carico veramente si addensa, come se la luce fosse una qualità della materia. Fu il grande problema dei barocchi quello di concentrare i carichi e insieme le luci su sostegni senza errare nella sintassi logicadelle strutture⒊La polemica che Moretti accende contro i razionalisti negli anni trenta trova un’eco in “Valoridella modanatura”, “Spazio” n.6, 1951-52. L’arte moderna ha messo al bando ogni forma di cornice e modanatura, un tale rifiuto in architettura, dice Moretti, è da addebitarsi all’antinomiacreata fra razionalismo e decorazione, ma anche allo svalutarsi di quegli elementi ad opera del vuoto utilizzo di forme nello stile floreale o liberty.
Moretti individua il valore della modanatura ravvisandone il senso tettonico, di transito, di passaggio, come scansione del tempo. La modanatura è il segno della stratigrafia degli edifici.Esaltazione della “Struttura reale”, cioè commento della natura costruttiva dell’opera, per poi diventare materiale espressivo.Un’importante riflessione sull’architettura classica è contenuta in “Struttura come forma” in“Spazio” n.6, 1951-52. Moretti contesta il fenomeno per cui nell’architettura contemporanea si considerino separabili i valori plastici da quelli funzionali, da quelli costruttivi. Rifiuta l’atto di semplificazione nei confronti del pensiero di Vitruvio operata dai trattatisti dal ‘500 in poi. Letre categorie firmitas, venustas, utilitas possono soltanto delimitare, descrivere un soggetto ma non definirne l’essenza. Questo perché, dice Moretti, l’architettura è un complesso di relazioni, non una sommatoria di problemi, “Un’opera di architettura è dunque in ogni suopunto realtà e rappresentazione “. Ogni punto è un fatto di ordine tecnico e funzionale, chesottostò alle imposizioni parametriche della realtà e della tecnica, e un fatto espressivo .In “Strutture e sequenze di spazi”, “Spazio” n.7 del 1952-53, il tema principale dellearchitettura di Moretti viene esplicitato in forma teorica. Lo spazio interno, il vuoto viene visto come elemento fondamentale del progetto. Lo spazio interno è considerato vera e propriamateria da progettare. Ne individua qualità specifiche: lo spazio ha una geometria (forma),dimensione (volume), densità (valore della luce), pressione (rapporto psicologico col fruitore,principio del flusso dei fluidi). Questioni che vengono argomentate analizzando casi di studio del passato, perché “! grandi spazi dell’architettura nascono con Roma”, dove gli spazi interni rappresentano un forte tema progettuale come Villa Adriana, il Palazzo Ducale di Urbino, laRotonda di Palladio. Il tema della concatenazione degli spazi, inoltre, una delle chiavi di lettura dell’edificio della Scherma al Foro Italico e dell’edificio della GIL a Roma.Un altro tema centrale della poetica di Moretti è il valore del tempo e la componente narrativadel progetto. In “Strutture ideali dell’architettura di Michelangelo e dei barocchi” la questionedel linguaggio come stratificazione del tempo ed espressione specifica di una cultura analizzata sull’esempio di Michelangelo. Nel Vestibolo della Biblioteca Laurenziana Michelangelo compie una rilettura della semantica della colonna in strutture prestigiose dell’antichità chesubiscono l’aggressione del tempo e le trasformazioni per gli usi contingenti degli uomini. Lacolonna inalveolata diventa una rappresentazione, “Un racconto epico in cui si inseriscono tutti i fatti minuti della vita”. Una dimensione angosciosa del tempo assunta come elemento poetico.
Il girasole 1947-50
Nel novembre 1945 Moretti fondò con il conte Fossataro, conosciuto in carcere, la Cofimprese, società che svolse un ruolo non marginale nella gestione delle operazioni della ricostruzione post-bellica a Milano.
La Cofimprese previde la costruzione di venti alberghi a Milano, dei quali ne furono costruiti solamente tre e realizzò tra l'altro il complesso di Corso Italia, prima di sciogliersi nel 1950.La palazzina "Il Girasole" costruita a viale Bruno Buozzi a Roma nel 1950 è uno dei progetti più noti del periodo, ed è considerata un esempio precoce di architettura postmoderna. L'edificio è pubblicato da Reyner Banham su “The Architectural review” del 1954 e nella mostra Itali Builds al Moma di NY citato anche nel saggio di Robert Venturi Complessità e contraddizioni nell'architettura 1966 come esempio di architettura ambigua, in bilico tra tradizione ed innovazione.In seguito Moretti progettò ville per committenti illustri, tra cui Villa La Saracena a Santa Marinella per l'ex direttore del quotidiano romano Il Messaggero Francesco Malgeri.Nel 1950 inoltre fondò la rivista Spazio, Rassegna delle Arti e dell'Architettura (pubblicata fino al 1953) volta alla ricerca di un collegamento fra le diverse forme d'arte (dall'architettura alla scultura, dalla pittura al cinema e al teatro), non a caso il numero uno si apriva con un saggio intitolato Eclettismo e unità di linguaggio. La rivista era gestita e redatta quasi totalmente dall'architetto romano che fece confluire in essa i risultati della sua attività di ricerca e di studio, su di essa pubblico saggi fondamentali, quali Forme astratte nella scultura barocca, Discontinuità dello spazio in Caravaggio e Strutture e sequenze di spazi. Moretti ne fu per l'intero ciclo editoriale direttore e redattore. La rivista, stampata a Milano in un primo momento dalla tipografia E. Barigazzi, quindi dalla tipografia Lucini, ebbe vita breve, limitata all'uscita di soli sette numeri. Nei decenni successivi Moretti fece uscire sporadicamente dei numeri, perlopiù monografici, della rivista: nel 1959 uscì un numero dedicato allo scultore Pietro De Laurentiis. Nell'aprile del 1963 pubblicò su Spazio il saggio Strutture di insiemi e nel 1964 il saggio Significato attuale della dizione "architettura". È del luglio del 1968 un numero in cui compare il saggio Capogrossi dedicato al celebre pittore romano.Era il 1954 quando Moretti decise di fondare la galleria d'arte, anch'essa denominata Spazio, nella sua città, Roma, cui si affiancheranno successivamente altri luoghi espositivi che alimenteranno il dibattito sull'arte informale tra la Capitale e Torino.Il suo interesse verso l'arte si palesò inoltre dalla tendenza al collezionismo d'opere, soprattutto, del Seicento e dell'antichità.Nel 1957 divenne consulente esterno della SGI (Società Generale Immobiliare) per la quale progettò, tra l'altro, gli edifici alla testata dell'EUR. Nello stesso anno collabora con il Comune di Roma e con il ministero dei Lavori Pubblici, elaborando i progetti per il piano intercomunale di Roma (mai approvato) e per il Parco Archeologico, dai quali nacque la polemica con Bruno Zevi e con l'Espresso sulla devastazione dell'Appia.Sempre nel 1957 fondò l'Istituto per la Ricerca Matematica e Operativa applicata all'Urbanistica (IRMOU) con il fine dichiarato di portare avanti gli studi sulla cosiddetta architettura parametrica, dottrina che si rifaceva all'applicazione di teorie matematiche nella progettazione urbanistica. Rapportare la progettazione dell'ambiente costruito all'analisi matematica, evidenzia le radici funzionaliste di Moretti che studia nuove relazioni dimensionali dello spazio architettonico ed urbanistico, come Le Corbusier aveva studiato il modulor e la sezione aurea. Questi studi furono presentanti nel 1960, con vasta eco di stampa, alla XIII Triennale di Milano.Nel 1958 passò poi a progettare importanti quartieri residenziali, tra cui il CEP di Livorno; inoltre in quell'anno partecipò alla realizzazione del progetto del Villaggio Olimpico pensato per la XVII Olimpiade in programma a Roma nel 1960. Proprio per la progettazione del villaggio nel 1961 ottenne il Premio IN/ARCH 1961 per la miglior realizzazione nella regione Lazio. Sulla medesima direttrice urbanistico-progettuale è il Quartiere di Decima a Roma, parzialmente realizzato tra il 1960 e il 1966 per conto dell'INCIS.In questo periodo Moretti ebbe un'influenza rilevante sui lavori del piano regolatore di Roma, che sarà adottato dal Consiglio comunale il 18 dicembre 1962.
Nel 1957 divenne consulente esterno della SGI (Società Generale Immobiliare) per la quale progettò, tra l'altro, gli edifici alla testata dell'EUR. Nello stesso anno collabora con il Comune di Roma e con il ministero dei Lavori Pubblici, elaborando i progetti per il piano intercomunale di Roma (mai approvato) e per il Parco Archeologico, dai quali nacque la polemica con Bruno Zevi e con l'Espresso sulla devastazione dell'Appia.Sempre nel 1957 fondò l'Istituto per la Ricerca Matematica e Operativa applicata all'Urbanistica (IRMOU) con il fine dichiarato di portare avanti gli studi sulla cosiddetta architettura parametrica, dottrina che si rifaceva all'applicazione di teorie matematiche nella progettazione urbanistica. Rapportare la progettazione dell'ambiente costruito all'analisi matematica, evidenzia le radici funzionaliste di Moretti che studia nuove relazioni dimensionali dello spazio architettonico ed urbanistico, come Le Corbusier aveva studiato il modulor e la sezione aurea. Questi studi furono presentanti nel 1960, con vasta eco di stampa, alla XIII Triennale di Milano.Nel 1958 passò poi a progettare importanti quartieri residenziali, tra cui il CEP di Livorno; inoltre in quell'anno partecipò alla realizzazione del progetto del Villaggio Olimpico pensato per la XVII Olimpiade in programma a Roma nel 1960. Proprio per la progettazione del villaggio nel 1961 ottenne il Premio IN/ARCH 1961 per la miglior realizzazione nella regione Lazio. Sulla medesima direttrice urbanistico-progettuale è il Quartiere di Decima a Roma, parzialmente realizzato tra il 1960 e il 1966 per conto dell'INCIS.In questo periodo Moretti ebbe un'influenza rilevante sui lavori del piano regolatore di Roma, che sarà adottato dal Consiglio comunale il 18 dicembre 1962.Progettista Luigi MorettiCommittente Adolfo Fossataro (committenza privata)Ubicazione - - nazione Italia- città Roma - provincia - via/piazza, n° civico Viale Bruno Buozzi 64, angolo via P.A. MicheliDatazione progetto 1947Inizio realizzazione 1948-50Fasi significative di realizzazione Destinazione d'uso originaria Edificio residenzialeDestinazione d'uso attuale Edificio residenziale
Descrizione - - luogo L’edificio sorge nel quartiere dei Parioli, a nord di villa Borghese.- esterno L’edificio, un parallelepipedo leggermente trapezoidale, è costruito su un basamento di travertino e presenta sul fronte principale una profonda apertura centrale che ha il duplice scopo di illuminare l’atrio aperto all’interno e separare in due parti la facciata, una sorta di schermo staccato dal piano di facciata vero e proprio e indipendente dalla distribuzione planimetrica degli interni, solcata dai grandi infissi orizzontali scorrevoli dei soggiorni, che valicano i confini laterali dell’edificio stesso. Il coronamento è un frontone spezzato, asimmetrico. Il basamento è in lastre di travertino grezzo di Tripoli, mentre le fasce marcapiano sono rivestita di tessere di mosaico vetrose.Il fronte laterale (su cui si affacciano le camere da letto) presenta un andamento a “dente di sega”, soluzione che permette una migliore illuminazione e che valse all’edificio l’appellativo di “Girasole”.Il superattico è parzialmente occupato da un’ampia terrazza.Il fronte posteriore è uno schermo, una sorta di membrana di protezione dei locali di servizio rivestito di intonaco.- interni L’edificio si sviluppa in un piano seminterrato, un piano rialzato, tre piani tipo di due appartamenti ciascuno, un attico con un solo alloggio e un superattico in corrispondenza ddl frontone spezzato della facciata principale.Dall’ingresso si passa a un vasto atrio in parte coperto e in parte a cielo aperto. Su questa apertura centrale, che si estende per tutta l’altezza dell’edificio, si innestano i due corpi scala, quella principale agganciata a un colossale pilastro di cemento che dall’ingresso pubblico porta ai piani residenziali e quella privata che esce sul retro.Gli spazi del soggiorno hanno aperture molto ampie, mentre nelle camere da letto l’illuminazione risulta più mediata grazie ad infissi scorrevoli trasversali rispetto al prospetto laterale.Il piano tipo è diviso in due appartamenti dalla direttrice della fenditura della facciata principale.Ogni appartamento, concepito come unità indipendente, prevede un soggiorno sul prospetto principale, le camere da letto e i servizi su quello laterale e le cucine e un piccolo alloggio di servizio su quello posteriore.- schema planimetrico L’edificio, costruito sull’asse longitudinale nord-sud del lotto, ha una pianta a U organizzata attorno a una corte interna.- sistema e materiali costruttivi Struttura intelaiata in cemento armato.Il rivestimento della facciata principale e di quella laterale è in tessere di mosaico vetroso per l’elevazione, in travertino per il basamento mentre il fronte posteriore è intonacato.- programma funzionale Edificio per appartamenti di lusso con due appartamenti per piano, più un attico con un solo alloggio e un superattico con terrazza.Ubicazione degli archivi cartacei o fotografici Archivio Centrale dello Stato di Roma, Fondo Luigi Moretti.Archivio Plinio Marconi, Roma.Bibliografia essenziale F. BUCCI, M. MULAZZANI, Luigi Moretti. Opere e scritti, Milano, Electa, 2000.C. ANTONNICOLA, Luigi Moretti. La palazzina il Girasole, Rome 1950, in “Le Moniteur Architecture”, n. 50, aprile 1994, pp. 46-49.L. SPINELLI (a cura di), Itinerario: Moretti e Roma, in “Domus”, n. 734, gennaio 1992, p. 80.L. FINELLI, Luigi Moretti: la promessa e il debito. Architetture 1926-1973, Roma, Officina edizioni, 1989, pp. 67-70.A. BELLUZZI, C. CONFORTI, Architettura italiana 1944-84, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 95-100.S. SANTUCCIO (a cura di), Luigi Moretti, Bologna, Zanichelli, 1986, pp. 80-83.s.a., Immeuble d’habitation a Rome, in “L’architecture d’Aujourd’hui”, n. 41, giugno 1952, pp. 40-45.L. MORETTI, Eclettismo e unità di linguaggio, in “Spazio”, n. 1, luglio 1950.
Terragni e Lingeri casa Giuliani Frigerio Como 1939-40 scomposizione della scatola volumetrica con facciate in aggetto sulla intelaiatura portante
Casa albergo in via Corridoni, Milano. 1948Committente: Comune di MilanoCollaboratori: Ettore RossiImpresa: Società CofimpreseNell’immediato dopoguerra Moretti lavora soprattutto a Milano dove fonda, con Adolfo Fossataro, la società Cofimprese a cui il Comune di Milano affida la realizzazione di una serie di complessi residenziali.In una intervista del 1987 Adolfo Fossataro ricorda:“… dopo la liberazione conoscemmo, Moretti ed io contemporaneamente, un assessore comunista, l’assessore Montagnana, il quale ci prese in simpatia e accettò l’idea di Moretti di costruire le case-albergo, per le quali io mi occupai di trovare i finanziamenti e di recuperare i fondi, mentre Moretti avrebbe curato la parte progettuale ed esecutiva…. Il Comune accettò in pieno l’idea delle case albergo perché io mi ero impegnato a trovare dei contributi finanziari. Ricordo bene che il contratto era di circa un miliardo, anche se poi arrivò a quasi tre miliardi, perché i lavori anziché durare diciotto mesi, durarono quasi cinque anni. Il contratto iniziale, dicevo, fu esattamente di 900 milioni, e questa fu una grossa bomba che scoppiò a Milano, quando si seppe che due novellini, chiamiamoci così, avevano sfondato con un’amministrazione comunista mentre altri no. Infatti Rossi era un fascistone, Moretti era un fascista, io ero un fascista, e, nonostante ciò costruimmo queste case albergo..”L’edificio di via Corridoni rappresenta una forte novità nella concezione dell’edilizia residenziale di quegli anni. E’ concepito per ospitare 520 piccoli appartamenti, di mq 20 ciascuno, fruibili da una sola persona, affiancati da infrastrutture per servizi comuni (ristorante, sale soggiorno, locali di servizio diversi), e completati da corpi di collegamento destinati a negozi ed uffici.Caratterizzato dalle grandi fenditure delle testate, coincidenti con i corridoi centrali, l’edificio, in cemento armato, è rivestito in mosaico di vetro bianco, primo esempio di una finitura che Moretti riproporrà in opere successive.Negli anni successivi Moretti realizza a Milano altre due case-albergo, in via Lazzaretto e in via Bassini.Moretti ha detto:“L’edificio è una delle opere più ardite dell'architettura moderna e nel suo tipo unica in Europa. Nel suo stile d’avanguardia nessuna concessione è stata fatta a elementi decorativi, ma tutta la bellezza e l’efficacia è stata realizzata con le sole aperture delle finestre, che con la loro dislocazione rispondono esattamente alle necessità interne delle stanze. Pur essendo un’architettura senza decorativismi, essa assume un valore particolarmente lirico, specialmente attraverso le grandi fenditure delle testate, che segnano esattamente lo spazio dei corridoi centrali. Corridoi che sono concepiti come strade sovrapposte, ciascuna delle quali a servizio di due fila di case minime.„
Documentazione conservata in archivio * Bozze dell'articolo La casa albergo di via Corridoni in Milano; n. 4 copie degli elaborati di progetto: pianta del primo piano (17 giu. 1948 - 22 lug. 1948), pianta del terzo e quarto piano (20 apr. 1948 - 14 giu. 1948), pianta del seminterrato (22 mag. 1950), pianta del piano terreno (16 mar. 1950). * N. 3 disegni autografi: tre ipotesi di progetto. * N. 7 elaborati di progetto: piante, diversi livelli e pianta della cellula tipo.Riferimenti bibliograficiDomus, Paesaggio urbano, 1950, n. 243, p. 12 Pagani C., Spazio, Documentario dell'architettura italiana dal 1946 al 1949, Roma 1950, n. 1, p. 35 Moretti L., Spazio, Struttura come forma, Roma 1951, n. 6, pp. 5-21Bottoni P., Antologia di edifici moderni in Milano, Editoriale Domus, Milano 1954, pp. 54-57Pagani C., Architettura italiana oggi, Ulrico Hoepli Editore S.p.A., Milano 1955, pp. 195-197Santini P.C., Comunità, Profili di architetti: Luigi Moretti, Milano 1957, n. 52, pp. 66-71Pica A., Milano. Guida Ariminum, 1964 Bonelli R., Luigi Moretti, Roma 1975, p. 9 Grandi M./Pracchi A., Milano. Guida all'architettura moderna, La ricostruzione, Zanichelli Editore, Bologna 1980, pp. 244-245, 249AA. VV., Milano, La città storica, Touring Club Italiano, Milano 1985, p.334Santuccio S., Luigi Moretti, Zanichelli Editore, Bologna 1986, p.33, pp. 70-73Milelli G., Parametro, Gli scritti di Luigi Moretti: autoritratto nero su bianco, Faenza Editrice, Faenza 1987, n. 154, n. 2, pp. 24-31, 42-49 Finelli L., Luigi Moretti. La promessa e il debito. Architetture 1926-1973, Roma 1989, pp. 54-55Irace F., Abitare, Moretti a Milano, Editrice Segesta, Milano 1991, n. 297, pp. 148-149Irace F., Milano Moderna. Architettura e città nell'epoca della ricostruzione,Moretti a Milano, Federico Motta Editore, Milano 1996, pp. 10-49 Bucci, F./Mulazzani M., Luigi Moretti. Opere e scritti, Electa, Milano 2000Gramigna G./Mazza S., Milano. Un secolo di architettura milanese dal Cordusio alla Bicocca, Ulrico Hoepli Editore S.p.A., Milano 2001, p. 224 Note La casa-albergo di via Corridoni è uno dei 22 complessi residenziali che la COFIMPRESE, società di Luigi Moretti e Antonio Fossataro, doveva realizzare per incarico del Comune di Milano. Gli edifici effettivamente realizzati furono in realtà solo tre: oltre a quello di via Corridoni, quelli di via Lazzaretto e di via Bassini (zona Città-Studi).
L'edificio fa parte di un complesso di opere che il Comune di Milano programma al termine della seconda guerra dando il via al piano di ricostruzione della città devastata dai bombardamenti.La casa albergo di Luigi Moretti si trova in via Corridoni 22, in una zona semi centrale della città appena oltre la cerchia dei navigli, non lontano dal Palazzo di Giustizia.Inserito in un'area quadrangolare, l'edificio ha una pianta ad H costituita da due corpi principali, elevati su sei e quattordici piani, con struttura portante in cemento armato e copertura piana a terrazza. Allineato al bordo stradale è il fabbricato basso, destinato ad ospiti femminili, originariamente per "donne laureate", mentre quello alto, riservato ai maschi, è molto arretrato dal bordo del lotto e preceduto da una sistemazione a giardino con platani. Di collegamento fra i due fabbricati lineari è un corpo basso con l'ingresso principale comune per la ricezione degli ospiti, attraverso il quale sono smistati gli accessi alle due sezioni.Le facciate sono prevalentemente rivestite da tesserine a mosaico bianche, con finitura ad intonaco nelle parti inferiori, e contraddistinte da aperture ripetute in serie, con tagli verticali sulle testate per illuminare i lunghi corridoi. Il fabbricato più alto, dalla cui fronte ad est emergono due volumi in corrispondenza dei collegamenti verticali, è diviso nettamente da una profonda fenditura centrale, con ponticelli al settimo e all'ultimo piano, cui corrisponde un ingresso di servizio. Lo spazio dei singoli piani è suddiviso con alloggi minimi con camera singola e bagno, con cucina comune, serviti da due blocchi di scale con ascensore. Completano la razionale organizzazione per funzioni alcune attrezzature collettive: bar ristorante, sale di soggiorno e lettura con biblioteca, una palestra al piano seminterrato e un salone per bagni termali e sauna.Il passare del tempo non ha causato seri problemi di degrado all'edificio; le facciate sono in discreto stato di conservazione e il problema principale riguarda l'esteso distacco del rivestimento a mosaico. Con alcuni interventi di adeguamento il complesso ha mantenuto nel tempo la destinazione alberghiera; oggi è occupato dal Daniel's Hotel che ospita prevalentemente studenti che partecipano ai progetti internazionali Erasmus e docenti stranieri. La residenza, gestita direttamente dal Politecnico, attualmente è occupata solo in una parte del corpo più alto, la cosiddetta Torre A.Moretti era molto legato alla casa albergo di via Corridoni, per la quale si compiaceva di un risultato così appagante raggiunto con mezzi limitati. Riconosciuto il valore, l'opera è ufficialmente considerata bene artistico di particolare interesse e dal 1998 sottoposta a tutela da parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.Notizie storiche Committente della casa albergo di via Corridoni è il Comune di Milano, per il quale la Cofimprese realizza tra il 1947 e il 1956 un ampio complesso di opere pubbliche comprendente case popolari, case unifamiliari a schiera, case I.N.A., scuole ed asili, opere di fognatura e canalizzazioni. Un progetto preliminare per la costruzione di residenze a favore di persone senza tetto a seguito degli eventi bellici è redatto nel 1946 dal Comune che delibera l'acquisto di gruppi di case albergo o altre costruzioni da edificare su terreno di proprietà pubblica e da destinare in affitto a basso canone a piccoli nuclei familiari, a scapoli e nubili, a impiegati, operai e a studenti. Nei propositi dell'Amministrazione con questo intervento da un lato si contribuirà alla soluzione del problema della disoccupazione, dall'altro si darà un notevole apporto al riassetto della vita civile ed al potenziamento efficace della ripresa economica cittadina.Un mese dopo sono individuate le aree più adatte alla costruzione delle case albergo previste: sei in tutto, fra le quali non compaiono le aree di via Filippo Corridoni e di via Bassini, poi interessate dall'edificazione, ed è già indicata l'area di via Zarotto sulla quale sarà realizzato il secondo lotto.Nel marzo 1947, la Giunta Municipale, presieduta dal Sindaco Greppi, delibera l'approvazione dell'accordo con la Compagnia Finanziaria delle Imprese di Costruzioni (Cofimprese) per la costruzione di tre case albergo. Il contratto è siglato nel mese di giugno.Il progetto dell'edificio di via Corridoni - come degli altri due complessi - è elaborato dall'architetto Luigi Moretti, con l'ingegnere Giulio Borelli estensore dei disegni delle strutture in cemento armato.La costruzione dei tre gruppi di case, pur regolata da un unico contratto e sottoposta ad una unica direzione dei lavori, assolta da Enrico Ghiringhelli, tecnico degli uffici comunali, è stata tenuta distinta in tre lotti dal punto di vista contabile: il primo lotto corrispondente al complesso di via Corridoni, il secondo a via Zarotto, il terzo a via BassiniL'area da edificare è consegnata all'impresa nel luglio 1947; i lavori di costruzione del palazzo sono conclusi tra la fine del 1950, con il corpo su sei piani, e l'inizio del 1951, quando è giunto a completamento l'edificio elevato su quattordici piani.
Edificio per uffici e abitazioni Corso d’Italia Milano 1949-55; Caravaggio
Davide e Golia, Gall Borghese Roma
Il complesso è ubicato lungo corso Italia. Un lotto pregiato nel nucleo storico della città.Il lotto non è lontano da piazza Missori, entro l’isolato delimitato dalle vie Rugabella, e Sant’Eufemia. Questa zona è stata quasi totalmente rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale e riorganizzata sulla base di un piano particolareggiato che propone un nuovo modello urbano impostato su alti blocchi edilizi e aree distinte secondo destinazioni funzionali diversificate.Il progetto si impone -in tutti i sensi- sull’intorno, anche sui ben più modesti lotti edificabili circostanti, sia in termini di dimensioni che di risultati progettuali conseguiti.Moretti affronta il tema di un complesso polifunzionale nel contesto storico di Milano, proseguendo la ricerca e le sperimentazioni progettuali attorno al rapporto tra impianto planimetrico, volumi e superfici.La vicenda costruttiva si protrae a lungo negli anni, in ragione dell’ampiezza e complessità dell’intervento.Il complesso si compone di cinque edifici, accomunati da una immagine unitaria ma con precise differenze in termini di altezza, forma e orientamento. I vari corpi sono distribuiti attorno ad un fulcro attraversato da un sistema di percorsi, piazze e giardini.L’assetto del complesso è preannunciato già sul corso da due corpi, uno di nove piani, l’altro di tre. Sulla via Rugabella si allinea un altro fabbricato di tre piani, che definisce il limite nord-ovest dell’area. Arretrato al bordo più interno del lotto è il corpo di fabbrica destinato a residenza, che si eleva sino a quattordici piani ed è sottopassato dalla nuova strada di accesso. I diversi edifici presentano differenti impaginazioni di facciata, sia nella griglia delle finestre che nei materiali di rivestimento, mosaicato a tesserine bianche per il blocco di uffici e con lastre di calcare compatto per quello adibito ad abitazione; questo ultimo, con due o quattro appartamenti per livello, ha le facciate maggiori aperte da logge.Ma è il corpo destinato ad uffici a caratterizzare l’intero progetto, preannunciato dall’incombente massa volumetrica che sembra quasi essere semplicemente adagiata-appoggiata: il blocco prolunga sino ad aggettare sulla strada a partire dalla base sottostante. Il complesso polifunzionale è, certamente, una delle tappe progettuali più importanti di Moretti, nella quale egli esplora il rapporto tra l’impianto planimetrico, rigoroso, e l’espressività della forma, secondo una impostazione propria dell’architettura organica, letta in chiave post-razionalista.In “Spazio” n. 5 del 1951 esce il testo “Discontinuità dello spazio in Caravaggio”. Il discorso è incentrato sulla rappresentazione dello spazio nella cultura architettonica barocca e in particolare nella pittura di Caravaggio. A testimonianza di come le due discipline pittura earchitettura siano connesse, come il significato dello spazio si renda autonomo dalla specificaforma artistica. Dalla continuità dello spazio rinascimentale, dalla intelligibilità in ogni punto della rappresentazione di Boccaccio o Piero della Francesca, Moretti giunge a descrivere lo spazio seicentesco. ネ la luce che diventa definizione ed invenzione dello spazio. Tutto ciò cheesiste nella rappresentazione lo si attribuisce alla luce, come nella Conversione o nel Martirio di S.Matteo. Infatti nell’architettura del seicento romano la luce diventa sinonimo formale di struttura ed energia. [….] nella fronte di S.Carlino la luce splende ove il carico veramente si addensa, come se la luce fosse una qualità della materia. Fu il grande problema dei barocchi quello di concentrare i carichi e insieme le luci su sostegni senza errare nella sintassi logicadelle strutture⒊
Il corpo di sinistra, triplo e più alto, presenta la sezione orizzontale fortemente rastremata nella parte costruita a sbalzo verso corso Italia. Il corpo di destra, a manica semplice, è situato in aderenza agli stabili preesistenti. Normalmente all’asse della strada interna, che lo sottopassa si innalza per quattordici piani il corpo maggiore, partito in due verticalmente da una fenditura mediana.La complessa soluzione urbanistica, grazie a una meditata articolazione dei corpi di fabbrica e a un attento studio volumetrico, ha consentito un alto sfruttamento ma evitato l’intasamento edilizio dell’area, e ha stabilito una comunicazione diretta fra corso Italia e via San Senatore. La modulazione dei volumi trae partito dalle condizioni ambientali e si inserisce con naturalezza, senza lacerazioni, nel tessuto preesistente. Si ritiene che riescano di particolare interesse, dal punto di vista formale, il fianco del corpo alto su via Rugabella per la sua modulazione plastica di blocco chiuso in netto contrasto con le altre fronti ampiamente vetrate verso via Santa Eufemia in cui il sovrapporsi delle terrazze in arretramento e in lieve torsione planimetrica si risolve in un elemento ad andamento elicoidale appena avvertibile, che si potrebbe definire di dinamicità virtuale.”(tratto da 50 immagini di architetture Luigi Moretti) Documentazione conservata in archivio* Copie degli elaborati di progetto datate 1949: piante degli edifici sede della Palmolive, della Clorodond e della Orestein Kopper. * N. 24 disegni autografi: studi per l'impostazione generale e dei moduli abitativi. * n. 42 elaborati di progetto: studio dell'insolazione dei fabbricati, planimetria e assonometria del complesso, piante e sezioni dei fabbricati "20-32-50", dettagli degli elementi prefabbricati per la facciata del fabbricato "32". * Fotografie del modello e del fabbricato realizzato.BibliografiaMoretti Luigi, Ricerche di architettura. Sulla flessibilità di funzione di un complesso immobiliare urbano (firmato S.), in «Spazio», 1951-1952, 6, pp. 43-44Palazzo volante librasi in Corso Italia. Argomento di discussione per i milanesi, in «Corriere lombardo», 2-3 dic. 1955Audacie dell'edilizia moderna, in «Il Quotidiano sardo», 18 gen. 1956; «La Provincia», 7 gen. 1956; «L'Adige», 20 gen. 1956; «Il Tirreno del lunedì», 2 gen. 1956; «La Sicilia», 20 gen. 1956Missaglia Aldo, Milano duemila: tra grattacieli la casa volante, in «Momento sera», 29 feb. 1956Neri Gaetano, Il palazzo volante preoccupa i meneghini, in «Il Giornale», 4 mar. 1956Santini Pier Carlo, Profili di architetti: Luigi Moretti, in: «Comunità», 1957, 52, pp. 66-71Aloi Roberto, Nuove architetture a Milano, Milano, Hoepli, 1959, pp. 215-22150 immagini di architetture di Luigi Moretti, introduzione di Giuseppe Ungaretti; con un disegno di Giuseppe Capogrossi, Roma, De Luca, 1968Canella Guido, Figura e funzione nell’architettura italiana dal dopoguerra agli anni ’70, in «Hinterland», 1980, 13-14, p. 63Luigi Moretti, a cura di Salvatore Santuccio, Bologna, Zanichelli, 1986 (Serie di architettura, 21), pp. 85-88Intervista ad Adolfo Fossataro, in «Parametro», 1987, 154, pp. 28-29Irace Fulvio, Itinerari: Moretti a Milano, in «Abitare», 1991, 297, pp. 140-153Una astratta cornice barocca. Luigi Moretti in Corso Italia a Milano, a cura di R. Vio, in «D’A. D’Architettura», 1991, 5, pp. 74-80Irace Fulvio, Moretti a Milano, in: Milano moderna: architettura e città nell’epoca della ricostruzione, Milano, Motta, 1996, pp. 10-49Luigi Moretti: opere e scritti, [a cura di] Federico Bucci, Marco Mulazzani, Milano, Electa, 2000 (Documenti di architettura)Archivio centrale dello Stato, Luigi Moretti: la Casa delle Armi, le sue opere e il suo archivio, esposizione e catalogo a cura di Massimo Domenicucci...[et al.], Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2005 (Quaderni dell’ACS)Finelli Luciana, Luigi Moretti la promessa e il debito: architetture 1926-1973, con un saggio su La casa della Gioventù in Trastevere di Luigi Corvaja e Antonino Gurgone, Roma, Officina, 20052, pp. 60-63Archivio centrale dello Stato, Luigi Moretti: la Gil di Trastevere: la casa della Gioventù italiana del Littorio, le sue opere e il suo archivio, esposizione e quaderno a cura di Massimo Domenicucci...[et al.], Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2007 (Quaderni dell’ACS, 9)
In Complexity and contraddiction in Architecture del 1966 Robert Venturi pubblica il timpano spezzato nella palazzina "il girasole" a Roma (1947-50) come un precedente pop della sua architettura ironica e “camp” (Jencks 1973) che apre la strada al “postmodern”. Questa opera romana però (insieme alla contemporanea cooperativa di abitazioni “Astrea”) è ben più profonda e complessa delle villette di Venturi; nella palazzina la frattura percorre tutta la facciata enfatizzando l'atrio d'ingresso con un taglio profondo fino al cuore dell’edificio, le scale e il cavedio. Lo zoccolo di pietra a spacco di cava, composto secondo un disegno derivato dall’astrattismo geometrico, rivela da una parte l’accostamento alle avanguardie non-figurative, dall’altra la rimeditazione di talune proposte borrominiane. Le due semifacciate sembrano ante scorrevoli che si aprono a scoprire il cuore dell’interno della palazzina romana attraverso il suo atrio e impluvio. Le innovazioni linguistiche dei prospetti non son quindi gratuite e superficiali ma nascono da una profonda revisione di un tipo edilizio che da Roma antica arriva alla contemporanea. “La fenditura centrale -Moretti ha scritto- seziona al vivo l’intiero edificio e, con una prospettiva tagliente ed istantanea, rivela e penetra integralmente la profondità degli spazi che entrano nella composizione. Il grande atrio aperto sotto la fenditura e la casa determina e sottolinea gli spazi in latitudine e dichiara il peso, la densità, gli sforzi e la figura dell’intera macchina costruttiva. Questi due temi della fenditura e dell’atrio esprimono anche in termini di chiaroscuro il loro penetrare gli spazi, con ombre intense e misteriose…Il basamento a rustico in contrappunto al rivestimento in mosaico di vetro, bianco e luminoso, dei piani superiori a sbalzo. La partizione palladiana in basamento e colonnato sembra qui trasposta in superfici grezze e in superfici splendenti di mosaico…le strutture in calcestruzzo armato sono lasciate in vista all’interno ed all’esterno come forma all’esterno anche come materia…Un’altra modalità fondamentale di composizione si rivela ancora nell’edificio: strutture o materiali diversi non sono mai sposati; sono sempre invece ben staccati in modo da evitare angoli incerti di forma e di materia, che turbano il nitore formale dei particolari. Legno, mosaico, pietra, stucco, ecc. hanno sempre confini propri e precisi e rigirano su se stessi i loro profili terminali. L’interno della casa è tutto in stucco romano, la qual cosa dona agli spazi interni un valore tattile e una possibilità non comune di forma. Si notino ad esempio gli spigoli dei pilastri tutti trattati secondo certi profili varianti, uno a uno secondo la provenienza della luce.„C. JENCKS, Modern Movements in Architecture, Anchor Press, NY 1973
Un’importante riflessione sull’architettura classica è contenuta in Struttura come forma in <<Spazio>> n.6, 1951-52. Moretti contesta il fenomeno per cui nell’architettura contemporanea si considerano separabili i valori plastici da quelli funzionali, da quelli costruttivi. Rifiuta l’atto disemplificazione nei confronti del pensiero di Vitruvio operata dai trattatisti dal ‘500 in poi. Letre categorie firmitas, venustas, utilitas possono soltanto delimitare, descrivere un soggettoma non definirne l’essenza. Questo perché, dice Moretti, l’architettura è un complesso direlazioni, non una sommatoria di problemi, Un’opera di architettura è dunque in ogni suopunto realtà e rappresentazione [ Ogni punto è un fatto di ordine tecnico e funzionale, chesottostà alle imposizioni parametriche della realtà e della tecnica, e un fatto espressivo .
Il girasole 1947-50
La polemica che Moretti accende contro i razionalisti negli anni trenta trova un’eco in “Valoridella modanatura”, “Spazio” n.6, 1951-52. L’arte moderna ha messo al bando ogni forma di cornice e modanatura, un tale rifiuto in architettura, dice Moretti, è da addebitarsi all’antinomiacreata fra razionalismo e decorazione, ma anche allo svalutarsi di quegli elementi ad opera del vuoto utilizzo di forme nello stile floreale o liberty.Moretti individua il valore della modanatura ravvisandone il senso tettonico, di transito, di passaggio, come scansione del tempo. La modanatura è il segno della stratigrafia degli edifici.Esaltazione della “Struttura reale”, cioè commento della natura costruttiva dell’opera, per poi diventare materiale espressivo.Un’importante riflessione sull’architettura classica è contenuta in “Struttura come forma” in“Spazio” n.6, 1951-52. Moretti contesta il fenomeno per cui nell’architettura contemporanea si considerino separabili i valori plastici da quelli funzionali, da quelli costruttivi. Rifiuta l’atto di semplificazione nei confronti del pensiero di Vitruvio operata dai trattatisti dal ‘500 in poi. Letre categorie firmitas, venustas, utilitas possono soltanto delimitare, descrivere un soggetto ma non definirne l’essenza. Questo perché, dice Moretti, l’architettura è un complesso di relazioni, non una sommatoria di problemi, “Un’opera di architettura è dunque in ogni suo punto realtà e rappresentazione “. Ogni punto è un fatto di ordine tecnico e funzionale, chesottostò alle imposizioni parametriche della realtò e della tecnica, e un fatto espressivo .In “Strutture e sequenze di spazi”, “Spazio” n.7 del 1952-53, il tema principale dellearchitettura di Moretti viene esplicitato in forma teorica. Lo spazio interno, il vuoto viene visto come elemento fondamentale del progetto. Lo spazio interno è considerato vera e propriamateria da progettare. Ne individua qualitò specifiche: lo spazio ha una geometria (forma),dimensione (volume), densità (valore della luce), pressione (rapporto psicologico col fruitore,principio del flusso dei fluidi). Questioni che vengono argomentate analizzando casi di studio del passato, perché “! grandi spazi dell’architettura nascono con Roma”, dove gli spazi interni rappresentano un forte tema progettuale come Villa Adriana, il Palazzo Ducale di Urbino, laRotonda di Palladio. Il tema della concatenazione degli spazi, inoltre, una delle chiavi di lettura dell’edificio della Scherma al Foro Italico e dell’edificio della GIL a Roma.Un altro tema centrale della poetica di Moretti è il valore del tempo e la componente narrativadel progetto. In “Strutture ideali dell’architettura di Michelangelo e dei barocchi” la questionedel linguaggio come stratificazione del tempo ed espressione specifica di una cultura analizzata sull’esempio di Michelangelo. Nel Vestibolo della Biblioteca Laurenziana Michelangelo compie una rilettura della semantica della colonna in strutture prestigiose dell’antichità chesubiscono l’aggressione del tempo e le trasformazioni per gli usi contingenti degli uomini. Lacolonna inalveolata diventa una rappresentazione, “Un racconto epico in cui si inseriscono tutti i fatti minuti della vita”. Una dimensione angosciosa del tempo assunta come elemento poetico.
Giuseppe Capogrossi - Incisione per "L'alfabeto di Capogrossi" di Gillo
Dorfles12 giugno 1962
Lucio Fontana concetto spaziale 1960
Si considerino, allora, le superfici della Saracena. Verso il patio esterno, il muro laterale del corpo alto è una sorta di lama il cui distacco dal volume lascia intravedere, arretrate, le strutture dei solai. La parete dietro la quale si sviluppa la scala - a soletta continua in cemento armato - si incurva, assottigliandosi nella parte terminale e si richiude sul pianerottolo di arrivo, creando una seconda più profonda fenditura sulla superficie esterna. Le tre asole di luce, aperte nella parete curva che cela la scala, mostrano il sottile spessore del muro, che appare letteralmente ritagliato al livello del seminterrato. Sulla superficie adiacente, una nuova sottile incisione verticale fornisce una lama di luce ai bagni ma il suo tracciato slitta lateralmente in corrispondenza del piano rialzato. L'ultima consistente frattura della superficie - occasione per ricavare una sorta di protetto terrazzino per le camere - corrisponde ad uno scarto nella giacitura del muro perimetrale. Sul fronte a mare, infine, la superficie delle pareti si dissolve negli infissi, lasciando come una sorta di griglia, costituita dalle testate dei muri perimetrali e da quello di mezzeria e dalle solette dei terrazzi e della copertura, a scompartire lo spazio. Nei lunghi fronti della galleria e del soggiorno rivolti verso il giardino interno, Moretti opera una analoga volontà di astrazione. I 'volumi negativi' della galleria e della grande sala sono individuati dalla diversa quota degli sbalzi di copertura - una differenziazione esplicitata [….] anche relativamente all'atrio; al contempo, l'introduzione di un intervallo tra solai e pareti - con interposizione di listelli vetro cementati direttamente nell'intonaco - rivela l'indipendenza tra gli spazi e le relative superfici. Su queste si dispongono, quasi fossero lastre a se stanti, le parti piene; ognuna perfettamente definita ai bordi e staccata da quella adiacente. Lo si può notare sia nei muretti di basamento della galleria e di quella parte del soggiorno cui corrisponde, in proiezione, la sala scavata, sia nelle lunghe fasce che fungono da brise-soleil le quali, appese alle coperture con sottili tondini di ferro, danno l'impressione di fluttuare a mezz'aria. Le superfici della Saracena sono come una tela; possono essere squarciate e sollevate, oppure su di esse possono solidificarsi segni astratti: sono 'superfici trasfigurate'. Il loro rapporto 'con la stereometria e l'impianto architettonico dell'edificio' varia da una parziale proiezione alla totale indipendenza. A questa escursione corrisponde, per Moretti, il grado di autonomia delle leggi formali che organizzano le superfici, sino al limite di una espressione puramente plastica o pittorica.La casa è divisa in due spazi: sulla costa sono affacciate le sale di soggiorno e per il pranzo, le stanze per il riposo invece sono poste più indietro, lontane dal mare. Le due parti sono unite da una galleria amplissima, digradante dalla zona notte a quella giorno, aperta, nella sua lunghezza, da un lato sul grande giardino, dall'altro, a mezzo del suo percorso, su un piccolo ed intimo giardino chiuso. Le stanze dei bambini e degli ospiti fiancheggiano la galleria. Il corpo a torre racchiude tutte le altre camere. Il basamento a mare, su cui poggia la terrazza antistante la sala di soggiorno, racchiude la grotta al livello del mare, chiusa dal cancello di Claire Falkenstein.La struttura portante è un telaio di cemento armato. Le pareti esterne sono trattate con intonaco grezzo."Con una materia atomizzata - i cretoni di pozzolana mescolati all'intonaco - e purtuttavia restituita come materia omogenea, modellabile plasticamente e che - come afferma Moretti a proposito della 'terza struttura generalizzata' borrominiana - si addensa là ove appoggeranno i maggiori carichi assottigliandosi dove i minori carichi lo richiedono - e si osservi, nella casa al mare, l'evidente rastremazione verso l'alto del muro di spina."
Claire Falkenstein cancello della cavana
della Saracena a Santa Marinella e ingresso
Fondazione Guggenheim Venezia
Già nel 1955 al comune di S. Marinella insieme al progetto per la villa “Saracena” è presentato quello dell’adiacente villa "Califfa", per gli stessi committenti, ma la costruzione avviene fra il 1964-67. Anche questa volta l’edificio si caratterizza nella sua apertura verso il mare, nella gelosa chiusura verso il mondo esterno, nel rivestimento di intonaco rugoso, nei tagli delle “fessure, quasi respiranti come branchie di un animale marino” (Finelli Luciana, Luigi Moretti la promessa e il debito: architetture 1926-1973 [...], pp. 72-75). La villa è la prima da sinistra del trittico incompiuto di ville di Moretti, a cui appartengono la Saracena e la Moresca, collocate in un lotto tra la via Aurelia antica e il mare. Il bellissimo intonaco a rinzazzo di grana grossa e in quell'arroncignato parapetto in ferro del balcone a mare, il quale, piuttosto che a un sentimento barocco, parrebbe da riferirsi al senso di una fiaba salgariana o magari di un'armatura da torneo medioevale. Certo questa casa si rifà al tono della sua maggiore vicina, quella villa Pignatelli d'Aragona che noi consideriamo un capolavoro di Moretti, ma pure a quell'ineseguito progetto di case a Nervi, nel quale, come in questo caso, la disposizione della pianta a risega consente l'apertura a mare di tutti i locali. Spalancata a bere l'aura marina verso mezzogiorno, la casa è invece chiusa, come una torre di guardia, verso terra. (Pica 1970). Perfino le rare aperture che si sono dovute praticare anche da questo lato sono poi come occluse da una sorta di paravento murario che ha l'aspetto, per la verità alquanto conturbante, di fasciame di barca in demolizione.Moretti ha scritto:“La Kaliffa come la Saracena è completamente introversa verso la gente di strada (per altro Le pare proprio che meriti, democrazia e amor cristiano a parte?) ed è tutta estroversa, tutto amore verso il mare…” (lettera di Luigi Moretti a Iride Cerabona, redattrice di «Life», 28 marzo 1969). “ Il prossimo” dobbiamo amarlo. E’ una voce cresciuta con noi dalla infanzia incantata.Per amarlo è necessario conoscerlo, vederlo in uno spazio che ne consenta di definirne la figura; figura misteriosa specchio di noi stessi verso la quale sia naturale come il respiro di aprire le braccia, dividere il proprio pane e la propria parola.Ma questo “prossimo” dove è ora?Questo amore, nato con noi per lui, si è spento; rimane eco verbale di un pensiero staccato dal nostro vivo meccanismo umano, residuo labilissimo di una incisione abrasa sempre più violentemente che si tenta di riamplificare da pulpiti vuoti e da bigonce ridicole in piazze semideserte. Oggi sappiamo soltanto che c’è la “gente”. La gente che ci preme, che respira rumori, che non ci conosce, che non ci ama, che non ha un volto.C’è la “gente”, tanta “gente” che non ci è possibile amare.Allora che posso fare? Questo palpito radicato, segreto, per il prossimo rifiuta la gente.Cerco senza alcun dispregio, forse con umiltà addolorata di chiudermi in essa e lasciare soltanto uno stretto varco, speranza, che da esso filtri un “prossimo” da accogliere.E mi taglio, non per orgoglio, ma per bisogno di vivere, un pezzo di cielo mio e uno spazio di mare anche senza Nessuno.”„
Pica Agnoldomenico, Due opere di Luigi Moretti: una casa sul Tirreno e un santuario sul lago di Tiberiade, in «Domus», 1970, 482, p. 6 Moretti Luigi, La villa “La Califfa” a Santa Marinella, in in «Domus», 1970, 482, p. 7Roisecco Giulio, La Califfa a Santa Marinella, in «Moebius», 1970, 1, pp. 54-61Pica Agnoldomenico, Luigi Moretti: un architetto al di là del cantiere, in «Civiltà delle macchine», 1973, 3-4, pp. 59-66Luigi Moretti, a cura di Salvatore Santuccio, Bologna, Zanichelli, 1986 (Serie di architettura, 21), pp. 166-169Luigi Moretti: opere e scritti, [a cura di] Federico Bucci, Marco Mulazzani, Milano, Electa, 2000 (Documenti di architettura)Carrano Eleonora, Moretti: le opere romane, Roma, Prospettive, 2005 (Architetti a Roma), pp. 124-127Archivio centrale dello Stato, Luigi Moretti: la Casa delle Armi, le sue opere e il suo archivio, esposizione e catalogo a cura di Massimo Domenicucci...[et al.], Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2005 (Quaderni dell’ACS)Finelli Luciana, Luigi Moretti la promessa e il debito: architetture 1926-1973, con un saggio su La casa della Gioventù in Trastevere di Luigi Corvaja e Antonino Gurgone, Roma, Officina, 20052 , pp. 72-75 Greco Antonella , Remiddi Gaia, Luigi Moretti: guida alle opere romane, Roma, Palombi, 2006, p. F 64 (Il moderno attraverso Roma, 5)
La villa "Moresca", 1967-81, è l'ultima da sinistra del trittico compiuto a dieci anni della morte dell’architetto di ville di Moretti, a cui appartengono la Califfa e la Saracena, collocate in un lotto tra la via Aurelia antica e il mare.Come le due costruzioni vicine anche la Moresca si presenta chiusa verso la strada e aperta invece verso il mare. Anche il trattamento delle facciate riprende quello studiato per la Saracena, a cui si raffronta. La soluzione planimetrica e volumetrica richiama immediatamente l'andamento a ventaglio della Califfa, qui raddoppiato e reso più complesso dall'incastro di tre volumi degradanti verso il mare.Anche nella distribuzione degli spazi interni è visibile un chiaro riferimento ai progetti delle ville vicine. Infatti la curva descritta dal piano aggettante sospeso sull'ingresso della Saracena viene assunta, nel progetto originario, quale elemento generatore di un complesso sistema di tracciati che regolano l'andamento planimetrico del nuovo edificio, determinando addirittura la giacitura dei muri divisori interni.Struttura intelaiata in cemento armato. Le pareti esterne sono trattate con intonaco grezzo.