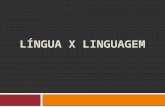Nel segno di Michelangelo. La scultura di Giovan Angelo Montorsoli a Messina
Aspetti della lingua comica di Giovan Battista Andreini, in «La lingua italiana», VII, 2011, pp....
Transcript of Aspetti della lingua comica di Giovan Battista Andreini, in «La lingua italiana», VII, 2011, pp....
r i v i s ta a n n ua l e d i r e t ta da m a r i a lu i s a a lt i e r i b i a g i
m au r i z i o da r da n op i e t r o t r i f o n e
g i a n lu c a f r e n g u e l l i
c o m i tat o d i r e da z i o n ee l i s a d e r o b e r t og i a n lu c a c o l e l l a
e m i l i a n o p i c c h i o r r i
c o m i tat o s c i e n t i f i c oz y g m u n t b a r an s k ig e r a l d b e r n h a r dg i o va n n a f r o s i n i
g a s t o n g r o s sc h r i s t o p h e r k l e i n h e n z
a da m l e d g e waya l d o m e n i c h e t t i
f r a n z r a i n e rl o r e n z o t o m a s i n
*
«La lingua italiana. Storia, struttura, testi» is an International Peer Reviewed Journal.
The eContent is Archived with Clockss and Portico.
LA LINGUAITALIANA
storia , strutture, test i
rivista internazionale
!" " · 20
p i sa · romafabriz io serra editore
mmxi
Amministrazione e abbonamentiF#$%"&"' S(%%# ()"*'%(
Casella postale n. , succursale n. +, I ,- ./ Pisa,tel. +/0 1,1,2.//., fax +/0 1,1,32+++
I prezzi u4ciali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.
Print and/or Online o!cial subscription prices are available at Publisher’s web-site www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere e5ettuati tramite versamento su c.c.p. n. 3 ,2,,1o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)
U!ci di Pisa: Via Santa Bibbiana .+, I ,- .3 Pisa,tel. +/01,1,2.//., telefax +/01,1,32+++, [email protected]
U!ci di Roma: Via Carlo Emanuele I 2+, I 11 +, Roma,tel. +/01-3120/2,-, telefax +/01-3123--1,, [email protected]
*
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. + del , giugno .11,Direttore responsabile: Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo e5ettuati, compresi la copia fotostatica, il micro6lm, la memorizzazione
elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright .177 by Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma
*
www.libraweb.net
Stampato in Italia · Printed in Italy
"889 3.2-0132"889 (:(**%'9";' +.--+1+1
SOMMARIO
W':<=#9= S;>?(";@#%), La strati"cazione cronologica dei turchismi in italiano AF%#9;"8;' NBC(& R'DE9, Locuzioni preposizionali nella prosa italiana delle origini FGG"H:"# D( D'D"9";"8, Poi che nella Commedia di Dante : tra tempo, causa e rilievo
informativo IGF%#9;(8;# G#**#, Prefazioni a traduzioni scienti"che e ‘questione della lingua’ nel
Cinquecento JFLH;# D’O9=>"#, Aspetti della lingua comica di Giovan Battista Andreini KGG"H8(LL( P':"D(9", Il troppo e il vano della lingua : l’ideale della proprietà espressiva
dal dibattito linguistico alla scuola italiana dopo l’Unità MFS":!"' C%H8;>"9#, Tra dire e pensare : casi di grammaticalizzazione in italiano e in
siciliano FNKU%8H:# R(H*9(%, Varietà regionali e doppia#io cinematogra"co : la strategia di Giù
al Nord FIGS":!"# C#L'*'8*', « Sono il noto che può condurre all’ignoto desiderato » : il dialetto
negli Scritti linguistici di Manzoni FJKE:"8# D( R'$(%*', Scuola o scola ? Monolinguismo, polimor"a e variazione nei sil-
labari postunitari FKAA9)%(# V"!"#9", “Alto sentire” : le parole del valore FGO
'88(%!#*'%"' :"9=H"8*";'
E%:"9= S*%H)8>':D, Gli studi di linguistica italiana in Danimarca o#i FMA
%(;(98"'9"
S#9)%# C'!"9', Giacomo e Monaldo Leopardi falsari trecenteschi. Contra$azione dell’antico, cultura e storia linguistica nell’Ottocento italiano (Laura Ricci) INF
M#88"D' P#:(%D', D#9":' P'=="'=#::", Grammatiche di italiano per stranieri dal ’%&& a o#i. Pro"lo storico e antologia (Francesco Feola) INP
A%9#:)' S':)#9", La sintassi del sonetto. Petrarca e il Trecento minore (Carlo En-rico Roggia) INA
U%8H:# R(H*9(%, Sprache und Tabu. Interpretationen zu französischen und italieni-schen Euphemismen (Lucia Bolzoni) IFO
G#8L#%%' FH8;':"::', Croniche, edizione critica e studio linguistico a cura di Nadia Ciampaglia (Francesco Bianco) IFP
Demetrio Skubic octogenario, a cura di Martina OQbot, « Linguistica », R:!""" ("), R:"R (""), : (""") (Elisa De Roberto) IFM
Abstracts IIO
ASPETTI DELLA LINGUA COMICA DI GIOVAN BATTISTA ANDREINI*
L!"# D’O$%&'#
( .
G )' studi su Giovan Battista Andreini – nel quale si riconosce attualmente il più grande uomo di teatro del Seicento italiano – sono a*itti da una distorsiva asim-
metria : a fronte dei numerosi lavori dedicati ai più diversi aspetti storici e letterari della sua opera spicca infatti la scarsità di edizioni a+dabili e l’assenza di analisi linguistiche che ne sono di solito il naturale avvio o complemento.( Né si può dire che quella di Andreini sia da questo punto di vista una sorte isolata : il lettore con interessi storico-linguistici che frequenti edizioni di testi comici seicenteschi ha anzi l’impressione di trovarsi spesso, per dir così, in partibus in!delium, in un territorio nel quale vige una singolare sospensione del galateo ,lologico e i problemi relativi alla ,ssazione dei testi e alla loro puntuale illustrazione sono dunque in più d’un caso sbrigativamente liquidati. Eppure Andreini manipola consapevolmente i codici linguistici ed espressivi ricevuti in
* Citerò i testi di Andreini dalle stampe seicentine, seguendo i criteri editoriali enunciati in D’Onghia (-../, pp. -0---01) e impiegando le seguenti sigle : AS = Amor nello specchio, Parigi, Nicolas della Vigna, (/-- (London, British Library, G (.123.-) ; Ca = La Campanaccia, Venezia, Salvadori, (/-1 (Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 13 0 G -3.1 ; princeps : (/-() ; DB = Li duo baci, Bologna, Monti e Zenero, (/10 (Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 13 0-G -3.-) ; DC = Le due comedie in comedia, Venezia, Imberti, (/-1 (London, British Library, (.4( l 0.2) ; DL = Li duo Leli simili, Parigi, Nicolas della Vigna, (/-- (London, British Library (/- a (() ; Fe = La Ferinda, Parigi, Nicolas della Vigna, (/-- (London, British Library, G (.123.1) ; LB = Lelio bandito, Venezia, Combi, (/-0 (London, British Library, (.4( l -..( ; princeps : (/--) ; Ro = La Rosa, Pavia, Magri, (/12 (Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 13 0-G -3.() ; Sc = Lo Schiavetto, Venezia, Ciotti, (/-. (London, British Library, ((4(3 aa (() ; Su = La Sultana, Parigi, Nicolas della Vigna, (/-- (Venezia, Bibliote-ca Nazionale Marciana, Dramm. -.5.() ; Tu = La Turca, Casale, Go+, (/(( (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Dramm. -21.-) ; Tu-. = La Turca, Venezia, Guerigli, (/-. (London, British Library, (.4( k (..-) ; Ve = La Venetiana. Comedia de sier Cocalin dei Cocalini da Torzelo Academico Vizilante dito el Dormioto, Venezia, Raimondi, (/(5 (London, British Library, ((4(3 a (5).
Ringrazio di cuore per i loro preziosi suggerimenti Alfredo Stussi, Lorenzo Tomasin, Pietro Trifone e Piermario Vescovo.
( Sull’importanza di Andreini cfr. tra l’altro Ferrone ((52/ '', p. (() e da ultimo Snyder (-..5, p. 1). Quanto alle edizioni, se ne dispone, in ordine cronologico, per : Lo Schiavetto (Falavolti, (52-, pp. 34--(1, che si basa sulla princeps del (/(-), Le due comedie in comedia (Ferrone, (52/ '', pp. 5-(.3), Amor nello specchio (Maira / Borracci, (554 ; Snyder, -..5), Il nuovo risarcito Convitato di Pietra (Carandini / Mariti, -..1), La Centaura (Da-vico Bonino / Vazzoler, -..0), La Maddalena lasciva e penitente (Palmieri, -../), l’Adamo (Ru+no, -..4) e La Ferinda (Palmieri, -..2) ; aggiungo che una nuova edizione della Centaura a cura di Alessia Rossi è in corso di stampa presso la casa editrice ArchetipoLibri di Bologna. Il livello dei lavori citati è assai diseguale : si va dalla buona qualità di Carandini / Mariti (-..1) a quella modesta di Palmieri (-..2), su cui vedi D’Onghia (-.((). Quanto agli studi linguistici, oltre ai preziosi lavori di Altieri Biagi ((5/5/(52.) e Spezzani ((54./(554), osservazioni speci,camente dedicate ad Andreini si trovano in Marazzini ((551, pp. 4--43 e -52-1.0), Rebau-dengo ((550, pp. (.0-((3), Stussi ((555, pp. 2.-2(), Trifone ((550/-..., pp. 3.-35) ; sulla lingua della commedia ‘ridicolosa’ di ambiente romano vedi ora Giovanardi (-.(.). Per quel che è invece della bibliogra,a critica, rinvio all’utile regesto in Palmieri (-..2, pp. -3-1-), avvertendo che in essa spiccano tre lavori d’insieme (Fer-rone, (551 ; Rebaudengo, (550 ; Fiaschini, -..4) e alcune notevoli letture di singole opere (come Besutti, -..3 sulla Ferinda e Vescovo, -..0 su Amor nello specchio).
)!"# 6’7$%&'#32eredità dal proprio mestiere di attore, e la sua comicità, pensata per il testo scritto, è frutto di una cultura letteraria per nulla dilettantesca.(
Allo sviluppo della personalità di Andreini contribuì in buona misura la sua condizio-ne di ,glio d’arte : la madre Isabella, letterata e virtuosa di canto e recitazione, fu tra le prime dive nella storia del teatro italiano, e il padre Francesco diede corpo e voce con successo straordinario al personaggio del Capitan Spavento :- per via dei genitori An-dreini si colloca dunque al displuvio di due tradizioni teatrali vivaci e prestigiose, quella tosco-,orentina (Francesco era pistoiese) e quella veneta (Isabella era nata a Padova da una famiglia veneziana) ; ma ha ancor più interesse notare che l’origine della madre ebbe qualche conseguenza sulla sua stessa competenza linguistica : lo dimostrano le settantasette lettere autografe, nelle quali si trovano alcuni fenomeni che sembrano da imputare a una componente nativa veneta, forse rinsaldata dalla frequentazione assidua della corte mantovana e di città come Milano e Venezia.1 Nelle osservazioni che seguo-no cito tra parentesi il numero della lettera e l’anno :Saltano all’occhio le incertezze sulla gra,a delle consonanti di grado intenso, con una tendenza all’ipercorrezione che si nota in dubbitando (10.(/(2) e dubbitare (/-.(/11), subbito (15.(/-., 01.(/-(, 04.(/-1, 3/.(/-5) e subbita (3(.(/-/), rubbando (01.(/-(), gabbinetto (01.(/-(), taccito (01. (/-(, 03.(/-(), addoprare (-(.(/(-) e addopra (10.(/(2), ciaschedduno (11.(/(2), ra"ioni ((.(/./), a"itato (4.(/.5), cellebre (0/.(/-(), pallesa (43.(/3.), doppo (/.(/.5, 2.(/.5, 05.(/-3, 4..(/0.), stuppì (-3.(/(1), essito (05.(/-3), essilio (31.(/-2), segretto (11.(/(2), avvido (01.(/-(), guarnizzione (-0.(/(-), disperazzione (-4.(/(/), protezzione (30.(/-2), a#izzioni (35.(/1(, /-.(/11) ; per contro sono da registrare di!cil (1-.(/(2), cavalo (11.(/(2), solecitato (/..(/1-, ma a poca distanza sollecito), insoportabili (3-.(/-4) e insoportabil (35.(/1(), otterà (11.(/(2), tratenga (32.(/1(), posesione (-5.(/(/). Dal punto di vista gra,co va registrato anche l’isolato boracchie ‘borracce’ (01.(/-(), interessante perché sembra attestare l’uso settentrionale del trigramma chi per esprimere l’a8ricata palatale sorda (Ghinas-si, (54/, pp. 5/-(..). Reattivo all’assenza settentrionale di anafonesi sembra Martiningo, forma ipertoscana del cognome bresciano Martinengo (1/.(/(5). Notevole per il rispetto fonetico è la forma si ‘ci’ ri9essiva documentata più d’una volta (Marazzini, (551, p. 1.- nota (/ registra forme analoghe nello Schiavetto, ed è incline a ritenerle compatibili con uno scrivente d’origine toscana, anche se gli ess. radunati in Rohlfs (5/5, II § 0/., cui egli stesso rinvia, sembrano indicare che si tratta di un fatto settentrionale con propaggini nella Toscana nordoccidentale) : « Florinda [...] et io le s’inchiniamo » (3.(/.5), « si siamo consumati » (4.(/.5), « Florinda e io se ne prevaleremo » (5.(/.5), « desiderava che [...] si trasferissimo a Roma » (-1.(/(-), « se le inchiniamo » (0-.(/-(). Va-rie le incertezze relative al timbro delle vocali protoniche e soprattutto alla mancata chiusura di e in protonia, anche in fonetica di frase : Verginia ((..(/.5), Felippo ((4.(/((), re!utato (-5.(/(/), resoluzione (10.(/(2, 12.(/-.), legna"io (1(.(/(2), de ‘di’ (15.(/-. : « 3. ducatoni de debito »), ricor-dandoleme (3..(/-/, dov’è notevole anche la sequenza dei clitici) ; si registrino qui anche i dubbi di Andreini sulla forma vallombrosano : si hanno vallumbrosano ((0.(/(.), vallombrosano ((3.(/(., corretto su vallimbrosano), vallembrosano (-1.(/(-, di nuovo corretto su vallimbrosano). In postonia si nota solo un isolato giovene ((.(/./), contro il pluriattestato giovine (per es. a 4.(/.5, 1(.(/(2 bis, 04.(/-1, etc.). Riconducibili alla scripta settentrionale sono pure le varie forme con prostesi di a- : agradirà (-(.(/(-) e a"radirle (40.(/3.), arricordi (33.(/-2, /-.(/11), appresentare (34.(/1() e appresentai (40.(/3.). Degni d’essere registrati sono anche i pochi condizionali in –ia (che godevano tuttavia di prestigio letterario, almeno in poesia) : dopo haveria (1.(/.4, 4.(/.5 bis) e saria (/.(/.5) si trova molto più tardi solo vedria (/3.(/11, ''' pers. sing.) ; e qui andrà segnalato il tipo anche settentrio-
( Vedi su questo soprattutto Fiaschini (-..4) ; già Zorzi ((5/3/(55., p. (/2) aveva notato, esaminando la Venetiana, « che il teatro dell’Arte è spesso tutt’altro che un prodotto “artigianale” (come vorrebbe il suo nome) ; al contrario, nei suoi esempi prototipici, esso si rivela opera di intellettuali avvertiti e partecipi della cultura letteraria e artistica del tempo ».
- Su Isabella e Francesco cfr. rispettivamente De’ Angelis ((55() e Tessari ((524).1 Cito le lettere autografe di Andreini dall’edizione di Ferrone ((551b).
#:;<==' 6<))# )'$%!# "7>'"# 6' %'7?#$ @#==':=# #$6A<'$' 35nale e veneto saressimo ‘saremmo’ (15.(/-.). Quanto a lessico e fraseologia, spicca quello che si direbbe un calco sul dialetto in « Frittellino è dietro ad impiantar la compagnia » ‘Frittellino sta organizzando la compagnia’ (((.(/.5 ; per il costrutto, vivo in area veneta, cfr. ad es. Boerio (23/, p. -02). Altri elementi meritevoli d’una menzione sembrano poi sparmiando ‘risparmiando’ ((4.(/((), che potrebbe risentire del tipo sparagnare (per il Veneto cfr. ad es. Cortelazzo, -..4, p. (-2/ e Boerio, (23/, p. /2-) e capigliara ‘parrucca’ (00.(/-( ; cfr. )<' B.(/45.1. e sgg., con ess. quasi esclusivamente settentrionali ; il più antico, dal canzoniere di Gasparo Visconti, documenta ap-punto capigliere ‘parrucche’, mentre il signi,cato sincronico è esclusivamente quello di ‘massa di capelli, chioma abbondante o disordinata’).
Osservazioni ugualmente sicure non sono possibili per la lingua delle principes delle commedie, dato che mancano prove di una diretta sorveglianza di Andreini sul lavoro delle tipogra,e (e non si sa se qui fossero arrivati autogra, o copioni di altra prove-nienza). Non si possono dunque addebitare a cuor leggero all’autore i tratti gra,ci e fonomorfologici delle edizioni antiche, ma va notato che in esse ricorrono forme e fenomeni appena schedati nelle lettere autografe : nella princeps parigina di Amor nello specchio ((/--) si trovano per esempio si fregheremo ‘ci fregheremo’ (.. e conservarsi ‘con-servarci’ -.-, arricordatevi (.0, (1., (10, saressimo (00, subbito (30, (5- ; e per limitarsi a un fatto isolato ma vistoso, già la Turca ((/(() recava condizionali come iscorgeressimo 5., vedressimo 5., diverressimo (/3.( Anche il lessico rivela qua e là venature molto proba-bilmente venete : si notino per esempio – e sempre sulle labbra di personaggi italofoni – abbavato ‘adirato’ (Tu 22, DC 13), capigliara ‘parrucca’ (AS // : anche nelle lettere), discorrenza ‘diarrea’ (Sc (-(, Tu 01), frezzoloso ‘frettoloso’ (Tu /1), slizzegar ‘scivolare’ (Tu 34 ; sliccicano in DL (/), svaligio ‘rapina’ (AS 4-), nonché la perifrasi verbale « son dietro a far la campana d’un pezzo » attribuita alla ,orentinissima Succiola (Sc (/4) e anch’essa già notata nelle lettere.-
Tutt’altro discorso – che non c’è spazio per sviluppare qui – sarebbe da fare circa il rapporto tra il carteggio e le commedie quanto a certi fatti di intonazione espressiva : in una missiva del 3 agosto (/-. Andreini scrive per esempio che « quello ch’io dissi, [...] posto in lance, poi, non pesa tanto più che non pes[a] una picciolissima penna di passe-ra » (15.(/-.). L’arti,ciosa metafora e l’impiego di lance ‘bilancia’, di chiara ascendenza petrarchesca (A?C """)'B.0(-0- « et queste dolci tue fallaci ciance / librar con giusta lance »), derivano senz’altro dalla pratica della scrittura teatrale, tant’è vero che l’imma-gine ricorre insistentemente nei discorsi di vari ‘amorosi’ andreiniani : « Oh, come tutto con la lance del cuore lo bilancio » (Sc 21), « se non libro il tutto con giusta lance, lancie mille mi passino il petto » (Tu 35, dove si vede bene il punto d’avvio petrarchesco), « il padre alora posto in su la lance di povertà, di disonore e di sinistra fortuna, traboccando alla disperazione m’assalì » (DC 1(), « su la lance della vendetta si libra il tuo errore, e ti sentenza a morte » (Su (04), « la lance dell’intelletto » (DL 2).
Più tranquillamente attribuibili all’autore sono le scelte in materia di sintassi e di for-mazione delle parole. Quanto al primo punto è da notare che nonostante la sua qualità
( Accanto allo Schiavetto (per cui vedi oltre), anche la Turca sarebbe un ottimo banco di prova per la costituenda ,lologia andreiniana : nessuno infatti sembra essersi accorto che le edizioni del (/(( e del (/-. di8eriscono per centinaia di varianti, senz’altro addebitabili all’autore e notevoli dal punto di vista stilistico e linguistico (sulla commedia vedi intanto Zazo, (52/ e Perocco, -.(., pp. -21--20).
- Per abbavato, che è tipo lessicale veneto-meridionale, vedi )<' '?.((.2 e sgg. ; per capigliara vedi sopra ; per discorrenza vedi i dati in D’Onghia (-.(., pp. -1.--1() ; per frezzoloso cfr. frezza in Cortelazzo (-..4, p. 32/) e la nota a frezarse in D’Onghia (-.(., p. -14) ; per slizzegar vedi Cortelazzo (-..4, p. (-34) ; quanto a svaligio, nonostante l’assenza dai vocabolari dialettali, si noti che svalisàr è del veneziano rinascimentale (Cortelazzo -..4, p. (102), e che l’esempli,cazione raccolta in %6)' BB 35. (Sarpi, Badoer, Siri e Brusoni) depone a favore di una di8usione specialmente veneta della voce.
)!"# 6’7$%&'#/.spesso iperletteraria il teatro andreiniano accoglie con una certa larghezza i fenomeni deputati alla riproduzione del parlato.( Ecco una campionatura relativa a un paio di fatti notevoli come l’ordine marcato dei costituenti frasali e il cosiddetto che ‘polivalente’ :-
I. Piuttosto robusto il ricorso alla dislocazione a sinistra, di cui allego alcuni esempi (per il tratto cfr. essenzialmente D’Achille, (55., pp. 5(-(13 e Trifone, (553/-..., pp. (-(-(-3) : « La giustizia mi sovvien d’averla veduta dipinta » (AS 4-), « questa candela un servo suo la dovrà accesa tener in mano » (AS 5-), « vedi Florinda se del mio combattere ne riporto la ghirlanda » (AS 50), « quel che disse [...] pensatelo voi » (AS 5/), « la candela accesa la terrà il vostro servo » (AS 52), « la quale subbito [...] la toccherete con la verga » (AS 52), « Le malore le numerano quelli che hanno il mal francese » (AS (-2), « quanto sia discontenta ben nel foglio di questa fronte caratteri lagrimosi gli occhi te lo narrano » (DC 53), « Ch’io non torni a desinare ve l’accerto » (DL (), « questa lettera la conosci ? » (DL 0.), « Costei la veggo così risoluta » (DL 01), « Florinda, se non fosse ,gliuola di V.S., io l’odierei a morte » (DL 23), « Vorrei di lui farne alla presenza di V.S. sacri,cio infelice » (DL 54), « Di questa così fatta biancheria il gran Turco [...] me n’inviò in dono quatrocento bertoni » (Sc /-4), « Al cane che invecchia la volpe gli piscia addosso » (Sc 1/), « A chi è pieno di spavento ogni scoter di picciola fronda gli è tormento » (Tu ((4), « Delle bevande sue allopiate io non ne berrò più » (Tu (3-), etc. Notevole la mancanza di esempi per la dislocazione a destra : posto che qual-che caso sia sfuggito allo spoglio (com’è ben possibile), resterebbe agli atti la netta preponde-ranza numerica della dislocazione a sinistra, secondo una distribuzione tipica della lingua scritta antica di tono più sostenuto (oltre a D’Achille, (55., pp. (50--.1 vedi per questo aspetto Trifone, (553/-..., pp. (-0-(-3 e Rossi, (555). Più rari i casi di tema sospeso (per cui vedi D’Achille (55., pp. ((2-(-.) : si vedano per esempio « L’Arpia doppo aver ucciso il viandante il cielo le dà questo castigo » (DL /1), « Lidia è mia, e chi dice altramente li taglierò il naso e l’orecchie » (DL 53), « e chi mi vorrà levar Lidia, a lui vorrò levar la vita » (DL 55), « Che ’l pauroso gli par d’aver le budella in paniere » (Su (1/), « quel consiglio che mi darà il mio bene, a quello appigliar mi voglio » (Tu (.5).II. Attestati anche vari casi di che ‘polivalente’ (per cui vedi Testa, (55(, pp. -./--(- con biblio-gra,a precedente, e Trifone, (553/-..., p. (-/) : « E ch’hai, le mani di Gige e di Briareo, che ti dimentichi il numero ? » (AS (1-), « Cominciate a dimenar le ventaiole, che sapete che ’l vento li piace » (Sc 15), « s’è treschevole, siasi per sé che – per monna Sandra – se mi fa infantastichire e infreneticare ci saremo raccozzati in mal punto » (Sc /-), « Seguita, seguita che ne fai stupire » (Sc /2), « Dite velocemente che mi vien sonno » (Sc 5.), « O che vengano un poco gli altri Poeti a nasarvi dove discende la discorrenza poetica, che vederanno che concia loro darete » (Tu 01), « Entriamo, che quel consiglio che mi darà il mio bene, a quello appigliar mi voglio » (Tu (.5). Si notino qui anche un paio di esempio di che indeclinato, nel primo caso con ripresa pronominale (cfr. D’Achille, (55., pp. -.3--/.) : « questo è colui ch’io gli perdonai » (DL (.5), « con questa spada fatta dello stesso ferro che fu composta la falce della Morte » (Tu 2().
Meritano invece sistematica registrazione i casi di paraipotassi, soprattutto perché si tende a credere che il costrutto sia di fatto scomparso già nel corso del Cinquecento.1
( Per questo aspetto si vedano essenzialmente gli studi di Nencioni ((54//(521), D’Achille ((55.), Testa ((55() e Trifone ((553/-...), quest’ultimo dedicato al teatro.
- Non ho invece eseguito spogli estesi per altri fenomeni interessanti come l’uso del periodo ipotetico di terzo tipo con imperfetto indicativo (su cui vedi D’Achille, (55., pp. -53-1(() e i cosiddetti cambi di progetto sintattico (su cui vedi Testa, (55(, p. --. e Trifone, (553/-..., p. (-3). Vedi comunque per il primo tratto « ora cacciando mano a quel pugnale m’uccideva, se ’l Cielo e Vostra Signoria Illustrissima non soccorrevano questa innocente » (AS 42) e « se tu non eri, io era disperatissima » (AS ((-) ; per il secondo « Chi è questo bel soldatino ? Un esercito di questi, i Turchi subbito si renderebbero » (AS (5-) e « Io per me, come vedo quel cavallaccio salso e disciolto or in montagne trottar al cielo, ora in valli galoppar all’inferno, tutta mi s’increspa la fronte » (DC (().
1 Sulla paraipotassi vedi l’ottima messa a punto di De Caprio (-.(.), cui si rinvia anche per la bibliogra,a precedente. Se sul piano generale vale la diagnosi secondo cui « il colpo mortale a questo, come a tanti altri costrutti dell’italiano antico, fu dato dall’insorgere della nuova concezione prospettica del periodo portata
#:;<==' 6<))# )'$%!# "7>'"# 6' %'7?#$ @#==':=# #$6A<'$' /(Nei testi di Andreini il tipo più attestato è quello con antecedente ipotetico (ma sono numerosi anche i casi con antecedente temporale), e la frequenza tutt’altro che disprez-zabile del fenomeno induce a esser cauti prima di concludere che esso fosse del tutto residuale a quest’altezza cronologica :« Amato peso io t’amo, e s’entro il vivo d’uno specchio rimirandomi ti movesti pietosa ad amar-mi, e io nello specchio di questo essangue volto gli occhi ,ssando tutto ti dono il cuore » (AS ((2), « S’ella giurò per Lidia di non amar cosa ancor che bella, e io per Florinda giuro di disprezzar cose celesti ancora » (AS (-.), « E se Vostra Signoria non mi chiamerà, né parlerà meco, né io con voi, e me n’entrerò in casa » (AS (4/), « e se la putta no voles avrir, e vu desì a Rondel che sidi Cam-panaz » (Ca 10), « son leone poiché, se la pantera con l’odor molle e sovave [sic] alletta e invita a seguitarla, e io col fetor ,ero [...] tutti intimoriti spavento » (DB -1--0), « allor fatto di coniglio appunto leone, e mi discopro » (DB 35), « E a pena ciò detto, fatte le due signore di due Veneri due Arpie, e mi vilipendono » (DB 35), « e alorché la lingua chiederà il baccio, e Asmodeo farà che l’otteniate » (DB 41), « E com’io dico cuccù, e voi accoccategliela » (DB 44), « Non temere, che alor che i tuo’ signor in amor saran contenti, e tu felice » (DB ((1), « nel tempo che Florinda si dorrà sopra questo cuore [...], e tu per di dietro gittale questa polvere sul collo » (DB ((3), « Condotta che ella sarà al destinato luogo [...], e V.S. [...] potrà con aiuto amico trarla allo stesso avello » (DB ((/), « nel tempo che tutte tre guardavano in ginocchioni quel cuore, e io nelle spalle col cartoncino [...] spolverizava le spalle » (DB (-4-(-2), « E alor che Lidia fu entrata, e Florinda saltò fuori » (DL 0-), « S’ho il viso di boia, e tu hai collo d’appiccato » (DC (1), « S’io ho del bu8alo, e tu del becco » (DC (0), « Se ad altrui sembra il ,glio di Venere, ed a me una furia » (DC (/-(4), « E se Florinda s’eternò col pianto, e Durante con l’oro » (DC ((1), « Se la vigilia pela al latino, e a me che sono il volgare pela ancora » (LB -1), « Se chillo è lo signore, e io songo l’ammasciatore » (LB 45), « E allor che dissetarmi e isfamarmi voglio, e tu fai che l’acque mi fuggano » (Ro 10), « S’io pareva un tincon da padellaccia di frate certosino, e V.S. al viso mi assembrava uno spazzacamino » (Ro (-2), « E come al gentil pastorello per lo merito della sua natural facondia un anello donaste, e io, per lo pregio del suo grand’amore, le fo dono di questo bellissimo diamante » (Ro (04), « S’io con lo strale d’uno sguardo l’ho piagata, e con lo stesso [...] la risano » (Sc (2-(5), « Signora, s’altri cose belle dice con la lingua, e io altresì cose belle farò con la mano » (Sc 02), « A8è s’egli parla del principe, e io parlerò d’Orazio » (Sc 2.), « Se non ti piace il parer d’aitri, e tu fa’ a tuo mo’ » (Sc (-2), « e tal bota che mi sto mal, e lu è tutto slanegao e ,apo [...] ; s’ho caldo, e lu sta tuto a pendolon ; e se dal fredo me fo tuto un grumo, e lu [...] el se tira [...] in sé stesso » (Su 32), « ma alor ch’il vinci-tore ha vinto e lo prende e lo gode, e gli altri s’acquetano » (Su 55), « se ti aver el to contento, e mi aver el mio » (Su (0/), « S’un sangue di questo seno diede ad altrui la vita, e il sangue pur di questo petto a me darà la morte » (Su (/3), « S’ella ama Candida, e Candida altresì ama lei » (Tu (10).
Per quel che riguarda la formazione delle parole e la morfologia derivativa, spicca il largo impiego di forme alterate (soprattutto diminutivi), che nei testi teatrali mira in ge-nere ad « alimentare la forza illocutoria degli enunciati facendo ricorso all’emotività ».( Il fatto si associa per lo più a personaggi di modesta estrazione sociale : si vedano pove-ruccio e poverucci 0/, boccuccia 0/, collarino 0/, litteratucci (/2, ragionette (/2 sulle labbra della serva Bernetta in Amor nello specchio, e si noti un caso per più aspetti interessante come « Schiavottolo, ninottolo, bufottolo, vero alcabuottolo » (Su 25), in cui la sequela di oscuri diminutivi, pronunciata dall’oste Fegatello, assume il valore d’una formula magi-ca che dovrebbe indurre Lelio a tornare dalla donna tradita. Quando poi al basso rango sociale si aggiunge la connotazione linguistica ,orentina popolare, il tratto raggiunge una frequenza poco meno che martellante : così, nel solo primo atto dello Schiavetto l’al-
dal Rinascimento » (Ghinassi, (54(, p. 35), schedature più ampie e mirate dimostrerebbero probabilmente che il declino dei costrutti paraipotattici fu più lento e graduale di quanto non si tenda a credere.
( Trifone ((553/-..., p. (13) ; e prima Giovanardi ((525).
)!"# 6’7$%&'#/-bergatrice ,orentina Succiola si esibisce in un fuoco di ,la di botticino ((, furbacchiotti (-, struzzolo (0, collezzioncella (3, pietruzzola -/, pentolini -4, tantolino -4, capolino -2, cosette -2, piazzuola 1., !lastroccole 1., sennuccio 0(, principuccio 0(, cui vanno aggiunti nel setto-re degli accrescitivi-spregiativi la serqua furfantaccio, sudiciaccio, dapocaccio, bricconaccio ((, baccellone (-, uccellaccio (-, 1/, buacci (-, sboccataccia (3, caponaccia -2, avarone 1(, goccio-lone 1-, pecorone 1-, cornacchione 13. È notevole – indicando una tendenza al sovraccarico espressivo – che il procedimento venga applicato anche ai nomi propri, come in « Tu sei il mio caro Lardello, Lardelletto, Lardelluccio, Lardellinuccio » (Tu (-/).( Andreini non rinuncia poi, con una delle sue tipiche mosse metalinguistiche, a ridicolizzare l’abuso di diminutivi prendendo di mira un esponente della letteratura u+ciale come il Poeta personaggio della Turca : « Poeta : “Bisognerà che ci riduciamo in alcun cespugliuzzo e di queste caverne in un antruccio”. Fringuello : “Oh che vi venga il cancheruccio con questo vostro parlare in uccio biciuccio” » (Tu (3.). Esempi del genere – come già « fur-fantaccio, sudiciaccio, dapocaccio, bricconaccio » e simili – indicano in maniera chiara la tendenza di queste serie a perdere di signi,cato, in favore di un compiacimento pura-mente fonico che è il tratto saliente del cosiddetto ‘comico del signi,cante’.-
Ma la curiosità morfologico-lessicale di Andreini si rivela soprattutto nell’ampio ri-corso a pre,ssati e su+ssati dall’aspetto spesso singolare, che in più di un caso sono da ritenere con tutta probabilità neoformazioni. Ecco qualche esempio :I. Pre!ssati. a- : « nell’acque marine s’appozzò e s’abissò » (Tu (3 ; altri ess. di abissarsi in Tu 0, (33) ; dis- : « da ceppo ferreo mi disferro » (DL /1), « tutto in pezzi voglio disgomitolarmi » (DL 2.), « O poltro dispoltrati, idest [...] o poltrone dispoltronati » (LB (-2), « Ti porrò nel chiostro, e io postea ti dischiostrerò » (LB (1/), « spoverire e disfamare » (Sc -0), « nella pulitezza appresso me, quante ,orentine ci sono, tutte si ponno dis,orentinare, e dite pur loro che si dis,orentinino » (Sc 1-), « mi voglio disgiudeare » (Sc /3), « a tempo ch’io mi dispupilli e disvergini » (Sc (-(), « e s’io sono Lardello, perché volete dislardellarmi ? » (Tu 20), « Convien che la nebbia si disnebbi all’apparir di nuovo sole » (Tu (1() ; in- : « Oh, come m’incerbero, o come m’inradamanto, o come m’intesifono, o come m’in9egetonto, o come m’insatanasso » (DC 34), « se mi fa infantastichire e infreneticare ci saremo raccozzati in mal punto » (Sc /-) ; « m’invipero, m’inaspido, m’imbasilisco, m’indrago e m’incoccodrilo » (Sc 22), « m’incerasto, m’infesibeno, m’iniaculo, m’inchelidro e m’infareo » (Sc (3(), « infeltrato e istivalato » (Su 3.) « indiavolato, insatanassato » (Tu 4/), « Poeta, chi più t’infor-sa ? » (Tu (1() ; s- (o is-) : « Ecco, quasi a8amato lupo, Orazio se smacchia » (LB -/), « spoverire e di-sfamare » (Sc -0), « parmi veder ispuntare e ismacchiare barbara gente » (Tu ((4), « Olà smacchiate da queste frondose macchie » (Tu (14).II. Su"ssati. -ario : postribolario (Su 0.) ; -atico : « queste scarpe, quali in iscarpatica favella dicono : ambula » (DB 44) ; « gon,o di quella quintaessenza manzatica, vitellatica, capponatica e porcati-ca » (Sc /3) ; -e"iare : « ecco la gruccia porporeggiante, ecco la civetta atteggiante » (DB -/), « car-
( Un altro esempio che documenta il gioco sui nomi propri è o8erto dalla battuta in cui Succiola squa-derna il suo pedigree : « Succiola : “Holla [una madre], e ha nome la Ceccabimba, alloggia in via Pentolini ; ho una sirocchia, che pur si chiama Ceccabimba, una Ceccobimbetta, un’aitra Ceccabimbotta. Or ne volete piue di cotesta ceccobimbaria ? [...]”. Nottola : “Ceccobimbaria ! Eh eh ! [...] Cotesta ceccobimbata m’ha fatto tanto ridere, ch’i’ mi son pisciato addosso” » (Sc (0). Fatti analoghi sono documentati già prima in Della Porta (cfr. Giovanardi, (525, p. 3(2), ed è forse a questa tradizione linguistico-espressiva che si ispira un conoscitore del teatro dell’Arte come Dario Fo, quando in una delle sue prime prove, la farsa Marcolfa ((532), adopera forme come Marcol!nuccia, Marcol!nettuccia, Marcolfuccia, Marcol!na e Giuseppinettuccio (Fo, (520, pp. (/--( ; su Fo e la Commedia dell’Arte vedi Vescovo, c.d.s.)
- Su questo aspetto è d’obbligo il rinvio al fondamentale saggio di Altieri Biagi ((5/5/(52.) ; la lunga vitalità di procedimenti analoghi si può documentare additando un luogo epigonico della tradizione delle maschere : ecco come uno degli ultimi grandi Pulcinella, Antonio Petito, fa il verso al primo amoroso nella sua « tragedia a vapore » Francesca da Rimini : « Ah ! ingrata traditrice spetrice così tratti un infelice che per te s’è ridotto n’alice senza camicie ! » (Poole, (555, p. 1.).
#:;<==' 6<))# )'$%!# "7>'"# 6' %'7?#$ @#==':=# #$6A<'$' /1telleggiando il dis,dai a terminare a corpo a corpo » (LB -/), « Cavalletta : “State così in iscurzo, scurzeggiate”. Lelio : “Eccoti, scurzeggio” » (Ro 24), « tutt’oggi mi convien piazzeggiare per ogni piazza grande e per ogni piazzuola » (Sc 1.), « È ’l maggiordomo, il maggiorente, quello che può maggioreggiare sopra tutti » (Sc 11), « stella non istelleggia » (Su (.(), « non istelleggiano le stelle » (Tu 1/), pindare"iando (Tu 02, (44), « per amor vostro mi contento d’esser pugneggiato, legneg-giato e sasseggiato » (Tu (11), « O se fosse vero, come nel campo del mio cuore anderebbero fertileggiando i miei contenti ! » (Tu (/3), « rumoreggino i tamburi, sventoleggino gli stendardi » (Tu-. (42) ;( -esco : « pentolesco gorgogliamento » (Sc (11), « sagginale cucinesco » (Sc (/2), « alla mia pagliaresca stanza » (Tu (04) ; -evole : « s’è treschevole, siasi per sé » (Sc /-), « la guizzevole fami-glioletta marina » (Tu (.-((), « questo leuto è sonevole » (Tu (3), « per questi girevoli colli anderà saltellando la greggia » (Tu 14), « animo fratellevole » (Tu //), « il guerreggievole rumoreggiare degli oricalchi » (Tu 51) ; -fero : « signore pianellifere » (DB 14), « So,stico : “Olà, olà, o dal tugurio, o dal grebano, o dall’ostello paglifero !” Venturino : “Ostello paglifero, eh ? un zolfanellifero mande-rebbe te se fossi colà dentro in fumifero !” » (LB (-2), « Morire eh ? Il Ciel più tosto mi faccia viver ignudo fra i giuniperi privo del suon de’ pifari, che star carico d’oro tra i mortiferi omiferi » (Sc ((4 ; giunipari vale ‘ginepri’) ; -icolo : « So,stico : “Video, che non hai cuor di cuniculo”. Venturino : “Che di cunicolo ? L’ho di leonicolo, anzi di leofanticolo, o testicolo” » (LB 52) ; -i!care : stelli!cato (Ro (/4) ; -istico : « bestia gomorristica » (AS (40) ; -oio : « sono tutta dal sudore fatta un colatoio, e dal tanto girar un arcolaio, un naspatoio » (Sc -4) ; -oso : « vituperoso, ignominioso, diavoloso » (DB 42), « Là fu la cosa tanto tumultuosa, e armifocosa » (Tu-. (..), « razzazza ignominiosa, vellosa, caudosa e cornuosa » (Tu (3.) ; -tore : « l’ire vostre pianellatrici » (DL 0() ; -uto : « caputo [...], gozzuto [...], naticuto come una mosca culaia » (Sc (/2), « Poeta : “[...] è vergogna che stia a mani compli-cate chi è così quadrato, di gambe bovine, pettoruto, nerboruto, e settoluto.” Fringuello : “Oh oh oh oh, che domine di parlaruto è cotestuto ?” » (Tu 5-).
Poche osservazioni su questi casi : di frequente i denominali si trovano vicini al sostan-tivo da cui derivano (per es. !orentine e dis!orentinare, ferri e disferrare, chiostro e dischio-strare), sicché molti degli esempi andrebbero accostati anche a quelli di bisticcio di cui si parlerà tra breve. È da notare poi che molte voci sono parte di serie più ampie (lo si è già visto a proposito dei diminutivi), e nell’ambito di questa sottospecie si distinguono bene alcuni procedimenti : (i) l’insistenza sul tratto morfologico può essere indizio della natura arti,ciale o accesamente fantasiosa di tutta la sequenza, come in « manzatica, vi-tellatica, capponatica e porcatica » o in « m’invipero, m’inaspido, m’imbasilisco, m’indra-go e m’incoccodrilo » ;- (ii) la serie può essere aperta da voci assai comuni cui seguono, sull’onda di un ‘contagio’ morfologico, voci assai meno comuni o di pura fantasia (cfr. colatoio-arcolaio-naspatoio, ignominiosa-vellosa-caudosa-cornuosa) ; (iii) la serie può essere costruita usando una tecnica che ricorda quella dell’aprosdoketon, con l’elemento ,na-le che di8erisce radicalmente per signi,cato dai precedenti (cuniculo-cunicolo-leonicolo-leofanticolo-testicolo).1
( I denominali costruiti con il su+sso -e"iare sono tra i più frequentati dagli scrittori seicenteschi, e prediletti ad esempio da Marino : Colombo ((5/4, pp. (-2-(11) registra tra l’altro ninfe"iare, arbore"iare, colombe"iare, isole"iare, porpore"iare, rubine"iare, trastulle"iare, lingue"iare.
- Una sequenza analoga a quest’ultima – precisamente « o come m’incerbero, o come m’inradaman-to, o come m’intesifono, o come m’in9egetonto, o come m’insatanasso » – è segnalata anche in Trifone ((550/-..., p. 34) ; bisogna notare che a dispetto dell’apparenza sequenze simili non sono mai composte per intero da neoformazioni : in « m’invipero, m’inaspido, m’imbasilisco, m’indrago e m’incoccodrilo » Andreini mescola per esempio invenzioni proprie (imbasiliscarsi, inaspidarsi, incoccodrillarsi) con forme blasonate (in-dragarsi è dantesco, inviperarsi è in Sannazaro).
1 Una prova dell’originalità lessicale andreiniana si ottiene veri,cando sul %6)' la presenza delle forme appena elencate (e s’intende che al %6)' si riferiscono tutte le indicazioni di volume e numero di pagina). Molte di esse – e non solo quelle di tono comico – non sono registrate, e andranno prudentemente ritenu-te, e ,no a prova contraria, neoformazioni : è questo il caso di armifocoso, capponatico, caputo, cartelle"iare, caudoso, cornuoso, cucinesco, dischiostrarsi, disgiudearsi, disgomitolarsi, dispoltrarsi, dispoltronarsi, dispupillare,
)!"# 6’7$%&'#/0Il movimento dal noto all’ignoto, o dal comune allo stravagante, che si nota bene nel
tipo (ii) obbedisce ai principi di esibizionismo e ricerca della novità tipici della cultura barocca, e può aver luogo anche a dispetto di ogni verosimiglianza morfologica, come accade nelle sequenze pifari-mortiferi-omiferi, paglifero-zolfanellifero-fumifero e pettoruto-settoluto-nerboruto-parlaruto-costestuto :( qui gli addendi ,nali sono sempre ingiusti,cati dal punto di vista grammaticale (dato che mortifero vale ‘morto’ e non ‘che porta morte’, e similmente accade per omifero, zolfanellifero, fumifero, parlaruto, cotestuto). L’accumulo dei su+ssati non segue dunque alcuna regola morfologica ma soddisfa esclusivamente un intento di giocosa ostentazione e costituisce, sul piano linguistico, l’esatto corrispet-tivo di quella « soumission de la fonction au décor » indicata da Jean Rousset come uno dei tratti essenziali dell’architettura e della letteratura barocche.-
Sempre al ‘comico del signi,cante’ pertengono altri espedienti molto cari ad Andrei-ni come i bisticci e i giochi di parole ; i casi più semplici, particolarmente di8usi, sono quelli in cui la pointe è ottenuta avvicinando lemmi formalmente prossimi (talvolta con lo stesso etimo) ma lontani o quantomeno ben distinti dal punto di vista semantico (corsivi miei) :1 « Se sapessero ch’anch’io per la stessa causa con Amor piato, piatto ben con le pugna mi farebbero il volto » (Tu 35), « degli occhi di Candida al fulgòre la fòlgore ne nacque » (Tu 35), « a cui di questa amorosa coppia, copia farà più di sguardi » (Tu /.) ;
inaspidarsi, incerastarsi, inchelidrarsi, incoccodrillarsi, infarearsi, infesibenarsi, iniacularsi, gomorristico, manza-tico, paglifero, pianellatore, pianellifero, postribolario, scarpatico, scurze"iare, treschevole, vitellatico, voraginare, zolfanellifero. Analogo giudizio va dato per le forme registrate in %6)' ma attestate per la prima volta in An-dreini o retrodatate dai suoi testi : appozzarsi (' 32-, con un es. da Viani), fertile"iare (? 24., solo in Andreini), imbasiliscarsi (?'' -2(, con un es. di Tesauro), inradamantarsi (?''' 41, solo in Andreini), insatanassarsi (?''' 23, con ess. da Andreini, Baru8aldi, Faldella), intesifonarsi (?''' -23, solo in Andreini), legne"iare (?''' 51., con il signi,cato diverso di ‘far legna’ in Tommaseo), pentolesco (B'' (.//, con il signi,cato diverso di ‘pa8uto’ in Caro), pindare"iare (B''' 05., con ess. da Salvini in poi), sasse"iare (B?'' 323, con un es. da Cesarotti), spo-verire (B'B (.-3, solo in Andreini). Altrettanto spesso le voci sono documentate già in precedenza : abissarsi (' 0-, con ess. da Iacopone in poi), atte"iante (' 2.20, con ess. da Lorenzo de’ Medici in poi), diavoloso ('? 10.-, con ess. da Burchiello in poi), disfamare ('? //(, con ess. da Dante in poi), disferrarsi ('? /4., con ess. da Giambullari in poi), dis!orentinarsi ('? /4-, con un es. da Muzio), disnebbiare ('? /55, con ess. da Dante in poi), disverginare ('? 215, con un es. dall’Ottimo Commento), !nestrare (? (.13, con ess. da Francesco Colon-na), fratellevole (? 1(., con ess. da Boccaccio in poi), girevole ‘che ha andamento sinuoso’ (?' 204, con ess. da Ariosto in poi), gozzuto (?' (..(, con ess. da Boccaccio in poi), guerre"evole (?'' (3/, con ess. da Boccaccio, Bembo e Straparola), incerberarsi (?'' /33, con ess. di Oddi, Andreini, Menzini), indragarsi (?'' 204, con ess. da Dante in poi), infantastichire (?'' 252, con un es. da Gelli), infeltrato (?'' 5(-, con ess. da Franzesi, Cecchi e Razzi), in$egetontarsi (?'' 5/-, con ess. da Oddi e Andreini), inforsare (?'' 52( con ess. da Dante in poi), infrenetichire (?'' 55/, con un es. da Masuccio), inviperarsi (?''' 003 con ess. da Sannazaro in poi), istivalato (?''' (02 instivalato, con ess. da Sanudo in poi), ma"iore"iare ('B 00., con ess. da Agnolo Pandol,ni in poi), naspatoio ‘naspo’ (B' -.4, con un es. da Colombini), nasuto (B' -(-, con ess. dal Casa in poi), naticuto (B' -(4, con ess. da Boccaccio in poi), pagliaresco (B'' 1/2, con ess. da Sannazaro in poi), piazze"iare (B''' 11., con pochi ess. dal Novellino in poi), porpore"iare (B''' 5-., con ess. da Mattioli in poi), pugne"iare (B'? 5.5, con ess. da Sermini e Sabadino degli Arienti), sonevole (B'B 0.4, con ess. da Boccaccio e da Buti), smacchiare (B'B (1- s.v. smacchiare1, con ess. da Marini in poi), stelle"iare ‘risplendere’ (BB (-2, con ess. da Chiabrera in poi), stelli!cato (BB (-5, con ess. da Groto, Frugoni, Ammirato), sventole"iare (manca, ma in BB /(( sventole"iante con un es. in De’ Sommi). Anche una ricerca così rozza consente di individuare nel lessico andreiniano alcune componenti culturali sulle quali occorrerebbe andare più a fondo : spiccano i dantismi (disfamare, disnebbiare, indragarsi) e le voci che sembrano da ricondurre invece a Boccaccio (fratellevole, guerre"evole ; gozzuto, naticuto) ; ma sono notevoli anche la probabile presenza di Sannazaro (inviperarsi, pagliaresco) e l’at-tenzione che Andreini presta ad alcune stravaganti neoformazioni di un commediografo manierista come Oddi (incerberarsi, in$egentontarsi).
( La passione barocca per la novità e l’ostentazione è ben illustrata in studi classici come Maravall ((523, pp. 141-0(.) e Rousset ((523, pp. (2(---2) ; per alcuni fatti linguistici relativi al contesto italiano vedi l’e+cace sintesi di Coletti ((551, pp. (2--(51). - Rousset ((523, p. (2- e pp. -(5----).
1 Cfr. anche i materiali discussi in Altieri Biagi ((5/5/(52., pp. 0--01).
#:;<==' 6<))# )'$%!# "7>'"# 6' %'7?#$ @#==':=# #$6A<'$' /3il grado di complicazione può essere accresciuto aumentando il numero degli addendi in bisticcio : ecco così « o grimo gramo tutto in un grumo » (Sc 10), « questi rabini arrabbiati, over rabini rabuini » (Sc /0), ma anche « Che venga il canchero a Titone, a Titano, a tettéme e a quelle tettaccie » (Tu 4), ,no al convenzionale ma molto insistito « Piano cara mia vita, che non perdeste la vita, ch’a me torreste la vita col cader della vostra vita, poiché la mia vita vive nella vita vostra » (Tu (.3).(
Più interessanti sono i casi in cui le parole vengono equivocate o scomposte, a volte per accentuare i qui pro quo che possono aver corso tra personaggi di diversa provenien-za geogra,ca. Un equivoco basato sull’ambiguità di una sola parola si ha per esempio in « Rondone : “Che giorn’è oggi ?” Nottola : “Che proposito ! È giobbia !” Rondone : “Per questo l’ho nel mercore, sapendo che solo in sabbato fa le sue ,erezze” » (Sc 52), dove si gioca sul fatto che mercore vale sia ‘mercoledì’ sia ‘deretano’.- Altrove si assiste invece a giochi più compiaciuti in cui è attivo un meccanismo di slittamento ludico da una forma all’altra : « crediatemi, che dall’andar tanto giravoltolando m’è venuto il capogiro, o ’l capogirlo che dir vogliamo, o vero il capogatto com’alle bestie » (Sc -5) ;1 « Tedesco : “Io maxime, mi non aver lingua tescanna.” Rondinello : “Toscana !” Tedesco : “Sì sì, mo-scana.” Rondinello : “Sì, moscana moglie di moscone !” » (LB ((/) ;0 « Tedesco : “Missiersì, matona sì, iò, queste ,liol de Vulvacane.” Rondinello : “Sì, di prepuzio di gatto ! Di Vul-cano !” Tedesco : “Iò, de Volacan.” Rondinello : “Volapesci !” » (LB ((4) ; « Lelio : “Quando ti vuol vender costui ?” Sultana : “Fra quattr’ore, e prima ancora.” Lelio : “Quanto è ’l prezzo ?” Sultana : “Cento cecchinia”. Lelio : “La cecchinia senz’altro sarà la moglie del zecchino ; cento cecchini tu vuoi dire.” Sultana : “Sì sì signor, ti interderla, e mi mal proferirla” » (Tu 00-03).
Un uso della lingua di intonazione prestidigitatoria si coglie anche nelle ri9essioni etimologiche (o più spesso pseudoetimologiche) innescate in continuazione dai nomi ‘parlanti’ dei personaggi. Ecco qualche esempio :« Io che son Coradella tutto cuore » (AS 0.) ; « Lelio : “O Granello per antonomasiam !” Granello : “Quasi testicolo, eh ! E per questo vi sto appiccato, né senza me potete far la cosa » (AS (1/) ; « [...] dovreste pur esser consimili, voi Melina diminutivo di mela grande, e lui Peruccio di gran pero lo stesso ; e siete così discordi » (AS (2-) ; « Arminia mia, che armato il cuor d’onestà e la mano di virtù, insegnando di chitarra armoniosamente fate il vostro nome glorioso » (DC -2) ;3 « Flo-rinda ,ore sfogliato, ,ore inlanguidito, ,ore dall’orto di mia virtù spiantato, perché nel campo di disonestà io divenissi ,ore assai più disprezzabile dei ,ori che producono le ortiche » (DC 1-) ; « Sardellino : “Or sia, mi chiamo Sardellino, e questi Grugnetto.” Venturino : “Uno buono di quadragesima, l’altro di Carnevale” » (LB 04) ; « Veramente la cortigiana – dirò cosa conforme al mio nome di Tordello – è come coloro che vendono i tordi, stanno sempre in sul pelare » (Ro 32),
( Per il gergale grimo ‘vecchio’ cfr. Cortelazzo (-..4, p. /-.) ; per rabuini ‘diavoli’, ugualmente gergale, cfr. Brambilla Ageno (-..., p. 3--) ; per tettéme (< tetar ‘succhiare’), tipica ingiuria veneziana che vale più o meno ‘in malora’, cfr. Cortelazzo (-..4, p. (120).
- Per il secondo signi,cato di mercore cfr. D’Onghia (-..5, p. ((2).1 In questo caso l’agudeza è doppia perché la scomposizione comica non ha esito fantasioso – come nella
serie di poco successiva Vulcano-Volacan-volapesci – ma si mantiene nell’ambito del lessico reale : capogiro (o capogirlo, secondo un’alternanza ammessa in Crusca, (/(-) viene infatti inteso come capo-giro (con giro forma settentrionale per ‘ghiro’) e fornisce perciò l’appiglio a capo-gatto, che è tuttavia una parola esistente, e designa un « male che viene alle bestie » giusta Crusca ((/(-) ad v. capo (e si noti la precisazione di Succiola : « capogatto com’alle bestie »).
0 La forma camu8ata moscano ‘toscano’ è ben attestata tra Cinque- e Seicento, da Ruzante a Lando a Maggi (D’Onghia, -.(., p. (0).
3 In questo esempio si assiste non a un gioco metalinguistico, ma a una sorta di dissoluzione fonica del nome lungo la frase (corsivi miei) : « Arminia mia, che armato il cuor d’onestà e la mano di virtù, insegnando di chitarra armoniosamente fate il vostro nome glorioso ».
)!"# 6’7$%&'#//« vedete Succiola, la succiola è un frutto dolce, non siate or voi così aspra [...] » (Sc -4) ; « O Rondo-ne, Rondone ! Si dice che ’l rondone è uccello innistancabile, sempre per lo cielo girandosi : ma tu col nome di Rondone il volo serbi di poltrone » (Sc 3/).
Procedimenti analoghi possono anche superare il con,ne di battuta, come certi,ca un dialogo tra Lelio e Florinda (Ro 04-3.) nel quale è svolta un’ampia esegesi simbolica del nome della fanciulla (eccone l’inizio : « Vi fo riverenza o bella signora Florinda, detta Flos indus ; cioè ,ore non solo bello a questo nostro cielo, ma bella agl’Indi, agli Africani, ai Persi, agli Siti. Fiore a cui il mondo tutto, anzi ogni cuore fu destinato in giardino. Fiore immarcessibile, ond’ha, che malgrado di Sirio o d’Orsa gelata, sempre è ,ore colorito e fresco. Fiore, ch’ha le radici in terra, in Cielo l’odore [...] », e così per diverse pagine).(
Talvolta Andreini spinge questa manipolazione del codice comico ,no alle soglie della dissoluzione del signi,cato, come accade in due notevoli scene della Campanac-cia e dello Schiavetto che documentano un alto grado di virtuosismo espressivo. Nella Campanaccia il protagonista, complici le tenebre e una pesante ubriacatura, confonde il rivale in amore Tremimarte con la propria ombra (Ca 13-15) : ne risulta uno scambio concitato straordinariamente e+cace durante il quale – grazie a un abile sfruttamento del congegno egloghistico dell’eco – il Dottore sprofonda poco a poco nell’assenza di identità, in un dialogo scandito da rapide battute il cui signi,cato tende a dissolversi per via dell’ossessiva ripetizione di parole spesso brevissime o monosillabiche.- Nello Schia-vetto (Sc /2-4.) questa tendenza allo sfarinamento linguistico va oltre, e l’innamorato Fulgenzio, in combutta con un sensale compiacente, ‘parla’ in lingua mutolina, gattesina e sorzolina (5, (-), un idioma inesistente composto di serie blandamente onomatopeiche del tutto prive di signi,cato :[(] F!)%<$D'7 : Temp’è di mescolarmi infra la turba ; e non sapendo parlar ebraico muto ,nge-
rommi. Ba, ba, ba, ba ?[-] L<7$ C#""&'$7 : Quest’è muto, e ne saluta, per quanto non da la lingua ma dal ginocchio
comprendo. E di più, convien che sia forestiero, non avendolo più veduto in queste parti.[1] S<$:#)< : Lasciate, ch’io lo intenderò, ch’ho lingua muta, e in quel linguaggio parlo molto
bene.[0] C#'$7 : Tu ne vuoi far ridere ! Che lingua muta ?[3] S<$:#)< : Che lingua muta ? O state a sentire. Be, be, be, be ? Vedete voi : costui co ’l suo Ba,
ba, ba, ba n’ha detto buon dì a tutti, e io col mio Be, be, be, be gli ho risposto dicendo che tutti noi gli rendiamo il buon giorno.
[/] L<7$ C#""&'$7 : Bene, per la Torrà ! Seguita, seguita, che ne fai stupire.[4] C#'$7 : Certo ch’è maravigliosissima cosa, e quasi incredibile.[2] F!)%<$D'7 : Baraù, babbù ; gnaù, gnargnù, gnaù gnaù ?[5] S<$:#)< : Oh, vedete, quest’è lingua gattesina, con la mutolina congiunta.[(.] S#>7<) : E come gli risponderai ? Eh eh ! È forza ch’io rida !
( Esempi dellaportiani analoghi sono discussi in Altieri Biagi ((5/5/(52., pp. 3(-3-).- Su questa scena vedi anche Spezzani ((54./(554, pp. (52--.-) ; eccone un assaggio : « Campanaccio : “Pot-
ta de Zuda ! L’ombra ghe pesa la man ! Orsù, lasseme intrar.” Tremimarte : “Orsù, lasseme intrar.” C : “El tocca a mi.” T : “El tocca a mi.” C : “Mo chi èt ti ?” T : “Mo chi èt ti ?” C : “Son Campanaz !” T : “Son Campa-naz !” C : “Sì, mi !” T : “Sì, mi !” C : “O poveraz mi, che sì che son perdù ! Mo zit, l’ha rason : el pò esser anca lu un Campanaz, ma no po’ el bel, el bon, el spos ! Dime un poc, èi-t Campanaz el bel ?” T : “El bel.” C : “El bon ?” T : “El bon.” C : “El spos ?” T : “El spos.” C : “In chi po’ ti ?” T : “In chi po’ ti ?” C : “Dil ti.” T : “Dil ti.” C : “Ti.” T : “Ti.” C : “Ti.” T : “Ti.” C : “Vuot che ’l diga ?” T : “Vuot che ’l diga ?” C : “Sì.” T : “Sì, l’è Zelinda.” C : “Ohimè, e’ son ben mo pers ! Uh uh uh ! Oh de casa !” T : “Oh de casa !” C : “Avrime a mi !” T : “Avrime a mi !” C : “Son Campanaz !” T : “Son Campanaz !” [...] ». L’archetipo di scene simili è l’inizio dell’Amphitruo plauti-no, testo non per caso sfruttatissimo anche dalla tragicommedia francese degli anni Trenta del Seicento, ad esempio con Les Sosies di Rotrou (Rousset (523, pp. /(-/3).
#:;<==' 6<))# )'$%!# "7>'"# 6' %'7?#$ @#==':=# #$6A<'$' /4[((] L<7$ C#""&'$7 : Udiamo un poco.[(-] S<$:#)< : A questa lingua gattesina risponderò con lingua sorzolina : ma sapete quello che
gattesinescamente e mutescamente ha detto ? Vuoi che ’l dica, muto ? Ben non intende questo parlare, e vedete che tacque, né s’è mosso. Aspettate : Barabam, barabam, bi, be, ba ?
[(1] F!)%<$D'7 : Fi, fe, fo, fu ![(0] S<$:#)< : Fi, fe, fo, fu vuol dir ch’io gli dica.[(3] L<7$ C#""&'$7 : Oh che gran cosa ![(/] F!)%<$D'7 : Qua, qui, quaraqui ! Qua que quu ?[(4] S<$:#)< : Dice di più, che vorrebbe vender anch’egli alcune cosette, e ch’è un sellaio.[(2] C#'$7 : Volontieri [...]
Qui davvero « la lingua cessa di trasmettere signi,cati » ed è ridotta al rango di un bor-bottio sillabico che può acquistare senso solo sulla scena, e che ha tuttavia il pregio assai barocco di essere « maravigliosissima cosa, e quasi incredibile » (4).(
- .
I fatti presentati ,n qui sulla base di un’esempli,cazione prevalentemente italiana non devono oscurare l’aspetto più vistoso dell’esperienza linguistica di Andreini commedio-grafo, ossia il frequente ricorso a un’ampia tastiera espressiva, che solo in parte coincide con quella codi,cata negli stessi anni dalla Commedia dell’Arte. Pochi sono i casi in cui Andreini adopera solo l’italiano (Li duo Leli simili, La rosa), e unico è il caso della Vene-tiana, scritta per intero in un veneziano assai ben dominato e di8erenziato dall’interno per via stilistica, del quale sono notevoli sia la regolarità grammaticale sia la ricchezza lessicale.- Quanto alla posizione eccezionale del veneziano nella tavolozza di Andreini, alla sua ottima conoscenza avranno contribuito sia la provenienza della madre sia la specializzazione nel ruolo del Magni,co allato a quello dell’Amoroso. La Venetiana ri-sulta in e8etti intestata a « sier Cocalin de i Cocalini da Torzelo Academico Vizilante dito el Dormioto », che è appunto il nome ipercalmiano assunto dall’Andreini-Magni,co, ra+gurato nelle vesti di Cocalin dal codice Menaggio.1 Che fosse proprio Andreini a vestire i panni di Cocalin è confermato da un passo della lettera che l’editore Angelo Salvadori, certo in accordo con l’autore, premette alla propria stampa veneziana della Campanaccia nel (/-1 (Ca A/r) :0
( L’espressione tra virgolette in Altieri Biagi ((5/5/(52., p. 02).- Sulla Venetiana cfr. Zorzi ((5/3/(55., pp. (/5-(4.), Cortelazzo ((521, p. 1/4), Stussi ((551, p. 20), Rebau-
dengo ((550, p. (.3) e Stussi ((555, p. 2.) ; sulla perfetta padronanza del veneziano rivelata da Andreini in questa commedia si era già so8ermato Cozzi ((535, pp. (50-(53).
1 Vedi Ferrone ((551, tav. 33) : nell’immagine Cocalin è ra+gurato come un vecchio curvo che regge un paio di occhiali. Il particolare potrebbe essere collegato al nomignolo che nella Turca il servo Fringuello a+ bbia al turco Occhialì chiamandolo « messer Occhialino de gli occhialini » (Tu (0.), alludendo forse scher-zosamente allo stesso Andreini (ma Occhialì sta qui propriamente per Uluc Alì, il temibile corsaro turco morto già nel (324 : vedi Perocco, -.(., p. -21).
0 Tutta la lettera è un documento di estremo interesse, e vale la pena di trascriverne una porzione più ampia e di discuterla brevemente.
[c. A3r] LO STAMPATOR A CHI LEGGE. Con l’occasione di trovarsi in Vinezia il Signor Gioan Battista Andreini tra ’ Comici del Serenissimo Signor Duca di Mantova detto Lelio, dallo stesso intesi come questa Comedia detta la CAMPANACCIA era suggetto suo, e dicitura sua, benché sott’altro nome stampata in Pari-gi nel tempo che serviva alla Maestà cristianissima del Re LUIGI [...] ; e che aveva fatto questo per giovar ad un suo Compagno Comico detto Giovanni Rivani, che in Teatro faceva la parte del Graziano, e tuttavia la fa, detto Campanaccio [...] ; e per darle molto ben appoggio, poiché pare che tal parte molto ben convenga col Pantalone, il Pantalone ancor c’introdusse, per non levar alla consuetudine il suo Orizonte : in altre sue Comedie questo non ha mai fatto per non allontanarsi dal buon ordine di far parlar tutti gli interlocutori in un solo linguaggio come apertamente si può veder non solo nella TURCA, nello SCHIAVETTO, in LELIO
)!"# 6’7$%&'#/2
Parimente favellando seco [con Andreini] intesi la VENEZIANA Comedia esser suo ridicoloso capriccio, e che si compiacque di mandarla fuori sotto nome di Coccalino Accademico Vigilante detto il Dormiotto per gusto particolare ch’egli aveva di rappresentar alcuna volta la parte di Coccalino vecchietto allegro.
Salvo i casi appena richiamati, la produzione comica andreiniana è dunque improntata alla pluridialettalità – e assai più di rado al plurilinguismo – secondo gradazioni tuttavia assai diverse : vi sono commedie come la Turca, Li duo baci e Amor nello specchio in cui a una preponderante presenza dell’italiano si a+anca la coloritura dialettale bu8a delle serve (il veneziano di Masenetta nei primi due testi, il bolognese di Melina nel terzo) ; diverso è invece il caso della Campanaccia, in cui a parlare dialetto sono i personaggi fondamentali (il veneziano Trifonio e il bolognese Campanazz). Sovrapponibili a que-sto secondo tipo – ma con tendenze più rilevate all’esibizionismo linguistico – sono La Ferinda e Le due comedie in comedia : nella prima tengono un ruolo importante i dialet-ti delle maschere (veneziano, bolognese, bergamasco), ma sono ammessi scampoli di ferrarese, tedesco, ,orentino popolare, genovese, napoletano, veneziano bulesco, pe-dantesco ;( nella seconda i teatranti che fanno le prove per mettere in scena un tipico canovaccio parlano veneziano, bolognese, ferrarese, pedantesco e ,orentino popolare, cui s’aggiungono nella scena sesta dell’atto quinto il bergamasco, il napoletano e il fran-cese.
L’apice della complessità espressiva è raggiunto nello Schiavetto e nel Lelio bandito, che ribadiscono la distanza tra la produzione comica di Andreini e la commedia delle maschere propriamente detta : nello Schiavetto non compaiono infatti – salvo che per una breve apparizione metateatrale (Sc (5() – i dialetti attribuiti ai tipi ,ssi del teatro professionistico, bensì varietà periferiche o stravaganti (il ,orentino demotico dell’al-bergatrice Succiola, il furbesco dei malandrini al séguito di Nottola, il giudeo-italiano dei mercanti ebrei) ;- il Lelio bandito mette invece in scena le vicende di un aristocratico ,orentino (Lelio) ingiustamente costretto a vivere da bandito nei boschi tra la Campa-
BANDITO, comedie stampate in Italia : ma nella SULTANA, nei DUO LELII, nell’AMOR NELLO SPECCHIO, e nella CENTAURA, comedie stampate in Francia. Io dunque desideroso di rigettar questa Campanaccia con l’intervento dell’istesso signor Giovanni Battista l’ho stampata, essendo questi suoi componimenti comici di grido felicissimo, leggendosi e ’n [c. A/r] diverse parti rappresentandosi con applauso universale [...]. Stampasi anche al presente un suo bellissimo capriccio intitolato LE DUE COMEDIE in COMEDIA, opera stravagantissima ; come invenzione bizarra fu la FERINDA, composta sotto l’ordine di quelle favole che oggidì si rappresentando cantando. Chi è vago di nuovo diletto legga questo nuovo componimento, che di nuove piacevolezze goderà nuovo frutto : e vivete felici.
L’avviso intende ristabilire la paternità andreiniana della Campanaccia (vedi Ferrone, (551, p. -1.) e propo-ne una sistemazione dell’opera teatrale di Andreini che si dichiara basata su un criterio linguistico-espres-sivo, ma che è in realtà curiosamente fallace. L’asserzione secondo cui il « buon ordine di far parlar tutti gli interlocutori in un solo linguaggio » non sarebbe stato tradito è infatti inesatta per quasi tutti i pezzi della lista, specie per lo Schiavetto e il Lelio bandito ; è vero piuttosto che le maschere tipiche del repertorio pro-fessionistico hanno un ruolo importante solo nella Campanaccia e nella Ferinda, isolata però per via del suo impianto ‘operistico’ (vedi su questo Besutti, -..3).
( Per questa s,lata di lingue, che apre il terzo atto della Ferinda, cfr. D’Onghia (-.((, pp. -.---.1).- Con un’episodica in,ltrazione di pavano quando Succiola recita un epita+o che si immagina composto
per Alberto da un suo creditore padovano : « El fo tanto usurar, tanto poltron / quelù che laghè chive el so’ corbame, / che s’ti tol de sta terra per loame / el nascerà lomè zecche e piaton » (Sc 53) ; si aggiunga l’infal-libile ricetta ciarlatanesca spacciata da Rondone per « uscir di disperatione » : « Recipe brachia tres funarum, postea vade super scalam, et circum circam pone illam ad travem fortiter ligatam ; deinde collum tuum appende et Diabolus invocando mitte te deorsum giù de scala saltando ; che statim statim promitto non potendo illam disperationem de super evacuare, propter viam podicis factum est omnia » (Sc 32).
#:;<==' 6<))# )'$%!# "7>'"# 6' %'7?#$ @#==':=# #$6A<'$' /5nia e l’Abruzzo : la selva in cui si rintana questo Robin Hood barocco è in realtà soprat-tutto linguistica, perché i suoi compagni si esprimono spesso in dialetti o lingue diverse dalla sua, che è un inamidatissimo italiano letterario. Se a ciò si aggiungono le autorità che lo braccano e qualche altra comparsa, si arriva al vertiginoso prospetto degli inter-locutori stampato in LB (. :Lelio bandito, poi nel ,ne TeodosioSo,stico Pedante |Grugnetto |Rondinello |Leoncino |Trivella |Spinello paggetto veneziano |> Tutti banditiTedesco |Sardellino |Serpentello |Zufolotto |Ferrarese |Riniero general di soldati napolitaniLepido suo capitano, poi Orazio GelieriTeo,lo |Sidonio |> Signori di Castel di Sanguine. NapolitaniQuattro altri signori che non parlino |Sandrino carbonaro ,orentinoMarinella tenuta come ,gliuola, poi Florinda sorella di Lelio banditoSilvano pastor napolitanoAltri pastori, che non parlanoTeodoro, poi Doralice ,glia di RinieroVenturino servo di TeodoroNapolella fantesca napolitanaBargello e sbirri del paesePastori armati, per combatter solo nel ,ne
Il totale assomma ad almeno una trentina di personaggi : di questi non parlano italiano So,stico (pedantesco), Spinello (veneziano), il Tedesco (tedesco), il Ferrarese (ferrare-se), Sandrino (,orentino demotico), il pastore Silvano e la fantesca Napolella (napoleta-no), il bargello (siciliano), un capraro che all’inizio dell’atto quinto si rivolge a So,stico in abruzzese e in,ne Venturino, che si ,nge mendicante mantovano (LB 4/) e genti-luomo veneziano (LB 5.). Eppure, come rivela lo stesso prospetto, queste numerose varietà dialettali ed espressive non risultano a8atto distribuite secondo lo schema tipico della Commedia dell’Arte, dato che i personaggi non sono organizzati nella consueta serie di coppie che informano la struttura dei canovacci (due vecchi, due amorosi, due zanni, e così via).( Come si è anticipato, sono invece rare le coloriture alloglotte in sen-so stretto :- non si va infatti oltre i frammenti di francese o tedesco segnalati nelle Due comedie in comedia, nella Ferinda e nel Lelio bandito ; va aggiunto che nella Sultana si tro-vano poche battute in turco (Su /-), che insieme a qualche inserto dialettale rompono il
( Cfr. lo schema in Zorzi ((542/(55., p. (02), e si tenga ben in conto il fatto che il Lelio bandito appartie-ne al genere tragicomico, costituzionalmente contraddistinto da uno spiccato virtuosismo strutturale ed espressivo : cfr. Rousset ((523, pp. 3(-42).
- Così anche nella ‘ridicolosa’ romana : Giovanardi (-.(., p. (.2).
)!"# 6’7$%&'#4.monolinguismo italiano di quella commedia, e che vengono immediatamente troncate da un aspro commento del servo Fegatello : « Se voi altri non parlate in altro linguaggio che in questo scomunicato, non sarete intesi ».(
Sarà utile a questo punto fare qualche assaggio su alcune delle varietà dialettali cui Andreini si mostra più a8ezionato : indicazioni interessanti si possono ricavare – anche per la diversità della stilizzazione – dal trattamento riservato a veneziano, bolognese e ,orentino popolare (al bergamasco, che ,gura con larghezza solo nella Ferinda, An-dreini si mostra invece meno interessato, e ugualmente de,lata è la posizione del na-poletano, che s’incontra solo di rado). Un ruolo di primo piano lo tiene senz’altro, per l’impegno mimetico profuso, la riproduzione del veneziano : si prenda ad esempio la prima scena della Venetiana (Ve ((-(-) :[(] C7"#)'$ : Signor Stefanelo ? Maschere, maschere an ?[-] S=<C#$<)7 : Avé-u sentìo, signor Cocalin, quel bagordo carnevalesco che criava « Maschere,
maschere » ? Avé-u sentìo quei zimbani ? quele gnacare ? quele campanele ? quele pive sordine ? Oh che spassi, oh che solazzi !
[1] C7"#)'$ : Ho sentìo pur massa, e sì gongolo tuto. E’ ve saludo, signor Zaneto ![0] Z#$<=7 : Vostro, signor Cocalin ! El s’ha pur dao licentia de far Carneval ![3] OA:<=# : Signora Belina ve baso la man per mile volte, colona : averemo pur de i solazzi. Ohi-
mè, quando sarò-io in maschera ?[/] B<)'$# : Oh, cara signora Orseta, anca mi me destruzo in pensarlo ![4] V<$<='#$# : Cape ! La dona xè come ’l sparavier : co’ la sente a scorlar i sonagi la bulega tuta.
Avé sentìo quei zimbani e soni, e però sé tute aliegre e trepetizotole ! Vostra per traverso, si-gnor Pachiera ! Eh, no respondé ? Ah can, ah crudelazzo, ah salvadesina da lazzo !
[2] S=<C#$<)7 : Oh bon, oh bon. Eh eh eh ! Pachiera, in cervelo, no andar miga in barca, che la scrizza così un giozeto con ti.
[5] P#"&'<A# : Cape ! Oh, l’ha dito ben : va’, che per la toa fadiga ti meriti de sorbir do vuovi de capon.
[(.] V<$<='#$# : Ti è cusì doto ? L’è pecao che la forca no deventa una stagiera per pesarte, e saver quanto val la to dotrina.
[((] S=<C#$<)7 : Eh eh eh ![(-] C7"#)'$ : Eh eh eh ! Ohimei, ohimei, custìa me fa crepar da rider : di’ pur via, ch’el xè da
carneval ![(1] P#"&'<A# : Sì sì, di’ pur via, mustazzo da romper un esercito de polmoni ![(0] C7"#)'$ : Daghela, daghela Venetiana ! Mo via, che stas-tu a far ?[(3] Z#$<=7 : Mo cari signori, mi no credo che se possa aldir più bel carneval de questo certissi-
mo. Mo cito, e’ vedo vegnir maschere.[(/] S=<C#$<)7 : Sì, le vedé-u ? Certo, giubilo tuto ![(4] Z#$<=7 : E’ le vedo senz’altro, e sì le vien per sto canal.[(2] B<)'$# : Oh signora Orseta, aliegramente ![(5] OA:<=# : Signora, mi son tuta alegrezza !
( Le battute turche della Sultana sono riportate ma non tradotte in Perocco (-.(., p. -2-) ; ecco lo scambio come si legge sulla stampa principe : « Nudrice : “Aahali.” Sultana : “Ne ister se Sultanum.” Nudrice : “Ben, seni satar.” Sultana : “Ne, ister se hala.” Nudrice : “Alla hatala vlè ister” ». Il signi,cato è grossomodo il se-guente : « Nutrice : “Ahimè.” Sultana : “Cosa vuoi signora ?” Nutrice : “Io ti voglio vendere.” Sultana : “Come vuole Allah.” Nutrice : “Va bene, come vuole Allah” » (ringrazio di cuore Kaan Ozbek, che ha tradotto per me questo segmento turco). Quanto ai dialetti che s’incontrano nella Turca si tratta del bolognese di Fla-minio (Su ((2) e del napoletano dei birri (Su (14) ; va poi segnalato che la protagonista, pur perfettamente italofona, imita a un certo punto l’italiano approssimativo parlato dai turchi (Su 0.-03) : gli ingredienti fon-damentali sono quelli che si trovano spesso anche nel linguaggio comico di gitani e tedeschi, ossia l’impiego indistinto dell’in,nito, l’uso di mi e ti soggetto e di no ‘non’ (ad es. 01 : « Sì signor, borsa turchesca star larga ; insomma mi no sol darte questo, ma altre cose de mazor stima se ti torme con ti. E perché ti no sospetti mi dirte el tutto » ; vedi anche Perocco, -.(., p. -2-).
#:;<==' 6<))# )'$%!# "7>'"# 6' %'7?#$ @#==':=# #$6A<'$' 4([-.] C7"#)'$ : Aldì, aldì i soni ! Criemo anca nu tutti : Viva viva Carneval ![-(] S=<C#$<)7 : Viva Carneval ! Viva Carneval ! Viva viva ! Oh, quante barche, oh quante gondole
in,orae e infrascae de laurani, de olivi, e de riose e zensamini, e de moschete. No par mo nel cuor de l’inverno, che semo da primavera, tanto sti ,ori someia al natural.
[--] V<$<='#$# : Capuzzi, le xè ben bele ![-1] P#"&'<A# : Has-tu, Venetiana, ochià quei dol,ni co’ i xè politi ?[-0] C7"#)'$ : Tasi zò là, piegora ! Varda che le xè zonte.
Si tratta di un veneziano grammaticalmente molto curato : vanno registrati in tal senso il dittongo di riose -(, le forme del participio dao 0, pecao (. (accanto a ochià -1, secondo un’alternanza normale) e in!orae -(, infrascae -(, la costanza dell’apocope della vocale ,nale negli in,niti (sorbir 5, crepar (-, rider (-, romper (1, vegnir (3) ; l’esito di #!- in aldir (3 e aldì -. bis, l’esito di )E in someia -(, la regolarità di sonorizzazioni e fricatizzazioni (sa-ludo 1, bulega 4, salvadesina 4, miga 2, fadiga 5, saver (., piegora -0 ; zimbani - e 4, destruzo /, crudelazzo 4, lazzo 4, mustazzo (1, zensamini -(, capuzzi --, zò -0, zonte -0 contro l’isolato giubilo (/), la metatesi di scorlar 4 e scrizza 2 e altri esiti caratterizzanti come quelli pre-senti in giozeto 2 e vuovi ‘uova’ 5. Si notino inoltre il pronome e’ (1, (3, (/ ; in opposizione ad a’ padovano, bolognese e di altre zone dell’Italia settentrionale), xè esclusivo (4, (-, --, -1, -0), le forme verbali interrogative con enclisi del pronome sarò-io 3, avé-u - bis, vedé-u (/ e stas-tu (0 e has-tu -1 con la conservazione di –s desinenziale protetto da pro-nome enclitico, la resa sintatticamente fedele di « la sente a scorlar » 4 con a introduttore d’in,nito dipendente da verbo percettivo.(
Una simile abilità mimetica non è che il segno d’una tecnica teatrale più ra+nata della media, grazie alla quale Andreini dà corpo a dialoghi rapidi e vivaci nei quali il dialetto è ben connotato su livelli diversi anche sotto il pro,lo lessicale : al piano nobile di questo edi,cio stanno, nel nostro campione, le battute in veneziano civile attribuite alle fanciulle da marito Belina e Orseta, punteggiate di complimenti e scarsamente in-clini a un’espressività che vada oltre la menzione di maschere e solazzi (« ve baso le man per mile volte, colona » 3, « cara signora Orseta » /, « oh signora Orseta, aliegramente » (2) ; nell’ammezzato abitano le battute più colorite dei vecchi Cocalin e Stefanelo, che danno voce a una realtà meno stilizzata (zimbani, gnàcare e campanele), e che si aprono a qualche espressione popolare o a qualche epiteto di rimprovero (« in cervelo » (2, « no andar miga in barca » ‘non arrabbiarti’ (2, piegora -0) ; al piano terra sta in,ne il vene-ziano plebeo e costituzionalmente incline al doppiosenso della Venetiana e di Pachiera (sonagi ‘testicoli’ 4, bulega ‘ribolle’ 4, trepetizotole ‘giocherellone’ 4, « salvadesina da lazzo »
( Per la descrizione del veneziano mi servo di Stussi ((553-(554/-..3), Ferguson (-..4) e Tomasin (-.(.). Di séguito qualche rinvio sui fenomeni richiamati : per il dittongo io cfr. Stussi ((553-(554/-..3, p. /3 e nota 2.) con bibliogra,a precedente, Ferguson (-..4, pp. 25-5.), con considerazioni circa la vitalità dell’esito soprattutto in epoca cinque- e seicentesca, e Tomasin (-.(., pp. 22-25) ; per le forme del participio passato cfr. Stussi ((553-(554/-..3, p. /4) anche per l’ammessa alternanza tra i tipi dao e dà nonché Cortelazzo ((521, p. 143) e Tomasin (-.(., p. 5.) a proposito del loro valore di blasone del veneziano ; per l’apocope della vocale ,nale negli in,niti cfr. Stussi ((553-(554/-..3, pp. //-/4) ; per forme come aldir, che derivano da una sovrapposizione con gli esiti di #) + dentale, cfr. Stussi ((553-(554/-..3, p. /2) ; per l’esito di )E cfr. Stussi ((553-(554/-..3, p. 4.) ; per sonorizzazioni e fricatizzazioni cfr. Stussi ((553-(554/-..3, pp. /2-4.) e Ferguson (-..4, pp. 53-52 e (.--(.0) ; per la di8usione di processi metatetici soprattutto nella fase di quello che egli chiama « Middle Venetian » ((3..-(2..) cfr. Ferguson (-..4, p. (.3) ; per giozo, probabilmente dovuto ad ana-logia con %)!=='A<, e vuovo vedi D’Onghia (-.(., p. -.5 nota) e Cortelazzo (-..4, p. (3..) ; per e’ pronome atono di prima persona cfr. Ferguson (-..4, pp. (10-(13) e Tomasin (-.(., p. 25) ; per xè cfr. Ferguson (-..4, pp. (3(-(3-), che documenta l’espansione della forma ai danni di è soprattutto dal Cinquecento in poi ; per la conservazione di –s in voci interrogative di '' pers. cfr. Stussi ((553-(554/-..3, pp. 4--41) ; per a introduttore di in,nito dipendente dai verbi percettivi, tratto di8uso in vari dialetti settentrionali, cfr. D’Onghia (-../, p. (54 e nota 32).
)!"# 6’7$%&'#4-lett. ‘selvaggina da laccio’ e dunque ‘pendaglio da forca’ 4, « vuovi de capon » ‘uovi di cappone’ 5, « mustazzo da romper un esercito de polmoni » ‘buona a nulla’ (1, capuzzi ‘cavoli’ --).(
Le cose vanno molto diversamente per il bolognese : quel che importa in questo caso ad Andreini non è una riproduzione linguistica con intenzioni di sia pur stilizzata fedel-tà, quanto piuttosto lo sfruttamento dei truismi, delle farciture latine e degli strafalcioni tradizionalmente associati alla loquela del Dottore.- Si prendano ad esempio due passi dalla Campanaccia, il primo ad apertura di commedia, il secondo a poca distanza, quan-do il protagonista conciona sul catarro di Trifonio (Ca 0-3, /-2) :[(] TA'C7$'7 : Carissimo signor Dottor, el dise el proverbio de nu altri da la Gondola da i dol,ni
d’arzento, zoè chi tardi arriva mal aloza.[-] C#>;#$#""'7 : Signor no, vu mentì per la gola onestament. Al dis, el proverbi, chi tard arriva
dorm in loza, perché l’è piene tutte le camere. Ma lassand le bagatelle, e vegnand alle minchio-narie, che vol dir che l’è tri dì che no v’ho vist ? E’ savì pur ch’a’ son voster zener in promessa, scilicet in potenzia, videlicet spos, che non ha ancor consumà, nempe un marì senza moier benché l’appa.
[1] TA'C7$'7 : Signor Campanazzo...[0] C#>;#$#""'7 : I mie’ titol, signor ![3] TA'C7$'7 : Quai è-i ?[/] C#>;#$#""'7 : E no ’l savì ?[4] TA'C7$'7 : Signor no.[2] C#>;#$#""'7 : Oh, al bisogna dirme : « Eccellentissimo Signor Dottor Grazian Campanaz da
Budri, Dottor in utriusque, id est Dottor ante, et post usque ad imum, zoè de sott e de sovra, da press e da luntan ». E tant son Dottor al chiar, quanto al scur, tant el dì da lavor quant la festa, Dottor a cena e a desenar, Dottor de dì e de not, d’invern e d’estad, vestì e desvestì, dor-mend e veiand, per acqua e per terra, de drit e de rovers, de piatt e de ,l, de punta e de tai, per pas e per guerra ; Dottor in pales e in nascos, in casa e in strada, al nuvol e al seren, denter e fuora, e pien e vuod, e san e malà, e ridend e pianzend, e sonand e cantand e balland e saltand, e se vuoi e se no vuoi ; insomma son Dottor per amor e per forza, con i e8ett e con i defett. Un’altra volta desime i mie’ titol, se volì che ve responda.
[5] TA'C7$'7 : Signor zenero caro, sto vostro nome con sto retornelo xè massa longo [...]
*
[(] C#>;#$#""'7 : I catar, signor Pantalon [sic], i s’inzeneran intel stomegh e intela testa, perché un è cald e l’alter è fred, sti cald e sti fred tra de lor i viegnen a inzenerar delle gozze d’acqua, le qual viegnen a cascar in qualibet parte corporis e zeneran el catar ; com sarav a dir, signor : se le se ferman intela testa, le ve causan un malum dolori,cum in dimidia parte capitis, nunc a destra, nunc a sinistra ortum ; se le pian la strada e che le cascan inti occhi le ve causan le
( Allego qualche rinvio relativo ai lemmi di signi,cato meno ovvio : per andar in barca ‘arrabbiarsi’ vedi le altre occorrenze andreiniane in D’Onghia (-.((, p. -.0, s.v. barca), cui va aggiunta quella in DC 03 (« I se dise vilania, e sì i no va miga in barca ») ; per gli equivoci sonagi cfr. l’o8ensivo sonai da sparavier ‘coglione’ usato dal bergamasco Bagattino ne L’amico tradito di Pier Maria Cecchini (Molinari / Guardenti, (555, p. 31/) ; tre-petizotole, privo di riscontri, va ricondotto a trepar ‘scherzare’ registrato ad es. in Cortelazzo (-..4, p. (0-() ; i vuovi de capon, inesistenti in natura, potrebbero veicolare un’altra allusione ai testicoli (dato che anche vuovi duri ‘uova sode’ ha lo stesso signi,cato genitale : D’Onghia, -../, p. 35) ; meno chiaro « mustazzo da romper un esercito de polmoni », dove polmoni potrebbe avere il valore traslato di ‘fanfaroni’ (come polmunazo in Vescovo, (550, p. (4-), e dunque l’intero epiteto verrebbe a signi,care qualcosa come ‘buona a nulla’ ; per capuzzi lett. ‘cavoli cappucci’ usato come esclamazione cfr. Cortelazzo (-..4, p. -5. ; per la vicenda della parola vedi Tomasin, -..5).
- Già Spezzani ((54./(554, p. (0/) ha osservato che nella maschera del Dottore « ,n dalle origini la com-ponente parodica medico-giuridica è più importante dell’ambientazione dialettale ».
#:;<==' 6<))# )'$%!# "7>'"# 6' %'7?#$ @#==':=# #$6A<'$' 41cataratte ; se le partin da i uocch e le ve cascan intele orecchie, le ve causan una sordità ; over se le ve cascan inti dient, le ve guastan i dient. Avì mai vist quand piov signor ? L’acqua la dà prima su i cup che la no fa in terra, quell’acqua manda zò quelle grondal, le grondal sbusen i sassi, non per una volta cascand, quia avém la sententia : gutta cavat lapidem, non bis, sed saepe cadendo. Tal fa quest’e8et el catar cascand in su i dient. Se el ve casca mo inti cordun del col, el ve incorda [iucorda stampa] el col, e se ’l partirà da sti cordun, el ve casca intela paletta della spalla, e ve causa una ehebis, ditta cusì da Avicena in lengua arabica ; dalla paletta el ve casca in sul pett e ve causa un’asma, d’intel stomeg el ve casca intel corp, cioè in quel budel ch’ha grand intrada, e non ha ussida, e ve causa un dolor colico ; da sto budel el ve casca qui in quest osso dit sìo da i notomist e ve causa una siatica, da quest’osso el ve casca intel zenocchio e ve causa una giunagra, dal zenocchio el va intel piè e ve causa una podagra, dal piè el va intele dide e ve causa la gotta, perché omnis gutta cadit a cerebro, dalle dide el va intel scappin, d’intel scappin in la calzetta, d’in la calzetta in le scarpe, e se la scarpa è rotta la va a far i fat suo’, sì che e’ sì guarì.
[-] TA'C7$'7 : Adesso che son varìo andemo al palazzo a far el scritto.
La caratterizzazione espressiva del Dottore passa soprattutto attraverso elementi non strettamente grammaticali : frasi strampalate perché ossimoriche (« vu mentì per la gola onestament », « lassand le bagatelle e vegnand alle minchionarie »), sconclusionati frain-tendimenti (« chi tard ariva dorm in loza, perché l’è piene tutte le camere »), bu8onesche enumerazioni come quelle che scandiscono la battuta sui titoli (« de sotto e de sovra, da press e da luntan [...] »). Nella diagnosi sul catarro si notano invece l’insistenza sul latino sgangherato (« malum dolori,cum in dimidia parte capitis », « gutta cavat lapidem, non bis sed saepe cadendo », etc.) e una certa propensione al lessico tecnico (vedi ad esempio cordun, incordare, paletta della spalla, sio, siatica).( Conducendo uno spoglio della parte di Campanaccio si cava in e8etti poco di strettamente bolognese :- accanto a tratti pan-settentrionali come la sonorizzazione delle consonanti sorde intervocaliche o l’este-sa caduta delle vocali ,nali, si possono notare la larga di8usione di un vero e proprio ‘su+sso-bandiera’ come –az (vestazze A-r, Campanaz passim, collanazza A-v, mustaz 04 e mustazzon ((, -3, Menegaz ((, !losofaz (0, bellonaz 10, letterazza 3-, poveraz 34) ; la riduzione di –io ,nale a –i (che caratterizza anche altre varietà settentrionali) in proverbi 0, Budri 0, servizi /, vizi -/ bis, giudizi -/ bis, Trifoni ‘Trifonio’ 10 ; l’impiego di forme con innal-zamento o dittongamento promossi da metafonesi come tri ‘tre’ 0, cup ‘coppi’ 4, cordun ‘cordoni’ 4, tus ‘tosi’ ((, 3-, morus ‘morosi’ (0, e uocch / (plur., ma poco prima occhi), dient 4 ter, bardassuò (( (plur.), biè A-r, (- (plur.), elemient -/ bis (plur.) fradiè A-v (plur.) ; l’uso del non anafonetico lengua (4, contro punta 3) ; l’impiego dei clitici di prima e terza persona a’ 0, 3 e passim e al 0, 3 e passim, e soprattutto le forme happa ‘abbia’ 0, sippa
( Per cordun lett. ‘cordoni’, ossia ‘legamenti’, cfr. ad es. Altieri Biagi ((54., p. /5) ; per il signi,cato di incor-dare è utile l’illustrazione di incordamento data in Boerio ((23/, p. 114) : « incordatura, raggricchiamento del collo, sorta di malattia » ; per paletta della spalla ‘scapola’ cfr. Boerio ((23/, p. 030) e i rinvii presso D’Onghia (-.(., p. -(/) ; sìo ‘ischio’ (%6)' ?''' 34-) risente foneticamente di siatica : cfr. schia e sia ‘ischio’ in Aprile (-..(, p. /5). Ancora senza riscontri convincenti – beninteso per chi scrive – sono la ehebis addebitata ad Avicenna e la giunagra : quest’ultima potrebbe essere il corrispettivo riferito al ginocchio della podagra che segue ; quan-to a ehebis ci si può chiedere con prudenza se non sia da connettere alle voci arabe con base hbs che indicano nel lessico di Avicenna costrizione o ritenzione (dunque una ristagnazione del catarro in corrispondenza della scapola ?) : cfr. Van Riet ((525, p. (.5 n° ((4).
- Mancando studi sistematici sul bolognese, mi servo per qualche riscontro dei risultati dello spoglio condotto su un’operetta bolognese di Giulio Cesare Croce stampata nel (35-, i Chiacchiaramenti, viluppi, in-trichi, travagli et cridalesmi fatti nel sbaragliamento, ovvero mutare massaritie che si fa in Bologna il mese di Ma"io, il giorno di San Michele (mi servo dell’ed. in Chia / Fava, -..5, pp. /4-(.5, che ho collazionato a scopo di veri,ca con l’esemplare della princeps custodito alla British Library con segnatura ((0-/ c -().
)!"# 6’7$%&'#40‘sia’ A-r, A0r, (., (-, (1, -/, 0/, sippadi ‘siate’ (-, (1 (sippa anche in AS (2., -.0). Un tratto di fedeltà al bolognese che risulta contrastivo rispetto al veneziano (l’altro dialetto in scena nella Campanaccia) può essere indicato in,ne nell’enclitico di prima persona –ia che si nota nelle voci verbali verbi interrogative (« ve faroia [...] ? » /, « non hoia dit [...] ? » 13, « che v’hoia dit [...] ? » 02, « Che t’hoia dit [...] ? » 02, « che sentia [...] ? » 3-).( La lingua del Dottore appare ancor più stinta sotto il pro,lo lessicale, dato che i lemmi bolognesi a sua disposizione sono poco meno d’una manciata : l’esclamazione « Potta de Zuda » 13, 1/ (anche in AS (2., (2- e DC /0, (..), baciocch ‘sempliciotto’ 15, la locuzione « s’a’ ’l so » ‘no’ 04, fanesinin ‘fanciullino’ 31.-
Ben maggiore è la cura tributata alla riproduzione del ,orentino demotico, come mostra uno spoglio delle battute di Succiola limitato con pochi scon,namenti al primo atto dello Schiavetto.1 Sul piano gra,co vanno segnalati cascio ((, bascio (/, ribascio (/ (ma bacio 0() e infrascidire 0(, dove la scrizione sc intende riprodurre la pronuncia e8ettiva delle voci.0 Dal punto di vista fonetico spiccano il largo ricorso all’epitesi (cosie ((, daroe (-, faroe (-, (1, piue (1, (0, 43, orsue (/, -2, 11, quie -2, 50, diroe -4, -2, sie ‘sì’ -2, renderoe 1-, anderoe 0(, chiuderoe /( ; mene (-, (/ bis, /., 5/, ohimene (0 bis) e le numerose forme con palatalizzazione di l preconsonantica (caido caido ((, ascoita (-, manigoido (-, aibergo (-, -2, aibergar (-, aitra (0, (3, 1/, /- aitro (3, -5, 40 aitri -4 bis, -5, 14, voita (3, soivere ‘asciol-vere’ (3, -4, Aiberto -2 bis, 1., 1(, 1-, 1/, 12, 15 bis, 0( bis, aicuno 53, aicuna 1(, moit’oro -2, moita -2, moito 43, 53 bis ; nonché in fonetica di frase bei colpo /-) ;3 altro fenomeno piuttosto di8uso è l’anticipo di i in parola dotta che si nota in disgraizia (-, graizia (3, di graizia -4, 40 (ma di grazia (/, -/) ;/ pur contando su una documentazione generalmente meno larga sono attestati anche l’evoluzione popolare e rusticale di skj- a stj- in stiavi 50, stiavetto (1/, la prostesi di i- in iscema 5/, islargatevi (-4, istate ‘state’ (-2, ispenderebbe (13, l’evoluzione popolare e rusticale di %) intervocalico in ve"hia (1/, cui nel ,orenti-no civile s’oppone il tipo veglia a partire dal Cinquecento, la confusione tra forme che continuano #! e quelle che continuano #) + dentale testimoniata da lalde -2, il suono di transizione -g- in pagoni -4.4 Dal punto di vista morfologico vanno notati almeno gli
( Per la riduzione di –io a –i cfr. ad es. miei ‘meglio’ in Croce (Chia / Fava, -..5, p. (.0) ; per le forme me-tafonetiche cfr. Accorsi ((52., pp. )? e )?'') e i plur. cavedun 4- (in opposizione al sing. cavedon 50), bragun 4-, tus 2/, signur 22, bruoz ‘barocci’ 2- in Chia / Fava (-..5) ; per i clitici a’ e al cfr. Chia / Fava (ivi, per es. pp. 40, 4/, 42 e 42, 2., 2-) ; per happa e simili cfr. Spezzani ((54./(554, p. (03 e nota -4) nonché apan ‘abbiamo’, sipa ‘sia’, apa ‘abbia’ in Croce (Chia / Fava, -..5, pp. 2/, 5., 5/ e (.-) ; per l’enclito –ia di ' pers. cfr. in Croce « i fussia pur restà, / ch’aveva là cinquanta comdità ! » e « Ch’in soia mi ? » (Chia / Fava, ivi, pp. 42 e 52).
- « Potta de Zuda », « s’a’ ’l so » e fanesina occorrono anche nel bolognese della Ferinda (D’Onghia, -.((, pp. -./, -.(, -.3) ; per il secondo elemento val la pena di riportare la relativa battuta della Campanaccia, che funziona da glossa : « Signor no in volgar, nani in frances, minime in latin, guarda, absit, s’a’ ’l so ! » (Ca 04) ; per baciocch e fanesinina cfr. Coronedi Berti ((2/5-(240, pp. (14 e 042 s.v. fandsèin ; fansin anche nel bolgonese crocesco : Chia / Fava, -..5, pp. 4- e (.0).
1 Faccio riferimento agli appunti di Altieri Biagi ((5/3/(52., pp. 2--((() e a Poggi Salani ((5/4).0 Si aggiunga mascìa nella citazione dalla Tancia che chiude il primo atto : già Falavolti ((52-, p. 43) ha
rilevato che nell’originale si ha invece macìa, come conferma il riscontro con l’edizione di Fassò ((53/, p. (...).
3 Per il primo tratto vedi Altieri Biagi ((5/3/(52., p. 20) e Poggi Salani ((5/4, p. -03) ; per il secondo Rohlfs ((5//-(5/5, ' § -00) e Poggi Salani ((5/4, p. -0-).
/ Esempi simili mi sembrano da spiegare alla luce della tendenza di iod in iato a passare facilmente in un’altra sillaba (cfr. Rohlfs, (5//-(5/5, ' § 1-4) ; Poggi Salani ((5/4, pp. -0---01) considera invece questa come « i anaptittica ».
4 Per esiti del tipo stiavi cfr. Rohlfs ((5//-(5/5, ' § (5.) e Altieri Biagi ((5/3/(52., p. 21) ; per i- prostetica cfr. Altieri Biagi (ivi, p. 20) ; per gli esiti di %) cfr. Castellani ((530/(52.), Altieri Biagi ((5/3/(52., p. 20), Poggi Salani ((5/4, p. -01) ; lalde è tipo reattivo al passaggio a u di l seguita da dentale : l’esito, proprio della Toscana occidentale, giunge nel Quattrocento a lambire Firenze, dove non mette radici ma propizia forme di rea-
#:;<==' 6<))# )'$%!# "7>'"# 6' %'7?#$ @#==':=# #$6A<'$' 43aggettivi dimostrativi cotesto ((- ter, (1 bis, (0, -2 bis, 1(, 11, 13), cotesta ((-, (0 bis, (3, (/, -2, 10, 15), cotesti ((-, 10), coteste ((0, 1-, 0(), e il pronome cotestui 1( ; gli avverbi di luogo costà (- e colà 1-. Notevoli per il rispetto sintattico sono le forme pronominali ridotte enclitiche in contesti interrogativi o esclamativi : « o che domine, buacci, volete vo voi ? » (- (dove si nota anche sequenza di forma atona e forma tonica), « che domine avete vo nel gozzo ? » 15, « o che non possiate vo morto meno infracidire ! » 0(, « Oh, a quell’otte stestù a manucare » (-.(
Ancor più corposa è la caratterizzazione lessicale, per la quale è su+ciente fornire pochi esempi :- nella parte di Succiola si incontrano forme come ch’i’ vada ancaione ‘che io vada zoppicando’ 40, anticuore ‘tumore’ /., (//, bassotti ‘lasagne’ -4, chiotti ‘mogi’ (-2, ciuciurlaia ‘bu8onata’ (0, frugoni ‘colpi’ (3 (anche in LB 35, 41), gobbo ‘carciofo’ -4, gozzaia ‘risentimento’ (-2, dar nel lecco ‘centrare il bersaglio’ /-, manucare (-, vin mu%aticcio ‘vino che sa di mu8a’ (1, musoni ‘colpi’ (3 (anche LB 41), otta ‘ora’ ((, (-, -4, -2, peducci ‘zampe di montone o di porco’ -4, per!dioso -2, alla sbardellata ‘esageratamente’ ((, /. sfondolare ‘sprofondare’ -5 e così via.1
La risentita personalità di Succiola – che può a8ermare senza tema di smentita di avere « la lingua arruotata di fresco » (/() – ha un’ulteriore e insistente manifestazione nella serie di « scomunicati proverbi » (/-) che ne costellano le battute. Questa robusta componente paremiologica emerge però solo nell’edizione dello Schiavetto datata (/-. : nessuno dei proverbi allegati di séguito si trovavano infatti nella stampa principe del (/(- (edita in Falavolti, (52-). Che la commedia fosse stata sottoposta a una revisione stilistica risulta anche da un punto della dedicatoria di Andreini a Girolamo Priuli (,glio del doge Antonio), datata -4 dicembre (/(5 (Sc a-r-v) :Oh, se questo Schiavo in povere vestimenta di semplicissima dicitura tanto fece nel teatro di sé stesso graziosa mostra, che farà poi adornato d’un poco più di miglior locuzione ? Così conver-tendo il suo remo in penna, il suo mare in inchiostro e la sua trireme in un libro manuscritto,
zione come appunto lalda, altorità e simili (Castellani, -..., pp. -52--55) ; per pagoni cfr. Rohlfs ((5//-(5/5, ' § 115), Altieri Biagi ((5/3/(52., p. 21), Poggi Salani ((5/4, p. -0/).
( Per il tipo stestù cfr. Zuliani (-..4).- Rinvio sistematicamente a Crusca ((/(-), ricorrendo anche a Poggi Salani ((5/5) e più di rado all’edizio-
ne commentata del Malmantile. Per la Crusca mi servo dell’edizione in linea curata da Mirella Sessa (http ://vocabolario.signum.sns.it), e mi limito perciò a segnalare la voce sotto cui sono raccolti i materiali volta a volta richiamati.
1 Di séguito qualche rinvio per le voci ricordate : per ancaione cfr. Crusca ((/(-) ad v. anca ; per anticuore cfr. Crusca ((/(-) ad v. ; per bassotti cfr. Crusca ((/(-) ad v. lasagne (« Lasagne maritate, crediamo, che voglia dire quelle, che noi chiamamo bassotti, che si cuocono nella tegghia, con peverada di carne, e si ruosolano ») ; per chiotto cfr. Crusca ((/(-) ad v. cheto e Poggi Salani ((5/5, pp. 01-00) ; per ciuciurlaia tacciono i dizionari sto-rici e i dizionari d’impianto toscano, ma vedi Malagoli ((515, p. (.() ad v. ciuciurlata, con rinvii al viareggino e al livornese ; per frugoni cfr. Crusca ((/(-) ad v. frugare ; per gobbi cfr. Crusca ((/(-) ad v. (« E gobbo diciamo alla pianta del carciofo ricoricata ») ; per gozzaia cfr. Crusca ((/(-) ad v. (« raunamento di materia fatta nel gozzo, ma il metaforico ha tolto il luogo quasi del proprio, e vale sdegno ») ; per lecco cfr. Crusca ((/(-) ad v. leccare (« E Lecco sust. diciamo al segno al quale, in giucando alle pallottole, o alle piastrelle, o morelle, cia-scuno cerca d’avvicinarsi il più ch’e’ può, con quella cosa, ch’e’ tira ») ; per manucare cfr. Poggi Salani ((5/5, pp. 43-44) ; per mu%aticcio cfr. Crusca ((/(-) ad v. mu%are ; per musone cfr. Crusca ((/(-) ad v. ingo%are (« Ingo8o [...] vale picchiata, come musone, rugiolone, grifone, punzone o colpi simili ») ; per otta cfr. Poggi Salani ((5/5, pp. (.1-(.0) ; per peducci cfr. Crusca ((/(-) ad v. piede (« e da piede peduccio, che è tutta quella parte dal ginocchio in giù del montone, e del porco, la quale non si dice peduccio, se non ispiccata dall’animale ») ; per per!dioso cfr. Crusca ((/(-) ad v. per!dia (e si noti l’analogo superbioso ancora nel ,orentino vivo dello Zannoni : Bencistà, -..., pp. /3 e 41) ; per alla sbardellata cfr. Crusca ((/(-) ad v. sfolgorato ‘immoderato’ (« fece sfolgorate spese nella detta brigata spendereccia : diremmo anche disorbitanti, e in modo basso, sbardellate »), nonché Malmantile (I, p. 01) ; per sfondolare cfr. Crusca ((/(-) ad v. e Poggi Salani ((5/5, p. (34).
)!"# 6’7$%&'#4/il feci scorrer per l’Egeo de’ letterati, accioché mi dicessero s’egli era bastante per resistere agli assalti de’ pirati malevoli, e fatto sicuro al,ne da mordaci incursioni, alle stampe il diedi.
Una collazione tra la stampa del (/(- e quella del (/-. rivela in e8etti numerosi interven-ti, e anche lo scialo di proverbi attribuito a Succiola deve essere ritenuto funzionale al raggiungimento della « miglior locuzione » pubblicizzata nella dedicatoria : in tal senso è signi,cativo che quasi tutti i modi di dire in questione trovino riscontro nel primo Vo-cabolario degli Accademici della Crusca, apparso nel gennaio del (/(- e da subito al centro di un intenso dibattito.( Non si tratta certo di una coincidenza, e lo dimostra il fatto che Succiola illustra i proverbi con parole talvolta identiche a quelle impiegate dagli accade-mici, e le capita persino di impiegare uno dopo l’altro due o tre motti schedati sotto la stessa voce a distanza ravvicinata anche dal Vocabolario ; non manca neppure – in bocca all’interlocutore Belisario – il ripescaggio della formula latina con cui la Crusca glossa parecchi modi di dire. Ma ecco gli esempi (alla battute di Succiola segue il riscontro sulla Crusca) :
diciamo no’ aitri da Firenze che non si può aver il mel senza mosche, cioè non si può aver il ben se non con fastidio » (-5) ; cfr Crusca ((/(-) ad v. mosca : « E’ non si può avere il mele senza le mosche, e vale, ch’e’ non si può acquistar cosa veruna, senza di+cultà, e fatica Non vi ricordate di quel motto che dice : tanto va la capra zoppa che nel lupo s’intoppa ? Cioè chi seguita di far male ,nalmente trova il gastigo ? » (13) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. capra : « Vassi capra zoppa se lupo non la ’ntoppa. È proverbio, e vale, che si seguita di far male, in,n che non si dà nel gasti-go Arricordatevi che mentre il can piscia la lepre se ne va : questo si dice in proverbio di colui che perde l’occasione » (1/) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. cane : « Mentre che ’l can piscia la lepre se ne va : cioè, chi non sollecita quando e’ può, perde l’occasione Succiola : “Al cane che invecchia la volpe gli piscia addosso.” Rampino : “Che vuol inferire ?” Succiola : “Vuol dire la poca stima che si fa dell’uomo a cui mancano le forze” » (1/-14) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. cane : « Al cane che invecchia la volpe gli piscia addosso, che è : come mancano le forze, l’uomo non è stimato
« il proverbio non erra : can che non abbaia morde » ((1.) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. cane : « Can che morde non abbaia invano Non è allegrezza di pan caido, che dura poco » ((1.) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. pane : « Allegrezza di pan caldo, si dice d’allegrezza che dura poco Sa’ tu quello che diciam no’ aitri quando la cosa è a perfezzione ? Pan d’un dì e vin d’un anno » ((1() ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. pane : « Pan d’un dì, e vin d’un anno, denotando e’ termini ne’ quali e’ sono più perfetti Chi fa l’altrui mestiere / fa zuppa nel paniere » ((1/) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. zuppa : « Diciamo in proverbio : Chi fa l’altrui mestiere, fa la zuppa nel paniere : cioè chi si mette a far quel ch’e’ non sa, getta via la fatica e ’l tempo », e vedi anche Malmantile (I,
Orsue, seguitiam co’ motti : buon pavero è cattivo oca, cioè chi fu buon in gioventù è tristo da vecchio » ((1/) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. papero : « Buon papero, e cattiva oca, e vale buon da giovane e tristo da vecchio Il can rode l’osso perché non lo pò ingoiare » ((//) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. cane : « Il can rode l’osso, perch’e’ non lo può inghiottire, cioè non fare per non po-tere Succiola : “[...] sì che non vi posso alloggiare, perché son dietro a far la campana d’un pezzo.” Belisario : “Che volete inferire con questa [...] ?” Succiola : “Far la campana d’un pezzo : s’intende ,nir un negozio senza intermetterlo, però che la campana che non è fatta d’un pezzo non può aver buon suono” » ((/4) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. campana : « Far la campana d’un pezzo : che è ,nire un suo fatto senza intermissione, detto così, perché la campana, che non è fatta d’un pezzo, non può aver buon suono la luna non cura l’abbaiar de’ cani, cioè [...] i grandi non istimano i poveri » ((/4) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. luna : « La luna non cura l’abbiar de’ cani : e vale, che le cose grandi, e di valore, non curan delle piccole, e vili Belisario : “Io pure ho ’l lupo per gli orecchi.” Succiola : “Oh, [...] cotesto è de’ nostri tiri ,orentini ; e vuol dire tener il lupo per gli
( Gli unici due modi dire che non si trovano nella Crusca sono « a gatta vecchia topo tenerello » (32) e « come si vede la lepre è tempo di accannare » ((.-). Sulla prima Crusca vedi l’aggiornato panorama di Ma-razzini (-..5, pp. (-4-(01).
#:;<==' 6<))# )'$%!# "7>'"# 6' %'7?#$ @#==':=# #$6A<'$' 44orecchi : chi ha impresa di+cile a seguitare e pericolosa a tralasciare.” Belisario : “È vero : il latino dice appunto in simil proposito Auribus lupum tenere [...]” » ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. lupo : « tenére il lupo per gli orecchi. Di chi ha per le mani impresa di+cile a seguitare, e pericolosissima a trala-sciare. [...] Lat. auribus tenere lupum Il lupo non caca agnelli dician no’ aitri quando vogliam dire che da cosa trista non nasce cosa buona » ((/5) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. lupo : « Il lupo non caca agnelli, e vale che delle cose triste non nascon le buone è vero il proverbio che dice : a carne di lupo dente di cane, cioè il tristo mettilo alle mani di chi sia peggior di lui » ((25) ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. lupo : « A carne di lupo zanne di cane, cioè : un malvagio metterlo alle mani con un piggiore Non si grida al lupo, che non sia in paese » (-.() ; cfr. Crusca ((/(-) ad v. lupo : « E’ non si grida mai al lupo, ch’e’ non sia in paese ».
Colpisce – se si accetta l’ipotesi prospettata qui – una così massiccia ispirazione voca-bolaristica entro una commedia tanto disinvolta e stravagante da ogni punto di vista ; ma l’immagine di un Andreini intento a compulsare la Crusca del (/(- per aggiorna-re stilisticamente il suo primo successo teatrale conferma una volta di più il carattere nient’a8atto artigianale, ma anzi letterario e persino libresco, delle sue scelte linguisti-che ed espressive.
B '@)'7%A#C'#A""7A:', M#A'# GA#D'# (a cura di) ((52.), Lotto Lotti, Rimedi per la sonn, Bologna, Commissio-
ne per i testi di lingua.A)='<A' B'#%', M#A'#-L!':# ((5/3/(52.), La « riforma » del teatro e una « pulitissima » scuola toscana,
in E#6<>, La lingua in scena, Bologna, Zanichelli, pp. 32-(/(.A)='<A' B'#%', M#A'#-L!':# ((5/5/(52.), Dal comico del « signi!cato » al comico del « signi!cante », in
E#6<>, La lingua in scena, Bologna, Zanichelli, pp. (-34.A)='<A' B'#%', M#A'#-L!':# ((54.), Guglielmo volgare. Studio sul lessico della medicina medioevale,
Bologna, Forni.A;A')<, M#A"<))7 (-..(), La lingua della medicina animale, in Le Parole della Scienza. Scritture tec-
niche e scienti!che in volgare (secoli XIII-XV), a cura di Riccardo Gualdo, Galatina (Le), Congedo Editore, pp. 05-4/.
B<$"':=F, A)<::#$6A7 (a cura di) (-...), Giovan Battista Zannoni, La Crezia rincivilita per la creduta vincita di una quaderna, Firenze, Libreria Chiari.
B<:!==', P#7)# (-..3), Da « L’Arianna » a « La Ferinda » : Giovan Battista Andreini e la « commedia musicale all’improvviso », « Musica Disciplina », B)'B, pp. --4--4/.
B7<A'7, G'!:<;;< ((23/), Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Cecchini.BA#>@'))# A%<$7, FA#$"# (-...), Studi lessicali, a cura di Paolo Bongrani, Franca Magnani e
Domizia Trolli, Bologna, Clueb.C#A#$6'$', S')?'# / M#A'=', L!"'#$7 (-..1), Don Giovanni o l’estrema avventura del teatro. « Il
nuovo risarcito Convitato di Pietra » di Giovan Battista Andreini, Roma, Bulzoni.C#:=<))#$', AAA'%7 ((530/(52.), GL intervocalico in italiano, in I6., Sa"i di linguistica e !lologia
italiana e romanza (&'()-&'*)). Tomo I, Roma, Salerno Editrice, pp. -(1---(.C#:=<))#$', AAA'%7 (-...), Grammatica storica della lingua italiana. I. Introduzione, Bologna, il
Mulino.C&'#, I)#A'# / F#?#, V)#6'>'A (a cura di) (-..5), Giulio Cesare Croce, Opere dialettali e italiane.
Il mondo visto dal basso, Roma, Carocci.C7)<==', V'==7A'7 ((551), Storia dell’italiano letterario. Dalle origini al Novecento, Torino, Einaudi.C7)7>@7, C#A><)# ((5/4), Cultura e tradizione nell’« Adone » di G.B. Marino, Padova, Antenore.C7A7$<6' B<A=', C#A7)'$# ((2/5-(240), Vocabolario bolognese italiano, Bologna, Monti.C7A=<)#DD7, M#$)'7 ((521), Uso, vitalità e espansione del dialetto, in Storia della cultura veneta.
'?/&. Il Seicento, a cura di Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, Vicenza, Pozza, pp. 1/1-145.
C7A=<)#DD7, M#$)'7 (-..4), Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel B?' secolo, Limena (Pd), La Linea.
)!"# 6’7$%&'#42C7DD', G#<=#$7 ((535), Tra un comico-drammaturgo e un pittore del Seicento : Giovan Battista An-
dreini e Domenico Fetti, « Bollettino dell’Istituto di storia della società e dello stato veneziano », ', pp. (51--.3.
Crusca ((/(-), Vocabolario degli Accademici della Crusca, Venezia, Giovanni Alberti.D’A"&'))<, P#7)7 ((55.), Sintassi del parlato e tradizione scritta della lingua italiana, Roma, Bo-
nacci.D#?'"7 B7$'$7, G!'67 / V#DD7)<A, FA#$"7 (-..0), Giovan Battista Andreini, La Centaura,
Genova, il Melangolo-Teatro Stabile di Genova.D<’ A$%<)':, FA#$"<:"#-R7>#$# ((55(), La divina Isabella : vita straordinaria di una donna del
Cinquecento, Firenze, Sansoni.D< C#;A'7, C&'#A# (-.(.), Paraipotassi e « sì » di ripresa. Bilancio degli studi e percorsi di ricerca (&'+'-
+,&,), « Lingua e Stile », B)?, pp. -23-1-2.D’O$%&'#, L!"# (-..5), Il veneziano cinquecentesco alla luce di un nuovo dizionario. Primi appunti,
in Lessico colto, lessico popolare, a cura di Carla Marcato, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. (.(-(1(.
D’O$%&'#, L!"# (a cura di) (-../), Andrea Calmo, Il Saltuzza, Padova, Esedra.D’O$%&'#, L!"# (a cura di) (-.(.), Ruzante, Moschetta, Venezia, Marsilio.D’O$%&'#, L!"# (-.((), recensione a Palmieri (-..2), « Italianistica », B), pp. (54--.4.F#)#?7)=', L#!A# (a cura di) ((52-), Commedie di Comici dell’Arte, Torino, !=<=.F#::G, L!'%' (a cura di) ((53/), Teatro del Seicento, Milano-Napoli, Ricciardi.F<A%!:7$, R7$$'< (-..4), A linguistic history of Venice, Firenze, Olschki.F<AA7$<, S'A7 (a cura di) ((52/), Commedie dell’Arte, Milano, Mursia, due voll.F<AA7$<, S'A7 ((551), Attori mercanti corsari. La Commedia dell’Arte in Europa tra Cinque e Seicento,
Torino, Einaudi.F<AA7$<, S'A7 (a cura di) ((551b), Comici dell’Arte, Corrispondenze. G. B. Andreini, N. Barbieri,
P. M. Cecchini, S. Fiorillo, T. Martinelli, F. Scala, ed. diretta da Siro Ferrone, a cura di Claudia Burattelli, Domenica Landol,, Anna Zinani, Firenze, Le Lettere.
F'#:"&'$', F#@A'D'7 (-..4), « L’incessabil agitazione ». Giovan Battista Andreini tra professione teatra-le, cultura letteraria e religione, Pisa, Giardini.
F7, D#A'7 ((520), Le commedie di Dario Fo. Volume ?', a cura di Franca Rame, Torino, Einaudi.%6)' = Grande dizionario della lingua italiana, a cura di Salvatore Battaglia e di Giorgio Barberi
Squarotti, Torino, !=<=, (5/(--..-.G&'$#::', G&'$7 ((54(), Casi di « paraipotassi relativa » in italiano antico, « Studi di grammatica
italiana », ', pp. 03-/..G&'$#::', G&'$7 ((54/), Incontri tra toscano e volgari settentrionali in epoca rinascimentale, « Archi-
vio glottologico italiano », )B', pp. 2/-(...G'7?#$#A6', C)#!6'7 ((525), « Pedante, arcipedante, pedantissimo ». Note sulla morfologia derivati-
va nella commedia del Cinquecento, « Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di Messina », 4, pp. 3((-31-.
G'7?#$#A6', C)#!6'7 (-.(.), Sulla lingua delle commedie “ridicolose” romane del Seicento, « La lin-gua italiana », VI, pp. (.(-(-(
)<' = Lessico Etimologico Italiano, diretto da Max P,ster e Wolfgang Schweickard, Wiesbaden, Reichert, (545 sgg.
M#'A#, S#)?#=7A< / B7AA#""', A$$#-M'"#<)# (a cura di) ((554), Giovan Battista Andreini, Amor nello specchio, Roma, Bulzoni.
M#)#%7)', G'!:<;;< ((515), Vocabolario pisano, Firenze, Accademia della Crusca.Malmantile = Il malmantile racquistato di Perlone Zipoli [Lorenzo Lippi] colle note di Puccio Lamoni
[Paolo Minucci] e d’altri, Prato, Luigi Vannini, (2(3, quattro voll.M#A#?#)), J7:H A$=7$'7 ((523), La cultura del Barocco. Analisi di una struttura storica, Bologna, il
Mulino [' ed. (543].M#A#DD'$', C)#!6'7 ((551), Storia della lingua italiana. Il secondo Cinquecento e il Seicento, Bolo-
gna, il Mulino.M#A#DD'$', C)#!6'7 (-..5), L’ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani, Bologna, il Mulino.
#:;<==' 6<))# )'$%!# "7>'"# 6' %'7?#$ @#==':=# #$6A<'$' 45N<$"'7$', G'7?#$$' ((54//(521), Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato, in I6., Di scritto e
di parlato. Discorsi linguistici, Bologna, Zanichelli, pp. (-/-(45.P#)>'<A', R7::<))# (a cura di) (-../), Giovan Battista Andreini, La Maddalena lasciva e penitente,
Bari, Palomar.P#)>'<A', R7::<))# (a cura di) (-..2), Giovan Battista Andreini, La Ferinda, Taranto, Lisi.P<A7""7, D#A'# (-.(.), Turchi in commedia : in Italia fra la !ne del Cinquecento e l’inizio del Seicento,
in Sûzi!ât-i mü’ellefe. Contaminazioni e spigolature turcologiche. Scritti in onore di Giampiero Bellin-geri, a cura di Vera Costantini e Matthias Kappler, Crocetta del Montello (Tv), Terra Ferma, pp. -43--20.
P7%%' S#)#$', T<A<:# ((5/4), Motivi e lingua della poesia rusticale toscana. Appunti, « Acme », BB, pp. -11--2/.
P7%%' S#)#$', T<A<:# ((5/5), Il lessico della « Tancia » di Michelangelo Buonarroti il Giovane, Firenze, La Nuova Italia.
P77)<, G7A67$ (a cura di) ((555), Francesca da Rimini, da Napoli. Tre esilaranti farse napoletane dell’Ottocento, Napoli, Filema.
R<@#!6<$%7, M#!A'D'7 ((550), Giovan Battista Andreini tra poetica e drammaturgia, Torino, Ro-senberg & Sellier.
R7&)C:, G<A&#A6 ((5//-(5/5), Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, Einaudi, tre voll.
R7::', F#@'7 ((555), « Non lo sai che ora è ? ». Alcune considerazioni sull’intonazione e sul valore pragma-tico degli enunciati con dislocazione a destra, « Studi di grammatica italiana », (2, pp. (03-(51.
R7!::<=, J<#$ ((523), La littérature de l’âge baroque en France. Circé et le paon, Paris, Corti [' ed. (533].
R!CC'$7, A)<::#$6A# (a cura di) (-..4), Giovan Battista Andreini, L’Adamo, Trento, La Fine-stra.
S$I6<A, J7$ R. (a cura di) (-..5), Giovan Battista Andreini, Love in the Mirror, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies.
S;<DD#$', P'<=A7 ((54./(554), L’« Arte rappresentativa » di Andrea Perrucci e la lingua della commedia dell’arte, in I6., Dalla commedia dell’arte a Goldoni. Studi linguistici, Padova, Esedra, pp. (-(--(/.
S=!::', A)CA<67 ((551), La letteratura in dialetto nel Veneto, in I6<>, Lingua, dialetto e letteratura, Torino, Einaudi, pp. /0-(./.
S=!::', A)CA<67 ((553-(554/-..3), Alfredo S., Medioevo volgare veneziano, in I6<>, Storia linguisti-ca e storia letteraria, Bologna, il Mulino, pp. -1-2..
S=!::', A)CA<67 ((555), I dialetti del Veneto e il teatro, in « Quaderni dell’Istituto Italiano di Cultura di Sãn Paolo », n.s. 2, pp. 4.-2(.
T<::#A', R7@<A=7 (a cura di) ((524), Francesco Andreini, Le Bravure del Capitano Spavento, Pisa, Giardini.
T<:=#, E$A'"7 ((55(), Simulazione di parlato, Firenze, Accademia della Crusca.T7>#:'$, L7A<$D7 (-..5), « Verçe et altre erbe le qual à cavo, ale qual [...] in todesco ven decto cabuç ».
Dieta e medicina nei volgarizzamenti di un « Regimen sanitatis » del secolo B'?, in Storia della lingua e storia della cucina, a cura di Cecilia Robustelli e Giovanna Frosini, Firenze, Cesati, pp. (((-(-..
T7>#:'$, L7A<$D7 (-.(.), Storia linguistica di Venezia, Roma, Carocci.TA'C7$<, P'<=A7 ((550/-...), La lingua della commedia italiana dal Cinquecento al Novecento, in
I6<>, L’italiano a teatro. Dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligra,ci internazionali, pp. 5-(.0.
TA'C7$<, P'<=A7 ((553/-...), Oralità, fantasia verbale, grammelot. Il testo teatrale fra grammatica e pragmatica, in I6<>, L’italiano a teatro. Dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligra,ci internazionali, pp. (.3-(02.
V#$ R'<=, S'>7$< (a cura di) ((525), Avicenna latinus. Liber quartus naturalium de actionibus et pas-sionibus qualitatum primarum, Louvain la Neuve, Peeters-Leiden, Brill.
V<:"7?7, P'<A>#A'7 (a cura di) ((550), Andrea Calmo, Il Travaglia, Padova, Antenore.V<:"7?7, P'<A>#A'7 (-..0), Narciso, Psiche e Marte ‘mestruato’. Una lettura di « Amor nello specchio »
di Giovan Battista Andreini, « Lettere Italiane », 3/, pp. 3.-2..
)!"# 6’7$%&'#2.V<:"7?7, P'<A>#A'7 (c.d.s.), Dario Fo e la (sua in$uenza sulla) commedia dell’arte, « Révue des Étu-
des Italiennes », c.d.s.Z#D7, A)<::#$6A# ((52/), « La Turca » di Giovan Battista Andreini. Un caso di editoria teatrale nel
Seicento, « Quaderni di teatro », ?''', pp. /(-4-.Z7AD', L!67?'"7 ((5/3/(55.) = Giovan Battista Andreini ‘elisabettiano’ in I6., L’attore, la Comme-
dia, il drammaturgo, Torino, Einaudi, pp. (/4-(4(.Z7AD', L!67?'"7 ((542/(55.) = Intorno alla Commedia dell’Arte. I. Sui caratteri originali del fenome-
no, in I6<>, L’attore, la Commedia, il drammaturgo, Torino, Einaudi, pp. (0(-(31.Z!)'#$', L!"# (-..4) = « Vedestu » o « vedestù » ? L’accentazione delle forme allocutive contratte nel to-
scano antico, « Lingua e Stile », B)'', pp. 1-(-.