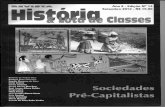Oltre il codice. A proposito di Beyond MIDI. The handbook of musical codes
A proposito della Monarchia. Note in margine al ritrovamento del ms. Additional 6891
Transcript of A proposito della Monarchia. Note in margine al ritrovamento del ms. Additional 6891
41, Nuova Serie
gennaio-giugno 2013anno LIII
L’ALIGHIERIRassegna dantesca
fondata da Luigi Pietrobonoe diretta da Andrea Battistini, Saverio Bellomo, Giuseppe Ledda
SAGGI
Robert Hollander 5 Dante’s Nine Invocations RevisitedEnrico Rebuffat 33 «Luogo è in inferno detto Malebolge»:
una ricerca di topografia dantesca LECTURAE DANTIS
George Corbett and Heather Webb 63 Three Paths in One Journey. A Vertical Reading
of Inf. I, Purg. I, Par. ILuca Marcozzi 83 Dante, la paura e il dolore: lettura di Inferno XVI
NOTE
Gian Paolo Renello 115 A proposito della Monarchia. Note in margine al ritrovamento del ms. Additional 6891
RECENSIONI
Nicolò Maldina 157 Rec. a «Nuova Rivista di Letteratura Italiana», XIII/1-2 (2010): Saggi danteschi per Alfredo Stussi a cinquant’anni dalla sua laurea
Giuseppe Ledda 160 Rec. a Lectura Dantis 2002-2009. Omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settanta anni
Federica Barcaglioni 163 Rec. a Emilio Pasquini e Carlo Galli, Lectura Dantis Bononiensis, vol. 2
Silvia Tranfaglia 167 Rec. a Grupo Tenzone, Amor che movi tua vertù dal cieloPietro Bocchia 168 Rec. a Sergio Cristaldi, La profezia imperfetta.
Il Veltro e l’escatologia medievaleElena Gurioli 171 Rec. a Edoardo Fumagalli, Il giusto Enea e il pio Rifeo.
Pagine dantesche
DirezioneAndrea Battistini, Saverio Bellomo, Giuseppe Ledda
RedazioneLuca Lombardo, Nicolò Maldina, Anna Pegoretti, Filippo Zanini
Comitato d’onoreRobert Hollander, Mario Marti,John Freccero, Karlheinz Stierle
Comitato scientificoZygmunt Barański, Teodolinda Barolini, Lucia Battaglia Ricci,
Bodo Guthmüller, Emilio Pasquini,Jeffrey T. Schnapp, Luigi Scorrano, John Scott
I collaboratori sono pregati di inviare copia del loro contributo(sia per attachment che per posta) al seguente indirizzo:
Giuseppe Ledda - Università di BolognaDipartimento di Filologia classica e Italianistica
Via Zamboni 32 - 40126 Bologna - Italia (e-mail: [email protected])I volumi per eventuali recensioni debbono essere inviati a
Giuseppe Ledda, vedi indirizzo sopra
Abbonamenti e amministrazione: A. Longo Editore - Via Paolo Costa 33 - 48121 RavennaTel. 0544.217026 Fax 0544.217554 www.longo-editore.it
e-mail: [email protected]
Abbonamento 2013 Italia: € 40,00 (due fascicoli annui)Abbonamento 2013 estero: € 60,00 (due fascicoli annui)
I pagamenti vanno effettuati anticipatamente con assegno, vaglia postaleo con versamento sul ccp 14226484
oppure con carta di credito (solo Visa o Mastercard) e intestati a Longo Editore - Ravenna
I contributi pubblicati su «L’Alighieri» sono soggetti al processo di peer review. Ogni contri-buto ricevuto per la pubblicazione viene sottoposto, in forma rigorosamente anonima, alla let-tura e valutazione di due esperti internazionali, esterni alla direzione della rivista.
ISBN 978-88-8063-763-9
© Copyright 2013 A. Longo Editore sncAll rights reserved
Printed in Italy
GIAN PAOLO RENELLO
(Università di Salerno)
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA.NOTE IN MARGINE AL RITROVAMENTO DEL MS. ADDITIONAL 6891*
ABSTRACT
L’autore, prendendo spunto dal recente ritrovamento di un testimone del trattato dan-tesco, sviluppa una serie di considerazioni che si oppongono alla ricostruzione stemmaticaproposta dall’ultima edizione critica di Prue Shaw, in particolare per quel che riguarda laposizione dell’editio princeps (K). Essa infatti, benché presenti, a suo giudizio, evidentielementi di contaminazione con la famiglia α, viene ora ricondotta all’interno della famigliaß. L’autore prende in esame, assieme all’editio princeps, anche la prima traduzione tedescaad essa coeva e il volgarizzamento di Ficino su cui si basa quest’ultima. Partendo dalle di-chiarazioni del volgarizzatore tedesco, secondo il quale la sua traduzione è stata ricontrollatasu un ms. latino, e dall’esame comparato delle tre versioni, l’autore ipotizza che tale ms.sia interno a ß e sia lo stesso servito come base della princeps K.
The author, following on from the recent discovery of a witness of Dante’s Monarchia,develops a number of considerations that oppose the stemmatic reconstruction proposedin Prue Shaw’s most recent critical edition, particularly focusing on the position of theeditio princeps (K). This one, although it presents, in the author’s opinion, traces of con-tamination with the α family, is now brought within the ß family. Together with the editioprinceps, the author also considers its coeval, the first German translation, and Ficino’sItalian translation, on which the latter is based. Starting from the statements of the Germantranslator, who tells us that his translation was checked against a Latin manuscript, andthrough this examination of the three versions, the author suggests that this manuscript iswithin ß family and it is the same as that which served as the basis of the princeps K.
Premessa
Dopo il 2006 e il 2009, anno di pubblicazione rispettivamente dell’edizioneelettronica e dell’edizione critica della Monarchia, fatiche immense, entrambecurate da Prue Shaw, il 2011 può essere considerato un altro Annus Mirabilisper il trattato dantesco. I due precedenti avvenimenti editoriali avevano in effettigià contribuito a ridestare, intorno al libello, grande interesse in Italia, sostan-ziatosi in una nutrita serie di articoli, a partire almeno dalla acuta analisi del-
* Sono grato a Gino Belloni, Pietro Beltrami, Alberto Casadei, Paolo Chiesa, Diego Quaglionie Paolo Trovato per la pazienza con la quale hanno seguito lo sviluppo di questo lavoro. Una faticaresa meno ardua dai loro apprezzamenti, e senz’altro più corretta e precisa di quanto avrei potutofare senza le loro puntuali critiche.
«L’Alighieri», 41 (2013)
GIAN PAOLO RENELLO116
l’edizione elettronica che ne ha dato Paolo Chiesa, recensore successivamenteanche dell’edizione cartacea, cui ha fatto seguito il numero monografico degli«Studi Danteschi» del 2010, l’articolo di Paolo Trovato nello stesso anno e, neiprimi mesi del 2011, un mio intervento; si tratta di lavori che, accanto ai problemistorici e filosofici posti dal trattato, hanno spesso preso in esame anche, e più ingenerale, i problemi ecdotici che la nuova edizione critica aveva avuto il meritodi mettere in luce1.
La fine del 2011, però, insieme ad un ulteriore intervento di Alberto Casadei,in cui lo studioso rimetteva in discussione con nuovi argomenti l’autenticitàdell’autoriferimento dantesco a I.xii, 6, ha riaperto i giochi anche sul lato dellatradizione manoscritta, riservando a tutti una grande sorpresa: quasi a voler co-ronare tanta attenzione intorno ad un testo tormentato da vicende difficili, chehanno visto come possibile esito addirittura la sua estinzione, è stato infatti perla prima volta descritto un secondo codice londinese, il ms. Additional 6891, dadue studiosi, contemporaneamente e in maniera autonoma: Diego Quaglioni, ilquale, in aggiunta, discute ed emenda una nutrita serie di lezioni adottate dal-l’edizione critica attuale, sui cui ci soffermeremo in un secondo momento, e, informa più analitica, Prue Shaw stessa2.
Per la verità il testimone era già stato trovato e siglato come N1 da Aldo Rossinel 1960, ma il filologo, inspiegabilmente, non ne fece menzione prima del 1999,lasciandosi addirittura precedere da una breve notizia intorno alla sua esistenzadata da Paul Oskar Kristeller3.
L’antichità del ms. Additional 6891, che entrambi gli studiosi hanno ora de-nominato Y, in coerenza con le sigle degli altri testimoni, è senz’altro fuori di-scussione; mentre però Prue Shaw, in accordo con Rossi, lo situa a cavallo deldecennio 1340-1350, specialmente a causa delle parole dell’explicit, la stessamotivazione induce invece Diego Quaglioni ad anticiparne la datazione fino a
1 Cfr. P. CHIESA, L’edizione critica elettronica della «Monarchia»: la filologia informatica allaprova dei fatti, in «Rivista di Studi Danteschi», VII (2007), pp. 325-54; ID., recensione a Dante, Mo-narchia, a c. di P. SHAW, in «Rivista di Studi Danteschi», IX (2009, ma 2010), pp. 398-408. Cfr. poi«Studi Danteschi», LXXV (2010), la sezione Contributi ad una rilettura della «Monarchia», concontributi di P. CHIESA, G.C. GARFAGNINI, R. IMBACH, P. ALLEGRETTI-G. GORNI e L. TROMBONI. In-fine si veda ancora P. TROVATO, La doppia «Monarchia» di Prue Shaw (con una postilla sulla «Com-media»), in «Ecdotica», VII (2010), pp. 25-39.
2 D. QUAGLIONI, Un nuovo testimone per l’edizione della «Monarchia» di Dante: il Ms. Add. 6891della British Library, in «Laboratoire Italien», XI (2011), pp. 231-80, http://laboratoireitalien.revues.org/595(ultimo accesso: 8/5/2012); P. SHAW, Un secondo manoscritto londinese della «Monarchia», in «StudiDanteschi», LXXVI (2011, ma 2012), pp. 223-64. In questo stesso numero si legge anche il suaccennatocontributo di A. CASADEI, “Sicut in Paradiso Comedie iam dixi”, ivi, pp. 179-97.
3 A. ROSSI, Da Dante a Leonardo. Un percorso di originali, Firenze, Sismel, 1999, p. 136.Devo dire che, come accaduto alla recente editrice della Monarchia, anche a me era sfuggito l’im-portante volume di ROSSI, visto per la prima volta a casa di Paolo Trovato e consultato successiva-mente in biblioteca. Accanto alle contestazioni di Shaw circa alcune affermazioni dell’autore,specialmente intorno alla stima a volte eccessiva che egli fa di B, il volume contiene spunti degnidi essere attentamente presi in considerazione, e su cui converrà tornare, sia riguardo la posizionestemmatica dell’editio princeps K, sia riguardo alcune lezioni di B. Si può incidentalmente osservareche, sempre a causa del silenzio di Rossi, del manoscritto non ebbe contezza, e non poté quindiascriverlo fra i testimoni noti, neppure P.G. RICCI, in occasione dell’edizione critica del 1965.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 117
porlo fra i primissimi esemplari del libello dantesco4.I due studiosi concordano anche nel ritenere che Y non offra particolari pro-
blemi di posizionamento stemmatico: le argomentazioni addotte appaiono in ef-fetti più che convincenti per situarlo all’interno della sottofamiglia β2 dellostemma ipotizzato da Prue Shaw nella propria recente edizione critica del trattatoe di cui diamo qui per comodità l’immagine:
4 Cfr. QUAGLIONI, Un nuovo testimone cit., p. 234. Per le ipotesi di datazione cfr. A. ROSSI, Pre-cisazioni testologiche sull’edizione oporiniana con referenze ad un nuovo codice della «Monar-chia», in ID., Da Dante a Leonardo cit., pp. 175-76.
5 L’articolo di Shaw contiene alcune inesattezze circa la descrizione del testimone: l’epistolacontenuta nelle ultime tre carte del manoscritto non è di Clemente VII ma di Clemente VI (p. 225)ed è diretta a Ortolf von Weißenek e non Weisserak (ibidem), errore questo, probabilmente derivatoda ROSSI, Precisazioni testologiche cit., p. 177. Si veda ancora QUAGLIONI, Un nuovo testimonecit., p. 234 e n. 9. Per la disposizione stemmatica du Y si veda oltre p. 126.
Sola differenza di rilievo a questo livello è che Prue Shaw ipotizza la famigliaβ2 trimembre, ponendo P e Y, da lei ritenuto pochissimo contaminato, come col-laterali e diretti discendenti da β2, accanto a un perduto x1 da cui discendono ilFeliniano 224 (F), e N, l’Additional 28804, ovvero l’altro londinese; Quaglioniinvece mantiene l’originaria struttura bipartita di β2 “abbassando” P a discen-dente da un collaterale perduto di Y5.
Fig. 1: A sinistra Y in β2 secondo Shaw. A destra l’ipotesi di Quaglioni
GIAN PAOLO RENELLO118
I. Il manoscritto e l’autoriferimento dantesco
Tralasciando le più che esaurienti analisi del testimone a livello filologico,mi soffermerò invece su una delle ragioni che rendono di estremo interesse Y,vale a dire il fatto che questi si aggiunge alla esigua schiera dei manoscritti chepresenta gravi problemi di lettura del famoso autoriferimento dantesco, a I.xii,6, sicut in Paradiso comedie iam dixi, addirittura introducendo una nuova e ina-spettata lezione. In luogo della frase a testo nell’edizione critica, leggo infatti,in accordo con Prue Shaw, alla carta 4r, inminuadiso inmediate iam dixi, mentreDiego Quaglioni legge, con formula dubitativa, sic(ut) in inmu (?) adiso i(n)me-diate ia(m) dixi 6. Come che sia, è evidente che l’oscurità di una parte della le-zione, unitamente alla scomparsa della parola Comedie rimpiazzata da unnotevole inmediate, è in grado di riproporre con rinnovata forza all’attenzionedegli studiosi la mai sopita querelle intorno al valore dell’inciso quale autorife-rimento autoriale a Par. V, 19-24, soprattutto per le evidenti ricadute che essoavrebbe sulla datazione del trattato. È noto che esso è del tutto assente nell’editioprinceps e quasi del tutto assente in F dove compare solo sicud in seguito da unalacuna fino a fine rigo; è parzialmente presente in P dove manca l’espressionein Paradiso ed è presente in G e U nella forma paradisi comedia (G), Paradisicomœdia (U). I restanti testimoni presentano invece l’espressione completa.
A questo proposito vale la pena osservare che Prue Shaw, pur senza spiegarnel’eziologia, ritiene che la variabilità dell’inciso nei tre manoscritti β2, P, F e Nrappresenti un classico caso di diffrazione in praesentia e tale ipotesi, a suo giu-dizio, si rafforza con la comparsa di Y 7.
Su una presenza non problematica del riferimento dantesco completo in Navevo già avuto modo di esprimere altrove le mie perplessità8. Ora a me pare, alcontrario di quanto afferma la studiosa, che queste si siano ulteriormente raffor-zate proprio grazie alla variante presentata da Y: la lezione di N nascerebbe quasicertamente per contaminazione con un qualche altro manoscritto da cui ha potutotrarre un inciso non direttamente ricostruibile da alcuno degli altri membri dellastessa famiglia, ivi compreso l’ultimo arrivato9.
6 SHAW, Un secondo manoscritto cit., p. 231. QUAGLIONI, Un nuovo testimone cit., p. 245. ROSSI,Precisazioni testologiche cit., p. 178 legge in minua d i s o, con scansione in tre elementi del-l’espressione che appare invece unita nel codice. La spaziatura dell’ultimo di questi intende forserappresentare la sua maggiore dimensione rispetto al resto del testo, notata anche da Shaw.
7 SHAW, Un secondo manoscritto cit., pp. 230-31. Nell’edizione critica da lei curata, DANTE
ALIGHIERI, Monarchia, in Le opere di Dante Alighieri. Edizione nazionale a cura della Società Dan-tesca Italiana, V, Firenze, Le Lettere, 2009 (d’ora in avanti EN), p. 273, Shaw dichiara che β2 «èdel tutto privo di problemi», il che può essere vero per quel che concerne la determinazione deisuoi membri, cui si aggiunge con altrettanta certezza Y; molto meno pacifico è, a mio giudizio, ilfatto che solo questa famiglia presenti in quasi tutti i testimoni lacune o seri problemi di lettura aI.xii, 6, a cui si aggiunge anche il problema dei rapporti non ancora chiaramente delineati fra β2 eβ3, come ricorda anche QUAGLIONI, Un nuovo testimone cit., p. 247.
8 G.P. RENELLO, L’edizione critica della «Monarchia», in «Italianistica», XL/1 (2011), pp. 141-80, a p. 165.
9 La contaminazione ha giocato un ruolo tutt’altro che trascurabile nella trasmissione del trat-tato, cfr. P. SHAW, Il codice Uppsalense della «Monarchia», in «Studi Danteschi», XLVI (1969), pp.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 119
Quanto alla diffrazione di cui parla Shaw, essa può variare secondo la pro-spettiva dalla quale la si osserva. Consideriamo infatti i manoscritti F N P Y, esuddividiamo l’inciso nei quattro segmenti A: sicut, B: in paradiso, C: comedie,D: iam dixi.
Nella tabella che segue i testimoni sono stati disposti secondo l’ordine stem-matico definito da Quaglioni, con Y al primo posto, per le ragioni che diremopiù avanti. Inoltre, abbiamo incluso nel segmento B le due parole che formanol’espressione “in paradiso” sia per come si presenta la lezione di Y, sia perchéessa è incompleta in P, la qual cosa ci fa sospettare che in origine formassero untutt’uno; si può anzi, al riguardo, ritenere che forse proprio tale fusione abbiacausato l’incomprensione che caratterizza ben tre testimoni su quattro. Ecco dun-que come si presenta il prospetto relativo ai quattro testimoni10:
293-331, a p. 331 (e successivamente in EN, p. 242), e di P.G. RICCI, A sette anni dall’edizione na-zionale del «Monarchia», in *Atti del convegno nazionale di studi danteschi, Ravenna, Longo,1971, pp. 79-114, a p. 80. Essa ha interessato trasversalmente e diffusamente gran parte dei testimoni(si veda oltre), credo addirittura in misura maggiore di quanto fino a oggi immaginato. I due editori(per cui si veda, oltre ad EN, p. 275, anche DANTE ALIGHIERI, Monarchia, a cura di P.G. RICCI, inLe opere di Dante Alighieri, Edizione Nazionale a cura della Società Dantesca Italiana, v, Milano,Mondadori 1965 [d’ora in avanti EN 1965], p. 70), hanno inoltre osservato che N non può esserecopia di F per motivi cronologici, né F è copia di N per ragioni di ordine filologico. Fra queste, cu-riosamente, entrambi non considerano l’assenza del riferimento dantesco in F, che mi pare difficile,stante la situazione della famiglia, possa classificarsi come una semplice omissione. Essa invece,a mio parere, testimonia che il progenitore comune ai due esemplari doveva avere una lacuna ouna seria difficoltà di lettura non risolvibile per congettura come, almeno in teoria, potrebbe averfatto N.
10 Il simbolo Ø indica uno spazio vuoto.
mss. segm. A segm. B segm. C segm. D
Y sicut imminuadiso immediate iam dixi
P sicut Ø Comedie iam dixi
F sicud in Ø Ø Ø
N sicut in paradiso Comedie iam dixi
Tabella 1: Distribuzione dell’autoriferimento in β2
Si vede immediatamente che la sezione critica è costituita dai due elementicentrali B e C. L’ipotesi di diffrazione in praesentia per β2 avanzata da Shaw sibasa unicamente sull’assunto che l’inciso in forma completa di N non sia pro-blematico. Ma se si prendesse in considerazione la controipotesi di una conta-minazione di N e quindi questi venisse escluso dal nostro esame, la stessa tabella
GIAN PAOLO RENELLO120
mostrerebbe che la diffrazione di cui parla Shaw andrebbe piuttosto considerata,almeno per il segmento B, diffrazione in absentia, perché nessun dubbio vi puòessere sul fatto che la lezione di Y sia errata11. Tralasciando F, dove l’inciso noncompare, lasciando però la traccia di uno spazio vuoto12, consideriamo P: comericorda Shaw, il suo copista, Francesco Piendibeni, era solito segnalare scrupo-losamente le eventuali lacune o difficoltà di lettura con appositi richiami a latodel rigo corrispondente per indicarne la criticità13. Questo è quanto avviene ancheper la lacuna a I.xii, 6, dove il richiamo del copista riguarda tuttavia solo il se-condo segmento, [in Paradiso]14. Il prospetto della tabella mostra che si trattaappunto della locuzione più incerta; essa manca in P e in F, mentre in Y appare,più che corretta, riscritta in qualche modo, dando luogo ad un’espressione diprimo acchito francamente incomprensibile. Valutare di quale tipo di diffrazionesi tratti non è insomma questione di astratta terminologia; una diffrazione in as-senza segnala infatti, in questo caso, che il luogo testuale del segmento B era difatto illeggibile già all’altezza di β2, e che, almeno per quella famiglia, dovevatrattarsi di una vera e propria crux; è facile allora immaginare che, se tale cruxrisalisse a β o addirittura all’archetipo, da essa sarebbe potuto persino essere par-tito il tentativo di ricostruzione che ha condotto alla lezione oggi accettata15.
Discorso appena differente si può poi svolgere per il segmento C, che vedecomunque un testimone lacunoso a fronte delle due lezioni difformi di P e Y, laprima delle quali ritenuta attualmente corretta.
È già stato chiarito a sufficienza sia nell’edizione Ricci, sia in quella Shaw,che P e N non hanno collegamenti fra loro. D’altronde è banale osservare che ilmanoscritto copiato da Piendibeni, indipendentemente dal fatto che sia posterioreo meno a N16, non può aver preso da quest’ultimo, altrimenti l’inciso sarebbepresente nella sua interezza. È possibile il contrario? Anche qui la completezzadella frase in N fa supporre di no. A sua volta il ms. P non può avere letto nem-meno da Y non tanto per la lacuna in luogo del primo termine, indecifrabile,quanto invece a causa della differenza del segmento C, per la quale si veda piùoltre una possibile spiegazione.
Sempre a proposito della copia di Piendibeni, Paolo Chiesa aveva osservatoche lo spazio lasciato vuoto è in verità maggiore di quanto sarebbe necessarioper contenere il segmento in paradiso17. Controllando su Y lo stesso luogo te-
11 Per il segmento C sono logicamente possibili entrambi i casi: diffrazione in praesentia se unodei testimoni ha la lezione corretta, altrimenti di nuovo in absentia. Incidentalmente osservo che se ildixi finale fosse in realtà un dixit, si avrebbe ancora un’altra diffrazione in absentia.
12 Che l’inciso non compaia non significa necessariamente che l’antigrafo fosse ivi lacunoso; lospazio vuoto lasciato in F fino a fine riga induce anzi a supporre il contrario. Quello che si può dire èche il copista di F non è riuscito a leggere o a capire di cosa si trattasse.
13 Si veda in particolare P. SHAW, Le correzioni di copista nella «Monarchia», in «Studi Dante-schi», LXIII (1991), pp. 281-312, specialmente pp. 288-91.
14 Rinvio all’edizione elettronica per la consultazione delle immagini. Cfr. DANTE ALIGHIERI, Mo-narchia, ed. by P. SHAW, electronic edition, Birmingham, Scholarly Digital Editions & Firenze, SocietàDantesca Italiana, 2006.
15 Si leggano in proposito le osservazioni di QUAGLIONI, Un nuovo testimone cit., p. 247.16 N è stimato essere dell’ultimo quarto del XIV secolo, P della sua fine; cfr. SHAW, EN, p. 227.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 121
stuale si può constatare che quell’area potrebbe invece adeguatamente corrispon-dere ad un’espressione come inminuadiso, ancorché inintelligibile, o a qualcosadi equivalente; in ogni caso essa pare adeguata per una locuzione che dovevaessere più lunga di in paradiso, soprattutto considerando, come si è già dettosopra, che le ultime lettere di tale locuzione sono più grandi delle lettere prece-denti, quasi il copista avesse dovuto riempire uno spazio precedentemente la-sciato vuoto, cosa, questa, che confermerebbe una volta di più l’estrema difficoltàdel luogo18. Non si può in definitiva che concordare con quanto sostiene DiegoQuaglioni a proposito della posizione decisamente eccentrica di Y, quando rilevache proprio a causa di tale eccentricità Y più di ogni altro manoscritto è in grado«di rendere compiutamente ragione dell’instabilità del testo, nella linea di tra-smissione rappresentata dai manoscritti F P»19.
Lo studioso assume che l’esemplare di cui Y è copia potesse presentare inquel punto un guasto materiale a fine pagina e che la lacuna riguardasse propriociò che precedeva adiso, che probabilmente iniziava alla pagina successiva; eglifornisce un possibile restauro del guasto con la frase sicut in inmu<tabilibus vo-luntatibus in par>adiso inmediate iam dixi20.
È questa un’ipotesi che ha indubbiamente il merito di rendere conto della pre-senza di inmediate, chiaramente leggibile nel testo ed indiscutibilmente interes-sante, sia perché non pare lettura banale, sia per gli orizzonti di lettura che puòaprire; esso farebbe infatti riferimento a quanto appena detto da Dante non tantoall’inizio di quello stesso capitolo, come aveva immaginato già a suo tempo Witte,ma proprio alla frase che chiude il paragrafo immediatamente precedente, là dovel’autore parla delle substantie intellectuales – che per definizione posseggono im-mutabiles voluntates – e delle anime separate, che non perdono il libero arbitrio«ob immutabilitatem voluntatis», riprendendone e ribadendo in tal modo anchenella ricostruzione della lacuna il concetto di immutabilitas. Di conseguenza ilsusseguente iam dixi, per quanto infrequente, rientrerebbe nell’usus dantesco diparlare di sé in ambito trattatistico quando si richiama a qualcosa di appena enun-
17 Cfr. CHIESA, L’Edizione critica elettronica della «Monarchia» cit., p. 337, n. 34. A questoproposito lo studioso non concorda con l’affermazione di Shaw (ma già di Ricci), che lo spazio la-sciato nei manoscritti è adeguato alle parole mancanti. Nel caso di P egli parla di uno spazio vuotodi 12-15 caratteri, che potrebbero, a ben vedere, diventare anche 16.
18 Si dovrebbe a questo riguardo osservare che mentre inminuadiso è scritto per esteso, la parolache segue, i�mediate, presenta invece un compendio iniziale comunissimo per i nessi in/im. Ciò fa-rebbe pensare che la scrittura estesa di inminuadiso fosse dovuta sia all’incapacità di capire cosasignificasse, sia all’esigenza di riempire uno spazio vuoto piuttosto esteso lasciato in precedenza.La mano che ha scritto inminuadiso è la stessa che ha vergato il resto del testo; sospetto quindi cheil copista abbia inizialmente tralasciato il punto per ritornarvi in seguito.
19 QUAGLIONI, Un nuovo testimone cit., p. 245. Naturalmente non si deve dimenticare che taleeccentricità è comunque confinata all’interno di una sottofamiglia dell’intero stemma, e semmaiproprio tale specificità andrebbe ulteriormente indagata, per tentare di spiegare come mai proprioquesta famiglia presenta difficoltà di lettura dell’inciso.
20 Ibidem. Accanto a questa lo studioso avanza una seconda ipotesi, secondo la quale il copistapotrebbe aver letto adiso dove originariamente vi era aduō = adverso; in tal caso la frase potrebbecorrispondere a sicut in muti<s ex> adverso immediate iam dixi.
GIAN PAOLO RENELLO122
ciato 21. Questa interpretazione, infine, non perderebbe di validità neppure se l’in-ciso venisse letto inminuadiso, come sostenuto da Prue Shaw e da me.
Il restauro di Quaglioni, tuttavia, mi pare suggerisca l’idea che il libero arbi-trio in quanto dono è in tutte le volontà immutabili che si trovano in Paradiso,scostandosi così da Dante, per il quale, essendo invece esso il massimo dono diDio all’humane nature, rappresenta semmai la condizione necessaria per diven-tare volontà immutabili, sottoinsieme chiaramente non coincidente con l’interogenere umano; gli uomini infatti non sono angeli, «quarum sunt inmutabiles vo-luntates»22; al contrario, proprio nella libera e volontaria sottomissione del loroappetitus ad un corretto esercizio del iudicium sta la possibilità di accedere alParadiso: il loro divenire «anime separate bene hic abeuntes» è ottenuto, appunto,«ob immutabilitatem voluntatis».
Prue Shaw avanza invece un’altra ipotesi. Dopo aver messo in evidenza cheentrambe le due nuove espressioni contengono in forma frammentaria le parolegià note23, ritiene, come già Aldo Rossi24, che il copista non sia riuscito a leggereuna originaria ᵱ con la coda tagliata in luogo di par, prima di adiso. Benché, disolito, di fronte a una forma grafica incomprensibile, ogni copista cerchi sempredi derivare per semplificazione un senso e una forma plausibile25, l’ipotesi appare
21 K. WITTE, Dantis Alligherii de Monarchia libri III, codicum manuscriptorum ope emendatiper Carolum Witte, editio altera, Vindobonae, 1874, p. 23, aveva sospettato che l’inciso fosse unaglossa, appoggiandosi anche all’autorità di Ficino, che nell’edizione da lui consultata ne era privo(ma su ciò si veda oltre). Egli riteneva che solo il segmento sicut dixi fosse originariamente presentenel testo come richiamo dell’autore all’inizio dello stesso capitolo e andava quindi mantenuto; leparole in paradiso erano da ritenersi invece spurie, ovvero chiosa a margine e perciò da eliminare.L’ipotesi non ha trovato praticamente accoglienza, sia per l’inusuale presenza di iam dixi, sia perché,contrariamente a quanto da lui sostenuto, non si vede a cosa possa riferirsi quell’inciso parziale. Ineffetti, tutto il capitolo iniziale è un’analisi del concetto di libero arbitrio, ma da nessuna parte,prima dell’inciso, si afferma che esso è un dono, e men che meno che sia il massimo dono divino;dunque non ha senso la presenza del solo sicut iam dixi che afferma proprio il contrario. La sceltaparziale di Witte non fu accolta nell’edizione di G. GIULIANI, Le opere latine di Dante Alighieri,Firenze, Le Monnier, 1878, p. 338, n. 28, il quale, anzi, espunse completamente il passo. Con ciònaturalmente non si vuole affermare che Dante fosse alieno dal richiamare passi o concetti da luiprecedentemente esposti nella stessa opera, anche se la forma personale iam dixi, per la sua decisainfrequenza, rispetto alle forme impersonali, autorizza in questo caso qualche perplessità. Sullaquestione si veda comunque quanto da me scritto in RENELLO, L’edizione critica della «Monarchia»cit., pp. 165-66.
22 Per gli angeli la natura del iudicium è altra. Si veda a tal proposito DANTE ALIGHIERI, Monar-chia, a c. di G. Vinay, Firenze, Sansoni, 1950, p. 72, n. 4: «negli angeli volontà e appetito sono di-stinti come nell’uomo, quindi è identico il trinomio “apprehensio-iudicium-appetitus”, con ladifferenza che negli angeli l’“iudicium” non risponde ad una “inquisitiva deliberatio consilii”, maad una “subita acceptatio veritatis” […]». La perfezione della loro libertà dipende pertanto da taleimmediata accettazione «che esclude a priori una sopraffazione dell’“appetitus”[...]».
23 «Le lettere -adiso di Paradiso rimangono, così come le lettere -media (non -medie) di Co-media, ma questi frammenti di parola sono stati incorporati in parole nuove, -media in inmediate,e -adiso in un non facilmente intellegibile inminuadiso». Cfr. SHAW, Un secondo manoscritto cit..p. 231.
24 ROSSI, Precisazioni testologiche cit., p. 178.25 Come avviene nei vari casi di banalizzazione del testo, di cui le diffrazioni, ad esempio, pos-
sono per certi aspetti essere considerate una sottocategoria.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 123
fondata anche se incompleta: non si vede infatti come una forma come adiso,quale si trova ad esempio in N o B, o anche inꝑadiso, come può leggersi invecein L e Z, possa portare a inminuadiso.
La congettura acquista maggior valore, però, se si ipotizza che prima di inparadiso vi fosse il compendio di un’altra parola. In tal caso l’espressione uadisopotrebbe effettivamente essere un errore di lettura per una ᵱ tagliata in cui laparte inferiore, per ragioni varie non è stata letta; la stessa ipotesi porta inoltre aritenere che l’esemplare da cui deriva Y fosse in scrittura gotica, nella quale nondi rado la ᵱ risulta leggermente aperta in alto sì che, in caso di scrizione pocochiara, dovuta, ad esempio, all’illeggibilità della parte inferiore, essa potrebbepersino essere scambiata per una u26. La mia ipotesi, ad integrazione di quella diShaw, è che nell’antigrafo di Y la parte iniziale dell’inciso si leggesse in originecome sic mꝑadiso, ovvero sic(ut) i(te)m i(n)p(ar)adiso, con le due parole finalipochissimo spaziate, o non spaziate affatto, già nell’esemplare di partenza. Ilnostro copista, ancorché esperto, forse per un deterioramento della carta, o altreragioni a noi ignote, non è riuscito a decifrare il luogo; è così possibile che, neltentativo di venire a capo di una lettura difficile, abbia sciolto il titulus sopra en-trambe le i interpretandole erroneamente come in e che, non riuscendo neppurein questo modo a comprendere o interpretare l’espressione ottenuta, abbia infinedeciso di lasciare a testo il vocabolo così ottenuto27.
Una simile congettura paga d’altronde il prezzo della perdita della pur note-vole lezione immediate, (scritta me|diate), a favore invece di Comedie, con tuttii problemi che la genesi di quest’ultima comporta. Ipotizzo anche in questo casoche essa possa essere stata causata da una difficoltà di lettura di un compendioiniziale – forse per un guasto materiale della carta, un deterioramento dell’in-chiostro o del segno – e dunque sia stata ricostruita. Quel che è chiaro in ognicaso è che anche Y conferma come, almeno ai piani alti di β2, l’intero passofosse in qualche modo guasto, tormentato e di difficile lettura. Anche per questonon trovo soddisfacente la spiegazione fornita da Shaw secondo la quale mediatesarebbe nato per “agglutinazione” intorno alla parola media. Il copista avrebbecompiuto, per una qualche ragione, un poco probabile doppio intervento, neppuresuggerito o giustificato dall’incomprensibile parola precedente, premettendo ilprefisso – e aggiungendo la terminazione te. Se le cose stessero davvero così sidovrebbe accettare innanzitutto che la lezione fosse media e non medie, comeanche Shaw stessa non manca di notare; in tal caso andrebbero perlomeno ri-considerati i due esemplari (tardi) G e U che leggono in Paradisi Comedia persciogliere ogni dubbio; viceversa la tradizione stessa del passo potrebbe richie-dere un ulteriore vaglio.
In conclusione il testo latino che contiene l’inciso andrebbe, credo, così resoe tradotto:
26 Si veda, tanto per rendersene conto, l’esempio ad loc. che, nell’edizione elettronica, può for-nire l’immagine della parola nel ms. N.
27 Per l’ipotesi item cfr. A. CAPPELLI, Lexicon abbreviaturarum, Milano, Hoepli, 1899, p. 159.
GIAN PAOLO RENELLO124
[…] hec libertas sive principium hoc totius nostre libertatis est maximum donum hu-mane nature a Deo collatum sicut item in Paradiso Comedie iam dixi(t) [...]
[…] questa libertà ovvero questo fondamento di tutta la nostra libertà è il più grandedono fatto da Dio alla natura umana, come ho (ha) già detto in maniera simile nelParadiso della Commedia […] 28
Ho volutamente inserito una t tra parentesi tonde, per la possibilità che talecitazione sia in realtà una glossa esterna al testo in terza persona, possibilità chenon mi pare affatto da escludere sia per l’interscambiabilità fra le forme verbaliabbreviate della prima e terza persona del perfetto di dico, sia, e di nuovo, per ra-gioni di usus scribendi. Consideriamo infatti l’avverbio item, presente in praticain questo solo trattato: esso si trova sempre ad inizio frase ed ha puntualmentevalore iterativo29. Nel passo contestato item si trova invece internamente alla fraseed ha il compito di riaffermare intensivamente che il concetto che viene espressosi trova espresso parimenti in un’altra opera e precisamente nella Commedia inPar. V, 19-24. Se già la presenza di iam aveva dato adito a dubbi e perplessitàcirca la sua valenza autoriale, item rende le cose assai più complicate, proprioperché rafforza l’idea di devianza dalla norma dantesca. L’ipotesi sulla natura diinterpolazione o di glossa non d’autore inserita nel testo tornerebbe insomma pre-potentemente in prima linea. D’altronde la spia lessicale che di glossa possa trat-tarsi è data proprio da item, con il quale l’ignoto glossatore sembra volerrichiamare iterum all’inizio del paragrafo cui si riferisce. La chiosa potrebbe cioèeffettivamente dire, quasi ripetendolo esternamente al testo e a mo’ di conferma,che ciò che viene qui espresso si trova detto anche da un’altra parte30.
28 Principium in questo contesto, oltre al senso principale di ‘fondamento’, ‘principio’, richia-mato ad inizio capitolo, sembra arricchirsi di un’idea, seppur sfumata, di ‘dono’, intanto perchéesso è significato attestato nel medioevo (cfr. C. DU CANGE et al., Glossarium mediæ et infimæ la-tinitatis, Paris, Librairie des Arts, 1938, t. VI, p. 504, ad loc.), poi perché il termine viene variato eripreso (donum) subito dopo da Dante, infine perché collatum a sua volta può valere elargito, offerto,concesso ecc. detto anche di un donativo. Il senso sarebbe allora che il principio della libertà, proprioin quanto dono, è il più grande che Dio abbia mai concesso all’uomo.
29 Cfr. DU CANGE et al., Glossarium cit. t. IV, p. 430, ad loc. L’avverbio è presente otto voltenel trattato; di queste ben quattro si trovano nel libro III, cap. ix, dove ritorna tre volte nella formula«item scribit» con riferimento a quanto dice Matteo nel Vangelo. Segnalo anche una sola occorrenza,sempre a inizio frase, nella Quaestio de aqua et terra, ma la discussione intorno all’autenticità deltrattato non è ancora definita.
30 Su questa linea di pensiero, e seguendo una seconda e più radicale ipotesi, si potrebbe anchesupporre che nell’antigrafo di Y fosse scritto effettivamente qualcosa come sic(ut) i(teru)mi(n)p(ar)adiso iam dixi(t), ovvero che compendiato fosse proprio l’avverbio iterum, le cui possibiliforme sono, accanto alle più immediate iteꝝ e iteru,̅ altre come it᷒᷒m e itu, (si veda CAPPELLI, Lexiconcit., pp. 172-73). Specialmente nel caso di it᷒᷒m, una grafia corrotta, in cui non si leggesse il com-pendio er sopra la t avrebbe potuto essere sciolta come inm, e portare a inminuadiso. Una tantoesplicita ripresa dell’avverbio che apre il paragrafo darebbe allora ancor più compiutamente il sensodi una chiosa esterna al testo. Il glossatore lo avrebbe cioè richiamato per ricordare che il concettoappena espresso si trova ripetuto anche da un’altra parte. Certo, potrebbe apparire inconciliabile lacontemporanea presenza di iam e iterum, ma essa sarebbe risolvibile se si rendesse iam con «ap-punto», traducendo quindi: «come ho (ha) appunto detto un’altra volta (i.e. di nuovo) nel Paradisodella Commedia». Poiché iterum indica che qualcosa di precedentemente detto o fatto viene ripe-
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 125
Fra quanti hanno dichiarato che l’inciso fosse una glossa, vi è stato anchechi, come Gustavo Vinay, pur ritenendola «malamente passata nel testo»31, haanche ammesso, in via puramente ipotetica, che l’autore della Commediaavrebbe anche potuto rileggere e glossare, addirittura negli ultimissimi giornidella sua vita «un’operetta di circa vent’anni prima» senza che questo mutassel’orizzonte generale che vedeva l’opera scritta negli anni 1312-1313:
Se anche la tradizione manoscritta fosse perfettamente concorde (e non lo è) nel ri-portare l’inciso, la concordanza sarebbe tutt’altro che risolutiva perché, è cosa nota,non risalirebbe più in là di un qualche archetipo assai lontano dall’autografo: dirò dipiù non sarebbe risolutivo l’autografo stesso, perché l’importante non è per noi se lacitazione sia dantesca, ma se sia coeva alla redazione del trattato e questo appuntonon è oggi dimostrabile in alcun modo32.
Qui Vinay, pur di escludere che la composizione della Monarchia sia poste-riore all’elezione di Arrigo VII, credo che conceda troppo sul terreno delle ipotesi.Al di là di una tradizione tutt’altro che concorde, e a non voler considerare ilpossibile errore del dixi finale, osta ad una congettura di seconda e tardiva reda-
tuto, ne seguirebbe allora che le terzine di Par. V, 19-24 rieccheggiano o ripetono proprio il passodella Monarchia che precede l’inciso, il quale ultimo, pertanto, non ha ragione di trovarsi in quelpunto se non in quanto chiosa o glossa esterna al passo in questione.
31 DANTE ALIGHIERI, Monarchia, a c. di G. Vinay, cit., p. 74, n. 5.32 Ivi, p. XXXVII. Seppure come extrema ratio ammette tale possibilità anche G. PADOAN, “Alia
utilia rei publice”. La composizione della «Monarchia» di Dante, in «Letture classensi», XXVIII
(1999), pp. 7-27, spec. p. 24, poi in ID., Ultimi studi di filologia dantesca e boccacciana, a c. di A.M.Costantini, Ravenna, Longo 2002, pp. 41-57. Ritiene senz’altro autentico l’inciso, ma data il trattatoal 1314, M. PALMA DI CESNOLA, “Isti qui nunc”, la «Monarchia» e l’elezione imperiale del 1314, in«Studi e Problemi di Critica Testuale», LVII (1998), pp. 107-30, poi, con il titolo «Monarchia». Ladatazione intrinseca, in ID., Questioni dantesche, Ravenna, Longo, 2003, pp. 43-62, sulle cui argo-mentazioni si è espresso con fondate obiezioni E. FENZI, È la «Monarchia» l’ultima opera di Dante?(A proposito di una recente edizione), in «Studi Danteschi», LXXII (2007), pp. 215-38, in particolarep. 225. Fenzi, in un saggio pregevole anche se non in tutto condivisibile, ritiene valide entrambe ledatazioni del trattato, alta per i primi due libri e bassa per il terzo, spinto fin oltre la stesura del Pa-radiso. Sulla posizione di Palma di Cesnola si veda ancora il già citato, CASADEI, “Sicut in paradiso”cit., pp. 187-90. L’analisi delle posizioni qui ricordate, pure importanti, esula dagli scopi del presentestudio e ci riserviamo di ritornare in seguito con altro scritto. Non posso tuttavia non richiamare ilbel lavoro di A.M. CHIAVACCI LEONARDI, La «Monarchia» di Dante alla luce della «Commedia», in«Studi Medievali», s. 3, XVIII/2 (1977), pp. 147-83. In esso la studiosa mostra, direi con estremachiarezza, come idee, concetti e parole espresse nella Monarchia trovino spesso una loro naturalericollocazione e soprattutto riformulazione proprio nella Commedia, che ne diventa in un certo sensol’alveo più elaborato e naturale. Condivisibili dunque le considerazioni finali con le quali ella rifiutala presenza dell’inciso se non come interpolazione, adducendo argomentazioni non solo testuali elogiche ma anche stilistiche: «La Monarchia segue un suo alto andamento oratorio, ha un suo stilee una sua coerenza di linguaggio e non si interrompe mai in tale modo privato e glossatore. In par-ticolare il solenne enunciato del periodo in questione, anche ha la bellezza – nella velocità e densitàdel rapporto logico (“quia per ipsum hic felicitamur ut homines, per ipsum alibi felicitamur ut dii”)– delle grandi terzine teologiche dantesche, ci sembra rifiutare categoricamente, sul piano stilistico,una simile interpolazione […]». Ci pare questa l’espressione forse più compiuta di quanto ebberogià a sostenere dopo Witte, ad esempio, G. GIULIANI nella sua edizione del trattato del 1878, o M.BARBI, Problemi di critica dantesca. Prima serie (1893-1918), Firenze, Sansoni, 1934.
GIAN PAOLO RENELLO126
zione più di un motivo: si dovrebbe intanto ammettere, e non se ne vede la ra-gione, che Dante, a distanza di un congruo numero d’anni (addirittura venti se-condo lo studioso)33, avrebbe ripreso in mano l’unico trattato da lui portato atermine per chiosare un solo passaggio in tutta l’opera, e tutto questo esclusiva-mente per affermare che il concetto ivi espresso era stato da lui “già” ribaditoanche nel Paradiso34. Secondariamente, e non mi pare obiezione da poco, di so-lito quando un autore revisiona una propria opera di molti anni addietro è difficilecredere che intervenga in un solo passaggio, fosse pure fondamentale. Si sarebbecostretti dunque ad avanzare un’ulteriore ipotesi, che cioè Dante, per ragioni dachiarire, non fosse riuscito a completare il lavoro di revisione del trattato in que-sta seconda occasione, limitandosi al primo libro, ma tralasciando, il secondo especialmente il terzo, della cui importanza sia politica sia teologica era certo benconscio, come testimoniano le parole di apertura di quest’ultimo, confermate dalfatto che in particolare proprio quel libro gli costò, post mortem, l’accusa di ere-sia, nonché la messa al bando e il rogo dell’opera. Un ovvio corollario della pre-cedente congettura è che dovremmo anche accettare la possibilità che possanoesistere allora altri passi modificati rispetto ad una prima redazione del testo.Siamo di fronte, insomma, ad una ridda di ipotesi, da cui diventa quasi impos-sibile uscire, su nessuna delle quali si hanno notizie e che non sono neppure con-fermate, o anche solo sospettate, da alcuno dei traduttori e degli editori che daFicino a Fraticelli, a Witte, fino a Prue Shaw si sono cimentati col trattato35.
A me pare ad ogni modo innegabile che il ms. Additional 6891 sia un testi-mone decisamente importante. Ritengo infatti del tutto probabile, in accordo conDiego Quaglioni, che esso rappresenti uno stadio di trasmissione precedente ognialtra ricostruzione del testo, e ancor più che il suo antigrafo sia da situare stem-maticamente ad un livello assai alto proprio a causa del secondo segmento dellafrase, inminuadiso, un ircocervo verbale altrimenti difficilmente giustificabile.Da questo punto di vista trovo più convincente ed economica la disposizionestemmatica dei testimoni β2 ipotizzata dallo studioso rispetto a quella di Shaw.In effetti Y è il solo manoscritto a noi noto che presenta un inciso totalmente dif-ferente; ciò lo classifica probabilmente come il più vicino fra tutti i testimoni al-l’esemplare in cui esso era presente, forse ancora come una chiosa che potevabenissimo esser presa come correzione o giunta d’autore a margine. Il copistapuò averlo inserito nel testo senza riuscire a comprenderlo e da qui sarebbe natoun fenomeno di semplificazione diramatosi presso gli altri testimoni, per cui èsopravvissuta la sola forma īᵱadiso, essendosi ritenuto distrattamente o erronea-mente, magari a causa di una grafia poco chiara, come ad esempio il primo titulusnon visibile, che im fosse errata ripetizione del successivo ī. Il copista di P po-trebbe a sua volta aver parzialmente corretto o ripreso una lezione da un esem-plare che aveva già di suo tentato un ripristino della frase, seppur incompleto, e
33 DANTE ALIGHIERI, Monarchia, a c. di G. Vinay, cit., p. 74, n. 5. Si tratta, è ovvio, di un lapsus,in evidente contrasto con quanto scrive sia nell’Introduzione, sia solo una decina di righe dopo ilpasso qui citato.
34 Considerazioni analoghe mi pare svolga anche CASADEI, “Sicut in Paradiso” cit., p. 196.35 Ivi, p. 191.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 127
ciò spiegherebbe la lacuna del segmento B, per il quale Piendibeni ha lasciatouno spazio apposito, dopo aver debitamente segnalato a margine il problema. Sipuò così spiegare più agevolmente anche la differenza fra la lettura di Y, inme-diate e quella di P, Comedie che potrebbe essere vista come una prima parzialericostruzione di quanto doveva trovarsi in quel punto. P insomma rifletterebbeuno stato intermedio fra Y e la frase completa quale si trova poi in N e negli altritestimoni.
Le ipotesi finora discusse intendono ovviamente proporre una possibile so-luzione innanzitutto al problema testuale specifico del ms. Additional 6891. Essenon hanno la pretesa di risolvere ipso facto anche la questione della presenzadel riferimento dantesco a testo nell’archetipo o addirittura nell’originale. È pa-tente tuttavia che ove fosse verificata una delle congetture, si aprirebbero nuoviscenari sulla natura e sulla pertinenza dell’inciso. Si tratta, come a ognuno èchiaro, di problemi di non facile né immediata soluzione, ma bastano in ognicaso i dubbi che tale variante è in grado di sollevare per rendere manifesto comeY non sia così pacificamente neutralizzabile all’interno della famiglia β2.
2. La posizione di K
La comparsa del ms. Additional 6891 nel panorama dei testimoni della Mo-narchia pone in verità una seconda e certamente spinosa questione a cui non cisi può legittimamente sottrarre dopo quanto si è detto, vale a dire: come va orainterpretato, alla luce di Y, il silenzio di K36?
In un articolo precedente avevo osservato che K si unisce in diverse occasionia manoscritti della famiglia β per una serie di lezioni erronee che potrebberoportarlo nell’orbita di influenza di quest’ultima37. Una rivisitazione più accuratadei testimoni della Monarchia mi permette ora di aggiungere alcuni altri indizidi possibili errori, questa volta di natura formale, che mi pare rafforzino questaipotesi. Essi, non adeguatamente presi in considerazione dagli ultimi due editoridel testo, riguardano invero la disposizione e l’ordinamento dei capitoli dellaMonarchia in tutti i testimoni noti, a cui aggiungeremo, e le ragioni saranno ma-nifeste nel prosieguo del discorso, anche la traduzione tedesca del libello, curatada Heroldt e coeva alla princeps38.
Grazie all’apparato iconografico dell’edizione elettronica, è possibile verifi-care la disposizione dei capitoli nel trattato in tutti gli esemplari ivi classificati,
36 Cfr. anche QUAGLIONI, Un nuovo testimone cit., p. 247.37 Tali osservazioni presero spunto da un suggerimento di CHIESA, L’edizione critica elettronica
della «Monarchia» cit., p. 333, secondo il quale il fatto che K non facesse parte della famiglia αnon vietava di indagare se esso potesse far parte invece della famiglia β. Cfr. RENELLO, L’edizionecritica cit., pp. 155-60. P. SHAW, in EN, p. 244, nota d’altronde che vi sono errori manifesti e nonfacilmente classificabili come poligenetici che collegano, ad esempio, K + E. Si veda anche TRO-VATO, La doppia «Monarchia» di Prue Shaw cit., p. 33.
38 Si tratta dunque di errori nel senso che, se si accetta la disposizione dei capitoli del trattatosecondo le edizioni di RICCI e/o SHAW, allora l’editio princeps, K, non ne possiede la giusta dispo-sizione.
GIAN PAOLO RENELLO128
ai quali aggiungo, per completezza, anche Y. Dei tre libri che lo compongono, ilprimo è senz’altro quello che presenta il minor numero di problemi in questosenso. Le differenze fra i vari testimoni sono infatti poche, isolate e non omoge-nee39. Assai più movimentata e interessante appare invece la situazione dei restantidue libri: basti dire che, per il secondo libro, solo T è portatore dell’ordinamentodei capitoli ritenuto valido dagli editori Ricci e Shaw, mentre solo K D M riflet-tono l’ordinamento del terzo nell’edizione Shaw del 200940. Utilizzando come ri-ferimento l’ultima edizione critica, un esame autoptico dei testimoni mostra inparticolare che41:
a II.v, 18, i manoscritti delle famiglie β2 e β3 segnalano un nuovo inizio dicapitolo: per β2 si ha: F P (Declarat), N Y (Declarata); per β3 si ha: D E G R V(Declarata), Ph (Declaratum). Sono pertanto escluse le famiglie β1, β4 ed α,che in questo punto è formata ancora da A1 e T. Ad essere precisi tale rilievo eragià in Ricci, il quale se ne servì, fra l’altro, per legare β2 e β3 in una seppur in-definita parentela, accettata poi anche da Shaw, la quale osserva a sua volta che
39 Per quel che concerne il libro I l’edizione elettronica contiene alcune imprecisioni della cu-ratrice: A1 e D sono privi dell’inizio del capitolo vi, ma Shaw dichiara nella nota rispettiva dei duemanoscritti che ognuno di essi è l’unico a non avere un inizio di capitolo in quel punto.
40 Nel terzo libro SHAW si discosta con fondate ragioni dalla suddivisione dei capitoli introdottada RICCI, e, come già era con le edizioni di WITTE, BERTALOT e ROSTAGNO, reintroduce un nuovocapitolo a III.x, 18. Si veda comunque oltre. Sempre secondo la studiosa, alla lista dei mss. che pre-sentano un ordinamento corretto nel III libro andrebbe aggiunto anche T, poiché «una interruzionedi riga dopo il primo periodo a III.iv non può essere considerata una divisione fra capitoli» (EN, p.271). Che T faccia parte o meno di quell’esiguo gruppo di mss. non sposta i termini del problemache qui si tratta. È però anche vero che T non solo presenta una evidente interruzione di linea allafine del primo paragrafo a III.iv, ma comincia inoltre la prima linea del successivo con un “rientronegativo” ovvero sporgente a sinistra rispetto al testo del paragrafo, esattamente come accade perogni altro inizio di capitolo in quel manoscritto.
41 SHAW, nell’edizione elettronica, avverte in genere quando un testimone presenta l’inizio diun capitolo non conforme all’edizione da lei curata; se si tratta di un gruppo di testimoni la segna-lazione riguarda però solo il primo di essi in ordine alfabetico, specificando in più che non è l’unico.Ad esempio, nel caso di A, la studiosa avvisa a II.ix, 12 che «several manuscripts start a new chapterat this point», senza indicare quali. In tal modo però le sfugge che i mss. A2 D G Ph V, ovvero lafamiglia β3 - E R, non solo cominciano un nuovo capitolo a II.ix, 12 (A2 D V leggono Sed Romanus,G Et Romanus, Ph Set Romanus), ma sono poi gli stessi che spostano anche l’inizio del capitolosuccessivo, da II.x, 1 a II.x, 1.3 (Maxime enim fremuerunt), cioè un paragrafo avanti rispetto a quellodell’edizione critica (il copista di G, pur andando a capo e iniziando un nuovo paragrafo, non lo hasegnalato con un capolettera). Tali mss. mostrano così l’esistenza di un legame fra i quattro esem-plari sopra elencati, che di fatto isola ancora di più il già solitario E, andando oltre le affermazionidi SHAW contenute sia nell’edizione elettronica, sia nella successiva edizione critica (cfr. EN, p.281), da cui risulta che β3 avrebbe all’interno del gruppo esclusivamente «[...] una lista di varianticomuni a coppie di manoscritti». Sempre nell’edizione elettronica un’altra imprecisione si trova aIII.x, 12. Qui alcuni manoscritti β, presentano un nuovo inizio capitolo (A2 F N P, cui ora si associaY: Amplius. In pratica è l’intera famiglia β2 cui si aggiunge A2), ma SHAW invece, in una nota edi-toriale ad A, sostiene che «only ms. A begins a new chapter at this point» e analoga dichiarazionefa per il Feliniano, salvo poi sostenere nello stesso luogo in P che «the scribe starts a new chapterhere»; infine in N è poi lo stesso copista a segnalare l’inizio del capitolo con la dicitura Ca(pitulum)xi, anticipato di qualche paragrafo rispetto ai testimoni non β2. Questa stessa caratteristica formaleviene invece correttamente riconosciuta da SHAW nello studio dedicato al ms. Additional 6891, eusata per confermare una volta di più l’appartenenza del nuovo testimone inglese alla famiglia β2.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 129
con Declaranda K inizia un nuovo capitolo42. Ciò che però né Ricci né Shawosservano, e che pare a me invece rilevante, è che proprio K, con Declaranda,nel cominciare un nuovo capitolo a II.v, 18 si congiunge a β2 e β343.
A II.x, 1, nessun manoscritto β (di cui ora fa parte anche A2) segnala l’iniziodi un nuovo capitolo. Anche in questo caso K si congiunge a β, lasciando isolatoT, ormai unico testimone di α44.
Sommando a questi indizi gli errori che accomunano K ed E, fra cui i treesclusivi dei due testimoni, ritenuti da Prue Shaw stessa non facilmente spiega-bili45, mi pare che vada rafforzandosi l’ipotesi che K, l’editio princeps, sia for-temente connessa con l’area β, forse vicina a β3, o come cercheremo diargomentare più avanti, in una posizione intermedia fra β2 e β346.
È in questo contesto, allora, che l’assenza del famoso inciso in K acquistaun senso affatto differente e potrebbe spingere ulteriormente nella medesima di-rezione. Se infatti Ricci e Shaw non hanno ritenuto rilevante il fatto che l’inciso
42 RICCI, EN 1965, pp. 97-98. A questo si deve aggiungere che D presenta un ulteriore iniziocapitolo a II.x, 4 (Sed ergo) in questo associandosi a S di β4 (SHAW nell’edizione elettronica afferma,certamente per una svista, che D è il solo manoscritto a comportarsi in questo modo e altrettanto facon S). S a sua volta non inizia il capitolo a II.ix, 12 ma a II.ix, 15 (Cumque). La posizione di R nonè deducibile in maniera univoca dalla trascrizione: sembra effettivamente che vada a capo per ini-ziare un nuovo capitolo, ma non vi è indicazione di un capolettera. In ogni caso, secondo le con-vincenti argomentazioni di SHAW, R è un descriptus di E. Nulla infine si può dire di P, il quale haqui una vasta lacuna. A margine di queste osservazioni si può notare che il volgarizzamento di Fi-cino, che secondo RICCI, EN 1965, pp. 102-05, è di area β3 - β4, si avvicina in effetti specialmentea E più che a R (una piccola conferma si ha forse a I.i, 1, dove Ficino traduce in lui seguendo E cheha in eo contro R che ha in ea). Il volgarizzamento mostra tuttavia un tenue legame anche con G:mentre tutti i testimoni recano a II.ix, 12 «Sed Romanus populus», G ha «Et Romanus populus» eFicino ha «El popolo romano» a fronte, ad esempio, del volgarizzamento anonimo, che allo stessopunto legge «Ma il popolo romano».
43 Cfr. nell’edizione elettronica le Transcription Notes relative all’editio princeps: «The begin-ning of each new chapter is simply marked by the beginning of a new paragraph. Thus (in accor-dance with some manuscripts but not others) there is a new chapter at Declaranda igitur on p. 106,and at Adhuc dicunt on p. 163». La riga che segnala l’inizio di un capitolo è sempre rientrata da si-nistra rispetto al corpo del testo. È vero che K si comporta allo stesso modo anche dopo la citazionedi un testo poetico, puntualmente reso in carattere corsivo; questo accorgimento, però, fa sì che ledifferenze fra i due sistemi siano immediatamente e facilmente riconoscibili. Segnalo che il volumecontenente l’editio princeps è ora disponibile in internet: http://books.google.com.au/books?id=wRxEAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0 (ultimo accesso04/2012).
44 A dire il vero SHAW (Cfr. Transcription Notes al testimone nell’ed. elettronica) rileva corret-tamente il comportamento dell’editio princeps nel libro II, ma non rileva che l’assenza del capitoloII.x, 1 è di K + β.
45 Cfr. SHAW, EN, p. 244 e EAD., Un secondo manoscritto cit., pp. 243-44, in cui la posizione èleggermente modificata. Si veda inoltre RENELLO, L’edizione critica cit., pp. 155-60. Rettifico quiquanto ebbi già a dire in quel precedente lavoro in cui ipotizzavo K in area β ma indipendente daglialtri manoscritti. Soprattutto mi dolgo di non aver letto in passato il lavoro di ROSSI, che precorreper altra via conclusioni assai vicine a quelle che qui avanzo e che anzi, pur adducendo come provalezioni non valide, arriva a ipotizzare (p. 193), sulla scorta anche di BERTALOT, che K ed E sianoimparentati.
46 Vedi infra.
GIAN PAOLO RENELLO130
in P e F fosse lacunoso (nel primo parzialmente, nel secondo totalmente) e si eraarrivati addirittura a sostenere, sulla base dell’autorità di α e di gran parte di β,che l’editore della princeps avesse volutamente stralciato l’inciso, ritenuto pre-sente nel suo esemplare di riferimento, ora la comparsa di Y altera il panorama.Possiamo cioè supporre che K rientri a pieno titolo fra i testimoni che mostranouna criticità nel passo e che questi sono quindi quattro e non più tre: due non ri-portano l’inciso (K per intero F mantenendo sicud in), uno riporta una frase dicui solo l’ultima parte è comprensibile (Y), il quarto riporta solo l’ultima parteche però differisce da Y (P). A questo punto anche la storia editoriale della prin-ceps richiede un supplemento di indagine secondo questa nuova prospettiva.
Torniamo dunque all’edizione del 1559, anzi: torniamo alle due edizioni del1559, la princeps di Oporino e la traduzione in tedesco del trattato di Dante, cu-rata da Heroldt per l’editore Bischoff (Episcopius). In particolare sarà quest’ul-tima la prospettiva privilegiata dalla quale operare, a mia conoscenza per la primavolta, il confronto con l’editio princeps e il volgarizzamento di Ficino.
3. Heroldt fra editio princeps e Ficino
Il titolo completo della prima traduzione tedesca è Monarchey Oder Daszdas Keyserthumb, zu der wolfart diser Welt von nöten: Den Römern billich zu-gehört, vnnd allein Gott dem Herrn, sonst niemands hafft seye, auch dem Bapstnit. Herren Dantis Aligherij Des Florentiners ein zierlichs Büchlein, in drey teylauszgeteilt. Vn vor zweihundert dreyszig dreyen jare, zu vertaedigung der Würdindes Reychs Teütscher Nation Lateinisch beschriben: vormals nie gesehen auchneüwes verdolmetscht. Durch Basilium Joannem Heroldt, Basilea, 1559.
Il volume contiene, nell’ordine, la prefazione-dedica di Heroldt a GioacchinoII, principe elettore e margravio di Brandeburgo, e, a seguire, la traduzione delproemio di Ficino e quella del volgarizzamento vero e proprio47.
Ogni capitolo, esattamente come nell’edizione ficiniana, presenta all’inizioun trafiletto in corsivo e termina con il numero di capitolo corrispondente. I tra-filetti dell’edizione tedesca sono traduzioni generalmente più stringate ed essen-ziali e quindi non sempre precisamente corrispondenti agli omologhi italiani.Un esame più accurato del volume mostra, poi, che Heroldt non ha seguito pe-dissequamente la scansione dei capitoli del volgarizzamento; se in alcuni casiappare evidente come ciò sia dovuto a semplice disattenzione, in altri la causa èa mio giudizio da ricondurre a probabili scelte editoriali autonome; altri casi an-cora vanno infine connessi, come intendo mostrare, ai controlli incrociati con ilmanoscritto latino di riscontro che Heroldt dichiara, nella sua introduzione, diaver utilizzato48.
47 Gioacchino II, divenne margravio e principe elettore di Brandenburgo nel 1535. Sotto la suagiurisdizione, nel 1539, la marca di Brandenburgo aderì alla Riforma.
48 «[…] so ich erst aus Italienischer spraach wie es der über die mass gelehrt herr Marsilius Fi-cinus verdolmetscht hat ins Teütsch bracht und hernach gegen dem Lateinischen als es mir zur hand
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 131
Il primo libro è formalmente diviso in quindici capitoli, contro i diciotto delvolgarizzamento e i sedici che costituiscono la norma, attestata dall’edizione cri-tica. Anche là dove il numero dei capitoli sembra corretto, undici nel secondolibro e sedici nel terzo, la scansione interna è tuttavia assolutamente differentedall’ordine ritenuto canonico49.
Una prima oggettiva ragione di tale differenza è dovuta al fatto che nell’edi-zione tedesca il primo capitolo di ogni libro, con una piccola eccezione nel primoe nel terzo di essi, corrisponde in realtà al secondo del libro corrispondente nellaversione ficiniana50. Ciò accade perché Heroldt fa precedere ad ogni primo ca-pitolo dei tre libri un proemio (vorrede), che lui considera d’autore, ma che difatto è il primo capitolo del libro omologo nel volgarizzamento. Suppongo cheil traduttore sia stato tratto in inganno dalla dicitura italiana; all’inizio del primocapitolo del primo libro, Ficino parla infatti di un “proemio” dell’autore, e di“proemio” parla anche negli omologhi capitoli degli altri due libri; da qui pro-babilmente la decisione di Heroldt di ignorare la successiva indicazione, chepure compare in ciascuno di essi, di «primo capitolo»51. Una conferma che forseper Heroldt le cose stessero in questo modo si trova alla fine del “proemio” alprimo libro: qui infatti il traduttore inserisce, in completa difformità dalla ver-sione ficiniana, e ritenendolo una degna conclusione, un epitaffio da lui consi-derato dell’Alighieri, che altro non è che lo stesso che si trova inciso sulsarcofago del poeta a Ravenna, dettato da Bernardo Canazzo Scannabecchi.
La numerazione dei capitoli nel primo libro conosce però altri e ben più in-teressanti scarti: al primo capitolo della versione heroldtiana corrisponde, infatti,l’unione dei capitoli secondo e terzo di Ficino, il quale, a sua volta, aveva invecediviso quello che di norma è il secondo capitolo del trattato. La decisione di riu-nire i due capitoli è a mio avviso importante: essa infatti si può spiegare solosupponendo che a Heroldt così si presentasse il manoscritto latino di riscontro,perché senza un’altra fonte di informazione cui attingere non avrebbe certo po-tuto immaginare la scansione esatta dei capitoli del volume. L’ipotesi trova con-ferma in altri due capitoli del volgarizzamento del primo libro: il quinto e sestocorrispondono infatti da un lato al solo capitolo terzo della versione di Heroldt,
kommen gehalten und rechtgemacht [...]». Cfr. HEROLDT, Monarchey cit., p. X. Per i problemi con-nessi alla numerazione di pagina nell’edizione tedesca si veda la nota successiva. Purtroppo al mo-mento non vi è alcun modo di valutare con precisione il rapporto che intercorre fra la versione diFicino, il manoscritto latino di controllo e gli interventi editoriali di HEROLDT. Si tratta di un aspettoa mio giudizio non secondario, che dovrebbe essere approfondito a partire da un’analisi assai piùdettagliata della versione tedesca, della quale forse non sarebbe inutile una traduzione italiana.
49 L’introduzione, la traduzione del proemio di Ficino e del primo capitolo, da HEROLDT ritenutoinvece proemio di Dante al primo libro, si trovano nelle pagine non numerate che precedono il trat-tato dantesco, il quale comincia dunque a p. 1 con quello che in realtà è il secondo capitolo delprimo libro. Le pagine precedenti, a partire dalla prefazione, saranno numerate, per convenienza,in cifre romane.
50 Nel primo libro il primo capitolo del trattato tedesco inizia dal secondo paragrafo del secondolibro. Discuteremo oltre le possibili ragioni di tale scostamento.
51 «Cominc[i]a la Monarchia di Dante Alighieri, et prima el proemio dov’egli annunzia doveredare notizia di detta tenporale monarchia. Capitolo i». Cfr. P. SHAW, La versione ficiniana della«Monarchia», in «Studi Danteschi», LI (1978), pp. 289-408, a p. 328.
GIAN PAOLO RENELLO132
dall’altro a quello che è normalmente ritenuto il capitolo quarto del trattato latinoe quindi, c’è da supporre, anche del relativo manoscritto di controllo. La con-clusione che si impone mi pare ovvia: Heroldt ha volutamente ignorato le divi-sioni dei capitoli stabilite, o meglio aggiunte, da Ficino là dove esse noncorrispondevano a quelle del manoscritto latino di riscontro, ritenendole indebite.Fatti gli opportuni calcoli e le necessarie verifiche si trova dunque che il capitoloquarto dell’edizione di Heroldt, corrisponde al settimo del volgarizzamento e alquinto del manoscritto latino. La sfasatura di un capitolo rispetto al manoscrittolatino e di tre rispetto al volgarizzamento rimarrà sostanzialmente invariata, purse viziata da altri errori di conteggio, per il resto del trattato. Dopo il capitolosettimo Heroldt passa, ad esempio, direttamente al capitolo nono, salvo poi nu-merare come nono anche il capitolo successivo, segno che si era probabilmenteaccorto dell’errore di numerazione del capitolo precedente. Un errore simile sitrova anche dopo il dodicesimo capitolo; il tredicesimo è infatti numerato allostesso modo e l’errore sarà corretto al capitolo successivo, numerato come quat-tordicesimo. Nonostante queste sviste la ripartizione del primo libro concepitada Heroldt in un proemio e quindici capitoli è da considerare sostanzialmentecorretta, in quanto corrisponde ai sedici capitoli in cui si ritiene che normalmentesia suddiviso il primo libro.
La scansione dei capitoli del secondo libro della versione tedesca porge ildestro ad ulteriori riflessioni. Esso è costituito, oltre che dal solito proemio, daundici capitoli invece dei dieci attesi. Questo perché, mentre non stupisce trovare,a p. 89, l’inizio del capitolo quinto, corrispondente a II.v, 18 dell’edizione critica,ma in perfetta sintonia con la divisione attuata anche da Ficino52, più problema-tica appare invece l’introduzione di un nuovo capitolo a II.x53: là dove tutti i ma-noscritti β, e quindi anche Ficino, ignorano tale divisione, Heroldt sembraassociarsi ad α tramite T, rimasto ormai unico rappresentante di quella famiglia.
Cominciamo con l’interruzione a II.v, 18. Abbiamo già osservato che Heroldtcorregge le divisioni dei capitoli stabilite da Ficino quando queste non corri-spondono a quelle del manoscritto latino. Se nel secondo libro, invece, la divi-sione del capitolo a II.v, 18 è stata mantenuta, rispettando l’identica divisionedel volgarizzamento, ciò significa, allora, che anche il manoscritto latino conte-neva la medesima suddivisione. Tale divisione è però esclusiva delle famiglieβ2 e β3; ci troveremmo dunque di fronte ad un interessante indizio di collega-mento fra il manoscritto di riscontro utilizzato da Heroldt e questa particolarearea della famiglia β, indizio che, come abbiamo ricordato sopra, è condivisoanche dall’editio princeps.
Veniamo ora alla situazione di II.x, 1. Come già detto, con l’introduzione diun nuovo capitolo in questo punto, il secondo libro nella versione heroldtianaabbandona inaspettatamente β per allinearsi ad α, mentre K si comporta allastregua di tutti i manoscritti β. Poiché Heroldt agisce diversamente è lecito do-mandarsi la ragione di tale scelta. Si possono presentare logicamente diverse si-
52 Per il quale ovviamente è invece il capitolo VI.53 Cfr. HEROLDT, Monarchey cit., p. 121.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 133
tuazioni: il manoscritto di controllo presentava un capitolo a II.x, 1 – e quindi oera contaminato con α o era un secondo manoscritto – oppure tale inserzione èstata decisa autonomamente da Heroldt. L’idea di un secondo manoscritto, an-corché non impossibile, non pare la più economica né la più probabile, senza direche il traduttore non ne fa mai cenno. Che qui il manoscritto fosse contaminatocon α implicherebbe che anche K si sarebbe dovuto comportare nello stessomodo, cosa che invece non è avvenuta54. Pare allora più sensato supporre che He-roldt abbia agito autonomamente introducendo un nuovo capitolo; probabilmenteha ritenuto che la frase del paragrafo precedente chiudesse un ragionamento cherichiamava in forma circolare la frase di apertura del capitolo stesso, mentre ilparagrafo successivo si apriva con nuove argomentazioni. Sembra insomma che,in questo caso, Heroldt si sia dato un certo grado di autonomia, sia da Ficino, siadal manoscritto latino; dovremo quindi integrare la precedente ipotesi fatta in me-rito al rifiuto delle divisioni dei capitoli adottata dal volgarizzatore italiano: He-roldt si è scostato da Ficino o perché il manoscritto latino differiva dalvolgarizzamento o anche perché le modifiche introdotte dal filosofo italiano nongli erano parse logicamente giustificate dalla struttura dell’argomentazione. Inaltre parole l’editore tedesco ha valutato attentamente, leggendole, tanto la tra-duzione italiana, quanto la versione latina, decidendo caso per caso se conformarsio meno ai testi che si trovava davanti. D’altronde il capitolo a II.x, 1 rappresentail solo momento nella suddivisione dei capitoli in cui Heroldt si trova d’accordocon T. A meno di non trovare altri elementi di comunione con quel testimone,sembra più economico immaginare che egli abbia deciso in questo preciso casodi muoversi in maniera indipendente dal modello ficiniano e da quello latino,piuttosto che pensare a un testo contaminato55.
Possiamo a questo punto aggiungere che anche l’inizio del primo capitolo delprimo libro, il secondo nel volgarizzamento di Ficino, ci pare rientri in questoschema. Esso infatti, come già detto, non comincia dal primo paragrafo, che sitrova invece nel proemio, ma dal secondo:
Primum quidem igitur videndum quid est quod «temporalis Monarchia» dicitur, typout dicam et secundum intentionem.
Heroldt ha probabilmente ritenuto che l’annuncio dell’argomento iniziale delprimo libro della sua edizione meglio si adattasse a chiudere la prefazione. In-fatti, mentre nel testo latino il secondo paragrafo continua il primo:
Est ergo temporalis Monarchia, quam dicunt «Imperium», unicus principatus et superomnes in tempore vel in hiis et super hiis que tempore mensurantur.
Il testo tedesco, invece, anche grazie ad una forma decisamente più assertiva,
54 Si potrebbe certo ipotizzare un intervento editoriale, ma francamente non se ne vede né ilsenso né la necessità.
55 HEROLDT avrebbe insomma agito in base alla stessa logica individuata da RICCI, EN 1965, p.98, per cui a un nuovo argomento va assegnato un nuovo capitolo.
GIAN PAOLO RENELLO134
in cui spicca la soppressione del corrispettivo di ergo, contribuisce a dare il sensodi un nuovo inizio56.
Il terzo libro è anch’esso problematico. Consta del solito proemio cui seguononon quindici, ma sedici capitoli e una conclusione che in realtà corrisponde aitre paragrafi finali dell’ultimo capitolo del trattato, riconoscibile anche in questocaso da un trafiletto in corsivo che la precede e che esplicitamente annuncia laconclusione dell’opera57. Anche in questo caso il primo capitolo mostra delledifferenze rispetto a Ficino e alla versione latina: esso infatti include anche l’ul-timo paragrafo, il quinto, del capitolo precedente, che per Heroldt corrispondeal proemio58.
A ciò si deve aggiungere che, di nuovo, il sistema di numerazione rivela unacerta confusione da parte dell’editore. Innanzitutto il capitolo quinto comprendeanche il capitolo sesto, vale a dire il settimo della versione italiana59. Nel capitolosuccessivo le cose tornano comunque a posto, perché Heroldt lo numera noncome sesto ma come settimo, segno che anche in questo caso si è accorto di avercommesso un errore unendo i due capitoli precedenti. Un’altra variazione nelcomputo dei capitoli si ha con il salto dal capitolo nono al capitolo undicesimo60,che a questo punto, e del tutto casualmente, corrisponde all’omonimo capitolodell’edizione ficiniana. Si tratta anche qui, certamente, di una svista, ma essa èimportante. Va preliminarmente osservato, infatti, che se il capitolo undicesimodi Heroldt e quello di Ficino si corrispondono, ciò è possibile solo perché tantoHeroldt quanto Ficino non spezzano il capitolo decimo al paragrafo 18 introdu-cendo un nuovo capitolo, in accordo in ciò con β - MD e contro KT + MD, linea,quest’ultima, accettata poi anche dall’edizione critica di Ricci61. Heroldt, oltre-tutto, non correggerà la numerazione al capitolo successivo. Quello che però quiinteressa rilevare è che anche in questo caso l’editore tedesco, avendo rispettatol’aggiunta del capitolo ficiniano, deve averlo fatto perché ha trovato, per quantoda noi detto sopra, un analogo comportamento nel manoscritto di controllo. Siamodunque di fronte a un nuovo e interessante indizio: solo i manoscritti della fami-glia β3 con l’esclusione di D, presentano contemporaneamente un nuovo capitoloa II.v, 18 e, come visto sopra, non hanno la suddivisione di capitolo a III.xi.
Possiamo in tal modo restringere ulteriormente l’area di collegamento delmanoscritto di controllo a quest’ultima famiglia. Per spiegare poi la posizioneeccentrica di D, si può notare che, nell’edizione Ricci esso fa parte con M della
56 HEROLDT, Monarchey cit., p. 1: «Die zeitlich ehnig herrschafft so da genannde wirt eyn Key-serthumb oder Monarchey ist eyn eynige herrschafft und über alle andere fürstenthumb inn der zeitoder inn den dingen oder ob den dingen inn den zeit gemesse werden». La definizione sembra, adire il vero, tagliata su misura per la Germania dell’epoca, visto che la Monarchia è definita comesignoria al di sopra «di tutti gli altri principati».
57 Ivi, p. 205: «Beschluß rede wie hoch der Keiser dem Papst verbunden».58 Ivi, p. 133.59 Ivi, p. 159, primo capoverso.60 Ivi, p. 183.61 L’edizione SHAW inserisce invece un nuovo capitolo a questo punto, in accordo con KT +
MD. Si vedano le persuasive argomentazioni di tale scelta editoriale alle pp. 329-30.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 135
famiglia β4, discendente con quest’ultimo da un comune progenitore x9, mentrenell’edizione Shaw appartiene a β3, con M sempre in β462. Entrambi gli editoriargomentano, credo con ragione, in favore di uno stretto collegamento fra i duetestimoni, fra loro contaminati; ciò fa sì però che la posizione stemmatica delprimo non sia così univocamente determinabile come attestano ancora le osser-vazioni di Shaw63.
Il fatto che K qui si discosti dalla maggioranza dei testimoni β e si associ aT non mi pare poi possa essere ritenuto un indizio sufficiente di una assenza diparentela fra β e l’editio princeps. È possibile infatti che lo stesso editore di Ksia intervenuto accorgendosi che a III.x, 18 in realtà la struttura argomentativarichiedeva un nuovo capitolo, con un ragionamento analogo a quello svolto daShaw64.
Il trattato procede poi in maniera regolare fino all’ultimo capitolo, il quindi-cesimo. Qui Heroldt si discosta di nuovo e definitivamente da Ficino, e credoanche dal manoscritto, introducendo dapprima un nuovo capitolo, il sedicesimo,in corrispondenza di III.xv, 12 del volgarizzamento e successivamente una con-clusione a xv, 16. L’introduzione del nuovo capitolo a III.xv, 12 può essere giu-stificata dal fatto che il paragrafo precedente deve aver dato all’editorel’impressione, come già a II.x, 1, di aver terminato lo svolgimento di un ragio-namento e che quindi quanto seguiva non facesse parte dello stesso capitolo.Decisamente più interessante è invece quanto avviene a III.xvi, 6, anche visiva-mente percepibile come un capitolo a sé; qui infatti Heroldt si accorda precisa-mente con il ms. P, il quale è il solo fra tutti i testimoni noti a iniziare nelmedesimo luogo un nuovo capitolo. È possibile che Heroldt avesse autonoma-mente deciso che quest’ultima parte, composta dai tre paragrafi finali del trattato,andasse separata da ciò che precedeva, stante l’evidente valore di conclusioneche essa rappresentava, ma non si può in alcun modo escludere che egli avesseinvece trovato un qualche riscontro ancora una volta nel manoscritto latino chesegnalerebbe in tal caso collegamenti anche con β2.
Quali prime conclusioni, seppure parziali, si possono trarre a questo punto?A me pare un dato acquisito che il manoscritto latino utilizzato da Heroldt siada collegare a testimoni della famiglia β3, tenendo però ben presente che vannoancora meglio chiariti i rapporti fra tale famiglia e β2 con i quali, come abbiamoappena visto, e come cercheremo di mostrare meglio più oltre, è possibile chevi siano stati contatti. Questo anche nonostante i due nuovi capitoli, uno a II.x,1 e l’altro a III.xv, 12, per i quali abbiamo avanzato l’ipotesi di un’iniziativa per-sonale dell’editore non strettamente legata all’edizione latina di riferimento65.
62 Gli stemmi sono visibili in SHAW, EN, p. 239 e p. 301.63 Cfr. EN, pp. 289-92, che riprende RICCI.64 Ivi, pp. 269-71.65 All’indirizzo internet http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00039127-5 (ultimo ac-
cesso 14/02/2012) del sito della Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek e dellaBayerische StaatsBibliothek è finalmente possibile consultare ed eventualmente scaricare l’edizionetedesca del 1559.
GIAN PAOLO RENELLO136
4. Heroldt fra α, β e K
L’analisi fin qui condotta della struttura dei capitoli dei testimoni latini, delvolgarizzamento di Ficino e della traduzione di Heroldt ci ha portato ad affermareche sotto questo aspetto K sembra appartenere alla famiglia β. Vogliamo ora ag-giungere, a supporto di questa ipotesi, un’indagine più accurata, benché forzata-mente parziale, della sostanza testuale del testimone tedesco, con l’intento dicercare elementi che permettano di stabilirne la provenienza e chiarirne megliole relazioni in particolare proprio con l’editio princeps e il manoscritto di con-trollo.
Una prima verifica fornisce immediatamente un’informazione importante cheva apparentemente in direzione opposta alla nostra tesi: la versione heroldtiana èpriva delle due lacune che, individuate da Ricci, contraddistinguono tutta la fa-miglia β2.
La prima, a I.viii, 4, è dovuta a un saut du même au même. Giova, per le con-clusioni che ci interessano, riportare intanto il passo quale si presenta in A1T enella versione tedesca:
Sed tunc genus humanum [T: humanum genus] maxime est unum quando totum uni-tur in uno quod esse non potest nisi quando uni principi totaliter subiacet ut de sepatet. Ergo humanum genus uni principi subiacens maxime deo simillatur et per con-sequens magis est secundum divinam intentionem quod est bene et optime se habereut in principio huius capituli est probatum.
So ist menschliches geschlecht am maisten aines wann es sich samptlich verainigt ineinem den dann nit sein mag weder eben so es ainem fürsten zumal underthon wiedann für sich selbs erscheint. Also so menschliches geschlecht ainem fürsten under-thon so vergleicht es sich Gott am maisten und eben in disem fal so ist es dann Gottam aenlichten und nach seinem fürnemen am maisten den im am basten kompt wieoben bewaert67.
La lacuna in β è stata per comodità sottolineata sia nel testo latino, sia nellacorrispondente traduzione tedesca. Ecco ora come si comporta il volgarizza-mento di Ficino, che già Ricci aveva stabilito provenire da un manoscritto dellafamiglia β3, ovviamente lacunoso:
Et allora la generazione humana è massime huna quando tutta inn-uno s’unisce, equesto non può essere se non quando è subgetta a uno principe. Per la qual cosa alloras’assomiglia massime a Dio e così è secondo la ’ntentione sua, e hottime si conduce68.
66 RICCI, EN 1965, p. 51.67 HEROLDT, Monarchey cit., p. 23.68 SHAW, La versione ficiniana cit., pp. 336-37. Curiosamente FICINO ha articolato il periodo in
due frasi, mentre la lacuna le aveva ridotte a una. Per far ciò ha introdotto «Per la qual cosa» esat-tamente là dove andava, quasi avesse “visto” la congiunzione «Ergo» che, nella versione latinacompleta, inizia effettivamente la seconda frase come conseguenza della prima. Forse ha anticipatoil «per consequens» successivo che a sua volta viene reso con «e così». Sullo stile della traduzione,visto anche in opposizione a quella del volgarizzatore anonimo, si vedano le pp. 308-24 dell’intro-
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 137
Poiché certamente una simile corruttela non poteva essere sanata dall’editoretedesco in alcun modo per congettura, la sola possibilità che rimane è che Heroldtabbia fruito di un testo latino che presentasse il passo completo. La convalida diquest’ipotesi si ricava esaminando la parte finale di questo stesso periodo, doveemerge un’altra differenza fra Heroldt e Ficino. La frase «ut in principio huiuscapituli est probatum», assente nella versione italiana, ma presente in tutti i mss.noti, si trova anche nel testimone tedesco (in corsivo nella citazione), pur se tra-dotta in forma più sintetica. Se da un lato questo può essere indizio di una certalibertà del traduttore italiano, dall’altro è evidente che Heroldt aveva consultatosenz’altro un altro esemplare, per mezzo del quale verificare la traduzione edeventualmente correggerla o completarla ove necessario.
Ci si potrebbe a questo punto legittimamente domandare se l’esemplare inquestione non fosse proprio l’editio princeps, ma tale eventualità è decisamenteda escludere. Ecco infatti come K legge il medesimo luogo:
Sed tunc genus humanum maxime est unum quando totum unitur in uno quod essenon potest nisi quando uni principi totaliter subiacens ut de se patet. Ergo humanumgenus uni principi maxime Deo assimilatur et per consequens maxime est secundumdivinam intentionem quod est bene et optime se habere ut in principio huius Capituliprobatum est69.
Leggendo il passo si constata in primo luogo che, contrariamente a quantosostenuto da Pier Giorgio Ricci, il gruppo KA1T non si presenta qui così unito70.L’editio princeps differisce infatti in una lezione da T e in altre due da A1T; indue casi si tratta di un’inversione: nel primo K legge «Sed tunc genus humanum»dove T (con Ph) ha «Sed tunc humanum genus»; nel secondo K si accorda conPh leggendo «probatum est» contro «est probatum» di A1T. La terza differenzaè tuttavia quella più importante perché in K si trova, al posto di subiacet di A1T,la forma subiacens (sottolineata nel testo), che viene invece eliminata nella fraseimmediatamente seguente. Si può ritenere che tali differenze derivino da un in-tervento editoriale di Oporino, anche se nel terzo caso l’ellissi che ne risulta ob-bliga ad uno stravolgimento del senso della frase per non renderla innaturale71.Heroldt invece è rimasto più fedele al testo latino di riscontro. Ad ogni modoproprio la diversa posizione di subiacens nella stampa di Oporino chiarisce senza
duzione di SHAW al volgarizzamento del filosofo. Il passo comunque non doveva presentarsi cosìlimpido, se anche l’anonimo ha sentito l’esigenza di dividere in due frasi il periodo: «Ma allora lagenerazione umana massime è una quando tutta è unita inn-uno: che essere non puote se non quandoa uno principe è suggetta. E allora massimamente a Dio si risomiglia, e per conseguente massima-mente è secondo la divina intenzione: che è bene e ottimamente stare, come nel principio di questocapitolo è provato». Cfr. P. SHAW, Il volgarizzamento inedito della «Monarchia», in «Studi Dante-schi», XLVII (1970), pp. 59-224, a p. 136. Come si vede, anche l’anonimo ha dato un senso conclu-sivo e coordinato alla seconda frase, pur se con eleganza minore, come mostra la ripetizione di«allora». Inoltre non sopprime la frase finale come invece fa Ficino.
69 Cfr. Editio princeps, p. 67.70 RICCI, EN 1965, p. 51.71 Per un’ipotesi alternativa su subiacens si veda alla fine del presente lavoro, la n. 123.
GIAN PAOLO RENELLO138
ombra di dubbio che Heroldt ha utilizzato davvero un manoscritto di controllo,perché altrimenti la traduzione di questo luogo concorderebbe esattamente conl’editio princeps e in particolar modo non conterrebbe due occorrenze del verbosubiacere (underthon) quando ne compare una sola in K.
La seconda lacuna che ha permesso a Ricci di identificare β si trova a I.xiii,3, dove, in chiusura di paragrafo, si legge la frase «quod si aliter aliquid agereconetur, frustra conatur». Di nuovo Heroldt, pur con una traduzione stringata enon letterale, si presenta puntuale all’appuntamento, mentre Ficino, in linea conla famiglia di appartenenza rimane muto72. Ricci aveva poi individuato un’altrainteressante traccia che gli permetteva di separare quella che per lui era la fami-glia α da β: a II.v, 15, dove β, e di conseguenza Ficino, leggono «autore», Heroldt,con la lezione «beschirmer», si unisce a KA1T, leggendo «tutoris»73.
A prima vista pare proprio che il manoscritto utilizzato da Heroldt per la re-visione del testo tedesco tradotto da Ficino presenti una serie di elementi che louniscono a KA1T. Tale relazione non è tuttavia così stretta come si potrebbe pen-sare, e questo a causa di altre differenze degne di nota che coinvolgono, questavolta in negativo, solo Heroldt e A1T, ovvero la famiglia α nell’edizione Shaw.
A II.iii, A1T presenta una vistosa lacuna, mancando dei paragrafi 12, 13 e 16.Tale lacuna non si registra invece in K + β + Heroldt, oltre che, va da sé, in Fi-cino74. Una seconda lacuna, caratteristica anch’essa solo di TA1, si trova a I.viii,3, ma di nuovo essa non si riscontra in Heroldt, anche se la traduzione apparepiù sintetica. La frase latina mancante è «Sed genus humanus maxime Deo as-similatur quando maxime est unum»; al suo posto in Heroldt troviamo «abereben da macht es sich am aenlichsten wann es ganz am maisten ainzig», tradu-zione che a sua volta si stacca da K, direi volutamente, per seguire Ficino che inquesto punto legge: «Ma questa massime a·llui s’assomiglia quando è massimehuna [...]»75. Infine una terza lacuna di A1T individuata da Ricci si trova a II.v,20, dove manca l’espressione «[...] quod quicunque finem iuris intendit cum iure
72 «Dann so es sich understünde ander werts etwas zu uben so ist es vergebens». Cfr. HEROLDT,Monarchey cit., p. 42.
73 Ivi, p. 87; SHAW, La versione ficiniana cit., p. 36174 Cfr. RICCI, EN 1965, p. 58. La prima lacuna è la seguente: «[12] […] terra antiqua, potens
armis atque ubere glebe. / Oenotri coluere viri; nunc fama minores / Ytaliam dixisse ducis de nominegentem: / hee nobis proprie sedes, hinc Dardanus ortus. [13] Quod vero Athlas de Affrica fuerit,mons in illa suo nomine dictus est testis, quem esse in Affrica dicit Orosius in sua mundi descrip-tione sic: “Ultimus autem finis eius est mons Athlas et insule quas Fortunatas vocant”; ‘eius’, idestAffrice, quia de ipsa loquebatur», per cui cfr. HEROLDT, Monarchey cit., pp. 71-72, il quale, per in-ciso, aggiunge che le isole Fortunate di cui parla il testo corrispondono alle Canarie. La seconda è:«Tertia Lavinia fuit, Albanorum Romanorumque mater, regis Latini filia pariter et heres, si verumest testimonium nostri Poete in ultimo, ubi Turnum victum introducit orantem suppliciter ad Eneamsic: “Vicisti, et victum tendere palmas / Ausonii videre: tua est Lavinia coniunx”. Que ultima uxorde Ytalia fuit, Europe regione nobilissima» per cui cfr. ivi, p. 73. Un’altra lacuna di A1T si trova aI.x, 5: «[...] sive Imperator. Est igitur Monarchia […]»; in HEROLDT, Monarchey cit., p. 26 troviamoinvece: «[...] oder Kaiser. Darumb so ist die eynzig Herrschafft [...]».
75 Ivi, p. 22. Editio princeps, p. 66. SHAW, La versione ficiniana cit., p. 336. Nel caso di FICINO
si deve pensare ad un intervento del traduttore che mira a rendere più scorrevole il testo piuttostoche a una qualche contaminazione con un testimone privo dell’espressione «genus humanum».
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 139
graditur», presente in Heroldt che traduce: «Wer sich auff das ende der billichaitrichtet der selb handelt nach dem, un das ende der billichait erheyscht [...]».
In conclusione il manoscritto utilizzato da Heroldt, privo delle lacune di β edi A1T rilevate da Ricci, si associa al solo K, o meglio al suo antigrafo, il qualesi conferma differente da tutti i mss. noti fino ad oggi. L’ipotesi più probabile edeconomica, in base a quanto sopra visto, è che l’editio princeps e la traduzionedi Heroldt abbiano condiviso una medesima fonte. Se così fosse, la posizionedel testimone tedesco, traduzione di un volgarizzamento italiano da un testo la-tino appartenente senz’altro alla famiglia β, ma privo delle lacune che la carat-terizzano, perché corretto sulla base del manoscritto latino fonte dell’editioprinceps, assumerebbe un’importanza decisamente superiore a quanto immagi-nato fino ad oggi. A questo si aggiunga che la stessa editio princeps potrebbe asua volta aver provocato interventi di Heroldt sulla propria stampa. Di qui anchela difficoltà nel discernere da quali di questi testimoni abbia attinto Heroldt pertradurre specifici passi dell’edizione tedesca del trattato. Si possono infatti darecasi in cui, a prescindere dal comportamento delle famiglie α e β, Heroldt si ac-corda con Ficino e K, o con K contro Ficino, o con Ficino contro K, o infinecontro entrambi76. Ne sia esempio il campione di verifica che segue, con l’av-vertenza che la situazione prevalente vede concordare fra loro Heroldt e Ficino,± K, né poteva essere altrimenti; più interessanti, ancorché minoritarie, sono tut-tavia le varianti di Heroldt contro K e Ficino o con K ma contro Ficino, perchéo indicano la provenienza da una fonte alternativa o sono il frutto di un’autonomascelta editoriale.
Heroldt con Ficino e K: è senz’altro la situazione più semplice per il tradut-tore, dato che vede confermato il testo italiano da cui traduce dall’accordo conil testimone latino a sua disposizione. In linea di massima si potrà comprenderese Heroldt riproduce fedelmente Ficino o segue, secondo linee più o meno di-vergenti, le lezioni dell’editio princeps o del manoscritto:
I.iii, 9: Heroldt legge Averrois con K + β + Ficino contro A1T (auctor)77.I.xiii, 3: I testimoni β + K leggono «Omne inquit» (V legge «omne id»),
omesso da A1, mentre T ha solo inquit. Heroldt, pur chiaramente connesso a β +K, ha «Deßhalb sagt Aristot. Eyn jedes ding [...]» sostituendo «Aristotele» al-l’antonomastico «Philosophus» di tutti i testimoni e seguendo così più da pressoFicino che a sua volta traduce: «però disse Aristotile nella ‘Metafisicha’: “Ognicosa […]”»78.
Heroldt con Ficino contro K: sono possibili due casi: nel primo Heroldt haadottato la lezione di Ficino e del manoscritto β di controllo, concordi fra loro;in tal caso la differenza con K può essere dovuta a mancata consultazione del
76 Andrebbero considerati anche i casi di difformità nell’ordinamento dei capitoli esaminatinella sezione 3 di questo studio.
77 HEROLDT, Monarchey cit., p. 10.78 Ivi, p. 42.
GIAN PAOLO RENELLO140
testimone a stampa o, come pare più logico, alla minore validità attribuita allesue lezioni, forse eliminate dall’editore usando probabilmente un criterio di mag-gioranza; in alternativa, Heroldt ha dato ragione a Ficino contro il manoscrittodi controllo e K, indipendentemente dal fatto che questo potesse essere d’accordocon l’antigrafo o avesse introdotto per via editoriale lezioni differenti facendoricorso al iudicium per stabilire a quale lezione dare la preferenza. Si noti chequesta categoria rientrano tanto l’autoriferimento dantesco quanto i tre errori co-muni a KE:
I.xii, 6: Sicut in Paradiso Comedie iam dixi. Heroldt, come è evidente, si ac-corda con Ficino nell’accogliere a testo l’autoriferimento.
I.xv, 1: KTA1 leggono «quintum modum», il testo tedesco presenta una tra-duzione che fa riferimento al «primum modum», caratteristico di β e Ficino79.
A II.v, 11: un esempio di diffrazione. K T + A D G L M U leggono alterumexemplum, E R leggono aliud, B C F H N P Ph S V Y Z leggono altum, da cuiFicino ha «grande exenpro» che Heroldt trasforma in sichtbarn zeychen80.
III.ii, 3: nell’espressione «in necessariis consequentis », consequentis è pre-sente in KT U ma manca in Heroldt, Ficino e β-U81.
A III.vi, 1: nella frase «Saul rex intronizatus fuit et de trono depositus per Sa-muelem», de trono è presente solo in KT contro β + Ficino + Heroldt82.
A III.xii, 8: solo K+E leggono iudicem per il corretto invicem, e così fa He-roldt, accordandosi dunque con Ficino ed il resto di β83.
A III.xii, 9: K + E leggono Decius per il corretto dicimus. Di nuovo Heroldtconcorda con Ficino + tutti gli altri testimoni84.
A III.xii, 11: solo KT leggono «per differentiam superpositionis»; la locuzioneè assente nella versione tedesca, in Ficino e nella famiglia β, ormai priva di QR85.
A III.xiv, 2: a Deo recipitur, è omesso in K + E ma presente in Heroldt e Fi-cino assieme a β-E86.
Heroldt con K contro Ficino: qui il traduttore può aver dato ragione al ma-noscritto di riferimento, che è anche lezione di K, contro una modifica introdottadal filosofo italiano. Assai meno probabili le altre due tesi: che Heroldt fossed’accordo con K ma non con il manoscritto, a sua volta d’accordo con Ficino;che i tre testimoni presentassero ognuno una differente lezione e Heroldt ha adot-tato quella dell’editio princeps:
79 Ivi, p. 51: «Weiter das ists eyner u gủt haben auff die erste weiß i ruffen oder beneenire stapfflen gegen eynander». La parola weiß deriva da wîs ‘modo’, ‘maniera’ (scil. in modum).Cfr. O. SCHADE, Altdeutsches Wörterbuch, Halle, Buchhandlung des Waisenhauses, 1872-1882, IIteil, p. 1170, s.v. wîs. Vedi anche M. LEXER, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, Leipzig, 1878Dritter Band, c. 938 (wîse, wîs).
80 Ivi, p. 85, SHAW, La versione ficiniana cit. p. 360.81 Ivi, p. 135.82 Ivi, p. 156.83 Ivi, p. 185-186: «so sollen sie sich einziehen under eynander».84 Ivi, p. 186: «Dann wir sagen nit also der Keyser ist Papst».85 Ivi, p. 187.86 Ivi, p. 193: «Dann was man von der Natur bekompt das bekompt man auch von Gott».
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 141
a III.xiii, 3, nell’espressione «illud, quo non existente aut non virtuante» autnon virtuante è presente in KTU + A B F H L M N P V Z + Heroldt, ma non inFicino87.
Heroldt contro Ficino e K: in questo caso o il manoscritto di controllo ripor-tava una lezione differente da K e Ficino, oppure il traduttore è intervenuto edi-torialmente sul testo, non trovando valide le alternative offerte da alcuno deitestimoni a sua disposizione, compreso lo stesso manoscritto di controllo:
I.iii, 6: altro classico caso di diffrazione: K ha la lectio singularis in anima-libus, A1T leggono in materialibus, nove testimoni leggono in mineralibus, le-zione accolta a testo da Shaw (E ha inumerabilibus, poi corretto dal copista).Heroldt dal canto suo legge i rtʒ, associandosi piuttosto alla lettura in mine-ralibus e non a Ficino, che, con «nelle cose naturali», sembra invece riferirsi a«in naturalibus», lezione presente solo in MS (in naturalibus) e, parzialmente,in Z (naturalibus)88.
A II.vii, 12: ait enim sic: “Scite Crhisippus [...]”, solo K presenta la lezioneaccettata da Ricci e Shaw sic: Scite, contro il sic te di tutti i manoscritti menoPh (sit) e T, che ha originariamente uno spazio vuoto successivamente riempitodal copista con scite. Heroldt non si accorda con K (e nemmeno con T), perchémanca sic scite, limitandosi a tradurre solo ait enim con und sagt. Allo stessotempo non segue Ficino in cui compare il solo sic: «in questo modo»89.
A II.viii, 1: si presenta un caso piuttosto complesso. L’edizione critica legge:«Nam, cum diremptio universalis litigii magis Deo sit cure quam diremptio par-ticularis, [...]»; la lezione diremptio... diremptio, a testo nell’edizione critica, èpresente nella sola editio princeps. La netta maggioranza dei manoscritti, e fraquesti anche l’Additional 6891, legge directio in entrambe le occorrenze (A B CD E F H L M N P Ph R S T U V Y Z la prima volta, gli stessi, eccetto A C G, laseconda). G presenta la coppia disceptio/directio, in cui solo il primo terminepassa in Ficino, seppur liberamente, con la traduzione «dichiarare». A C leggonoinvece directio/direptio (variante, quest’ultima, che potrebbe confermare indi-rettamente la lezione diremptio di K). Direptio di A C passa poi nel volgarizza-mento anonimo che traduce «distruzione»90. Heroldt legge «Dann Gott tregt
87 Così la versione tedesca, p. 189: «Das jenig on wolliches Sein oder on wolliches krafft [...]».SHAW, La versione ficiniana cit., p. 400. Il volgarizzamento del filosofo italiano in realtà qui è assaipiù conciso della versione latina. In ogni caso, nella frase immediatamente seguente: «aliud habettotam suam virtutem», aliud, accettato da SHAW, si trova in K e Ficino; T U leggono aliquid, HE-ROLDT invece ha eyn anders, che può valere tanto aliud quanto alterum, lezione però del solo M.Pare dunque più sensato ritenerlo in accordo con l’editio princeps ed il volgarizzamento ficiniano.
88 SHAW, La versione ficiniana cit., p. 331; HEROLDT, Monarchey cit., p. 8. Per una visione piùchiara della reale situazione testuale è utile l’utilizzo dello strumento word collation dell’edizioneelettronica. Per inumerabilibus del ms. E si veda, nella stessa edizione, la relativa immagine e laspiegazione fornita al riguardo da P. SHAW nella nota ad. loc. Per la traduzione rtʒ come minera-libus cfr. la voce mineralia in Glossarium Latinum-Germanicum mediae et infimae aetatis, suppl.al Lexicum mediae et infimae latinitais, a c. di L. Diefenbach, Fraconforte sul Meno, J. Baer, 1857,p. 362.
89 HEROLDT, p. 104; SHAW, La versione ficiniana cit., p. 367.90 SHAW, Il volgarizzamento inedito della «Monarchia» cit., p. 174. L’anonimo non traduce in-
GIAN PAOLO RENELLO142
hoher sorg all gemeynen zanck zůerlegen dann das stukweiß gezanckabzůleynen»91. Il traduttore si distacca chiaramente da K, come anche da tutti imanoscritti, perché invece di due sostantivi utilizza due verbi. Solo con K, poi,Heroldt si differenzia ulteriormente, perché nella traduzione i verbi sono diffe-renti e non sinonimi, mentre l’editio princeps usa in entrambi i casi il medesimosostantivo. Quanto ai verbi, «abzůleynen» significa ‘rifiutare’, ‘disapprovare’,‘opporsi’ e sembra intervento editoriale, dato che non trova riscontro in nessunmanoscritto noto92. Più complesso il caso del primo verbo, «zůerlegen»: da unlato esso potrebbe rimandare proprio a direptio93, anche se il significato del verboerlegen è ‘abbattere’, ‘uccidere’ specie in ambito venatorio e non presenta quelsenso di devastazione e distruzione richiamato dal termine latino. Un altro si-gnificato di erlegen è però legato al latino solvere e forse in questa accezione siricollega al sostantivo diremptio.
III.ii, 2: altro caso di diffrazione. L’edizione critica legge «Hec igitur irrefra-gabilis veritas prefigatur». Prefigatur è lezione di C D F G H P S U V; prefigu-ratur si trova in B L M N Ph T Z; K infine ha la lectio singularis premittatur,frutto probabilmente di un intervento editoriale. Il passo in Heroldt è così reso:«So stelle sich nun gleich dise unwiderwürffliche warheyt vornen an den an-griff», che si accosta al latino prefigatur, mentre nel volgarizzamento la formasi presuppone di Ficino pare più prossima a prefiguratur94.
5. K contaminato con T?
Se i controlli comparativi svolti tanto sul testo quanto sull’organizzazionedel volume tedesco paiono sufficienti a dimostrare che Heroldt ha sì tradotto daFicino, ma ha utilizzato anche un manoscritto da cui deriva l’editio princeps, ilproblema diventa allora la valutazione di detto manoscritto, il cui discendente èstato inizialmente posto da Ricci nella famiglia α, per poi essere stato successi-vamente elevato a ramo autonomo nello stemma codicum di Prue Shaw.
Muovendoci in direzione differente dai due precedenti editori, la nostra ipo-tesi è che questo manoscritto sia un esemplare di β che presenta estese e reci-proche contaminazioni fra le due famiglie, in grado di spiegare tanto l’assenzanel manoscritto di controllo delle lacune proprie a β e ad A1 viste sopra, quantoanche la particolare situazione testuale di I.xii, 6.
vece directio, che compare come primo termine nel testo latino. Anche Ficino non traduce i duetermini ma solo il primo di essi.
91 HEROLDT, Monarchey cit., p. 105. Leggo stukweiß in luogo dell’errato stnkweiß che apparenel testo a stampa.
92 Per leynen, leinen, lehnen cfr. le forme ablehnen, ableinen. Cfr. J. GRIMM, W. GRIMM, DeutchesWörterbuch, Leipzig, 1854, B. I, c. 71 (d’ora in avanti DW). Vedi anche LEXER, Mittelhochdeutschescit., B. I, s.v. lenen, c. 1868.
93 Per erlegen cfr. GRIMM, DW, B. III, cc. 897-898.94 HEROLDT, Monarchey cit., p. 134. Per angriff vedi R.R. ANDERSON, U. GOEBEL, O. REICHMANN,
Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, Berlin-New York, de Gruyter, 1989, B. I, s.v., c. 1188.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 143
In quest’ultimo caso la questione è inoltre complicata dal fatto che il recentetestimone londinese, portatore di una lezione inaspettata, rientra in β2; tutto som-mato la corruttela potrebbe interessare questa sola famiglia, la cui non facile si-tuazione testuale ha da sempre dato adito a svariate ipotesi, nessuna delle qualipare, per ora, avere un grado di affidabilità elevato.
Per quanto riguarda l’inciso si possono inizialmente considerare due possi-bilità. Nella prima la frase è non corretta o incompleta, come abbiamo prece-dentemente argomentato; in tal caso può trattarsi di una glossa presente giànell’archetipo, oppure, benché a nostro giudizio improbabile, è frase d’autore.La seconda invece ritiene che il verbo dixi finale potesse trovarsi in origine nellaforma dixit, lasciando pertanto in vita la sola ipotesi di una glossa. Lo stato del-l’arte degli studi sulla Monarchia non è in grado attualmente di fornire elementicerti non solo per discutere quale delle due ipotesi sia più probabile, ma neppureper stabilire se sia una glossa o un inciso d’autore. Pier Giorgio Ricci non ebbedifficoltà al riguardo a redarguire aspramente tutti coloro che si opponevano allapresenza dell’inciso nel testo critico, con parole, dal suo punto di vista, perfet-tamente pertinenti95:
Contro l’inciso seguitano ad accanirsi tutti coloro che lo paventano come ostacolo adatare la Monarchia ad anni anteriori agli ultimi della vita di Dante; e perciò varia-mente lo insidiano, gli uni avanzando l’ipotesi che sia aggiunta posteriore di Dantestesso, gli altri sforzandosi di attribuirlo addirittura a qualche glossatore. Ma nessunaprova, filologicamente accettabile, recano di siffatte asserzioni; e fintanto che taleprova non venga prodotta, l’inciso ha pieno diritto di esser conservato nel testo comeoriginario e genuino allo stesso titolo di qualsivoglia altra frase del trattato, e noncome tarda giunta dantesca o come glossa abusivamente intrusasi.
La posizione di Ricci, che ha sostanzialmente trovato l’accordo di Prue Shaw,è forte e debole allo stesso tempo. Da un punto di vista strettamente filologiconon vi sono effettivamente “prove” in grado di contestare la sua affermazione,né forse vi saranno mai. Ma questo significa che in realtà il discorso filologicoè tutt’altro che chiuso; lo conferma, ove ce ne fosse bisogno, il fatto che lostemma dello stesso Ricci è stato invalidato e sostituito da un nuovo stemma,senza considerare che ancora oggi altri luoghi della tradizione, specialmentedopo la lettura, pur prudente, delle pagine di Aldo Rossi, andrebbero a mio parererivisti. La definizione continiana di edizione critica come «ipotesi di lavoro»,saggiamente ricordata da Prue Shaw nel dare alle stampe il trattato di Dante, mipare mostrare una volta di più la sua validità. Sarà quindi bene lasciare aperta lastrada ad una discussione nella quale possono e devono intervenire anche fattoriche non siano solo filologici, là dove lo si reputi necessario. Del resto lo stessoRicci ne era conscio, quando ammetteva che in qualche modo è inevitabile pro-cedere a volte per via di congettura, utilizzando quelle che lui ha chiamato ad-dirittura “prove di laboratorio”, che altro non erano che «il senso, la grammatica,la verisimiglianza storica, le fonti, le componenti psicologiche, ecc.»: come si
95 RICCI, EN 1965, p. 159, ad loc.
GIAN PAOLO RENELLO144
vede non tutti elementi propriamente di stretto ambito filologico, eppure stru-menti indispensabili perché un filologo possa trarre il massimo profitto dallapropria arte96. Questo spiega, d’altronde, perché, intorno all’inciso, la gran partedelle argomentazioni fin’ora presentate partano da considerazioni storiche, sti-listiche, retoriche o filosofiche; questo spiega inoltre perché, a meno di un eventostraordinario come potrebbe essere l’apparizione di un testimone ancor più de-cisivo di Y, non sarà forse possibile uscire da questo recinto. Il processo delleipotesi si potrà affinare, forse ci si potrà avvicinare alla verità su questa vicenda,o magari e addirittura è stata già raggiunta ma non siamo ancora in grado di ren-dercene conto; in ogni caso, e dovremo farcene una ragione, rimarranno ipotesisu cui il giudizio non potrà che essere quello di una loro maggiore o minore fon-datezza rispetto alle conoscenze possedute al momento della loro elaborazione.
Per tornare al nostro problema si dovranno, credo, tenere in considerazionealcuni fattori che possono aver influito sulla trasmissione del testo. Ad esempioè del tutto evidente lo squilibrio esistente fra il ramo α costituito da T e A1, ovveroda un solo testimone completo e da un manoscritto che a sua volta si stacca nellaseconda metà (A2), lasciando completamente isolato T, per congiungersi con lafamiglia β, verso la quale convergono tutti gli altri manoscritti e, per quanto ciriguarda, anche l’editio princeps. Benché non sia questo argomento di stretta fi-lologia, pure le ragioni che spingono alcuni rami di una tradizione ad estinguersiin favore di altri fanno parte della storia di questa stessa tradizione, come hannoosservato Paolo Trovato e Vincenzo Guidi in un interessante lavoro che analizzala relazione fra decimazione dei testimoni e stemmi bipartiti97. Le ragioni chedeterminano la scomparsa di rami di una tradizione da un albero “reale” possonoessere svariate, anche se non sempre necessariamente drammatiche. E però undato che ci sembra storicamente individuabile, vale a dire l’eliminazione fisicadi gran parte degli esemplari della Monarchia, esiste ed è ricordato in un passodel Trattatello in laude di Dante di Boccaccio nel quale si sottolinea che la famadel libello arrivò tardi ed è legata alla venuta di Ludovico il Bavaro in Italia.
Se accettiamo l’idea veicolata da Boccaccio che il trattato dantesco divennenoto soprattutto nel periodo immediatamente precedente la sua condanna, saràallora da mettere in conto che di esso ne siano state tratte in quel periodo nume-rose copie o che comunque la sua diffusione fosse ampia98. Allo stesso tempo èanche da supporre che il rogo cui accenna Boccaccio abbia provocato una deci-
96 Ivi, p. 108. Naturalmente la posizione di Ricci non è isolata, come può confermare un qual-siasi buon manuale di filologia.
97 V. GUIDI, P. TROVATO, Sugli stemmi bipartiti. Decimazione, asimmetria e calcolo delle pro-babilità, in «Filologia Italiana», 1 (2004), pp. 7-48. L’articolo è diviso in due parti, la prima di Tro-vato, pp. 7-34, analizza filologicamente i concetti di decimazione, albero reale e stemmaappoggiandosi ai risultati ottenuti dalla seconda di Guidi, pp. 35-45, in cui tali questioni sono esa-minate e simulate da un punto di vista più propriamente statistico e probabilistico.
98 Cfr. GUIDI, TROVATO, Sugli stemmi bipartiti cit., pp. 25-26: « […] vien da pensare […] chesignificative intensificazioni nel processo di trasmissione si verifichino solo quando entra in giocola variabile del successo dell’opera: che agisce, modificandole, sulla domanda e sull’offerta dicopie». Si vedano anche le riflessioni al riguardo di P.G. RICCI in Enciclopedia Dantesca alla voceMonarchia.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 145
mazione di vasta entità e con percentuali che potrebbero aver superato senza dif-ficoltà il livello di guardia per la stessa sopravvivenza del trattato, coinvolgendonequasi sicuramente, e forse irrimediabilmente, lo strato più alto dei testimoni99.
Una seconda riflessione riguarda β2, per il quale si può considerare l’ipotesiche, fra tutti i discendenti, sia questo il solo ramo ad aver mantenuto, pur conestrema difficoltà, i contatti più fedeli con la versione originale dell’inciso, ancheeventualmente indicando, proprio con la sua incerta presenza a testo, che essonon ne facesse originariamente parte, relegando in tal caso gli altri esemplari aportatori di una variante più o meno corretta della frase in questione100.
Le due precedenti osservazioni suggeriscono di vagliare l’ipotesi che nei con-fronti di K si possa essere prodotto un vasto fenomeno di contaminazione checoinvolga trasversalmente il ramo β e il ramo α della tradizione. Di quest’ultimafamiglia già sappiamo che entrambi i manoscritti sono decisamente tardi: A èun esemplare oltremodo scorretto della seconda metà del XV secolo e fa partedi β3 per poco meno della seconda metà del trattato; T, ritenuto da Ricci, copiadi un manoscritto di notevole pregio, risalente alla metà o addirittura alla primametà del XIV secolo, è però un testimone che risale agli inizi del XVI secolo e,a ben vedere, precede di pochi decenni le prime due edizioni a stampa101. Si trattainsomma di testimoni per cui è difficile pensare che siano passati indenni o im-muni da contatti più o meno saltuari con esemplari non omogenei, ciò anche ac-cettando il principio recentiores non deteriores, il cui valore di verità non è indiscussione in sé, ma va accertato caso per caso. Sarebbe allora utile ricercare,anche solo a un primo grado di approssimazione, se K presenti legami tanto conun qualche gruppo di β quanto con T, mostrando quindi di non essere un auto-nomo testimone della tradizione come vuole Shaw.
All’interno di β il testimone con cui K presenta interessanti contatti è sen-z’altro E: come già osservato, entrambi presentano tre errori non facilmente spie-gabili, assenti in tutti gli altri testimoni così come nella traduzione tedesca e nelvolgarizzamento di Ficino102. Il ms. E, d’altro canto, è un testimone piuttosto
99 Sui rapporti fra albero reale e stemma si veda ancora la chiara definizione data in GUIDI,TROVATO, Sugli stemmi bipartiti cit., pp. 12-13. La damnatio del trattato dantesco può far supporreche esso fosse ritenuto importante e venisse letto in ambito imperiale, specialmente dopo la con-danna dell’opera di Marsilio da Padova. Si può anche immaginare che il rogo ne abbia aumentatola notorietà ma allo stesso tempo diminuito, e di molto, la possibilità di consultarlo, specialmentenei territori dove il controllo della Chiesa era più stringente.
100 Come ad esempio è la lezione paradisi comedia, di G e U (comoedia in quest’ultimo caso),forse derivata da paradiso comedie per intervento dei copisti, anche se sarebbe più sensato imma-ginare il contrario sia per la forma, sia per la logica (è il Paradiso che è incluso nella Commedia),sia per la presenza di comedia rispetto al quale termine meglio si giustifica immediate di Y.
101 RICCI, EN 1965, pp. 55-56; ID., Il manoscritto Trivulziano della «Monarchia», in «StudiDanteschi», XXXII (1954), pp. 51-63.
102 Cfr. EN, p. 244. Gli errori sono elencati supra a p. 23. Ancora una volta emerge come unapiù accurata lettura della versione tedesca potrebbe forse chiarire se la verifica di HEROLDT fra ilmanoscritto latino, la sua traduzione e la versione di FICINO riguardi solo l’ordinamento dei capitoli,pur con alcune variazioni, o anche, e a che livello, il testo in sé. Ovviamente è anche possibile chea Basilea i due editori avessero addirittura due testimoni differenti, magari imparentati ma è questaun’ipotesi che, alla luce di quanto detto fin qui, pare assai improbabile.
GIAN PAOLO RENELLO146
isolato di β3, famiglia a sua volta decisamente atipica, in cui, per dirla diretta-mente con le parole di Prue Shaw: «Non vi è alcuna lista di omissioni, errori ovarianti di lezione condivise da tutti i manoscritti che compongono il gruppo»103.Si tratta di un’affermazione a dir poco sorprendente e forse potrebbe essere ne-cessario un nuovo e più accurato esame della situazione di questo gruppo, tantopiù che la stessa caratteristica fu riscontrata da Ricci che non provò nemmeno adiscuterla104. Ho dunque deciso di analizzare meglio e in maniera più estesa levarianti in cui compaiono K ed E partendo dai rilievi compiuti a suo tempo daRossi, perché, nonostante i risultati di quest’ultimo fossero viziati da grave im-precisione, come notato da Shaw, l’idea mi è parsa fondamentalmente corretta105.Rossi non poteva disporre di un’edizione elettronica e ancor meno di un motoredi ricerca come VBase, grazie al quale è oggi possibile trovare, ad esempio, tuttele varianti ritenute erronee condivise anche da questi due testimoni. La lista ditali lezioni si rivela interessante: a parte quelle di più chiara matrice poligenetica,spiccano infatti, oltre alle tre varianti esclusive e di cui già s’è detto, diverse le-zioni condivise con altri esemplari in particolare della famiglia β2. Fra queste:
I.ii, 1: omissione di quidem in E K M N R S (igitur videndum) e F (ergo vi-dendum), contro quidem igitur videndum degli altri;
I.ii, 4: questione di E F K N R Y contro inquisitione di tutti gli altri;I.xiv, 10: et sic melius E F G K N R contro la maggioranza che ha et si melius
(altri hanno et similis);II.iv, 4: de iure fit et est di K E R, contro de iure fuit et est della maggioranza
dei testimoni (G ed H omettono rispettivamente et est e fuit/fit, S ha adeo fuit etest de iure);
II.v, 16: eam caperet di K E R, contro ut eam caperet degli altri tranne A PhU;
II.v, 25: dicendum di B C E K L Ph R Y, contro dicenda di tutti gli altri tranneS (danda);
II.viii, 1: postulatur di E F K N P R Y, contro postulamus/postulemus dellamaggioranza dei testimoni, meno G (postulantes) e Ph V (postulatus);
III.iv, 10: nec di E F K N R U Y contro non di BPV e neque dei rimanenti te-stimoni, tranne D G che omettono la frase;
III.ix, 8: hec di A E K P R Y contro hoc dei rimanenti testimoni;III.ix, 8: increpuit di A C E F H K N P Y Z contro increpavit degli altri ma-
noscritti (Ph ha increpare).
Si tratta ovviamente di una lista minima, nella quale possiamo, per comodità,ricondurre ad errori di K E anche i due errori K + E + R, ritenendo, con Shaw,che l’esemplare di Parigi sia un descriptus dell’Ashburnham 619. Le altre otto
103 SHAW, EN, p. 281.104 RICCI, EN 1965, pp. 72-79, 94-96 e 98. Così come RICCI, SHAW esamina le varianti comuni
ai vari testimoni presi a due a due, aggiungendo nel novero anche Ph, non conosciuto dal precedenteeditore.
105 ROSSI, Da Dante a Leonardo cit., p. 197; SHAW, Un secondo manoscritto cit., p. 243.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 147
lezioni vedono sempre errori condivisi fra K E e almeno un testimone β2: per laprecisione una volta ciascuna Y e P Y, due volte ciascuna F N, F N Y e F N P Y.Considerati isolatamente i testimoni, si ha che K E entra in contatto tre volte conP, e sei volte con F, N e Y106. Le intromissioni di altri testimoni di β sono inoltre,come si vede, contenute: nessuna nei casi 2, 4, 5 e 7, una nei casi 3 (G), 8 (U) e9 (A), due nel caso 1 (M S), infine quattro per i casi 6 (B C L Ph) e 10 (A C H Z).A fronte dei dieci casi in cui compare β2, quasi nulli sono i contatti con β1 (unsolo caso) mentre se ne contano quattro con altri testimoni di β3 e altrettanti contestimoni di β4. Mi pare insomma che i sospetti di Aldo Rossi, all’epoca non suf-fragati dall’indagine da lui condotta, non fossero privi di fondamento: esiste unlegame che mette in relazione K E specialmente con testimoni di area β2, in cuinon tutte le lezioni erronee sono facilmente classificabili come poligenetiche.
Esaminando ulteriormente la famiglia β3 emergono altri aspetti interessanti.Anche in questo caso è di fondamentale aiuto l’edizione elettronica; essa metteinfatti a disposizione un’opzione, Make Variant Group Profiles, la quale, unavolta scelto un esemplare, permette di conoscere quante varianti di ogni gruppoo famiglia sono condivise fra questa e il testimone dato. Lo scopo è quello, fral’altro, di mostrare eventuali variazioni più o meno repentine nel comportamentodi un testimone, in relazione ai vari gruppi dello stemma, per eventualmente ri-levare possibili fenomeni di contaminazione. Uno sguardo più generale è fornitodall’opzione Make Outline Variant Group Profiles, mentre una terza opzione,Make Full Outline Variant Group Profiles, combina le due precedenti. Analiz-zando tramite la seconda opzione una sintesi dei comportamenti dei testimoniin relazione ai vari gruppi, si ricavano in particolare i seguenti dati: K presentaovviamente, con 77 varianti comuni su 77, una affinità del 100% con quella cheShaw ha chiamato la famiglia “non-beta”. Subito dopo, però, K mostra una pa-rentela di 55 varianti comuni con la famiglia β3, con una percentuale superioreal 12,6%, un valore che fa sospettare che vi sia un collegamento più che spora-dico fra questa famiglia e l’editio princeps107. Analogo il comportamento di Tche ha una percentuale di condivisione con la famiglia β3 di circa il 9%108. Questi
106 Nel caso di I.ii, 1 igitur ed ergo possono spesso essere confusi a causa di compendi simili,per cui si può facilmente pensare che F sia da associare al primo gruppo di mss. caratterizzati, insostanza, dall’omissione di quidem.
107 Va detto per chiarezza che nei risultati sui profili delle varianti dei gruppi possono comparireanche testimoni di altri gruppi. Si può tuttavia restringere secondo necessità il campo d’azione del-l’indagine agendo sui valori minimi e massimi entro il quale effettuare la ricerca. Per quanto ri-guarda poi i rapporti fra K e β3, non sono riuscito purtroppo a visualizzare la lista completa dellevarianti, perché ancora una volta, nonostante i numerosi tentativi, il programma andava in erroreper problemi di memoria anche se usato online, cosa che non succedeva esaminando profili di altrigruppi rispetto allo stesso testimone, ma con un numero di varianti meno elevato.
108 La pagina delle varianti comuni fra T ed ER presenta un errore a II.ix, 8 perché, forse per unproblema di codifica o del database, il testo visualizzato non contiene nessuna delle varianti di le-zione mostrate. In effetti la frase mostrata nell’edizione elettronica è quella successiva alla fraseche dovrebbe essere presente. Per verificarlo basta esaminare lo stesso luogo testuale attraverso laword collation. Un altro problema è dato dalla difficoltà di calcolare le varianti per il gruppo β4completo, vale a dire con la presenza anche del ms. U: se esso viene aggiunto modificando ma-nualmente la ricerca, il programma VBase restituisce spesso errore.
GIAN PAOLO RENELLO148
due testimoni non presentano peraltro affinità di rilievo con altri membri dellafamiglia β. L’interesse per β3 è poi dato dal fatto che i profili delle varianti mo-strano che si tratta del gruppo che ha maggiori collegamenti con tutti gli altri te-stimoni109. Si va da poco oltre l’8% di B, appartenente a β1, per arrivare a circail 19% di M di β4 (che attesterebbe appunto dell’alto grado di contaminazionefra questo esemplare e, in particolare, D all’interno di β3), con medie del 12%proprio per i testimoni della famiglia β2, a conferma di una qualche relazioneprivilegiata fra i due gruppi. β3, in definitiva, sembra funzionare come un luogodi interferenza e di incontro di tutti i testimoni, compresi K e T.
Spostiamo ora l’attenzione su questi ultimi due testimoni. L’interrogazionedi VBase mostra che le lezioni erronee in cui essi si uniscono sono cinque, mentrequelle valide sono diciassette, delle quali ben sedici si trovano ripartite fra il se-condo e il terzo libro del trattato ovvero tutte successive all’inciso di I.xii, 6 cosìcome lo è anche l’altra lezione accettata da Shaw a I.xiii, 3: «quod si aliter aliquidagere conetur, frustra conatur», per la quale, indipendentemente dal fatto che Ksia contaminato con T, si può anche accettare l’ipotesi di Aldo Rossi, che il passosia interpolato110. Vi è poi la lezione a I.viii, 4-5, precedente dunque l’inciso, incui però K legge: «[...] totaliter subiacens, ut de se patet. Ergo humanum genusuni principi maxime Deo assimilatur», non del tutto uguale, cioè, come notatosopra, alla corrispondente lezione di TA1. Le cinque lezioni erronee non sonod’altro canto tali da poter stabilire un sicuro legame di parentela fra K e T; sitratta infatti di errori o poligenetici (canticum per canticorum) o banali in KT(Monarchiæ contro Monarche) o errori che pur non rientrando in queste categoriesi spiegano in ogni caso facilmente111.
Accanto al gruppo di lezioni KT visto vi è poi un altro interessante profilodelle varianti che lega, in questo caso, KT a U in modo esclusivo. Esso constain tutto di altre dieci lezioni, tutte presenti nei soli libri secondo e terzo del trat-tato; di queste ben otto sono ritenute valide da Prue Shaw. Le due varianti con-siderate errate sono costituite dalla lezione in Phrygia regione a II.iii, 10, ma giàFavati, con il quale concordo, la riteneva corretta112.
Se alle osservazioni precedentemente viste sull’ordinamento interno dell’edi-
109 Fa eccezione l’incompleto Q, che si arresta a I.xiv, i.110 Cfr. A. ROSSI, Analisi testuale della «Monarchia» e il Berlinese, in ID., Da Dante a Leonardo
cit., pp. 136-75, a p. 174.111 Se ne veda l’analisi in SHAW, EN, p. 267, la quale inoltre ribadisce che « […] nella prima
metà del trattato non vi sono errori comuni fra KTA1 e questo fatto di per sé è estremamente signi-ficativo». Proprio l’elevato numero di lezioni buone di KT spinse RICCI a ritenere i due testimonimembri di una stessa famiglia, e ciò diede origine alle fondate critiche di FAVATI, da cui ha preso lemosse l’edizione SHAW.
112 Cfr. G. FAVATI, Sul testo della «Monarchia» di Dante: proposta di nuove lezioni, in «IDE.Trimestrale letterario-politico redatto nei seminari dell’Istituto Dantesco Europeo», I/2 (agosto1970), pp. 1-29, poi in *Psicoanalisi e strutturalismo di fronte a Dante, I, Firenze, Olschki, 1972,Premesse, pp. 3-42. Si veda ancora RENELLO, L’edizione critica cit., p. 161 e infine QUAGLIONI, Unnuovo testimone cit., p. 259. È notevole anche il fatto che accanto alle lezioni KTU non vi siano le-zioni buone comuni a due esclusive di KU, TU o A1U. Questo suggerisce che U non ha contaminatoda α ma probabilmente dall’interposto antigrafo di K.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 149
tio princeps che fanno pensare che essa sia in realtà derivata da un manoscrittodi area β, affianchiamo sia le lezioni comuni fra questa e β2 / β3 sia le lezioniche accomunano K ed il Trivulziano, la conclusione che una forma anche vastadi contaminazione leghi K, o meglio il suo antigrafo, con testimoni in particolaredi β2 / β3 e con T lungo gran parte del testo pare di gran lunga la più economicae la più probabile.
6. L’autoriferimento fra Heroldt e K
Poste queste premesse sia sul volume di Oporino, sia sulle relazioni fra K,Heroldt e β, possiamo cercare di inquadrare insieme le due edizioni basiliensidel 1559.
Heroldt, come ricorda Witte nell’edizione critica da lui curata113, e come èora possibile riscontrare sul testo online, afferma di aver tradotto la Monarchiadi Dante in tedesco dal volgarizzamento di Ficino e di averne riscontrato la tra-duzione su un testo latino che doveva essergli capitato fra le mani solo succes-sivamente: «und hernach gegen dem Lateinischen als es mir zur hand kommengehalten»; si tratta di una dichiarazione assolutamente credibile; non si capirebbealtrimenti perché non abbia tradotto direttamente dal latino il medesimo trattato,evitando, diciamo così, un doppio lavoro. Due sono le riflessioni che le paroledi Heroldt inducono: la prima è che a Basilea doveva trovarsi una copia del vol-garizzamento italiano e che ad essa aveva avuto accesso il traduttore tedesco114,la seconda è che il testo latino gli è occorso solo dopo aver effettuato la tradu-
113 WITTE, Monarchia cit., p. lxxiii.114 Il trattato di Dante a Basilea era però noto da anni. Dallo scambio epistolare fra MATTIA FLA-
CIO e Caspar von Nidbruck, diplomatico alla corte di Vienna, suo amico e protettore, emerge che giànel 1552, dunque prima che il trattato finisse all’indice, FLACIO cercava il libello dantesco, di cui in-tendeva parlare in un’opera sui maggiori personaggi storici in chiave antiierocratica. Cfr. Catalogustestium Veritatis, Qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae : Opus varia rerum, hoc praesertimtempore scitu dignißimarum, cognitione refertum, ac lectu cum primis utile atque necessarium. CumPraefatione Mathiae Flacii Illyrici, qua Operis huius & ratio & usus exponitur, Basileæ, per Joan-nem Oporinum (Dante si trova a p. 868). Anche Oporino, però, conosceva il trattato; sappiamo infattiche nel 1554 Flacio, grazie all’aiuto di Nidbruck, ne venne finalmente in possesso, pur se limitatoal solo terzo libro. Esso era stato inviato per lui dall’editore di Basilea al cancelliere imperiale per iltramite di Wendelio Rielio (un editore di Strasburgo). Si veda F. CHENEVAL, Die Rezeption der Mo-narchia Dantes bis zur Editio princeps im Jahre 1559, München, Fink, 1995, pp. 376 ss. Una con-ferma indiretta di ciò la fornisce proprio il Catalogum, nel quale l’autore, a proposito dellaMonarchia, cita solo la terza questione trattata da Dante proprio nell’ultimo libro, ovvero l’indipen-denza dell’Imperatore dal Papa, come se delle altre due non avesse alcuna conoscenza; FLACIO inoltreindividua nella risposta di Dante a tale questione la causa della sua condanna: «Scripsit librum quemappellavit Monarchiam. In eo probavit, Papam non esse supra Imperatorem, ob eamque rem a qui-busdam haereseos est damnatus». Chi invece parlerà più diffusamente e completamente della Mo-narchia, anche se è ancora una volta il terzo libro quello a cui dedicherà maggior attenzione, saràPIETRO PAOLO VERGERIO IL GIOVANE nel Postremus Catalogus Haereticorum Romae Conflatus, 1559,Pfortzheim, Corvinus, 1560; ma qui è lui stesso a dichiarare (p. 18) di possedere la versione italianadi Ficino, forse addirittura la stessa da cui ha tradotto HEROLDT. Per altre notizie sulla conoscenzadel libello nel XVI secolo si veda RENELLO L’edizione critica cit., pp. 172 ss.
GIAN PAOLO RENELLO150
zione ed è servita a quel punto per verificare la correttezza del proprio lavoro e,indirettamente, anche se Ficino fosse stato o meno fedele all’originale, per even-tualmente procedere con le dovute correzioni. Dobbiamo allo stesso tempo esclu-dere che Oporino, sicuramente in possesso del manoscritto latino, abbia potutovedere e consultare l’edizione italiana, perché essa da sola avrebbe de factosmentito l’attribuzione del trattato a un Dante a cavallo fra XV e XVI secolo.
Qui giova aprire una parentesi a proposito dell’editio princeps, sulla quale,benché manchino notizie fondamentali, come quella riguardante il manoscrittoda cui deriva, sono comunque possibili altre osservazioni su aspetti a mio giu-dizio non trascurabili, qualora si consideri nella sua interezza il volume miscel-laneo che la contiene. L’edizione elettronica mette infatti a disposizione dellostudioso il solo trattato di Dante preceduto dall’epistola dedicatoria di Oporinoa Hieronimus Fricker. Il volume nella sua interezza mostra invece che, come perla Monarchia, ognuno dei trattati presenti nella raccolta oporiniana è precedutoda una epistola dedicatoria115. Così, dopo il libello dantesco, segue il Tractatusde translatione imperii di Radulphus de Columna Carnotenis, autore altresì delladedicatoria al “charissimo patri” «Lamberto de Castello legum honorabili pro-fessori», che nell’epistola ci viene presentato come l’ispiratore dell’opuscolostesso. Assai più interessanti risultano però i due ultimi trattati del volume. A p.217 si trova infatti la Chronica Magister Jordanis Qualiter Romanum Imperiumtranslatum fuit in Germanos, & primo quare Romanum imperium sit honoran-dum, preceduta alle pp. 214-16 da una epistola dedicatoria indirizzata all’amicoAugustinus Guntzerius nientemeno che dallo stesso Basilus Johannes Heroldt,curatore della traduzione tedesca del trattato di Dante. A questo segue poi il Deortu et authoritate Imperii Romani, un trattatello in forma epistolare del primomarzo 1446, inviato dal suo estensore Enea Silvio Piccolomini, futuro papa PioII, all’imperatore del Sacro Romano Impero Federico III d’Asburgo. La lettera èpreceduta da due dediche, la seconda delle quali è indirizzata all’imperatore dallostesso autore, ma la prima (p. 259) è, per la seconda volta e in maniera sorpren-dente, oltre che atipica, un’epistola dedicatoria rivolta da Heroldt ai «Viris Cla-rissimis» e «Senatoribus Augustalibus» d’Alsazia Johannes Faber e Simon Pfirt,in cui si trovano fra l’altro espressioni quali «Oporinus ille noster» e «benemeritohomini Oporino nostro». Tutto ciò conferma almeno che Oporino ed Heroldt la-vorarono nello stesso periodo a stretto contatto mentre preparavano rispettiva-mente il volume miscellaneo che conteneva l’editio princeps della Monarchia ela traduzione tedesca del trattato. Ancora più interessante è però il fatto che l’in-testazione della miscellanea stampata da Oporino riporta solo quattro dei cinquetitoli poi effettivamente compresi nel volume. Non si tratta sicuramente di unasvista perché nell’epistola dedicatoria a Fricker che precede il testo della Mo-narchia, immediatamente prima della famosa dichiarazione sul Dante “fami-liare” di Poliziano, Oporino conferma che oltre all’opera di Alciato ne sono stateaggiunte altre tre di argomento analogo116:
115 Il primo trattato, per la precisione, è preceduto da un’epistola nuncupatoria.116 Cfr. l’edizione elettronica, pp. 50-51.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 151
[...] libuit hunc ad te non solum iam, sed luculento etiam foenore auctum adiuntisqueejusdem aut saltem non dissimilis argumenti libellis tribus comitantibus remittere:iisque etiam hactenus non editis, dignis tamen, qui non perpetuo squalore ac situ pe-rirent, sed tandem aliquando una cum plurimis aliis nostro seculo idemtidem velutde Orco emergentibus, ipsi etiam prodirent in medium.
Quando Oporino scrive l’Epistola, datandola 30 giugno 1559, i trattati pre-visti per la miscellanea sono dunque solo quattro. Alla fine del volume, però, ladata risulta spostata in avanti di circa tre mesi. Deve dunque essere successoqualcosa in questo lasso di tempo e questo qualcosa è l’aggiunta di un quintotrattato, assente dal frontespizio e dalla lettera, cosa che ovviamente ha ritardatola pubblicazione del volume. Il testo aggiunto è proprio il De ortu et authoritateImperii Romani di Enea Silvio Piccolomini, preceduto, come abbiamo detto piùsopra, da una dedicatoria di Heroldt in cui si trovano espressioni di grande stimae amicizia verso Oporino. Come non pensare, allora, che il curatore della tradu-zione tedesca abbia avuto il permesso di consultare il ms. latino e si sia sdebitatocon l’amico e collega preparando per lui l’edizione di un altro testo inedito conil quale arricchire la miscellanea che questi stava allestendo117? Ciò spiegherebbesenza difficoltà le due date sul volume di Oporino e quindi perché entrambi icuratori pubblicarono le rispettive edizioni a circa un mese di distanza l’unodall’altro, comunque meno dei «pochi mesi», ipotizzati da Prue Shaw; la quasicontemporaneità fu favorita proprio dall’inserzione da parte di Heroldt, all’ul-timo minuto, di un altro trattato nella miscellanea oporiniana118.
117 Cfr. Andreæ Alciati iure consulti clariss. De formula Romani Imperii Libellus, Basilea, 1559,pp. 259-60. L’inizio della dedicatoria del quinto trattato è a questo riguardo illuminante, perchéHEROLDT lascia intendere di aver tratto un vantaggio da eventi contingenti: «Germanis nostris inproverbio est, VV. CC. Saepius bene verti huic illud, alteri quod obsit: dictum me hercle, eventusipse, ut omnibus seculis, ita libellorum editione horum, nunc comprobatum». Oporino, infatti, ag-giunge ancora Heroldt subito dopo, gravato da numerosi impegni, era partito per la Fiera di Fran-coforte, interrompendo il progetto editoriale cui stava lavorando. Heroldt dunque intervieneaggiungendo il quinto trattato, probabilmente ricavandone in cambio l’accesso al manoscritto latinodella Monarchia – e forse in questo va ravvisato il vantaggio di cui parla. Non sarebbe inoltre nem-meno da escludere la possibilità che il volume sia stato stampato assente Oporino, visto che la fieradi Francoforte si svolgeva anche allora nel periodo autunnale.
118 Cfr. SHAW, Un secondo manoscritto cit., p. 244. Nelle due edizioni a stampa si parla rispet-tivamente del mese di ottobre 1559 per Oporino e del solo anno 1559 per Episcopius. HEROLDT,tuttavia, data la sua prefazione al volume «den ersten Herbstmonats», ovvero il primo settembre, enon vi è motivo di pensare che fra la data segnata da Heroldt e quella di Episcopius vi sia una qual-che sostanziale differenza, proprio perché, al contrario di Oporino, non si è dovuto specificare perla seconda volta il mese. Può forse aver influito sull’asserzione di Shaw quanto dice anche Rossi aproposito dell’epistola dedicatoria di Oporino a Hieronimus Fricker, datata effettivamente Basielae,pridie Calend. Iulij 1559 (cfr. l’editio princeps, p. 59). Ma tale data va considerata come traccia diun precedente progetto editoriale, al pari del frontespizio, che evidentemente Oporino non potevapiù modificare forse per ragioni di tempo ed economiche, o (vedi nota prec.) perché era assente;essa fa dunque riferimento solo ai primi quattro trattati e non all’intero volume portato a terminedopo l’aggiunta di un quinto e dato alle stampe successivamente come testimonia il colophon postosotto il testo di PICCOLOMINI: BASILEÆ EX OFFICINA/ Ioannis Oporini, Anno salutis huma-/næM. D. LIX mense/ octobri (p. 297). Si veda su questo punto ancora RENELLO, L’edizione criticacit., pp. 177-78.
GIAN PAOLO RENELLO152
Se l’ipotesi ha un qualche fondamento ne segue che Heroldt ha avuto accessoin un secondo tempo allo stesso testimone di Oporino, contaminato con T, dacui avrebbe ricavato le lezioni presenti in α e assenti in β e quindi in Ficino. Que-sto stesso testimone, tuttavia, sarebbe potuto anche essere in qualche misura la-cunoso o oscuro proprio là dove doveva trovarsi il famoso autoriferimento119.Heroldt aveva però effettuato la traduzione sulla base del volgarizzamento di Fi-cino, in cui l’inciso era presente; niente vieta allora di pensare che egli potrebbeaver agito esattamente in direzione opposta a quanto fecero Fraticelli nel 1839e Torri nel 1844, i quali crearono un vero e proprio cortocircuito editoriale dalleconseguenze imprevedibili per le edizioni che seguirono. Essi pubblicarono in-fatti il volgarizzamento di Ficino utilizzando come testo a fronte i due manoscrittilatini da loro utilizzati: Fraticelli il Magliabechiano M, Torri il Laurenziano L.Tanto Ficino che i manoscritti presentavano il famoso inciso, ma furono riscon-trati sul testo della princeps, ritenuta in quel momento l’edizione di riferimentoe quindi la più sicura depositaria del dettato dantesco, in cui, è noto, l’incisomanca. Fu dunque a causa dell’autorità di quest’ultima che i manoscritti e il vol-garizzamento non vennero ritenuti fededegni, ragion per cui entrambi gli editoriespunsero da essi l’autoriferimento. Il volgarizzamento di Ficino così correttodivenne poi a sua volta autorevole testimone per le successive edizioni latine eitaliane del trattato. L’errore dei primi editori si ripercosse così, pur con nuovee diverse motivazioni, e fatta eccezione per Bertalot, nelle edizioni di Witte, Giu-liani, Moore, Rostagno e persino, più recentemente, nelle traduzioni di FrediChiappelli e Bruno Nardi, il quale ultimo, pur utilizzando l’edizione Ricci, an-cora riteneva che in Ficino mancasse la frase espunta a suo tempo120.
Nel caso dell’edizione tedesca Heroldt può avere deciso, al contrario, di man-tenere nella propria versione l’autoriferimento dantesco, indipendentemente dallasua presenza o meno nel manoscritto latino, perché comunque perfettamentechiaro e leggibile nella traduzione italiana, ritenuta da lui in quel punto eviden-temente più affidabile, tanto più che essa confermava senza mezzi termini la pa-ternità dantesca, già asserita da Ficino, all’inizio del trattato. Ciò spiega anchela sua convinta dichiarazione che l’autore fosse il Dante Alighieri Fiorentino eautore della Commedia, sulla scorta inoltre dell’introduzione da lui curata, an-ch’essa ripresa da quella premessa da Ficino alla propria traduzione121. Se la pre-
119 Con questo si spiegherebbe inoltre perché nell’edizione tedesca non sono presenti i tre famosierrori che legano K ed E. Ritengo infatti che essi siano stati emendati da HEROLDT proprio graziealla verifica sul volgarizzamento di Ficino.
120 Anche E. MOORE, che evidentemente si ricollega a WITTE, mantiene la sola frase finale sicutdixi. Cfr. Tutte le opere di Dante Alighieri, Oxford, 1894, p. 347. Per B. NARDI si veda Monarchia,in DANTE ALIGHIERI, Opere minori, t. II, Milano, Ricciardi, 1966 (rist. 1979), p. 348 n. ad loc.Escludo dalla lista VINAY per il quale, come s’è detto altrove, le motivazioni dell’esclusione del ri-ferimento dantesco sono di ben altro spessore.
121 SHAW, Un secondo manoscritto cit., p. 264, rileva l’inesattezza di una mia asserzione, conla quale sostenevo che Oporino negava la fiorentinità di Dante contro la dichiarazione opposta diHeroldt. Naturalmente SHAW ha ragione e le sono grato della segnalazione. Si tratta infatti di unamia svista, che ha causato il salto di un aggettivo; si sarebbe invece dovuto leggere che quello chenegava Oporino e affermava Heroldt era la «fiorentinità antica» dell’autore del trattato.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 153
senza della frase nella traduzione tedesca non è certamente da sottovalutare, essatuttavia non dimostra in verità alcunché circa la presenza della stessa frase nelmanoscritto latino utilizzato da Heroldt e ancora meno, dunque, può deporre afavore di una effettiva presenza autoriale della frase a testo nell’archetipo. L’au-torità di Ficino era tale per cui sarebbe stato senz’altro logico dare credito al vol-garizzatore italiano piuttosto che ad una copia guasta, o lacunosa, o comunqueilleggibile in quel punto. Sotto questa prospettiva anche l’affermazione della dif-ferenza autoriale proclamata da Heroldt e Oporino acquista un diverso e più pre-ciso senso. Al momento della pubblicazione della princeps il testo di Dante erainfatti ben noto e circolante in Europa e anche Oporino lo conosceva; difficilecredere allora che l’editore della princeps intendesse falsificare la paternità del-l’opera che si apprestava a pubblicare122. È invece vero che Heroldt poté basarela propria affermazione circa la paternità dell’Alighieri sulla scorta della tradu-zione italiana, mentre Oporino, all’oscuro della copia ficiniana, si attenne unica-mente ad un manoscritto latino, forse adespoto e anepigrafo o più probabilmenterecante una generica indicazione sull’autore, come è di diversi altri testimoni anoi pervenuti e forse, soprattutto, privo dell’autoriferimento o forse difficilmenteleggibile e quindi inutilizzabile, o comunque non credibile123. Per quest’ultimo
122 A. ROSSI, Collaboratori all’edizione di Basilea: da Erasmo a Flacio a Herold, in ID., DaDante a Leonardo cit., pp. 180-94, a p. 193, richiama uno studio di C. Gilly ove risulta che all’Uni-versitätbiblioteck di Basilea, fra le carte ivi conservate di Bonifacio Amerbach, (di cui Oporinoaveva sposato in quarte nozze la figlia Faustina Iselin), il fascicolo XII contiene il catalogo dellasua biblioteca, mentre nel XIII una scheda attesta la presenza del manoscritto della Monarchia. Valela pena aggiungere che Bonifacio Amerbach, intimo e poi erede di Erasmo da Rotterdam, fu stu-dente nel 1525 ad Avignone, dove conseguì il titolo di Doctor utriusque iuris con quell’Andrea Al-ciato che apre la miscellanea oporiniana del 1559, e a cui rimase in seguito legato da amicizia.
123 Metodologicamente parlando mi pare più prudente partire dall’ipotesi che la dichiarazionedi Oporino circa la paternità del trattato sia stata fatta in buonafede e da lì verificare se questa portia contraddizione. Ci si può allora domandare se e quali elementi di prova (o che egli riteneva tali)avesse per fare una simile affermazione. Uno di tali elementi era sicuramente l’antigrafo di K. Sel’editio princeps, come credo, era contaminata con testimoni di entrambe le famiglie, allora lo erasenz’altro anche il suo antigrafo. A questo si aggiunga che per l’editore di Basilea ritenere che l’au-tore del trattato fosse il Dante amico di Poliziano morto fra il 1513 e il 1514 (cfr. la voce «Alighieri,Dante III», in Enciclopedia Dantesca cit., vol. II, p. 178) non era ipotesi priva di fondamento, comesi ricava da L. SEBASTIO, Capitoli sulla «Monarchia» di Dante nel Protestantesimo (1550-1560),in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari», XV (1972), pp. 339-84, inparticolare p. 359. È possibile, allora, che a suffragare la presunzione di Oporino abbia contribuitoproprio l’antigrafo, il quale evidentemente non dovette apparirgli risalente al XIV secolo o agliinizi del XV – altrimenti non avrebbe avuto senso la sua affermazione circa l’autore ma piuttostoagli ultimi anni di esso, o forse addirittura agli inizi del successivo. Oporino era umanista e filologoassai ferrato, scopritore ed editore di testi latini e greci, buon conoscitore di manoscritti, e potevasenz’altro giungere a questa conclusione esaminando attentamente il codice su cui basava la prin-ceps. Un esemplare appartenente ad un’area intermedia vicina a β2 e β3 avrebbe potuto giustificaretanto la presenza degli errori di E, quanto l’assenza dell’inciso; forse spiegherebbe persino l’intro-duzione di un nuovo capitolo a III.xv,16, condiviso con il solo P, eliminato dall’editore della prin-ceps, ma mantenuto da HEROLDT. Allo stesso tempo la contaminazione con T, o con il suo antigrafo,lo renderebbe portatore anche delle lezioni di quest’ultimo. Il copista dell’antigrafo di K può avertrascritto ai margini le lezioni di T o del suo antigrafo, mancanti nell’esemplare da lui riprodotto,e fra queste è possibile ci fosse anche l’inciso, Ciò spiegherebbe ad esempio l’apparente inesattezzadi K (per cui vedi supra), che a I.viii, 4 inserisce subiacens ed elimina subiacet. Se però il copista
GIAN PAOLO RENELLO154
era dunque lecito sospettare che l’autore fosse un altro Dante, ovvero l’amico diPoliziano, proprio perché poteva aver creduto che il trattato che stava per darealle stampe non fosse il medesimo descritto a suo tempo da Mattia Flacio. A mepare insomma che Pier Giorgio Ricci nell’accusare Oporino di aver falsificato idati riguardo l’autore del trattato abbia in realtà scambiato la causa per l’effetto:avendo Oporino dichiarato che l’autore non era Dante, è stato obbligato a rimuo-vere l’autoriferimento. In realtà credo sia avvenuto esattamente l’opposto: poichéla copia latina utilizzata da Oporino o non conteneva alcun autoriferimento, o erailleggibile o non affidabile, ne segue che per l’editore fosse plausibile ritenereche quello non era il trattato di Dante Alighieri. Se questa ipotesi fosse fondata visarebbe addirittura spazio, ma il condizionale è assolutamente d’obbligo, perun’altra ipotesi: non fu cioè l’editore della princeps a intervenire pesantementeeliminando l’inciso dantesco, come sostenne Ricci, ma fu invece Heroldt che, te-nendo conto della versione ficiniana, decise di dover mantenere a testo una fraseforse lacunosa, incomprensibile, o addirittura assente nel manoscritto latino.
Nota sull’edizione elettronica (in risposta a Prue Shaw)
Alla fine dell’esame del nuovo manoscritto londinese e delle analisi del Rossi, PrueShaw dedica un fin troppo generoso spazio ai rilievi da me fatti intorno all’edizione elet-tronica della Monarchia, a cui mi corre obbligo rispondere brevemente.
I rilievi principali da me individuati si possono sostanzialmente suddividere in trecategorie:
Mancanza di dati o errata rappresentazione degli stessi.Al momento in cui scrivevo l’articolo la situazione era quella da me descritta nel pre-
cedente lavoro. Sul sito era chiaramente detto che le immagini di F, per ragioni di copy-right, mancavano, ma queste erano correttamente presenti sul DVD. Nulla invece sidiceva delle immagini assenti sia online, sia sul DVD, del ms. H e parzialmente di N,che mi era stato assicurato essere completo. Ovvio il mio disappunto. Ora apprendo dal-l’articolo di Prue Shaw, e constato, che l’apparato iconografico di H e di N, in rete, ècompleto. Non posso però non registrare con sconcerto che tutte le immagini dei mano-scritti sono state messe in rete il 19 febbraio 2009 mentre le immagini di H sono stateaggiunte dai responsabili dell’edizione elettronica solo il 24/05/2011, ossia dopo la pub-blicazione del mio articolo. Inoltre osservo che al momento in cui scrivo (febbraio 2012,verificato ancora nel mese di aprile), mancano le immagini di R per le carte che vannoda 20r (in corrispondenza di II.v, 13) in avanti, fino all’interruzione del trattato a III.x, 8,mentre per T l’immagine della carta 141v (corrispondente a I.xiii) è purtroppo parzial-mente riprodotta (sono visibili solo le prime otto righe).
Quanto all’errata rappresentazione dei dati, le interrogazioni preconfezionate che so-stenni essere o incomplete o non ben formulate, mi trovo costretto a riconfermare quantoho detto e chiunque può prenderne atto consultando il DVD o il sito. Le query preimpo-
avesse inserito subiacens a margine nell’antigrafo, perché si era accorto di averlo tralasciato neltesto, l’editore avrebbe potuto ritenerlo erroneamente correzione o variante di subiacet e non un’in-tegrazione della frase seguente. OPORINO, per il quale l’antigrafo era comunque opera di un con-temporaneo di Poliziano, avrebbe integrato o corretto nella propria edizione tutte le varianti trannel’autoriferimento a I.xii, 6, ritenendolo ovviamente non attendibile.
A PROPOSITO DELLA MONARCHIA 155
state non sono tutt’ora del tutto esatte: ad esempio i testimoni non-β sono K-T e nonanche A1. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che non è stato studiato un meccanismoper separare le lezioni di A1 da quelle di A2 (che naturalmente non fa parte della querypreimpostata su β3, così come, peraltro, U manca dal gruppo di testimoni β4). In questomodo non si dà correttamente conto dell’accurato lavoro di analisi e collazione svoltodal filologo, che però è stato fatto ed esiste come si può chiaramente verificare utiliz-zando, ad esempio, la Word collation. Oltre ad A2, mancano nel gruppo β3 anche i testi-moni ER, forse a causa del fatto che la terza famiglia non è così facilmente delineabile,come Prue Shaw stessa riconosce nell’edizione critica (pp. 281-85), quando esamina lostemma delineato da Ricci. Aggiungo, quale ulteriore esempio di rappresentazione erro-nea dei dati, che se si usa il semplice “search” per trovare la parola paradiso, risulta cheessa si trova in tredici testimoni su venti. Ovvio che siano assenti i testimoni K, F e P,dove la parola non esiste. Ovvio pure che non si trovi in G e U che hanno Paradisi e nonParadiso. Ma non dovrebbero mancare A ed E dove invece la parola c’è. L’incompletezzadel risultato si spiega con il fatto che solo in questi due manoscritti la parola è spezzatain fondo al rigo e quindi non viene letta completamente. È certamente un problema dicodifica, non un errore del filologo, ma è una situazione cui evidentemente i responsabilidel progetto informatico non hanno pensato e che contrasta, tanto per dire, con la Wordcollation al passo, dove si ha l’esatta rappresentazione della situazione attivando la vi-sualizzazione delle spelling forms originali dei testimoni. Di conseguenza si hanno dueinformazioni contrastanti all’interno del programma su uno stesso dato.
Usabilità.In questo caso il mio appunto voleva essere un suggerimento, ovvero la possibilità
di esportare i dati in determinati formati (fogli di calcolo, documenti di testo, XML, ec-cetera) in maniera tale che si potesse riutilizzarli in futuro senza dover ogni volta ripeterele stesse interrogazioni. A questo aggiungerei che non sarebbe male mettere un pulsanteche faccia sì che si possano visualizzare gli eventuali successivi 50 risultati della scher-mata. Minuzie, si dirà. Ma dopo tanto sforzo per creare un’edizione così complessa edelaborata di un testo, perché non tener conto anche di queste esigenze, non certamentedi difficile programmazione e del resto decisamente utili? Infine, ma forse è chiederetroppo, perché prevedere il funzionamento del programma per Windows e Mac e nonanche per Linux?
Problemi di funzionamento di VBase.Anche qui sono costretto a contraddire la studiosa. Il motore di ricerca in certi mo-
menti e a seconda del tipo di interrogazione, ha tempi di risposta decisamente lunghi enon poche volte va in timeout anche se usato in rete. Usato come web locale in Windows,pur dotato di memoria sufficiente per il lavoro che deve svolgere, il problema resta in-variato. Ho provato su diverse macchine e sistemi operativi e anche in altri contesti, inrete e in locale, a richiedere, ad esempio, le varianti per i testimoni non-β e il motore èandato molte volte in errore, a meno di non cambiare uno dei parametri, in particolareimponendo una riduzione del numero massimo di manoscritti entro cui effettuare la ri-cerca. Stesso problema quando si richiede il profilo delle varianti dei gruppi se il numerodi varianti è troppo elevato (diciamo oltre la trentina). Sembra insomma che la principalecausa all’origine di tali errori sia legata all’elaborazione dei dati che incide sul consumodell’unità centrale e sulla memoria. Altro serio difetto di funzionamento è dato dalla dif-ficoltà di vedere tutti i risultati che superino la soglia fissata, di default, a 50. Chiederedi visualizzare 100 risultati alla volta manderebbe in timeout la macchina, chiedere divisualizzare i risultati a partire dal cinquantesimo la manda in errore.
GIAN PAOLO RENELLO156
Delle tre tipologie di rilievi osservo che solo alla prima, e parzialmente, si è dato ri-sposta. Tuttavia non è questo il punto. Ciò che invece a me preme chiarire è che gli ap-punti mossi riguardano insufficienze o carenze nell’elaborazione e nella rappresentazionedei dati, minime e rimediabili – infatti essi occupano poco più di una nota – che attengonoesclusivamente l’oggetto elettronico in quanto tale, e non certo il lavoro filologico-lette-rario che esso rappresenta, al quale ho invece dedicato ben altro spazio e analisi. Se ilDVD ha dunque dei difetti essi riguardano solo il prodotto informatico in sé e non i datiche contiene. Detto questo è altrettanto ovvio che il DVD costituisce un assoluto passoavanti nel campo della filologia e della filologia informatica, e non posso che concordarepienamente con Prue Shaw quando osserva che senza di esso gran parte delle mie rifles-sioni sull’edizione critica non sarebbero state possibili. Dirò di più: senza il lavoro diPrue Shaw, è lo stesso DVD come progetto culturale che non avrebbe mai visto la luce.Questo però non significa che non se ne debbano vedere i limiti realizzativi, appuntoperché vengano superati e se ne migliori il modo in cui i dati vengono elaborati e rap-presentati. Diverso sarebbe stato il caso di una rappresentazione dei dati insufficiente,non perché i responsabili materiali della realizzazione del DVD hanno fattivamente di-menticato di inserire dati o hanno creato un algoritmo non sempre efficace per la lororappresentazione, ma perché metodologicamente e filologicamente il modello che li strut-tura si è rivelato inadeguato o incompleto. In realtà la mia nota si può sostanzialmenteriassumere con l’osservazione che il DVD in quanto programma non è un’implementa-zione adeguata del modello teorico che intende rappresentare.
Chiudo con un’ultima considerazione che riguarda sempre l’oggetto informatico inquanto tale. Come ogni prodotto immesso sul mercato, anche per un prodotto informaticoquando viene distribuito a qualsiasi titolo incompleto o difettoso, solitamente segue unaggiornamento che ponga rimedio al problema. Ebbene, è compito del produttore infor-mare gli utenti cui è stato inviato il prodotto difettoso che un tale aggiornamento è di-sponibile tramite download con le eventuali istruzioni di aggiornamento per il DVDacquistato, che a tutti gli effetti deve riflettere quanto si trova sul sito.
Negli ultimi numeri de «L’Alighieri»
N. 36, 2010 SAGGI: D. BOLOGNESI, Il contrapasso come chiasma. Appunti su Inferno XXVIII –G.L. PIEROTTI, Reti Restorff e filologia dantesca. LECTURAE DANTIS: V. MARUCCI, L’«altopasso»: lettura del canto XXVI dell’Inferno – G. CIAVORELLA, Corrado Malaspina e sua «genteonrata». Ospitalità e profezia (Purgatorio VII, 109-39) – G. LEDDA, Autobiografismo profeticoe costruzione dell’identità. Una lettura di Paradiso XVII. NOTE: L. PEIRONE, Il muro di fuocodel Purgatorio dantesco – F. AFONSO, Light Gradation. The encyclopedic World Views of Danteand Bonaventure – A. BENEDETTI, Giovanni Sforza, Dante e la Lunigiana. RECENSIONI.
N. 37, 2011 SAGGI: F. BUCCI, Avvento liturgico e Avvento storico. Appunti su Inferno I-II –W. WETHERBEE, Judging Dido – D. CAPPI, L’interesse per la storia nella prima redazione delComentum Comedie di Pietro Alighieri. LECTURAE DANTIS: S. CARRAI, Attraversando leprime bolge. Inferno XVIII – S. BELLOMO, Le Muse dell’indignazione: il canto dei simoniaci(Inferno XIX). NOTE: V. BARTOLI, In difesa di «orror» (Inf. III, 31) con il conforto della scienzamedica medievale – A. SEVERI, Ancora sul rapporto tra Dante e Petrarca: il paragone maternodi Inf. XXIII in Epyst. I, 14 – D. PANTONE, Misogallismi di Benvenuto tra Dante e Petrarca – F.LAURENTI, Preistoria di una traduzione. La Divine Comédie francese di Jacqueline Risset (In-tervista). RECENSIONI.
N. 38, 2011 SAGGI: L.E. HOOPER, Exile and Rhetorical Order in the Vita nova – L. MAZZONI,Le polemiche dantesche fra Giovanni Iacopo Dionisi e Baldassarre Lombardi. Con dodici let-tere inedite (Prima parte). LECTURAE DANTIS: N. GARDINI, Umanesimo e lacrime di sangue.Una lettura di Inferno XIV – F. TATEO, Lettura di Inferno XXIV (l’esemplarità di una similitudinee l’enigma della Fenice) – A. BRUNI, Per il canto XXX dell’Inferno – P. MANNI, Inferno XXXIV:il canto di Lucifero. NOTE: A. CASADEI, Questioni di cronologia dantesca: da Paradiso XVIII aPurgatorio XXXIII – D. SBACCHI, «Lo gran mar de l’essere» (Par. I, 113). RECENSIONI.
N. 39, 2012 SAGGI: P. ALLEGRETTI, Dante geremiade: un modello per la Vita nova – S. BEL-LOMO, Virgole infernali: alcune considerazioni sul problema dell’interpunzione – S.A. GILSON,“Aristotele fatto volgare” and Dante as “Peripatetico” in Sixteenth-Century Dante Commentary– L. MAZZONI, Le polemiche dantesche fra Giovanni Iacopo Dionisi e Baldassarre Lombardi.Con dodici lettere inedite (Seconda parte). LECTURAE DANTIS: S. SARTESCHI, Canto diGuido da Montefeltro o di Bonifacio VIII? Lettura di Inferno XXVII – E. ARDISSINO, Nuclei te-matici nel canto di Piccarda (Paradiso III). NOTE: G. INGLESE, Una discussione sul testo dellaCommedia dantesca “Simulacra gentium argentum et aurum”. Parodia sacra e polemica anti-clericale nell’Inferno – G. SICA, Oltre il velo. La visione del divino in Virgilio e Dante. RE-CENSIONI.
N. 40, 2012 SAGGI: V. RIBAUDO, L’etimologia tra teoria retorica e prassi poetica nella Com-media – M. LEONARDI, «Mostrando come spira e come figlia»: figure di caritas e sapientia nelcielo del Sole – S. FERRARA, Tra pena giuridica e diritto morale: l’esilio di Dante nelle Epistole.LECTURAE DANTIS: A. BATTISTINI, Il «ver c’ha faccia di menzogna»: Lettura di Inferno XVII
– N. MALDINA, L’«oratio super Pater Noster» di Dante tra esegesi e vocazione liturgica. PerPurgatorio XI, 1-24. NOTE: P. CHERCHI, Joanot Martorell, Ausiàs March e la Vita nova – R.HOLLANDER, Inferno V, 138: Francesca’s Confession – V. BARTOLI, Il concetto di sinderesi nellaCommedia – G. ALONZO, «E quel di Portogallo». Note sul biasimo dantesco a D. Dinis. RE-CENSIONI.
ISBN 978-88-8063-763-9
ISSN 0516-6551
L04
00
41€ 20,00