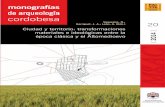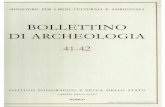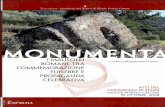2010 - Roma, il suburbio e l'Italia in età medio- e tardo-repubblicana: cultura materiale,...
Transcript of 2010 - Roma, il suburbio e l'Italia in età medio- e tardo-repubblicana: cultura materiale,...
Direttori:Daniele Malfitana · Jeroen Poblome · John Lund
Comitato scientifico:S. E. Alcock (Brown University, R.I.) · P. M. Allison (University of Leicester) · D. Bernal (Universidad de Cadiz) · M. Bonifay (Centre Camille Jullian - UMR 6573, CNRS) · R. Brulet(Université Catholique de Louvain) · L. Chrzanovski (International Lychnological Associa-tion) · F. D’Andria (Uni versità di Lecce) · M. de Vos (Università di Trento) · K. Dunbabin(McMaster University, Ontario) · M. Feugère (Equipe TPC - UMR 5140, CNRS) · I. Free-stone (Cardiff University) · M. Fulford (University of Reading) · C. Gasparri (Università diNapoli “Federico II”) · E. Giannichedda · F. Giudice (Università di Catania) · A. Hochuli- Gysel (Fondation Pro Aventico, Avenches) · S. Ladstätter (Österreichische Akademie der Wis-senschaften) · M. Lawall (University of Manitoba) · M. Mackensen (Ludwig-Maximilians-Universität, München) · D. Manacorda (Università di Roma Tre) · D. Mattingly (Universityof Leicester) · M. Mazza (Università di Roma “La Sapienza”) · D. Michaelides (Universityof Cyprus) · M. D. Nenna (Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon) · M. O’Hea (University of Adelaide) · E. Papi (Università di Siena) · D. P. S. Peacock (Universityof Southampton) · N. Rauh (Purdue University) · P. Reynolds (University of Barcelona) ·G. Sanders (The American School of Classical Studies at Athens) · F. Slavazzi (Università diMilano) · K. W. Slane (University of Missouri- Columbia) · N. Terrenato (University ofMichigan) · M. Torelli (Università di Perugia) · H. von Hessberg (Universität zu Köln) ·
A. Wilson (University of Oxford) · D. Yntema (Vrije Universiteit Amsterdam)
Coordinamento redazionale:Carmela Franco (Londra) · Annarita Di Mauro (Catania)
Revisione testi in lingua inglese:Elizabeth A. Murphy (Brown University, R.I., USA)
Consulente di redazione per la grafica e la fotografia:Giovanni Fragalà
*
«Facta» is an International Peer-Reviewed Journal.The eContent is Archived with Clockss and Portico.
FACTAA JOURNAL OF ROM AN
MATERIAL CULTU RE S TUD IES
edited by
daniele malfitana, jeroen poblome,
john lund
4 · 2010
PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMXI
Amministrazione e abbonamentiFabrizio Serra editore®
Casella postale n. 1, succursale n. 8, i 56123 Pisa,tel. +39 050542332, fax +39 050574888
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabilipresso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.
Print and/or Online official subscription rates are availableat Publisher’s web-site www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa,tel. +39 050542332, fax +39 050574888, [email protected]
Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma,tel. + 39 06 70493456, fax + 39 06 70476605, [email protected]
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 22 del 15-ix-2004Direttore responsabile: Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parzialeo per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica,il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta
della Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2011 by Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.
Stampato in Italia · Printed in Italy
www.libraweb.net
issn 1971-9051issn elettronico 1974-451x
SOMMARIO
Jeroen Poblome, Daniele Malfitana, John Lund, Editorial preface 9Clementina Panella, Roma, il suburbio e l’Italia in età medio- e tardo-repubbli-
cana: cultura materiale, territori, economie 11Martin Pitts, Artefact suites and social practice: an integrated approach to Roman
provincial finds assemblages. 125Janne P. Ikäheimo, Pot calling the kettle black? Classifying re-fired Roman cooking
pots 153
review section
Piazza Armerina. Villa del Casale e la Sicilia tra Tardoantico e Medioevo, a cura diP. Pensabene (Daniele Malfitana) 163
Èchanges et vie économique dans le Nord-Ouest des Gaules. Le témoignage des am-phores du iie siecle avant J.-C. au ive siècle après J.-C. eds. F. Laubenheimer,E. Marliere (Stefania Pesavento Mattioli) 168
Books received (a cura di Annarita Di Mauro) 173
Instructions to authors 175
Addresses of contributors 177
ROMA, IL SUBURBIO E L’ITALIAIN ETÀ MEDIO- E TARDO-REPUBBLICANA:
CULTURA MATERIALE, TERRITORI, ECONOMIE
Clementina Panella
li Atti del Convegno dedicato al territorio di Roma tra la fine dell’età monar-chica e la nascita del sistema delle ville (Suburbium ii) offrono numerosi spunti
di riflessione.1 Lo spazio interessato dalle ricerche presentate in questo volume ha ri-guardato la città “fuori le mura”, mentre l’arco cronologico ha abbracciato un perio-do tra i meno noti della storia della città in relazione all’organizzazione dei territori,all’evoluzione dei paesaggi, alla produzione e alla circolazione di beni di largo consu-mo. In tale ambito le indagini sul campo di questi ultimi anni e la raccolta sistemati-ca della documentazione bibliografica e di archivio hanno fornito le basi per ridise-gnare un quadro aggiornato delle forme di occupazione dell’agro (abitati, vie, luoghidi culto, necropoli) e del suo sfruttamento (fattorie e ville, cave, bonifiche, impianti etracce di coltivazione). In particolare i canali e gli scassi per vigna registrati in più pun-ti del suburbio orientale e meridionale,2 grosso modo databili tra iv (con qualche an-ticipazione più antica) e ii/i secolo3 hanno riportato in primo piano il nodo rappre-sentato dai rifornimenti vinari della città in età medio- e tardo-repubblicana e più ingenerale i problemi collegati all’agricoltura remunerativa dell’Italia repubblicana, so-prattutto nel periodo compreso tra v e iii secolo, che è apparso fino a tempi recenti,relativamente al paesaggio agrario del Lazio, come un’“età oscura”.4
La testimonianza delle anfore
Generalmente, in assenza del vino bevuto o svanito, è alle anfore – contenitori vina-ri per eccellenza – che sono affidate le stime sullo smercio di questa derrata e indiret-tamente sulla produzione vitivinicola delle regioni interessate dall’esportazione.5
1 Per un primo commento, v. il mio intervento alla Discussione in Suburbium ii, pp. 389-392.2 Ai siti recensiti da Volpe 2009 vanno aggiunti gli altri impianti presentati in Suburbium ii da Buccel-
lato - D’Annibale - Torri 2009, da Egidi 2009 e tutti quelli confluiti nella Carta Archeologica e nel cd-rom annesso al volume. Per la presentazione analitica dei ritrovamenti di Centocelle (villa della Piscina evilla detta ad duas lauros, villa “delle Terme”) e di Tor Spaccata (quattro complessi riferibili a ville) si rimandaa Volpe 2004 e a Gioia 2008.
3 Le date sono da intendere a.C., salvo diversa indicazione.4 L’espressione è di Carandini 2006, p. 559.5 L’indistruttibilità della ceramica ha fatto sì che lo studio di questi manufatti abbia costituito la base del-
le ricerche finalizzate alla ricostruzione del commercio di una grande varietà di derrate (vino, olio e olive,conserve di pesce e pesce in salamoia, frutta e conserve di frutta, carne secca, nocciole, aridi, miele), ma an-che di generi di diversa natura (pece, allume), benché sia certo che altri tipi di contenitori realizzati in ma-teriale deperibile (otri, botti) siano stati impiegati nell’antichità per trasportare e distibuire queste medesi-me merci dai luoghi della produzione a quelli del consumo (Marlière 2002 e 2007). Alle traversate permare, in particolare, hanno risposto per secoli le anfore con le loro dimensioni medio-grandi, idoneeall’“imbottigliamento” di una grande quantità di sostanze a fronte di una relativa maneggevolezza; la ter-
G
Ora, in riferimento a Roma e al periodo in esame, i dati spettanti a questa classe del-l’instrumentum sono assai scarsi,1 al contrario di quanto accade in altri centri dell’Oc-cidente, ma anche in zone prossime a Roma, come l’ager Portuensis.2 Va detto che leanfore che circolano nel Mediterraneo fanno riferimento in quest’epoca, ed in parti-colare in età medio-repubblicana, a determinati tipi, di cui si conoscono nelle linee ge-nerali le aree di origine: da quelle etrusche a quelle massaliote, destinate entrambe ascomparire dai mercati extraregionali nel iii secolo, dalle più longeve anfore puniche(del Nord-Africa e delle zone sotto l’influenza cartaginese, inclusa la Sicilia occiden-tale e la Sardegna),3 a quelle corinzio-corciresi e di provenienza egea e microasiatica(Lesbo, Chio, Taso, Rodi, Cos, Cnido), anch’esse relative a produzioni di lunga dura-ta. Anche l’Italia Meridionale nei rispettivi settori greci e italici e la Sicilia (in ambitogreco, italico, punico) hanno conosciuto per il trasporto del vino già nel v secolo, poipiù intensamente nel iv e nel iii secolo e oltre, una produzione di contenitori cera-mici che fanno capo ad una famiglia molto eterogenea di anfore studiata recente-mente da Ch. Van der Mersch e suddivisa in sei tipi (MGS i-vi).4 Il tipo v (che evolvedal più antico tipo iii) e il tipo vi rientrano in un gruppo da tempo radicato nella tra-dizione degli studi con il nome di anfore “grecoitaliche”.5 La loro produzione è attestata già nel corso del iv secolo ad Ischia («quartier éloigné de Naples»)6 e forsedai decenni finali di questo stesso secolo a Neapolis7 e, con qualche scarto cronologi-
minazione a punta permetteva un loro razionale stivaggio nelle navi mercantili, mentre la loro resistenzaera assicurata dalla qualità dell’impasto e dallo spessore delle pareti. Sull’“architettura” complessa dei cari-chi v. la ricostruzione della disposizione delle Dressel 1 nella nave naufragata alla Madrague de Giens pres-so Marsiglia in Tchernia - Pomey - Hesnard 1978, pp. 21-25.
1 Ne dà conto Volpe 2009, p. 377, tabella 3: le anfore da trasporto (tutte le produzioni e tutti i tipi inclu-si) in sette scavi romani con contesti compresi tra il iv e il i secolo (Curia, Esquilino/Aqua Marcia, Palati-no/Domus Regis Sacrorum, villa dell’Auditorium, Meta Sudans, Casale Brunori, Centocelle/villa della Pisci-na) hanno percentuali sul totale della ceramica raccolta comprese tra lo 0,5-0,8% (scavo della villadell’Auditorium) e il 5,07% (scavo della Meta Sudans).
2 Morelli - Olcese - Zevi 2004, pp. 49-50; Olcese 2009, p. 146, nota 13: le anfore riferibili ai tipi Van derMersch v, vi e v/vi (ivi, p. 148, fig. 3) hanno percentuali tra il 10 e il 30% sul totale del materiale ceramicoraccolto in cinque siti di questo territorio di recente indagati dalla Soprintendenza Archeologica di Ostia.Le analisi di laboratorio condotte su alcuni campioni mostrano un’eterogeneità di impasto, che rimanda aduna molteplicità di provenienze. Solo per alcuni di essi è stato possibile istituire confronti con gruppi di re-ferenza noti (di Minturno, forse di Mondragone): Olcese - Thierrin Michael 2009.
3 Tipologia, centri di produzione e diffusione in Ramon Torres 1995.4 Van der Mersch 1994. La sigla MGS sta per anfore “MagnoGreche-Siciliane”. In questo studio l’area
geografica comprende le regioni a Sud del Silaris/Sele e la Sicilia; la cronologia riguarda il v, il iv e il iii se-colo fino alla caduta di Siracusa del 211.
5 Utilizzata per la prima volta da Benoit 1957, pp. 251-256, questa denominazione intendeva mettere inevidenza i rapporti tra un gruppo anfore di età ellenistica caratterizzate da elementi tipologici comuni, ri-tenute tra le più antiche produzioni italiche, e il mondo greco, da cui si riteneva che il modello derivasse.La terminologia è stata generalmente accolta, nonostante i tentativi di sistematizzare su nuove basi la lorotipologia (v. Appendice i). I contributi essenziali sono di Lyding Will 1982, Manacorda 1986 e 1989, He-snard et alii 1989, Van der Mersch 1994 e 2001; Olcese 2004; Cibecchini - Capelli c.s.
6 Morel 1988a, p. 329.7 Per Ischia (fornaci presso Santa Restituta) v. Olcese - Picon - Thierrin Michael 1996; Olcese 2004;
per Ischia e Neapolis, Olcese 2005-2006; per gli scarti di fornace di grecoitaliche rinvenuti nel corso degliscavi per la realizzazione della Metropolitana di Napoli (San Lorenzo Maggiore, Piazza Dante) riportabiliai tipi Van der Mersch iii, v, vi, ma anche iv, si rimanda a Giampaola 2005, pp. 89-90 e Olcese 2005-2006,p. 62, passim. La produzione del tipo Van der Mersch iv, databile tra il iv e i primi anni del iii secolo, è at-testata anche ad Ischia (Olcese 2004, pp. 177-178).
12 clementina panella
co tra territorio e territorio che non riusciamo a definire con esattezza, nel Lazio, inCampania, in Etruria e sul versante adriatico della penisola.1 L’adozione generalizza-ta nel iii secolo di questo tipo di anfora (dallo Ionio alla Sicilia, dal Tirreno all’Adria-tico) mostra la volontà di uniformarsi ad un modello immediatamente riconoscibileed universalmente accettato sui mercati extraregionali, anche in riferimento a siste-mi standardizzati di misurazione.2
Gli studi più recenti hanno evidenziato che il fenomeno produttivo e commercialericostruibile attraverso l’indicatore fornito dalle grecoitaliche,3 rinvenute talvolta in si-ti assai lontani dall’Italia e dalla Sicilia (da Mas Castellar-Pontós presso Emporiae/Am-purias al Pech Maho presso Narbona, da Cadice ad Aléria in Corsica, da Alessandria aPanticapeo) e nei relitti (almeno quindici in Occidente tra 300 e 200),4 è nel iii secolo
1 Per i centri di produzione di anfore repubblicane dell’Italia tirrenica (grecoitaliche e Dressel 1) si ri-manda a Olcese 2009, p. 147, fig. 2 e nota 19. All’addensamento di testimonianze relative al Lazio meridio-nale (Astura, Minturno, Fondi, Formia) e alla Campania settentrionale (Sinuessa/Mondragone, ager Faler-nus) corrisponde il gruppo di officine dell’Etruria meridionale costiera (ager Cosanus - Porto di Cosa: LydingWill 1987; Albinia: Vitali 2007; Vitali - Laubenheimer - Benquet 2007) e settentrionale (ager Pisanus eVolaterranus: Menchelli 1990-1991, p. 170; Pasquinucci - Del Rio - Menchelli 1998, p. 357, fig. 1, note 10,12 e da ultimo Menchelli et alii 2007, pp. 142-143). Probabile è la presenza di fornaci a Graviscae, porto diTarquinia (Fosso della Bandita a Pian di Spille presso Montalto di Castro: Incitti 1986a), e a Pyrgi, porto diCaere (Cava di Caolino: Incitti 1990), interessate, per quel poco che è stato pubblicato, dalla fabbricazionedi Dressel 1A, Dressel 1B e di grecoitaliche apparentemente di ii secolo. All’elenco occorre aggiungere sul-la base degli impasti Pompei/Sorrento (esemplari del tipo Van der Mersch v e vi e Dressel 1 con “black sand”fabric nella casa del Cinghiale, nella casa dei Fiori, nella casa delle Forme di Creta: Scotti 1984, pp. 273-275,tavv. 147-151; D’Ambrosio - De Caro 1989, fig. 47, FC 1800A e fig. 54, FC 3449). Prevale in tutti i siti la pro-duzione di Dressel 1 (metà ii/terzo quarto del ii-i secolo), ma le grecoitaliche sono presenti quasi ovunqueall’inizio del funzionamento degli impianti, così come molti sono i centri che nel corso del i secolo con-vertono la produzione delle Dressel 1 nelle Dressel 2-4 (ager Cosanus, Fondi, Sinuessa / Mondragone, Pom-pei…). Occorre inoltre tener presente nel computo complessivo delle aree produttive quelle sicure (poche:Naxos, Gela/Agrigento, Metaponto, Temesa/Nocera Terinse) o supposte (molte) in ambito siciliano e nel-l’Italia meridionale illustrate per il iv-iii secolo nello studio di Van der Mersch 1994, a cui si rimanda (perVelia v. ora Maggi 2004 e 2005), e quelle del versante adriatico interessato anch’esso dalla manifattura digrecoitaliche (v. oltre) e successivamente da quella delle Lamboglia 2 e delle Dressel 6A. Per le anfore delBruzio di età tardo-repubblicana (Dressel 1, Lamboglia 2, Dressel 2-4), v. oltre, pp. 52-53.
2 In Sicilia e nella Magna Grecia di età ellenistica i moduli sono basati sul ¯Ô‡˜ (l 3,24) e i suoi multipli:Van der Mersch 1994, p. 112. Le unità di volume nel mondo romano sono basate sul sextarius (circa l 0,54)e sui suoi multipli: l’amphora (= 48 sextarii, circa l 26), la metreta (=1,5 amphorae) e il culleus (=20 amphorae):De Sena 2005, pp. 136-137. Per fare un esempio, le grecoitaliche di Cattolica (v. oltre, p. 18, nota 1) equival-gono all’incirca ad un’amphora: Stoppioni 2008, pp. 136-137, passim.
3 Mi riferisco in particolare al tipo Van der Mersch v, esemplificato dalle anfore dei relitti eoliani dellaSecca di Capistello e di Panarea (Roghi 1) (fine iv/inizi iii secolo) (v. Fig. 1.1-2), e al tipo Van der Mersch vi,esemplificato sia da un’anfora di Camarina (v. Fig. 2.3) che da un’anfora frammentaria di Taranto (v. Fig.2.5). I due tipi corrispondono rispettivamente alle forme Will 1a1 e Will 1d e alle grecoitaliche antiche di Ma-nacorda 1986 e 1989. Ho scelto di far precedere i numeri romani della tipologia dello studioso belga dal suonome piuttosto che dalla sigla MGS già menzionata (v. sopra, p. 12, nota 4) e dalla sigla RMR (anfore “Ro-mane Medio-Repubblicane”: Van der Mersch 2001), perché sulla base del solo “disegno” non è oggi possi-bile attribuire le grecoitaliche ad un ambito storico-economico preciso (sui problemi posti dalla tipologiadelle grecoitaliche rimando all’Appendice i).
4 Cibecchini 2004, p. 63 assegna a questi cento anni tredici relitti con grecoitaliche nel MediterraneoOccidentale: tre agli anni 300-250 e dieci agli anni 250-200. In questo computo manca il relitto degli IlôtsBruzzi in Corsica, datato da Long 2004, p. 148 al 230-210, mentre il relitto di Pointe Lequin, che l’autrice po-ne tra il 200 e il 175, potrebbe appartenere anch’esso al iii secolo. Va segnalato che le date proposte per que-sti giacimenti da Van der Mersch 2001, p. 172 e tab. 2 si discostano, talvolta sensibilmente, da quelle pro-poste dalla Cibecchini (v. Appendice i).
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 13
già abbastanza visibile. Le grecoitaliche attribuite ad ambito “romano”, contraddi-stinte almeno dal secondo quarto/metà del iii secolo dalla pratica della bollatura in la-tino, cioè le anfore che spettano a territori appartenenti allo stato romano o a città en-trate nell’orbita politica, militare, economica di Roma mediante l’istituto dellealleanze (Neapolis già dal 326) attraversano con le loro presenze, dalla fine del iv, tuttoil iii e la prima metà del ii secolo. Cosa e Paestum, entrambe colonie del 273, definisco-no i limiti dell’estensione territoriale portata a termine fino a quel momento nell’Ita-lia centrale tirrenica, mentre Rimini, colonia del 268 e Brindisi, colonia del 244, segna-no la presa di possesso dell’altro versante peninsulare. Queste anfore si accompagnanonei viaggi per mare1 alla ceramica a vernice nera degli ateliers etrusco-laziali des petitesestampilles, alla Campana A di Neapolis arcaica e antica, alla ceramica a vernice nera ar-caica e antica di Cales (Campana B di Cales), colonia del 334, alla Campana B etrusca,2mentre si perdono alla fine del iii secolo le tracce delle grecoitaliche magnogreche esiciliane, se ad esse ci si riferisce in termini geopolitici e culturali, a cui allude la deno-minazione MGS di Van der Mersch. La conquista dell’Italia meridionale era di fatto av-venuta nel settantennio che va dalla deditio di Capua nel 343 alla vittoria su Taranto del267/266. La Sicilia era diventata provincia già nel 241. Le rivolte divampate un po’ovunque durante la guerra annibalica vennero duramente represse e con la sconfittadi Cartagine nel 201 il potere di Roma non fu più messo in discussione, con un totalestravolgimento dell’assetto amministrativo, politico e sociale di queste regioni.
La scala della commercializzazione delle grecoitaliche, che aveva un certo rilievo,come si è detto, già nella metà/seconda metà del iii secolo, cresce con il trascorreredei decenni, parallelamente ad una costante trasformazione delle caratteristiche mor-fologiche dei contenitori. Si passa da anfore di altezza piuttosto ridotta con pancia atrottola ben distinta dalla spalla, collo basso, orlo triangolare leggermente inclinato,anse flesse (tipi Van der Mersch v e vi: v. Figg. 1.1-2, 2.3-5, 3.6-7), ad anfore di maggioridimensioni,3 dal corpo ovoidale, dal collo più lungo e con anse sinuose, mentre l’or-lo assume il profilo a labbro obliquo e il fondo diventa pieno e sempre più massiccio.A queste anfore, assenti nella classificazione di Ch. Van der Mersch, che chiude la suaanalisi con il iii secolo, corrisponde la denominazione di grecoitaliche tarde o recen-ti di Manacorda 1989. La serie è inaugurata dagli esemplari del Grand Congloué 1presso Marsiglia che corrispondono alla forma Will 1c (v. Fig. 3.8), e comprende nelii secolo una successione di tipi di cui danno testimonianza le anfore dei relitti dellaChrétienne C, Monte Rose, La Ciotat, Punta Scaletta4 (= forma Will 1e: v. Fig. 3.9).
Tali modifiche rispondono a scelte di carattere economico: maggiore maneggevo-lezza, maggiore capacità, maggiore resistenza, maggiore accuratezza metrologica,5maggiore standardizzazione. Il processo, che sembra lineare nel lungo periodo, po-trebbe tuttavia aver interessato con modi e tempi diversi le singole aree produttrici.Nel breve periodo ignoriamo la storia dei singoli impianti, mentre è all’interno di que-sti ultimi che bisognerebbe stabilire una gerarchia tra quelli più aggiornati ed aperti
1 Sul commercio marittimo di questa età v. Morel 2005.2 Utilizzo per queste due classi di vasellame fine le definizioni proposte da Cibecchini - Principal 2004.3 L’altezza va dai 60/70 cm delle anfore più antiche ai 90/100 cm delle più recenti.4 V. Tchernia 1986, pp. 314-315.5 È assegnata alla fine del iii secolo la lex Silia ponderibus publicis (Cloud 1985).
14 clementina panella
alla sperimentazione, in grado di innovare sul piano tipologico, ed officine, apparte-nenti magari allo stesso orizzonte cronologico, più conservatrici e meno disposte adintrodurre variazioni rispetto al modello. Di qui la possibile esistenza di una fascia piùo meno ampia di sovrapposizioni morfologiche all’interno delle quali non siamo ingrado, in base ai dati disponibili, di operare suddivisioni sensate.
La diffusione è invece resa evidente dalle quantità di reperti registrati in Italia ed al-trove. Ai ventisette relitti con grecoitaliche nel Mediterraneo occidentale segnalati daF. Cibecchini tra il 200-150/125,1 fanno riscontro le presenze nella Gallia interna giànei decenni precedenti la conquista del 125-121 della Transalpina2 (è il caso dei ritro-vamenti di Vieille-Toulouse nell’Istmo gallico3 o di quelli del sito occupato in seguitoda Lugdunum/Lyon),4 nella Spagna Citeriore, già provincia nel 197 (in particolare aCartagena),5 a Cartagine prima della distruzione,6 mentre la scoperta di un certo nu-mero di fornaci nell’Italia centrale tirrenica consente di superare alcune delle incer-tezze che gravavano sulle aree di origine del iii secolo e ad ancorare su basi docu-mentarie un po’ più solide alcuni territori alla produzione di anfore e di vino.Concorrenti, spesso presenti in Italia nei contesti tardo-repubblicani, ma in quantitàmodeste, sono solo le anfore egee (di Chio, di Cos, di Cnido, e soprattutto di Rodi)7
1 Cibecchini 2004, p. 63; Cibecchini 2008, p. 485.2 Carta di distribuzione contenente anche dati quantitativi in Poux 2004, p. 195, fig. 114. A questo studio
(pp. 192-196 e nota 570) e a Olmer 2003, pp. 216-217 si rimanda per l’elenco delle attestazioni e per la bibliografia.
3 Benquet 2007. 4 Poux - Savay Guerraz 2003.5 Località El Molinete: Molina Vidal 1998, pp. 124-125, 136.6 Morel 1998a-2004; Bechtold 2007a; v. anche Appendice II.7 Segnalo solo alcuni contributi recenti sui ritrovamenti di anfore rodie in Italia, recensiti per la prima
volta da Dell’Aglio - Lippolis 1989: per la Sicilia, Garozzo 2003 e 2008; Garozzo 1999, in particolare pp.281-286, ove si recupera tutta la bibliografia sulle anfore ellenistiche – soprattutto rodie – rinvenute nell’isola;per Centuripe, Patané 2002, pp. 158-160, fig. 10, 6, 11; pp. 162-167; per la Sardegna, Mastino - Spanu - Zucca2005, p. 109, nota 561; per il Salento, Auriemma 2004, 2, pp. 150-152, passim; per Taranto, Lippolis 1997, pp.23-26; per Pompei, Pascual - Ribera - Finkielsztejn 2007; per Falerii Novi (Civita Castellana), Bevilacqua1994; per Populonia, Tilloca 2001, Lancioni 2003, Rizzitelli 2006; per le Marche, Marengo 2000; perAquileia e l’Italia settentrionale, Tiussi 2007; per i relitti, Gianfrotta 2007b, p. 68. Insieme ad Erice (Pellegrini 1887) e a Siracusa (Gentili 1958), Taranto è la città che ha restituito la più ampia documen-tazione di contenitori rodii, proponendosi anche come centro di ridistribuzione in Italia e in Sicilia. È inu-tile dire che la “visibilità” delle anfore greche (e rodie in particolare) è affidata alla costante presenza dellabollatura, che ha determinato la conservazione dei pezzi e la loro pubblicazione. Ciò non vale ad esempioper le anfore corinzie/corciresi (Corinzie B), anch’esse presenti in età ellenistica nell’Italia meridionale, inSicilia, in Adriatico e nel Nord-Africa (Cartagine, Leptis Magna, Sabratha), ma assai più raramente bollate.Una carta di diffusione delle anfore rodie in base alla cronologia dei bolli è in Rauh 1999, p. 166, fig. 2; peril commercio dell’isola nel ii secolo e il riorientamento di tale commercio dopo il 166 verso il Sud (Egitto)e il Sud-Est si rimanda a Finkielsztejn 2001b. Dati quantitivi relativi ai bolli delle anfore rodie in diversi si-ti del Mediterraneo – anche occidentale – divisi per i periodi i-vi secondo la cronologia di V. Grace sonopresentati da Étienne 1990, p. 216, fig. 4. Rielabora i dati quantitivi nelle principali città dell’Egeo e del-l’Oriente Finkielsztejn 2001b secondo la sua nuova cronologia. Va segnalata l’assenza di bolli rodii a Ro-ma nell’IG xiv, benché sia certo che le anfore rodie siano giunte sul mercato romano, come dimostrano iritrovamenti in larghissima parte inediti nelle stratigrafie urbane del ii e degli inizi del i secolo, anteriori al-la trasformazione della forma (a cui diamo il nome di Camulodunum 184) e alla fine del complesso sistemadi bollatura che aveva caratterizzato la produzione di età ellenistica. Inconsistente comunque il dato ro-mano in confronto agli 80.000 bolli conservati nel Museo greco-romano di Alessandria (Empereur 1998, p.398) a cui vanno aggiunti altri diciottomila esemplari della Collezione Benaki (Grace 1985, pp. 42-43), di-stribuiti su tre secoli, dalla fine del iv al i secolo a.C., relativi ad una produzione che timbra sistematica-mente ambedue le anse.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 15
e le anfore puniche,1 di cui tuttavia non è dato conoscere con certezza il contenuto(conserve di pesce, olio, carne secca, ma anche vino).2
Intorno alla metà/terzo quarto del ii secolo le officine tirreniche che avevano pro-dotto anfore grecoitaliche cominciano ad adottare un nuovo modello che è l’esito diun’ulteriore modifica delle caratteristiche morfologiche dei contenitori più antichi.Nasce così la Dressel 1, la classica anfora vinaria italica, fossile-guida in Occidente dell’età tardo-repubblicana.3 Alle fornaci che continuano a produrre, altre se ne ag-giungono aumentando il numero dei centri produttori di vino e di anfore destinate amercati più o meno lontani.4 All’incremento della scala produttiva, corrisponde l’impressionante quantità dei ritrovamenti nella Francia centrale, occidentale e sud-occidentale5 e in Spagna.6 Ciò parrebbe significare che la continuità suggerita dalla
1 V. la documentazione ora edita degli scavi nella Regio vii di Pompei: Pascual - Ribera - Finkielsztejn2007. 2 Tresserras - Matamala 2004.
3 Ampia è la bibliografia delle Dressel 1: sintesi ancora attuali in Tchernia 1986 e in Empereur - He-snard 1988; v. anche Poux 2004. 4 È il caso del Bruzio, v. pp. 54-53.
5 Olmer 2003, pp. 147, 157-170, 209-216 ha studiato, basandosi sulla diffusione dei bolli impressi sulle Dres-sel 1, la direzione dei flussi di importazione in Gallia del vino tirrenico, osservandone le variazioni a secon-da dei comparti regionali: vini dell’ager Cosanus in Gallia centrale e centro-orientale – Borgogna, Arvernia,Lionese – (ivi, p. 214, fig. 59), vini attribuiti al Lazio meridionale e alla Campania soprattutto nell’Istmo gal-lico (ivi, p. 213, fig. 58). Per l’insieme della Gallia, indipendentemente dal materiale bollato, l’apporto dei vi-ni tirrenici viene stimato (tra il 125 e il 50) intorno ad un milione di anfore all’anno, pari cioè a 2,5 milioni diettolitri (Olmer 2008, pp. 217-218). Oltre un milione sarebbero le Dressel 1 giunte in poco meno di un se-colo a Bibracte in Borgogna, capitale degli Edui, che deve aver funzionato anche come centro di ridistribu-zione (plaque tournante économique: Olmer 2003, p. 136) nella Gallia centro-orientale e verso le regioni ger-maniche e la Britannia. Presenze, diffusione per ambiti regionali, dati quantitativi e bibliografia delle anforeitaliche in 2001, pp. 45-128; Poux 2004, p. 203, fig. 118, passim; per il materiale bollato Olmer 2003, pp. 261-263, 265; per Toulouse e Vieille-Toulouse, Benquet 2007. Per le vie di transito verso la Gallia centrale, ac-canto all’asse Rodano/Saona, deve aver funzionato anche una via che partendo da Arles attraversava le Cé-vennes per raggiungere la Loira e l’Allier fino all’Alvernia: Olmer 2003 e 2008, pp. 226-228. Basandosisull’analisi tafonomica dei contesti, Poux 2004 ha riesaminato le cause del consumo di vino nella Gallia in-dipendente, mettendo da parte fattori economici o di acculturazione e giustificando la massiccia acquisi-zione di questa derrata nel mondo celtico con il funzionamento di una società all’interno della quale i fe-stini rituali e i riti di libagione avevano un posto primordiale nella autorappresentazione delle élites locali(in ultima analisi nella gestione del potere). Benché fossero altri gli scopi della ricerca, M. Poux ha fornitougualmente una base documentaria eccezionale anche per chi vuole recuperare dai dati archeologici la “di-mensione economica” (produttiva e commerciale) dell’offerta romana sollecitata dalla domanda delle po-polazioni indigene, indipendentemente dall’uso che esse hanno fatto del vino e delle anfore. Diversa è latradizione del bere nella Gallia destinata a diventare Provincia, da Narbona a Marsiglia. La cultura del vino,impregnata di elementi mediterrani (come attestano, accanto alle anfore, i servizi connessi al vino, primitra tutti le coppe in ceramica a vernice nera e i vasi per versare, i mestoli e i colini), aveva in quest’area ra-dici lontane trasmesse per il tramite di Marsiglia dal vi secolo alle regioni confinanti con una produzionevinicola, nel caso della colonia focese, e una commecializzazione mediterranea non irrilevante, affidata dal-l’età arcaica alle anfore massaliote (carta di diffusione in Bats 1990, pp. 276-277). Sulla storia della viticoltu-ra in Provenza e Languedoc, v. ora la sintesi di Brun 2004, pp. 199-216, con bibliografia. Massalia è anche iltramite della diffusione del vino italico nella Gallia indipendente, così come il sito che precede Narbo Maius(Naro, identificata con Montlaurès) lo è per l’Istmo gallico e l’Aquitania.
6 Per la diffusione delle anfore italiche di età repubblicana nella Hispania Citerior si rimanda a MolinaVidal 1997, che ha esaminato e quantificato le anfore di una trentina di siti tra Ampurias e Cartagena, e aMárquez Villora - Molina Vidal 2005: Emporion, Saguntum, Carthago Nova sono i punti di arrivo di uncommercio che è stato analizzato, dopo il pionieristico articolo di Nolla - Nieto 1989, per comparti re-gionali. Sono state così precisate le zone di influenza dei tre porti principali, con una separazione abbastanzanetta nelle importazioni delle Dressel 1 e delle Lamboglia 2 (cioè di vino tirrenico e vino adriatico) che pas-
16 clementina panella
storia degli impianti ceramici è solo apparente, se si confrontano i dati quantitativi registrati nei siti di consumo con quelli dei decenni immediatamente precedenti (oltresessanta sarebbero i relitti con Dressel 1 individuati finora nel Mediterraneo occiden-tale, ma il loro numero è in costante crescita).1 In controluce si legge lo sviluppo diuna viticoltura capace di rispondere sia ad una accresciuta domanda interna, sia ad accresciute richieste “estere” provenienti da una diversificata gamma di consumatoriitalici e non (coloni, soldati, appaltatori, commercianti, ma anche élites indigene di regioni non ancora conquistate). Ma questa è una storia ampiamente nota che precede (in alcuni casi) o procede (in altri) parallelamente alla romanizzazione del-l’intero Mediterraneo.2
Meno conosciuta è l’importanza che assume in questa stessa seconda metà del ii se-colo la produzione delle anfore di area adriatica anch’esse vinarie e anch’esse ispirateal modello grecoitalico.3 Per questo versante della penisola lo stato degli studi nonconsente ancora di seguire con la stessa precisione il filo rosso che collega, all’internodelle officine, le grecoitaliche adriatiche4 (già nel iii secolo) alle Lamboglia 2,5 se nonricorrendo alla morfologia e agli impasti. Proprio il rapporto con le Lamboglia 2 haspinto in questi ultimi anni a raccogliere indizi intorno ad aree e territori finora trascurati nella storia della viticoltura in Italia nella sua fase più antica. Tali indizi
serebbe per il Cabo de la Nao e San Antonio presso Dianium/Denia. Nel Nord-Est prevarrebbero le prime,giunte e ridistribuite da Ampurias, nel Sud-Est si avrebbero attestazioni alte delle seconde, giunte e distri-buite da Carthago Nova. Rotte influenzate da turbolenze, correnti e venti e destini diversi analizzati ancheda Pérez Ballester 2003 e 2004; Pérez Ballester - Pascual Berlanga 2004; Vivar 2004. Per la docu-mentazione di Saguntum v. Aranegui Gascó 2004; per Ampurias Nolla Brufau 1974 e 1978; per Numan-tia, distrutta da Scipione Emiliano nel 133, Sanmartí 1992, Sanmartí - Principal 1997; per le Baleari, “pun-to critico” delle rotte meridionali, Toniolo - Fayas Rico 2002. Tre le differenze tra il consumo di vino italicoin Spagna rispetto alla Gallia: inferiori quantità, natura del consumo (il vino sembra radicato nei costumialimentari, piuttosto che costituire un bene di prestigio) e per la tipologia dei consumatori (romani, italici,popolazioni indigene “acculturate”).
1 Secondo Long 2004, p. 187 sarebbero ottanta le navi con Dressel 1 naufragate lungo le coste della solaFrancia meridionale.
2 Carandini 1988, 1989a e 1989b; Tchernia 1986; Poux 2004; Panella 2006.3 La storia delle grecoitaliche adriatiche è ancora da scrivere in relazione sia al iii secolo, sia alla prima
metà del ii secolo, anche se alcuni dati sono già acquisiti. Occorre rivolgersi ai tipi Adria 16-18 (Toniolo 2000,pp. 137-171, appartenenti a tombe del II secolo) o al tipo Will 3, datato da Lyding Will 1989, pp. 301-302 tra il166 e 146, per avere un’idea delle anfore di transizione dalle grecoitaliche alle Lamboglia 2, ma la documen-tazione spettante ai grandi centri del Mediterraneo orientale – primi tra tutti Corinto, Atene, Alessandria –è in gran parte inedita. D’altro canto è verso quest’area, che aveva già da secoli produzioni vinarie fiorentied esportate, che si rivolgerà almeno dalla metà/terzo quarto del II secolo il commercio delle regioni adria-tiche affidato alle Lamboglia 2, facendo perno su Delo (dopo il 166 con la creazione del porto franco, o for-se meglio, dopo il 146 e prima dell’88 o del 69), e – per la diffusione nel Levante – su Alessandria.
4 Manacorda 1998; Toniolo 1998 e 2000; Stoppioni 2008; Horvat 1997, p. 123, fig. 47 (carta di diffu-sione delle grecoitaliche nell’Adriatico settentrionale, tutti i tipi inclusi).
5 Rassegna bibliografica in Bruno 1995; aggiornamenti (centri di produzione, epigrafia) in Carre 2002;Carre - Pesavento Mattioli 2003, p. 268, nota 1; Starac 2008. Due sono gli impianti che presenterebbe-ro una continuità produttiva dalle grecoitaliche alle Lamboglia 2, entrambi nel Piceno meridionale: SilviMarina (prov. Pescara), in prossimità della foce del fiume Piomba (Staffa 2003, pp. 118-119, fig. 2, 1-2) e Ma-rina di Città Sant’Angelo (prov. Pescara) tra le foci del Piomba e del Saline (Staffa 2003, 119-129, fig. 3, 1-3;Staffa 2004, pp. 279-280, fig. 27), ma, non essendo nota la cronologia dei contesti, non è possibile sapere sesi tratti di una documentazione spettante al iii o al ii secolo. Tuttavia ad una grecoitalica del tipo Van derMersch v (quindi del iii secolo) potrebbe appartenere un fondo cavo da Silvi Marina (Staffa 2003, fig. 2, 2).
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 17
tendono a dimostrare che esistono le condizioni per l’esistenza già a partire dal iii se-colo,1 e più concretamente nella prima metà del ii secolo, di contenitori vinari desti-nati al trasporto di eccedenze, realizzati in diversi punti del versante nord- e medio-adriatico della penisola, o meglio tra l’area deltizia padana e il Piceno (Marche eAbruzzi attuali).2 Sul piano delle fonti letterarie viene a questo proposito citato il pas-so di Polibio (iii, 88, 1-3), che ricorda che Annibale dopo aver attraversato l’Umbria eil Piceno, giunto al mare,3 fece lavare i cavalli nel vino vecchio per liberarli dalla scab-bia «vista l’abbondanza della produzione».4 Anche la testimonianza di Catone (Origi-nes) attraverso Varrone (r.r. i, 2, 7) e ancora Polibio (ii, 15) alludono a quella stessa ab-bondanza in riferimento all’ager Gallicus e alla Cisalpina, ove la viticoltura dovevaessere stata avviata dai Galli con tecniche apprese per il tramite di Marsiglia, degliEtruschi e dei Greci. D’altro canto tra il 289 (o il 283), fondazione della colonia marit-tima di Sena Gallica, e il 181, fondazione della colonia di Aquileia, testa di ponte stra-tegico-militare verso l’Europa centro-orientale,5 queste regioni vengono interessateda un vasto fenomeno coloniario documentato dalla centuriazione,6 che coinvolgeprima il Piceno e l’ager Gallicus (e la Puglia meridionale: del 244/243 è la colonia lati-na di Brundisium, altra testa di ponte strategico-militare e commerciale, ma verso
1 La pubblicazione delle necropoli di Adria (iv-ii secolo) ha dimostrato che le grecoitaliche, che costi-tuiscono la maggioranza delle anfore rinvenute nelle tombe, presentano già dal secondo quarto del iii se-colo (tipi Adria 3, 4, 5, ma già forse il tipo 2, con cui si risalirebbe alla fine del iv/inizi iii secolo) impasti ca-ratteristici dell’Adriatico (Toniolo 2000, pp. 17 e 32 ss.). Questo dato, unito alla somiglianza tipologica dellegrecoitaliche dei tipi 16-18 rinvenute nelle tombe del ii secolo con le Lamboglia 2 che da questo versante del-la penisola provengono, costituisce la prova dell’esistenza di una produzione di vino e di anfore che si sta ri-velando precoce in un areale abbastanza difficile da definire, ma che sembra coinvolgere l’arco settentrio-nale dell’Adriatico (Adria, Spina), inclusa l’area padana (Cattolica) e il Piceno meridionale (Hatria/Atri). Allametà del iii secolo si data la discarica della darsena di Cattolica con oltre novecento grecoitaliche del tipoVan der Mersch v e v/vi: il “butto”, che contiene numerosi scarti di fornace, può essere attribuito ad un’offi-cina situata in prossimità della foce del fiume Tavollo (Stoppioni 2008). Attualmente questa è la prima te-stimonianza certa dell’adozione delle grecoitaliche nel milieu adriatico, mediato sia attraverso i contatti conla Magna Grecia, documentati già a Spina e ad Adria prima del iii secolo, sia soprattutto attraverso i contat-ti con Neapolis mediati da Roma (o attraverso i contatti con Roma mediati da Neapolis; la vicina colonia diAriminum adotta nella monetazione il piede romano-campano). La fondazione di questo centro segna il ter-mine post per la produzione di Cattolica. Altri territori, solo indiziati della fabbricazione di queste anfore inun ambito territoriale prossimo, sono la stessa Adria: Righini 1997 e Toniolo 2000, e forse Spina: De Lu-ca De Marco 1979; Desantis 1991-1992. Sulla circolazione di anfore e vini nel settore adriatico tra iv e il iiisecolo, con qualche accenno anche ad eventuali luoghi di produzione sul versante orientale di anfore vicineal tipo v, è in Van der Mersch 1994, pp. 137-139. Il più antico relitto nell’alto Adriatico peninsulare è quellodi Grado (metà iii secolo o poco dopo) con grecoitaliche del tipo Van der Mersch vi, molto vicine al tipo 4di Adria e ad alcune anfore della discarica di Cattolica. Su uno degli esemplari di questo carico è un graffito(ante/post cocturam?), che ha la forma del psi greco, interpretato come numerale (Tortorici 2000).
2 Lo scarico della darsena di Cattolica fa riferimento probabilmente ad Ariminum, colonia del 268. È pos-sibile pensare ad una cronologia alta anche per la documentazione raccolta a Hatria/Atri nel Piceno meri-dionale, colonia dedotta tra il 290 e il 286 o poco più tardi: Tchernia 1986, pp. 55-56.
3 Sulla localizzazione dell’episodio del 217 – tra Ancona e il confine settentrionale dell’ager Praetutianus– v. Alfieri 1981, p. 23.
4 Il “vino vecchio”, di cui parla lo storico, presuppone un impianto di vigneti non troppo recente, chepotrebbe risalire alla metà del iii secolo. Si tratterebbe di una produzione vinaria ancora priva sbocchi com-merciali per Tchernia 1986, p. 57, ma l’ipotesi va ora confrontata con i nuovi dati relativi alle grecoitalicheadriatiche.
5 Una produzione di grecoitaliche è stata supposta anche ad Aquileia (Horvat 1997). Dal suo territorioprovengono con sicurerezza Lamboglia 2 (fornace di Locavaz).
6 Bandelli 1991, pp. 89-90, nota 76, con bibliografia.
18 clementina panella
l’Oriente) e poi, dagli inizi del ii secolo, la stessa Cisalpina fino alle valli prealpine. Néva ignorato il ruolo produttivo – sempre nel iii secolo – del Salento (che si distingue-rà nel ii e nel i secolo per la produzione e la diffusione soprattutto dell’olio del Brin-disino), come suggerisce la documentazione archeologica collegata alle anfore gre-coitaliche di Ugento e di Torre San Giovanni sul versante ionico della provincia diLecce e a quelle (forse) di Valesio sul versante adriatico della provincia di Brindisi,1 ecome lasciano supporre le testimonianze letterarie relative al vino di Taranto, uno deipochi vini nobili di quest’area.2
Ancora senza prove certe è una produzione in età ellenistica di grecoitaliche (e inseguito di Lamboglia 2) anche sul versante orientale dell’Adriatico. Indizi, basati es-senzialmente sulla diffusione, sono stati raccolti per Issa/Vis, Epidamnos/Dyrrachium,Apollonia.3 Il ritrovamento di un gran numero di esemplari lungo le coste della Dal-mazia (si parla di un centinaio di relitti e di “rilasci” in acqua di grecoitaliche e so-prattutto di Lamboglia 2),4 potrebbe essere spiegato con la pericolosità di una costafrastagliatissima infestata per secoli dai pirati, punto di transito obbligato della para-litoranea orientale, che è stata, a causa dei venti e delle correnti favorevoli e della pre-senza delle innumerevoli isole ed insenature, il percorso per eccellenza della traver-sata adriatica.5 Di segno diverso potrebbero essere le presenze ad Apollonia, Durazzo,Butrinto e nelle altre città greche dell’Illiria, che, oltre ad essere centri di ridistribu-zione e di transito verso il Nord e verso l’interno, sono da considerare anche centri diconsumo.6 I luoghi di origine degli esemplari più antichi rinvenuti ad Apollonia po-trebbero essere tirrenici o dello Ionio (Taranto?), come dimostrerebbero le centinaiadi grecoitaliche recentemente edite dei tipi Van der Mersch v e vi reimpiegate in undrenaggio presso l’Odeon.7
Intorno alla metà/terzo quarto del ii secolo, contemporaneamente alla nascita dellaDressel 1, la forma dell’anfora vinaria adriatica (la Lamboglia 2) appare morfologica-mente connotata, benché articolata in una certa quantità di tipi, in relazione ad offi-cine che operano nel Salento (Taranto?) e, in particolare, nel territorio di Brindisi8
1 Desy 1983; Desy - De Paepe 1990; Yntema 2006, pp. 105-106, fig. 8a: grecoitalica da una tomba di Va-lesio datata intorno alla metà del iii secolo.
2 Le fonti (da Orazio ad Ateneo: Tchernia 1986, pp. 336-337; Lombardo 1996) sono tutte più tarde del-l’epoca di cui ci stiamo occupando. Sulle cause della “visibilità” della viticoltura e del consumo – smodato– di vino in questa città in confronto alle notizie su questi stessi temi spettanti ad area messapica e a Brin-disi, v. Lombardo 1996, pp. 4-5 (qui anche per le altre poche attestazioni letterarie relative alla coltivazionedella vite nel Salento). Qualche dato sulle anfore rinvenute a Taranto è nell’Appendice iii.
3 Kirigin - Katunaric - Šešeli 2006; Tartari 1982, p. 271; Mano - Dautaj 1997, p. 146.4 Kirigin - Katunaric - Šešeli 2006, con bibliografia.5 Sui collegamenti marittimi di attraversamento che potrebbero spiegare alcuni elementi della diffusio-
ne, si rimanda ai numerosi contributi editi in Strutture portuali e rotte marittime.6 Shehi 2003, p. 210, tav. 1; v. anche Buora 2003, p. 41, fig. 1; Lahi 2009, pp. 73-86, passim.7 Lahi 2008 e 2009, p. 82, figg. 29-30: per questo autore le anfore dei tipi Van der Mersch v e vi presenti
in Albania sarebbero “sud-italiche con qualche apporto dalla Campania”. Sulle rotte utilizzate per rag-giungere le coste dell’Illiria, l’Epiro e la Grecia, partendo dai porti e dagli approdi della Puglia, v. Auriem-ma 2004, con bibliografia; Lahi 2009, p. 141, fig. 53. Ad Apollonia iniziava la via Egnatia, della seconda me-tà del ii secolo, che rappresentava l’asse transbalcanico di collegamento di Roma/Brindisi (attraverso la ViaAppia) con Tessalonica e Bisanzio.
8 Palazzo 1989, fig. 1, 1; Palazzo - Silvestrini 2001, tav. xvii: tipo Apani i (metà/seconda metà del iisecolo a.C.); Manacorda 2001a, p. 232, fig. 3, 4: tipo Giancola 2A della prima metà del i secolo (in assenza
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 19
(qui, come si è già detto, anche per una produzione olearia, “imbottigliata” e tra-sportata nelle anfore ovoidi dette di Brindisi,1 diffuse prevalentemente in Oriente),nella Venetia orientale (Aquileia),2 nell’entroterra padano (Mutina/Modena, forse Pia-cenza),3 in Emilia4 (Bononia, Ariminum, Forum Corneli/Imola, Cesenatico),5 nell’agerGallicus6 (Cesano di Senigallia e dintorni,7 Suasa), nel Picenum8 (dall’ager Firmanus aPotenza Picena a Nord9 all’ager Praetutianus e Hadrianus a Sud10). Ager Gallicus e Pice-no appaiono – almeno in base al materiale bollato – le aree più impegnate nel-l’esportazione marittima, soprattutto nella fase più tarda della produzione delle Lam-boglia 2 (decenni centrali del i secolo). Sull’organizzazione dei territori di questafascia peninsulare, qualche ulteriore osservazione è nell’Appendice iii.
Anche per queste anfore, come per le Dressel 1, la diffusione è ampia e in alcunicentri di un certo peso quantitativo. L’esportazione, diretta essenzialmente ad Est,11interessa l’Istria con punte anche nell’entroterra centro-europeo per il tramite diAquileia, le coste illiriche, greco-epirote e greco-macedoni per il tramite di Ancona,12
di pezzi interi da Giancola, il tipo è esemplificato dall’anfora completa di Apani). Pur rientrando all’internodella famiglia delle Lamboglia 2, le anfore Apani i/Giancola 2A hanno delle particolarità morfologiche chetuttavia non sono rilevabili quando si esamina materiale frammentario. Inoltre il registro epigrafico è in comune con quello delle anfore ovoidi olearie (bolli degli Aninii per Apani, di Visellius per Giancola). Neconsegue che neppure i bolli, che sono stati pubblicati per decenni senza disegni del supporto, aiutano a capire l’incidenza nelle esportazioni d’oltremare di questi contenitori. La diffusione sembra comunque, separagonata a quella delle anfore olearie, quantitativamente assai inferiore. Tra la metà del ii e il i secolo saranno infatti i vini delle regioni centro- e nord-adriatiche, almeno sulla base del materiale bollato, ad alimentare la maggior parte del commercio transmarino.
1 Manacorda 1994a e 2003; Palazzo 1994, 1996, 2005, 2006; Palazzo - Silvestrini 2001.2 Maselli Scotti 1980; Maselli Scotti 1987.3 Da Maranello, località Torre delle Oche, nel territorio di Mutina, colonia del 183: Bertolani - Gior-
dani - Loschi Ghittoni 1995; Giordani 1990, pp. 151-159 e passim; Giordani 2000, pp. 365-366; Giordani2001, pp. 255-256; per Placentia, colonia del 218, v. Marini Calvani 1992, p. 776.
4 La Cispadana orientale, cioè la costa romagnola, viene ricordata dalle fonti letterarie per i vitigni di ab-bondanza e per i rendimenti eccezionali delle sue vigne (per il territorio a Sud di Rimini, Catone attraver-so Varrone, r.r., 1, 2, 7; per il territorio di Faventia/Faenza, Varro, loc. cit.; Col., r.r., 2; App., BC, 1, 91; per Mo-dena, Plin., NH, xiv, 39; per Ravenna, Strabo, 5, 1, 7; Col., r.r. 3, 13, 8; Plin., NH, xiv, 34; Martial, 3, 56). La viteè la spionia, il cui nome viene forse da Spina; ciò rimanderebbe a colture antiche della Cisalpina (Tchernia1986, p. 111 e passim). I Caesenatia vina sono menzionati da Plinio (NH, xiv, 67).
5 Fornace in località Ca’ Turchi: Farfaneti 2000, pp. 130-133.6 Paci 1998; Luni 2002. “Vini senza nome” sono quelli che spettano all’ager Gallicus, frutto di vigneti di
cui gli scrittori antichi ricordano la straordinaria fecondità, ma non la qualità (v. sopra).7 Carre 2002. 8 Delplace 1993 e 1996.9 Officina di Fosso San Biagio presso Firmum (Brecciaroli Taborelli 1984); per le ricognizioni nel-
l’ager e per la ricostruzione del paesaggio agrario di questo territorio si rimanda a Pasquinucci - Men-chelli 2002; per la fornace di Potenza Picena e per nuove indagini territoriali nell’area della colonia e delmunicipium di Trea, v. Vermeulen et alii 2009, pp. 93-95.
10 Per l’ager Praetutianus v. Guidobaldi 1996a, pp. 206-207; Guidobaldi 2001, p. 90. Della fornace di Co-logna Marina, nel territorio di Castrum Novum/Giulianova, è data notizia da Cipriano - Carre 1989, pp. 77,81. L’Hadrianum (di Hatria/Atri: v. sopra, p. 18, nota 1 e il Praetutianum sono vini di qualità (Tchernia 1986,pp. 167-168, 259-260, 348-349), menzionati solo da autori di età imperiale (ivi, pp. 338-339), ma le attestazionidi officine delle Lamboglia 2 consentono ora di pensare a produzioni già avviate in età repubblicana.
11 Tchernia 1986, p. 53 sgg., 72-73; Cipriano - Carre 1989, Appendice C.12 La colonia siracusana di Ankon è punto di appoggio della navigazione commerciale greca verso il delta
padano, poi fulcro insieme con Brindisi dei collegamenti dell’Italia con il mondo ellenistico e con il Mediterraneo orientale, già entrata nell’orbita romana nel 178 o meglio integrata nel sistema di difese del-lo stato romano in quanto base navale nelle operazioni contro la pirateria illirica (Delplace 1993, pp. 28-29e passim). Sulla diffusione delle Lamboglia 2 nell’alto Adriatico, v. Horvart 1997, p. 125, fig. 49. Per l’Alba-
20 clementina panella
di Brindisi e forse di Taranto, l’Egitto (Alessandria, alto Egitto, Fayoum), la Grecia(Atene, Delo, Rodi, Cos, Tenos, un relitto a Thasos), l’Asia minore (Pessinunte, Efe-so).1 il Levante.2 Queste ultime regioni sono raramente toccate dalle coeve anfore vi-narie tirreniche e comunque investite in modo molto più consistente dalle importa-zioni dei vini greco-insulari e microasiatici. Fa eccezione la Spagna, ove le Lamboglia2 appaiono attestate in relazione a determinate rotte – quella “meridionale” che pas-sava per le Baleari tagliando il Golfo del Leone – e a determinati centri (per esempioCarthago Nova), che ne garantivano la ridistribuzione.3 Ancora più a monte c’è da sup-porre (sempre? in alcuni casi?) una formazione dei carichi diretti ad Occidente nei por-ti/deposito tirrenici, in primo luogo a Puteoli (ciò vale anche per le Lamboglia 2 e perle non numerose anfore ovoidi di Brindisi rinvenute in relitti con carichi “misti”).
Un’ipotesi di periodizzazione
Riprendendo un’ipotesi di periodizzazione proposta da J.-P. Morel, ci sembra possibi-le ripercorrere le fasi salienti della cultura materiale della media e tarda repubblica,puntando sui momenti di discontinuità riscontrati nella storia produttiva e commer-ciale della ceramica fine da mensa e delle anfore.4 Le datazioni proposte presentanodue fasce di sovrapposizione (relative agli anni 265/250 e 220/200), che indicano “ipunti critici”. È inutile rilevare che i tasselli che compongono questo quadro dipen-dono dalla visibilità dei siti, dalla loro interpretazione tipologica e funzionale e dalladatazione dei contesti, che riflette a sua volta quella che assegniamo alla ceramica, te-nuto conto che le due classi più rappresentative di quest’epoca – il vasellame a verni-ce nera e i contenitori da trasporto – sono oggi sottoposte a profonde revisioni. Bastacambiare una delle variabili e l’intero sistema subisce contraccolpi e va ripensato. Al-trettanto inutile è sottolineare il rischio di ridurre a schema elementi culturali com-plessi, puntando sui macrofenomeni e macrosistemi e lasciando da parte la notevolevarietà dei microfenomeni e microsistemi regionali, ognuno dei quali ha una sua sto-ria. Ma il tentativo ha lo scopo di sollecitare la pubblicazione di dati inediti, di contri-buire alla ricostruzione su base storica dell’evidenza archeologica, ed ha il vantaggiodi far emergere i nodi irrisolti sopratutto per difetto o per l’inaffidabilità della docu-mentazione, oppure per la nostra incapacità di interpretare i dati.
Periodo i (300-265/250). La data iniziale, che segna il primo fondamentale cambia-mento rispetto al passato, è legata all’andamento della produzione e della diffusionedelle ceramiche a vernice nera (ceramica da simposio per eccellenza e quindi colle-gata al vino). Gli ultimi anni del iv secolo (325/320) vedono la fine dell’esportazionemassiccia della ceramica attica a vernice nera in alcune regioni dell’Occidente e la dif-fusione in quest’ambito territoriale di vasellame non originario dal Mediterraneoorientale. La principale classe di ceramica fine centro-tirrenica presente nella primametà del iii secolo nei circuiti interregionali e mediterranei occidentali è quella che
nia, ove le Lamboglia 2 sono in assoluto le anfore più attestate nel ii-i secolo, si dispone ora della raccoltapubblicata da Lahi 2009, da prendere con riserva per quanto attiene all’identificazione delle forme.
1 Monsieur 2001, p. 75 e p. 80, figg. 11-12; Bezeczky 2004, p. 85, fig. 1, 6.2 Finkielsztejn 2000, tav. 108.3 Pérez Ballester - Pascual Berlanga 2004. 4 Morel 1998b, pp. 518-520.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 21
fa capo all’atelier des petites estampilles,1 o meglio al gruppo di ateliers, localizzati traRoma e l’Etruria meridionale, che utilizzano sul fondo dei vasi un tipo particolare distampigliatura.2 Nel mondo delle anfore questo è il periodo delle grecoitaliche “ar-caiche” (Van der Mersch v, v. Fig. 1.1-2). Si tratta di contenitori afferenti a diverse edifferenziate aree geografiche e culturali (Magna Grecia, Sicilia, ma anche Campa-nia/Ischia e Neapolis e, nel corso e/o allo scorcio del periodo, Lazio meridionale/Min-turno, Pompei/Sorrento, Etruria (meridionale, settentrionale?), senza dimenticarel’area adriatica. v. sopra per il tipo 3 di Adria e per le anfore di Cattolica), a cui si rico-nosce la messa in campo di circuiti regionali3 e dei primi circuiti extraregionali e me-diterranei.4 L’esportazione d’oltremare sembra già appannaggio in questo periodo
1 Numerose sono le classi di vasi figurati, facenti capo all’agro Falisco, a Caere, a Tarquinia, che prece-dono l’exploit del gruppo dell’atelier des petites estampilles (o che si associano per un breve lasso di tempo aquest’ultima produzione) e che conoscono una circolazione di breve e medio raggio, talvolta anche medi-terranea (v. i piattelli di Genucilia attribuiti a Caere), non paragonabile tuttavia a quella della ceramica del-l’atelier (su di esse, una bibliografia aggiornata è nelle note di Ferrandes 2006).
2 Individuato e studiato per la prima volta da Morel 1969, questo vasellame viene oggi datato tra gliultimi decenni del iv e la fine del iii secolo (Ferrandes 2006; Stanco 2009). I centri di origine finora iden-tificati riguardano l’intero territorio etrusco-laziale (Roma, Segni, Caere, Lucus Feroniae, Vulci, Tarquinia, Fa-lerii Veteres e altri: Ferrandes 2006 e 2008, p. 364, nota 12; Stanco 2009; per Veio e per una carta delle for-naci di ceramica a vernice nera della media valle del Tevere in base ai dati delle ricognizioni, v. Di Giuseppe2005b, pp. 43-45, fig. 6), con diramazioni anche in aree coloniali (Ariminum e Aesis) e con una probabile filia-le a Populonia nell’Etruria settentrionale. Il periodo di massima produttività e diffusione sembra ricollega-bile all’attività delle officine di Roma, riconoscibili per caretteristiche formali, decorative e tecnologiche,corrispondenti alla fase iii della tipologia di Stanco 2004 = facies ceramica 6 di Ferrandes 2006, pp. 151-157, collocabili tra il 280-270/265-260. I vasi stampigliati rinvenuti nei maggiori centri del Mediterraneo ne-gli anni a cavallo tra il primo e il secondo quarto del iii secolo potrebbero provenire pertanto in parte o ingran parte proprio da Roma (sulle officine romane, v. Olcese 1998, pp. 141-145; Stanco 2009, pp. 159-160).A titolo informativo si segnala che né in Suburbium ii, né negli allegati a questo volume elaborati dalla So-printendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (Carta delle attestazioni dal v al ii secolo a.C. e cd-rom), vi è riscontro nelle zone prossime alla città, così intensivamente indagate sino al ix miglio, di forna-ci di ceramica o di laterizi. Eppure la città produce dall’età regia diversificato materiale fittile (tegole, coppi,antefisse, lastre), lucerne, vasi in ceramica comune e da fuoco ed è indiziata nell’età medio-repubblicana an-che della produzione di ceramica fine (piattelli di Genucilia, vasellame del gruppo dell’atelier des petitesestampilles, pocola deorum, ecc.). Gli unici riferimenti relativi a questa attività artigianale restano pertantoquelli segnalati da Petracca - Vigna 1985, ma si tratta di officine di età imperiale, trovate casualmente, nonscavate e in gran parte rimaste inedite, ad eccezione dell’impianto rinvenuto sull’Esquilino nel 1877 all’in-crocio tra via dello Statuto e via Merulana che è da collegare all’attività laterizia (pesi da telaio, dolii) deiSextii (Lanciani 1877), datata in età repubblicana (ivi, p. 133, nota 1). Di ambito urbano (Oppio, Esquilino,Celio) sono anche i dati suggeriti dalla toponomastica (nomi di quartieri come “in figlinis”, Argiletum, forseLateranum) e dai rari e dispersi ritrovamenti archeologi (v. gli scarichi di lastre Campana e altro materale fit-tile di Via Gallia, databili tra tarda repubblica e età augustea): Manacorda 2007, pp. 199-202. Al suburbiodovrebbe spettare invece una fornace di età repubblicana, di cui è stata data recente notizia, rintracciata nel-lo scavo della villa dell’Auditorium sulla via Flaminia (Auditorium 2006, p. 393, passim) (v. oltre, p. 26, nota 3).
3 Tale ci sembra la diffusione delle grecoitaliche registrate in Sicilia e in Magna Grecia da Van derMersch 1994, pp. 76-78, alla cui analisi si rimanda, ma una parte dei materiali potrebbe non essere origina-ria di queste regioni. È il caso delle anfore del relitto di Capistello a Lipari, che costituisce invece per que-sto studioso il punto di partenza proprio del suo tipo MGS v (v. oltre, p. 23, nota 5). Carte di distribuzionecompaiono in Van der Mersch 1994, p. 123 sgg., ma i tipi MGS i-vi vengono trattati tutti insieme ed è mol-to difficile riarticolare una cronologia e una diffusione che prenda in considerazione punti di origine diffe-renti da quelli attribuiti all’Italia meridionale e alla Sicilia.
4 Al di fuori dell’Italia e della Sicilia, va segnalata la presenza di anfore del tipo Van der Merch v, in quan-tità assai modeste in centri costieri del Mediterraneo occidentale e nel loro immediato hinterland: Aléria (v.oltre, pp. 23-24, nota 7), Lattara/Lattes (2001, pp. 46, 51), Cartagine (v. Appendice ii), Leptis Magna (necropolisotto il teatro: De Miro - Fiorentini 1977, pp. 40-42, n. 56, tomba 5a) e Sabratha (necropoli di Mellita: Bisi -
22 clementina panella
dei territori centro-tirrenici.1 Le analisi archeometriche sembrano confermare questotrend, evidenziando nel commercio mediterraneo di quest’età l’apporto di Neapo-lis/Ischia o più genericamente di “Ischia/Golfo di Napoli”, secondo la definizione diG. Olcese, formula che non esclude un più ampio ambito produttivo campano-lazia-le.2 Un’abbondante bibliografia ha analizzato gli intrecci di interessi tra famiglie ro-mane, neapolitane e mercanti greci, che si percepiscono dietro l’alleanza del 326. Il va-lore del porto di Neapolis, tra i più importanti del Tirreno, è causa non secondaria delsuccesso economico e commerciale della città e del suo territorio3 all’indomani dellafirma del foedus con Roma, una città quest’ultima non servita dal mare, ma che al ma-re affidava in quei decenni difesa ed offesa.
I bolli sono in greco4 (alcuni sicuramente ischitani, altri neapolitani: Olcese 2004e 2005-06).5 Inizia allo scorcio di questo periodo (secondo quarto del iii secolo)6 la tim-
Di Vita 1969-1970: un esemplare con bollo AN¢[P]øN, ivi, p. 209, fig. 30, tomba A, n. 8; p. 230, fig. f; si no-tino le due impressioni digitali alla base delle anse, come accade spesso sulle grecoitaliche di Ischia), Ibizae Cartagena. Per la Catalogna, poco hanno aggiunto all’analisi puntuale di Nolla - Nieto1989, pp. 368-376(v. l’esemplare di Ullastret, Girona, ivi, p. 389, fig. 2) i ritrovamenti più recenti di grecoitaliche riportabili altipo Van der Mersch v: le loro attestazioni rifletterebbero un commercio complementare, inferiore in que-sta prima metà del iii secolo a quello punico e a quello massaliota. Delle anfore relative ai siti sopra citati siignora l’origine, ad eccezione forse di quelle con i bolli ¢Iø = ¢›ˆ(Ó) e BIø = BȈ(Ùfi˜ o altro scioglimen-to) di Carthago Nova/Cartagena (Martín Camino 1996 e 1998), che potrebbero trovare confronto con quel-li, di analogo testo, del relitto di Capistello (attribuito ora ad Ischia/Neapolis, v. p. 23, nota 5).
1 Van der Mersch 2001, p. 171, passim. 2 Olcese 2004, p. 178.3 Numerosi elementi confermano la visione di una città prospera a seguito del foedus aequum con Roma
e della concessione della civitas sine suffragio, vitalità dovuta alla funzione di porto (manutenuto e drenato traiv e iii secolo) sul Mediterraneo greco che Neapolis poteva offrire a Roma, meglio di Cuma, anch’essa dal 338entrata nel novero delle civitates sine suffragio, ma condannata a perdere il porto a causa dell’impaludamentodella sua baia. L’economia di Neapolis non subì contraccolpi negativi neppure dalla creazione del porto di Puteoli dopo la guerra annibalica, anzi, a giudicare dalla diffusione delle produzioni neapolitane (CampanaA, anfore/vino), è possibile ritenere che fu proprio questa fondazione (e gli interessi romani verso il grandecommercio dopo la vittoria su Cartagine) ad ampliare gli sbocchi commerciali della città campana, su cui doveva necessariamente appoggiarsi una parte del traffico che gravitava su Pozzuoli, garantendo ad essa e aisuoi mercanti aperture nel Mediterraneo fino ad allora inimmaginabili: De Caro 2005, pp. 654-661, con bi-bliografia. Cuma, non più funzionale sul piano portuale e marittimo, divenne invece con il territorio flegreola meta di elezione delle residenze dell’aristocrazia romana a partire da ii secolo (De Caro 2005, pp. 643-654).
4 Un Indice è in Van der Mersch 1994, p. 159 ss.; per i bolli rinvenuti in Sicilia, in gran parte su grecoi-taliche e in gran parte in greco, v. da ultimo Garozzo 2008, pp. 587-588, note 57-82, con bibliografia.
5 Le anfore del relitto della Secca di Capistello a Lipari, unanimemente datato al 300-280, hanno un cor-redo epigrafico che trova confronti con il materiale bollato di Ischia (Olcese 2005-2006, p. 66). L’ipotesi cheil carico della nave provenga da quest’isola, che contraddice un’opinione diffusa (quella che il carico sia sici-liano: Van der Mersch 1994, pp. 74-75), può costituire un caposaldo nell’interpretazione di uno dei relitti piùsignificativi di questo periodo e aprire nuove prospettive alla ricerca. Irrisolto rimane il problema dell’origi-ne del lotto di vasi a vernice nera (circa 300 pezzi) riesaminato da Morel 2004, pp. 83-87, che potrebbe spet-tare ad altra area, comunque non identificata. Ad Ischia/Neapolis sembra che vadano attribuite anche le gre-coitaliche di tipo Van der Mersch v di due relitti leggermente più antichi, quelli di Panarea (Roghi 1) e di CapoGraziano B (Filicudi B) (ultimi decenni / fine del iv secolo), nonché un gruppo di esemplari riferibili allo stes-so tipo, con analoghe caratteristiche tecnologiche e di impasto (impasto F1), dalla necropoli di Portinenti (Li-pari): Campagna 2000, p. 452, con bibliografia; Olcese 2004, p. 181. Da questa necropoli viene il più antico ouno dei più antichi bolli in latino finora rinvenuto (N.AVLANI retro., ripetuto su entrambe le anse della stes-sa anfora). Per i bolli in greco si rimanda a Campagna 2000. Tra di essi (ma da strati superficiali della necro-poli) si segnala [A]NTA§§ = [\A]ÓÙ¿ÏÏ(Ô˜), attribuito da Van der Mersch 1994, p. 162, ad area siciliana, mache potrebbe essere assegnato, in base ad analisi di laboratorio, ad Ischia/Golfo di Napoli o più genericamentealla Campania/Lazio meridionale (Olcese 2004, p. 182, gruppo chimico 2 di Ischia), come gli esemplari conlo stesso marchio di Ischia e di Ensérune (letto erroneamente ANTAX: Jannoray 1955, pp. 326-327, nota 1).
6 Un indizio che la bollatura in latino possa risalire ancora più indietro nel tempo è fornito da un bollo
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 23
bratura in latino1 (bolli di N. Aulanius:2 anteriore al 252-251, di L. Valerios:3 ante 250?, di
di difficile interpretazione, impresso sull’ansa di una Van der Mersch v (o iii?) rinvenuta nella necropoli diAléria in Corsica (Jehasse 1973, p. 194, n. 357, tavv. 143 e 170), trascritto RI.L retro. + anfora da Hesnard etalii 1989, pp. 30-31, nota 20, se mai da interpretare come PI.L + anfora, con P molto aperta, L ad uncino. Latomba è datata da J. e L. Jehasse al 325-275, al 300-275 da Van der Mersch 1994, p. 172, che legge il bollo, co-me gli editori, NIø. Sugli altri elementi dei corredi funerari di questa città, tra i quali a partire da un certomomento compaiono ceramiche campane, etrusche e soprattutto laziali in sostituzione dei prodotti attici,punici e dell’Italia meridionale, v. Van der Mersch 1994, p. 135. Un altro indizio è costituito dal graffito(forse dopo la cottura) su una grecoitalica del tipo Van der Mersch iii nell’Antiquario di Orbetello: MPK (oMRK) ritenuto in alfabeto latino (Tchernia 1986, p. 48), a cui Van der Mersch 2001, pp. 194-195, nota 376assegna una datazione alla seconda metà del iv secolo. Più vicina alla data assegnata al bollo latino di Lipa-ri è una grecoitalica del tipo Van der Mersch v con un graffito sulla spalla (dopo la cottura) che riporta ilnome di M. Veio(s), da Pisa/San Rossore (v. oltre, p. 25, nota 4 e p. 36, nota 3). Analoga potrebbe essere la da-tazione (ante 258?) di un bollo di controversa interpretazione, impresso sull’ansa di un esemplare di questostesso tipo, rinvenuto nella “cella vinaria” della Stoà Ovest dell’Agorà di Camarina (Pelagatti 1984-1985, p.689, fig. 3, tav. cxlviii, 2): AMOL (se con andamento discendente, L ad uncino), o ]NOMA (se con anda-mento ascendente: Van der Mersch 1994, p. 179, che interpreta come una N mal impressa quella che con-sidera come prima lettera). Se l’alfabeto fosse realmente latino, un possibile scioglimento potrebbe essereA. Mol(lius), un gentilizio registrato da Schulze 1904, p. 427.
1 Per bolli e graffiti in latino sulle anfore grecoitaliche, v. l’Index di Van der Mersch 2001, pp. 194-199.Ho aggiunto i riferimenti bibliografici solo per il materiale epigrafico pubblicato dopo il 1994 (per i bolli ingreco) o dopo il 2001 (per i bolli e i graffiti in latino) e per le assenze. Al Corpus dei bolli sulle anfore romane, i.Le anfore italiche (eds. C. Panella, V. Morizio), in preparazione, devo tutte le informazioni sulla bollatura pre-senti in queste pagine.
2 Dalla necropoli di Portinenti a Lipari: Campagna 2000, pp. 455-456, 470, n. 55, fig, 2.d; tavv. ii i, iv e-f,h. Del gentilizio non esistono, come sembra, altre attestazioni, ma v. la forma Aulenus (Roma, cil vi, 8022,Venafro, cil x, 4916, 4926 e Telesia, cil ix, 2221, 2300). Aulianius è documentato come cognomen (illrp, 680)in età repubblicana e Aulanius è attestato a Vasto (prov. Chieti) in un’iscrizione del i secolo d.C. (M. PaquiusAulanius: cil ix, 2827). Quest’ultimo cognome sarebbe derivato per Solin - Salomies 1988, p. 28 da un ori-ginario gentilizio.
3 Alla gens Valeria, originaria della Sabina, ben attestata a Minturno, appartiene una serie di bolli con di-versi testi già registrati da Van der Mersch 2001, pp. 197-198, s.v.: da Minturno (anche retro.), da Mas Ca-stellar-Pontós (dal riempimento di un silos datato al 225-200 dell’insediamento iberico abbandonato versoil 185-175), dalla Sicilia (senza provenienza, oggi nella Collezione Mandralisca di Cefalù, e da Panormos/Pa-lermo; per quest’ultimo, impresso su un’anfora del tipo Van der Mersch v, v. Lauro 2005: L.VALER, pa-leograficamente diverso dai precedenti: L non uncinata, V evoluta), forse da Cartagine (da espungere dal-l’elenco di Van der Mersch i due es. di Populonia che da un mio ricontrollo appartengono ad altro nome).Il bollo L.VALIIR (VA in nesso, E a due tratti,) da Siracusa (Garozzo 2003, tav. xciv, 4) è paleograficamen-te simile agli esemplari timbrati [L.]VALERIO di Minturno, ma da diverso punzone, come indica il testo.Ad un Valerius con il prenome M(arcus) sembrano da riferire i due bolli M.VA (dalla Sicilia), da non confon-dere per paleografia con M.VA (o L.VA) della c.d. nave “punica” di Marsala (v. nota seguente). L(ucius) è in-vece certamente il prenome espresso nel bollo L.VA.PE da Selinunte, che sembra appartenere ad altra se-rie e ad altro individuo. Difficili da sciogliere le lettere finali, giacché l’esemplare dovrebbe essere anteriorealla distruzione della città avvenuta alla metà del iii secolo. Poiché è poco verosimile pensare in un’età co-sì risalente ad un cognomen, che compare nell’epigrafia anforaria molto più tardi, può forse essere presa inconsiderazione l’ipotesi che si tratti di un patronimico riferibile ad antichi prenomi oschi, Pe(rcennus), Pe(s-- -), Pe(tro)?: v. Salomies 1987, pp. 85, 112. Lo stesso vale per un’altra serie ben documentata, sicuramente deliii secolo avanzato, Q.ANTRO, che preferisco riferire al gentilizio, in vero raro, Antronius (Schulze 1904, p.124), piuttosto che sciogliere RO, come propone Manacorda 1989, pp. 445-446, nell’etnico Ro(manus). Unesemplare recentemente edito da Capena (Stanco 2001, p. 185, n. 190, tav. iv) su una grecoitalica di tipo Vander Mersch vi di piccolo modulo, con impasto presumibilmente campano (mia autopsia), estende la diffu-sione di questo marchio, noto finora solo in Sicilia (Lilibeo, Erice) e a Ischia, anche all’Italia centrale. Ri-tengo inoltre che le serie Q.ANT, Q.ANTR/Q.ANT.R, Q.ANTRO appartengano per caratteristiche paleo-grafiche e per i luoghi di ritrovamento allo stesso individuo (non così per Van der Mersch, che distinguedagli altri, Q.ANT). Dall’ager capenate proviene un’altra grecoitalica anepigrafe, ma del tipo Van der Merschv (Incitti 1986b).
24 clementina panella
M.VA(lerius) o L.VA(lerius):1 prima guerra punica?), indizio di un diretto intervento“romano” nella fabbricazione delle anfore e nel commercio vinario. Altre grecoitali-che del tipo Van der Mersch v di ambito tirrenico (v. l’ipotesi di una provenienza adesempio da Minturno, nel Lazio meridionale, oltre che di ceramica a vernice nera as-sai poco diffusa, anche delle anfore bollate da L. Valerios, che raggiungono la Sicilia ela Spagna) potrebbero essersi perciò affiancate a quelle di Ischia e Neapolis nella di-stribuzione mediterranea del vino.
Un’altra regione che potrebbe rientrare tra le zone produttive e commerciali delversante tirrenico è l’Etruria costiera, dove le anfore etrusche Py 4A sono ancoraesportate nel iv secolo nell’Europa interna e in Grecia e sono ancora prevalenti allafine del iv/primi decenni del iii secolo nei circuiti dell’Etruria settentrionale, me-diante rotte “che sembrano far ancora capo all’area cerite e a quella tarquiniese”.2Schiacciate da Ovest dalle anfore massaliote e da Sud dalle grecoitaliche i contenitorietruschi si ripiegano sul distretto minerario ancora vitale (Populonia/Elba) e sem-brano cedere il posto in questa prima metà del iii secolo alle produzioni meridionali.Ciò che accredita l’ipotesi di una produzione di grecoitaliche in questa regione già negli anni precedenti e contemporanei alla i Punica è la documentazione relativa adanfore del tipo Van der Mersch v di Volterra, Castiglioncello, Populonia, Orvieto, So-vana, Chiusi, Vulci, Orbetello, Viterbo, Norchia,3 associate esclusivamente a cerami-ca etrusco-laziale. Si può presumere che in parte esse conseguano da rilasci lungo lecoste di produzioni provenienti dal Sud (campano-laziali), come può essere il caso del-le grecoitaliche simili a quelle del relitto della Meloria A (v. oltre) rinvenute a San Ros-sore, nel porto di Pisa,4 o per i ritrovamenti nelle acque dell’arcipelago Toscano (Mon-tecristo, Elba, Giglio) che fanno da ponte verso la Corsica e verso il Golfo del Leone.Il dossier si arricchisce con una grecoitalica del tipo Van der Mersch v di Populoniabollata sull’ansa ºI§ = º›ÏˆÓ (nome assai diffuso o altro antroponimo che inizi conqueste lettere),5 con due anfore di forma Van der Mersh iv, magnogreche/siciliane o
1 Dai pressi della c.d. nave “punica” di Marsala (Fig. 2.4), letto erroneamente da Culican - Curtis 1976,p. 144, fig. 80a, C.VF; per la prima lettera, che Van der Mersch 2001, p. 197 interpreta come M, pensereiad una L ad uncino, capovolta e retrograda, come accade ad esempio al bollo PAP (Culican - Curtis 1976,pp. 157, 168, fig. 92a) dalla stessa Lilibeo, impresso su un’anfora di identificazione incerta tra Dressel 1A ogrecoitalica già sulla via delle Dressel 1, che presenta le due P capovolte (Manacorda 1986, p. 582, nota 5).
2 Cibecchini 2006, pp. 545-546; Ciampoltrini 1995, p. 296, con bibliografia.3 Bibliografia in Manacorda 1981, p. 24, nota 96; Van der Mersch 2001, p. 176; Tchernia 1986, p. 48;
altri esemplari compaiono a Pisa, a Fiesole, Artimino, transitati probabilmente per il porto di Pisa (biblio-grafia in Rossi 2003, p. 160) e distribuite attraverso l’Arno. A Bora dei Frati (insediamento versiliese di etàellenistica) le analisi mineralogiche tendono a dimostrare la presenza di grecoitaliche importate, ma anche(almeno in un caso) riferibili all’Etruria settentrionale (Menchelli et alii 2007, pp. 142-143).
4 Tre esemplari del tipo Van der Mersch v, attribuiti ad area campana in base ad analisi minero-petro-grafica, rinvenuti nel crollo della banchina del porto (Rossi 2000, p. 128, fig. 1 e Rossi 2003, pp. 161-163, nn.1-3; figg. 1 e 5), di cui una (ivi, p. 163, n. 2, inv. 143 e p. 165, fig. 5) con graffito dopo la cottura sulla spalla di M.Veio(s) (v. pp. 23-24, nota 7 e p. 36, nota 3).
5 J. Shepherd, in Romualdi 1992, pp. 167-168, n. 5, fig. 50. Populonia è tra i siti nell’Etruria costiera ovemaggiore è la presenza di grecoitaliche, anche bollate (per M.BAIBI, v. oltre, p. 86, nota 4). La città era neipressi di uno dei distretti minerari più importanti del mondo antico (ferro dall’Elba e metalli dall’entroter-ra campigliese), ospitandone le lavorazioni, e disponeva di un porto ben protetto nel golfo di Baratti, col-locato sulle vie di transito Sud-Nord verso la Gallia e Est-Ovest verso la Corsica/Sardegna. Dall’esame ma-croscopico delle paste delle grecoitalche che rappresentano l’80% delle anfore rinvenute negli scavi di questiultimi anni, iscrivibili in un orizzonte cronologico che comprende sia il iii che il ii secolo, gli editori desu-
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 25
neapoltane/ischitane, della necropoli di Aléria, con graffiti in etrusco riferibili forseal transito sulle coste di questa regione.1 In parte esse potrebbero essere invece l’esi-to di produzioni locali2 con circuiti locali o regionali, così come di carattere territo-riale e microregionale è la ceramica fine che a questi contenitori si associa (ad ecce-zione del gruppo des petites estampilles), uscita da una miriade di fabbriche anche dibuon livello. D’altro canto si ritiene poco probabile che tutti i vigneti, che avevano alimentato dall’età arcaica un commercio non irrilevante di vini trasportati in anfore(tipi Py 3A e Py 4A),3 siano scomparsi con la conquista romana per ricomparire solonel iii/ii secolo,4 benché sia credibile che l’impatto della conquista e l’espropriazionedel litorale da parte di Roma che vi istallerà le proprie colonie (le prime campagnenell’Etruria centrale tirrenica, contro Roselle, si datano intorno al 300; nel 280 la regione di Vulci e la valle dell’Albegna sono già “romane”; del 273 è la guerra roma-no-cerite con successiva fondazione della colonia marittima di Pyrgi), possa aver determinato una battuta di arresto negli insediamenti e nello sfruttamento agricolo,seguita tuttavia nel corso del secolo da una ripresa produttiva di cui è possibile indi-viduare qualche traccia già nella seconda metà (grecoitaliche etrusche al Pech Maho,anfora di Ses(tius) di Skerki Bank, probabile primo impianto delle officine dell’ager Co-sanus e nella zona di Pisae/Volaterrae). Necessitano di approfondimento i dati raccol-
mono una prevalenza delle importazioni da area campana (50%) sulle produzioni definite “tosco-laziali”(30%) e siciliane (15%): Gualandi - Rizzitelli 2005, pp. 146-147 e 151, con bibliografia; v. anche Costanti-ni - Ghizzani Marcìa 2004. Per le importazioni riferite ad ambito campano-laziale nella prima metà del iiisecolo nell’Etruria settentrionale (anche interna: Garfagnana, Lunigiana) sulla base di analisi mineralogi-che, si rimanda a Menchelli et alii 2007, p. 142 (con bibliografia).
1 Jehasse 1973, p. 554, n. 25 (1261); p. 565, n. 63 (1215). Un altro graffito in etrusco, forse prima della cot-tura, è presente su una Van der Mersch v di piccolo modulo, di ignota provenienza nel Museo di Firenze,AßIE = Avie (retro., con digamma a forma di parentesi quadra): Bertone 1991, p. 135, cat. n. 3.
2 Si veda la documentazione di Menchelli et alii 2007, pp. 142-143 (con bibliografia) relativa ad analisiminero-petrografiche condotte su campioni di grecoitaliche rinvenute nell’Etruria settentrionale, che pro-verebbero l’origine dall’Etruria meridionale e settentrionale di esemplari (in due casi, quelli indiziati di ori-gine nord-etrusca, attribuibili con buona probabilità al tipo Van der Mersch v: ivi, tav. 1, nn. 5-6) trovati aBora dei Frati. Attribuiti a produzione nord-etrusca (pisano/volterrana) sono anche alcuni esemplari di gre-coitaliche da Luni nel ii secolo (ivi, p. 143).
3 Officine di anfore vinarie etrusche sono state individuate nella fascia costiera settentrionale, datate dalvii al iii secolo (Menchelli 1990-1991, nota 50, con bibliografia), nel centro di Pisa (Menchelli 1994, p.208) e nella stessa bassa valle dell’Albegna nel territorio vulcente (fornaci della Doganella: Attolini - Cam-bi - Castagna 1991, pp. 142-144; Zifferero et alii 2009 = prima metà del vi secolo; in questo caso con unasostanziale convergenza topografica con il più recente sistema di fornaci tardo-repubblicane e primo-im-periali di Albinia, essendo l’Albegna il tramite dello smistamento). Per le possibili aree di produzione nel-l’Etruria meridionale della forma Py 4A (Pyrgi, Caere, Veio), v. Cibecchini 2006, p. 545 (con bibliografia) e icontributi di G. Marchand, F. Hérubel e E. Gailledrat, X. Aquilué, in Gli Etruschi da Genova ad Ampurias, At-ti del xxiv Congresso di Studi Etruschi ed Italici (Marseille–Lattes 2002), Pisa-Roma, 2006. Sui relitti v. Cibecchini2006; sulla circolazione mediterranea una sintesi è in Bats 2007. È interessante notare che gli impasti attri-buiti ad area ceretana o tarquiniese (Graviscae) sono simili a quelli dei bacini a “impasto chiaro sabbioso”ampiamente diffusi nel iv e alla metà del iii secolo insieme ad altri prodotti laziali, quali i piattelli di Genu-cilia e, con un leggero scarto cronologico, ai vasi dell’atelier des petites estampilles. Mi è capitato di vedereframmenti di grecoitalica con questo tipo di pasta, che è comune nei manufatti dei contesti di Roma dal-l’età arcaica fino all’età medio/tardo-repubblicana (bacini, mortai, ciotole, olle e brocche, ma anche bru-ciaprofumi, tegole, coppi, decorazione architettonica fittile) e che è di produzione locale (una probabile for-nace presso la villa dell’Auditorium, periodo 3, villa 2, detta dell’Acheloo del 300-225: H. Di Giuseppe, inAuditorium 2006, pp. 204, 393). 4 Tchernia 1986, p. 57.
26 clementina panella
ti intorno alla produzione già menzionata di grecoitaliche nell’Etruria meridionale(oggi Lazio settentrionale), a Pyrgi, uno dei porti di Caere, colonia marittima del 264e a Graviscae, porto di Tarquinia, colonia del 181, ma di essa non si conosce né la cro-nologia, né l’eventuale diffusione.
Per quanto riguarda il gruppo dell’atelier des petites estampilles, le cui officine, comesi è detto, sono attribuite a Roma e a molti altri centri di area laziale ed etrusca, è bennota la sua circolazione marittima di ampio raggio, soprattutto tra Languedoc e Ca-talogna, nel Nord-Africa punico e nella Gallia meridionale (Lattes, Olbia di Proven-za).1 “Romana” è ritenuta l’attività commerciale riflessa dalla diffusione di questa ce-ramica,2 che escludendo la Campania, l’Italia meridionale e la Sicilia greca per laconcorrenza delle fabbriche locali, sembra riproporre rotte etrusche, soprattuttoquelle che facevano capo a Caere.3 L’esportazione, superiore a quella di qualsiasi altraproduzione fine coeva della Campania o della Magna Grecia in generale, coincide sulpiano cronologico (prima metà del iii secolo) con lo smercio delle anfore del tipo Vander Mersch v, ma i dati disponibili non consentono di riproporre quel “binomio” travino e ceramica fine che si affermerà nella seconda metà di questo stesso secolo. Lepresenze dei vasi “con piccoli stampigli” non solo interessano siti diversi da quellicoinvolti dal commercio affidato alle anfore (è quel che accade in Gallia, ove le gre-coitaliche di questo periodo sono assai poche), ma, qualora vasellame dell’atelier e an-fore si ritrovino nelle stesse località, il primo ha valori molto più alti delle seconde (èquel che accade a Cartagine). Le differenti attestazioni “a terra” sembrano dipenderedalle richieste del mercato: l’autosufficienza delle produzioni di ceramica a vernicenera in Etruria settentrionale (per esempio quella volterrana)4 e meridionale spinge-rà verso il Nord la ceramica di Neapolis, mentre il vino massaliota sembra arginare, al-meno fino ad un certo momento (l’ultimo relitto noto con anfore del tipo Bertucchi5 è quello di Tour Fondue presso Giens della metà del iii secolo)5 l’arrivo di vini dal-l’Italia nei territori tradizionalmente sotto il controllo di Marsiglia. Inoltre nessunodei tre o quattro relitti di quest’età ha restituito insieme alle anfore grecoitaliche uncarico complementare con questo tipo di ceramica.6 Non vi è dubbio che la circola-zione di questi vasi consegua dal commercio marittimo, così come sono chiare le direttrici (verso Marsiglia/Ampurias a Nord e verso Cartagine e l’Africa a Sud), men-tre è poco probabile che essi abbiano viaggiato come carico autonomo, com’era accaduto alla ceramica attica, o come forse sarebbe accaduto, in seguito e in alcuni ca-
1 Cibecchini - Principal 2002.2 Morel 1990b, pp. 152-155: “ovunque fosse localizzata l’officina, i vasi … devono essere considerati una
creazione romana e la loro esportazione un commercio di Roma” (ivi, p. 154).3 Zevi 2002, p. 32. Già dal iv secolo civitas sine suffragio. Almeno nel iv secolo si presume il coinvolgi-
mento di Caere e dei suoi porti (Alsium, Pyrgi, Punicum) nella politica transmarina di Roma. Dopo la guerradel 273, la città che aveva avuto un’importante produttività ceramica figurata (piattelli di Genucilia), ma an-che stampigliata, sembra importare vasi dell’atelier romano des petites estampilles (Stanco 2009, p. 161). Conl’annessione a Roma della costa, Pyrgi è colonia marittima.
4 Di Giuseppe 2005b, in part. pp. 36-42. 5 Long 2004, pp. 145-146, con bibliografia.6 La ceramica a vernice nera dei relitti di Capistello degli inizi del iii secolo (Morel 2004, pp. 83-87: 300
vasi) e di Cala del Diavolo/Montecristo della metà circa del iii secolo si riferisce a produzioni peculiari, nonriconducibili ad un’origine precisa, scarsamente attestate nei siti terrestri (Cibecchini 2004, pp. 59-60). Perquest’ultimo giacimento una provenienza campano/laziale non è stata esclusa (Cibecchini 2002, p. 214,nota 21; Cibecchini 2004, p. 62; Maggiani 1982 suggeriva Minturno).
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 27
si, alla Campana A.1 Piuttosto che ritenere che i piatti e le coppe dell’atelier accom-pagnassero altre categorie di oggetti più o meno di pregio a noi ignoti, sembra più ve-rosimile l’ipotesi che siano esistiti flussi secondari distinti tra commercio ceramico ecommercio vinario. Nella diffusione così difforme da quella delle anfore grecoitalichepotrebbero ad esempio aver giocato un ruolo importante i grandi porti/empori, pres-so i quali tutto arrivava e presso i quali poteva avvenire un frazionamento dei carichia seconda della domanda e/o una riaggregazione delle merci nei viaggi transmarini.Si pensa in particolare a Cartagine, la città maggiormente in grado di irraggiare lon-tano intorno al 300 la sua influenza e il suo commercio (v. i tre trattati romano-carta-ginesi ricordati da Polibio, che si susseguirono, prima dell’esplosione della guerra, ne-gli anni compresi tra 348 e il 279, e che non riguardavano solo circostanze di eventualeconflittualità, ma anche forme di contatto quali il commercio e la sosta per i riforni-menti). Se nel trattato nel 279 era tolto a Roma lo ius commerci nella Sardegna, nellaCorsica punica, in tutta l’Africa eccetto Cartagine, ed era conservato solo nell’epar-chia della Sicilia, tenendo conto che la diffusione di questo vasellame interessa la zo-na d’influenza cartaginese (oltre Cartagine, Utica, Kerkouane, Mozia, la Sardegna, laCorsica), non è difficile pensare che è nella Sicilia punica (ove questo vasellame è inqualche misura attestato) che si operava la ridistribuzione in Nord-Africa e in Corsi-ca ad opera degli stessi Cartaginesi. A Cartagine farebbe capo anche lo smercio a Car-thago Nova e al litorale del levante e del sud-est della Spagna, forse (anche) attraversoIbiza, e quindi un arrivo di questi manufatti da un rotta meridionale. Resta invece dacapire la gestione dei rapporti con il settore settentrionale del Mediterraneo centro-occidentale (Aléria, Genova, Marsiglia con la sua zona di influenza – Olbia di Pro-venza, Lattara/Lattes –, Ampurias con la sua zona di influenza, il litorale catalano me-ridionale) che sembra seguire invece una direttrice che riflette la tradizionale rete ditraffici del mondo etrusco, ma in cui si inserisce ora direttamente Roma.2
Lo studio di Cibecchini-Principal 2002 fornisce gli elementi per individuare ledirezioni dell’esportazione del vasellame dell’atelier nella pensola iberica (dalla Lan-guedoc occidentale all’Ebro e soprattutto nell’area di Emporiae/Rhode in Catalogna),che, insieme a Cartagine, è certamente la zona più ricettiva di questa classe di mate-riali, funzionando sia come punto di contatto diretto con l’Italia centrale tirrenica, siacome zona di distribuzione verso il Nord (Languedoc) e verso il Sud (litorale catala-no meridionale, Sagunto e forse Baleari).3 Dipenderebbero invece da Cartagine le im-portazioni nell’altra fascia del territorio spagnolo, quella di Carthago Nova, che pre-senta una facies ceramica parallela a quella della città punica. Questo articolo dà ancheconto degli arrivi in Spagna della Campana A arcaica e di altre produzioni italiche avernice nera più sporadicamente attesate (ad esempio la ceramica di Cales), ma si trat-ta di vasellame fine che dovrebbe raggiungere questo medesimo ambito territoriale
1 Morel 1998b, pp. 504-508; Morel 2005, pp. 103-104.2 Sulla rete di “ports of trade” stabilita da Roma anteriormente alla I Punica attraverso conquiste (An-
zio nel 338), deduzione di colonie (Terracina nel 329, Ponza nel 313), alleanze (Cuma nel 338, Neapolis nel 326),trattati (Cartagine, Rodi, Taranto, Siracusa, Egitto tolemaico), si rimanda a Domínguez Pérez 2006.
3 Nel lavoro di Principal 1998, pp. 43-48, passim, il lettore troverà tutta la bibliografia di riferimento fi-no all’anno dell’edizione, con osservazioni sui circuiti mediterranei del vasellame fine nel iii secolo (per ilruolo giocato all’interno di questi traffici da Marsiglia, fedele alleata di Roma dal iv secolo al 46, da Ampu-rias-Rhode e da Ebusus/Ibiza, ivi, p. 211 sgg.; 176-181 e passim).
28 clementina panella
più tardi rispetto a quello etrusco-laziale,1 associandosi in maniera più congrua alleanfore del tipo Van der Mersch v e soprattutto v/vi a cui rimandano i relitti datati daF. Cibecchini tra il 240 e il 220, quando cioè l’esportazione della ceramica stampiglia-ta si era già conclusa ed emergeva, come dimostra il relitto della Meloria A, il bino-mio grecoitaliche/Campana A arcaica, a cui accenneremo in seguito.
Se per quest’ultima fase una partenza dal porto di Napoli della ceramica a vernicenera è scontata, resta invece irrisolto per la prima metà del iii secolo il nodo del por-to/dei porti di partenza dei vasi dell’atelier des petites estampilles. Lo stesso nodo ri-guarderebbe anche l’esportazione delle grecoitaliche prodotte in ambito etrusco-la-ziale, ammesso, come sembra, che una produzione di anfore in quest’area esista nellaprima metà del iii secolo, o meglio che esista una loro circolazione che superi l’am-bito regionale. Indiziata è Ostia, che potrebbe aver svolto il compito di appoggio lo-gistico, ma delle fasi iniziali della sua storia poco si conosce. La fondazione come ca-strum intorno alla fine del iv secolo2 (coincidente con l’istituzione dei duumviri navalesnel 311, a sua volta da collegare all’allestimento della prima marina da guerra di Ro-ma)3 o poco prima, rende evidente la vocazione militare e difensiva del sito all’inter-no di uno scacchiere assai turbolento, ma la vocazione marittima, in quanto scalo diRoma ed anello della catena di approdi lungo la costa tirrenica utilizzati nella naviga-zione di lungo raggio e di cabotaggio, è dimostrata, anche nei decenni precedenti lafondazione della cittadella, dalla presenza di ceramiche di importazione attiche, fali-sche, etrusche, magnogreche.4 La funzione di servizio di Roma costituirà in seguitouna costante della storia della città, essendo le sue attrezzature portuali inadatte, finoalla realizzazione del porto di Claudio, ad accogliere le navi d’alto mare, a cui si an-davano aprendo gli orizzonti marittimi di Roma. Di fronte alle esigenze di un impe-ro d’oltremare, la classe dirigente romana scelse già alla fine del iii secolo l’antica co-lonia di Cuma (Dicearchia) ribattezzandola Puteoli, come porta del Mediterraneoaperta ai traffici con l’Egitto e l’Oriente, e non Ostia, che rimase esclusa dal generaleriassetto dei collegamenti mediterranei di età tardo-repubblicana.5
ii Periodo (265/250-220/200). Un secondo significativo cambiamento si verifiche-rebbe negli anni della prima guerra punica (265-241). Quest’ultima segnerebbe per J.-P.
1 Per la diffusione della ceramica a vernice nera nella Gallia meridionale, così difforme da quella dellegrecoitaliche, v. Cibecchini 2002, p. 221, nota 41 e p. 218, note 28-31.
2 Sulla storia di questa città nelle sue fasi più antiche si rimanda a Zevi 1996 e 2002.3 Accetta provvisoriamente questa cronologia, ottenuta dai reperti ceramici rinvenuti nelle stratigrafie
relative alla fondazione del castrum, Zevi 2002, pp. 14-15, che fa tuttavia notare che, se tale datazione si ri-velasse giusta, il castrum potrebbe costituire solo un episodio, per quanto importante, di un processo inse-diativo iniziato in età arcaica (terrecotte architettoniche di questa età da riconnettere alla fondazione colo-niaria assegnata dalle fonti ad Anco Marcio presso le foci del Tevere) e proseguito per tutto il iv secolo, comeattesta la ceramica figurata rinvenuta sporadicamente nel sito. Sull’argomento tornano Tchernia - Viviers2000, pp. 768-771 (fonti e bibliografia). 4 Adembri 1996.
5 Ragioni geografiche ed economiche (necessità di disporre di porti idonei ad accogliere le grandi navimercantili, di cui si erano dotate le marinerie dei centri più attivi del Mediteraneo, Alessandria per prima,e di ridistribuire le risorse granarie collegate a trasporti d’alto mare), ma anche scelte ideologiche e politi-che (pilotate dagli Scipioni) furono alla base della creazione di un complesso portuale così lontano dalla ca-pitale: Zevi 2002, pp. 48-50; Tchernia - Viviers 2000, pp. 783-789; Zevi 2004 con bibliografia sulla città, sulsistema portuale Roma/Ostia/Pozzuoli fino alla costruzione del porto di Traiano, sugli scali fluviali roma-ni, sull’approviggionamento granario dell’Urbe (ivi, pp. 218-219).
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 29
Morel un ripiegamento delle zone produttive di ceramica a vernice nera su loro stes-se,1 con una proliferazione delle officine (anche di qualità) dai circuiti commerciali ab-bastanza ristretti, con due eccezioni,2 la prima Campana A esportata (ceramica “elle-nizzante” per questo studioso), ben attestata nella Gallia meridionale e in Catalogna,3e la ceramica a rilievo e liscia di Cales (ceramica “estruschizzante”, anche in base allasua circolazione).4 Sul piano delle anfore, tutte le aree produttive fin qui menzionate(accertate o supposte)5 dovrebbero essere attive, mentre la forma delle grecoitaliche,che risulta in rapida evoluzione, potrebbe fornire la prova di una moltiplicazione del-le officine: compaiono anfore di transizione dal tipo Van der Mersch v al tipo Van derMersch vi (v. Fig. 2.3-4)6 con attardamenti del tipo v fino alla metà del iii secolo (re-litti di Cala del Diavolo/Montecristo,7 Meloria A all’Elba (relitto detto della Torre),8Tour Fondue a Giens,9 Bon Capó/L’Ametlla de Mar presso Tarragona,10 che tende-rei a datare proprio intorno agli anni centrali del secolo e ad attribuire alla fase piùevoluta del tipo Van der Mersch v).11 Per quanto riguarda la provenienza dei carichi,le grecoitaliche sono tipologicamente molto simili, tanto da far supporre una produ-zione in serie, un’organizzazione più strutturata rispetto ai decenni precedenti e invia di ipotesi una medesima origine. L’associazione alla Meloria delle anfore con laCampana A arcaica assicura a questo giacimento una provenienza da Ischia/Neapolis,che sembra confermata per i contenitori da trasporto dal ritrovamento tra i materia-li delle fornaci di Neapolis di un punzone ™IMIA = ™›ÌÈ·(˜)12 che potrebbe essere ri-ferito ai marchi ™IM, ™IMI e ™IMIA (retro.) documentati sulle anfore del relitto (al-
1 Benché vi siano dati che indicano una continuità produttiva dell’attività dell’atelier des petites estampil-les (v. i pocola deorum, i piatti da pesce Morel 1120, ecc.), che raggiungerebbe la fine del iii secolo, ciò che rap-presenta il discrimine tra la prima metà e la seconda metà di questo secolo, è la fine dell’esportazione di lun-go raggio dei vasi di queste officine; certa è inoltre la fine delle produzioni figurate dei principali centriartigianali dell’Etruria. Cause e problemi sono discussi in Ferrandes 2006, pp. 165-167, passim.
2 Su tutte le classi di vasellame a vernice nera il riferimento è e resta Morel 1981.3 Cibecchini 2004, p. 59, con bibliografia. In Catalogna già nel terzo quarto del iii secolo è presente la
Campana A accanto alla ceramica di Rosas, che verrà superata dal vasellame di Neapolis nel quarto di seco-lo successivo: Principal 1998, pp. 18-19.
4 Morel 1988a. Nei diversi comportamento rispetto ai mercati J.-P. Morel individua due modelli: quel-lo greco (Atene, Neapolis), che si affida all’esportazione per via di mare, e quello etrusco (Volterra, Arezzo,Cales) che sa diffondere per via di terra, senza passaggi marittimi (Morel 2008, pp. 178-179).
5 Per i centri di produzione più o meno sicuri in Magna Grecia (Nocera Terinese/Temesa: Valenza 1991;Velia: v. sopra, p. 13, nota 1) e in Sicilia (travolta quest’ultima dalla prima guerra punica), v. Van der Mersch1994, pp. 85-86, con bibliografia. La produzione adriatica (Adria?, Cattolica) sembra avere (o continuare adavere) una circolazione a scala regionale.
6 Indicate nelle pubblicazioni generalmente come MGS o MGS/RMR v/vi. Si tenga conto che qualorasi disponga solo di frammenti di orlo l’attribuzione all’uno o all’altro tipo è abbastanza arbitraria, soprat-tutto in questi decenni. Si capisce perciò l’importanza, ai fini della tipologia, del materiale dei relitti e dellenecropoli. 7 Maggiani 1982.
8 Cibecchini 2002. 9 Long 2004, pp. 145-146.10 Asensio-Martín 1998. La datazione di Cibecchini 2004, p. 63 per tutti e quattro questi relitti è il 250-
225. Le anfore sono classificate come Van der Mersch v/vi.11 Alla fase finale di questo tipo assegnerei le anfore del deposito di Camarina già menzionato (v. sopra,
pp. 23-24, nota 7), che ha restituito un numero notevole di esemplari (almeno trecento) apparentemente maiutilizzati (Pelagatti 1984-1985, pp. 687-692). Il loro impasto sembra rimandare alla produzione diGela/Agrigento. Almeno tre sono tuttavia i tipi di argilla riscontrati da Olcese 2004, p. 182. La distruzionedella città nel 258 può costituire un sostegno alla ricostruzione dell’evoluzione crono-tipologica delle gre-coitaliche (v. Appendice i). 12 Olcese 2005-2006, p. 70.
30 clementina panella
la base e sul gomito dell’ansa).1 La ceramica a vernice nera del relitto di Montecristoappartiene a produzioni peculiari, ma trova anch’essa confronti con i materiali dellaMeloria,2 con conseguente inclusione anche di questo carico tra quelli spettanti adarea campana/neapolitana.3 Per i materiali della nave della Tour Fondue, che tra-sportava anche anfore massaliote del tipo Bertucchi 5, ma che non aveva, come acca-de nella nave di Bon Capó, ceramica di accompagno, l’unico indizio è fornito dallapresenza sulle grecoitaliche di bolli in greco, mal conservati, di cui almeno due, TPE,XAPME, ricorrono ad Ischia;4 all’isola o alla baia di Napoli rimanda l’analisi minera-logica di un’anfora del carico.5
La diffusione, così com’è documentata dai ritrovamenti sottomarini, interessa, ilMediterraneo nord-occidentale seguendo la rotta che dalle coste dell’Etruria e dal-l’Arcipelago toscano (Elba) andava verso la Corsica (la presa di Aléria in Corsica è del259) in direzione delle Baleari,6 oppure la rotta settentrionale diretta in Gallia, a Mar-siglia o ad Ampurias e alle rispettive zone di influenza. L’assenza di relitti sulla rottameridionale alla metà del iii secolo potrebbe essere smentita da future scoperte, masulla base di ciò che oggi si conosce, il dato potrebbe riflettere lo stato di guerra in at-to. Va detto, con la prudenza richiesta dalla carenza e dalle lacune dell’edito, che sui si-ti di terra, dove si può presumere che le grecoitaliche e la ceramica a vernice nera fos-sero dirette (Gallia meridionale, Spagna), alla presenza di quest’ultima (soprattutto inGallia meridionale) si contrappongono, come nei decenni precedenti, scarse attesta-zioni di anfore, le quali invece continuano ad essere ben documentate in quei centridel medio e alto Tirreno che hanno restituito stratigrafie del iii secolo (v. sopra), a lo-ro volta scarsamente o affatto coinvolti dalle importazioni di vasellame fine campano.7
In sostanza i due decenni centrali del iii secolo rappresentano, sul piano tipologi-co delle anfore, un’età “cuscinetto”, come dimostrano le incertezze di attribuzioni aitipi Van der Mersch v e vi degli esemplari interi disponibili e il ricorso in tante pub-blicazioni alla denominazione Van der Mersch v/vi. D’altro canto Van der Mersch1994 fissava al 260 la nascita del suo tipo MGS vi sulla base della cronologia assegnataal deposito di Camarina, ove le poche anfore documentate, se mostrano differenze
1 Cibecchini 2002, pp. 212-213, tavv. i e ii, B.2 Cibecchini 2002, p. 214; Cibecchini 2004, pp. 59, 62.3 Maggiani 1982 ha ipotizzato un’origine delle grecoitaliche da Minturno.4 L’officina che usa ad Ischia il marchio TRE = TÚ¤(‚ÈÔ˜?) è sicuramente locale (gruppo chimico 1 di Ol-
cese 2004, pp. 177-178); i bolli XAPME e XAPMEø + anforina di Ischia (in entrambi i casi XAP in mono-gramma; ME in nesso) appartengono al gruppo chimico 2, assegnato in via di ipotesi al Golfo di Napoli(Olcese 2004, p. 178) e compaiono su anfore attribuite al tipo Van der Mersch v. La desinenza ionica del genitivo -ˆ, presente anche in un altro bollo su grecoitalica da Ischia, KAPI§Eø, rafforza l’ipotesi di unaprovenienza pithecusana di queste due serie, dal momento che la forma dialettale ionica si conserva nel-l’isola in età ellenistica, al contrario di quanto avviene in Sicilia, ove la dorizzazione della lingua è comple-ta già nel v secolo. XAPMEø compare da identica matrice su un’ansa di Cartagine (Wolff 1986, p. 148, fig.9), mentre l’assenza di disegni o foto impedisce di assegnare ad un unico personaggio le anfore timbrateXAPME rinvenute in Sicilia (Selinunte, Gela, forse Heraclea Minoa: Van der Mersch 1994, p. 178, s.v.), ben-ché il nome X¿ÚÌ˘ sia piuttosto raro.
5 Olcese 2005-2006, p. 70. 6 Long 2004, p. 145 sgg.7 Attestazioni nell’alto Tirreno citate per confronto alle anfore del relitto della Meloria A, in Cibecchi-
ni 2002, pp. 213-214, note 12-21; pp. 221-222, nota 42 e relativa bibliografia: a Pietra Pertusa in Valdinievole,nell’isola di Migliarino presso Pisa, nell’isola del Giglio in località Saraceno, nello scavo della villa tardo-re-pubblicana e presso il Castellare del Campese, nel porto delle Murelle a Marina di Montalto.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 31
con le grecoitaliche del relitto di Capistello, non hanno ancora quelle caratteristicheche riconosciamo alla Van der Mersch vi (anse e collo più lunghi, anse più lunghe etalvolta flesse, pance più affusolate). Gli altri documenti relativi a tale tipo raccolti daquesto autore nell’Italia del Sud sono genericamente datati ai decenni immediata-mente precedenti alle operazioni militari della seconda guerra punica, che imperver-sò su questi territori, fornendo dei preziosi termini ante, ma non consentendo di giun-gere a cronologie molto precise. La data del 260 è proposta anche per l’inizio dellaproduzione del tipo RMR vi (Van der Mersh 2001, pp. 172-173), ma in realtà nella ta-bella ove sono recensiti i relitti attribuiti ad ambito “romano” (ivi, pp. 176-177, tab. ii)le prime RMR vi sono quelle del relitto di Terrasini, assegnate alla metà del iii seco-lo, laddove i carichi di Cala del Diavolo della Meloria vengono classificati rispettiva-mente come RMR v e MGS v con datazione (certamente troppo alta) alla prima me-tà del iii secolo.
Tenendo presente che ciascuna area produttiva può aver recepito o adottato il mo-dello in tempi differenti, mi sembra che molti dei dati archeologici disponibili mo-strino che tra il 240 e il 220 la forma delle grecoitaliche si stabilizzi sul modello del ti-po Van der Mersch vi = Will 1d (v. Fig. 2.5) (“grecoitaliche antiche” per lo studiosobelga).1 Le rotte appaiono consolidate in Occidente; la documentazione dei relitti fi-no alla fine del iii secolo2 si riferirebbe unicamente ad esportazioni centro-tirreniche3(secondo F. Cibecchini campano-laziali).4 Molto più articolata è la circolazione rico-struibile attraverso i bolli delle anfore, ben documentati anche in Sicilia. Alcune pro-duzioni (v. quelle ad esempio di Tr. Loisios, C. Aristo/°¿ÈÔ˜ \AÚ›ÛÙˆÓ, M. Antestios, M.Lurius) raggiungono anche l’Oriente (Atene, Elis in Elide, Hermion in Argolide, Pan-ticapeo sul Mar Nero, Rodi, Alessandria).5 Un quadro della diffusione nei siti terrestribasata solo sul materiale bollato costituisce per altro solo un indizio (la punta di uniceberg) del fatto che ovunque potevano arrivare anche anfore anepigrafi (per una di-
1 Al tipo Van der Mersch vi può essere avvicinato qualche esemplare delle necropoli di Adria attribuitoai tipi 4 e 5 individuati dalla Toniolo, ma a partire dal tipo 3 le grecoitaliche rinvenute in questo centro sem-brano seguire un sviluppo morfologico autonomo, che trova assai poche corrispondenza con le coeve an-fore del versante tirrenico.
2 Quattro relitti assegnati a questo periodo sono nelle acque della Corsica: Cala Rossa, Tour d’Agnello,Îlots Bruzzi, Sanguinaire A (Long 2004, pp. 154-156, con bibliografia), uno in Sicilia: Terrasini B presso Pa-lermo (Giustolisi 1975 e Bivona 1975), uno a Mallorca: Cabrera 2 (Ramon Torres 1995, p. 62, con biblio-grafia) e due in Francia: Saint Hospice tra Monaco e Nizza (Pomey et alii 1992, p. 53) e Pointe Lequin 2 a Por-querolles (Pomey et alii 1992, p. 36). Al 240+/–20 Van der Mersch 2001 data quelli di Cala Rossa (v. Fig.3.6), Tour d’Agnello, Pointe Lequin 2. F. Cibecchini colloca i primi due nell’ultimo quarto del iii secolo in-sieme ai relitti di Cabrera B e Terrasini B (troppo alta la data assegnata a questo relitto – metà del iii seco-lo – dagli editori), mentre quello di Pointe Lequin 2 sarebbe del primo quarto del ii secolo (v. Appendice i).
3 Van der Mersch 2001, pp. 177-178, tab. ii.4 Cibecchini 2004, p. 62: le grecoitaliche sono associate alla Campana A nei relitti Lequin 2 e Sangui-
naire A; non si esclude una consistente presenza di tale ceramica anche nei carichi di Cala Rossa e Tourd’Agnello.
5 Per l’Oriente, una sintesi con bibliografia è in Lund 2000, che distingue le anfore del tipo Van derMersch v =Will 1a da quelle del tipo Van der Mersch vi assimilate ai tipi Will 1d e 1c, fornendo per ciascu-na di esse una carta di distribuzione (p. 79, fig. 3 e p. 81, fig. 5) e segnalando tra l’altro (p. 80) che tra le 170anfore intere di Delo solo due appartengono a grecoitaliche (dall’isola anche i bolli C.ARISTO e °AIOC/APICTøN, con sigma lunato), mentre tra le 34 anfore ellenistiche occidentali complete del Museo greco-romano di Alessandria esse sarebbero al massimo tre (Empereur 1998, p. 394; le anse timbrate da questa città sono, tuttavia, almeno quattro: tre bolli M.LVR e un bollo di Tr. Loisios).
32 clementina panella
scussione della rappresentatività dei bolli sull’insieme delle anfore, resta fondamen-tale il contributo di Empereur 1982).
Se i ritrovamenti sottomarini1 e terrestri2 forniscono indicazioni sui luoghi dellosmercio, qualche dato sui centri di origine delle grecoitaliche in circolazione in que-sta seconda metà del iii secolo può essere ricavata dalle analisi mineralogiche con-dotte sulle anfore della fase finale di occupazione del Pech Maho, fissata tra il 250 e210/200, quando l’oppidum iberico viene abbandonato o per il passaggio di Anniba-le nel corso della seconda Punica3 o in seguito alle incursioni dei Volcae Tectosages.4Dei sessantasei campioni esaminati (si tratta di grecoitaliche dei tipi Van der Merschv e vi), il 97% proverrebbe dall’Italia centrale tirrenica (Campania/Lazio meridio-nale).5 Trentasette di questi campioni erano stati già analizzati chimicamente da M.Picon e M. Ricq, i quali avevano indicato con molta prudenza per la maggior partedi essi un’origine siciliana.6 G. Thierrin Michael attribuisce invece la categoria pe-trografica 3, che raggruppa i bolli greci, e la categoria petrografica 2 (bollo M.LVRI)7
1 Accanto ai relitti vanno ricordati i ritrovamenti subacquei isolati, che risalgono a naufragi non più iden-tificabili o a scarichi portuali, come sono quelli di Pisa/San Rossore presso la linea di riva di età ellenistica,da cui provengono, oltre alle tre grecoitaliche di tipo Van der Mersch v già menzionate (v. sopra, p. 25, nota4), sei esemplari del tipo Van der Mersch vi (Rossi 2003, pp. 163-169, nn. 4-9), di cui uno bollato sul gomitodell’ansa TE TE (forse TE ripetuto due volte; E con il primo tratto orizzontale più lungo; testo con anda-mento ascendente): Rossi 2003, pp. 163-164, n. 4, figg. 3-4 = Camilli - De Laurenzi - Setari 2006, p. 63, n.48 (dalla Campania settentrionale in base ad analisi minero-petrografica). Come confronto (v. Olcese 2004,p. 183) è stato richiamato un bollo [- - -]TE (incompleto anche alla fine?) del Pech Maho, ma sulla base del di-segno assai infelice di Solier 1979, p. 93, fig. 24, 5 l’accostamento all’esemplare pisano mi sembra improba-bile. Altre grecoitaliche dello stesso tipo a Cala Barbiere presso Punta Ala (Cygielman 1982, pp. 47-48, figg.16-18), a Prato Ranieri, loc. Boschetto presso Follonica (una con graffito NE in nesso, retro.: Paribeni 1982,p. 49, fig. 21), abbastanza vicine alle anfore timbrate da Tr. Loisios. I ritrovamenti negli scali portuali d’Etruriasono raccolti in Memorie sommerse, carta a p. 227; per quelli di Puntone di Scarlino, v. Bargagliotti - Ci-becchini 2003, pp. 54-56.
2 Per la circolazione delle grecoitaliche di tipo Van der Mersch vi trovate in Magna Grecia e in Sicilia sirimanda a Van der Mersch 1994, pp. 81-82 e passim; per il Lazio (inclusa Roma) e la Campania settentrio-nale, v.Van der Mersch 2001, pp. 171-172, note 147-154 da aggiornare per Roma con i dati editi in Auditorium2006 e Suburbium ii. In Paribeni 2004 e Ciampoltrini 2004 il lettore troverà la segnalazione di numerosiritrovamenti di grecoitaliche in Etruria settentrionale (dai tipi più antichi ai più recenti: cinque i gruppi in-dividuati da E. Paribeni), sia negli insediamenti etruschi sulla costa pisano-lucchese, sia negli abitati liguridelle Alpi Apuane. Inoltre, in quasi tutti i siti nei quali è stata registrata la presenza di anfore del tipo Vander Mersch v sono state rintracciate anche grecoitaliche del tipo vi in quantità generalmente, per quanto èdato sapere, ancora modeste: da Populonia a Cartagine, da Pompei e da Taranto a Carthago Nova, dall’op-pidum di Teste-Nègre aux Pennes-Mirabeau vicino Marsiglia distrutto durante la ii Punica (Gantès 1978) aLattara/Lattes (2001, pp. 47-48, 50-56, p. 52, fig. 5: tipologia degli orli appoggiata ai dati stratigrafici del sitoe integrata con i confronti regionali lungo l’arco che da Ventimilia raggiunge e include la Spagna; aggior-namenti per Lattes sono in Sanchez - Adroher Auroux 2004), dal Pech Maho a Mas Castellar-Pontós, daAmpurias a Alorda Park, un oppidum iberico a Nord di Tarragona, ove nella fase iii, databile all’incirca al200 a.C., le anfore grecoitaliche costituiscono il gruppo di importazioni più numeroso di quello punico cen-tromediterraneo e punico-ebusitano (Asensio 1996, fig. 12, 147, 157). Completano il quadro i relitti e i cen-tri che hanno restituito anche (o solo) il materiale iscritto menzionato in queste pagine, che integra i datiraccolti da Van der Mersch 2001, p. 175, fig. i e pp. 177-179, tab. i-iii.
3 Thierrin Michael 2000, p. 2254 Solier 1979. Qualora si trattasse di quest’ultimo avvenimento, l’abbandono potrebbe essere legger-
mente anteriore: 220-215 (Morel 1981, p. 56, nota 179).5 Thierrin Michael 2000, p. 229. 6 Hesnard et alii 1989, pp. 60-65.7 Questo bollo è stato ritrovato in tre esemplari al Pech Maho (alla base dell’ansa) e recentemente (su
parete) a Cetamura presso Gaiole in Chianti, a pochi km da Siena, un insediamento di altura etrusco, si-
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 33
alla “regione situata tra Roma e Sorrento”. Sicuramente pompeiano è il campioneriferibile alla categoria petrografica 4 (che corrisponde al gruppo chimico 5 di He-snard et alii 1989, p. 61, fig. 28) pari al 14% sul totale dei pezzi esaminati. Due cam-pioni isolati testimonierebbero importazioni dall’Etruria, ma né dall’area di Rosi-gnano Marittimo (Etruria settentrionale), né – sembra, benché non sia dettoesplicitamente – da Cosa (Etruria meridionale). La Sicilia, se presente, avrebbe secondo questa ricerca attestazioni bassissime. In totale le officine presenti al PechMaho sarebbero una quindicina, di cui tre sarebbero le “rifornitrici” principali (suquesto punto analisi chimiche e petrografiche giungono alle stesse conclusioni, benchè le ipotesi di origine siano, come si è detto, diverse).1 Un controllo eseguitoda G. Olcese suggerisce per alcuni esemplari di questo sito somiglianze morfologi-che, epigrafiche, di impasto con le grecoitaliche del gruppo chimico 2 di Ischia, lacui origine sarebbe da riportare, come si è già detto, a Ischia/Golfo di Napoli o piùgenericamente al Lazio/Campania.2
I bolli in latino sono in progressivo aumento, benché convivano con quelli in greco3spettanti, per quelli di cui è dato sapere, in buona parte ad area ischitano/neapolitana.4
tuato all’incrocio tra le strade che univano Volterra con Arezzo e Fiesole con Chiusi, rioccupato nella se-conda metà del iv secolo probabilmente in connessione con l’avanzata romana: De Grummond 2005, pp.33-34, fig. 3.7. Allo stesso personaggio è da attribuire la serie MLVR da Cartagine (cil viii, 22637.65) e M.LVRda Atene alla base di due anse; tre sono i bolli M.LVR da Alessandria e uno da Hermion, Magoula in Argoli-de (De Grummond 2005, p. 34, nota 19).
1 Thierrin Michael 2000, p. 228, fig. 6. 2 Olcese 2004, p. 183.3 I bolli in greco contengono normalmente un nome proprio (quando non troncato declinato in nomi-
nativo o in genitivo), più raramente due o tre lettere (nomi in forma molto contratta?), oppure una sola let-tera o un simbolo. Gli antroponimi greci non rivelano la posizione civile degli individui (liberi, schiavi?), alcontrario di quanto avviene normalmente nell’onomastica dei bolli in latino. Sulle difficoltà o sull’impos-sibilità allo stato attuale delle conoscenze di decifrare nell’ambito del processo produttivo il ruolo dei per-sonaggi che timbrano (proprietari delle officine in quanto artigiani indipendenti, o lavoranti) si rimanda aVan der Mersch 1994, pp. 113-116. Per altro, ogni area può aver utilizzato un suo codice, come avviene suicontenitori da trasporto greci, greco-insulari e microasiatici, codice che può aver subito anche cambiamentinel tempo.
4 Per i bolli attestati sia in Sicilia, sia in Campania, a dimostrazione dei contatti tra queste due regioniin età ellenistica, tutti in greco ad eccezione di quelli spettanti a Tr. Loisios, C. Aristo, M. Antestios, Q. An-tro(- - -), v. Garozzo 2006, da aggiornare con i nuovi dati di Ischia e di Neapolis (Olcese 2004 e Olcese 2005-2006). In particolare va notato che molti dei bolli rinvenuti ad Ischia trovano confronto con esemplari dacentri sotto l’influsso o il dominio punico (Selinunte, Heraclea Minoa, Lilibeo, Erice) e sembrano mancarenei siti della Sicilia orientale. Per Erice, ove Pellegrini 1887 registra un’ottantina di bolli che potrebberoappartenere a grecoitaliche, è la presenza del santuario che attira gli arrivi di anfore vinarie da tutto il Me-diterraneo. Erice in sostanza si presenta come il più importante centro ricettivo di vino della Sicilia (alme-no sulla base del materiale bollato: 771 bolli di cui 541 rodii), al pari di altri santuari, come quello di Astar-te/Hera a Tas-Silg sulle coste orientali dell’isola di Malta, anch’esso di origine fenicio-punica, con attivafrequentazione in età romana, o quello di Via Malta a Cagliari, in un’altra area di cultura punica, anch’es-so probabilmente dedicato a Venere, da cui provengono 400 Dressel 1 e 200 anfore di tradizione punica(Tronchetti 1996, p. 501). Per spiegare la notevole concentrazione di contenitori vinari ad Erice, A. Pel-legrini pensò a rituali che prevedessero il consumo di vino. L’ipotesi è ripresa e discussa da Bruno 2004,pp. 114-115 per il santuario di Malta. È nota tuttavia l’intensa attività svolta da alcuni luoghi di culto nella ri-distribuzione di merci e di derrate e nello scambio di beni: è il caso di Delo, che presenta, in relazione al-la documentazione anforaria, una situazione analoga ai siti citati sopra. Funzioni simili non possono esse-re escluse per altri santuari del Mediterraneo, in particolare per quelli che hanno carattere emporico comequelli sopra ricordati. Non va inoltre sottovalutato il fatto che il porto di Erice (Trapani) fu un’importan-te base navale cartaginese fino al 241 a.C., quando passò sotto il controllo romano (tra l’altro l’antico cul-to della Venere Ericina venne istituzionalizzato a Roma nel 215 a.C. con la dedica del tempio sul Campi-
34 clementina panella
La bollatura in latino,1 come ha fatto notare D. Mancorda,2 rappresenta un fenomenodi importanza capitale sotto diversi aspetti. L’onomastica indica un ambiente romanoo centro-italico nel quale spiccano gentilizi riferibili a famiglie di antica origine: i Valerii,gli Antistii, i Baebii, i Lurii, i Decii (non conosco in questa fase nomi individuali). La do-cumentazione si arricchisce con i graffiti praticati prima o dopo la cottura delle anfore,3
doglio e nel 181 con la dedica del tempio extra portam Collinam: nel dies natalis del tempio era associata lafesta dei Vinalia priora che segnava il consumo del vino nuovo di cui si iniziava la vendita). La ridistribu-zione di vino può aver interessato la Sicilia occidentale, ma anche il Nord-Africa e il lontano Occidente. Li-lybaeum/Marsala, anch’essa punto nodale del commercio diretto nel Mediterraneo meridionale, ha resti-tuito alcune grecoitaliche bollate in greco e in latino (Brugnone 1986; quasi tutti i bolli pubblicati siritrovano anche nella vicinissima Erice e rientrano nel medesimo circuito marittimo), ed è indiziata di es-sere anche uno dei centri di produzione di queste anfore (Bechtold - Valente 1990), ma il dato, più vol-te ripreso nella letteratura (il quartiere artigianale presso il Baglio Anselmi), lascia larghi margini di incer-tezza. Dalla necropoli punica una grecoitalica del tipo Van der Mersch vi intera, tipolgicamente assai vicinaad alcuni esemplari del Pech Maho (Bisi 1971, p. 684, fig. 16, da una tomba datata alla fine del iii secolo).Della varietà di grecoitaliche rinvenute nei pressi della cd. nave “punica” naufragata lungo la costa fa fedela pubblicazione di Culican - Curtis 1976.
1 Il corredo epigrafico delle anfore è strettamente legato, come si è già detto, alle tradizioni dei singoliambienti produttivi e può variare di significato a seconda degli ambiti geografici ed artigianali in cui la pra-tica della bollatura viene adottata (un’ampia esemplificazione dell’epigrafia dell’instrumentum e sul ruolodei diversi operatori che intervengono nelle differenti categorie di iscrizioni è in Nonnis 2003). Nelle pro-duzioni anforarie dell’Italia romana il bollo contiene solitamente uno, più raramente due nomi legati davincoli di societas (nel caso di domini: v. T. (et) Q. Iventii/Iuventii) o di dipendenza (dominus/servo) e sembradirettamente collegato al processo di fabbricazione dei contenitori, sia che rappresenti il proprietario dell’officina (che può essere anche il proprietario del fundus da cui proviene la merce da invasare, come potrebbe essere il caso dei marchi delle più tarde Dressel 1 e Lamboglia 2 riferibili a nomi di personaggi prosopograficamente noti: Silla, Pompeo, Cinna, Sestio…) o l’affittuario della stessa, sia che rappresentiun’unità di lavoro (in tal modo sono stati interpretati i tanti nomi servili attestati sulle Dressel 1, sulle Lam-boglia 2, sulle anfore ovoidi di Brindisi, sulle Dressel 6A, sulle Dressel 6B). Esiste anche la possibilità che ilbollo si riferisca alla committenza in vista della commercializzazione di derrate derivanti da un fundus chenon disponga dei mezzi per la produzione delle anfore (è ciò che sembra accadere nelle officine “raggrup-pate” come sono quelle di Apani presso Brindisi: Palazzo 2003). Meno fondata è l’ipotesi di un rapportodella timbratura con il mondo del commercio, che si esprime attraverso un’altra serie di iscrizioni (bolli suitappi, tituli picti, graffiti): Manacorda - Panella 1993; Manacorda 1993 e 2003. Per la bollatura delle altreclassi dell’instrumentum si rimanda a Morel 1983 e ora a Nonnis 2003. Più incerta rimane invece la funzio-ne e la destinazione del bollo sulle anfore. L’ipotesi che si tratti di una garanzia che si offre al destinatariodella merce (di qualità, di carattere fiscale, di carattere commerciale), com’è dimostrato per le produzionianforarie greche e microasiatiche è compromessa dalla mancanza di sistematicità nel mondo romano del-la pratica stessa (produzioni mai bollate; esistenza all’interno di una stessa officina di materiale bollato enon bollato). 2 Manacorda 1986, p. 582-583; Manacorda 1989, pp. 444-446.
3 Queste iscrizioni pongono un problema intepretativo, in quanto i graffiti sono generalmente assimi-lati ai tituli picti e riferiti perciò ai commercianti. Ma i graffiti su grecoitaliche potrebbero avere altro signi-ficato. Il loro contenuto (gentilizi “eccellenti”) consentirebbe di supporre che i personaggi menzionati sia-no i produttori della merce trasportata, il cui ordinativo appare già predisposto – per i graffiti praticati primadella cottura – al momento dell’esecuzione del vaso e – per quelli post cocturam – immediatamente dopo.La documentazione disponibile difetta di casi in cui l’anfora contrassegnata con un graffito presenti ancheun bollo o una sigla spettante all’officina: si segnalano un esemplare di Mas Castellar-Pontós con graffitoMAR.RVLIO e bollo [E, in greco o in greco-osco (v. oltre), e una grecoitalica già vicina alle Dressel 1A daScannicci (prov. Firenze) con graffito in etrusco LECV (prima della cottura, retro., L a uncino, E con codo-lo) e bollo [C]R (retro. e capovolto): Bruni 1997, pp. 170-171, fig. 14, da una tomba datata ai primi decennidel ii secolo. Lecu è un gentilizio etrusco documentato da iscrizioni di Volterra su due urne cinerarie, unadel secondo quarto del i secolo, l’altra dell’inizio del I secolo. Quest’ultima appartiene a un Aule Lecu, raffi-gurato sul coperchio con in mano un fegato in riferimento alla sua funzione di aruspice (bibliografia in Bru-ni 1997, p. 171, note 147-148).
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 35
anch’essi in latino, riferibili a gentes tra le più importanti della repubblica: Aemilii, Aure-lii, Campatii,1 Minuci, Rullii,2 Veii.3
È inutile segnalare – lo ha già fatto Van der Mersch 2001 – l’autorevolezza deipersonaggi rievocati dai nomi di queste famiglie e i loro rapporti con opere di bonifi-ca, costruzione di strade e di acquedotti.4 Il bilinguismo presente su alcuni bolli (è ilcaso di C. Aristo/°¿ÈÔ˜ \AÚ›ÛÙˆÓ)5 fa intravedere le attività di personaggi italici e ro-mani attivi in ambiente grecofono, mentre l’apporto della Campania nella produzio-ne di grecoitaliche sembra trovare conferme nei bolli che mostrano rapporti con ilmondo osco. È il caso del già citato bollo di Tr. Loisios, rintracciato con una sessanti-na di esemplari nel Mediterraneo sia occidentale che orientale,6 che io daterei alme-no al 230 in base al profilo degli unici due esemplari (da Taranto e da Ischia)7 di cui si
1 Nolla Brufau 1974, p. 170, n. 80, fig. 16, 3; p. 181, fig. 23, 9. Per un’origine ceretana dei Campatii, v. To-relli 1969, p. 320.
2 García Sánchez 1997, p. 267, n. 9, fig. 3. L’anfora, del tipo Van der Mersch vi (v. Fig. 3.7), possiede, co-me si è già detto, anche un bollo alla base dell’ansa in greco o in osco: ßE = Ve(- - -), con digamma a formadi parentesi quadra, E in nesso (la lettura è confermata da un altro bollo su grecoitalica dalla stessa locali-tà, da diverso punzone: García Sánchez 1998, pp. 234-235, n. 10). Il digamma di questa forma scompare ge-neralmente in epoca alta (iv secolo), ma permane a lungo in alcune aree della Grecia e dell’Italia meridio-nale. La stessa forma di digamma è presente nel bollo ß impresso su un’anfora massaliota (Bertucchi 1992,p. 156) e nel bollo [EL = Vel(- - -) su una grecoitalica da Ischia del tipo Van der Mersch v, attribuita al grup-po chimico 1 di accertata origine locale (Olcese 2004, p. 178 e p. 191, fig. 2.5), che per punzone e per crono-logia non ha rapporti con il bollo di Mas Castellar-Pontós. Il graffito MAR.RVLIO è stato praticato primadella cottura (Comes - Rodà 2002, p. 218, n. 56). Se il bollo assicura la provenienza dell’anfora da un am-biente dove si usava l’alfabeto greco (o greco-osco), il commerciante o il produttore della merce trasporta-ta, a cui il graffito va riferito, è un romano o un italico. Maraeos è prenome attestato in età arcaica, gene-ralmente abbreviato Mar. (Salomies 1987, pp. 76-78). Il gentilizio Rullius è raro nell’epigrafia lapidaria, mamolto documentato su una particolare produzione ceramica dell’Italia centrale del i secolo denominatadell’“atelier di Rullius”: con il dominus numerosi servi bollano piccoli vasi (contenitori di porpora?). Su que-sta produzione, attribuita ad Aquino e sulla porpora di origine vegetale fabbricata in questa città, v. da ulti-mo Gianfrotta 2007a, con bibliografia.
3 Il più antico di questo gruppo (il confronto dell’anfora con gli esemplari della Meloria comporta unadatazione intorno alla metà del iii secolo; troppo alta la data – fine iv/inizi iii secolo – di Rossi 2000 e 2003)è il già citato graffito MVIIIO (E a due tratti, corsiva) = M. Veio(s) su una grecoitalica del tipo Van der Merschv da Pisa/San Rossore (Rossi 2003, p. 163, n. 2; fig. 5 a p. 165 = Rossi 2000, p. 129, nota 16, inv. G.143:), rin-venuta insieme ad altre due grecoitaliche identiche (Rossi 2003, p. 161, n. 1, fig. 1 e p. 163, n. 3 = Rossi 2000,p. 128, n. 801, fig. 1) sulla linea di riva di età ellenistica, non lontato dall’area della nave del “leone”che tra-sportava grecoitaliche vicine a quelle del relitto della Chrétienne C, datato al 175. Rimando a Torelli 2003per la diffusione del gentilizio e per l’ipotesi di un’origine campana della famiglia (v. anche pp- 23-24, nota 7e p. 25, nota 4). 4 Van der Merch 2001, pp. 184-185, passim.
5 Van der Mersch 1994, pp. 163-164: antroponimo greco preceduto da prenome latino, datato post 240:Empereur - Hesnard 1987, p. 29. Gli esemplari timbrati da Tr. Loisios sono registrati in Van der Mersch1994, pp. 168-169 tra i bolli magnogreci-siciliani, in quanto l’autore assegna questo “fabbricante” a tale area.Sugli idionimi utilizzati apparentemente in funzione di gentilizio, preceduti da un praenomen, documenta-ti nell’epigrafia dell’instrumentum in diversi ambiti produttivi e geografici nel iii e nel ii secolo, v. Nonnis2003, pp. 256-257.
6 Agli esemplari raccolti da Van der Mersch 1994, va aggiunto un altro bollo dalla Sicilia, recente-mente edito (loc. Fontana Schette, Monte Gibliscemi, Mazzarino, prov. Caltanisetta): Gianfrotta 2007b,p. 67, fig. 2. Qui anche per la diffusione e per una bibliografia aggiornata. Per le attestazioni in Sicilia v. Ga-rozzo 1999, p. 317, n. 50; Garozzo 2006, p. 724, A.19.
7 Manacorda 1989, p. 444, fig. 1; Olcese 2004, p. 192, fig. 3.5. I pezzi di Taranto (v. Fig. 2.5) e di Ischiasono gli unici di cui si sia conservata (ed è stata disegnata) una parte significativa del contenitore; i pochi al-tri, documentati da disegni o da foto, essendo relativi ad anse, non sono evidentemente attribuibili ad alcuntipo di grecoitalica. Tuttavia l’anfora di Ansedonia, presentata da E. Lyding Will ad illustrazione della sua
36 clementina panella
conosce la parte superiore dell’anfora, alla formula onomastica che lo accomuna sen-za alcun dubbio ai marchi del iii secolo,1 ma soprattutto perché documentato a Car-tagine, ove mi sembra poco verosimile che una grecoitalica così timbrata arrivi nelcorso della ii Punica, benché le guerre non abbiano mai ostacolato traffici e com-merci. Questi elementi consentono di supporre per l’attività del personaggio almenoun terminus ante 221. Nella stessa direzione va la tipologia: se le grecoitaliche del re-litto della Meloria A sono da datare, come penso, intorno alla metà del iii secolo, leanfore di Tr. Loisios dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere posteriori di unoo due decenni. Mantengo pertanto la datazione “alta” nonostante che il bollo di Sa-guntum (Plaza de Armas del Castillo nell’area del Foro), raccolto in un riempimentoassegnato al primo terzo del ii secolo e messo in relazione con i lavori posteriori allaguerra annibalica,2 la contraddica. La cronologia di questo contesto può essere esat-ta, ma costituisce per l’esemplare e il suo “fabbricante” solo un terminus ante.3 La da-tazione “bassa” (ii secolo), proposta da E. Lyding Will, deriva dalla presenza a Delodi un Trebios Loisios negotiator, attivo nel 162-161, che può più giustamente essere iden-tificato come un suo discendente. Per quanto riguarda infine la localizzazione di que-sta officina, G. Olcese afferma che l’impasto delle due anfore timbrate da Tr. Loisios diIschia è sul piano visivo un po’ diverso da quello delle grecoitaliche sicuramente lo-cali, mentre dal punto di vista mineralogico esso è caratterizzato da degrassante ana-logo a quello delle anfore ischitane, «pur distinguendosi da esso per parametri tessi-turali».4 Per quanto sibillina sia la frase, sembra che debba essere abbandonata laprovenienza siciliana o bruzia di questo fabbricante suggerita qualche anno fa dai so-stenitori della «piste sicilienne».5
Si è notato nella fase più antica della bollatura in latino, quella di questa seconda me-tà del iii secolo, un “certo orgoglio” nel riportare il proprio nome nel corredo epi-grafico, come accade nei bolli per tanti versi simili (nella formula e nell’uso del no-minativo in -o(s)), della ceramica a vernice nera prodotta tra la fine del iv e nel iiisecolo a Teano, a Cales, a Minturno. C’è da aggiungere che l’origine romana o cen-tro-italica denunciata dalla lingua e dall’onomastica non aiuta nell’identificazione deicentri di produzione delle anfore, che avrebbero potuto trovarsi in qualsiasi territorio
forma 1d, dà un’idea della configurazione di un esemplare intero (Lyding Will 1982, fig. 82, f ). Dal testorisulta chiaramente che l’autrice attribuisce a questa immagine le grecoitaliche bollate da Tr. Loisios (LydingWill 1982, p. 350); per il resto occorre tralasciare, in quanto creano solo confusione, le osservazioni (anchecronologiche) che accompagnano l’analisi della forma (ivi, pp. 348-353).
1 Manacorda 1989, p. 444.2 Aranegui Gascó 1995, pp. 247-248, passim, fig. 1.3 Senza datazione è il bollo TR.LOISIO da Carthago Nova (Márquez Villora - Molina Vidal 2005, p.
165, n. 16), città fondata da Asdrubale nel 229 su un insediamento preesistente. Le grecoitaliche sono bendocumentate nel iii secolo: nell’immondezzaio della Plaza de San Ginés, datato tra il 220 e il 210, hanno unapercentuale del 21,5% sul totale delle anfore raccolte. Da questo centro anche i bolli ¢Iø, BIø, IEPø,AN¢PøNO™ (tre esemplari) e C.ARISTO: Martín Camino 1996, p. 11, a pie’ di pagina; Martín Camino1998. 4 Olcese 2004, p. 179 e nota 35.
5 Tchernia 1986, pp. 49-51; Hesnard et alii 1989, p. 31; Van der Mersch 1994, pp. 168-169. Va detto chel’unico altro bollo latino registrato da Van der Mersch nel suo Index (insieme a Tr. Loisios e C. Ariston), èTEVCR.FAB = Teuc(he)r Fab(i) (scil. servus) (ivi, p. 175), che non è né su grecoitalica, né appartiene al iii se-colo, bensì è su una Lamboglia 2 della fine del ii/inizi del i secolo.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 37
della penisola o della Sicilia ove Romani o Italici avessero proprietà e fossero implica-ti in una produzione di vino e/o di contenitori da trasporto.1 Diverso è il caso dei bolliin greco o in osco2 che rimandano invece ad una fabbricazione delle anfore in zonegrecofone o oscofone (ma la merce trasportata potrebbe appartenere a Romani o Italici). Quanto al binomio lingua/mercati, v. oltre, p. 44, nota 4 e p. 47, nota 3.
Per ciò che riguarda le grecoitaliche bollate, qualche indicazione cronologica po-trebbe provenire dalla paleografia (L ad uncino e piana, A con barretta trasversale rea-lizzata con un trattino obliquo o spezzato, O e Q aperte o chiuse, O nana, T longa) odal tipo di desinenza usata per il nominativo singolare (-o per -os e -us). Tali elementipotrebbero consentire per esempio di isolare un gruppo di officine più antiche (quel-le di L. Valerios, di Tr. Loisios e di altri, come M. Antestios, C. Ariston, M. D(e)cios,3 Q. Vol-cios,4 sui quali è riconoscibile la terminazione in -o), ma il confronto con l’epigrafia la-pidaria urbana proposto da L. Pedroni (il quale tende a collocare la data delcambiamento della desinenza -os in -us nel 240-230 a.C.),5 non è sufficiente a garanti-re sempre e in ogni luogo la uniformità dei comportamenti epigrafici e ortografici (v.la L ad uncino dei bolli degli Aninii su anfore brindisine, che dovrebbero essere po-steriori al 150 a.C.), soprattutto se il riferimento è con materiali che provengono daaree e da storie di acculturazione diverse, a cui va aggiunto un processo di alfabetiz-zazione e di pratica della scrittura di maestranze poco colte, tutt’altro che lineare.
Infine la diffusione. Se sembra che bolli in greco e in latino interessino le stesse aree(Sicilia, canale di Sicilia, Occidente mediterraneo, relitti), c’è da rilevare che una presenza, anche se esigua, di marchi in latino che attribuisco alla seconda metà del iiisecolo, è attestata anche in area cento-tirrenica, e non soltanto sulle coste, com’è il
1 A questo proposito può, ad esempio, essere citato il passo di Livio (xxv, 10) che assicura che i Roma-ni possedevano case a Taranto nel corso della seconda guerra punica. Sulla base dell’impasto (“pasta riccadi molte piccole inclusioni nere”: Gallia Informations, 1998-1999, s.v.) non stupirebbe se la grecoitalica bolla-ta da M. Antestios del relitto di Pointe Lequin 2 provenisse da Pompei, ove, com’è noto, all’epoca del nau-fragio si parlava e si scriveva in osco (per i problemi della datazione di questo relitto v. Appendice i). Il per-sonaggio può essere messo in relazione con la ben nota famiglia degli Antistii di origine laziale (da Gabii:Licordari 1982, p. 28 sgg.), nella quale è molto diffuso il prenome Marcus. Magistrati con questo nome so-no documentati a Roma e nel Lazio in età repubblicana (Broughton, Magistrates, ii, p. 530). In questa stes-sa età gli Antistii sono presenti anche in Campania (Pompei: Castrén 1975, p. 135, n. 34; Capua: D’Isanto1993, pp. 64-65, n. 25).
2 I due bolli di Erice, NI.AHVDIIS = Ni. Ahvdiis, sono su anfore di tipo non determinato, ma verosimil-mente grecoitaliche. Per Van der Mersch 1994, p. 161 gli esemplari proverrebbero da zona oscofona a Suddel Silaris; per Nonnis 1999, p. 82, da Pompei, ove la famiglia degli Audii è ben documentata in età prero-mana, anche con lo stesso prenome (Niumsis corrispondente al latino Numerius). Un fundus Audianus notosulle tavolette di Cecilio Giocondo, incluso nei fondi demaniali del i secolo d.C., potrebbe indicare interes-si fondiari della gens in età pre-sillana (Nonnis 1999, loc. cit., con bibliografia).
3 Il bollo è M.DCIO da Erice (cil x, 8051.11). Il ritrovamento di un bollo dallo stesso punzone a Fregellae(informazione di D. Nonnis) ha permesso di correggere la lettura M.DLIO del cil, e di attribuire i due esem-plari a grecoitalica.
4 Da Messina (su ansa), non capito da Bitto 2001, pp. 134-135, n. 57, e da Toulon (su spalla), letto erro-neamente CC.VOLKIO da A. Hesnard, in Brun et alii 1993, pp. 87-88, n. 2, fig. 60: Q aperta, interpretata da-gli editori come CC, mentre la lettera K nasce da un fraintendimento delle lettere LC assai vicine. Que-st’anfora, di cui resta solo un frammento di spalla, è datata al primo quarto del ii secolo sulla basedell’inclinazione del pezzo (?). Per il gentilizio Volcius, diffuso in area campano-laziale, v. Schulze 1904, p.99. Questi pochi esempi danno l’idea della difficoltà in cui ci si trova nella raccolta del materiale epigraficodelle grecoitaliche (e delle anfore in genere): errori di interpretazione, cattive trascrizioni, assenza di docu-mentazione del supporto… 5 Pedroni 2001, pp. 81-86.
38 clementina panella
caso di Populonia: si tratta di Q.ANTRO (Capena), M.D<E>CIO (Fregellae), M.LVRI(Gaiole in Chianti), M.A[- - -] (Ardea)…1
Rimane aperto il problema dell’appartenenza a questo periodo o al successivo delladocumentazione spettante all’ultimo quarto del iii secolo, o meglio agli anni 220/200.Qualora si partisse dagli indicatori di cui disponiamo (morfologia, bollatura, diffusio-ne) le grecoitaliche di questo ventennio si porrebbero in continuità rispetto ai decen-ni precedenti, con un’accentuazione della circolazione dei vini centro-tirrenici già re-gistrata nei decenni tra le due Puniche. Il plebiscito Claudio del 218 tenta di limitarel’attività commerciale della nobilitas, che evidentemente era già consolidata (v. oltre,p. 74 e nota 5). All’interno di questi due decenni sono infatti da collocare alcune offici-ne che realizzano anfore più evolute del tipo Van der Mersch vi, ma non ancora assi-milabili ai tipi degli inizi/primo quarto del ii secolo (anfore del Grand Congloué 1). Èil caso delle grecoitaliche del relitto di Skerki Bank.2 Il bollo SES tridente impresso suuna di esse le avvicina alla nota produzione cosana dei Sestii,3 alla quale sembrerebbe-ro rimandare anche l’analisi macroscopica dell’impasto, la somiglianza morfologicadegli esemplari del relitto con le grecoitaliche rinvenute nel porto di Cosa, il simbolodel tridente che caratterizza i bolli di questa famiglia nelle fornaci, nel relitto del GrandCongloué 24 e altrove. Ne conseguirebbe che quest’officina (o meglio che l’attività im-prenditoriale dei Sestii), abbia avuto inizio molto prima della fine ii/inizi del i secolo,che è la data assegnata alle Dressel 1 timbrate SES + simbolo.5 L’assenza di elementicronologici esterni costringe a basare la datazione per questo ritrovamento6 sulla ti-
1 Carbonara 2005. 2 Freed 1994, pp. 64-67, figg. 43 e 47; Panella 1998, pp. 537-540.3 Sull’officina del portus Cosanus presso la Tagliata di Ansedonia, v. Manacorda 1978 e Lyding Will
1987 e 2001.4 Il relitto è stato pubblicato da Benoit 1957; una carta di diffusione in Gallia delle anfore dei Sestii è in
Olmer 2003, p. 147, fig. 11.5 È certa l’esistenza di una produzione di grecoitaliche nel portus Cosanus, ma si tratta di materiale fram-
mentario e non datato. La “novità” riguarderebbe l’inizio dell’attività dell’officina dei Sestii. Solo LydingWill 1987 e 2001 aveva proposto per questa officina una cronologia “alta”, agli inizi del ii secolo, sulla ba-se di elementi che non erano sembrati interamente affidabili. Evidentemente aveva colto nel segno (in tut-to o in parte).
6 La datazione dei relitti, anche quando compaiono chiari indicatori (monete, iscrizioni), cioè quandosi tratta di “relitti datati” secondo la definizione di Tchernia 1990, p. 296, è sempre “libera”, in quanto gli“indicatori” costituiscono solo i termini post quem del carico, mentre i depositi di terra sono vincolati da un“prima” e da un “poi” forniti dalle stratigrafie (Tchernia 1990). Tuttavia queste ultime non sfuggono a duealtri problemi, raramente presi in considerazione dagli archeologi: il primo è quello della residualità (sul-l’argomento v. Giannichedda 2007); il secondo è lo scarto cronologico tra la data di chiusura dei deposi-ti, che dipende dai reperti più tardi, e la data dei materiali in essi contenuti, che spettano alla formazionedei depositi stessi (di prima giacitura, come sono gli strati di vita e d’uso; di giaciture secondarie come so-no gli strati di costruzione o di abbandono). Si veda la situazione dell’immondezzaio della Plaza de San Gi-nés a Cartagena, datato dopo l’impianto della colonia di Asbrubale del 229 e prima della conquista romanadel 209 (Martín Camino 1996, pp. 21-22). Esso ha restituito i bolli (su grecoitaliche) ¢Iø e BIø, che po-trebbero trovare confronto con gli analoghi marchi del relitto di Capistello del 300-280 (quasi certamenteresidui), e il bollo AN¢PøNO™, retro. (contestuale) (Martín Camino 1998, p. 14; Márquez Villora -Molina Vidal 2005, n. 366a). Quest’ultimo marchio compare su una grecoitalica non altrimenti identifi-cata al Pech Maho (quindi ante 210/200: contestuale) (Van der Mersch 1994, p. 162, s.v.) e su un’anfora deltipo Van der Mersch vi, da uno dei riempimenti del silos 101 di Mas Castellar-Pontós datato al 200-175 (resi-duo) (García Sánchez 1997, pp. 260-261, nn. 1-2; p. 266, fig. 1; per la datazione dei riempimenti di questopozzo, v. Pons - Rovira 1997; v. anche oltre, p. 83).
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 39
pologia dei contenitori che trovano confronto con alcune grecoitaliche del relitto diTour d’Agnello presso Rogliano in Corsica di data controversa,1 ma che io situerei in-torno al 230-220. L’anfora di Sestius di Skerki Bank, con collo più stretto e con pareticoncave e pancia più affusolata, potrebbe essere posteriore di qualche anno.2 Ma esi-ste sempre il dubbio che l’officina possa aver utilizzato modelli che altri ambienti ave-vano già superato.3 Il che consentirebbe di abbassare leggermente la datazione deicontenitori di Skerki Bank, identificando, o meglio mettendo in rapporto il Sestius delbollo con il M. Sestius di Fregellae ricordato come attivo a Delo nel 190.4 Prospetto l’ipo-tesi, ma non ne sono convinta. Tuttavia va segnalato che se fosse valido il rapporto trail M. Sestius di Delo e il Sestius del relitto, resterebbe comunque aperto il problema del-l’origine della produzione precoce dei Sestii che F. Olmer vedrebbe collegata a Fregel-lae in base al cognome Fregellanus portato dal personaggio onorato a Delo, laddove iltrasferimento delle attività vitivinicole e ceramiche della famiglia nel Cosano sarebbela conseguenza della distruzione di questa città nel 125. L’ipotesi è interessante, macomporta una serie di passaggi nessuno dei quali può essere provato: non è nota unaproduzione di anfore a Fregellae; le famiglie, individuate mediante il gentilizio, si sud-dividono in diversi rami, di cui dà conto il cognome (non attestato nel bollo dell’anfo-ra di Skerki Bank, né mai sulle anfore dei Sestii del portus Cosanus), rami che rinvianotalvolta solo ad una lontana origine comune; nell’ambito delle parentele dirette entrain gioco anche il prenome e i membri del ramo “cosano” della gens Sestia non portanoil prenome Marcus (v. oltre, p. 51).
iii Periodo (220/200-150/140). La seconda guerra punica costituisce un terzo mo-mento di rottura riflesso nell’esplosione della Campana A.5 J.-P. Morel si chiede se
1 Van der Mersch 2001, p. 178: 240 +/– 20; Long 2004, pp. 146-147: 250-225; Cibecchini 2004, p. 63: 225-200. Queste oscillazioni danno il segno delle difficoltà in cui si muove la cronologia delle grecoitaliche, e diconseguenza, quella dei relitti (v. Appendice i). Il problema di questo, come di altri carichi naufragati, è co-stituito dal fatto che alcuni esemplari sono del tutto simili alle anfore di Tr. Loisios, (Liou 1982, p. 454, fig. 17,nn. 2 e 4), altri hanno collo più alto e conseguentemente anse più lunghe, pancia leggermente più affuso-lata (Liou 1982, p. 454, fig. 17, nn. 1, 3, 5-6): in termini cronotipologici i primi sembrerebbero precedere i se-condi, pur rientando entrambi all’interno dei decenni finali del iii secolo. La presenza nello stesso caricotende a far pensare ad una contemporaneità delle due serie, laddove mi sembra che le differenze tipologi-che dipendano in questo caso dalla diversità di modulo.
2 Il collo stretto e relativamente lungo e con pareti concave ricorda vagamente quello del contenitoretimbrato AN¢PøNO™ di Mas Castellar-Pontós, ma v. anche un esemplare di Tour d’Agnello in Liou 1982,p. 454, fig. 17, 6.
3 Alcuni relitti mostrano la coesistenza nello stesso carico di tipi diversi, più o meno evoluti, ma che sipuò supporre che fossero contemporaneamente in circolazione. Talvolta i lotti sembrano essere omogeneio sono definiti tali, talaltra si notano (o sono denunciate) differenze che sembrano rimandare a partite di of-ficine diverse o a diversa cronologia (v. Cala Rossa, Terrasini B). Tuttavia questo – che è un dato fonda-mentale, non è in genere percepibile soprattutto nelle pubblicazioni meno recenti.
4 IG xi, 4, 757; Ferrary et alii 2002, p. 215, n. 1, s.v. Sestii.5 Sugli ateliers di Neapolis (Corso Umberto, vico San Marcellino -via Duomo), situati sul bordo del lito-
rale e in prossimità del porto, ma mai scavati sistematicamente, v. Morel 1988a, pp. 342-343; bibliografia inDe Caro 2005, p. 659, note 31-32; sui recenti ritrovamenti di fornaci a piazza N. Amore nello scavo della stazione Duomo della Metropolitana, v. Giampaola 2005. Benché sia sempre più chiaro il peso della diffu-sione della Campana B calena (a Cartagine per esempio, ove calena è risultata la classe Byrsa 661 di Morel;per i relitti, numerosi soprattutto tra il 120 e l’80, v. A. Ribera i Lacomba, in Pedroni 2001, pp. 296-306), ilprimato della Campana A in questi anni sembra indiscutibile. Per la ceramica fine da mensa prodotta a Siracusa e a Morgantina (Campana C), che si inserisce anch’essa nelle reti commerciali della tarda repub-blica, v. Malfitana 2006.
40 clementina panella
questa svolta corrisponda alla fine della guerra (201) e alla fondazione di Puteoli nel 194(il portorium è del 199 o del 198, ma il porto doveva aver funzionato già durante la IIPunica)1 o se essa non vada posta all’inizio del conflitto, come dimostrerebbe il fattoche nel 218 Roma ha già il dominio sul mare (di quell’anno è il plebiscito Claudio). Iltermine del 200 sembra adattarsi meglio alla documentazione offerta dalla CampanaA (produzione di massa fortemente standardizzata, nata esclusivamente per il com-mercio mediterraneo, poco esportata nell’entroterra, ma diffusa in milioni di esem-plari al di fuori del centro di origine, Neapolis) e dalle anfore grecoitaliche. Il ritrova-mento che fa ritenere conclusa la fase della grecoitalica “antica” è il relitto del GrandCongloué 1 (v. Fig. 3.8) (datato tra il 200 e il 190)2 con la sua Campana A3 e con le sueanfore di forma Will 1c, riportabili alla grecoitalica tarda di Manacorda,4 denomina-zione che comprende nella prima metà del secolo una successione di tipi che si chiu-dono con la forma Will 1e e simili (v. Fig. 3.9).
Il periodo vede una documentazione in aumento anche in relazione ai centri di pro-duzione sulle coste tirreniche, riflessi nella varietà degli impasti, e presumibilmentesulle coste adriatiche (tipo Will 3, tipi 16-18 di Adria, tipo Apani i) ed un ulteriore deci-sivo balzo in avanti della diffusione in Occidente. Con tutte le cautele dovute ad unadocumentazione assai esigua, sembra che nella bollatura, quasi sempre in latino perquanto è finora pubblicato,5 accanto a personaggi contraddistinti da prenome e gen-
1 Liv., 24, 7, 10; Strabo, 5, 4, 3. Non risulta mai citata una grecoitalica del tipo Van der Mersch v rinvenutaquasi intatta nella fattoria di via Vecchia delle Vigne, che senza dubbio risale al iii secolo (Puteoli 1993, p. 151).
2 Il 193 è la data che Finkielsztejn 2001a, p. 192, ha assegnato all’eponimo KÏÂÈÙóÌ·¯Ô˜, che timbra al-cune anfore rodie del relitto. Il 205 era invece quella proposta per l’eponimia di questo personaggio da Gra-ce 1985, p. 31. Per questo bollo il relitto si avvicina allo status dei relitti “datanti” secondo la definizione diTchernia 1990, quei pochissimi cioè che possiedono monete o elementi epigrafici – per esempio lingottio altro – che forniscono una datazione certa, da distinguere dalla massa dei “relitti datati” sulla base dei ma-teriali trasportati e, in particolare per quest’epoca, sulla base della ceramica a vernice nera. Ma già Morel1981 avvertiva che le date da lui proposte per i relitti d’Occidente in base a questo formidabile indicatorecronologico erano largamente ipotetiche, soprattutto quando applicate a carichi studiati e pubblicati in ma-niera incompleta.
3 Morel 1998b, p. 492, con bibliografia. 6000 o 7000 sono i pezzi in Campana A antica, con tipi di cro-nologia alta, proveniente dalle officine di Neapolis. Campane potrebbero essere anche le oltre 400 anforegrecoitaliche appatenenti al carico (quasi tutte anepigrafi ad eccezione delle tre bollate T.Q.IVENT[I]). Sisegnala tuttavia che l’analisi dei materiali di questo contesto porterebbe a pensare che la nave trasportasseun carico “composito” (lo proverebbero le anfore grecoitaliche, rodie e cnidie), il quale potrebbe essere sta-to imbarcato lungo la rotta (o comunque seguendo un percorso non lineare), o prelevato da un porto-de-posito (Morel 1998b, loc. cit.). Se così fosse, i singoli lotti di merce (incluse le anfore) potrebbero avere di-verse provenienze.
4 Van der Mersch 2001 identifica le grecoitaliche di questo relitto con il tipo RMR vi, assegnadole im-plicitamente al Lazio meridionale/Campania settentrionale.
5 I bolli in greco non sembrano più attestati a partire dagli inizi del II secolo, ma occorre attendere lapubblicazione degli scarichi di fornace di Neapolis. La lunga parentesi produttiva di Ischia sembra chiuder-si in questi anni. Vi sono i due bolli di Metaponto (¢·ÌÔÎÚ¿Ù˘ e \AÏÎÈ·[- - -?]: Van der Mersch 1994, pp.85, 165 e 161), datati alla fine del iii/ii secolo, che tuttavia non circolano. Due bolli sono assegnati da Olce-se 2005-2006, pp. 70-71 alla produzione di Neapolis del ii secolo: ACK§H (abbreviazione dell’antroponimo\AÛÎÏËÈ¿‰Ë˜ o \AÛ΋ÈÔ˜) e ºI§I¶¶OY, entrambi presenti anche ad Ischia (Buchner - Ridgway 1993, pp.58, 135-136, tavv. 38 e 40, 124, 117). Il primo è su un’anfora abbastanza simile a quelle timbrate da Tr. Loisios diTaranto e di Ischia (tipo Van der Mesch vi) e sembra doversi datare ancora al iii secolo; del secondo, an-ch’esso sul tipo Van der Mesch vi, si dispone solo della cronologia assegnata ai contesti di Mas Castellar-Pontós (200-175: García Sánchez 1997, p. 263, n. 8, fig. 2), a cui spettano tre esemplari. Da questo sito an-che altri bolli in greco, in genere mal conservati e di difficile lettura, ad eccezione di AN¢PøNO™, già citato
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 41
tilizio o dal solo gentilizio (Ti. e Q. Iventii/Iuventii del relitto del Grand Congloué 1,1 Q.Pac(- - -) e N. Alfius N. f. dai pozzi del 180-140 del Tolosano,2 L. An(n)ius L. f. da Enséru-ne,3 L. Acilius da una tomba di Villaricos, prov. Almería),4 che corrispondono a poche
(v. sopra, p. 39, nota 6) e di ACK§H (García Sánchez 1998, p. 231, n. 1), tutti da stratigrafie degli anni 200-175. C’è da chiedersi se essi siano arrivati qui, come in altre località della Spagna, prima del 220, cioè primadello scoppio delle ostilità tra Roma e Cartagine, come sembrerebbe suggerire la tipologia dell’esemplaretimbrato da \AÓ‰ÚˆÓ, o al seguito dell’esercito romano nel corso della ii Punica, che ebbe dal 218 come tea-tro della guerra i territori occidentali e meridionali di questa regione, come sembrerebbe indicare la data-zione dei contesti di provenienza. ACK§H (da associare per caratteristiche paleografiche al bollo ACK§,anche con variante retro.) è tra i bolli più diffusi su grecoitalica, benché quasi sempre mal interpretato. Del-le due serie ACK§H/ACK§ (quando verificabile, dagli stessi punzoni) si riesce a seguire la diffusione cheinteressa l’Italia peninsulare (Ischia, Neapolis, già menzionate, e Tarquinia: Serra Ridgway 1996, p. 65, n. 3,tav. xliv, 50.3 e cxxxii, 3), la Sicilia (Monte Iato: Isler 1980, p. 1220, n. 11; Lilibeo: Brugnone 1986, p. 104, n.4, tav. xxii, 4), la Gallia (Ensérune: Jannoray 1955, p. 450; Lattes: 2001, p. 70, n. 329, da un contesto del 175-150), la Spagna (Mas Castellar-Pontós; Ampurias: García Sánchez 1999, p. 237, n. 32, v. anche Nolla - Nie-to 1989, p. 389, fig. 3, 6; Sagunto: scavo della Plaza de Armas del Castillo: Aranegui Gascó 1995, p. 253, fig.9, da uno strato datato al primo terzo del ii secolo) e la Cirenaica (Berenice/Benghazi: Riley 1979, p. 140,d67; fig. 71 e tav. xxv). Occorrerà verificare sulla base dello stile e dei punzoni se altri bolli che sembrano ri-portare lo stesso nome in forma più estesa, ACK§H¶IA[- - -?] da Erice (Pellegrini 1887, nn. 578, 582) e daHeraclea Minoa (De Miro 1958, p. 283, n. 27, fig. 50), possano essere attribuiti allo stesso personaggio, comeritengo verosimile.Una decina di bolli in greco sono ancora attestati sulle Dressel 1 (nel relitto di Riou 3 enello scarico di Sellia Marina, loc. Chiaro, prov. Catanzaro (v. oltre, p. 47, nota 3 e p. 53); in osco è la serie aduna e a due lettere delle Dressel 1A del relitto di Spargi datato intorno al 100 (Lamboglia 1961; Pallarés1975-1981; Tchernia 1990, pp. 198-199; per i bolli Poli 2004).
1 cil i2 3514; Benoit 1961, p. 38, fig. 34 (nave diretta ad Olbia di Provenza come dimostrebbe un altroesemplare da questo sito). Anfore timbrate Q.IVENTI, da attribuire probabilmente ad uno dei due perso-naggi menzionati al Grand Congloué 1 o con un loro discendente (Van der Mersh 2001, pp. 196-197, s.v.)sono diffuse in Sicilia (Erice, Trapani, Messina: per quest’ultimo ritovamento, v. Bonanno 1997-1998, pp.405-406, fig. 3a), ma anche a Taranto, e ad Elis in Grecia. Sulla famiglia, di origine tuscolana (Iuventii Thal-nae), presente sulla scena politico-militare romana negli anni a cui è attribuito il relitto, v. Salomies 1996.
2 Benquet 2007. Le grecoitaliche sono documentate con decine di esemplari in numerosi pozzi di Tou-louse e di Vieille-Toulouse, con tipi che illustrano l’evoluzione morfologica di queste anfore dal 180 al140/120. Di un certo interesse sono le iscrizioni dipinte (una trentina) in caratterei iberici presenti su questilotti. Esse contengono un nome seguito da un numero (Vidal - Magnol 1983). I personaggi menzionatispetterebbero ai commercianti (Tchernia 1999; Tolosa, pp. 194-197; Briquel Chatonnet - Hesnard - Pol-let 2004, p. 199) o ai destinatari (Gorgues - Long - Rico 2004, p. 41), i cui nomi sarebbero trascritti in iberi-co per essere compresi da interlocutori che usavano questa lingua. I tituli sarebbero stati apposti, secondole ipotesi finora formulate, nell’insediamento che precede Narbo, cioè Naro, identificata con Montlaurès, oa Emporiae/Ampurias, se questi sono i porti di sbarco, o in Italia, cioè nel porto di partenza (il Lazio per Bri-quel Chatonnet - Hesnard - Pollet 2004, loc. cit.). Varie sono anche le ipotesi che riguardano gli oriz-zonti etnici (italici, iberici, celtici), a cui l’onomastica dei tituli rinvia: tutti italici per Tchernia 1999; alme-no cinque italici per C. Domergue et alii, in Tolosa, pp. 195-196. Per l’uso dell’iberico come lingua delcommercio interregionale sul litorale del Languedoc occidentale ad Ovest dell’Herault, v. Vidal - Magnol1983. In iberico sono anche i tituli di alcune grecoitaliche del Pech Maho.
3 Lamour - Mayet 1980, n. 2; da datare probabilmente prima del 123, che segna l’abbandono dell’oppi-dum.
4 Aranegui Gascó 2002, pp. 410-411, fig. 2; letto LVKAON dagli editori precedenti; da datare quasi cer-tamente ante 146 (sua ansa, L a uncino, A con barretta mediana spezzata). Nella tomba vi era infatti ancheun’anfora rodia e un esemplare vicino alla Dressel 26 prodotta in Tunisia (o in Tripolitania) con bollo sulcollo a lettere incavate MA°øN, ben documentato su anfore di questa stessa forma a Cartagine prima del-la distruzione della città e in centri dell’estremo occidente (Baleari, Spagna) (Aranegui Gascó 2002, conbibliografia). L’uso del greco su contenitori provenienti da aree ove si parlava e scriveva in altra lingua, nonstupisce, anche in un caso come questo in cui l’officinator, visto il diffusissimo nome Magon, era certamen-te un punico. L’associazione lingua/luogo di origine non è perciò mai un indicatore sicuro di provenienzadell’oggetto (v. oltre, p. 47, nota 3).
42 clementina panella
unità su una quarantina di bolli onomastici, compaiano sia nomi individuali,1 in alcunicasi, per esempio quelli grecanici, certamente servili,2 sia, più raramente, sigle alfabe-tiche di una o due lettere già documentate in maniera assai modesta sulle grecoitalichedel iii secolo.3 Qualora vi fosse realmente un qualche significato cronologico nella pre-senza di bolli con nomi individuali, si potrebbe supporre che essa rifletta la crescita del-la manodopera schiavile nelle campagne, ma anche il raggiungimento, allo scorciodella produzione delle grecoitaliche, di una certa autonomia di questo tipo di mae-stranze nella gestione delle officine ceramiche collegate ai fundi,4 secondo i precetti ca-toniani. Inoltre, dopo gli inizi del ii secolo, cioè dopo la documentazione offerta dalleanfore del Grand Congloué 1, ci sembra che ci sia un vuoto di dati epigrafici, come sela bollatura tacesse per qualche tempo, per ricomparire alla fine del periodo su tipi ge-neralmente al limite tra le grecoitaliche e le Dressel 1A. Tuttavia dietro questi due fe-nomeni potrebbe anche scorgersi la volontà dei proprietari, dalle cui campagne pro-veniva il vino da imbottigliare e a cui le officine facevano capo, di non comparire, alcontrario di quanto avveniva nel iii secolo o di “nascondersi” dietro i servi (effetto delplebiscito del 218?).5 Ma bisognerebbe dimostrare una presenza significativa della nobi-litas sui bolli del iii secolo, cosa che sfortunatamente non è possibile.6 La posizione so-ciale dei personaggi testimoniati dai bolli di quest’età non è definibile: mancano cioèriferimenti accertati a personaggi di condizione o di status particolarmente elevati, alcontrario di quanto avverrà in altri momenti della timbratura delle anfore italiche. Co-munque vadano interpretati questi dati, non vi è dubbio che nella prima metà del iisecolo i documenti disponibili siano riferibili in gran parte a nomi individuali o a bol-li ad una o due lettere. Si rileva altresì una diminuzione in termini quantitativi dellabollatura che va vista non tanto in rapporto al materiale bollato della fase precedente,che era altrettanto scarso, quanto in rapporto all’aumento percepibile delle presenzecomplessive delle anfore di questa forma nei diversi comparti territoriali. I bolli no-minali scompaiono d’altro canto quasi del tutto anche dalla ceramica fine da mensadopo la ii Punica:7 completamente anonima è la produzione di massa della CampanaA del ii secolo (con la conseguenza di ignorare completamente gli attori di questa stra-ordinaria attività artigianale: Morel 2008, p. 169); anonima diventa un’altra classe di
1 L’affermazione nasce da valutazioni in absentia: nessun bollo riferibile a cognomina è sicuramente databile al iii secolo.
2 V. i bolli delle grecoitaliche di Albinia con i nomi di Aias, Apel(- - -), Apol(- - -), Arme(- - -), Mahe, Nicia, Sotic(us) (Laubenheimer 2007, pp. 67-72), il bollo di Surus dai pozzi di Vieille-Toulouse del 180-130 (Vidal -Magnol 1983, p. 3, n. 36; p. 4, n. 18), i bolli AL, DEC, EVD, SAL del relitto di La Ciotat A (Bouches-du- Rhone)del secondo quarto del ii secolo (Benoit 1958, pp. 23-25). Pur essendo possibile sciogliere queste ultime abbreviazioni con dei gentilizi, l’ipotesi che si tratti invece di nomi individuali nasce dal fatto che, apparte-nendo allo stesso carico, i bolli facciano parte di un medesimo lotto e si riferiscano pertanto ai lavoranti enon al proprietario della manifattura.
3 Una o due lettere compaiono tra i bolli di altri contenitori (di Corinto, di Corcira, di Marsiglia) e sa-ranno frequenti anche sulle anfore italiche. Ci si è a lungo interrogati sul loro significato nel processo pro-duttivo: per le anfore di Marsiglia Bertucchi 1992, pp. 166-172 assegna a tali sigle un significato temporale(ogni lettera corrisponderebbe ad un anno); per le anfore italiche (in particolare per le Dressel 1 di Albinia)rimando all’analisi di Olmer 2003, pp. 151-157, figg. 15-23; pp. 335-338, che ritiene che le lettere dell’alfabeto(timbres “codés”) indichino i luoghi (il posto o l’unità di lavoro) o il ritmo della produzione delle anfore.
4 Certamente attive anche prima di questa data, v. i bolli con nomi servili sulla ceramica di Cales del iiisecolo: Morel 1983, p. 22-24; Pedroni 2001, pp. 109-116. 5 Pedroni 2001, pp. 105-106.
6 Pucci 1993, pp. 73-74. 7 Tutta la problematica è trattata da Morel 1983, p. 25 sgg.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 43
vasellame a vernice nera, quella di Cales, sulla quale la bollatura aveva avuto una cer-ta consistenza fino alla fine del iii secolo per riapparire solo alla metà del i secolo incontemporanea con la bollatura della sigillata italica.1
Si è detto che a questo periodo appartiene il relitto del Grand Congloué 1, nel qua-le la ceramica da mensa (Campana A) rappresenta realmente una merce d’accompa-gno. Ma questo è anche il momento in cui, essendo abbastanza consistente il ritrova-mento di questo tipo di giacimenti (diciassette quelli registrati tra il 200 e il 150 daCibecchini 2004, p. 63, una cifra sottostimata e certamente destinata a salire), è possi-bile riscontrare più nel dettaglio un fenomeno che certamente è sempre esistito, mache ora acquista maggiore visibilità: quello dei carichi “misti”. Va notato infatti chese le principali officine di ceramica fine sono per ovvie ragioni quasi sempre urbane(l’eccezione è rappresentata da quelle della sigillata sudgallica), essendo le città il pun-to di riferimento principale per il loro consumo, diversa collocazione hanno le forna-ci di anfore, collegate ai fondi da cui le derrate da trasportare provengono e soprat-tutto ai luoghi che garantiscono l’accessibilità alle materie prime (argilla, acqua,boschi) e la trasferibilità dei prodotti (naturalmente preferite le coste e le zone lungoi fiumi). Nei casi in cui il vasellame da mensa è di fatto una merce di complemento,occorre prevedere dei porti-emporio, accessibili alle grandi navi o raggiungibili at-traverso una navigazione di cabotaggio, dove vasellame, contenitori da trasporto, lu-cerne, metalli lavorati, macine, coloranti, profumi e altri oggetti (ad esempio i pre-giati panni di lana) possano essere stati ammassati ed imbarcati per proseguire versoaltre mete. Pozzuoli, Marsiglia, Ampurias, Cartagine, Ibiza, Cadice hanno svolto cer-tamente la funzione di entrepôts e di centri di ridistribuzione e smistamento a secon-da della destinazione delle merci. Lungo le rotte, le soste potevano significare sbarcoed imbarco di partite di altri e diversificati materiali, vere e proprie rotture di caricoo, nel caso dei soli scali tecnici, scambi di piccola entità. Le reti di distribuzione se-condarie possono essere suggerite tra l’altro dalle dimensioni delle imbarcazioni (bar-che piccole per la ridistribuzione e il cabotaggio, grandi navi per i lunghi percorsi tran-smarini) e dalla dimensione delle istallazioni portuali.2 La molteplicità delle variabiliindica la difficoltà che incontra l’archeologia subacquea quando tenta di individuareattraverso l’analisi dei “commerci interrotti” la provenienza dei singoli lotti di mercee le loro destinazioni.3 F. Cibecchini immagina l’esistenza nella prima metà del ii se-colo di percorsi con pochi scali e pochi rilasci.4 C’è un ragionamento rigoroso in que-sta ricostruzione, ma la realtà, proprio sulla base dei dati da lei raccolti, potrebbe es-sere stata molto più complessa.5 È vero tuttavia che la formazione dei convogli, le
1 Pedroni 2001, pp. 81-86.2 In questa direzione vanno per esempio le ricerche di Cibecchini 2008 sul tonnellaggio e le dimen-
sioni dei relitti, e quelle di Pérez Ballester 2003, tese a stabilire nel País Valenciano una gerarchia di por-ti (porti principali, secondari, approdi) sulla base delle strutture portuali o di immagazzinamento conser-vate e una gerarchia degli itinerari (da porto principale a porto secondario, da porto secondario a portosecondario) (Pérez Ballester 2003, fig. a p. 120). Una discussione sui carichi “misti” dei relitti e sui pro-blemi della loro interpretazione è in Morel 1998b, pp. 491-496.
3 Panella 1998, p. 547; Morel 1998b, pp. 491-496.4 Cibecchini 2008, pp. 495-496. Morel 1998b, loc. cit. alla nota precedente, parla invece di “frecce spez-
zate”, di “itinerari non lineari”.5 Si pensi alle informazioni fornite dal relitto Chrétienne M2 tra Cannes e Saint-Raphaël, che probabil-
mente trasportava Dressel 1A e Dressel 1C, anfore puniche del tipo Mañá C2 e Campana B. Il suo armato-
44 clementina panella
principali rotture di carico e le ridistribuzioni di vasellame ed anfore dovevano avve-nire in quest’età nei grandi centri portuali menzionati sopra. J.-P. Morel aveva già sup-posto, sulla base della scarsa presenza di grecoitaliche a Cartagine rispetto alle cera-miche a vernice nera, che la città fosse un punto obbligato, ma di solo passaggio peril vino italico diretto in Spagna (v. Appendice ii).
Periodo iv (150/125 - età augustea). L’ultima cesura (ceramica a vernice nera ed an-fore) si colloca intorno al 150 (o in epoca graccana?) e si concretizza nella “concor-renza” sui siti del Mediterraneo tra Campana A, Campana B etrusca (dell’Etruria set-tentrionale: Volterra, Arezzo, Cosa) e Campana B di Cales,1 nella razionalizzazionedel commercio con una preponderanza accresciuta di quello vinario, ora affidato al-le Dressel 1 e alla Lamboglia 2. La ceramica da mensa continua ad essere una mercedi accompagno nei lunghi tragitti transamarini; manodopera a buon mercato (schia-vi), metalli grezzi, derrate di base costituiscono i carichi di “ritorno”, benché questaespressione abbia poco senso in un contesto in cui i trasporti sono circolari e si iscri-vono “nell’ambito di una vasta rete commerciale con merci, percorsi, scali e redistri-buzioni economicamente complementari”.2 La diffusione delle produzioni del ver-sante tirrenico si concentra ad Ovest: lo spartiacque con quella dell’Adriatico passalungo la dorsale appenninica e sullo Ionio in direzione della Sirte (Berenice).3 Una de-cina di relitti con grecoitaliche può essere assegnata ancora alla metà/terzo quartodel ii secolo.4 In quegli stessi anni, come dimostra la documentazione di Cartagine(certamente ante 149) spesso revocata in dubbio, di Numantia (distrutta nel 133)5 e diValentia (negli strati di fondazione del 138)6 e come attestano i tituli picti con data con-solare,7 alcune officine avevano già modificato il “disegno” delle anfore, passando al-
re, attestato sul ceppo dell’ancora, è scritto in alfabeto neopunico, Abdamon. La presenza di iscrizioni chesembrano scorgersi sui reperti (bolli su tappi, iscrizioni dipinte sulle anfore, graffiti sulla ceramica) fareb-bero pensare, che accanto ad un proprietario di nave di origine fenicio-punica, l’equipaggio fosse misto (pu-nici, latini, greci). Essi trafficavano con merci italiche (Dressel 1, ceramica Campana) e puniche (Mañá C2).La nave potrebbe essere originaria della Mauretania (le Mañá C2 sarebbero prodotte a Kouass, in Maroc-co), ma doveva essere partita dalle coste dell’Italia ed era naufragata prima della sua destinazione in Nar-bonese intorno al primo quarto del i secolo (Briquel Chatonnet - Hesnard - Pollet 2004).
1 Un tentativo di rendere omogenee le tante denominazioni della Campana B e delle produzioni chia-mate B-iodi e della “Cerchia della B” è in Cibecchini-Principal 2004, con bibliografia.
2 Gianfrotta 2007b, p. 68.3 L’Oriente e l’Occidente “si voltano le spalle”: questa è l’espressione usata da Morel 1998b, pp. 513-516,
sia in riferimento alla ceramica fine che alle anfore, ma nel frattempo viaggiano da Est verso Ovest schiavi,marmi, sculture, artisti e filosofi e da Ovest verso Est amministratori e pubblicani, negotiatores e mercanti,soldati.
4 Cibecchini 2004, p. 63. 5 Sanmartí 1985 e 1992.6 Ribera i Lacomba - Marín Jordá 2003. Rispetto alle stratigrafie di Cartagine anteriori al 146, qui è
già netta la prevalenza delle Dressel 1A rispetto alle anfore grecoitaliche, alle Tripolitane antiche e alle an-fore puniche
7 Venticinque sono i tituli picti con data consolare raccolti da Pérez Ballestrer 1995. Ad essi vanno aggiunti almeno un titulus su una Dressel 1A da Iesso (Guissona, Lérida: Guitart - Pera - Carreras 1998,p. 42, fig. 8), con data consolare del 121 o del 116 e un altro da Malta, recentemente pubblicato, che riporta probabilmente il consolato di C. Cassius Longinus e C. Sextius Calvinus del 124 (Bruno 2004, p. 141, fig. 36, 1).Le più antiche date che servono per fissare la cronologia iniziale delle Dressel 1 sono: il 129 su una Dressel1A di Rodez (Aveyron), forse riportato anche su un titulus di Roma (Castro Pretorio): cil xv, 4596 (per entrambe le iscrizioni v. Pérez Ballester 1995, p. 182), e il 124 sulla Dressel 1A di Malta già citata.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 45
la produzione di contenitori più solidi e standardizzati (Dressel 1 e Lamboglia 2). Infine, dal secondo quarto del i secolo è attestata nelle fornaci tirreniche l’adozionedi un nuovo modello, derivato dall’anfora di Cos, destinato ad avere successo in etàaugustea.
Si è parlato di “concorrenza” a proposito degli ateliers che producono e diffondonosu scala mediterranea a partire dalla metà del ii secolo vasellame fine da mensa a ver-nice nera. In realtà ciascuna delle tre classi menzionate sopra ha sua una peculiare col-locazione sui mercati della penisola e del Mediterraneo occidentale, che dipende dauna serie di fattori, tra i quali certamente ha contato, sia per le direzioni dei flussi, siaper l’intensità dello smercio, l’ubicazione dei centri produttori. Le fabbriche dellaCampana A erano situate in prossimità del porto di Neapolis, quindi con diretto sboc-co al mare, quelle della Campana B (sia etrusca che calena) erano nell’entroterra, pre-supponevano cioè un primo trasporto per via di terra fino a porti di imbarco (Pisa,Cosa per la Campana B etrusca, Volturnum per la Campana B calena).1 Una pregressae lunga tradizione artigianale giustifica queste scelte locazionali, che sembrano agliocchi dei moderni, antieconomiche. Significativo è a questo proposito il caso di Arez-zo, ancora più lontana dal mare di Cales o Volterra, che è riuscita ad esportare i suoivasi a vernice nera fino al Magdalensberg (un oppidum della attuale Carinzia, attivoper circa un secolo fino al 45 d.C.) e che ha continuato a produrre ceramica, la sigil-lata aretina, ancora per due secoli e a diffonderla in quantità pari, se non superiori aquelli della Campana A. La posizione delle officine spiega in parte la limitata diffu-sione della Campana B etrusca sui mercati mediterranei, che fa tuttavia da pendant aduna sua più estesa presenza nelle regioni centrali interne, al contrario di quanto ac-cade alla ceramica di Neapolis, come se, nel caso di quest’ultima, la vicinanza del ma-re avesse inibito la ricerca di mercati nell’entroterra. La ceramica di Cales ha una cir-colazione mista: si trova nelle regioni interne della penisola, ma ha anche unarilevante diffusione marittima, nonostante non avesse, come la Campana A, meritiparticolari. Infine, benché la circolazione della Campana B etrusca sia stata molto in-feriore a quella delle altre due classi, a documentarne il successo vi sono le numero-se imitazioni (o le succursali), come avverrà per la sigillata aretina.2 Sulla diversa “ac-coglienza” poi di queste ceramiche nei siti di consumo del Mediterraneo occidentale(esportazione “diretta” della Campana A verso Marsiglia ed Ampurias; Campana Betrusca prevalentemente a Cartagine e nella penisola Iberica, ma assente a Marsiglia;Campana B calena ben attestata a Cartagine fino al 146 e nella penisola Iberica – Car-tagena, Tarragona, Ampurias, Valencia – ove supera tra la fine del ii e gli inizi del I se-colo la Campana A, ma quasi assente in Gallia fino all’ultimo quarto del ii secolo), sirimanda alla recente analisi di F. Cibecchini, che riconferma attraverso l’incrocio deidati dei siti terrestri e dei relitti gli stretti legami, che persistono fino alla metà del I se-colo, tra Neapolis e Marsiglia, un asse diretto tra le due città greche, su cui aveva giàposto l’accento J.-P. Morel. La rotta sarebbe quella settentrionale che dall’arcipelagoToscano e dal Capo Corso si dirigeva verso la Provenza riguadagnando la costa all’al-tezza di Nizza e di qui a Marsiglia. La verifica della diffusione della Campana B di Ca-les prevalentemente esportata in Nord-Africa e in Spagna, consente di verificare l’im-
1 Pedroni 2001, pp. 326-330.2 Su questi temi si rimanda a Morel 1998b, pp. 499-503, 511 ss.; Morel 2005, pp. 105-106.
46 clementina panella
portanza di una seconda rotta, sempre settentrionale che, attraversato l’arcipelagoToscano, tagliava il Golfo del Leone in direzione di Ampurias, che ridistribuiva le mer-ci sia a Sud nella sua zona di influenza, sia nel Languedoc-Roussillon prima della fon-dazione di Narbona. Una terza rotta meridionale aveva infine come punto di arrivo edi ridistribuzione Cartagine (fino alla sua distruzione) o Cartago Nova, a sua volta ri-distributrice nei centri sotto la sua influenza, fino a Cadice.1
Per quanto riguarda le anfore, a cui il vasellame da mensa a vernice nera è certa-mente associato nel trasporto transmarino, non riusciamo a seguire con altrettantaprecisione la direzione dei flussi, non essendo sempre noti i “punti partenza”, benchéall’interno del periodo sia evidente una crescita impressionante dei ritrovamenti inmare (v. p. 21) e nei siti terrestri.2 Fornaci, caratteristiche morfologiche, apparato epi-grafico e analisi di laboratorio consentono di cominciare ad avere un’idea delle zonedi smercio delle principali aree produttrici di anfore (sia tirreniche che adriatiche), lequali non hanno tuttavia rapporti diretti con le manifatture di ceramica fine a grandediffusione.3 Quest’ultima diventava, infatti, parte del carico nei porti, ove le mercan-zie venivano ammassate e distribuite a seconda delle destinazioni, primo tra tutti, perl’Occidente, quello di Pozzuoli. Inoltre, non vi è spesso unità di provenienza neppu-re per le anfore relative ad uno stesso imbarco. Non tenendo conto dei contenitori del-le più disparate provenienze presenti in uno stesso relitto (anfore italiche insieme adanfore greche o neopuniche), la timbratura dimostra che anche tra le Dressel 1 di unostesso carico esistono partite riportabili a diversi centri di produzione. Si veda il casodel relitto di Santa Severa della metà del i secolo4 con anfore bollate da un SVL (il Sul-
1 Cibecchini 2004, p. 63 sgg. 2 V. a questo proposito Olmer 2003; Benquet 2007.3 Valga per tutti l’esempio di Neapolis, ove le quantità delle Campana A non sono confrontabili con una
pur probabile produzione di Dressel 1 (dalla città o più genericamente all’area del golfo). Per Morel 1998b,p. 495, sarebbe neapolitano il carico del relitto di Riou 3, datato intorno al 100 con ceramica Campana A tar-da e Dressel 1 bollate ¶I, XAP (Long - Ximénès 1988). Anche il negotiator timbra in greco (bollo sul tappoin pozzolana di un §‡Î·ÈıÔ˜: Hesnard - Gianfrotta 1989, B.20; un greco di Massalia secondo Brun 2004,p. 216). Si tratterebbe cioè dell’attestazione più tarda di una produzione neapolitana che adotti ancora nelcommercio internazionale il greco, che continua ad essere scritto e parlato in questo centro fino ad età im-periale. Si segnala tuttavia che anche le Dressel 1 e le Dressel 2-4 di Sellia Marina/Chiaro nel Bruzio ionico,riferibili ad uno scarico di fornace (v. oltre, p. 53), presentano, oltre a numerosi bolli in latino, due bolli ingreco: ANTIOXOY, traslitterato anche in latino, e ¢IøN. Ciò a riprova che altri centri dell’Italia meridio-nale avevano conservato lingua e scrittura greca. Il bilinguismo è attestato anche nella timbratura delle anfore ovoidi più antiche di Apani, grosso modo coeve alle Dressel 1 di cui si sta discutendo (Palazzo - Sil-vestrini 2001). I nomi servili attestati su questa produzione appartengono al mondo grecofono medio-orientale (Manacorda 2003); la lingua madre cioè di questi personaggi è il greco. Sembrerebbe quindi chei bolli rispecchino l’individualità degli artigiani. Ma in greco, oltre che in latino, è anche il bollo del pro-prietario dell’officina, C. Aninius. Si è perciò ipotizzato che l’uso del greco avesse (anche o soltanto) una va-lenza commerciale, partendo dal presupposto che la destinazione prevalente di queste anfore era verso iporti egeo-orientali nei quali la lingua latina era marginale (Palazzo - Silvestrini 2001, pp. 91-100). A Brin-disi, tra l’altro, proprio per la sua funzione di porto d’imbarco e transito delle merci dirette in oriente, il bi-linguismo si manterrà a lungo. Va segnalato tuttavia che il binomio lingua/mercati non sempre funziona,almeno nei casi in cui le anfore brindisine timbrate in greco compaiono (benché sporadicamente) anche inOccidente e sulle coste atlantiche (ad esempio, il bollo di Heraios rinvenuto ad Olisipo/Lisbona: Pimenta2003, p. 39, fig. 13, 96; p. 112, tav. 18, 5). Il collegamento della lingua con i luoghi dello smercio non è al mo-mento ravvisabile per le Dressel 1 di Riou e di Sellia Marina, in quanto i bolli non hanno trovato confrontoin altri siti. Va tuttavia segnalato che le Dressel 1 sono assai rare in Oriente e che la nave naufragata a Riouera diretta a Marsiglia. E perché Magon (v. p. 44, nota 4) timbra in greco delle Dressel 26 prodotte nel Nord-Africa, che spedisce a Villaricos, in Spagna? 4 Gianfrotta 1982.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 47
picius Galba supposto da Manacorda 1989?, v. oltre) e dai suoi servi che potrebberospettare a Terracina, e quelle timbrate da P. Lentulus (Crus) P. f. che dovrebbero pro-venire da Minturno.
La bollatura diventa ora una pratica abbastanza diffusa nelle officine di entrambi iversanti della penisola e testimonia della comparsa in questi due ambiti geografici diun certo numero di personaggi, per i quali è possibile suggerire l’appartenenza a fa-miglie urbane di rango.1 I casi si riferiscono soprattutto all’ultimo secolo della repub-blica, ma non mancano esempi risalenti al secolo precedente. La documentazionespettante ai contenitori da trasporto tirrenici, già raccolta da D. Manacorda, può es-sere sinteticamente ripresa2 e integrata, ricordando che le identificazioni con indivi-dui conosciuti attraverso la prosopografia sono spesso ipotetiche a causa delle abbre-viazioni dei bolli e della diffusione dei gentilizi. Si tratta di M. Claudius (Marcellus),3 L.(Cornelius) Cinna, P. (Cornelius) Sulla,4 i Sestii, Cn. Pompeius Magnus (v. oltre, pp. 63-64,nota 5), P. (Cornelius) Lentulus (Crus) (v. sopra), i Sul(picii) (Galbae?), Q. Ovinius, Ti Clau-dius (Nero?),5 M. Lollius Q. f.6
Questo elenco può dare l’impressione che siano stati solo i senatori implicati nel-le attività produttive ed imprenditoriali di quest’età. In realtà i casi citati costitui-scono un esiguo gruppo rispetto all’intero corpus dell’instrumentum, ove predomi-nano nomi che rinviano a personaggi di status civile generalmente libero ma diignota estrazione sociale,7 e soprattutto nomi individuali riportabili a servi, talvol-ta associati tra loro (nello stesso bollo o in due marchi distinti),8 talaltra associati alnome del dominus, com’è il caso dei servi P. Veveius Papus nel carico della nave diGiens presso Marsiglia,9 le cui officine di Dressel 1 e di Dressel 2-4 spettano a Fon-di,10 o di Tarula, servo e poi liberto di L. Cornelius Sulla (il dittatore), sulle anforeovoidi di Apani nel Brindisino.11 Da altrettanto pochi riscontri si ricava l’impressio-ne che non vi sia stata distinzione di comportamenti tra senatori e equites, quali so-no ad esempio M. Tuccius Galeo, che timbra anfore ovoidi del relitto di Planier 3 del-la metà del i secolo,12 o Postumus Curtius, documentato su Dressel 2-4, anforeovoidi(?), Lamboglia 2 tirreniche (piuttosto che Dressel 1) e Dressel 21-22,13 se è daidentificare con il C. Rabirius Postumus, cliente di Cicerone (Pro Rabirio), finanziato-re di Tolomeo Aulete e suo ministro delle finanze, le cui officine, attive anch’esseprobabilmente nel secondo quarto del i secolo (ante 64 o 53), sono da collocare inCampania e/o in territori del Tirreno meridionale (bolli su tegola a Paestum e su te-
1 Per le testimonianze di personaggi eminenti nell’epigrafia delle anfore adriatiche v. Appendice iii.2 Manacorda 1989, pp. 451-457, con bibliografia. 3 rtar ii, 523.4 Nipote del dittatore L. Cornelio Silla, deductor della colonia di Pompei nell’80, console designato nel
65, morto nel 47: Shatzman 1975, p. 336, n. 133; Zevi 1995, p. 16.5 Nonnis 2003, pp. 271-272.6 rtar ii, pp. 308-310. 7 Nonnis 2003, pp. 250-251.8 Il doppio bollo di servi è assai frequente sulle anfore del Brindisino: da ultimo Manacorda 2003.9 Per il relitto, v. Tchernia - Pomey - Hesnard 1978; per le fornaci, Hesnard 1977.10 Hesnard 1977.11 Fonti e bibliografia sul personaggio (tra i pessumi servorum di Silla) e sulle anfore che portano impres-
so il suo nome in Manacorda 1985, p. 147; Manacorda 1989, p. 458.12 Tchernia 1968-1970; sul personaggio e sulla localizzazione dell’officina – ora collocata nella valle del
Liri – Scardozzi 2007, con bibliografia completa.13 Si tratta di un non raro caso di officina “polivalente”.
48 clementina panella
gola e su Dressel 2-4 a Iulia Blanda/Tortora, prov. Cosenza),1 o P. Vedius Pollio, ami-co di Augusto e di Erode il Grande, che timbra anfore vinarie di Cos rinvenute aCartagine e di Chio rinvenute a Masada, Samaria, Herodium,2 e le cui ingenti ric-chezze immobiliari (domus sull’Esquilino, villa a Posillipo) e patrimoniali (nel Bene-ventano e probabilmente in Lucania settentrionale – Masseria Cicciotti e San Gillo– e nelle isole greche) finirono alla sua morte tutte o in parte nelle mani dell’im-peratore.3 È documentabile in sostanza nella tarda repubblica una visione unitariadei due ordines, che identificava la base principale del potere politico, economico esociale nella proprietà terriera.4
In un’ottica simile si muovono i rappresentanti delle aristocrazie municipali, a cuiappartiene ad esempio L. Eumachius, che bolla Dressel 2-4 pompeiane, padre di Eumachia L. f. sacerdos publica, nota per la dedica nel Foro della città vesuviana delpiù imponente monumento di età augustea (il c.d. Edificio di Eumachia) e per ilgrandioso sepolcro fuori Porta Nocera.5 Con tutta la prudenza dovuta all’insidiosi-tà delle identificazioni collegate all’onomastica, sembra tuttavia di poter affermareche le aristocrazie municipali, quando cominciano chiaramente ad emergere nellefonti e nella documentazione dell’instrumentum (soprattutto in età tardo-repubbli-cana e dopo la guerra sociale) sembrano implicate soprattutto nelle manifatture(dalla produzione laterizia a quella tessile e metallurgica) e nel commercio.6 In al-cuni casi le fonti letterarie e l’epigrafia lapidaria consentono di verificare come que-ste attività siano servite a porre le premesse per la loro ascesa politica e sociale.7 Inaltri casi è possibile documentare il collegamento, mediato attraverso l’amicizia e laclientela, tra i domini, a cui spetta in linea di massima il contenuto delle anfore, egli equites e i ceti italici coincidenti con i gruppi dirigenti locali, come attesterebbe-
1 Tchernia 1986, p. 117, nota 234; Manacorda 1989, p. 451, nota 32; Bezeczky 2004, p. 86, con biblio-grafia; Zevi 2005, pp. 825-826; per i ritrovamenti di Tortora/Blanda Iulia, nel Bruzio tirrenico, v. Sangine-to 2001, pp. 208-209; La Torre 2003, pp. 56-62. V. anche oltre, p. 53.
2 Tchernia 1969b; Freed - Moore 1996; Finkielsztejn 2005.3 Biografia del personaggio e bibliografia in Adamo Muscettola 1996; Gualtieri 2000, pp. 332-334;
Gualtieri 2001; Finkielsztejn 2005. 4 Manacorda 1989; Andreau 1999.5 Sull’origine della famiglia e su questi personaggi si rimanda a Zevi 1995, pp. 11, 17-18 e a Torelli 2000,
p. 316.6 Un’ampia esemplificazione del coinvolgimento nella manifattura e nel commercio di personaggi ri-
collegabili su base prosopografica alle famiglie più eminenti di Pompei, Aquileia, Preneste è in Nonnis 1999.7 La promozione sociale delle attività mercantili è con un certo margine di sicurezza riscontrabile nel
lungo periodo per gli Eumachii già citati e per i Lassii pompeiani. M. e C. Lassii timbrano in osco i copritap-pi in pozzolana delle Dressel 1 del relitto della Chrétienne A presso Agay/Anthéor (Saint-Raphaël, Var: He-snard - Gianfrotta 1989, B.16, con bibliografia), forse anteriore all’80. È interessante notare che l’attivitàimprenditoriale di queste due famiglie fu affidata in seguito a liberti: L. Eumachius Eros che bolla laterizi e aC. Lassius Afer, il cui nome compare su un titulus pictus di una Dressel 2-4 da Saint-Romain-en-Gal pressoVienne (Desbat - Lequement - Liou 1987, p. 162, fig. 10). Vanno segnalate anche le assenze. Nessuna tracciasulle anfore dei ricchi mercanti e armatori puteolani del i secolo menzionati da Cicerone: l’armatore e mer-cator P. Granius, a cui Verre sequestra navi e merci (Cic., Verr., ii, 5, 154), o gli Avianii (C. Avianius Flaccus e ifigli C. e M. Avianii), noti dall’epistolario ciceroniano (RE, ii, 2, cc. 2372-2373, nn. 2, 3, 6, s.v.), cui era affidataalla metà del i secolo una quota considerevole dei rifornimenti granari di Roma (Nonnis 2003, pp. 265-266).Si ricorda a questo proposito il noto passo del De Officiis (1, 151) di Cicerone: «Se la mercatura è piccola èspregevole. Se invece è grande e abbondante e importa molte cose da ogni luogo, approviggionando senzafrode molta gente, non deve essere tanto disprezzata; e quando essa, sazia di guadagno o più semplicementesoddisfatta, come accade spesso, si trasferisce dall’alto mare nel porto o dal porto stesso in possedimentiagricoli, può a buon diritto essere lodata».
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 49
ro i personaggi addetti al commercio di quegli stessi beni presenti su altri tipi diiscrizioni anforarie.1
Alla sfera del commercio rimandano, infatti, i tituli picti, i bolli sui copritappi in poz-zolana, i bolli sui ceppi delle ancore. Le anfore e i relitti della tarda repubblica evi-denziano differenze di prestazioni e di rango sociale tra coloro che costituivano il tra-mite tra domanda ed offerta, siano essi mercatores o negotiatores e navicularii.2 Leiscrizioni dipinte delle anfore e le iscrizioni impresse sulla pozzolana dei tappi (so-prattutto delle Dressel 1) si riferiscono solitamente ai commercianti, molti dei quali sidichiarano liberti, altri possono essere verosimilmente identificati con famiglie del-l’ordo municipale, come in via di ipotesi si è pensato per Sex. Arrius M. f., il cui nomecompare sui bolli dei tappi delle Dressel 1 al Dramont A,3 per L. Titius C. f., che tim-bra i tappi delle Dressel 1 di Sestius del Grand Congloué 2,4 per C. Sornatius C. f., unhomo novus di origine picena, il cui nome è attestato a Giulianova sul bollo di un tap-po di un’anfora non identificata (forse una Lamboglia 2).5
I bolli sui ceppi delle ancore identificano invece gli armatori, i proprietari di navi,che risultano normalmente ingenui.6 Nella documentazione fornita da anfore ed an-core negotiatores e navicularii appaiono in linea di massima distinti, così come non esi-ste quasi mai sovrapposizione o identità tra i nomi dei navicularii e quelli dei presu-mibili proprietari terrieri (ma per Ulpiano, in Dig. 33.7.12.1, le navi sono parteintegrante dell’instrumentum fundi). Tra le poche eccezioni a questa che appare quasiuna regola, si segnala il caso di Sex. Arrius M. f., il cui nome è impresso anche sui cep-pi d’ancora della nave naufragata a Dramont,7 costituendo l’unica attestazione fino-ra nota di un personaggio che è contemporaneamente commerciante e armatore.8Un caso altrettanto raro di coincidenza tra produttore di vino, produttore di anfore earmatore potrebbe essere quello di L. Cornelius P. f. Lentulus Crus, se fosse da identifi-care con il console del 49 a.C. il Lentulo ricordato da Cicerone come proprietario dinavi da carico (ad Att., 1, 8, 2 e 1, 9, 2). Verosimile è l’ipotesi di D. Nonnis che intrave-de nel bollo di Ti. Claudius Ti. f. sul copritappo in pozzolana di una Dressel 1 trovatanelle acque di Foce Verde a sud della foce dell’Astura, datata alla metà del i secolo, unmembro della famiglia dei Claudii Nerones (il padre di Tiberio?), che entrerebbe nelnovero dei senatori implicati nella commercializzazione del vino dei propri fondi (v.
1 Gli intrecci tra proprietà fondiaria e mercatura affidata a servi, liberti, e membri dei gruppi dirigentiitalici da parte dell’aristocrazia urbana sono stati esaminati da Manacorda 1989, p. 461; v. anche Nonnis2003.
2 Sulle differenze e sulle modificazioni di status tra le principali categorie di addetti al commercio nelcorso del tempo, rimando ad Andreau 2003, pp. 221-227 (fonti e bibliografia). Gli stereotipi sulla mercatu-ra proposti dagli scrittori antichi sono utilizzati da Giardina 1989 per tracciare un quadro della mentalitàcon la quale i ceti, che quelle fonti hanno prodotto, hanno guardato alle figure che esercitavano tale attivi-tà. V. oltre, pp. 74-75. 3 Hesnard - Gianfrotta 1989, B.6.
4 Hesnard - Gianfrotta 1989, B.36. Il nome di questo personaggio è da identificare anche su alcuni tap-pi di Lione trovati insieme a Dressel 1C probabilmente campane e ora su un esemplare di Carthago Nova(Gianfrotta 1998, p. 106). La cronologia è la fine del ii/inizi del i secolo.
5 Hesnard - Gianfrotta 1989, B.33; Manacorda 1989, p. 461, con bibliografia.6 Hesnard - Gianfrotta 1989; Manacorda 1989, pp. 460-461; Gianfrotta 1994 e 1998.7 Hesnard - Gianfrotta 1989, A.8.8 Un M. Arrius, certamente un suo discendente, timbra tra la fine della repubblica e gli inizi dell’età im-
periale laterizi documentati in area campana (presenti anche a Fondi): da ultimo Di Fazio 2004, p. 206.
50 clementina panella
sopra, p. 48, nota 5). Questo sembra essere anche il caso del C. Sornatius già menzio-nato, se il personaggio fosse da identificare con l’omonimo legato di Lucullo in Asiatra il 74 e il 68, implicato nel commercio degli schiavi ad Akmonia in Frigia,1 secondoquel binomio che sembra potersi istituire tra il commercio di vino e il commercio dischiavi, indissolubilmente connesso ai traffici della tarda età repubblicana, come sem-bra di potersi supporre per altri personaggi documentati sui tappi delle Dressel 1, co-me A. Saufeius del relitto di Ponza C nella “Secca dei mattoni” degli inizi del i secolo2e C. Raecius del relitto di Escombreras 2,3 epigraficamente collegati al mercato di De-lo, appartenenti entrambi a gentes di rango.4
Terre, ville, officine di anfore e navi sono attestate per i Sestii. Tre sono i personaggiprosopograficamente noti della famiglia,5 L. Sestius P. f. Albinianus (o Albanianus) Qui-rinalis, console suffetto del 23, è il probabile dominus della villa sul poggio di Settefi-nestre, mentre il proprietario della manifattura del portus Cosanus sarebbe per D. Ma-nacorda il padre, P. Sestius L. f. Collina, soprannominato Cosanus a causa dei suoirapporti con Cosa. Difeso da Cicerone nel 56 (Pro Sestio), ebbe parte attiva nella tor-mentata vita politica della metà del I secolo. J. D’Arms aveva pensato invece al padredi quest’ultimo, cioè a L. Sestius, tribuno della plebe tra il 100 e il 90, che aveva decisodi abbandonare la vita pubblica per dedicarsi ad attività più redditizie.6 La mia anali-si della documentazione delle Dressel 1 bollate SES e dei contesti di ritrovamento miha portato alla medesima conclusione, almeno per una parte delle anfore così tim-brate, che sembra oggi di dover collocare alla fine del ii/inizi del i secolo. Ciò nonesclude una continuità produttiva delle fornaci nei decenni successivi. Resta invece ildubbio, sulla base del rinvenimento di Skerki Bank, che l’impianto che usa un mar-chio analogo, abbia cominciato a funzionare già alla fine del iii secolo o agli inizi delii secolo (v. sopra, pp. 39-40). Proprietario di navi sarebbe nel 44 a.C. anche uno dei Sestii – Publius secondo Manacorda,7 il figlio Lucius secondo D’Arms8 – sulla base diun passo di Cicerone (ad Att., 16, 4, 4) che definisce luculenta le sue navi.
Grandi proprietari terrieri e armatori nell’ager Cosanus sono anche i Domitii Aheno-barbi: a loro forse spetta la proprietà delle fornaci di Albinia. Fonti letterarie ed epi-grafiche attestano che il nodo strada-fiume-approdo dell’Albegna costituiva uno deicentri vitali della regione agricola sostanzialmente controllata da questa famiglia.9 Inparticolare, in alcuni passi del Bellum Civile cesariano (1, 34; 1, 36, 1-2; 1, 56) si menzio-na la flotta privata che L. Domitius, console del 57, morto a Farsalo nel 48, arma nel 54nei propri possedimenti nel Cosano e nell’isola del Giglio per occupare Marsiglia. Su
1 Guidobaldi 1996b; Nonnis 2003, p. 271, nota 95, con altra bibliografia; Zevi 2005, p. 823.2 Il relitto è pubblicato da Galli 1993. La gens Saufeia, tra le più eminenti di Praeneste, è attestata a Ro-
ma (anche con membri di rilievo), a Tuscania, a Minturno, ad Atene e a Delo: Nonnis 1999, p. 79 (proso-pografia e bibliografia). Servi e liberti di un Aulus Saufeius compaiono nelle iscrizioni lapidarie di Minturno,Preneste e Delo. La coincidenza del prenome e le concordanze cronologiche tra queste iscrizioni e il bollodella nave di Ponza rende credibile l’ipotesi che si tratti dello stesso personaggio (Gianfrotta 1998, p. 106).Le presenze a Delo di un suo servo (Callicles) e di un suo liberto (A. Saufeius Zenodorus) fanno pensare al con-sueto binomio vino/schiavi. 3 Pinedo Reyes - Alonso Campoy 2004.
4 Gianfrotta 2007b, pp. 66, 69, con bibliografia.5 Ricostruzione dello stemma della famiglia con riferimenti alle fonti scritte, soprattutto Cicerone, in
Manacorda 1985, p. 102. 6 D’Arms 1980.7 Manacorda 1981, pp. 31-32. 8 D’Arms 1980, p. 83.9 Manacorda 1981, pp. 44-47; Olmer 2003, pp. 174, 203; Olmer 2008, pp. 228-229.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 51
di essa imbarca servi, liberti, coloni, pastores, tanto da costituire una piccola armata,di cui prende il comando. Che l’officina di Albinia facesse anch’essa parte di questeproprietà è ipotesi che è stata prospettata, senza trovare tuttavia riscontro nel corre-do epigrafico dei contenitori finora recuperati nello scavo delle fornaci, dove preval-gono le sigle alfabetiche e in misura assai più ridotta i nomi servili.1 Sicura invece èl’attività armatoriale della gens testimoniata, oltre che dai passi di Cesare già citati, daibolli con il solo cognomen AHENOBARBI sul braccio di due ceppi di ancora rinvenu-ti nelle acque dell’Isola delle Femmine presso Palermo.2 I caratteri epigrafici riporta-no al i secolo, lasciando ampia possibilità di scelta tra i personaggi della famiglia at-testati in questo secolo.3
Il periodo si chiude con l’affermazione di un modello “egeo” (l’anfora Dressel 2-4),destinato ad aver successo dall’età augustea in poi, imitato anche in ambiente adriati-co, ove tuttavia un ulteriore sviluppo tipologico della Lamboglia 2 porta alla realiz-zazione e ad una consistente diffusione della Dressel 6A. La ceramica a vernice neracede contemporaneamente il passo alla ceramica a vernice rossa (sigillata italica). Macon questi nuovi contenitori (Dressel 2-4 e Dressel 6A) e con questa nuova classe hainizio un’altra storia.
Un’ultima osservazione va fatta su un’area produttiva che si inserisce in quest’ultimafase dell’età tardo-repubblicana. Si tratta del Bruzio, già indiziato nel iii secolo di unaproduzione di grecoitaliche secondo Van der Mersch 1994, ma le officine delleDressel 1 (e di altre svariate forme anforarie coeve) hanno in genere altra collocazio-ne e nascono all’interno di una diversa geografia economica. Si tratta in primo luogodella fornace di Cropani Marina, loc. Basilicata (prov. Catanzaro) annessa ad una vil-la, che realizza Dressel 1A e Dressel 1B con bollo LVSI. Il gentilizio è documentato an-che su Dressel 2-4 a Cirò Marina e a Capo Colonna, seguito dal cognome Medicus,mentre un L. Lusius Petel(inus/-ianus) timbra con il suo servo Kalam(- - -)/Calam(- - -) la-terizi, embrici, fistulae in un’officina da porre con molta probabilità tra Strongoli (l’an-tica Petelia) e Cariati, in una località non lontana dalla statio tardoantica di Paternum,nella fascia centro-orientale del Bruttium.4 La fornace di anfore di Lusius a Cropanigravita nella stessa zona e conferma gli interessi nell’industria ceramica di più espo-nenti della stessa famiglia a partire dall’età tardo-repubblicana. Sempre al versante io-nico della regione sono probabilmente da attribuire anche le anfore di N. Scaptius edel suo servo Calamus/-anus (su Dressel 1, Lamboglia 2, contenitori con anse a nastrodi tipologia non determinabile e forse anfore ovoidi del tipo di Brindisi) e di EpidiusCalamanus (su Dressel 1 o Lamboglia 2 e Dressel 2-4). Impressionante è la diffusionetra Thurii/Copia a Nord e Capo Colonna e Cropani a Sud, passando per Punta Ali-ce/Cirò, di queste serie: di Lusius, di N. Scaptius e del suo servo Calam(- - -), di LusiusMedicus con il suo servo Calamanus, di Epidius Calamanus e di L. Lusius Petel(- - -) con ilsuo servo Kalam(- - -)/Calam(- - -). Si rimanda all’analisi di Aisa-Corrado-De Vingo2001, che hanno individuato e riallacciato questa documentazione, facendo anche ilpunto sulla “fortuna” in età tardo-repubblicana di Petelia, città chiamata in causa dai
1 Olmer 2003, p. 207, passim; Vitali - Laubenheimer 2004; Vitali - Laubenheimer - Benquet 2005.2 Hesnard - Gianfrotta 1989, p. 433, A.6.3 Gianfrotta 1980, p. 111. 4 Su Crotone e Petelia, v. ora Spadea 2005.
52 clementina panella
luoghi di ritrovamento, ma anche dal cognome Petel(inus/-ianus) di L. Lusius, il fab-bricante di laterizi.1 Non sembra casuale in questo contesto l’onnipresenza del nomeindividuale Calam(- - -)/Calamanus, variamente espresso, che compare anche come co-gnomen. Se la diffusione di questa produzione nel suo complesso si concentra nellearee sopra citate, rimandando ad un commercio regionale, Taranto da una parte e Ro-ma dall’altra, costituiscono i limiti dello smercio interregionale. Una sintesi su tuttala problematica con bibliografia è ora in Corrado 2009, che aggiunge a questi dati ilrecente ritrovamento nello stesso comparto territoriale, a Sellia Marina, loc. Chiaro(prov. Catanzaro) di uno scarico di fornace, con numerosissime Dressel 1A e Dressel2-4, contraddistinte da decine di bolli sia in latino che in greco (v. sopra, p. 47, nota 3).Sono nel contempo indiziate di aver ospitato officine di Dressel 1 e Dressel 2-4 ancheVibo e Locri, un centro quest’ultimo le cui produzioni anforarie risalgono all’età clas-sica2 e Reggio, se il titulus pictus REG rivenuto su una Dressel 1 nel deposito del Ca-stro Pretorio di Roma, fosse da sciogliere, com’è probabile, R(h)eg(inum vinum):3 l’an-fora ha la data consolare del 19 a.C. Sul versante tirrenico va forse collocata (a Blanda Iulia/Tortora) la produzione di Lamboglia 2 tirreniche (piuttosto che Dressel 1), Dres-sel 2-4, anfore ovoidi (?) e Dressel 21-22 del già menzionato Postumus Curtius, (v. sopra,pp. 48-49). Se non hanno ancora trovato un contenitore di riferimento i vini di Thuriie di Lagaria menzionati dalle fonti (Plin., NH, 14, 69; Strabo, V, 1, 14), il materiale rac-colto in questi ultimi anni sta restituendo molti elementi per intendere l’incidenzaeconomica della viticoltura in aree ben localizzate e la sua durata nel tempo, dandosostegno alle ricostruzioni del paesaggio agrario di Sangineto 2001 e agli accenni sul-le colture intensive delle fonti letterarie.4
Riassumendo, si osserva che 1) le grecoitaliche, prodotte un po’ ovunque nel iv e neliii secolo nella penisola e in Sicilia, rappresentano il modello vincente per il traspor-to vinario di età ellenistica;5 2) hanno una lunga durata e subiscono un processo evo-lutivo che le accompagna per oltre un secolo e mezzo; 3) gli indicatori che possono
1 Il vino di questa località è menzionato in cil x, 114 = ils 6468.2 Barra Bagnasco 1990; Van der Mersch 1994, pp. 68 (MGS ii), 71 (MGS iii).3 cil xv, 4590. Sul vino reggino v. Aten., i, 26e.4 Tchernia 1986, pp. 45, 47, 335-336; Brun 2004.5 Imitazioni “precoci” sono note in Gallia (Marsiglia: Bertucchi 1992, pp. 128-130), a Cartagine (Morel
1990a, p. 94; Morel 1998a, p. 33), ma soprattutto sulle coste atlantiche della Spagna, nel c.d.”Circolo delloStretto”. A Cadice (dal 206 in mano romana), nella fornace di Torre Alta e in altri impianti del territorio, siproducono, a partire dalla metà del iii secolo, insieme ad anfore puniche, anfore di forma Van der Merschv, vi, Will 1e e Dressel 1, quasi certamente adibite a trasporto di conserve di pesce (García Vargas 1998,pp. 69-71, fig. 20, forma 5; Sáez - Díaz 2007). Alla prima metà del ii secolo risale secondo Ramon 1991, pp.118-119 un’imitazione di grecoitaliche ad Ebusus/Ibiza (forma PE-24); ancora più tarda quella della Catalo-gna (López Mullor - Martín Menéndez 2006, pp. 444-445). Un’imitazione spagnola o della Gallia sud-oc-cidentale sembrerebbe inoltre provata da un bollo in iberico (trascritto tiri) sul gomito dell’ansa di un’an-fora di forma Van der Mersch v/vi dall’oppidum di Ensérune nell’Hérault (Jannoray 1955, p. 437, nota 1; tavliii, 3) e da un altro bollo forse nello stesso alfabeto (a meno che non si tratti di greco: £ + tridente) alla ba-se dell’ansa di un’anfora che potrebbe già essere una Dressel 1, da Numantia (Peña Redonda: Sanmartí 1985,p. 142, figg. 25-26, 150). L’ipotesi che in questi due casi si abbia a che fare con produzioni italiche su commandeiberica (2001, p. 65, nota 1), secondo quel binomio lingua/mercati, di cui abbiamo già parlato per le anforebrindisine (v. sopra, p. 47, nota 3), mi sembra interessante ma azzardata, proprio per il significato produtti-vo più che commerciale che diamo in genere ai bolli.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 53
guidarci nell’organizzazione e nell’interpretazione dei dati sono la morfologia, l’ori-gine (quando nota), l’impasto, le caratteristiche tecniche, la bollatura (quando essa èpresente), la diffusione (da utilizzare con cautela). Pur tenendo conto delle difficoltàche impediscono ancora di distinguere all’interno delle anfore Van der Mersch v i sin-goli filoni produttivi, relitti (Roghi 1 a Panearea, Capistello e Capo Graziano B nelleEolie, nave “punica” di Marsala) e siti terrestri (Portinenti a Lipari, Aléria in Corsica)già consentono di pensare a flussi di esportazione extraregionali organizzati, spettanticon una certa probabilità (tutti, in parte) ad area campano-laziale. In riferimento a Ro-ma, i decenni tra iv e iii secolo coincidono con il consolidamento degli ordinamentirepubblicani, con la stabilizzazione sociale in senso aristocratico seguita al completosuccesso del compromesso patrizio-plebeo e con il verificarsi di una forte spintaespansionistica verso il Nord e soprattutto verso il Sud. «In questi anni irrompe sullascena della società romana un insieme di elementi dinamici che incide in modo nonsuperficiale sui vecchi equilibri produttivi proto-repubblicani, imprimendo un’acce-lerazione nuova alla vita della città».1 Quattro sono i punti di svolta «dai quali non sisarebbe fatto più ritorno»: l’incremento rapido della massa degli scambi nel tessutoeconomico della comunità urbana, l’apparizione e la diffusione della moneta, l’irru-zione della forza-lavoro schiavistica, lo sviluppo demografico.2
Dopo questo avvio, le principali discontinuità, che vanno di pari passo con lo svi-luppo di un’agricoltura di alti rendimenti e aperta al mercato, sono quella manife-stata dalla produzione del tipo Van der Mersch vi (con tutte le sue varietà), che ri-flette la situazione di un’Italia peninsulare che è già romana3 e di un Mediterraneoche lo sta diventando; quella mostrata dalle forme Will 1c e Will 1e (con tutte le lo-ro varietà), la cui produzione si chiude con un’Italia e un Mediterraneo diventati ro-mani; quella evidenziata dalla Dressel 1 e dalla Lamboglia 2, che riflette il pieno ma-nifestarsi di un sistema di monopolio di alcune zone dell’Italia centrale tirrenica edell’Italia adriatica nella produzione di beni agricoli e manifatturieri da avviare amercati lontani. Sul piano evenemenziale, tali cesure possono essere associate ri-spettivamente alla fine della i Punica, alla fine della ii Punica, alla caduta di Carta-gine e Corinto, non nel senso di una sovrapposizione meccanica dei dati della cul-tura materiale ai grandi avvenimenti storici, ma nel senso generalmente condivisodel legame tra l’estensione della dominazione romana e lo sviluppo del trasportomarittimo del vino, ed anche – a monte – tra l’estensione territoriale romana in Ita-lia e la crescita di un’agricoltura speculativa. Con il vantaggio di rompere la circola-rità dei nostri metodi di datazione e di trasformare il cerchio vizioso intorno a cuiessi si annodano in una spirale che dovrebbe avvicinarsi a poco a poco alla realtà delpassato. In questo senso, riprendendo un’osservazione di D. Manacorda e trasferen-dola nell’orizzonte cronologico del iii secolo, la produzione di grecoitaliche di que-sti cento anni cruciali non andrebbe definita in base a fattori geografici, quanto piut-tosto, di volta in volta, alle particolari condizioni di sviluppo economico di alcuneregioni della penisola, che ne avrebbero consentito la produzione su vasta scala e la
1 Schiavone 1989, p. 23. 2 Schiavone 1989, pp. 23-26.3 Si ricordi l’esposizione nel tempio della Tellus, votato e realizzato nel 268, di una carta geografica del-
l’Italia, una sorta di “icona” che, dopo la sconfitta di Pirro, «simboleggiava la definitiva stabilizzazione sot-to il dominio di Roma della penisola»: Zevi 2005, pp. 817-818.
54 clementina panella
loro esportazione mediterranea.1 Fondamentale è il periodo tra le due guerre con-tro Cartagine (gli anni tra 240-220 a.C.), quando la Sicilia è provincia (241),2 si ac-centua il ruolo della Campania sul piano politico-militare ed economico e Roma puòcogliere i frutti delle attività produttive delle colonie che ha disseminato nella peni-sola dagli ultimi decenni del iv (fine delle guerre latine), ma soprattutto nella primametà del iii secolo,3 sia sul versante centrale del Tirreno (Etruria, Lazio, Campania),sia nell’alto e medio Adriatico, colonie che hanno avuto il tempo di consolidarsi inzone e regioni al momento delle loro fondazioni non completamente pacificate e dimettere in atto bonifiche e sistemi di coltivazione che prevedessero eccedenze ingrado di rispondere ad una domanda di beni di consumo in crescita. Né va sottova-lutata l’assimilazione di modelli produttivi da parte di comunità e di città rimasteformalmente “libere”.
Certo il passaggio dal tipo Van der Mersch v al tipo Van der Mersch vi è fluctuant,con conseguenti fraintendimenti nelle classificazioni e nelle cronologie degli esem-plari trovati nei relitti e nei depositi di terra. Il dominio di Roma sul mare è testimo-niato dalla lex Claudia, che con il suo divieto indica una presenza della nobilitas nei traf-fici marittimi, in riferimento ad una generazione nata qualche decennio prima. Sonoquesti gli anni in cui la bollatura in latino assume rilievo e si consolida. È pertanto al-le anfore del tipo Van der Mersch vi che occorre affidare il compito di aver assorbitoe trasmesso le novità di questa congiuntura, come aveva già supposto A. Tchernia:«les points de départ de la révolution qui ménera progressivement à un nouvel équi-libre de la viticulture en Occident se placent au plus tard pendant la deuxième guer-re punique, et plus probablement entre la première et la seconde».4
1 Manacorda 1981, p. 23. Anche in questo caso, come per il paesaggio agrario, la nascita e lo sviluppodelle officine che fabbricano contenitori da trasporto non sono uniformi e interessano con modi e tempi di-versi i singoli territori. Inoltre, benché gli impianti, nei casi noti, rimangano su se stessi e adottino con iltempo nuovi modelli (il passaggio più rilevante è quello dalle grecoitaliche alle Dressel 1 e alle Lamboglia2), le stesse variazioni morfologiche e le modificazioni della scala della produzione costituiscono un indiziodi una discontinuità imputabile alla dimensione del prodotto da esportare, che presuppone maggiori inve-stimenti, rinnovamento dei mezzi di produzione, cambiamenti della manodopera e dei gestori degli im-pianti e in ultima analisi dei proprietari delle officine e dei proprietari della terra. Rari sono i casi docu-mentati di una trasmissione diretta di una stessa manifattura per più di una generazione (i Sestii e i Laecaniioperano per due o tre generazioni). Fanno eccezione gli impianti che finiscono (da Augusto in poi) nelleproprietà imperiali.
2 La conquista dell’isola e quella di poco successiva della Sardegna (provincia dal 238) ebbero come ri-caduta non secondaria l’acquisizione di importanti risorse granarie. Ciò significò sollevare l’agricoltura del-le zone e dei territori prossimi a Roma dalla necessità di provvedere al fabbisogno di cereali della popola-zione urbana e di liberare forze e terreni per colture intensive e pregiate (la “frumentarizzazione” dellaSicilia sarà operata da Valerio Levino nel 210). Ma la tendenza dei grandi proprietari a specializzare le colturedestinate alla commercializzazione, considerate più redditizie, contemporaneamente alla crescita demo-grafica conseguente all’inurbamento della massa dei piccoli contadini espropriati delle loro terre, costrinsele autorità (dai Gracchi in poi) a cercare di predisporre iniziative tese a garantire ad una parte degli abitan-ti quote gratuite o a prezzi ridotti di grano, a trovare soluzioni per il funzionamento dei porti e per lo stoc-caggio delle merci. Ogni battuta d’arresto degli arrivi (per mare clausum, per carestie, per naufragi, per in-cursioni dei pirati) ha provocato momenti gravi di tensione e vere e proprie sollevazioni popolari che hannoscandito la storia della tarda repubblica: Virlouvet 1985 e 2003; Tchernia - Viviers 2000, pp. 779-783.
3 Per l’impatto della romanizzazione sui territori del Latium vetus e del Latium adiectum interessati dallacolonizzazione dell’ultimo terzo del iv e dei primi anni del iii secolo si rimanda a Morel 1995.
4 A. Tchernia in Hesnard et alii 1989, p. 32.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 55
L’altra cesura rappresentata dai tipi degli inizi/prima metà del ii secolo è invece piùnetta sul piano morfologico, così come sul piano della diffusione delle merci traspor-tate. E sul piano commerciale si ricorda l’istituzione del portorium a Puteoli (199 o 198)1seguito dall’impianto della colonia (programmata nel 197 e realizzata nel 194) a pochichilometri da Neapolis, i cui prodotti ceramici e viticoli, che erano già da qualche decennio esportati, trovano ora un più efficace punto di imbarco, la costruzione delporto di Roma a partire dal 193 presso l’Emporio (con la sua più antica infrastruttura,la Porticus Aemilia),2 l’istituzione del porto franco di Delo (166) e il suo forte poten-ziamento come centro di smistamento dei commerci a partire dal 146 (caduta di Corinto), e, sul piano politico-militare, le fasi finali dell’imperialismo repubblicano(sconfitta della Macedonia e distruzione delle due avversarie storiche: Cartagine inOccidente e Corinto in Oriente).
La terza rottura, certamente la più sensibile e definitiva, è infine rappresentata dal-la nascita delle Dressel 1 e delle Lamboglia 2, che benché derivino dalle precedenti esiano prodotte spesso nelle stesse officine, sono anfore “antigreche” (“antihellénique”per eccellenza o “anhellénique”),3 funzionali per standardizzazione, robustezza e ma-neggevolezza alla crescita esponenziale del commercio vinario della tarda repubblica.Nei rapporti con l’Occidente «possiamo pensare che la standardizzazione che le an-fore Dressel 1 testimoniano … fa da parallelo alla standardizzazione che nella produ-zione della ceramica da mensa a vernice nera si afferma nel corso del ii secolo nelleofficine campano-laziali ed etrusche».4 Sul piatto della bilancia occorre mettere anchel’uso del vino come mezzo con il quale diventa possibile scambiare con le popolazio-ni indigene dislocate ai margini dell’Impero altri beni divenuti di primaria importan-za come gli schiavi, i metalli, altre materie prime. A Delo si concentra il commerciodegli schiavi dell’Oriente “barbarico” ed è lì che si addensa la maggiore documenta-zione di cui disponiamo sulle Lamboglia 2 medio- e nord-adriatiche. Per converso ènella Gallia indipendente prima della conquista di Cesare che si registrano gli straor-dinari arrivi delle anfore vinarie tirreniche (a Bibracte, capitale degli Edui amici del po-polo romano, “produttori” di schiavi, ma anche di metalli nella rete di miniere nelMorvan, nel sito di Lione prima della fondazione di Lugdunum, e ancor prima – già al-la fine del iii secolo – a Tolosa e nel Tolosano, ricchi di metalli).5
1 Condivisibile è l’ipotesi di un collegamento tra la diffusione di questo vasellame a Cartagine e nel Mediterraneo occidentale (quella cioè che Morel definisce la sua esplosione commerciale) e la fondazionedella colonia di Puteoli, destinata a diventare nel giro di pochi anni la testa di ponte di Roma nei traffici conl’Oriente e con il Mediterraneo occidentale e meridionale (Morel 1988a, pp. 347-348; Morel 1988b, pp. 53-54). Sul ruolo di questo porto nel commercio del ii e del i secolo, sui suoi rapporti con Delo e con il commercio del grano e degli schiavi orientali, sulla complementarità di interessi tra Lazio e Campania cheè alla base della sua fortuna, sulla sua funzione di punto di arrivo dei rifornimenti granari di Roma, v. Musti1980 e 1981, pp. 250-253, passim. Sulla storia della città e del suo porto, v. i contributi raccolti in Puteoli 1993:in particolare, sulle attività imprenditoriali gravitanti intorno all’emporio, Camodeca 1993 e 1996, sui traffi-ci con il lontano Oriente De Romanis 1993.
2 Per le grandiose infrastrutture portuali del II secolo e per il rapporto della città con il Tevere dall’etàpiù antica si rimanda a Coarelli 2000 e a Domínguez Pérez 2006, pp. 183-186.
3 Morel 1976b, pp. 477-478. 4 Manacorda 1981, p. 24.5 Olmer 2008.
56 clementina panella
Viticoltura e paesaggio agrario
Questo è il racconto che ci sembra che nelle grandi linee derivi dall’analisi dei mate-riali ceramici. Ma esistono altre storie che si riallacciano ai dati che abbiamo fin quiraccolto. Si tratta dell’organizzazione delle campagne, dei regimi di proprietà e delledimensioni dei fondi adatti ad uno sfruttamento intensivo, dello status dei proprieta-ri e degli attori che a diverso titolo entrano nel processo produttivo e commerciale.Occorre cioè rivolgere l’attenzione ai sistemi produttivi che hanno consentito la cre-scita economica di cui anfore e ceramica fine da mensa costituiscono solo un indizioricorrendo ad altri tipi di fonti. Se per la fase che include gli ultimi due decenni del iiisecolo e la prima metà del ii secolo (appartengano essi al mio periodo ii o iii) il mo-dello tende ad identificasi con la villa “catoniana” (esemplificata dalla villa 3 dello sca-vo dell’Auditorium di Roma),1 se per il periodo iv (seconda metà del ii/i secolo) conla villa varroniana (la villa perfecta, esemplificata dalla villa di Settefinestre nel Cosa-no),2 che si può dire della situazione delle campagne, per esempio, durante e dopo laI Punica? L’archeologia dei paesaggi, lo studio e la tipologia degli insediamenti e deiterritori con le loro trasformazioni nel tempo possono rispondere meglio a queste do-mande: in assenza di scavi sistematici di fornaci, cioè dei centri di produzione dei con-tenitori (unica eccezione Giancola nel Brindisino e Albinia nel Cosano), occorre ri-tornare sui luoghi della produzione del contenuto, cioè sui territori il cui studio èprogredito in questi ultimi anni sia a livello di macro- che di micro-aree.3 Si tratta tut-tavia di piccoli tasselli, di frammenti, da cui è possibile ricavare alcune linee di ten-denza e svariate differenze nelle dinamiche e nei comportamenti.4 Ma va anche det-to che all’interno dei dati che man mano si accumulano, diventa sempre più difficileorientarsi.
1 Auditorium 2006, pp. 225-268 (periodo 4, fase 1). 2 Settefinestre 1985.3 Dopo la pubblicazione di Società Romana e Produzione Schiavistica (srps i), molti studi recenti hanno ar-
ricchito le conoscenze, oltre che del Suburbio, di alcuni comparti regionali e subregionali: valle del Teveree Sabina (per il Tiber Valley Project v. Di Giuseppe - Patterson 2009; Di Giuseppe 2009 e gli altri numero-si contributi editi in Mercator Placidissimus; per Caere: Enei 2001; per Veio: Tartara 1999; per il territorio diAcilia: Pellegrino 1983); ager Pisanus e Volaterranus (Pasquinucci - Menchelli 1999); valle del Cecina(Progetto Volterra: Terrenato - Saggin 1994); ager Cosanus e Valle d’Oro (Carandini - Cambi 2002); agerMinturnensis (A. Codagnone, L. M. Proietti, G. Rosi, in Coarelli 1989, pp. 85-175); valle del Liri (Hayes -Martini 1994); ager Falernus (Arthur 1991), Casertano (De Caro 1991) e più in generale Campania set-tentrionale (De Caro - Miele 2001); ager Suessanus e Sinuessanus (Vallat 1987); Teramano e Pescarese(Guidobaldi 1996a; Staffa 2003 e 2004); ager Firmanus (Pasquinucci - Menchelli 2002); ager Gallicus (Pa-ci 1998); valle del Potenza (Vermeulen et alii 2009, con bibliografia delle ricognizioni belghe); Marche ingenerale (aggiornamenti di De Marinis 2003 a Mercando et alii 1981); Daunia (Volpe 1990); Brindisino(Cambi 2001); Salento (Yntema 2006); Bruzio (Sangineto 2001; per Blanda, Lavinium, Cerillae, Clampetia,Tempsa: La Torre 1999); Lucania (Gualtieri 2001; per Venusia e il suo territorio Marchi - Sabbatini1996); Istria (Rosada 2003). Una parte dei contributi citati sono raccolti nel volume curato da Lo Cascio -Storchi Marino 2001, a cui si rimanda anche per altri articoli di sintesi spettanti all’Italia meridionale, cuinon abbiamo fatto cenno, e per le Conclusioni di F. Zevi e F. Grelle (ivi, pp. 637-654). Non va infine dimenti-cata l’attività incessante sul territorio di Lorenzo Quilici e Stefanella Quilici Gigli, ampiamente valorizzatanella bibliografia citata.
4 In una piccola porzione dell’Etruria meridionale si riscontrano notevoli differenze insediative tra le zone di colonizzazione di conquista (il cuore dell’ager Cosanus con le sue ville), quelle di colonizzazione dipopolamento (Saturnia e l’agro di Heba), quelle non centuriate (il territorio di Vulci) e quelle collinari: Carandini 1994.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 57
Se per la tarda repubblica (ii-i secolo), cioè per il periodo di pieno sviluppo diun’agricoltura di alti rendimenti finalizzata alla diffusione extraregionale dei prodot-ti, i ritrovamenti e le riflessioni più recenti hanno arricchito e precisato in terminiquantitativi e qualitativi il quadro degli insediamenti rurali, siano modesti appresta-menti (casae, tuguria), fattorie1 o villae,2 dimostrandone in alcuni ambiti territoriali lacrescita (è ciò che accade nel suburbio di Roma), molti sono gli elementi nuovi che siriallacciano al dibattito sulla fase che precede questo straordinario momento. Emer-ge infatti dall’analisi delle più recenti ricognizioni territoriali che tra le tante varietà especificità regionali3 sono esistiti in alcuni comparti le condizioni e i mezzi per un’ar-boricoltura specializzata già nel pieno iii o in età ancora più antica, in ogni caso in etàpre-catoniana.4 A tale tipo di sfruttamento vanno ricollegate – rimanendo in ambito“romano/latino” – sia le fonti letterarie relative alla pratica della viticoltura e alla pro-duzione di vino nel Latium vetus e nel Latium adiectum,5 sia le tracce di coltivazione edi organizzazione agraria rinvenute nel suburbio di Roma (edifici, canalizzazioni, ci-sterne, delimitazioni di proprietà), mentre le grecoitaliche del iii secolo mostrano chela produzione vitivinicola di alcuni territori non risponde in questa età solo a criteridi autoconsumo e di smercio sui vicini mercati cittadini, dove il vino poteva essere tra-sportato in otri (cullei) su carri o su animali da soma (v. gli aselli dossuari ricordati da
1 La distinzione tra fattorie e ville rappresenta uno dei problemi più spinosi delle ricognizioni. Quandonon esistono resti di strutture e l’identificazione è demandata alle concentrazioni in superficie del materia-le ceramico e edilizio, la ricerca tende oggi ad uniformare i criteri di riconoscibilità, fissando dei dati “og-gettivi” (tipo/qualità degli indicatori, dimensione delle aree di dispersione del materiale, cronologia: DiGiuseppe 2005a, p. 8 ss.; Carandini - Carafa - Capanna 2007), ma non mancano, anche in lavori recenti,differenze nella scelta dei parametri e una certa varietà nelle denominazioni (fattoria piccola, media, gran-de; villa piccola, media e grande; villa rustica; casa; casa colonica): Capanna - Carafa 2009, pp. 29-31 (conbibliografia); Di Giuseppe - Patterson 2009, pp. 23-24. Ne consegue l’impossibilità di individuare in molticasi nella letteratura chiavi di lettura univoche e chiare. Nella mente dei ricognitori le fattorie tendono adessere assegnate alla proprietà contadina (a piccoli, medi, grandi agricoltori), ma occorre segnalare che inalcuni casi esse potrebbero far parte di fondi più estesi, secondo una divisione in lotti di più grandi proprietào essere la parte destinata alla lavorazione e alla conservazione dei prodotti di una villa da immaginarsi nonlontana. E quale significato dare al termine villa rustica, anch’esso frequentemente utilizzato? Una villa sen-za pars urbana, cioè una “grossa fattoria”, come propone Carandini 2006, p. 593? E che fare della denomi-nazione anch’essa talvolta impiegata di “villa periferica”? Un tentativo di normalizzare la tipologia delle pic-cole case di campagna (tuguria) e delle fattorie, entrambe di lunghissima durata, è ora riproposta daCarandini 2006, pp. 592-596.
2 Di ville si può parlare fin dal vi/v secolo, se con questa definizione si intendono, sul piano tipologicoe funzionale, impianti monumentali che prevedono la separazione tra il settore residenziale (pars urbana)destinato alla permanenza del dominus in villa (o del grande affittuario che ne fa le funzioni) e quello produttivo/rustico (pars rustica), dotato degli strumenti della produzione: in tal senso il più antico edificio(degli inizi del v secolo) rinvenuto nello scavo dell’Auditorium sulla Flaminia può essere ed è consideratouna villa (Auditorium 2006, p. 103 sgg., in part. pp. 157-158). Diverso è il concetto di “villa” in quanto sistemasocio-economico, associato ad una forma di sfruttamento della terra a carattere intensivo, con colture specializzate (soprattutto vite e olivo), con manodopera fondamentalmente schiavile, secondo il modellocatoniano (“villa catoniana”).
3 Si confrontino in Carandini 2009, pp. 304-305 le differenze tra i dati riscontrati nelle ricognizioni dalui dirette di alcune aree nel suburbio settentrionale di Roma (v. oltre, p. 73, nota 5) e tra questi e quelli spet-tanti alle ricerche territoriali nell’Etruria meridionale inaugurate negli anni Cinquanta del secolo scorso daJ. Ward Perkins, proseguite da T. Potter nel 1979-1980 (il South Etruria Survey: bibliografia in Di Giuseppe2005a, p. 7, nota 4) e dal più recente Tiber Valley Project dalla British School di Roma, già menzionato.
4 Torelli 1990, pp. 127-128; Van der Mersch 2001; da ultimo Carandini 2009.5 Van der Mersch 2001, pp. 159-164.
58 clementina panella
Varrone in relazione ad altro territorio e ad altra epoca),1 ma comincia a prevedereanche sbocchi su mercati lontani. Nel caso di Roma, pur in assenza di anfore, le stimedel consumo sono tali da far intravedere un assetto delle campagne fortemente strut-turato già in questo iii secolo (ne riparleremo).
In sostanza, se la villa descritta da Catone nel De agri cultura, cioè un’unità produt-tiva specializzata, lavorata da schiavi ed aperta al mercato, è il modello con cui sonostati spiegati gli alti rendimenti e le esportazioni massicce dell’età tardo-repubblicana,per la sua origine si è fatto riferimento alla gestione del territorio risalente già al vi/vsecolo e poi più concretamente all’evoluzione delle fattorie spettanti alla piccola e me-dia proprietà contadina dell’età medio-repubblicana,2 le cui tracce (basamenti in ope-ra poligonale) si intravedono nei territori del Lazio e della Campania spesso sottostrutture più recenti,3 con il corollario che già in tale contesto la manodopera servileera di sicuro presente (dall’ultimo quarto del iv secolo) e forse in misura non margi-nale.4 Carandini inseriva nel processo di formazione le esperienze e le conoscenze ac-quisite mediante il contatto con altri mondi e culture, pensando alla Sicilia con la suaarboricoltura specializzata e i suoi vitigni pregiati ben presto impiantati nell’Italia cen-trale,5 o all’Africa con le sue ville urbane in campagna, o a Neapolis e alla Campaniaper lo sviluppo del produrre con schiavi.6 Della situazione della Sicilia e di Cartaginei Romani avevano avuto una conoscenza diretta con la presa nel 262/261 di Agrigen-to, dove fin dal v secolo l’arboricoltura, anche in vista dell’esportazione, era condot-ta da schiavi e formava grandi fortune,7 e con l’avanzata nel territorio di Cartagine(nel 256 e poi nel corso del iii e del ii secolo), dove già dalla fine dal iv secolo a.C. lacampagna era intensamente popolata da lussuosi edifici, circondati da vigneti e oli-veti.8 Del modo di produzione schiavistico Neapolis e la Campania potrebbero esserestati i luoghi dell’elaborazione. A queste esperienze si sarebbero sommate quelle gre-che e asiatiche assorbite attraverso le conquiste della prima metà del ii secolo, men-tre la traduzione del trattato di Magone9 dopo la caduta di Cartagine avrebbe com-pletato l’acquisizione del sapere agronomico del mondo punico.10 In ogni caso la villacatoniana, indipendentemente dalla sua più o meno lenta formazione e dai suoi pro-
1 Manacorda 1994b.2 Torelli 1990, p. 131: la villa catoniana non è «l’improvvvisa scoperta di un modello produttivo fatta
nel momento della grande espansione mediterranea», ma «il prodotto di una lenta evoluzione di una strut-tura sociale complessa, come quella romana nell’età della conquista della penisola nel iii secolo».
3 V. i numerosi ritrovamenti di basis villae registrati da Andreussi 1981, databili tra iv e ii nel Lazio (ter-ritori di Anagni, Tivoli, Cora) e da Vallat 1987 in Campania (ager Suessanus e Sinuessanus).
4 Torelli 1990, p. 131; Cornell 1995, pp. 280-288.5 Plinio attesta che il vitigno più diffuso ai piedi del Vesuvio era la Murgentina originaria della Sicilia (da
Morgantina); il vitigno dei colli Albani collegato ad un vino celebre – l’Albanum – era l’Eugenia di Taurome-nium/Taormina. Per Tchernia 1986, pp. 49-50 l’acclimatazione di questi due vitigni potrebbe risalire allaprima guerra punica, ma non esclude un arrivo più antico (nel iv secolo); nel iii secolo secondo Zevi 2002,p. 46, che nota che questi ceppi appartengono alla Sicilia sotto il controllo di Siracusa, ostile a Roma per tut-to il iv secolo, fino al regno di Ierone II, che potrebbe aver fornito ai Romani assieme ai vitigni, anche le co-noscenze della vinificazione.
6 L’ipotesi è già in Toynbee 1965, p. 162 sgg., 296-312; Carandini 2006, p. 605: «ma la villa è e resta unaforma eminentemente romana». 7 Van der Mersch 1994, p. 99 sgg. e note 89-91.
8 Polyb., i, 29, 7; Diod., xx, 8, 4.9 Sull’agronomo cartaginese e i suoi traduttori greci e latini v. Heurgon 1976.10 Carandini 1989a, pp. 112-114; Carandini 1989b, p. 509.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 59
totipi, sarebbe stata, nel momento della sua diffusione, il riflesso di nuovi assetti so-ciali e di un più razionale sfruttamento delle risorse agricole.
Resta il dato di fatto che gli indicatori che abbiamo evocato (fonti, paesaggio agra-rio, anfore) tendono a mostrare che la nozione di vino/capitale era ben stabilita nelmondo romano prima della testimonianza del De agri cultura di Catone e del model-lo che il trattato disegna,1 caratterizzato, come si è già detto, sul piano della finalitàeconomica dalla produzione di una o più colture specializzate per il mercato e sul pia-no dell’organizzazione della produzione dall’impiego di manodopera schiavile. L’uni-tà produttiva a cui Catone fa riferimento è apparsa nella riflessione di molti studiosiuna «forma dominante» dell’economia dell’Italia centrale tirrenica dell’età tardo-re-pubblicana («eccezione dominante» secondo la definizione di A. Carandini, quantita-tivamente minoritaria, ma qualitativamente in grado di subordinare a sé regioni as-sai lontane),2 destinata ad evolvere dall’ultimo quarto del iii/inizi del ii secolo a.C. ali d.C. (villa varroniana e columelliana) e a perdurare fino al ii secolo d.C. Analisi del-le fonti letterarie (sopratutto dei testi agronomici e giuridici) e scoperte archeologi-che (per prima in ordine di tempo la villa di Settefinestre) hanno sostanziato nell’ul-timo quarantennio il dibattito intorno al carattere di ciò è stato definito «il modo diproduzione schiavistico». Semplificando, a tale modo di produrre (con schiavi e per ilmercato) è stato ancorato lo sviluppo in alcune regioni della penisola di un’agricol-tura intensiva e remunerativa (viticoltura, olivicoltura) e l’esportazione massiccia del-le eccedenze nei principali centri mediterranei.3 Che il modello vada temperato, checoesistano forme diverse di conduzione agraria a seconda dei territori,4 a seconda del-le potenzialità delle risorse naturali dovute all’estrema varietà degli ambienti geogra-fici dell’Italia antica, a seconda della vicinanza ai centri di consumo (città) o alle vie dicomunicazione (strade, fiumi, porti), che convivano forme diverse di organizzazioneed estrazione della forza lavoro (servi, ma anche liberi),5 che vada superata la letturaevolutiva di tipo unilineare delle forme di organizzazione della proprietà agraria (dal-la piccola proprietà contadina alla villa, dalla villa catoniana alla villa varroniana e co-
1 Il De agri cultura è del 161, ma la sua redazione doveva essere quasi del tutto terminata nel 180 a.C e laPrefazione scritta forse già nel 200/190: Van der Mersch 2001, p. 165 e nota 71. La lunga elaborazione si accompagna alla lunghissima vita del Censore (234-149) e alle sue molteplici attività ed esperienze. Le osservazioni di Ch. Van der Mersch sul trattato sono convincenti: esso riflette, secondo questo studioso,pratiche agricole stabilite da almeno una generazione (cioè anteriormente alla ii Punica). Le prime conoscenze in campo agricolo devono essere state acquisite nel podere ereditato dal padre, a Tusculum inSabina, prima del 217 (Plut., Cato maior, 3, 2), che è l’anno della sua partenza per Roma e dell’inizio della suacarriera politica. 2 Carandini 1988, p. 300; Carandini 1989b, pp. 509-510.
3 Carandini–Settis 1979; Settefineste 1985; Carandini 1988, 1989a, 1989b, e complessivamente srps;per una sintesi della documentazione archeologica allora disponibile e del dibattito suscitato dallo scavo delpoggio di Settefinestre v. G. Pucci, in Settefinestre 1985, i, pp. 15-21.
4 Villa a gestione diretta (“catoniana”) e sfruttamento della grande proprietà mediante il sistema degliaffitti coesistono secondo Capogrossi Colognesi 1997, pp. 32-33, passim (con bibliografia). A proposito del-la locatio, nel gradino più basso vi è il pauperculus cum sua progenie di Varrone, che integra nei grandi lavoristagionali la manodopera servile; in quello più alto il grande affittuario che sostituisce il grande proprieta-rio assenteista, ma la cui presenza non determina in quest’epoca forme diverse di organizzazione della pro-duzione nella grande proprietà agraria, che resta a base schiavistica.
5 Sulla presenza di forza lavoro libera, sia pure temporanea (il piccolo contadino libero che non poten-do vendere il surplus agricolo, vendeva il surplus di lavoro), esterna all’unità produttiva costituita dalla villacatoniana, v. Lo Cascio 1997 e più recentemente Lo Cascio 2009, pp. 33-34, passim, con bibliografia; Cor-bier 1981; Capogrossi Colognesi 1997, p. 37.
60 clementina panella
lumelliana, e dalla villa schiavistica all’affitto agrario1 o dalla fattoria alla villa),2 chenello spazio rurale possono coabitare in ciascuno dei periodi storici considerati tuttii tipi di abitato e quindi di sfruttamento (piccole fattorie, villae, villaggi)3 costituisco-no altrettanti risultati della più recente riflessione storica, interessata più che alla con-testazione del sistema, che pure è esistito e della cui dominanza in certe regioni e incerti momenti non si dubita, a risolvere gli interrogativi a cui esso sul piano macro-economico non è (sempre e in ogni caso) in grado di rispondere e le contraddizioniche non è (sempre e in ogni caso) in grado di risolvere. Detto questo, gli elementi chesembrano dare unità di sviluppo all’economia agraria di alcuni territori dell’Italia traiii e i secolo sono l’intensificazione delle colture e l’espansione della produzione peril mercato, causate dall’incremento della domanda in conseguenza della crescita del-la popolazione delle città e in particolare di Roma e dall’ampliamento dei mercati disbocco soprattutto del vino italico nelle regioni via via conquistate.4
Anche sull’impiego di manodopera schiavile c’è da ridire, in quanto l’afflusso dischiavi comincia ben prima del 200 (con un uso familiare, “antico” della schiavitù, se-condo la terminologia marxiana) e prosegue ben dopo Augusto. Ma quando si parladi “modo di produzione schiavistico”, si fa riferimento alla cooperazione a fini pro-duttivi di molti uomini in un fundus (o in una manifattura urbana). Il fatto che tale fe-nomeno sia stato geograficamente ristretto e temporalmente circoscritto (iii-i seco-lo),5 non lo rende meno epocale per l’interpretazione della storia antica. La novità nonrisiede nello sfruttare i servi, quanto nel modo in cui li si utilizza, secondo un’articola-zione interna del lavoro che prevede la specializzazione dei compiti, garantendo, an-che con l’adozione stagionale di altro tipo di manodopera, il massimo del profitto conil minimo di spesa. Le quantità di tali individui e le modalità di impiego sostanziano il“modello”: 100.000 sarebbero secondo P. A. Brunt gli schiavi catturati nel corso della iPunica e 600.000 quelli viventi in Italia, esclusa la Cisalpina, nel 225.6 Tolti i servi pasto-res, distribuiti soprattutto nell’Italia meridionale e in Sicilia, e gli schiavi urbani, utiliz-zati anche nelle manifatture di ceramica, nell’indutria laterizia e nell’edilizia, si puòimmaginare che il resto di tali masse schiavili sia finito nelle campagne.
Va da sè che una razionalizzazione delle forze-lavoro in termini di efficienza eco-nomica e un’estensione del mercato a spese dell’autoconsumo non avrebbero avutosuccesso: a. se non fosse esistito un ceto di proprietari o una classe dirigente che giàprima di Catone (e lo dimostra il plebiscito Claudio) fosse disposta sia ad abbandona-re l’idea della rendita bassa e certa (pascoli, allevamento) per investire in colture pre-giate ad alta remunerazione ma rischiose, sia a rinnovare metodi di coltivazione perfar rendere di più le proprietà; b. se non ci fosse stata una classe di imprenditori pron-ta anch’essa ad affrontare i pericoli del commercio, soprattutto quelli rappresentati dailunghi viaggi per mare; c. se lo stato non ne avesse favorito la crescita attraverso la rea-
1 Lo Cascio 1997, pp. 21-23; Lo Cascio 2009, p. 31, passim.2 Carandini 2006, pp. 604, 608. In quest’ultima formulazione le fattorie sono separate nettamente dal-
le ville: “la villa nel senso tardo-repubblicano del termine (la villa catoniana, ndr) nasce ex novo”, secondoun’evoluzione autonoma di ciascun tipo di insediamento e con nessuna o con poche interferenze.
3 Vallat 2001. 4 Lo Cascio 2009, p. 34.5 Uso non “familiare” di schiavi forse già dall’ultimo quarto del iv secolo (v. sopra, p. 59, nota 4).6 Discusse e discutibili, tali cifre danno un ordine di grandezza: Brunt 1971, pp. 54, 59, nota 3; p. 67, no-
ta 21 e p. 121; Hopkins 1984, p. 111; Schiavone 1989, p. 25.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 61
lizzazione delle infrastrutture (strade,1 acquedotti,2 bonifiche,3 porti) e il manteni-mento della loro sicurezza (la difesa dei mari e dei porti, ad esempio, contro i pirati).4Gli scopi prevalentemente militari che hanno determinato spesso la realizzazione delle strade che percorrono la penisola e tutti i paesi via via conquistati non possonoprescindere dal fatto che esse non sono state solo percorse da uomini ed eserciti, mahanno attraversato vastissime estensioni di territorio non sempre controllato diretta-mente da Roma, sono state curate, manutenute e attrezzate (attraverso la creazionedi luoghi di sosta e di controllo, di mercati), mettendo in moto una pluralità di opera-zioni e di soggetti che hanno contribuito a quell’integrazione tra romani e indigeni cheè un’altra delle facce dell’imperialismo dell’età repubblicana: la conquista senza armi.5
Queste ed altre variabili spiegano l’intreccio che si verificò ad un certo momento trapolitica, economia, privilegi e arricchimenti nati dall’espansione militare, dall’occu-pazione di vaste porzioni dell’ager publicus e dalla speculazione commerciale e dannoconto delle premesse della crescita economica dell’Italia tardo-repubblicana. Della valenza economica degli investimenti nelle colture intensive (vino, ma anche olio) i ce-ti abbienti erano perfettamente consapevoli, benché la tentazione della rendita “bassae certa”, ma anche di più lucrosi guadagni (attraverso il prestito di denaro, ad esem-pio) condizionasse le loro scelte. La diversificazione degli investimenti si rapporta aquel grado di calcolo economico di cui le fonti ci hanno lasciato testimonianza (dallecolture estensive all’allevamento transumante e all’economia della selva, a cui furonodestinati prevalentemente gli agri dell’Italia centro-meridionale, dalle manifatture ur-bane al commercio e all’usura) e alla complementarietà delle risorse a cui attingere.
I vigneti potevano nascere perciò solo se si era disposti a scegliere terre idonee alloro sviluppo (non necessariamente contigue) e ad investire capitali in un’attività chenecessitava di tempo e di particolari cure per dare risultati consistenti.6 Poiché le dif-
1 Elementi fondamentali della rivoluzione urbana romana, e più in generale della «new space econo-my»: Laurence 2001.
2 Del 312 è l’Aqua Appia contemporanea alla costruzione della via Appia (Appio Claudio Cieco); del 273è l’Anio vetus (M’. Curio Dentato): questi due acquedotti sono indizio di una popolazone urbana in cresci-ta, così come avverrà un secolo dopo con la realizzazione nel 144 dell’Aqua Marcia e nel 125 dell’Aqua Tepula.
3 V. la bonifica del lago Velino effettuata nel 271 da M’. Curio Dentato, che rese coltivabili le terre delReatino.
4 Sul rapporto tra politica e commercio, tra stato romano e commercianti (mercatores e negotiatores) inetà repubblicana si rimanda alle posizioni coerentemente sostenute nel corso di tutte le sue ricerche da J.Andreau (indifferenza dello stato nei confronti del commercio, nessun condizionamento del ceto mercan-tile nelle scelte politiche o militari di Roma: un sistema, quello adottato dallo stato, in sostanza basato sullaisser faire: Andreau 2003). Di segno diverso è il quadro delineato da Harris 2003, che indica, pur denun-ciando la scarsezza o la reticenza delle fonti letterarie soprattutto per il iii e il ii secolo, momenti e occa-sioni in cui è possibile scorgere traccia di interventi di Roma in favore del commercio e dei suoi attori (tratali interventi anche quelli infrastrutturali). La bibliografia contenuta in entrambi questi contributi dà con-to del dibattito sul tema. 5 Cassola 1991.
6 Manodopera qualificata, mezzi di stoccaggio per far invecchiare il vino con tutti i rischi della perditadi intere partite a causa di sistemi di conservazione primitivi, necessità di attendere più anni per vendere ilricavato delle vendemmie rendevano oneroso l’impianto e la gestione dei vigneti. Lunghi erano anche itempi di attesa perché le vigne diventassero produttive e redditizie. Dopo l’acquisto a poco prezzo di unpraedium suburbanum nell’ager Nomentanus a dieci miglia da Roma, il ricco grammatico Remmio Palemone(intorno al 50 d.C.) aveva impegnato forti somme per impiantarvi viti celebri per le loro rese, ma le entra-te, anch’esse straordinarie, erano giunte solo dopo otto anni: fonti e discussione in Kolendo 1994, pp. 61-62. Il terreno fu acquistato in seguito da Seneca.
62 clementina panella
ferenze tra le varietà erano grandi, il vino non è mai stato un bene economicamenteomogeneo.1 Una prima distinzione riguardava l’età, ma per realizzare dei prodottipregiati (i vini nobili) entravano in gioco anche altri elementi quali il tipo dei vitigni,le caratteristiche dei terreni, i fattori climatici, i sistemi di coltivazione e i processi divinificazione e di invecchiamento.2 La messa a coltura a fini speculativi della vite (edell’olivo) ha generato concentrazione fondiaria, sfruttamento diverso dell’agro pub-blico ed espropriazione della piccola proprietà contadina, con conseguenti endemi-che crisi sociali.3 Quest’ultima ha continuato ad esistere in tutti i territori dell’Italiaantica e a produrre per secoli vini rustici per l’autoconsumo o per i mercati locali e re-gionali,4 ma solo i ceti abbienti disponevano di proprietà di una certa estensione5 e
1 Le anfore di Astura possono essere messe in relazione con Caecubum vinum, quelle di Fondi con il Fun-danum, quelle di Sinuessa con il Falernum, cioè con alcuni dei vini nobili dell’età tardo-repubblicana. Plinio(NH, xiv, 87 e 94-97) fa risalire la nascita della denominazione di origine al 121, cioè al consolato di Opimio,mentre Cicerone (Brutus, 287) fa riferimento al consolato di Anicio del 160 (Tchernia 1986, p. 60 sgg.).Un’iscrizione dipinta su un’anfora probabilmente grecoitalica dalla necropoli di “Le Saliere” a Capena conla menzione proprio del consolato di L. Anicio Gallo del 160 potrebbe fornire una conferma a questa datapiù antica, qualora la lettera F, che chiude il titulus, alludesse al F(alernum vinum) (cil i2, 2929). Ancora piùrisalente è la coppia consolare del 182 documentata su una grecoitalica di Bolsena, che segnala con la suapresenza un vino di “annata” (altrimenti perché riportare la data?). Il silenzio delle fonti per il vino di Min-turno urta contro l’evidenza archeologica, come accade per il vino del territorio di Cosa. Le anfore indica-no che esisteva già dal iii/ii secolo in questi due territori una viticoltura con eccedenze destinate al-l’esportazione, ma essa evidentemente non ha dato luogo nel lungo periodo a vini di qualità.
2 Alla varietà dei vini corrispondevano prezzi diversi (agli inizi del iv secolo d.C. l’Editto dei prezzi diDiocleziano, ii, 8-10, registra un rapporto di prezzo tra vino vecchio e vino dell’anno di 2:1, mentre quellotra vini di pregio e vini ordinari poteva essere di 4:1, poteva raggiungere valori di 10:1 e superare ampia-mente questo rapporto) e una differente destinazione commerciale. Il numero di dolia (100) che Catone pre-vedeva nel suo praedium e la notazione dei manoscritti indicano che egli intendeva conservare il vino di cin-que vendemmie, con tutti i rischi che il lungo stoccaggio comportava, evidentemente perché ritenuto piùredditizio. Su queste tematiche si rimanda a Tchernia 1986, pp. 28-39 e a Carandini 1989b, p. 506.
3 Su di esse e sugli strumenti messi in atto dal governo romano (v. la legge de modo agrorum, volta a li-mitare i danni di un incontrollato sfruttamento privato dell’ager publicus) per far fronte alla trasformazionedegli indirizzi economici dopo la guerra annibalica, si rimanda a Gabba 1990b, in part. pp. 273-283.
4 Tchernia 1986, p. 115: «Une vigne qui on travaille des ses propres mains et dont on vend le vin à peinfait ne coûte pas très cher à entretenir…Les plantes constituent la séule depense d’investissement impor-tante. Le petit proprietaire ou le colon partiaire, en période d’expantion des vignes et de montée des prix,peut être tenté par l’aventure».
5 I fundi nella logica di Catone e degli agronomi dovevano rispettare due regole, non essere troppo pic-coli, né troppo grandi: nel primo caso il vilicus, lo schiavo-manager che soprintendeva alla proprietà, sareb-be risultato sotto-occupato, nel secondo la sua sorveglianza non sarebbe stata sufficiente: Lo Cascio 2009,p. 29. Il fundus (ideale o reale – unità produttiva o unità di management), su cui Catone esercita le sue pre-scrizioni, destina alla vigna 100 iugeri (= 25 ettari) con 16 schiavi e all’oliveto 240 iugeri con 12 schiavi (Cato,de agr.,10-11; v. anche de agr., 3, 5 ove vengono indicate dimensioni leggermente diverse). Abbiamo qualchestima relativa alle dimensioni di alcuni fundi intorno a Roma: di 120-140 iugeri in età medio-repubblicana sa-rebbe l’estensione di quello spettante alla villa dell’Auditorium, ampliato forse a 240-280 iugeri (pari a 60/70ettari) in età tardo-repubblicana: C. Pavolini, in Auditorium 2006, pp. 48 e 52, passim (di dimensioni inferiorisarebbero quelli del suburbio sud-orientale, secondo le ipotesi di Volpe 2004, v. oltre, p. 71, nota 7). Gli ap-pezzamenti nelle aree più fertili dell’ager Veientanus sarebbero in media di 300 iugeri contro i 500 iugeri =124 ettari della villa di Settefinestre attribuita ai Sestii nel i secolo; tale è l’estensione supposta per le 35 villedella Valle d’Oro, pari a due unità della centuriazione a cui queste strutture sembrano adeguarsi: M. G. Ce-luzza, E. Regoli, in Settefinestre 1985, i, pp. 49-59, in part. p. 53. D’altro canto, com’è noto, più appezzamentianche non contigui potevano appartenere ad uno stesso dominus secondo criteri di concentrazione fondia-ria caratteristici della tarda repubblica (Q. Roscio Amerino aveva nell’81 tredici proprietà nella valle del Te-vere: Cic., Rosc., 6; 20: Di Giuseppe 2009, p. 452; v. anche Coarelli 1986, p. 42, che fa riferimento alla si-
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 63
potevano mettere in atto investimenti per l’acquisizione dei mezzi di produzione. Iprincipi di eleganza alimentare collegati al consumo del vino, che si diffondono a Ro-ma a seguito degli arricchimenti successivi alle guerre di conquista, spiegano perchégli appartenenti agli ordini superiori della società (senatori, cavalieri, élites locali) ab-biano costituito delle grandi cantine quando ancora i vini greci erano i migliori (tra ipiù apprezzati quelli di Chio e di Lesbo), ma anche perché a partire da un determi-nato momento con un accelerazione nel ii e i secolo, abbiano cominciato essi stessia praticare nei loro fundi la viticoltura, investendo denaro in un’attività che necessita-va, come già detto, di particolari attenzioni per essere redditizia. Il vino, che era di-ventato un elemento di status, riflesso del lusso e dell’arte (arte anche in rapporto aiprocessi di vinificazione su cui interveniva la tradizione, ma anche il genio persona-le)1 si trasformava così in un nuovo ed ulteriore mezzo di arricchimento delle classidominanti. D’altro canto la rovina dei contadini romani ed italici va anche cercata nelprezzo che avevano pagato in termini di uomini nelle guerre tra il iv e la metà del iisecolo a.C. e nell’arrivo in Italia a seguito delle conquiste territoriali, di un’enormeforza-lavoro gratuita costituita da centinaia di migliaia se non milioni di schiavi, ben-ché si ritenga che – sul piano del sistema – lavoro libero e piccola proprietà siano sta-ti funzionali alla villa schiavistica e ne abbiano garantito esistenza ed efficienza.2 Il lo-cale e il globale in sostanza non si escludono in quel dualismo ritenuto caratteristicodell’economia romana che vede coesistere nello stesso tempo e nelle stesse aree pro-duzioni il cui valore consisteva nell’autoconsumo da parte dei produttori (valorid’uso) e produzioni immesse nei circuiti commerciali (valori di scambio).
«La comparsa del modo schiavistico di produrre non appare … come un fenomenoconclamato e improvviso, ma si presenta in termini di trasformazione. Ma le trasfor-mazioni possono implicare a volte mutamenti straordinariamente rilevanti, quandopersistono e si incrementano nel tempo».3 Le ville pre-catoniane (alto- e medio-re-pubblicane) scoperte nel suburbio, nel Lazio, in Campania talvolta sotto strutture piùrecenti che ne modificano e/o ne moltiplicano gli spazi e le funzioni, tendono a con-fermare la precocità del fenomeno (rispetto alle ricostruzioni pregresse) e consento-no di osservarlo con maggior esattezza.4 La continuità tra media e tarda repubblica èriflessa nelle preesistenze, le trasformazioni nell’intensificarsi dello sfruttamento del-le risorse con un aumento dei siti messi a coltura e/o con il rinnovo delle piantagio-ni, nelle nuove configurazioni architettoniche degli edifici, nello sviluppo della pro-
tuazione di alcune zone del suburbio di Roma tra i secolo a.C. e i secolo d.C.). In tale quadro rientrano igrandi patrimoni di quest’età: Cn. Pompeius Magnus possedeva agri Lucani (Cic., Phil., 13, 12), terre in Cam-pania (a Formiae: Cic., ad Att., 7, 8, 4; 15,13, 5; Phil., 13, 11; nell’ager Falernus: Cic. Phil., 13, 11; Serv., ad ecl., 9, 36;a Cuma: Cic., ad Att., 4,10, 2; a Baiae: Sen., Ep., 51, 11); ad Alsium (Cic., Mil., 54), forse a Taranto, una casa for-se a Neapolis (Cic., ad Att., 4, 9, 1): Shatzman 1975, pp. 389-393. Per la diversificazione operata da questo per-sonaggio nei suoi investimenti fondiari e immobiliari (villa d’ozio a Baia, allevamento in Lucania, lana a Ta-ranto (?), vino altrove) v. Plin., NH, xviii, 35. Anfore con bolli che riportano il suo nome, trovate in marepresso Civitavecchia e nell’entroterra di Pantelleria, provengono probabilmente dalla regione vesuviana(Manacorda 2005, con bibliografia). Un ulteriore indizio dei suoi rapporti con il commercio si ricava dal-l’iscrizione dedicatagli a Roma dai negotiatores italici impegnati nei traffici con la Sicilia (cil vi, 40903 = cil
i2, 2710 = illrp, 380; Amela Valverde 2006).1 Tchernia - Brun 1999, p. 38. 2 Lo Cascio 2009, p. 176.3 Carandini 2009, p. 305. 4 Carandini 2009, pp. 305-308.
64 clementina panella
duzione in massa della ceramica fine da mensa (Campana A classica, ma anche Cam-pana B), di qualità non eccelsa, ma diffusa “a buon mercato” in maniera altrettantoconsistente, nell’incremento della produzione e della commercializzazione dei viniaffidati alle grecoitaliche nelle versioni degli inizi/prima metà del ii secolo e poi do-po il 150/125 in modo massiccio alle Dressel 1 e Lamboglia 2. Generalizzando e in ri-ferimento ad alcuni territori della penisola (il “rettangolo manifatturiero” come lo hadefinito A. Carandini),1 ciò che sembra nel lungo periodo scandire le discontinuità èil progressivo cambiamento di scala della produttività della campagne, che presup-pone un aumento della domanda (v. la progressiva crescita demografica di Roma epiù in generale per l’Italia il fenomeno dell’urbanizzazione che è il risultato della ro-manizzazione con conseguente diffusione di pratiche alimentari – dalla puls al pane –tra le quali vi è il consumo di vino), ma anche modifiche nei sistemi di sfruttamentoe della struttura sociale. Il cambiamento insomma non è solo quantitivo: “da unoscambio senza valorizzazione, cioè senza processo di accumulazione, si passa ad unoscambio che presuppone la formazione e la successiva valorizzazione del capitalecommerciale sulla base di una vera e propria accumulazione precapitalista”,2 cioè al-la “mercantilizzazione dell’economia agraria”.3
Inoltre, se la razionalizzazione produttiva e tecnologica4 dei mezzi di sussistenzapuò essere considerata un fattore “endogeno” da considerare nello sviluppo econo-mico che coinvolge tra gli ultimi decenni del iii e il ii secolo il mondo delle campagne,occorre anche ricordare che vi è stata in quei decenni una crescita rapida e completa-mente “esogena” delle risorse disponibili, in seguito alle confische ai danni delle co-munità dell’Italia meridionale che avevano defezionato durante la guerra annibalica eche alla sua conclusione furono seriamente punite, e in seguito a quell’“espansioni-smo di rapina” che connota la politica romana in Italia e nel Mediterraneo dell’età re-pubblicana5 con conseguente dichiarata ricerca di arricchimento dei protagonisti diquegli eventi.6 In questo quadro non vanno dimenticati né l’arrivo in massa in Italia, aseguito delle conquiste territoriali, di forza-lavoro gratuita costituita dagli schiavi, nél’assimilazione delle esperienze di altri ambienti (Sicilia, Africa, Oriente).
1 Carandini 1988; Carandini 1989b. In tale fascia di territorio trovano posto nel ii secolo le villed’ozio, ma certamente anche di produzione dell’altissima aristocrazia senatoria tardo-repubblicana, notedalle fonti e riproposte su carta da Carandini 1988, p. 301, fig. 4 (v. Tchernia 1986, pp. 64-65 e per il i se-colo pp. 116-118; sulle ville vesuviane, D’Arms 1984). Si tratta delle villae di Catone (a Venafro tra il Lazio ela Campania, ma anche a Tuscolo in Sabina non lontano dal praedium di Valerio Flacco e di M’. Curio Den-tato), di P. Cornelio Scipione Africano (a Literno), di M. Emilio Lepido (a Terracina, dove con i fondi pub-blici aveva fatto costruire una diga per valorizzare i suoi terreni), di L. Emilio Paolo (a Velia), di Sex. Sulpi-cio Galba (a Terracina e Minturno), di C. Lelio (a Pozzuoli e Formia), di Q. Fabio Massimo (nell’agerFalernus): Shatzman 1975, pp. 241-261. Negli esempi citati è il litorale da Sperlonga a Formia e da Capo Mi-seno a Cuma e a Pozzuoli, che sarà investito nella tarda repubblica dalla costruzione delle ville marittime,come la villa Prato di Sperlonga del terzo quarto del ii secolo (Broise - Lafon 2001; Lafon 2001). Fattorideterminanti perché le attività agricole potessero essere remunerative erano anche i rapporti tra la distan-za e il luogo di lavoro, la facilità di trasporto e il valore relativo del prodotto. In Etruria le ville di coloro checontavano in età tardo-repubblicana si trovavano non oltre Alsium (a un giorno di viaggio da Roma), le al-tre a tre giorni di viaggio: Carandini 1994, p. 169.
2 Schiavone 1989, pp. 23-24. 3 Lo Cascio 2009, p. 45.4 Sull’innovazione tecnologica in rapporto alla crescita economica in età romana si rimanda ai saggi
contenuti in Lo Cascio 2006. 5 Schiavone 1989, p. 36 sgg.6 V. la laudatio funebris di L. Cecilio Metello pronunciata dal figlio nel 221, di cui un passo è riportato da
Plin., NH, vii, 139; commento in Gabba 1981.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 65
Infine, se è possibile in alcuni casi intravedere una continuità di sviluppo della villain ambito laziale-campano fino al suo esito nell’azienda catoniana, la continuità nonsembra reggere qualora si confronti quel poco che conosciamo (non solo per difettodi documentazione) della situazione insediamentale del Lazio, della Campania e del-l’Etruria a partire dal tardo iv secolo con quella della prima metà del ii secolo che ve-de una moltiplicazione delle ville di tipo catoniano, oltre che sugli insediamenti piùantichi, anche in zone (di pianura e costiere) fino ad allora apparentemente non col-tivate, nonché l’occupazione di terre marginali (da parte dei contadini liberi?).1 Nellastessa direzione vanno i dati ricavabili dalla cultura materiale, quali l’esportazione inrealtà ancora modesta tra fine del iv e la fine del iii secolo delle merci italiche rispet-to alla diffusione mediterranea della prima metà e soprattutto della seconda metà delii secolo. La base della forza-lavoro si rispecchia nelle centinaia di nomi servili im-pressi sulle Dressel 1, sulle Lamboglia 2 e sulle anfore ovoidi di Brindisi,2 che provanol’importanza e il rilievo degli schiavi nella conduzione delle manifatture di anfore e,da qui, incontestabilmente, nella lavorazione dei campi.
La sete di Roma
Ritornarnando al punto di partenza di questo intervento, Roma appare poco coin-volta dalla circolazione della Campana A (arcaica, antica, media o “classica” e tarda),cioè dei vasi a vernice nera di Neapolis nelle diverse fasi corrispondenti all’attività del-le sue officine, anche nel ii secolo, quando esse producono ed esportano milioni dipezzi.3 Per la ceramica fine da mensa, questa “anomalia” (c’è più Campana A a Mar-siglia che a Roma) si spiega con la presenza a Roma e nelle sue vicinanze di ateliers cherealizzano una ceramica di buona qualità che ha continuato a rifornire la capitale da-gli ultimi decenni del iv secolo fin quasi – sembra – al declino del vasellame a verni-ce nera. È pertanto la ceramica “locale” che respinge verso il Nord (Gallia) e versoOvest (Spagna, Nord-Africa) la produzione campana (inclusa quella di Cales). Un fe-nomeno analogo sembra riguardare anche le anfore: grecoitaliche, Dressel 1, Lam-boglia 2 sono attestate in tutti i contesti di età medio- e tardo-repubblicana di Romache abbiano restituito questa classe di manufatti, ma in quantità, come si è detto al-l’inizio, finora assai modeste. Va detto che le stratigrafie spettanti all’età repubblicanasono nel complesso molto poche per una serie di motivi abbastanza ovvi: mancanza
1 Di qui, nei risultati delle ricognizioni, le distinzioni percentuali – nella lunga e nella breve durata – trai siti che continuano a fornire testimonianza di occupazione, quelli abbandonati e quelli di nuova forma-zione, nonché tra le fattorie e le ville che continuano ad esistere in quanto tali e tra le ville o le fattorie chevengono abbandonate (Di Giuseppe - Patterson 2009; Carandini 2009; Di Giuseppe 2009). Un gioco didati che è fondamentale in quanto la scomparsa delle fattorie può significare in qualche caso accorpamen-ti proprietari, cioè nascita di più estese unità fondiarie (è ciò che sembra accadere in alcuni momenti dellastoria dell’occupazione dei territori della valle tiberina: Di Giuseppe 2005a, pp. 19-22) e forse, in qualche ca-so, nella nascita di una vera e propria villa. Risultati relativi ad occupazione, creazione e dinamismo del-l’occupazione rurale nella Campania settentrionale sulla base del numero dei siti “vivi” e dei siti “nuovi”per grandi tagli cronologici in Vallat 2001.
2 I 2/3 degli individui che bollano le anfore italiche di età repubblicana sono schiavi: Nonnis 2003, p. 251.Sul loro ruolo nella produzione anforaria rimando a Manacorda 1989, pp. 453-463.
3 Stimati a 9 milioni i vasi in Campana A che avrebbero raggiunto la Gallia tra il 200 e il 50; altrettantisarebbero stati spediti verso l’Italia, la Spagna, l’Africa, la Sicilia e le altre isole del Mediterraneo occidenta-le: Morel 1998b, p. 487; Morel 2005, pp. 102, 104; Morel 2008, p. 165-169.
66 clementina panella
di attenzione negli scavi del passato per i reperti comuni con conseguente perdita del-la documentazione relativa alla cultura materiale; uso millenario dello spazio urbanocon cancellazione di intere sequenze insediative; natura dei ritrovamenti fondamen-talmente costituiti per l’età medio-repubblicana da depositi votivi, che per loro natu-ra non contengono anfore. Anche in scavi recenti (v. i dati dell’area della Meta Sudansmenzionati da Volpe 2009) strati di questo periodo sono stati raggiunti solo in picco-le porzioni di terreno, tagliati e ritagliati dagli interventi edilizi posteriori, antichi epost-antichi. In tali condizioni è impossibile recuperare materiale quantitativamentee statisticamente significativo, cioè materiale utilizzabile ai fini di una ricostruzionedei consumi urbani.
Benché non si possa escludere l’esistenza di un “Testaccio” repubblicano,1 l’im-pressione che si ricava dai dati editi e da quelli inediti (penso in particolare al mate-riale dello scavo che dirigo sulle pendici nord-orientali del Palatino, che ha restituitoe sta restituendo stratigrafie che si iscrivono in quest’arco cronologico) è che, in con-fronto ad altre classi ceramiche, le anfore siano realmente poche. Per dare un’idea del-l’inconsistenza dei dati che possediamo per Roma, si ricorda che tra il terzo quartodel ii secolo e la prima metà del i secolo sono stimate a 60 milioni le anfore tirrenichedi forma Dressel 1 che raggiungono la Gallia.2 Anche in questo caso si può dire, ri-chiamando l’osservazione di Morel sulla Campana A, che «vi sono più Dressel 1 a Bi-bracte o a Vieille-Toulouse che a Roma». Abbiamo già menzionato i rapporti percen-tuali tra le anfore da trasporto e le altre classi ceramiche in quei pochi contesti dellacittà di età medio- e tardo-repubblicana per i quali sono disponibili dati quantitativi (v.sopra, p. 16, nota 1). Per le grecoitaliche in particolare occorre segnalare pochissimealtre presenze edite a Roma, ma si tratta di qualche unità, che fuoriesce (anche a cau-sa del modo di edizione) da ogni valutazione di tipo statistico.3 Se non vi è dubbio che,qualora si scavino a Roma stratigrafie di quest’età, compaiano anfore vinarie italicheinsieme a pochi altri contenitori di altra tipologia e origine, è altrettanto vero che gliindici di presenza complessivi di questa classe di materiali sono assai bassi, se con-
1 Le assenze riscontrate a Roma potrebbero dipendere anche dal fatto che gli scavi non hanno indivi-duato zone riservate alla raccolta dei “vuoti a perdere” di quest’età, laddove il Testaccio dall’età imperialefornisce la prova dell’esistenza di luoghi (in questo caso prossimi all’Emporio) destinati agli immondezzaiurbani (ma solo delle anfore olearie per loro natura non riutilizzabili, frantumate e scaricate presso il por-to fluviale: Rodriguez Almeida 1984). Il dubbio che qualcosa di simile possa essere esistito anche in etàrepubblicana, per le anfore vinarie, nasce dal recente ritrovamento per la costruzione di un mercato pro-prio nell’attuale quartiere Testaccio di muri di anfore intere (soprattutto Lamboglia 2, Dressel 6A e Dressel1B), riutilizzate per una prima sistemazione del sito, su cui nasceranno agli inizi del ii secolo d.C. magazzi-ni di stoccaggio di contenitori vinari (Sebastiani - Serlorenzi 2008). Sulla collocazione presso Ripetta delportus Vinarius, ove giungevano soprattutto i prodotti trasportati via Tevere e nelle cui vicinanze potrebbe-ro essere immaginate discariche, v. ltur, s.v. (F. Coarelli). Altre strutture, che potrebbero essere a questoproposito chiamate in causa, sono le banchine in opera reticolata/mista, documentate in passato pressoPonte Milvio, da riconnettere anch’esse ai trasporti fluviali provenienti dal Nord. In realtà sembra che siaesistito da questo ponte fino a ponte Mazzini un vero e proprio sistema di docks e, che doveva servire sia leville della via Flaminia, sia l’intera città (C. Pavolini, in Auditorium 2006, pp. 52-53, nota 47).
2 Tchernia 1986, p. 86.3 Dall’aedes Portuni nel Foro Boario provengono anfore che dalla descrizione dovrebbero appartenere al-
le forme Van der Mersch iii, v e vi; da Largo Argentina un esemplare del tipo Van der Mersch vi; dai pozzidel Quirinale, insieme con ceramica a vernice nera etrusco-laziale e “romana” prevalentemente di iii seco-lo, un’anfora di piccolo modulo di tipo Van der Mersch v/vi: bibliografia in Van der Mersch 2001, p. 171.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 67
frontati con quelli che spettano a tutta la ceramica documentata negli stessi contesti.Le percentuali saliranno solo in età cesariano/augustea, quando i contenitori da tra-sporto (ma allora la documentazione riguarderà – per le anfore italiche – le Dressel 1e le Lamboglia 2) rappresenteranno il 30% dell’insieme dei reperti.1 D’altro canto lepresenze delle grecoitaliche e delle Dressel 1 sono scarse anche nel Suburbio, in zone,cioè, in cui gli interventi edilizi antichi non sono stati così massicci come nel centrourbano (a distruggere ci ha pensato però l’espansione della città contemporanea) e ri-sultano assai modeste anche in alcuni territori prossimi alla città.2 Nessun bollo suqualsiasi tipo di grecoitalica è attestato a Roma, due (in latino) sono quelli di Ostia fi-nora pubblicati.3
Per quanto riguarda l’origine di questo materiale, va detto che nei contesti di pro-venienza di iv e iii secolo le grecoitaliche sono associate quasi esclusivamente ad in-siemi ceramici centro-tirrenici prodotti a Nord e a Sud del Tevere, a Roma stessa (va-si dell’atelier des petites estampilles, piattelli di Genucilia, pocola, ecc.), o nel Laziosettentrionale (ager Faliscus) o nell’Etruria meridionale (ager Caeretanus), mentre assaiscarsa è la presenza della ceramica della Campania, a qualunque centro si voglia fareriferimento (Paestum, Capua, Neapolis…). Nello stesso tempo il Mediterraneo occi-dentale è interessato dal flusso di esportazioni del vasellame fine di ambito etrusco-laziale. Queste osservazioni sostanziano l’ipotesi già formulata4 che quest’ultima areaabbia prodotto anche anfore collegate ai tipi Van der Mersch iii-vi. Il che serve a direche non tutte le grecoitaliche rinvenute a Roma debbano essere necessariamente“campane” (o magnogreche/siciliane), anche se appare sempre più convincente l’as-sunto che commercio di ceramica e commercio vinario abbiano seguito, come di-mostra ad esempio la documentazione di Cartagine, “vie” separate almeno rispettoai punti di arrivo (v. Appendice ii). Se questo è vero, l’associazione nei depositi di Ro-ma di un certo tipo di vasellame fine e di un certo tipo di anfore non autorizza a sup-porre necessariamente una loro origine comume.
Essendo così rari gli indicatori, Roma sembra (il verbo è d’obbligo) interessata adacquisire (e per secoli) solo modeste quantità di vino dall’esterno. Tale situazione ri-chiede una spiegazione, essendo impensabile che i Romani che popolavano la città eil territorio (le stime sono dubbie, ma i numeri sono alti: 250.000 maschi adulti, cioè
1 Scavo del Palatino settentrionale diretto da A. Carandini: tesi di laurea di E. Lorenzetti; in contesti dietà augusteo-tiberiana dello scavo delle pendici nord-orientali del Palatino tale percentuale raggiunge il 50%(tesi di laurea di D. Greco).
2 V. i dati del Tiber Valley Project: Di Giuseppe - Patterson 2009, p. 18, fig. 4. Nel confronto quantitivo ditutte le classi di materiale raccolto (53.432 frammenti di ceramica appartemente a tutti i periodi documen-tati, fino cioè all’età tardoantica), il 5,6% appartiene alle anfore, contro il 39,7% della ceramica fine e il54,6% delle ceramiche comuni. Il dato, da prendere con cautela perché nelle ricognizioni si recupera in ge-nere ciò che si riconosce, indica comunque una certa autosufficienza di risorse alimentari delle campagne.Grecoitaliche dei tipi Van der Mersch v, vi e v/vi sono segnalate nell’ager Portuensis negli scavi già men-zionati della Soprintendenza Archeologica di Ostia (v. sopra, p. 12, nota 2). Grecoitaliche del tipo Van derMersch v vengono anche dai sondaggi effettuati sulla via Campana (presso la moderna via Portuense al km17,500) in fase con la costruzione della carreggiata più antica, datata alla fine iv/prima metà iii secolo (Ser-lorenzi et alii 2004, pp. 61-63; Di Giuseppe - Serlorenzi 2009, p. 585, fig. 10, 6-7), ma in questo caso sem-bra si tratti di qualche unità.
3 VOM[- - -] o MOV[- - -] (retro., lettura che mi sembra improbabile) e ANTI + simbolo(?): CIL I2, 3545,tav. 122, fig. 5 (ANT in nesso); RTAR i, 1.
4 V. sopra, p. 13, nota 1 per gli indizi dell’esistenza di fornaci di grecoitaliche a Pyrgi e a Graviscae.
68 clementina panella
750.000 abitanti tra città e un ager più ampio nel iii secolo dell’attuale suburbio)1 nonabbiano bevuto vino, elemento-base per altro nella dieta mediterranea e già da tem-po a Roma simbolo di acculturazione. Il iv secolo è il momento in cui si passa nelmondo latino come in quello italico da una pratica elitaria alla quotidianità del con-sumo.2 Anche assumendo un dato leggermente più basso per la popolazione (200.000abitanti nel 225 di cui 150.000 liberi e 50.000 schiavi)3 – esponenzialmente in crescitatuttavia fino al milione di abitanti dell’età augustea – le cifre del consumo risultanomolto alte, se si tiene conto che Catone dava vino (poco) anche ai suoi servi e chenel ii secolo cade l’interdizione del consumo di vino alle donne.4 E quella che ha for-nito R. Volpe, appoggiandosi a dati archeologici, è senza dubbio una ricostruzioneattendibile: il vino per Roma verrebbe dal suburbio intensamente coltivato a vigne-to, come documentano gli scassi per le viti databili grosso modo a questo periodo ri-trovati un po’ ovunque nelle zone prossime alla città più idonee per la qualità dei suo-li all’impianto di colture intensive.5 La produzione, calcolata in base a tali tracce e allestime delle rese dei vigneti fornite dagli agronomi latini (assai dibattute dalla storio-grafia moderna), sarebbe sufficiente sul piano teorico a rispondere alla domanda ur-bana, benché la distanza tra i filari e il tipo stesso di coltivazione promiscua (cereali,ortaggi, legumi) comportino una bassa produttività.6 Le modeste distanze7 e mezzidi trasporto quali i carri e gli animali da soma giustificherebbero l’impiego di conte-nitori in materiale deperibile (otri) piuttosto che di anfore, funzionali per forma e di-mensioni solo al trasporto marittimo. Una percentuale non quantificabile di vino po-trebbe venire dalla valle del Tevere e dell’Aniene su zattere per via fluviale, trasportata anch’essa in otri, almeno in questa età,8 né vanno esclusi arrivi dai ColliAlbani, dove il vitigno dell’Eugenia si era acclimatato forse già nel iv secolo dandoorigine ad un grand cru (v. sopra, p. 59, nota 5). Le importazioni del vino in anfore (do-cumentate dalle poche grecoitaliche ritrovate) si riferirebbero a vini di qualità, in cer-to modo “esteri”.
1 Volpe 2009, p. 380, nota 33, con bibliografia. 2 Van der Mersch 1994, pp. 123-125.3 Secondo i calcoli di Morley 1996 ripresi da Lo Cascio 1999, p. 223. V. anche Tchernia 2000, con
ipotesi di consumo di vino e di altre derrate di prima necessità (grano, olio) a Roma nella fase di massimacrescita urbana; sul numero raggiunto dalla popolazione in età imperiale, fonti archeologiche e discussio-ne in Coarelli 2000.
4 L’ultima trasgressione alla norma che impediva alle donne di bere vino, introdotta secondo la tradi-zione dal re Numa, è, secondo Plinio, del 194 (NH, xiv, 90).
5 L’archeologia preventiva con i suoi interventi su vaste aree al di fuori dei conglomerati urbani ha con-sentito di individuare in molte zone l’esistenza di questo tipo di apprestamenti che si integrano oggi alle ri-cerche sugli insediamenti rurali (bibliografia in Volpe 2009, pp. 369-370; per le tracce di scassi per vigne nel-la Francia meridionale v. Brun 2004, pp. 203-207 e Boissinot 2007).
6 Volpe 2009, p. 380, nota 33. Si tratta di proiezioni su un campione che rimane ridotto e che soprattut-to va sostanziato e potenziato con lo studio degli stabilimenti rurali.
7 Sei km, percorribili a piedi in due ore utilizzando la via Labicana, dividono il pianoro di Centocelle coltivato a vigneto dai mercati cittadini. Sull’estensione del suburbio in relazione ai tempi e ai mezzi di trasporto per raggiungere l’abitato, v. Arnaud 1998.
8 A partire dall’età tiberiano-claudia fino a tutto il ii secolo d.C. una piccola anfora a fondo piatto detta“di Spello” testimonia l’esistenza di un contenitore ceramico utilizzato per il trasporto a Roma dei vini del-la media e bassa valle del Tevere: Rizzo 2003, pp. 149, 209, con bibliografia. Sulla navigabilità del fiume finoalla villa di Plinio il Giovane a San Giustino, v. Molina Vidal 2009, pp. 227-230, passim.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 69
Lo sfruttamento del suburbio per colture pregiate (e al vino occorre aggiungere l’olio,la frutta, gli ortaggi) in età medio- e tardo-repubblicana, così come è oggi ricostrui-bile, fa uscire la zona più prossima alla città dall’economia di sussistenza che era sta-ta fino a tempi recenti la chiave di lettura dell’agricoltura praticata dai popoli latini neliv e in buona parte del iii secolo: superfici coltivate di modesta o modestissima esten-sione, infrastrutture rudimentali, culture arbustive marginali. Secondo tale ricostru-zione (il “modello tradizionale”) vi sarebbe una netta distinzione tra la situazione deliv-iii secolo, epoca nella quale la viticoltura sarebbe stata un’attività di complemen-to che non avrebbe oltrepassato il quadro di una coltura “vivrière”, e il ii secolo, epo-ca che avrebbe visto l’impianto di una attività vitivinicola strutturata.1
La documentazione oggi raccolta sui vigneti del suburbio non fornisce elementi ta-li da consentire l’individuazione di ambiti cronologici molto precisi,2 essendo già stra-ordinario che queste tracce di coltivazioni (trincee parallele tagliate nel tufo, canaliz-zazioni, pozzi, cisterne, strade poderali) possano essere assegnate ad età repubblicana(in qualche caso anche alla prima età repubblicana), possano essere collocate in unorizzonte di uno o due secoli (soprattutto iii e iii/ii) e collegate in qualche caso conedifici a cui il fundus lavorato a vigna apparteneva.3 Con tutti i limiti dovuti a datazioniindiziarie, l’analisi di questo vero e proprio palinsesto produttivo del suburbio roma-no ha dimostrato che i territori intorno a Roma potevano avere una capacità e un’or-ganizzazione della produzione in grado di soddisfare la domanda di vino di decine dimigliaia di individui, domanda superiore a quella di qualsiasi altra area interessata nel-lo stesso periodo da uno sfruttamento agricolo intensivo (i territori di Neapolis, del La-zio meridionale, della Campania settentrionale, ai quali potrebbero spettare le gre-coitaliche arcaiche ed antiche diffuse oltremare). La dimensione del mercato a cui ilvino era destinato fa intravedere quantità di prodotto superiore a quella riservata alsolo autoconsumo della famiglia contadina o al piccolo commercio, consentendo diallontanare anche per l’ager di Roma di età medio-repubblicana il modello dell’eco-nomia di sussistenza. È alle ville e alle fattorie che costellano il paesaggio intorno al-la città e alle loro trasformazioni nel tempo che va appoggiato lo sviluppo dell’arbo-ricoltura, le cui tracce sono riconoscibili nell’hinterland di Roma anche prima del“miracolo economico” post-annibalico. Mettendo da parte distinzioni non semprepercepibili o accertabili, “ciò che accomuna fattorie e ville è, per un verso, il fatto chele une e le altre corrispondano a terreni sfruttati intensivamente (v. le trincee scavatenel tufo, ndr) e, per un altro verso, il fatto che individuino unità che sicuramente pro-ducono per il mercato”4 (nel caso specifico per quello romano).
In tempi recenti Ch. Van der Mersch ha preso in esame l’insieme delle informazio-ni fornite dalle fonti scritte, dall’archeologia, dalla geografia umana, raccogliendo da-ti (assai dispersi, ma di notevole importanza) sugli esordi della rivoluzione che avreb-
1 Questo “modello” è stato contestato con solidi argomenti già da Torelli 1990, da Tchernia 1986, pp.41-66 e da Van der Mersch 2001, p. 157-159, con bibliografia.
2 V. Volpe 2009, pp. 373-374, tabella 1 e p. 377, tabella 2, per le tracce di arboricoltura rinvenute nel su-burbio in generale e sul pianoro di Centocelle.
3 Le trincee del vigneto della villa della Piscina datate alla prima fase della villa vengono riconfiguratealla fine del ii/inizi del i secolo in concomitanza con la ii fase edilizia: Volpe 2004, p. 459, passim.
4 Lo Cascio 2009, p. 32.
70 clementina panella
be portato nel volgere di un secolo (dal iii al ii secolo) al “vino romano” nell’acce-zione di D. Manacorda e di A. Tchernia.1 Nella sua ricostruzione, in linea con quelladi M. Torelli, il fenomeno si iscrive in un processo di lunga durata all’interno del qua-le casa colonica e villa «existent côte à côte à l’epoque medio-républicaine, reflets dedeux mondes entre lesquels l’écart va se creusant tout au long des guerres samnites,puis de celles contre les cités grecques du Sud et Carthage».2 Se la lunga durata degliinsediamenti trova numerosi riscontri, l’evoluzione di tipo unilineare (teleologica se-condo Capogrossi e Lo Cascio) è stata, come si è già detto, messa in discussione dal-la più recente ricerca storica e dalle indagini sul campo. Le ricognizioni effettuate nelsuburbio romano e nelle aree vicine alla città, volte ad individuare sul terreno la ti-pologia degli edifici rurali, hanno consentito di accertare, per fasce cronologicheomogenee, la contemporaneità di case/fattorie e ville, queste ultime caratterizzate inun primo tempo da una molteplicità di ambienti residenziali e produttivi intorno aduna corte centrale e poi da una separazione più netta tra parte rustica e parte resi-denziale contraddistinta dall’atrio canonico.3 Partendo dai dati dello scavo dell’areadell’Auditorium, A. Carandini fa precedere la villa catoniana lavorata da schiavi coo-peranti (periodo 4, villa 3: 225-80; v. sopra, p. 57, nota 1), in fase con la costruzione del-la via Flaminia del 220, da una villa patrizio-plebea lavorata probabilmente da clienti,da altri liberi e da famiglie di schiavi (periodo 3, villa 2, detta dell’Acheloo: 300-225),4e da una villa patrizia lavorata da nexi5 (periodo 2, villa 1: v-iv secolo), con la quale sirisale alla prima età repubblicana,6 ma avverte che ad ogni fase corrispondono la di-struzione o la destrutturazione dell’impianto precedente; il che rimanda a nuovi as-setti proprietari e a diversa organizzazione del lavoro agricolo e della forza-lavoro.
Gli edifici, a cui le trincee del pianoro di Centocelle e di Torre Spaccata fanno rife-rimento, comparirebbero a loro volta nel iii secolo. La loro realizzazione sembracomportare ora una rete ordinata di appezzamenti ben delimitati, al centro dei qualisorge l’edificio di riferimento in blocchi di tufo.7 Su queste strutture si imposteranno
1 Van der Merch 2001. 2 Van der Merch 2001, p. 193.3 Cifani 1998; Di Giuseppe 2005a; Capanna - Carafa 2009 (con bibliografia sul progetto); Carandi-
ni 2009. 4 Auditorium 2006, p. 191 sgg.5 La forma contrattuale del nexum, il vincolo che comportava la servitù per debiti, fu abolita con la lex
Paetelia Papiria del 326 (Livio) o del 313 (Varrone).6 Carandini 2009, p. 301; Auditorium 2006, p. 103 sgg.; per l’estensione del fondo di riferimento, v. sopra,
p. 63, nota 5.7 Sorgono a breve distanza l’una dall’altra le quattro ville di Torre Spaccata e le tre di Centocelle (della
Piscina, ad duas lauros e delle Terme). In questo comparto l’analisi geomorfologica e le presenze archeolo-giche variamente note hanno portato all’identificazione di 30/40 insediamenti analoghi (della stessa epo-ca?) su 10 km2 (Volpe 2000, p. 192; Volpe - Arnoldus 2005, p. 63). Le dimensioni dei fundi risulterebbero di50/70 iugeri pari a 12/18 ettari. Non si tratta di proprietà estese, ma i terreni prossimi alla città dovevanoavere alti costi. Le stime proposte per la villa dell’Auditorium sono superiori. Estensioni maggiori (80/100iugeri corrispondenti a 20/25 ettari) sono state supposte nel suburbio meridionale (loc. Vallerano tra la viaPontina e la via Laurentina) e nell’ager Veientanus (v. sopra, p. 63, nota 5 probabilmente a causa di terreni noninteramente sfruttabili a scopo agricolo o per la maggiore lontananza da Roma. La vicinanza alla città co-stituisce il nodo principale anche per la distribuzione delle colture, con produzione intensiva decrescenteman mano che ci si allontana dal mercato (dall’orticoltura all’allevamento): Kolendo 1994, p. 60; Volpe2000, pp. 186-197, con bibliografia. Le viti dominano nel paesaggio del suburbio repubblicano (ma un tor-chio per olio è stato rinvenuto nella villa più antica dell’Auditorium). Non a caso nella gerarchia delle col-ture proposta da Catone al primo posto c’è la vigna seguita dall’orto, dal saliceto, dall’uliveto, dal prato, dalcampo coltivato a frumento, dal bosco ceduo, dall’albereto, dal bosco da ghiande (de agr., 1, 7). Tale ordine
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 71
tra la fine del ii e gli inizi del i secolo (e in età augustea) altre costruzioni di maggiorprestigio e di più elevato tenore in opera cementizia e paramenti in opera incerta ereticolata (la villa della Piscina, la villa detta ad duas lauros), che determineranno la di-struzione delle preesistenze. Alla villa 3 dell’Auditorium è stata avvicinata la fase ori-ginaria della villa della Piscina (i fase), l’unica di cui è stato possibile ricostruire par-zialmente la planimetria e il paesaggio circostante, caratterizzato da nuove estesecoltivazioni. Alla stessa età, benché non si disponga di alcun dato stratigrafico, è sta-ta attribuita la creazione degli altri complessi sia in questo settore che in quello di Tor-re Spaccata.1 Se quest’ipotesi fosse corretta, ci troveremmo in un momento prossimoe forse coincidente con la villa “catoniana” dello scavo dell’Auditorium. Al iii secoloè datata anche la villa della via Gabina (ii fase) realizzata su un più modesto edificiorurale. Generalmente questa è la data assegnata alla villa di Grottarossa (ii fase) sullavia Flaminia, anch’essa sorta su un edificio più antico di v o iv secolo.2 Tra la fine deliv e gli inizi del iii è datata la villa dei colli di Enea presso Lavinium.3 Altri complessidi notevole interesse, talvolta sovrapposti a strutture di età arcaica o alto-repubblica-na, sono assegnati nel suburbio orientale al iii secolo.4 È importante aggiungere chenei rari casi in cui è stato possibile verificare nello scavo l’esistenza di più fasi edilizie,esse si succedono modificando gli assetti più antichi (continuità di occupazione, nondi uso o di vita). Geomorfologia, fertilità dei suoli e presenza di infrastrutture conso-lidate (strade, rete idrica, cisterne) giustificano la successione ininterrotta sullo stessosito degli insediamenti talvolta fino ad età tardoantica (villa ad duas lauros). E a pro-posito dei sistemi di sfruttamento il fatto che nel suburbio vi siano diversi momentisuccessivi di utilizzazione del vigneto5 con l’adozione di diversi orientamenti (comeaccade in prossimità della villa della Piscina o della villa delle Terme di Centocelle),potrebbe essere spiegato con nuovi investimenti sulle proprietà e/o diversi sistemi dicoltivazione, e/o introduzione di vitigni (di abbondanza?) ai fini di un maggior ren-dimento e probabilmente con la presenza di nuovi proprietari e di nuovi edifici, cheper scarsezza di dati non sono ricollegabili, se non in via di ipotesi, ai diversi modid’uso dei terreni circostanti.6 Ciò vale a dire che pur all’interno di insediamenti radi-cati su se stessi (e per secoli; e ciò che accade anche nel comparto della via Flaminia
cambia con il tempo, come dimostrano le preferenze di Varrone e dello stesso Catone secondo Plutarco(Cato maior, 21, 5: Giardina 1997, p. 158-159).
1 Gli edifici medio-repubblicani in blocchi di tufo sarebbero per dimensioni e livello qualitativo “ville”,non “fattorie” secondo Volpe 2004, pp. 451-455; Volpe 2008, pp. 262-263, non paragonabili tuttavia a quelledella successiva fase tardo-repubblicana, più vicine per estensione e apparato decorativo al modello della“villa classica” (Volpe 2009, p. 520).
2 Da ultimo Terrenato - Becker 2009, con bibliografia; per la datazione dell’edificio più antico v. Suburbium ii, pp. 525-526.
3 Bibliografia in Di Giuseppe 2005a, pp. 15, 22; Volpe 2004, pp. 453-455.4 Egidi 2009; qui anche per un complesso sistema di canalizzazioni e di trincee per viti nell’area Ikea
dell’Anagnina (vi a.C.-i d.C.).5 Tre “generazioni” di vigne sono state trovate a Nîmes, dalla fine del ii/inizi del i secolo al 30 a.C., con
una rigenerazione ogni 25 anni: Brun 2004, p. 214.6 I grandi lavori edilizi in opera cementizia del ii/i secolo, che hanno coinvolto e sconvolto le strutture
medio-repubblicane del suburbio, potrebbero aver cancellato intere sequenze stratigrafiche, che pure co-stituiscono parte integrante della lettura della storia di questo comparto (Volpe 2004, pp. 455-457; Volpe2008, p. 262).
72 clementina panella
presso l’Auditorium),1 nuove realtà (architettoniche e socio-economiche) spezzano osembrano spezzare ad ondate successive la continuità suggerita dalle preesistenze.2
Nelle ricognizioni della valle del Tevere il maggior numero di insediamenti nuovie il minor numero di abbandoni si registra tra la seconda metà/fine iv e la prima me-tà del iii secolo (e poi dopo il 150).3 Nel suburbio settentrionale le ville individuate nel-le ricognizioni del ii e del iv Municipio (tra il Tevere e la via Nomentana) sono anco-ra una rarità fino alla prima metà del iv, aumentano in maniera consistente nellaseconda metà del iv e nella prima metà del iii a.C. e continuano a crescere fino al i/iid.C.4 Con qualche décalage cronologico tra comparto e comparto gli anni compresitra metà/fine del iv e il iii secolo (già nella prima metà) mostrano una strutturazio-ne forte del territorio. Occorre tuttavia lavorare ancora molto sulle cronologie, cherappresentano l’anello più debole delle conoscenze. Come per le grecoitaliche, bastacambiare un tipo di periodizzazione, un elemento della tipologia dell’insediamento,la cronologia di una classe ceramica, ed interi quadri del paesaggio suburbano ri-schiano di dover essere ridisegnati.
Ciononostante, i contributi raccolti in Suburbium ii, le pubblicazioni altrettanto re-centi degli interventi del Comune di Roma a Centocelle e a Tor Spaccata, l’edizione del-lo scavo dell’Auditorium e i numerosi interventi relativi al progetto “Archeologia delsuburbio di Roma” della “Sapienza” -Università di Roma5 e al Tiber Valley Project dellaBritish School, oltre a dar conto di dati fondamentali per l’età arcaica e alto-repubbli-cana, tendono a presentare già in età medio-repubblicana situazioni fortemente inno-vative. Maggiore visibilità (ovviamente per problemi di conservazione) hanno i siti del-l’avanzato iii secolo o quelli del pieno ii secolo (non solo nei territori intorno a Roma),6
1 L’ultima villa (villa 4 del periodo 5), nasce nell’80 a.C. e persiste sino al 150 d.C. (Auditorium 2006, pp.281-300).
2 Carandini 2006, p. 604. 3 Di Giuseppe 2005a, p. 15.4 Carandini 2006, pp. 591, 607, figg. 239-240: nel v secolo, oltre alla villa 1 dell’Auditorium (periodo 2),
sono state individuate 16 ville piccole, medie e grandi; 21 sono i casi registrati nella prima metà del iv seco-lo, 86 nella seconda metà del iv, 102 nella prima metà del iii secolo e poi in progressivo aumento con unpicco di presenze nel i d.C. Il grafico a fig. 240 mostra in sovrapposizione per il territorio a Nord di Romale unità di presenza di ville, case/fattorie, villaggi dal ix a.C. all’viii d.C. In questa parte del suburbio le vil-le sopravanzano già nel iv secolo le case/fattorie, che continuano ad essere attestate con una certa stabili-tà contemporaneamente ad edifici di maggior pregio e livello architettonico.
5 Il progetto diretto da A. Carandini in collaborazione con la Soprintendenza Speciale per i Beni Ar-cheologici di Roma è stato finalizzato alla ricostruzione dei paesaggi antichi in diversi settori del suburbiodi Roma (Municipi ii, iv, ix, x, xviii) e di alcuni centri limitrofi sulle due rive del Tevere: bibliografia in Ca-panna - Carafa 2009, p. 27, nota 1. Tra le monografie già edite, Cupitò 2007.
6 Sembra far eccezione il comparto della media valle tiberina, ove è stata notata una “crisi” degli inse-diamenti rurali e di alcuni centri urbani proprio tra il 250 e il 150 (Di Giuseppe - Patterson 2009, p. 12 sgg.;p. 20, fig. 8; Di Giuseppe 2009, pp. 248-252), cioè nel periodo in cui altre zone prossime a Roma e della pe-nisola hanno restituito evidenze in crescita di produzione e di mercantilizzazione dei beni agricoli e mani-fatturieri. Guerre, drenaggio di uomini verso Roma e verso le colonie della Cisalpina, estensione della gran-de proprietà a scapito della piccola (tracce di questo fenomeno sarebbero rintracciabili nell’area oggetto distudio: Di Giuseppe–Patterson 2009, pp. 20-21) spiegherebbero tale spopolamento, che potrebbe riflette-re una realtà locale/subregionale, dal momento che in generale per questo periodo viene contestata l’esi-stenza di una crisi demografica dell’Italia (Lo Cascio 2009, pp. 36-40, 153, 165 sggs.). Una ripresa degli inse-diamenti si registrerebbe in quest’area solo dopo il 150. Va detto che nella gestione dei dati di questericognizioni vi è l’impiego di una periodizzazione (250-150) diversa da quella utilizzata da A. Carandini e dalsuo gruppo nel suburbio settentrionale (250-200; 200-150); il che pone qualche problema nell’allineamentodei fenomeni riscontrati.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 73
ma per queste età ci si muove all’interno di fenomeni già da tempo noti. Se è possibiledibattere sulla più o meno lunga gestazione della villa “catoniana”, una tappa nella for-mazione di un’agricoltura organizzata e remunerativa, funzionale al mercato urbanoin crescita, così come essa è riflessa nella documentazione archeologica, sembra per-tanto da collocare negli anni compresi tra la generazione del dittatore M’. Curio Den-tato, vincitore dei Sanniti, conquistatore nel 290 della Sabina e dell’ager Praetutianus,che si accontenta della sua plebeia mensura, e di L. Cecilio Metello (console del 251 e del247), che persegue l’acquisizione di pecunia magna, sia pure conseguita bono modo,1 an-ni questi che si rapportano anche ad un momento cruciale di trasformazione degli as-setti socio-economici di Roma, non meno importante dei cambiamenti del ii secolo.2Con la conquista della Sabina e le conseguenti confische seguite alle repressioni dellarivolta, dice Strabone che riporta un passo di Fabio Pittore forse attraverso Polibio, i«Romani presero conoscenza della ricchezza per la prima volta allora quando si impa-dronirono di questa popolazione». L’assegnazione di 50 iugeri di ager publicus (la vendi-tio quaestoria) destinati a coloro che erano in possesso di capitali, contro i lotti di 7 iu-geri delle distribuzioni viritane effettuate in questo stesso territorio, modificòun’organizzazione sociale all’interno della quale gli aristocratici erano stati fino a quelmomento economicamente non dissimili dalla massa civica di cui erano espressione.3Due altre osservazioni a questo passo: il rapporto che lo storico pone tra guerra e cre-scita economica e il fatto che questo evento ebbe una conseguenza culturale: i Roma-ni erano diventati più ricchi e ne avevano preso coscienza, avevano cioè “interiorizza-to” la percezione della novità.4 Non vi è dubbio che l’espansione romana in Sabina enella valle del Liri all’inizio del iv secolo e poi nel Nord della Campania dopo la batta-glia di Trifanum del 340 e nella regione di Benevento nel 268 sia stata accompagnata dal-la requisizione, da parte dell’aristocrazia, di immensi, fertili territori da valorizzare. Lacapacità di coloro che possedevano capitali di usare ed abusare della loro influenza pub-blica è riflessa nel passo di Dionigi di Alicarnasso (xvii-xviii, 4-5), che riferisce che L.Postumio Megello, console nel 291, utilizzò 2000 soldati per disboscare un gigantescopossedimento a Gabii, probabilmente per piantare viti ed olivi.
Come dimostra questo episodio, l’attrazione di un mercato in espansione (di Ro-ma, dell’Italia e delle province man mano conquistate: dopo la Sicilia e la Sardegna,l’Hispania, l’Africa) rende certi che furono i ceti abbienti ad approfittare delle oppor-tunità offerte dalla domanda per mettere in moto un processo produttivo che abbi-sognava di capitali per essere redditizio. Lo prova il plebiscito Claudio del 218 (o del219) che interdiceva ai senatori e ai loro figli di possedere navi di capacità superiore al-le trecento anfore (sicuramente vinarie e sicuramente, data l’epoca, grecoitaliche),equivalenti ad una piccola imbarcazione.5 E che fosse l’aristocrazia urbana ad occu-pare in questa età i fundi prossimi a Roma oltremodo appetibili (oltre che ovviamen-te anche altrove, come dimostrano le fonti) è ipotesi del tutto verosimile. La spiega-zione del divieto (la mercatura è attività disdicevole per i senatori: quaestus indecorosus
1 Plin., NH, vii, 139. 2 Gabba 1981, in part. pp. 542-543.3 Gabba 1988, p. 19; sulla venditio quaestoria, ivi pp. 23-25; sui nuovi modi di sfruttamento dell’ager publi-
cus in questa età Gabba 1990a, pp. 13-14. 4 Schiavone 1989, p. 26.5 Liv., xxi, 63, 3-4; su questa legge, rimasta in vigore (ma evidentemente non applicata) fino al iii secolo
d.C., v. Gabba 1981, pp. 545-548; Clemente 1983; Clemente 1990, pp. 50-54; Zevi 2002, pp. 43-44.
74 clementina panella
= guadagno indecoroso) è considerata unanimemente un’aggiunta di Livio. Essa, cherimanda ad un codice di comportamento etico e politico che si diffonde a Roma nelii e soprattutto nel i secolo, è in contraddizione con il contenuto della legge che con-siste solo in una limitazione del commercio, non nel suo divieto. In realtà il plebisci-to indica: 1) che esistevano attività commerciali, nelle quali erano implicati anche se-natori, che si svolgevano per mare e che erano di un certo rilievo; 2) che vi eranoproprietà senatorie (nel Lazio, in Campania, in Etruria?); 3) che le attività commercialinon erano condannate per principio, ma circoscritte sul piano quantitivo. Dal puntodi vista cronologico questo testo rimanda agli atteggiamenti di una generazione na-ta qualche decennio prima, per la quale, visto che esiste la legge, era normale non so-lo possedere proprietà terriere e immobiliari (il che è ovvio), ma anche trafficare connavi proprie. Diverse forme furono trovate per aggirare la proibizione, tenendosi lon-tani dal commercio, ma non dai profitti, come l’affidare le iniziative imprenditoriali adei prestanome (il liberto Quinctius nel caso di Catone)1 o ai cavalieri o ai ceti italicicoincidenti con i gruppi dirigenti locali, collegati ai domini da rapporti di clientela edamicitia.2
Qualche considerazione finale
Se il suburbio ha potuto servire (in tutto o in parte) Roma, altre regioni hanno ali-mentato il commercio mediterraneo del vino “romano” in questo e nei periodi suc-cessivi. Non si dice nulla di nuovo quando si osserva che la produzione delle anfore èconnessa al trasporto marittimo. Pochi sono i ritrovamenti all’interno delle terre (ameno che non siano servite da fiumi: v. la diffusione di grecoitaliche e Dressel 1 nellaGallia interna), quelli costieri si spiegano in gran parte con i rilasci nei porti di transi-to, che possono aver alimentato una ridistribuzione per cabotaggio, anch’essa limita-ta alle coste e all’immediato entroterra. È ciò che accade alla Campana A, che risultapoco o affatto distribuita nei territori prossimi alla città produttrice. Di qui anche ilsospetto che alcune produzioni vinarie (e anforarie) di massa siano nate solo perl’esportazione a grande distanza (per la Campana A sarebbe stato il “battesimo delmare”, che ne avrebbe fatto aumentare il pregio, intrinsecamente inesistente, ren-dendola esotica e relativamente preziosa),3 e con precise destinazioni: Marsiglia, Am-purias, Cartagine. È un’ipotesi credibile che in quest’ambito possano aver giocato unruolo importante relativamente poche famiglie, sostenute da interessi forti nei luoghidello smercio e legate mediante rapporti di clientela e di amicitia a comunità italichee indigene, come sembra intravedersi tra la fine del ii e la prima metà del i secolo: laproduzione di Albinia, forse collegata ai Domitii Ahenobarbi, prevalentemente nellaGallia centrale,4 quella laziale-campana prevalentemente nell’Istmo gallico, quella del
1 Plut., Cato maior, 21; Gabba 1980, p. 92.2 Manacorda 1989, p. 463; Giardina 1989, pp. 286-287, che così commenta il passo già citato (v. sopra,
p. 49, nota 7) del De officiis di Cicerone (1, 151): «È inutile riprendere… il vecchio problema del coinvolgi-mento del ceto senatorio nei traffici commerciali. Oggi nessuno più dubita (o dovrebbe dubitare) che que-sto coinvolgimento esisteva ed era ampiamente esteso, grazie ad una pluralità di soluzioni che garantiva-no l’apparente distacco tra i membri dell’élite e le merci». 3 Morel 2005, p. 102.
4 Su questa famiglia e le sue molteplici proprietà ed attività, v. sopra, pp. 51-52. Dei rapporti antichi de-gli Ahenobarbi con la Gallia fa fede la vittoria riportata da Cn. Domitius, console del 122 sugli Arverni che glifruttò il trionfo del 121 (sull’attribuzione a questo personaggio del tempio di Nettuno in circo e dell’“ara di
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 75
portus Cosanus (e forse della Feniglia) collegata ai Sestii,1 di diffusione generalizzata unpo’ ovunque in Gallia, ma anch’essa molto ben documentata nella Gallia centrale.2
Il secondo anello importante della catena è costituita dagli agenti del commercio edai proprietari delle navi, i navicularii (v. sopra, pp. 54-55). I principali intermediari tradomanda ed offerta sono i negotiatores, insediati, come informano testi ed iscrizioni la-pidarie, nelle zone conquistate per servire le esigenze dei romani ed italici e degli eser-citi ivi istallati o proiettati a rischio della vita nelle zone di confine e nelle regioni ester-ne dell’impero, spesso ancora ostili.3 Ad essi, che precedono talvolta di più di un secolole truppe e gli amministratori e le “bandiere” di Roma, potrebbero essere imputati, inparte, anche i differenti comportamenti nella diffusione di determinate classi di mate-riale riscontrati nei diversi centri importatori, evidenziati in questo periodo quasi uni-camente dalla ceramica fine, di cui si conosce in linea di massima l’area di origine. Masulle scelte di mercato a cui rimandano le differenze nello smercio di beni e di oggettipossono entrare in gioco diversificati altri fattori, di carattere geopolitico (zone d’in-fluenza), militare (forniture per l’esercito), culturale (uso e gusto) ed economico.4 L’ul-timo distinto elemento della terna costituita da produzione, distribuzione, consumoè la clientela5 che, nel caso delle anfore, può aver condizionato gli arrivi di certe qua-lità piuttosto che altre, di vini comuni piuttosto che di vini nobili (o viceversa).
*
Previste come Note, le Appendici sono degli approfondimenti su alcuni temi trattati neltesto, a cui è sembrato opportuno dedicare un po’ più di spazio.
Domizio Enobarbo”, v. Coarelli 1996, pp. 77-84; sull’esistenza di un monumento onorario dei Domitii sulCampidoglio, ivi, pp. 301-311)
1 Su questa famiglia e le sue proprietà nel Cosano, v. sopra, p. 51.2 Queste osservazioni derivano dalla diffusione del materiale bollato, analizzato da Olmer 2003 e 2008.
Le officine del portus Cosanus e di Albinia hanno certamente inviato anfore a Roma, come dimostra l’anali-si macroscopica delle paste, ma quasi nessuno dei contenitori identificati come “cosani” nelle stratigrafieurbane è bollato. Sul totale assai modesto di bolli su Dressel 1 editi da Roma (una ventina di esemplari cir-ca), solo tre potrebbero spettare agli ateliers di Albinia (AL, DA, IO), contro le centinaia di marchi prove-nienti dalle officine dell’Albegna registrati, per esempio, a Bibracte (tra gli inediti un bollo NH di Albinia,impresso alla base dell’ansa di una Dressel 1B, da Piazza Vittorio Emanuele a Roma, informazione di A.F.Ferrandes, già noto nel relitto di Cap de l’Estérel, Hyères, Var, datato intorno al 100 a.C.: Tchernia 1969,p. 476, fig. 22; Liou 1975, p. 590, e a Vienne: Pelletier 1966, p. 144). Nessun bollo dei Sestii è stato rinvenu-to (o pubblicato) a Roma. Si tratta di casualità o in questi impianti la certificazione di proprietà compare so-lo o principalmente sulle partite di anfore destinate al commercio su grandi distanze?
3 Morel 1990a, p. 410. Oltre alla strage dei 20.000 stranieri a Delo (in gran parte mercanti italici) nell’88da parte di Archelao (App., Mithr., 28), si ricorda a titolo di esempio il massacro dei negotiatores Italici a Cirtanel 112 perpetrato da Giugurta (Sall., BJ, xxvi, 1 e 3; xxii, 2; xlvii, 1-2) o in Gallia (Caes., BG, vii, 3, vii, 42, vii,55). Ancor prima, nel 239-238, al momento della rivolta dei mercenari, cinquecento Italici che navigavano ver-so l’Africa furono fatti prigionieri dai Cartaginesi con l’accusa di approviggionare gli insorti (Polyb., i, 83). Nel230 gli italikoì émporoi sono ricordati da Polibio (ii, 8, 2-3) insieme agli Issei per la denuncia delle vessazioni del-la pirateria illirica, che portò all’intervento romano contro i re Agrone e Teuta nel 229 (sui moventi anche eco-nomici della prima guerra illirica e in generale della politica estera della nobilitas romana sulla scorta della te-stimonianza polibiana e di altre fonti, v. ora Coviello 2003; Bandelli 2003, pp. 217-218, passim).
4 Morel 1998b., pp. 511-512; Morel 2008, pp. 174-175 (reti commerciali, intermediari).5 Morel 1998b, pp. 512-513; Morel 2008, pp. 180-183, che porta dati a sostegno dell’ipotesi che in alcuni
casi siano stati i “consumatori”, sulla base di autonome scelte etniche e culturali, ad influenzare la fabbrica-zione (in termini quantitativi e qualitivi) della ceramica fine: in un modo o nell’altro «le marché dictait sa loi».
76 clementina panella
Appendice i
Grecoitaliche: problemi di tipologia, denominazione, definizione, cronologia
La situazione degli studi su questa famiglia di anfore “visceralmente eteroclita”1 si ri-flette nel disagio che accompagna la lettura delle sintesi di cui oggi si dispone, anchedi quelle più aggiornate.2 Benché non siano mancati tentativi di far ordine, la tipolo-gia delle grecoitaliche è infatti sostanzialmente ancora assai confusa. Le frequenti de-nominazioni “miste” che si riscontrano nelle pubblicazioni (“Van der Mersch v/vi”,“grecoitalica/Dressel 1” o “grecoitalica/Lamboglia 2”) indicano l’impossibilità di at-tenersi a parametri morfologici più o meno correttamente codificati.3 Diverse sonole cause che hanno impedito finora di ottenere un’organizzazione dei dati affidabile:1) l’innegabile processo evolutivo che accompagna la storia di queste anfore (dal tipoVan der Mersch iii fino alla Dressel 1 e alla Lamboglia 2), sia che esso sia l’esito di ungenerale adeguamento a standard metrologici e formali universalmente accettati, siache sia l’esito di un distinto passaggio evolutivo dei singoli centri di produzione; 2) lamolteplicità delle officine (molte delle quali non identificate), a cui rimanda la gran-de varietà degli impasti; 3) la cronologia dei depositi, che è quasi sempre basata sullatipologia dei contenitori, innescando un vero e proprio circolo vizioso tra datazionedei contesti e datazione dei vasi. Il fatto è che il modello delle più antiche anfore vi-narie “italiche” è adottato nel iv e nel iii secolo contemporaneamente in tutte le areedella penisola e della Sicilia ove vi fosse un’agricoltura che prevedesse eccedenze daavviare ai mercati locali, regionali o mediterranei, ed ha una relativa lunga durata (da-gli ultimi decenni del iv fino alla metà/terzo quarto del ii secolo).
A fronte di un panorama così complesso, la tipologia di Ch. Van der Mersch è de-bole, essendo ridotta, rispetto ad un fenomeno di tale portata, intensità e diffusione,ai tipi v (Fig. 1.1-2) e vi (Fig. 2.3 e Fig. 2.5) (e al prototipo costituito dal tipo Van derMersch iii), costringendo chi cerca di confrontarsi con il materiale esistente a ricor-rere ad altre classificazioni o ad altre denominazioni. Irrisolta è pertanto una dellequestioni più inquietanti che questa classe di materiali pone e cioè «la sistematizza-zione dell’ampio repertorio degli oggetti esistenti e l’individuazione di costanti e va-rianti».4 In sostanza ignoriamo se le differenze morfologiche e di impasto dipendanoda diversa provenienza e/o da differente cronologia. Né è possibile, se non in rari ca-si, coniugare tipologia e zone di origine, con conseguente difficoltà di ricavare dai do-cumenti un preciso valore storico-economico.5 Ugualmente assai vago è il rapportotra epigrafia e tipologia e tra epigrafia e centri di produzione.
1 Van der Mesch 1994, p. 84.2 Analoghe considerazioni sui problemi posti dalla tipologia e dalla cronologia delle grecoitaliche nella
loro fase più antica in Asensio - Martín 1998.3 Tralascio i problemi della classificazione dei frammenti di orlo, solitamente risolti mediante l’impiego
di diversificate serie di dati metrici (altezza, spessore, inclinazione), misure che hanno un valore descrittivoimportante, ma che non sono una garanzia di un’esatta identificazione. Nelle fasi di transizione da una for-ma all’altra è difficile classificare correttamente anche gli esemplari interi. Nel caso delle grecoitaliche che“stanno diventando” Dressel 1 o Lamboglia 2 la riconoscibilità è spesso soggetta alla discrezione o all’arbi-trio dei singoli studiosi. 4 Manacorda 1989, pp. 443-444, nota 2.
5 Olcese 2004, p. 184.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 77
Occorre pertanto ammettere che non siamo in grado oggi sulla base della sola mor-fologia di distinguere le anfore spettanti ai diversi ambiti storici, produttivi e com-merciali che hanno realizzato in età ellenistica anfore grecoitaliche. Se è da apprezzareil tentativo di Ch. Van der Mersch di creare due serie parallele, la prima per i conteni-tori da trasporto attribuiti ad ambito magnogreco/siciliano, individuati dalla siglaMGS (anfore MagnoGreche-Siciliane),1 la seconda per i contenitori attribuiti ad ambito “romano”, identificati con la sigla RMR (anfore Romane Medio-Repubblicane),2 perchéindica una linea di ricerca metodologicamente corretta, il tentativo è fallito di fronteall’impossibilità di collegare il “disegno” dell’anfora alle regioni di provenienza accer-tate o presunte, le quali per altro non sono circoscritte all’Italia meridionale e al Latiumvetus/Latium adiectum, cioè ai due soli ambienti presi in esame dallo studioso belga. Perquesta ragione ho mantenuto il numero romano dei suoi tipi, ormai entrato nell’usocorrente, ed ho sostituito le abbreviazioni MGS e RMR con il nome dell’autore.
Van der Mersch dichiara apertamente che non era tra le finalità della sua ricercaquella di creare una tipologia, ma “involontariamente” essa è diventata il nodo intor-no a cui hanno ruotato tutte le problematiche che ha affrontato, da quelle cronologi-che a quelle della produzione e della circolazione. Purtroppo non è stata felice nep-pure la scelta degli esemplari di riferimento. Ciò vale soprattutto per il tipo vi. Le
1 Van der Mersch 1994.2 Anfore del Latium vetus e Latium adiectum, con esclusione di Neapolis e del suo territorio che Van der
Mersch 2001 attribuisce ad ambiente magnogreco, ma che esclude dallo studio del 1994 che si ferma al Silaris/Sele.
Fig. 1.1. Relitto di Capistello, Lipari(da Van der Mersch 1994, p. 77, fig. A: MGS v = Van der Mersch v).
Fig. 1.2. Relitto Roghi 1 di Panarea (le Formiche, Eolie)(da Van der Mersch 1994, p. 77, fig. B: MGS v = Van der Mersch v).
78 clementina panella
anfore di Camarina, città distrutta del 258, sono molto più vicine al tipo v che a ciò checi sembra debba essere il tipo vi1 (Fig. 2.3 = Pelagatti 1984-85, fig. 4 e tav. cxlvii, 1).L’esemplare di Taranto, bollato da Tr. Loisios, essendo ridotto al solo collo, è privo ditre elementi fondamentali ai fini del riconoscimento della forma (il profilo della spal-la, il profilo della pancia, la conformazione del piede – vuoto/pieno) (Fig. 2.5 = Ma-nacorda 1989, p. 444, fig. 1). Ne consegue che il tipo Van der Merch vi, che è l’“anel-lo” tra le grecoitaliche del iii e quelle della prima metà del ii secolo, manca di un“disegno” chiaro e definito. Il quadro è tuttavia leggermente migliorato con l’inseri-mento nel tipo RMR vi di un’anfora del relitto di Cala Rossa (Fig. 3.6)2 e dell’anfora diMas Castellar-Pontós3 con graffito sulla spalla MAR.RVLIO4 (Fig. 3.7), ma il collo delrelitto “punico” di Marsala appare ancora una volta poco pertinente5 (Fig. 2.4).
A confondere ulteriormente una situazione già di per sé intricata, hanno contri-buito le definizioni “grecoitalica antica” e “grecoitalica tarda o recente” utilizzate daD. Manacorda,6 che intendeva in tal modo separare le anfore spettanti ad un mondo
1 Dubbi sono espressi dallo stesso Ch. Van der Mersch.2 Van der Mersch 2001, p. 163, fig. 2b (da Liou 1975, p. 604, fig. 42.1).3 Van der Mersch 2001, p. 163, fig. 2c. 4 V. sopra, p. 36, nota 2.5 Van der Mersch 2001, p. 163, fig. 2a.6 Manacorda 1986 e 1989. Grecoitaliche arcaiche e grecoitaliche antiche sono i termini usati da Van
der Mersch 2001 per i suoi tipi RMR v e RMR vi.
Fig. 2.3. Camarina, deposito nella Stoà ovest dell’Agorà(da Van der Mersch 1994, p. 82, fig. A: MGS vi = Van der Mersch v/vi).
Fig. 2.4. Relitto “punico” di Marsala (da Van der Mersch 2001, p. 163,fig. 2a: RMR v/vi = Van der Mersch v/vi); bollo alla base dell’ansa M.VA o L.VA.
Fig. 2.5. Taranto (da Van der Mersch 1994, p. 82, fig. B: MGS vi = Van der Mersch vi);bollo sul gomito dell’ansa TR.LOISIO.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 79
non ancora romanizzato (le antiche) da quelle di ambito “romano” (le recenti).1 Aqueste ultime spetterebbero le anfore timbrate in latino, com’è quella bollata da Tr.Loisios, che è a sua volta l’esemplare utilizzato da Ch. Van der Mersch per illustrare ilsuo tipo vi, un’anfora che è a tutti gli effetti una grecoitalica “antica”.2 Poiché nellepubblicazioni sono impiegati assai spesso ed esclusivamente questi aggettivi (“antico”e “tardo”), il lettore non riuscirà mai a capire, in assenza di documentazione grafica,se l’oggetto di cui si parla appartenga ai tipi Van der Mersch v o vi o ai tipi che si sus-seguono a partire dalle anfore del Grand Congloué 1. I ritrovamenti di questi ultimianni hanno inoltre dimostrato che la timbratura in latino compare già sulle grecoita-liche del tipo Van der Mersch v e convive con quella in greco per tutta la seconda me-tà del iii secolo. Né sembra più accettabile che la distinzione tra grecoitaliche “ro-mane” o “magnogreche e siciliane” passi attraverso la lingua usata nella bollatura.3
A dare il colpo di grazia a questa “nebulosa terminologica” piena di contraddizio-ni e fraintendimenti, c’è infine l’eguaglianza istituita dallo stesso Van der Mesch delsuo tipo vi con la forma Will 1c,4 cioè con una delle anfore del Grand Congloué 1 (Fig.3.8),5 le quali appartengono senz’ombra di dubbio ad altro e nuovo orizzonte morfo-logico e sono assimilabili a loro volta, senza incertezze, alle grecoitaliche “tarde” diD. Manacorda.
Vale la pena accennare anche alla tipologia sotto molti aspetti pionieristica di E. Ly-ding Will, sia perché è stata alla base di quella di Ch. Van der Mersh, sia perché è fre-quentemente utilizzata nelle pubblicazioni anglossassoni.6 Se si evita di prendere perbuone alcune datazioni o alcune ipotesi di origine avanzate dalla studiosa americana,in parte smentite dalle ricerche successive, essa ha il merito di illustrare almeno duedei tipi (Will 1c e 1e) che circolano nel ii secolo, a partire appunto dalle grecoitalichedel relitto del Grand Congloué 1 (Will 1c). Lo schema seguente dà conto delle egua-glianze con i tipi di Van der Mersch:- forma Will 1a1 (Capistello) = Van der Mersch v (l’esemplare utilizzato come mo-
dello è lo stesso)7 (Fig. 1.1);- forma 1d (forse Porto Ercole; Ansedonia, collezione privata) = Van der Mersch vi
(l’esemplare illustrato dalla Lyding Will è molto simile all’anfora di Tr. Loisios, conil vantaggio di documentare una forma intera);
- forma 1c (Grand Congloué 1) – non documentata da Van der Mersch, che attribui-sce le anfore del Grand Congloué 1 al suo tipo vi (Fig. 3.8);
- forma 1e (Museo di Barcellona) – non documentata da Van der Mersch, in quantospettante al ii secolo avanzato (l’esemplare di Punta Scaletta a Giannutri nell’arci-pelago Toscano, già ai limiti con le Dressel 1, è molto vicino a quello utilizzato dal-la Lyding Will come modello: Fig. 3.9).
1 È questo il percorso di ricerca seguito alcuni anni dopo da Ch. Van der Mersch.2 Tale è per Van der Mersch 1994, p. 84 e 2001, p. 173.3 V. sopra, pp. 37-38. 4 Van der Mesch 1994, p. 84.5 Van der Mersch 2001, p. 178. 6 Lyding Will 1982, tav. 85.7 Nella tipologia della Lyding Will compare anche il tipo Van der Merch iv = Will 1a2, esemplificato in en-
trambi i casi da un’anfora del relitto di Filicudi F. Non ho preso in considerazione questa famiglia di anfore,perché oltre ad essere più antica dei tipi Van der Mersch v e vi, appartiene ad un altro filone tipologico. AdIschia è prodotta nelle medesime officine dei tipi Van der Mersch iii e v (Olcese 2004; Olcese 2005-2006).
80 clementina panella
Fig. 3.6. Relitto di Cala Rossa(da Van der Mersch 2001, p. 163, fig. 2b: RMR vi = Van der Mersch vi).
Fig. 3.7. Mas Castellar-Pontós, silos 101 (Alt Empordà, Girona)(da Van der Mersch 2001, p. 163, fig. 2c: RMR vi = Van der Mersch vi);
graffito sulla spalla MAR.RVLIO (ante cocturam); bollo [E (in nesso) alla base dell’ansa.Fig. 3.8. Relitto del Grand Congloué 1 (Marseille) (da Tchernia 1986, p. 314 = forma Will 1c).
Fig. 3.9. Relitto di Punta Scaletta (Giannutri, arcipelago Toscano)(da Tchernia 1986, p. 315 = forma Will 1e).
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 81
La forma Will 1b non esiste “in natura”, in quanto nasce da un cattivo restauro diun esemplare del Pech Maho.1 L’anfora avrebbe avuto sull’ansa un bollo ]ES,2 che perE. Lyding Will sarebbe stato il primo bollo latino su grecoitalica, suggerendo un’in-tegrazione [S]ES e quindi un rapporto con l’officina dei Sestii, con conseguente ipo-tesi di datazione al iii secolo dell’attività imprenditoriale di questa famiglia (datazio-ne, se si vuole, confermata ora dal ritrovamento della grecoitalica bollata SES dalrelitto di Skerki Bank, v. sopra, pp. 39-40). In realtà Y. Solier riteneva incerta la letturadel bollo,3 né esso (o qualcosa di analogo) compare nel suo articolo del 1979 o è men-zionato da G. Olcese che ha rivisto recentemente i materiali dell’oppidum conservatia Sigean.4 Ciò che qui interessa sottolineare non è tanto l’estemporaneità della formaWill 1b (la sua “invenzione” nasceva dalla necessità del tutto giustificata di isolare untipo intermedio tra le forme che oggi chiamiamo Van der Mersch v = Will 1a1 e Vander Mersch vi = Will 1d), quanto l’importanza di questo sito posto ad Ovest di Nar-bona, da cui proviene un nucleo di anfore intere, relativamente ben datate (in riferi-mento alla chiusura dei depositi) e in alcuni casi bollate e iscritte (graffiti, tituli picti iniberico), che hanno già consentito e consentiranno in futuro di disporre di dati rile-vanti su cronologia, centri di produzione, tipologia e bollatura delle grecoitaliche.5 Èinfatti opinione condivisa che il Pech Maho sia stato abbandonato, come si è già det-to, prima della fine del iii secolo a.C., in connessione con gli eventi della ii Punica oa seguito dell’invasione dei Tectosages, analogamente a quanto accade ad altri oppidadel Languedoc occidentale (v. sopra, p. 33, nota 4). Il 210/200 a.C. è la data comune-mente accettata per la fine dell’insediamento, che costituisce un termine ante quem deimateriali recuperati (51 grecoitaliche negli entrepôts presso le mura della cinta internascavati nel 1970-72, ma altre devono essere state rinvenute nella stessa area nel 1967).6Inoltre, su gran parte delle anfore sono state già condotte analisi per fluorescenza RXe analisi minero-petrografiche,7 ma esse hanno dato informazioni per lo meno “dif-formi” sui luoghi di origine (v. sopra, p. 33). Nessun collegamento è stato istituito trai risultati di queste analisi e la tipologia degli esemplari da cui sono stati prelevati icampioni, né tra tipologia e epigrafia. La documentazione disponibile consiste perciòancora nei disegni e nelle foto editi da Y. Solier, da cui si ricava la presenza di grecoi-taliche sia del tipo Van der Mersch v (forse meno numerose), sia di transizione al ti-po Van der Mersch vi (in questo senso aveva ragione la Lyding Will a cercare in que-sto centro la forma 1b), sia del tipo Van der Mersch vi, reimpiegati per conservarealimenti, ma arrivati (tutti, alcuni, quali?) in decenni precedenti alla distruzione del si-to (ma quanto prima e in che successione?). L’editore fa notare che le anfore, a cui èstato talvolta tagliato con cura il collo o il fondo, tradiscono un “usage de long durée”(buchi di riparazione, diverse tracce di usura) e fa confronti con le anfore dei relitti diCabrera B a Mallorca e di Cala Rossa a Porto Vecchio (Corsica), ma i carichi di que-ste due navi hanno cronologie non solo diverse, ma controverse (v. oltre). Se vale insostanza il terminus ante quem del 210/200 a.C., la consapevolezza di avere a che fare
1 Empereur - Hesnard 1987, p. 25. 2 Benoit 1961, p. 265.3 Lyding Will 1982, p. 345, nota 12. 4 Olcese 2004, p. 183.5 Tra gli studi più recenti, con bibliografia, v. Olcese - Thierrin Michael 1996; Thierrin Michael
2000; Olcese 2004. 6 Barruol 1969.7 Hesnard et alii 1989; Thierrin Michael 2000.
82 clementina panella
con materiali (sempre, in qualche caso) più antichi di questa data fa sperare che glistudi annunciati1 possano dare risposte a molte questioni che riguardano le grecoita-liche nelle loro versioni della metà/seconda metà del iii secolo a.C. Problemi analo-ghi pongono i ritrovamenti di Mas Castellar-Pontós, fermo restando che le grecoita-liche disegnate, pur essendo una diversa dall’altra, rientrano tutte nel tipo Van derMersch vi. Ad eccezione del frammento con il bollo di L. Valerios, che è assegnato adun contesto del 225-200, gli altri esemplari sono datati tutti sulla base delle stratigrafiedi provenienza al 200-175, cioè dopo il Grand Gongloué 1; una cronologia questa chenon convince (v. quanto già detto per i bolli ACK§H/ACK§ e AN¢PøNO™, alle pp.41-42, nota 5. La compresenza di oggetti all’interno di uno stesso sito o di uno stessostrato non fornisce informazioni sul quando questi manufatti siano stati prodotti (lacronologia del contesto offre solo il terminus ante), sul quando abbiano raggiunto quelcentro e sul quando siano usciti dall’uso per diventare “reperti archeologici”.2
Ritornando alla documentazione del Pech Maho e al corredo epigrafico delle gre-coitaliche di questo sito, la Olcese3 fa riferimento, oltre a M.LVRI e [TE]TE (sull’in-tegrazione di questo esemplare ho forti dubbi, v. sopra, p. 33, nota 1), già menzionatinel corso di queste pagine, ai bolli §.BI (da correggere in M.BI), AM, I, ¢IøN, XAPI§A, XAP in monogramma (testi analoghi a questi due ultimi bolli sono statirinvenuti ad Ischia su grecoitaliche del tipo Van der Mersch v,4 ove XAP è senza nes-si e, oltre a XAPI§A, è presente anche il bollo XAPI§Eø)5 e AN¢PøNO™,6 già no-to nell’oppidum,7 e attestato nella stessa forma a Taranto e a Reggio, in Sicilia aAcrae/Palazzolo Acreide (prov. Siracusa), Licata, Agrigento,8 Caleacte/Caronia Mari-na (prov. Messina),9 in Spagna a Sant Josep (Vall d’Uixó, Castelló, a Nord di Valen-cia),10 a Mas Castellar-Pontós11 (ripetuto su entrambe le anse di una stessa anfora) ea Cartagena12 (tre esemplari). XAPI§A e XAP potrebbero sottindendere lo stesso no-me diversamente abbreviato (ma XAP potrebbe avere anche altro scioglimento: v. ilbollo XAPME di Ischia). Inoltre, l’identità di antroponimo non significa identità dipersona in quanto le omonimie sono frequenti per i nomi molto comuni. Solo l’iden-tità dei punzoni o l’identità dello “stile” e della paleografia, nel caso di testi variamente abbreviati o di varianti epigrafiche, garantisce dell’identità del fabbricante. Ma diquanti bolli sono pubblicati le foto o gli apografi (a scala 1:1) più affidabili dei disegni?Nel gioco delle identificazioni rientra anche la tipologia dell’anfora, ma di quante grecoitaliche bollate sono editi disegni o foto? Non è questa la sede per entrare nelmerito, ma l’esempio che riporto dà un’idea dello stato degli studi. La serie AN¢PøNO™ può essere attribuita ad un solo punzone o a punzoni paleografica-mente molto simili, come dimostra la forma dell’omega e del rho. Il fabbricante è
1 Olcese 2004, p. 183.2 Principal 1998, p. 19; Mannoni - Giannichedda 1996, p. 25 sgg., passim.3 Olcese 2004, p. 183. 4 Olcese 2004, p. 177.5 V. sopra, p. 13, nota 1. 6 Van der Mersch 1994, p. 162, s.v.7 Barruol 1969, p. 391; Hesnard et alii 1989, p. 65, nota 89.8 De Miro 2000, p. 180, n. 584, fig. 127. 9 Lindhagen 2006, p. 54, fig. 23.10 Márquez Villora - Molina Vidal 2005, n. 366d.11 García Sánchez 1997, pp. 260-261, nn. 1-2; p. 266, fig. 1.12 Martín Camino 1996, p. 11, a pie’ di pagina; Martín Camino 1998, p. 14 (ante 210); Márquez Vil-
lora - Molina Vidal 2005, n. 366a-c.; v. sopra, p. 39, nota 6.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 83
pertanto uno solo, si chiama \AÓ‰ÚˆÓ e distribuisce le sue anfore in un areale medi-terraneo ampio. Solo dell’anfora di Mas Castellar-Pontós è dato il disegno: essa, ben-ché dal profilo bizzarro, può essere attribuita al tipo Van der Mersch vi. La presenzadel marchio al Pech Maho offre a sua volta il termine ante 210/200, consentendo di da-tare l’attività di questo personaggio allo scorcio del iii secolo. Ora il bollo AN¢Pø-NO™ di Caleacte, che appartiene senz’ombra di dubbio alla stessa serie, si troverebbesu una Van der Mersch v (cosa impossibile da provare, se, come sembra, dell’anforaresta solo un frammento di ansa) e proverrebbe da un contesto del primo terzo del iiisecolo.1 Se ciò fosse vero, non potrebbe essere riferito allo stesso personaggio men-zionato dai bolli del Pech Maho, di Mas Castellar-Pontós, di Taranto (per quest’ulti-mo esemplare mi appoggio all’autopsia di D. Manacorda), benché ricavato dallo stes-so punzone. Se ne desume che il bollo di Caleacte non poteva essere impresso su unaVan der Mersch v e che lo strato in cui è stato rinvenuto ha qualche “problema”. Va-le la pena sottolineare, riprendendo la questione delle omonimie, che la serieAN¢PøNO™ deve essere tenuta distinta da quelle con lo stesso nome abbreviatoAN¢P e AN¢Pø registrate da Van der Mersch 1994, pp. 161-162, s.v., che per pun-zone, cronologia, forma dell’anfora (rispettivamente MGS iv e MGS v) appartengonoa contenitori certamente più antichi.
F. Cibecchini ha presentato nel Convegno di Lattes del 2007 una nuova classifica-zione (Cibecchini-Capelli c.s.). In attesa della pubblicazione, segnalo nei contribu-ti già editi la tendenza ad abbassare le datazioni di alcuni relitti (ma sui problemi po-sti da questi giacimenti si è già discusso), da cui può derivare una diversa articolazionedella cronologia dei tipi “in viaggio”.2 Va anche segnalato che l’autrice, che ha lavo-rato molto e bene su questi materiali, ha avuto la possibilità di studiare alcuni conte-sti finora mal documentati e che le sue conclusioni rispondono a conoscenze e datiche ci sono al momento preclusi. Tra i carichi di navi naufragate (tutti “relitti datati”,secondo la definizione di A. Tchernia già richiamata, v. sopra, p. 39, nota 6, p. 41, no-ta 2) che ricevono una datazione piuttosto diversa dalle precedenti proposte (soprat-tutto da quelle di Van der Mersch 2001, p. 178 e di Long 2004), quattro in partico-lare sono quelli su cui richiederei un’ulteriore riflessione.3 Questi contesti, infatti,oltre ad “influenzare” la datazione di altre grecoitaliche tipologicamente simili manon datate, pongono questioni di un certo peso in relazione alla loro origine e ai per-sonaggi implicati nella produzione dei contenitori e nel commercio del vino in un pe-riodo cruciale della storia di Roma e del Mediterraneo. Si tratta dei relitti di:1. Cala Rossa presso Porto Vecchio in Corsica, datato da Van der Mersch al 240+/-20,
da Long al 230-210 e da Cibecchini al 225-200;2. Rogliano/Tour d’Agnello presso Cap Corse in Corsica, datato da Van der Mersch
al 240+/-20, da Long al 250-225, da Cibecchini al 225-200;
1 Lindhagen 2006, p. 192; v. anche Olcese 2005-2006, p. 66.2 Cibecchini 2004, p. 63; Cibecchini 2008, p. 485.3 Ad essi si aggiunge il relitto di Cabrera B (Mallorca), con grecoitaliche di passaggio dal tipo Van der
Mersch v al vi, datato da Van der Mersch 2001 al 250+/-20 e da Cibecchini 2004 al 225-200. Se la cronolo-gia “tarda” del relitto è corretta, come sembra sulla base delle anfore ebusitane presenti nel carico (Ramon1991, pp. 62-63, 150; Ramon 1995, p. 62), occorre pensare che le anfore fossero da anni in giacenza in qualcheporto-deposito e fossero state reimpiegate per quest’ultimo viaggio.
84 clementina panella
3. Terrasini B nelle acque prossime a Palermo, datato da Cibecchini al 225-200 (Vander Mersch riporta in questo caso la datazione alla metà del iii secolo prospettatadagli editori);
4. Pointe Lequin 2 presso l’isola di Porquerolles (Hyères), datato da Van der Merschal 240+/-20, da Long al 210-200, da Cibecchini al 200-175.Non è un caso che tutti e quattro questi relitti siano stati assegnati da Van der
Mersch agli anni tra la prima e seconda guerra punica, decisivi secondo questo auto-re per lo sviluppo della viticoltura nel milieu romano, e dalla Cibecchini nel corso del-la ii Punica o subito dopo (Pointe Lequin 2), nel presupposto che la presenza deglieserciti in Spagna abbia determinato una forte spinta all’esportazione dall’Italia dimerci essenziali per il rifornimento delle truppe.1 D’altro canto, avendo già attribui-to al 250-225 un altro gruppo di relitti certamente più antichi (Montecristo, Meloria A,Bon Capó, Tour Fondue), occorreva individuare un intervallo di tempo tra questi ul-timi e quelli di Cala Rossa, Rogliano, Terrasini B e Pointe Lequin 2 certamente più re-centi. Sembra in sostanza che l’interpretazione che i due studiosi hanno ritenuto dipoter trarre dalla documentazione sia stata condizionata dall’idea che hanno matu-rato sulla provenienza e sul movimento delle merci in questo scorcio del iii secolo.
L’assunto è, che non essendo possibile disporre di molti elementi per interveniresu una manciata di decenni – perché di questo si tratta – si sia ceduto ad impressionipersonali.
Ora, se per definire la cronologia dei relitti è fondamentale tener conto di tutti i ma-teriali trasportati, dei quattro in esame solo per Pointe Lequin 2 sono registrate lemerci di accompagno;2 gli altri tre sono “liberi”, la loro cronologia cioè dipende daquella che viene assegnata alle anfore. Ma occorre anche capire se le partite imbarca-te insieme indichino la contemporaneità non di uso (ciò è evidente nel caso dei relit-ti), ma di fabbricazione dei singoli lotti e dei singoli manufatti3 e, imprescindibilmen-te, la omogeneità del carico.
1 Nolla - Nieto 1989 e Asensio - Martín 1998 avevano già segnalato la scarsa presenza di grecoitalichein Spagna fino agli inizi del ii secolo. La stessa situazione è stata rilevata per la Gallia meridionale. Signifi-cativa a questo proposito la progressione degli arrivi (dallo 0% al 57,5%) nell’oppidum di Nages presso Nîmesin rapporto con le anfore massaliote, tra il 250-225 e il 175-150, cioè nello spazio di tre generazioni (Tchernia1986, pp. 95-96). A Lattara/Lattes (Py-Adroher Auroux-Sanchez 2001, pp. 45-46) le grecoitaliche sono ra-re prima del 225 a.C. (quando si segnalano gli arrivi al Pech Maho o a Mas Castellar-Pontós), data questache coincide con un primo loro salto quantitivo (il 5% sul totale delle anfore degli ultimi anni del iii secoloa.C.), laddove la maggior parte dei frammenti è riferibile ai contenitori marsigliesi che parrebbero aver bloc-cato in questo periodo e fino a questo momento la diffusione dei vini italici nelle aree di influenza di Mar-siglia. Nelle stratigrafie del ii secolo a.C. le grecoitaliche passano dal 20% dei contesti del 200-175 a.C. all’80%di quelli del 150-125 a.C. Nel pozzo 84-4 datato al 175-150 a.C., contenente Campana A e grecoitaliche, que-ste ultime hanno impasti che rimanderebbero soprattutto a produzioni laziali/campane (così anche pro-babilmente per i frammenti con pasta “marmorizzata”) (Poux 2004, pp. 552-554, fig. 288). Nella recente pub-blicazione dello scavo del Quartier 30-35 si registrano nelle fasce cronologiche che scandiscono la storia diquesto centro percentuali più alte di quelle segnalate sopra (gia intorno al 10% nell’ultimo quarto del iii se-colo a.C., il 44% negli strati del 200-175 a.C., intorno al 70% in quelli del 175-150 a.C., il 95% in quelli del 150-125 a.C.: Sanchez - Adroher Auroux 2004), ma la linea di tendenza resta praticamente uguale: il sorpas-so delle massaliote avverrebbe in pratica già nel secondo quarto del ii secolo a.C., come a Marsiglia, checostituisce il centro di distribuzione. 2 Gallia Informations, 1998-1999.
3 Un esempio di reimpiego è il carico del relitto di Heliopolis 2 (a Est di Toulon nel perimetro delle iso-le di Hyères, Var), che ha restituito un’antologia completa dei tipi di grecoitaliche databili tra la metà del iiie la metà del ii secolo, un vero e proprio recupero di fondi di magazzino riutilizzati per un trasporto di pe-ce: Joncheray - Long 2002. Forse anche per i relitti si dovrebbero adottare, quando possibile, i metodi di
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 85
Disegni e fotografie documentano le grecoitaliche del relitto di Cala Rossa, che èstato in questi anni oggetto di un nuovo scavo (2003-2005).1 La ceramica presente sul-l’imbarcazione (comune e da fuoco) è stata assegnata alla dotazione di bordo e nonoffre elementi cronologici precisi.2 La datazione del carico dipende, allo stato attua-le, da quella che assegniamo alle anfore del tipo Van der Mersch vi, simili al collo timbrato da Tr. Loisios, se mai meno evolute.3 La datazione di Ch. Van der Merschsembra plausibile. Il relitto interessa sia per i graffiti tracciati sulle anfore (C.BEBIO,4L. AVRII(li), con E a due tratti, MA.MINVCI = M. (et) A. Minuci(orum) – associazionedi due fratelli o consanguinei – e altri più difficilmente interpretabili),5 sia per il bolloM.VALERI (retro.), che potrebbe avere collegamenti con uno dei primi fabbricantiche timbra in latino le grecoitaliche, quel L. Valerios in via di ipotesi attribuito a Minturno (v. sopra, p. 24, nota 3), di cui condivide lo stile epigrafico. La cronologia del relitto non è perciò irrilevante nella storia delle produzioni e del commercio della media repubblica.
In una situazione analoga viene a trovarsi il relitto di Tour d’Agnello.6 Disegni e foto documentano le grecoitaliche presenti nel carico della nave, spettanti a due varianti, relative a due moduli (le anfore di modulo maggiore hanno la pancia più affusolata ed ovviamente il collo più lungo), ma entrambe sono ascrivibili al tipo Vander Mersch vi.7 Della ceramica rinvenuta nel relitto ricavo solo la notizia della presenza di una patera di forma Lamb. 36 che J.-P. Morel avrebbe collocato alla metàdel iii secolo.8
La somiglianza delle anfore di questo relitto con l’unica anfora intera della nave diTerrasini B, ha evidentemente “trascinato” quest’ultima nella stesso range cronologi-co. A Terrasini compare anche un esemplare frammentario con collo corto, orlo qua-
datazione delle stratigrafie di terra: assegnare cioè una data al naufragio, che corrisponde alla chiusura delgiacimento determinabile attraverso i materiali più tardi, una data ai singoli lotti di merce ai fini dell’inter-pretazone della formazione del carico, e una data al contenitore/nave.
1 Bernard - Cibecchini 2005, 2006 e 2007; Cibecchini et alii 2006.2 Bernard - Cibecchini 2005, p. 100; Bernard - Cibecchini 2006, p. 99: «di filiazione italica meridio-
nale, ma anche punica».3 Fa eccezione l’anfora edita da Liou 1975, p. 604, fig. 42, 1 = Long 2004, p. 147, fig. 23, almeno rispetto
all’esemplare pubblicato da Tchernia 1969a, p. 496, fig. 51 con graffito C TV(?) e ai disegni di Cibecchiniet alii 2006, p. 22, fig. 9, a-b e soprattutto Bernard - Cibecchini 2006, p. 93, fig. 81, 3. Questi due autori par-lano di lotti differenti di anfore riportabili a diverse officine, come testimonierebbero gli impasti (almenootto, di cui tre maggioritari). Il carico in ogni caso è «eterogeneo» e «formato da anfore di diversa prove-nienza»: Bernard - Cibecchini 2005, p. 100.
4 Un discendente, un parente del M. Baebius (M.BAIBI) che timbra le anse di grecoitaliche di Populoniae di Erice? (v. sopra, pp. 25-26, nota 5). Si noti nel bollo la forma arcaica Baibius per Baebius, mentre nel graffi-to manca il dittongo ae, ma è presente la forma del nominativo in -o(s). Da espungere dalla serie dei bolli,L.BAI di Taranto (come supposto da Shepherd 1985), perché su anfora Tripolitana del ii/iii secolo d.C. (au-topsia di D. Manacorda).
5 Bernard - Cibecchini 2006 aggiungono agli esemplari già pubblicati da Bebko 1971, p. 46, nota 272,tav. xl, 272, i graffiti C.BEBIO, C TV (forse un secondo esemplare rispetto a quello già edito da Tchernia1969a: v. sopra), T.ACIO. In totale sembra che siano stati rinvenuti cinque nuovi graffiti, tre (?) bolli in lati-no e due in greco, tutti di difficile lettura e non trascritti, e due bolli con simbolo (stella).
6 Liou 1982, pp. 452-454.7 Le anfore più basse e panciute si attestano sui m 0.75 di altezza (Liou 1982, pp. 452-453, fig. 17, 2 e 4);
quelle più alte affusolate raggiungono i m 0,85/0.87 (Liou 1982, pp. 452-453, fig. 17, 1, 3, 5-6): differente cro-nologia o due differenti officine? 8 Così Long 2004, pp. 146-147.
86 clementina panella
si orizzontale, spalla molto ampia1 che ha sulla spalla il graffito ante cocturam L.AIMIILIO2 (E a due tratti come nel graffito L.AVRII di Cala Rossa; dittongo ai perae, come nel bollo di M. Baibius). Il carico non presenta ceramica d’accompagno3 e leanfore recuperate, data la loro disomogeneità tipologica (si vedano i fondi vuoti cherimandano a varietà più antiche) e di impasti, sono state assegnate agli usi di bordo.La datazione pertanto è desumibile solo dagli esemplari che appaiono, seguendo i criteri di uno sviluppo unilineare, più tardi (oltre all’anfora intera, il collo n. inv. 64).Se questi ultimi possono far assegnare il naufragio, per esempio, al 220, i singoli contenitori possono avere, stando alle loro caratteristiche morfologiche, datazionidifferenti: il collo con il graffito o “i fondi vuoti” possono essere più antichi di uno,due o più decenni.
Del relitto di Pointe Lequin 2, Gallia Information (cd-rom) fornisce la foto di treframmenti: un collo (cilindrico e basso) privo di anse, una spalla e un frammento diansa bollata. Crediamo a L. Long e a G. Volpe quando affermano che le grecoitalicheappartengono al tipo Van der Mersch vi, ma gli oggetti documentati non consento-no un’identificazione certa. E che dire dell’unico esemplare disegnato che è un’anfo-ra più vicina al tipo Van der Mersch v che al tipo Van der Mersch vi,4 simile a quelladel relitto della Tour Fondue, datato a mio parere giustamente da L. Long al 250?5Dobbiamo supporre che vi sia stato un errore nella didascalia o uno scambio dei di-segni? Attenendoci alle sole foto, supporre che le grecoitaliche di questo carico sianodella stessa età di quelle presenti nel relitto del Grand Congloué 1 (generalmente da-tato al più tardi al 190) va forse meglio motivata. Sulla base della ceramica a vernicenera rinvenuta nel carico, J.-P. Morel ritiene che quest’ultimo, insieme a quello dellaMeloria A (datato dalla Cibecchini al 250-225),6 sia «il più antico relitto conosciutocon Campana A», documenti cioè le prime esportazioni finora note di questo tipo di vasellame da Ischia/Neapolis,7 certamente – ne deduco – anteriore al Grand Congloué 1. Il problema è che la cronologia di questo relitto coinvolge quella di unagrecoitalica del carico con il bollo M.ANTESTIO (ST in nesso), che oltre ad avere de-sinenza arcaica del nominativo in -o(s), comune a tutti i bolli che vengono attribuiti aliii secolo, ha diffusione mediterranea che coinvolge sia l’Occidente che l’Oriente:Cartagine;8 Cirta, capitale della Numidia, oggi Constantine in Algeria (devastata allafine del iii secolo),9 Panticapaeum/Kerch (Mar Nero, Ucraina),10 accanto ad Ischia
1 Quindi con caratteristiche tipologiche che rimandano ad un tipo Van der Mersch vi meno evoluto, co-me sono anche quasi tutti i colli rinvenuti. 2 Bivona 1975.
3 La associazione di armi tra i reperti del relitto ha fatto supporre che il carico appartenesse ad una na-ve da guerra (Giustolisi 1975, p. 31 sgg.). Sulle testimonianze di armi nelle navi da collegare a scontri coni pirati e a battaglie navali, v. Gianfrotta 1981; Gianfrotta 2001, che insegue da anni queste tracce e allacui bibliografia si rimanda. Tra i relitti che hanno restituito evidenze relative ad eventi cruenti si ricordanoquelli assai famosi di Spargi (probabilmente la nave è affondata piuttosto che naufragata) e di Albenga, de-gli inizi del I secolo. Dalle acque di Capo Rasocolmo (prov. Messina) viene probabilmente un’altra testi-monianza, questa volta collegata alle operazioni di guerra tra Ottaviano e Sesto Pompeo (Bacci 2001).
4 Long 2004, p. 150, fig. 27.5 Long 2004, p. 145, fig. 21e; il 250-225 è la data di Cibecchini 2004, p. 63.6 Cibecchini 2002, 2004, 2008; troppo alta la data di Van der Mersch 2001, p. 177: prima metà del iii
secolo. 7 Morel 1998b, p. 513.8 Mal interpretato in cil viii, 22637.11. 9 Berthier 1980, p. 23.10 Pridik 1917, p. 60, n. 2.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 87
(erroneamente letto M.ANTERIO, corretto sulla base di una mia revisione), Erice,Catania e Siracusa,1 diffusione che ricorda quella di C. Ariston, un personaggio che sitende a datare intorno al 240 (ma solo in base al bilinguismo dei suoi bolli), e di Tr.Loisios che, come ho detto, penserei attivo intorno al 230. La presenza di ceramicaampuritana potrebbe infine indicare una provenienza dalle coste catalane verso Mar-siglia, oppure si tratterebbe, come più probabile, di un carico formatosi in un porto-deposito. Una provenienza campana (Ischia/Neapolis), se è sicura per la ceramica fineda mensa molto più abbondante delle anfore, è probabile anche per queste ultimeper via degli impasti.2 E per ritornare al caso di M. Antestios, la grecoitalica (anepi-grafe) pubblicata da L. Long, se non è un errore, è rappresentativa dell’intero carico?Le anfore possono essere assegnate ad un carico unitario o vi sono elementi che pos-sono far pensare a partite diversificate? E, infine, è ipotesi praticabile che l’anfora diM. Antestios sia stata riutilizzata per quest’ultimo viaggio? Queste osservazioni ci ri-portano al punto di partenza. I relitti sono autoreferenziali e, benché abbiano mate-riali interi e insiemi costituiti da diverse categorie di oggetti, sono stati spesso sac-cheggiati, parzialmente scavati e in genere assai mal pubblicati…
Mi trovo complessivamente meno a disagio con alcune datazioni (o meglio, con la“filosofia”) di Ch. Van der Mersch, perché mi sembra che rispondano meglio a ciò cheho ricavato dall’analisi delle grecoitaliche nella prospettiva di una tipologia evolutiva.Ma come ho già detto in queste pagine, l’intero sistema può essere messo in crisi dal-l’ipotesi che l’adozione di determinati modelli abbia interessato con tempi differentile singole officine, delle quali nulla o quasi nulla sappiamo. Se ciò è vero, la tipologiaandrà riformulata per ciascun centro di produzione e fino a quel momento le data-zioni continueranno ad oscillare. In ogni caso se queste ultime, come nei casi men-zionati, sono affidate a metodi indiretti, difficilmente si potrà evitare l’effetto “domi-no” o, come dice J.-P. Morel, les décalages implicites qui s’accumulent, ovvero l’accumulodi spostamenti verso il basso, se non si terrà conto dei tempi di trasmissione delle tec-niche e delle mode, dei fenomeni di inerzia, della durata d’uso, delle situazioni di riu-so e di residualità3 (non solo nei siti terrestri). La materia è tutta da discutere. Non hosoluzioni, pongo solo problemi.
Appendice ii
Cartagine e il vino italico
I dati raccolti dalle numerose Missioni archeologiche che hanno operato in questi ul-timi decenni a Cartagine e le altrettanto numerose pubblicazioni relative a questa in-tensa attività di scavo non consentono ancora di ricostruire nel dettaglio un quadrodelle importazioni dall’Italia della principale antagonista mediterranea di Roma tra iiie ii secolo. Differenze talvolta sostanziali esistono per esempio nella “qualità” e nella“quantità” delle anfore rinvenute nei singoli settori di indagine, anche in relazione al-le presenze/assenze di alcuni tipi o produzioni (presenza di anfore rodie alla Byrsa,ma non nel porto commerciale). Vi sono tuttavia alcune linee di tendenza ormai ac-
1 Per la bibliografia di questi esemplari v. Van der Mersch 2001, p. 195.2 «Pasta ricca di molte piccole inclusioni nere»: Gallia Informations, 1998-1999.3 Morel 1990d, pp. 340-341.
88 clementina panella
certate. In particolare c’è un sostanziale accordo che gli arrivi di vasellame e vino ita-lici interessino essenzalmente gli anni successivi alla ii Punica.1 Ciononostante, già trala fine del iv e la metà del iii secolo la città acquisisce ceramica etrusco-laziale (vasidel gruppo dell’atelier des petites estampilles) e campana (ceramica di Teano, CampanaA arcaica), e qualche grecoitalica (tirrenica?), ma si tratta di presenze rare, quasi iso-late, benché costanti (mediate certamente dalla Sicilia occidentale punica – Lilybae -um),2 non confrontabili comunque con quelle massicce di ceramica a vernice nera diNeapolis (Campana A) o della Campana B di Cales dopo il 200.3 Non è chiaro però checosa realmente accada nel corso del iii secolo. Pochi sono i contesti di Cartagine chehanno restituito materiali consistenti di questo periodo, costringendo gli studiosi chese ne sono interessati a raggruppare i dati all’interno di fasce cronologiche ampie (iv-ii secolo), che non permettono di individuare nel breve periodo il volume dei flussicommerciali. Se per le grecoitaliche registrate negli scavi della Byrsa (per J.-P. Morelad esse spetterebbe in età ellenistica più del 25% del totale delle anfore raccolte, tuttele produzioni incluse)4 e del porto commerciale5 e negli scavi lungo la costa sul cardoxviii,6 si può pensare ad arrivi di una certa consistenza soprattutto del ii secolo7 (malo studioso francese avverte che sono documentati tutti i profili di orlo, da quelli oriz-zontali a quelli sempre più obliqui),8 i bolli su grecoitalica rinvenuti nella città appar-tengono ad un orizzonte cronologico che va collocato nel iii secolo e più precisa-mente tra le due prime Puniche. Essi non solo sono tra quelli più diffusi nelMediterraneo occidentale ed orientale (Tr. Loisios, M. Antestios, M. Lurius e forse L. Va-lerios, mentre alcuni bolli in greco potrebbero spettare a produzioni di Neapolis9 e diIschia, v. sopra, p. 31, nota 4 per KAPMEø), ma sono anche tra i più antichi della bol-latura in latino. Il successo del modello anforario si rifletterebbe nella nascita di imi-tazioni,10 di cui tuttavia si ignora la cronologia (forse già nel iii secolo).
Per quanto riguarda poi gli anni compresi tra il 200 e il 149, i dati mostrano che nelrapporto tra ceramica a vernice nera campana e anfore grecoitaliche (certamente oradell’Italia centrale tirrenica) gli arrivi della prima sono molto superiori a quelli delleseconde, benché avessero lo stesso “punto di partenza”. Se la domanda di Cartaginesembra cioè legata essenzialmente alla ceramica fine da mensa campana (Campana Ae Campana B di Cales)11 e se questo vasellame viaggiava, come si ritiene, general-
1 Morel 1998a, 2004 e Bechtold 2007a e 2007b (con tutta la bibliografia di riferimento).2 Bechtold 2007a, p. 64-65; Bechtold 2007b, pp. 29-33. Poste sulla rotta diretta in Nord-Africa, solo Li-
libeo (e Lipari) hanno restituito in quantità molto contenuta Campana B di Cales tra gli inizi del iii secoloe fino alla metà del ii secolo, in coincidenza con la documentazione di Cartagine.
3 Morel 1988a, 1990a.4 Missione francese: Morel 1998a. 5 Missione americana: Wolf 1986.6 Missione tedesca: Vegas 1987: tra quelli illustrati che provengono da strati datati tra la fine del iv e il
tardo iii/ii secolo l’orlo a fig. 7, 17 (p. 373) apparterebbe all’orizzonte più antico.7 Bechtold 2007a. 8 Morel 2004.9 Olcese 2005-2006, p. 66. 10 Morel 1990a, p. 94; Morel 1998a, p. 33.11 Il rapporto percentuale tra queste due classi di vasellame è ora analizzato da Bechtold 2007b: la
Campana A è in ogni caso molto più attestata, ma la Campana B calena ha valori che oscillano secondo icontesti tra il 25% e il 10% contro il 50-43% del vasellame a vernice nera di Neapolis. La produzione liscia diCales (la Calena antica) non raggiunge tra la fine del iii secolo e il 130 valori simili né in Gallia, né in Spagna,ove sembra che sia documentata prevalentemente nelle città romane o in siti con popolazione a maggio-ranza romana o italica (ivi, p. 27, bibliografia alle note 49-50). Se ne desume che questa classe ha avuto nel-la prima metà del ii secolo come mercato privilegiato Cartagine.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 89
mente insieme alla anfore vinarie, appare possibile supporre che la città abbia eserci-tato, anche in relazione a queste ultime, il tradizionale ruolo di ridistribuzione versogli empori punici della penisola iberica (Cadice, Ibiza, Cartagena) e nel Nord-Africa(bollo di M. Antestios a Cirta/Constantine in Algeria, non a caso documentato anchea Cartagine; anfore grecoitaliche a Lixus e in altri siti del Marocco atlantico tramite lamediazione di Cadice).1 I centri menzionati avrebbero a loro volta svolto la funzionedi reti secondarie di smistamento, con ulteriori frazionamenti delle merci.2
C’è da aggiungere che a Cartagine e al suo territorio spetta anche una produzionedi vino che avrebbe potuto bloccare l’acquisizione dall’“estero” di volumi rilevanti diquesta derrata. Accanto alla cerealicoltura, è infatti da assegnare al suo territorio, chevede tra l’altro un forte incremento dell’insediamento rurale dopo la seconda guerrapunica,3 anche un’evoluta arboricoltura, come dimostrano le fonti (Polyb., i, 29, 7;Diod., xx, 8, 4; App., viii, 67) e il trattato agronomico di Magone,4 che i Romani do-po la conquista della città fecero tradurre in latino e di cui si conosce qualche passoattraverso le citazioni di Varrone, Columella, Plinio. Si ritiene che quest’opera abbiaavuto una certa influenza sull’organizzazione dello sfruttamento delle campagne inItalia, così come si ritiene che la conoscenza dei sistemi utilizzati dai Cartaginesi nel-le coltivazioni (e nella viticoltura in particolare), pervenuta ai Romani attraverso icontatti diretti con il mondo punico in Sicilia e con il territorio stesso di Cartagine nelcorso della I Punica, abbia giocato un ruolo importante nello sviluppo di un’agricol-tura dagli alti rendimenti, che fu alla base del decollo economico dell’Italia romana.5
Appendice iii
Regioni adriatiche e arboricoltura speculativa dell’età tardo-repubblicana
«Emerge… da nuovi dati, l’importanza del commercio su lunga distanza dei vini prodotti in altre regioni italiche, la cui vocazione esportatrice era in precedenza igno-ta. L’attribuzione delle anfore Lamboglia 2 ai vigneti dell’alto adriatico richiede infat-ti un parziale ripensamento della geografia economica italica dalla tarda repubblicaall’età imperiale. Non è possibile, oggi, determinare l’organizzazione produttiva diquei vigneti: rimane quindi incerto se il loro successo debba essere attribuito all’im-pianto della villa schiavile, noto nel resto della penisola, o ad altre forme produttive,simili a quelle che consentivano le esportazioni galliche o ispaniche».6 Così si espri-meva A. Giardina qualche anno fa in un contesto in cui analizzava le ragioni di una“crisi” (quella che coinvolge l’Italia nell’età imperiale), sintetizzando i nodi collegatialla valorizzazione del dato archeologico (le Lamboglia 2) e alla ricaduta che la fontemateriale ha su altri oggetti di ricerca (in questo caso sulla storia economica). Perquanto le conoscenze sui contenitori adriatici siano oggi molto più avanzate rispettoa qualche anno fa (penso che ne diano conto le note che ho dedicato a questo argo-mento, v. sopra, pp. 17-21, passim), i dubbi dello storico permangono, anzi divengono
1 Majdoub 1996; Habibi - Aranegui Gascó 2005.2 Bechtold 2007a, p. 53. 3 Bechtold 2007a, pp. 65-66.4 Le diverse ipotesi di datazione del trattato (iv, iii, ii secolo) sono raccolte da Domínguez Petit 2004,
con bibliografia. V. anche sopra, p. 59, nota 9.5 Carandini 1989b, p. 509. 6 Giardina 1997, pp. 242-243.
90 clementina panella
più pressanti di fronte ad un fenomeno produttivo e commerciale che ha acquistato,con le ricerche e le scoperte più recenti, uno spessore quantitativo e qualitativo sem-pre maggiore.1
In quest’ambito riprendo qualche riflessione che può essere utile alla discussione.È noto che nelle regioni adriatiche le tracce archeologiche di ville sono finora me-
no evidenti di quelle della costa tirrenica, ma la massiccia presenza nei siti-mercatodell’Oriente e dell’Egitto del vino trasportato nelle Lamboglia 2 (e dell’olio traspor-tato nelle anfore ovoidi di Brindisi) dà la certezza che le zone destinate all’arboricol-tura speculativa dovevano essere anche in quest’area, tra la metà del ii e la prima metàdel i secolo, assai consistenti. La proprietà di Visellio (appartenente quasi certamen-te ad una famiglia centro-italica)2 nell’agro di Brindisi, a cui spetta nella prima metàdel i secolo l’officina di anfore di Giancola, comprenderebbe un fundus non grandis-simo (di circa 200 ettari pari a 800 iugeri),3 ma ben servito sul piano infrastrutturale(via Minucia, approdo presso il Canale Giancola), collegato ad una villa né di grandidimensioni, né lussuosa, sintomo forse di permanenze brevi del dominus in campa-gna. Lo schema sarebbe quello della villa con il suo campo intensivamente sfruttatocon colture pregiate (olivo, vite), in cui convive il trinomio villa-fornaci-approdo. Al-lo stesso dominus apparterebbe un secondo fundus, ove sorgono un villaggio e due for-naci (presso Masseria Pilella e presso Masseria Marmorelle). In questi impianti cera-mici operano gli stessi servi attestati a Giancola. Qui, secondo l’ipotesi di F. Cambi,predominerebbe l’aspetto più patrimoniale che capitalistico-commerciale, formatodal trinomio villaggio-fornaci-multisettorialità delle conduzioni agricole e ove si po-trebbe immaginare che oltre ai servi che coordinano, come a Giancola, l’attività del-le fornaci, sia stata utilizzata anche manodopera libera, residente nel villaggio e nel-le molte case sparse nel territorio, impiegata nella coltivazione degli ampi spaziarativi.4 Questa ricostruzione mostra la complessità dell’organizzazione agraria e lavarietà delle strutture produttive messe in atto contemporaneamente all’interno diuna stessa proprietà5 e rende credibile che situazioni del tutto analoghe a quelle cheinteressano l’Italia centrale tirrenica si siano sviluppate anche sul versante adriatico.6
1 Alla bibliografia già citata si aggiungano i contributi di Nonnis 2001, 2003 e, in particolare per Aqui-leia, Nonnis 2007.
2 Per l’ipotesi suggestiva, ma non provata, che il personaggio possa essere identificato con il cugino diCicerone C. Visellius Varro, v. Manacorda 1994a, pp. 4-5, con bibliografia.
3 Cambi 2001, p. 369 sgg. 4 Cambi 2001, pp. 387-388.5 Un quadro di sintesi in Manacorda 1994a e 1998; Palazzo 1994.6 Apani, posta su un antico canale a 13 km a Nord di Brindisi, in prossimità dell’approdo di Torre Gua-
ceto, con la sua “succursale” di La Rosa, ha restituito un complesso di fornaci che, diversamente da Gian-cola (“officina individuale” all’interno di un’azienda agricola), potremmo definire di tipo “raggruppato”(Peacock 1982; Manacorda 1994a; Palazzo - Silvestrini 2001), che si sviluppa intorno ad un nodo via-rio connesso ad un approdo. Accanto ai due forni individuati (degli Aninii e dei Vehilii), dovevano esserce-ne altri, come dimostrano la concentrazione del materiale – bollato e anepigrafe – in un’area enorme e lapresenza di molti altri nomi di “fabbricanti”. La pluralità degli operatori rimanda ad impianti utilizzati con-temporaneamente da più individui che avevano forse in comune i mezzi di produzione (tutti o una parte)e che cooperavano nella realizzazione dei manufatti (come accadeva ad esempio negli ateliers di sigillatasudgallica e della sigillata di Arezzo), oppure ad officine di proprietà di un singolo, che prestava i suoi forniad altri (da interpretare su basi onomastiche come proprietari delle derrate da invasare, v. oltre, p. 92, nota4). Nulla sappiamo invece della localizzazione dei fundi, da cui proveniva la merce da “imbottigliare”, inquanto non sono state condotte in quest’area ricognizioni volte a definire l’assetto del territorio circostante.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 91
Tuttavia, benché il modello manufatturiero di Giancola sia lo stesso di quello chesi osserva ad esempio nella stessa epoca nell’ager Cosanus (si ricordino i ventisei serviche timbrano nello spazio di una generazione le anfore di Visellio)1 e benché i domi-ni appartengano alle stesse classi sociali nel Brindisino2 come nel Piceno e nel Cosa-no, l’organizzazione degli spazi agricoli sembra privilegiare in area adriatica gli aspet-ti produttivi piuttosto che quelli residenziali che caratterizzano le ville tirreniche,come dimostrano gli insediamenti rustici di Potenza Picena e di Porto Recanati nelleMarche.3 La lontananza dal centro del potere può aver ingenerato comportamenti di-versi nella scelta della tipologia delle abitazioni rurali da parte dei ceti abbienti (sianoessi personaggi di antica origine urbana e soprattutto centroitalica, o membri emer-genti della comunità locale),4 ai quali dobbiamo assegnare la proprietà delle campa-gne che producono per l’esportazione. Identica è invece la ricaduta economica e com-merciale (a giudicare dalla diffusione delle anfore) di un’agricoltura praticata a finispeculativi, ed identico, se confrontato con l’apparato epigrafico delle Dressel 1, l’im-piego degli schiavi nella manifattura dei contenitori da trasporto.
Nel I secolo d.C. anche il versante adriatico restituisce testimonianze significativedi ville con un apparato architettonico del tutto simile a quello delle villae di lusso tir-reniche. Valgano gli esempi delle ville dei Laecanii nell’isola di Brioni5 o di Calvia Cri-spinilla a Loron presso Parentium/Parenzo6 e forse a Barcola presso Trieste,7 risalenti
1 Manacorda 2003, pp. 301-310.2 Per la prosopografia dei personaggi implicati nella Calabria romana nella produzione delle anfore, in-
sostituibile rimane il saggio di Manacorda 1994a.3 Percossi Serenelli - Frapiccini 2003; Mercando 1979; Mercando et alii 1981.4 Benché i personaggi implicati nella manifattura ceramica di quest’area siano in gran parte estranei al-
l’ambito brindisino come dimostrano i gentilizi Aninius, Visellius, Vehilius, Rudius, Betilienus e altri, l’analisicondotta da Silvestrini 1996, pp. 32-40 ha integrato il quadro disegnato da Manacorda 1994a, eviden-ziando il ruolo svolto anche dalla classe dirigente locale (i Fannii, i Cornelii, i Fabii).
5 A tre generazioni rimandano le proprietà dei Laecanii in Istria: possedimenti terrieri a Matteria (cfr. cil
v, 698), ville a Val Catena, probabilmente a Val Madonna (Kastrum) e a Monte Collisi nell’isola di Brioni,una villa rustica con annesse fornaci a Fasana, oggi Fažana (Pola), dove furono prodotte le Dressel 6B bol-late (Bezeczky 1998, p. 49 ss.). L’apogeo della produzione anforaria, sia in termini di quantità di manodo-pera utilizzata negli impianti, sia in termini di diffusione dei manufatti e delle derrate in essi contenute, spet-ta tuttavia all’età tiberiana/età claudia, cioè proprio all’età del C. Laecanius Bassus, pretore urbano del 32 d.C.e console suffetto del 40 d.C., ancora vivo nel 64 d.C. e, nella fase finale, forse al figlio omonimo, consoleordinario del 64 d.C., morto nel 76/77 d.C. Poiché l’attività produttiva del primo di questi due personagginon può essere datata prima dell’età tiberiana (Tassaux 1982; Tassaux 1983-1984, p. 208; Zaccaria 1989, p.481 e nota 90), è possibile che i pochi bolli rinvenuti in contesti datati ad età augustea del Magdalensbergpossano essere riferiti ad un C. Laecanius, appartenente alla generazione precedente a quella del più famo-so console del 40 d.C. (Tassaux 1998, pp. 82-84 con nuovo stemma della famiglia e datazione alla prima me-tà del i secolo a.C. del primo Laecanius conosciuto: un P. Laecanius).
6 Di Calvia Crispinilla, personaggio assai noto della Roma neroniana (Tac. Hist., i, 73; Dio, 62, 13, 34-35;PIR2, C 363; Raepsaet - Charlier 1987, i, p. 176, n. 184), si conoscono proprietà in Istria (Tassaux 1983-1984,pp. 203-204) e in Puglia, con attestazione di servi e liberti nel Tarantino, nel Brindisino, a Venosa e in Dau-nia (Manacorda 1995b, pp. 185-187; Manacorda 1995a, pp. 149-151, con bibliografia; Manacorda 2001b, p.402). Essa appartiene cioè alla schiera di quei domini, i cui fondi, destinati ad attività produttive diversifica-te (agricoltura intensiva e estensiva, allevamento e attività silvo-pastorali), risultano dislocati sia a Nord chea Sud dell’Adriatico. Sulla villa di Loron, sulla produzione di Dressel 6B e sui suoi proprietari, v. Tassaux etalii 2001; Rosada 2004. Nello scavo della villa, oltre a svariati contenitori bollati da Crispinilla sono stati rac-colti anche molti marchi SISENNAE (AE in nesso), riferibili a T. Statilio Sisenna Tauro, console del 16 d.C.(produttore di Dressel 6B e di sigillata nord-italica), che potrebbe essere stato il primo proprietario del com-plesso e dei suoi annessi produttivi: Tassaux et alii 2001, pp. 312-314.
7 Fontana 1993; Zaccaria - Župan©i© 1993, p. 169.
92 clementina panella
probabilmente già ad età augustea, nei cui fundi si trovano officine di anfore associa-te a nomi servili (33 sono i servi che timbrano le olearie Dressel 6B dei Laecanii nel-l’impianto produttivo di Fažana presso Pola).1 Come molte delle ville tirreniche, leproprietà dei Laecanii e di Crispinilla, insieme con i loro impianti ceramici, finirannonello spazio di una generazione nelle proprietà imperiali.
Andando più indietro nel tempo (quindi guardando ad un orizzonte cronologicoda collocare tra il 140/125 e l’età augustea) e in riferimento alle Lamboglia 2 (cioè adanfore prodotte dal Salento ad Aquileia, con una forte componente sul piano del-l’esportazione del Piceno) va segnalato che su diverse centinaia di esemplari bollatispettanti a questo tipo anforario oltre 200 testi si riferiscono a schiavi contro un cen-tinaio di liberi e che questi ultimi, quando presenti, appaiono associati nello stessomarchio a servi in proporzione maggiore rispetto a quanto accade sulle Dressel 1. Ov-viamente questi servi costituiscono la manodopera delle officine ceramiche, ma unatale massiccia presenza nella manifattura può gettar luce anche su quella presumibil-mente esistente nelle campagne. Tempererei pertanto le perplessità di A. Giardina sulmodo di produzione che sta dietro il successo dei vini adriatici: le anfore che traspor-tano questi vini, ampiamente diffuse, non mostrano, almeno nella bollatura, diffe-renze sostanziali dalle contemporanee tirreniche Dressel 1. Anche sui marchi delleLamboglia 2 è possibile individuare dei nomi di personaggi da ricollegare a famigliedi rango, fermo restando il margine di incertezza dovuto alla diffusione dei gentilizie alle forme molto contratte delle iscrizioni dell’instrumentum. Si tratta di (Licinius)Crassus, i Fabii (Hadriani?), gli Hos(tilii Sasernae e Mancini), i (Publicii) Malleoli, L. No-nius A(sprenas?), gli Octavii, (C.) Visellius (Varro?), L. Tarius Rufus, gli Herennii. Per L. Pa-conius si è pensato a L. Paconius Tryphon o più semplicemente a L. Paconius, cioè amembri di una delle famiglie italiche più importanti di Delo.2 Certamente questi per-sonaggi, se le nostre ipotesi sono giuste, non sono residenti, ma semplicemente im-plicati nelle attività produttive del territorio. Per dare un’idea degli interessi fondiarie imprenditoriali degli esponenti dell’aristocrazia senatoria distribuiti sull’uno e sull’altro versante della penisola si cita solitamente il caso dei Lentuli: L. Cornelius P. f.Lentulus Crus, console del 49 è quasi certamente da identificare con il L. (Cornelius) Lentu(lus) P. f. che timbra le Dressel 1 del relitto di Santa Severa e che diffonde il suovino, come attestano i bolli, in Gallia e in Spagna (Baleari), ma anche a Paphos, ad Ate-ne, a Laurion.3 Il territorio interessato dalle sue proprietà (e dalle sue officine cerami-che) spetterebbe a Minturno, come dimostra l’esistenza dei suoi servi tra i magistriMinturnenses.4 Ma lo stesso personaggio è riconosciuto nel bollo ORESTE LENTVLO(EN e VL in nesso) = Oreste(s) Lentulo(rum) (scil. servus) impresso su un’anfora ovoidedi Brindisi prodotta nella fornace di Apani, ove nel plurale si è voluto individuare lapresenza anche del fratello P. Cornelius Lentulus Spinther, console del 57.5
1 A differenza di questi ultimi, i bolli di Crispinilla (e prima di lei quelli dei proprietari che la hanno preceduta e quelli degli imperatori che le succederanno a Loron) non sono mai accompagnati da un nomeservile; il che fa pensare che nei due centri vi sia stata una diversa organizzazione della manodopera e del-l’impresa manifatturiera: Manacorda 1995b, p. 185.
2 Hatzfeld 1912, p. 66, nn. 10-11; Flambard 1982, pp. 71-75; Rauh 1993, pp. 223-231.3 Gianfrotta 1982. Per Lentulo, produttore di vino, produttore di anfore e armatore, v. sopra, pp. 48 e 50.4 cil i2, 2682, 2684, 2698, cfr. pp. 845, 934; Coarelli 1983, p. 52 sgg.5 Manacorda 1988, pp. 101-102.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 93
Sull’altra ansa della stessa anfora c’è il bollo con il nome di altro dominus, L. Appu-leius1 con il suo servo Philonicus.2 Questo straordinario documento permette di veri-ficare l’esistenza di un’associazione di servi, mediante la quale, come testomoniano itesti giuridici, i padroni (in questo caso i Lentuli e gli Appuleii) erano in grado di gesti-re le attività collegate all’organizzazione dell’impresa agricola.3
Lasciando l’Adriatico per lo Ionio, ma rimanendo nel Salento, qualche osservazio-ne può essere fatta sulla documentazione epigrafica delle anfore rinvenute a Taranto,il cui vino, come si è già detto, è considerato di qualità dagli scrittori antichi (v. p. 19,nota 2). Perduta l’autonomia dopo la sconfitta nel 267/266 nella guerra contro Romae poi più concretamente, a causa della sua defezione, nel corso della guerra annibali-ca, la città fu costretta a ridimensionare il suo ruolo nel contesto di una realtà politi-ca, amministrativa e sociale completamente mutata. Su queste tematiche, continui-tà/discontinuità, tenuta/declino in età romana la bibliografia è ampia.4 Sul pianodelle condizioni economiche, produttive e commerciali, all’ipercriticismo di J.-P. Mo-rel, che arresta la sua analisi, basata sull’artigianato e la diffusione dei manufatti ce-ramici tarantini al 209,5 data dopo la quale, secondo lo studioso francese Taranto èuna città “dalla voce fioca”,6 si contrappone il quadro disegnato da E. Lippolis che as-segna, in base alla documentazione archeologica restituita dalle necropoli e dall’abi-tato e in base alle iscrizioni e alle fonti letterarie, alla Taranto post-annibalica, una po-sizione di rilievo tra i centri urbani nella penisola, sia sul piano produttivo (economiadella selva e allevamento nelle Murge tarantine, pastorizia e industria laniera, agri-coltura nelle aree medio-collinari e pianeggianti lungo lo Ionio), sia sul piano com-merciale (quest’ultimo incentrato, in particolare, sui rapporti con Delo – tratta deglischiavi? – e con Alessandria, ma all’interno di un circuito di traffici che almeno nel iisecolo unisce il suo porto con Eraclea, Reggio, Neapolis, Siracusa e Ancona). Benchéassai poco si sappia sull’organizzazione delle campagne prima e dopo la conquista ro-mana, sull’ubicazione e dell’uso dell’ager publicus (Taranto tra l’altro riceve invii di co-loni nel 123, con assegnazioni individuali), le anfore, in gran parte rinvente nel corso
1 Il personaggio, che è dopo gli Aninii e Vehilius il terzo maggiore produttore di Apani, è di difficile iden-tificazione (Manacorda 1988, p. 103; Manacorda 1994a, pp. 12-14). Si conoscono due rami della gens, ori-ginaria di Luna, uno che aveva stretti rapporti di parentela con Augusto (Torelli 1982, p. 287), l’altro degliAppuleii Saturnini. Alla famiglia appartengono, oltre a diversi senatori (Broughton, Magistrates ii, p. 488),anche personaggi come Appuleius praediator dell’epistolario di Cicerone ad Attico del 45 (RE, ii, 1, s. v. Appuleius, c. 245, n. 3), o C. Appuleius Decianus (ivi, c. 260, n. 22), noto dalla Pro Flacco ciceroniana, implicatoalla metà del i secolo in operazioni economiche e commerciali prevalentemente in Asia. Sull’ipotesi di pa-rentela tra gli Appuleii e i Laenii Flacci, una famiglia dell’aristocrazia municipale di Brindisi, v. Silvestrini1996, pp. 34, 37 (su quest’ultima e sul coivolgimento dei Laenii Flacci nel commercio del vino, allo scorciodel i secolo, insieme ad un’altra famiglia dell’ordo brindisino, quella dei Philonii, v. Manacorda 1998, p. 320-324; Nonnis 2003, p. 273, nota 103). Nell’epigrafia brindisina il gentilizio è documentato nella stele sepolcraledi un Cottidianus, servo di un C. Appuleius Flaccus = AE 1966, 88. I rapporti con l’ambiente urbano sono evi-denziati dell’associazione della gens con i Lentuli.
2 Palazzo 1989, p. 549, fig. 1, 5 = RTAR ii, 714. Sul significato di questa duplice timbratura e sui perso-naggi coinvolti, v. Manacorda 1989, pp. 458-460; Manacorda 1994a, p. 14.
3 Di Porto 1984.4 Si rimanda alla sintesi del dibattito storiografico tracciata da Lippolis 2005.5 Si tratta, fondamentalmente, per l’età che qui interessa, della ceramica di Gnatia, a cui lo studioso fran-
cese riconosce complessivamente una circolazione limitata, a medio raggio (un marché de proximité: Morel2008, p. 163), ad eccezione dell’Alexandria Group (ivi, pp. 163-165), che interessa tuttavia solo Alessandria, laCirenaica e pochi altri siti per il tramite della stessa Alessandria. 6 Morel 1976a.
94 clementina panella
dell’Ottocento e confluite nelle “Collezioni Viola” del Museo Nazionale di Taranto,1offrono un intressante spaccato di quanto circolava nella città tra iii e i secolo.
Ch. Van der Mersch attribuisce a Taranto la produzione dei tipi v e vi in base ai ri-trovamenti localizzati in zone urbane interessate da attività artigianali (via Aristosse-no).2 Una quindicina sono i bolli editi su grecoitaliche registrati nel corso delle mie ri-cerche. Tre sono in greco: BIø[Tø] (un esemplare: lo stesso del relitto di Capistello?)e AN¢Pø[NO™] (due esemplari). Gli altri, in latino, sono riferibili a fabbricanti tra i piùdiffusi nel Mediterraneo in età ellenistica: Q. I(u)ventius, Tr. Loisios (cinque esemplari),C. Aristo/°¿ÈÔ˜ \AÚ›ÛÙˆÓ (rispettivamente uno e due esemplari), L. Vesgeius (noto consei esemplari ad Erice ed uno nella Collezione Mandralisca di Cefalù).3 Dei luoghi diorigine di questi bolli, di cui abbiamo ampiamente già parlato, non si hanno certezze,ma per nessuno si può pensare ad una provenienza da area tarantina, salentina o apu-la in generale. Lo stesso Ch. Van der Mersch nota che i bolli greci documentati sullegrecoitaliche non hanno caratteristiche ascrivibili allo ionico-tarantino, né rapporticon l’onomastica di questo settore. Ciò non sminuisce il valore documentario di que-sto piccolo corpus che comprova le attività commerciali della città prima o durante laseconda guerra punica (bolli di Tr. Loisios e C. Aristo/°¿ÈÔ˜ \AÚ›ÛÙˆÓ, \AÓ‰ÚˆÓ) e im-meditamente dopo di essa (bollo di Q. I(u)ventius). Sulla base della documentazionecomplessiva restituita da Taranto, essa risulta importare tra iv e ii secolo a.C. vino pre-valentemente dall’Egeo e dallo Ionio, come dimostrano i materiali bollati conservatinel Museo, ove 128 sono i marchi rodii (post 210), seguiti da quelli corinzio/corciresi,cnidi e tasii (Desy 1993, p. 251, tab. vi). I dati quantitivi, conseguendo da materiali bol-lati, consentono di definire i legami commerciali della città, confermano, se ce ne fos-se stato bisogno, l’importanza dei contatti con il mondo egeo-orientale, ma non dan-no conto delle effettive scelte dei consumi urbani, ricostruibili solo in base alla totalitàdelle anfore spettanti a contesti cronologicamente definiti e integralmente raccolti.
Più consistente è la documentazione epigrafica delle Lamboglia 2, che dalle gre-coitaliche derivano e che le sostituiscono dalla metà del ii secolo in area adriatica (qua-rantaquattro esemplari compaiono nel catalogo di Ph. Desy; ottantuno risultano dal-le mie ricerche, quasi tutti dalle località Montedoro, Santa Lucia e Peritato).4 Ancheper alcune di queste anfore si è supposto una provenienza tarantina, su basi in veroassai labili,5 in particolare per quelle timbrate da un Fabius (FAB in nesso) e dai suoiservi, Castir/Castirus (nome/i non documentato/i), Epicrates e Teucer/Teucher, atte-state anche a Delo e ad Atene, quindi databili (quasi certamente) rispettivamente an-te 89/88 e ante 86 (sacco di Silla).6 Ma la città importa sicuramente vino, ad esempio,dal Bruzio ionico (bolli di N. Scaptius e dai Lusius Medicus, v. sopra, pp. 52-53), dal Pi-ceno meridionale (Marina di Città Sant’Angelo: i bolli di Malleolus, v. pp. 17-18, nota 5,e Addendum), dalla valle del Cesano – territorio di Sena Gallica – nelle attuali Marche(bolli di Menolaus e di L. Salvius).7 Queste presenze confermano la vitalità della città edel suo porto ancora nel i secolo a.C. Che circolassero tuttavia in Oriente anfore con-
1 Viola 1885; Dell’Aglio 1988; Palazzo 1988. 2 Van der Mersch 1994, pp. 80, 86.3 RTAR i, 3; Pellegrini 1887, 730-735; Garozzo 2003, pp. 612-613, tav. xciv, 5. Il gentilizio non è noto,
forse da connettere a Vescius (Schulze 1904, p. 253).4 Viola 1885; Palazzo 1988; Desy 1989.5 Desy 1993, pp. 232, 251. 6 Desy 1994, p. 204.7 Mercando 1979, p. 118, n. 10; p. 119, fig. 30f; p. 120, fig. 31d; p. 121, n. 12; p. 117, fig. 29y; p. 120, fig. 31f.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 95
tenenti vino di Taranto sembra provato da un titulus pictus su una frammento di pa-rete non identificabile da Masada (Israele) con la menzione del Tarantinum (per Ta-rentinum (vinum)) e data consolare del 14 a.C.1 Non è possibile conoscere la forma delcontenitore che potrebbe essere, piuttosto che una Lamboglia 2, una Dressel 2-4,un’anfora che a Masada compare in contesti attribuiti ad età erodiana (37-4 a.C.), tim-brata da M. Octavius e dai servi Eudemus e [Spi]nt(h)er, come a Taranto. Anche per que-sto fabbricante, forse identificabile con l’Octavius che bolla una Lamboglia 2 nella for-ma OCTAVI di Taranto, è stata supposta un’origine da questa città o piùgenericamente dal Salento.2
*Addendum
Dopo la stesura di questo saggio, ho avuto modo di leggere l’articolo di A. Lindhagen, Thetransport amphoras Lamboglia 2 and Dressel 6A: a central Dalmatia origin?, “Journal of Roman Ar-chaeology”, 22, 2009, pp. 83-108. L’autore, riprendendo ipotesi già avanzate (Cambi 1989, pp.321-322; Lyding Will 1989 per i tipi Will 6 e 13; Kirigin - Katunaric - Šešeli 2006, pp. 193-194),attribuisce alla Dalmazia centrale (alle isole di Issa/Vis e di Pharos/Hvar e al vino di Naro-na/Vid e della valle della Neretva) la produzione di Lamboglia 2 e Dressel 6A, come per altroera stato supposto anche per le grecoitaliche (v. sopra, p. 19). Benché sia noto che queste an-fore provengono anche da territori diversi da quelli dell’Adriatico peninsulare o della Cisalpi-na, come dimostra la loro fabbricazione ad esempio in area vesuviana (anfore bollate da M.Lollius Q. f. e C. Ofi(- - -) del relitto della Madrague di Giens: A. Hesnard, in rtar ii, pp. 308-310),nel Bruzio ionico (Lamboglia 2 bollate da N. Scaptius: Corrado 2009), nell’Etruria interna(Montelupo Fiorentino, villa del Vergigno, loc. Pulica: Berti 1998) e altrove in ambito tirreni-co, il punto di domanda “Dalmatia origin?” resta, in quanto non si dispone di indicatori (mor-fologia, epigrafia e stile epigrafico, impasti e caratteristiche tecniche) che rendano possibilel’individuazione delle singole aree di origine di gran parte degli esemplari editi (e quindi even-tualmente anche di quelli illirici). Se si utilizza come discriminante il corpo ceramico, le argil-le “adriatiche”, come le definisce A. Lindhagen, ricorrono sul piano macroscopico anche sul-le anfore “ovoidi adriatiche”, sulle anfore con collo ad imbuto, sulle anfore a fondo piatto diForlimpopoli e simili, sulle Dressel 2-4 adriatiche, tipi e forme per le quali la produzione sullasponda occidentale dell’Adriatico è sostenuta da elementi certi o da indizi affidabili. Non so-no invece in grado di giudicare i risultati delle analisi minero-petrografiche (a quelle condot-te da Bruno 1995, da Bezeczky 1994 e da altri si affiancano ora quelle di I. Sondi-D. Slove-nec, The mineralogical caratteristics of the Lamboglia 2 amphorae from the central Adriatic (Croazia),“Archaeometry”, 45, 2003, pp. 251-263), perché sul piano del metodo mi sembra fuorviante at-tivare questo tipo di indagine ai fini dell’identificazione delle provenienze senza avere primacreato “gruppi di referenza” basati sui materiali di fornace o di origine sicura. Sul piano stret-tamente archeologico vorrei aggiungere solo alcuni dati che forse sono sfuggiti all’autore: lefornaci di Apani e Giancola hanno prodotto Lamboglia 2 (tipi Apani I e Giancola 2A e 7B: Pa-
1 Cotton - Geiger 1989, pp. 158-160, n. 818, tav. 22; Manacorda 1998, p. 323.2 Il bollo OCT (abbreviazione dello stesso gentilizio, Octavius), impresso a Taranto su Lamboglia 2 e a
Giancola, dallo stesso punzone, su Dressel 2-4 e anfore ovoidi, proviene dalla seconda fase di attività di questa fornace. Ovviamente non sono da escludere omonimie, soprattutto quando trattasi di un gentiliziocosì diffuso, com’è quello in esame. Su tutte queste serie (OCT, OCTAVI, M. OCTA e M.OCTAV + servi),v. Manacorda 1998, pp. 323, 325, con bibliografia, che prospetta, tra l’altro, per i contenitori timbrati da M.Octavius un’origine medio-adriatica.
96 clementina panella
lazzo-Silvestrini 2001; Manacorda 1998); le fornaci di Malleolus (con bolli già noti nel re-litto di Planier 3 della metà del i secolo: Tchernia 1968-70; Tchernia 1986, p. 118 e carta didiffusione a p. 402), di un Cadmus (Lamboglia 2) e dei (Rubrii?) Barbari (Dressel 6A) sono staterinvenute e scavate a Marina di Città Sant’Angelo (prov. Pescara), ai confini meridionali dellacolonia di Hatria/Atri, in una località identificata con la statio ad Salinas alla foce del fiume Sa-line (Staffa 2003, pp. 119-129, figg. 3-9; Staffa 2004, pp. 279-280, fig. 27); fornaci di Lambo-glia 2 anepigrafi sono state individuate nel territorio di Potenza Picena (prov. Macerata; v. so-pra, p. 20, nota 9) e tra Giulianova alla foce del Tordino e Roseto (prov. Teramo), su una collinaa poca distanza dal mare, in località Cologna Marina, nel territorio di Castrum Novum (v. sopra,p. 20, nota 10); i bolli MENOLA, ATHENOD(orus), ANTIOC(us) e forse NICIA sono attestati– dallo stesso punzone – anche su anfore “ovoidi adriatiche” (Mercando 1979), di cui non viè traccia finora in Dalmazia, così come i bolli di Q. Ninnius Secundus compaiono su Dressel 6Ae sulle anfore a fondo piatto dette di Forlimpopoli (Carre 1985), la cui provenienza dal Rimi-nese (Stoppioni 1993) e dal Piceno è certa (fornace di Città Sant’Angelo già citata, e di Mon-tesilvano, loc. Tesoro nel Pescarese con bolli di C. Herranius Geminus imparentato con i Ninnii:Staffa 2003, pp. 130-132; Carre 1985); i bolli di un Oct(avius) e di L. Aninius Surus, rispettiva-mente dalle fornaci di Giancola (Manacorda 1994a) e di Casola Canina (Imola: rtar ii, 824),compaiono – ricavati dalla stessa matrice – su Lamboglia 2, anfore ovoidi e Dressel 2-4 nel pri-mo sito, e su Dressel 2-4 e Lamboglia 2 nel secondo; gli scarti di fornace da un insediamentorustico sul fiume Piomba (Silvi Marina, prov. Pescara: Staffa 2003, pp. 118-119, fig. 2; p. 128,fig. 10) rimandano alla produzione di grecoitaliche (forse anche antiche), Lamboglia 2, anforea fondo piatto e Dressel 2-4 anepigrafi. Le Lamboglia 2 timbrate KANI (un bollo di cui esisteuna concentrazione consistente di ritrovamenti nella valle del Cesano, nel territorio di SenaGallica) e MENOLA, che compaiono insieme nel relitto di Stanici ¬elina su Lamboglia 2, so-no talmente simili da far pensare ad uno stesso centro di produzione, se non ad una stessa offi-cina; inoltre il bollo KANI potrebbe riferirsi sia ad un gentilizio (Kanius: Carre 2002; Nonnis2001), sia ad un cognomen Kanus (ipotesi Cambi/Lindhagen); fragile è lo scioglimenti dei bol-li L.POT e M.POT del relitto di Vis/Vela Svitnia con L. Po(n)tius, rintracciato su un’iscrizionedi Vis. Passando alle Dressel 6A, ben più numerose sono le officine che usano lo stesso mar-chio sia su queste anfore, sia sulle Dressel 6B (P. Q. Scapula, P. Sepullius, Flavius Fontanus, Copo-nius, gli Ebidii/Ebidieni, Sex. Iulius Severus), sia sulle Dressel 2-4 (Ebidii/Ebidieni e suoi servi, Au-tronius). Sulla provenienza istriana e nord-italica delle Dressel 6B non ci sono dubbi; lafabbricazione di Dressel 2-4 è ampiamente documentata nell’Italia settentrionale e meridio-nale (dal Piemonte all’Emilia, dalle Marche al Salento). È assai difficile infine contestare che ilgruppo delle Dressel 6A, isolato sul piano morfologico da Pesavento Mattioli 2002 e tim-brato dai Gavii, dagli Ebidii/Ebidieni, dagli Hostilii, dai Valerii, non sia di produzione nord-adria-tica “occidentale”. Ed infine, nelle discariche con scarti di fornace, di cui A. Lindhagen non sifida (v. tra le tante quelle di Cesano di Senigallia = bolli KANI e di L. Salvius, di Torre di Pal-me = bolli di C. Iul(ius) Poly(- - -) associato a (Q. Aemilius Lepidus?) Barbula e del Pescarese), Lam-boglia 2 e Dressel 6A non sono state rinvenute in centri che possano giustificare importazionidi vino da parte di comunità urbane, ma nelle campagne, in prossimità di ville, fiumi ed ap-prodi: se si trattasse sempre e comunque di arrivi dall’Illiria, chi sarebbero stati i consumatori?
Bibliografia
Adamo Muscettola 1996 = S. Adamo Muscettola, Un rilievo deliaco da Pietrelcina: sulle tracce di Vedio Pollione, «La Parola del Passato», 51, 1996, pp. 118-131.
Adembri 1996 = B. Adembri, Le ceramiche figurate più antiche di Ostia, in ‘Roman Ostia’ revisited.Archaeological and historical papers in memory of Russell Meiggs, eds. A. Gallina Zevi, A. Clar-idge, London, 1996, pp. 39-67.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 97
98 clementina panellaAequora = Aequora, fiÓÙÔ˜ jam, mare… Mare, uomini e merci nel Mediterraneo antico, Atti del
Convegno Internazionale (Genova, 9-10 dicembre 2004), eds. B. M. Giannattasio et alii, Firenze,2005.
Aisa - Corrado - De Vingo 2001 = M. G. Aisa, M. Corrado, P. De Vingo, Una fornace perla produzione di Dressel 1 sulla costa centro-orientale del Bruttium, in Atti del xxxiii Convegno Internazionale della Ceramica (Albisola, 26-28 maggio 2000), Firenze, 2001, pp. 301-312.
Alfieri 1981 = N. Alfieri, Insediamenti litoranei tra il Po e il Tronto in età romana, «Picus», 1,pp. 7-39.
Amela Valverde 2006 = L. Amela Valverde, Pompeio Magno. Italici qui Agrigenti nego-tiantur, «Gerión», 24.1, 2006, pp. 195-206.
Andreau 1999 = J. Andreau, Intérêts non agricoles des chevaliers romains, in L’Ordre équestre. Histoire d’une aristocratie, Actes du Colloque International (Bruxelles-Louven, 5-7 octobre 1995), eds.S. Demougin et alii, Rome, 1999, pp. 271-290.
Andreau 2003 = J. Andreau, Les commerçants, l’élite et la politique romaine à la fin de la Répu-blique, in Mercanti e politica, pp. 217-243.
Andreussi 1981 = M. Andreussi, Stanziamenti agricoli e ville residenziali in alcune zone cam-pione del Lazio, in srps i, pp. 349-370.
Aquileia = Aquileia dalle origini alla costituzione del Ducato longobardo. Territorio, economia, società,eds. G. Cuscito, C. Zaccaria, Trieste, 2007.
Aranegui Gascó 1995 = C. Aranegui Gascó, Un ánfora de Tr. Loisio en Sagunto (Valencia),«Extremadura Arqueológica», 5, 1995, pp. 247-263.
Aranegui Gascó 2002 = C. Aranegui Gascó, Las ánforas con la marca MA°øN, in Vivre,produire et échanger, pp. 409-415.
Aranegui Gascó 2004 = C. Aranegui Gascó, Sagunto. Oppidum, emporio y municipio romano, Barcelona, 2004.
Archeologia della vite = Archeologia della vite e del vino in Etruria, Atti del Convegno Internazionaledi Studi (Scansano, 9-10 settembre 2005), Siena, 2007.
Archeologia dell’Adriatico = L’Archeologia dell’Adriatico dalla Preistoria al Medioevo, Atti del Conve-gno (Ravenna, 7-9 giugno 2001), ed. F. Lenzi, Firenze, 2003.
Archeologia subacquea = Archeologia subacquea. Come opera l’archeologo. Storie dalle acque, viii Ci-clo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia (Certosa di Pontignano, Siena, 9-15 dicembre1996), ed. G. Volpe, Firenze, 1998.
Arnaud 1998 = P. Arnaud, Vers une definition géodynamique des suburbia. Eléments pour une zonation des zones péri-urbaines, «Caesarodunum», 32, 1998, pp. 63-81.
arse = Anfore romane e storia economica: dieci anni di ricerche, Atti del Colloquio di Siena (22-24 mag-gio 1986), Rome, 1989.
Arthur 1991 = P. Arthur, Romans in Northern Campania: a Study of Settlement and Land-usearound the Massico and Garigliano Basin, London, 1991.
Asensio 1996 = D. Asensio Vilaró, Les àmfores d’importació de la ciutadella ibèrica d’AlordaPark o Les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès, Tarragona), «Revista d’Arqueologia de Ponent»,6, 1996, pp. 35-79.
Asensio - Martín 1998 = D. Asensio i Vilaró, A. Martín i Menéndez, El derelicte de BonCapó (L’Ametlla de Mar): l’inici de l’expansió de vi itàlic a la Península Ibèrica, in ViAnt ii, pp. 138-150.
Attolini - Cambi - Castagna 1991 = I. Attolini, F. Cambi, M. Castagna, Political Geographyand Productive Geography between the Valleys of the Albegna and the Fiora in Northern Etruria, inRoman Landscapes. Archaeological Survey in the Mediterranean Region, eds. G. Barker, J. Lloyd,London, 1991, pp. 142-152.
Auditorium 2006 = La fattoria e la villa dell’Auditorium nel quartiere Flaminio di Roma, eds. A. Ca-randini, M. T. D’Alessio; H. Di Giuseppe, Roma, 2006.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 99Auriemma 2004 = R. Auriemma, Salentum a salo. Porti, approdi, merci e scambi lungo la costa
adriatica del Salento, 1-2, Galatina (Le), 2004.Bacci 2001 = G. M. Bacci, Il relitto di Caporasocolmo, in Da Zancle a Messina. Un percorso ar-
cheologico attraverso gli scavi (Catalogo Mostra), ii, 1, eds. G.M. Bacci, G. Tigano, Messina, 2001,pp. 273-277.
Bandelli 1991 = G. Bandelli, L’economia nelle città romane dell’Italia Nord-Orientale (i secoloa.C.-ii secolo d.C.), in Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des römischenReiches, Atti del Convegno (Köln, 18-20 mai 1989), eds. W. Eck, H. Galsterer, Mainz am Rhein,1991, pp. 85-103.
Bandelli 2003 = G. Bandelli, Dallo spartiacque appenninico all’“altra sponda”: Roma e l’Adria-tico tra il iv e il iii secolo a.C., in Archeologia dell’Adriatico, pp. 215-225.
Bargagliotti - Cibecchini 2003 = S. Bargagliotti, F. Cibecchini, Il porto romano in locali-tà Puntone di Scarlino (Gr): indagini archeologiche subacquee e porti moderni, in Atti del ii Conve-gno Internazionale di Archeologia Subacquea (Castiglioncello, 7-9 settembre 2001), Bari, 2003, pp.43-59.
Barra Bagnasco 1990 = M. Barra Bagnasco, Due tipi di anfore di produzione locrese, «Klear-chos», 125-128, 1990, pp. 29-48.
Barruol 1969 = G. Barruol, Informations archéologiques: Circonscription de Languedoc-Rous-sillon, «Gallia», 27, 1969, pp. 380-417.
Bats 1976 = M. Bats, La céramique à vernis noir d’Olbia en Ligurie: vases de l’atelier des petitesestampilles, «Revue Archéologique de Narbonnaise», 9, 1976, pp. 63-80.
Bats 1988 = M. Bats, Vaisselle et alimentation à Olbia de Provence (v. 350-v. 50 av. J.-C.), «Revue Archéologique de Narbonnaise», Suppl. 18, Paris, 1988.
Bats 1990 = Les amphores de Marseille grecque. Chronologie et diffusion, vie-ier siècles av. J.C., Actesde la table ronde (Lattes, 11 mars 1989), ed. M. Bats, Lattes, 1990.
Bats 2007 = M. Bats, La consommation du vin étrusque en Méditerranée occidentale. Un bilan cri-tique des connaissances, in Archeologia della vite e del vino in Etruria, Atti del Convegno interna-zionale di studi (Scansano, 9-10 settembre 2005), eds. A. Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero, Siena,2007, pp. 168-175.
Bebko 1971 = W. Bebko, Les épaves antiques du Sud de la Corse, «Cahiers Corsica», 1-3, Bastia,1971.
Bechtold 2007a = B. Bechtold, Alcune osservazioni sui rapporti commerciali fra Cartagine, laSicilia occidentale e la Campania (iv-metà del ii sec. a.C.). Nuovi dati basati sulla distribuzione diceramiche campane e nordafricane-cartaginesi, «Bulletin Antieke Beschaving. Annual Papers onClassical Archaeology», 82, 2007, pp. 51-76.
Bechtold 2007b = B. Bechtold, La classe Byrsa 661 a Cartagine. Nuove evidenze per la tipologiae la cronologia di ceramica calena nella metropoli punica, in Carthage Studies, 1, ed. R. F. Docter,Gent, 2007, pp. 1-36.
Bechtold - Valente 1990 = B. Bechtold, I. Valente, Un’area industriale punica nel cortiledel Museo Archeologico Baglio Anselmi, Marsala, «Sicilia Archeologica», 72, 1990, pp. 39-50.
Benoit 1957 = F. Benoit, Typologie et épigraphie amphoriques. Les marques de Sestius, «Rivistadi Studi Liguri», 23, 1957, pp. 247-285.
Benoit 1958 = F. Benoit, Nouvelles épaves de Provence (i), «Gallia», 16, 1958, pp. 5-39.Benoit 1961 = F. Benoit, Fouilles sous-marines. L’épave du Grand Congloué à Marseille, «Gallia»,
Suppl. 14, Paris,1961.Benquet 2007 = L. Benquet, Les importations de vin italique dans le Toulousain au cours du iie
s. a.C., in Les âges du Fer dans le sud-ouest de la France, xxviiie Colloque de l’afeaf (Toulouse, 20-23 mai 2004), Bordeaux, 2007, pp. 435-448.
Bernard - Cibecchini 2005 = H. Bernard, F. Cibecchini, in Bilan Scientifique du drasm,2003, Ministère de la Culture et de la Communication, 2005, pp. 100-101.
Bernard - Cibecchini 2006 = H. Bernard, F. Cibecchini, in Bilan Scientifique du drasm,2004, Ministère de la Culture et de la Communication, 2006, pp. 92-93.
Bernard - Cibecchini 2007 = H. Bernard, F. Cibecchini, in Bilan Scientifique du drasm,2005, Ministère de la Culture et de la Communication, 2007, p. 99.
Berthier 1980 = A. Berthier, Un habitat punique à Constantine, «Antiquités Africaines», 16,1980, pp. 13-26.
Berti 1998 = F. Berti, Guida archeologica del territorio di Montelupo, Montelupo Fiorentino, 1998.Bertolani - Giordani - Loschi Ghittoni 1995 = M. Bertolani, N. Giordani, A. G. Lo-
schi Ghittoni, Further Archaeometric Investigations on Roman Kilns along the upper ModenaPlain (Po Valley, N. Italy), in Estudis sobre ceràmica antigua, Actes del Simposi sobre ceràmica antigua (Barcelona, 18-21 de novembre 1993), eds. M. Vendrell-Saz et alii, Barcelona, 1995, pp. 135-140.
Bertone 1991 = S. Bertone, Anfore greco-italiche nel Museo Archeologico di Firenze, «Studi e Ma-teriali. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 6, 1991, pp. 135-141.
Bertucchi 1992 = G. Bertucchi, Les amphores et le vin de Marseille. vie s. avant J.-C.-iie s. aprèsJ.-C., «Revue Arquéologique de Narbonnaise», Suppl. 25, Paris, 1992.
Bevilacqua 1994 = G. Bevilacqua, Bolli anforari rodii da Falerii Novi, in Epigrafia della produzione e della distribuzione, pp. 463-475.
Bezeczky 1994 = T. Bezeczky, Amphorenfunde vom Magdalensberg und aus Pannonien. Ein Ver-gleich, Klagenfurt, 1994.
Bezeczky 1998 = T. Bezeczky, The Laecanius Amphora Stamps and the Villas of Brijuni, Wien,1998.
Bezeczky 2004 = T. Bezeczky, Early Roman Food Import in Ephesus: Amphorae from the Tetra-gonos Agora, in Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean, Acts of the Inter-national Colloquium at the Danish Institute at Athens (September 26-29, 2002), eds. J. Eiring, J.Lund, Aarhus, 2004, pp. 85-97.
Bisi 1971 = A. M. Bisi, Lilibeo. Nuovi scavi nella necropoli punica (1969-1970), «Notizie degli Scavidi Antichità», 25, 1971, pp. 662-769.
Bisi - Di Vita 1969-1970 = A. M. Bisi, A. Di Vita, Scoperta di due tombe puniche a Mellita (Sabratha), «Libya Antiqua», 6-7, 1969-70, pp. 189-230.
Bitto 2001 = I. Bitto, Le iscrizioni greche e latine di Messina, Messina, 2001.Bivona 1975 = L. Bivona, Note epigrafiche, in Giustolisi 1975, pp. 61-70.Boissinot 2007 = Ph. Boissinot, L’archéologie des vignobles antiques en France Méridionale, in
Archeologia della vite, pp. 35-41.Bonanno 1997-1998 = C. Bonanno, Messina, l’insediamento rurale suburbano nei pressi della via
per Catania, «Kokalos», 43-44, 1997-98, pp. 401-421.Brecciaroli Taborelli 1984 = L. Brecciaroli Taborelli, Una produzione di anfore picene
ed il vino palmense, «Picus», 4, pp. 55-93.Brique antique et médiévale = La brique antique et médiévale. Production et commercialisation d’un
matériau, Actes du colloque international (Saint-Cloud, 16-18 novembre 1995), eds. P. Boucheron,H. Broise, Y. Thébert, Rome, 2000.
Briquel Chatonnet - Hesnard - Pollet 2004 = Briquel Chatonnet, A. Hesnard, Ch.Pollet, Abdamon (?), armateur du navire La Chrétienne M2 (Var), une inscription sur jas d’ancreen néopunique, in Méditerranée occidentale antique, pp. 189-202.
Broise - Lafon 2001 = H. Broise, X. Lafon, La Villa Prato de Sperlonga, Rome, 2001.Broughton, Magistrates = T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, i-ii,
New York, 1951-1952.Brugnone 1986 = A. Brugnone, Altri bolli anforari dalla necropoli di Lilibeo, «Kokalos», 32,
1986, pp. 101-113.Brun 2004 = J. P. Brun, Archéologie du vin et de l’huile dans l’Empire romain, Paris, 2004.
100 clementina panella
Bruni 1997 = S. Bruni, La Valdera e le colline pisane inferiori: appunti per la storia del popolamen-to, in Aspetti della cultura di Volterra etrusca fra l’età del ferro e l’età ellenistica e contributi dellaricerca antropologica alla conoscenza del popolo etrusco, Atti del xix Convegno di Studi Etruschi edItalici (Volterra, 15-19 ottobre 1995), ed. G. Maetzke, Firenze, 1997, pp. 129-172.
Bruno 1995 = B. Bruno, Aspetti di storia economica della Cisalpina romana. Le anfore di tipo Lamboglia 2 rinvenute in Lombardia, Roma, 1995.
Bruno 2004 = B. Bruno, L’arcipelago maltese in età romana e bizantina. Attività economiche escambi al centro del Mediterraneo, Bari, 2004.
Brunt 1971 = P. A. Brunt, Italian Manpower 225 BC-AD 14, Oxford, 1971.Buccellato - D’Annibale - Torri 2009 = A. Buccellato, M. L. D’Annibale, C. Torri,
Elementi ricostruttivi del paesaggio suburbano di epoca repubblicana nel territorio compreso tra lavia Laurentina moderna e il corso del Tevere, in Suburbium ii, pp. 531-555.
Buchner - Ridgway 1993 = G. Buchner, D. Ridgway, Pithekoussai i, Monumenti Antichi deiLincei, serie monografica iv, Roma, 1993.
Buora 2003 = M. Buora, Sui rapporti tra Alto Adriatico e costa albanese (i secolo a.C.-i secolo d.C.),in Progetto Durrës, pp. 39-56.
Buora - Carre - Tiussi 2008 = M. Buora, M.B. Carre, C. Tiussi, Bolli su anfore Lamboglia2 o simili dall’area aquileiese, «Rei Cretariae Romanae Fautorum, Acta», 40, Bonn, 2008, pp.285-303.
Cambi 2001 = F. Cambi, Calabria romana. Paesaggi tardo repubblicani nel territorio brindisino, inLo Cascio - Storchi Marino 2001, pp. 363-390.
Cambi 1989 = N. Cambi, Anfore romane in Dalmazia, in arse, pp. 311-337.Camilli - De Laurenzi - Setari 2006 = Pisa. Un viaggio nel mare dell’antichità (Catalogo Mostra,
Roma, 3 aprile-31 maggio 2006), eds. A. Camilli, A. De Laurenzi, E. Setari, Milano, 2006.Camodeca 1993 = G. Camodeca, La società e le attività produttive, in Puteoli 1993, pp. 31-47.Camodeca 1996 = G. Camodeca, L’élite municipale di Puteoli fra la tarda repubblica e Nerone, in
Élites municipales, pp. 91-110.Campagna 2000 = L. Campagna, Le anfore della necropoli in contrada Portinenti (proprietà Leo-
ne), in Meligunìs Lipára, X. Scoperte e scavi archeologici nell’area urbana e suburbana di Lipari,eds. L. Bernabò Brea, M. Cavalier, Roma, 2000, pp. 443-478.
Capanna - Carafa 2009 = M. C. Capanna, P. Carafa, Il progetto “Archeologia del suburbio diRoma” per la ricostruzione dei paesaggi agrari antichi, in Suburbium ii, pp. 27-39.
Capogrossi Colognesi 1997 = L. Capogrossi Colognesi, Lavoro agricolo e strutture fondia-rie, in Terre, proprietari e contadini, pp. 27-46.
Carandini 1988 = A. Carandini, Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei Romani tra tardaRepubblica e medio Impero, Roma, 1988.
Carandini 1989a = A. Carandini, La villa romana e la piantagione schiavistica, in Storia di Roma, 4, Torino, 1989, pp. 101-200.
Carandini 1989b = A. Carandini, L’economia italica tra tarda repubblica e medio impero consi-derata dal punto di vista di una merce: il vino, in arse, pp. 505-521.
Carandini 1994 = A. Carandini, I paesaggi agrari dell’Italia romana visti a partire dall’Etruria,in L’Italie d’Auguste à Diocletian, Actes du Colloque International (Rome, 25-28 mars 1992), Rome,1994, pp. 167-174.
Carandini 2006 = A. Carandini, La villa dell’Auditorium interpretata, in Auditorium 2006, pp.559-610.
Carandini 2009 = A. Carandini, I paesaggi del suburbio, in Suburbium ii, pp. 295-310.Carandini - Cambi 2002 = Paesaggi d’Etruria, eds. A. Carandini, F. Cambi, Roma, 2002.Carandini - Carafa - Capanna 2007 = A. Carandini, P. Carafa, M. C. Capanna, Il progetto
“Archeologia del suburbio di Roma per la ricostruzione dei paesaggi agrari antichi”. Impostazione emetodologia della ricerca, in Cupitò 2007, pp. 13-25.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 101
Carandini - Settis 1979 = A. Carandini, S. Settis, Schiavi e padroni nell’Etruria romana. Lavilla di Settefinestre dallo scavo alla mostra, Bari, 1979.
Carbonara 2005 = V. Carbonara, Anfore, in Ardea. Il deposito votivo di Casarinaccio, ed. F. DiMario, Roma, 2005, pp. 301-314.
Carre 1985 = M. B. Carre, Les amphores de la Cisalpine et de l’Adriatique au début de l’empire,«Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité», 97, 1985, pp. 207-245.
Carre 2002 = M. B. Carre, Quelques marques sur amphores du territoire de Senigallia: un complement à la serie “KANI”, «Picus», 22, 2002, pp. 75-103.
Carre - Pesavento Mattioli 2003 = M. B. Carre, S. Pesavento Mattioli, Anfore e commerci nell’Adriatico, in Archeologia dell’Adriatico, pp. 268-285.
Cassola 1991 = F. Cassola, La colonizzazione romana della Transpadana, in Die Stadt in Ober-italien und in den nordwestlichen Provinzen des römischen Reiches, Atti del Convegno (Köln, 18-20mai 1989), eds. W. Eck, H. Galsterer, Mainz am Rhein, 1991, pp. 17-44.
Castrén 1975 = P. Castrén, Ordo Populusque Pompeianus. Polity and Society in Roman Pompeii, Roma, 1975.
Ciampoltrini 1995 = G. Ciampoltrini, Un pocolom e le mura di Orbetello, «Archeologia Classica», 47, 1995, pp. 289-302.
Ciampoltrini 2004 = G. Ciampoltrini, Gli Apuani tra integrazione e deportazione. Evidenzearcheologiche per Livio xl, 53, in Ligures celeberrimi, pp. 375-386.
Cibecchini 2002 = F. Cibecchini, Il relitto della Torre della Meloria, «Archeologia Subacquea.Studi, ricerche e documenti», iii, 2002, pp. 209-226.
Cibecchini 2004 = F. Cibecchini, Affinità e divergenze nella diffusione dei materiali ceramici trasiti terrestri e relitti; alcuni problemi di interpretazione dei dati provenienti da relitti e dei flussi didistribuzione in età repubblicana, in Méditerranée occidentale antique, pp. 57-74.
Cibecchini 2006 = F. Cibecchini, L’Arcipelago toscano e l’isola d’Elba: anfore e commerci marit-timi, in Gli Etruschi da Genova ad Ampurias, Atti del xxiv Congresso di Studi Etruschi ed Italici(Marseille-Lattes, 26 settembre-1 ottobre 2002), Pisa-Roma, 2006, pp. 535-552.
Cibecchini 2008 = F. Cibecchini, Tonnellaggi e rotte in età repubblicana. Il contributo dei relittidel Mediterraneo occidentale, in Comercio, redistribución y fondeaderos, pp. 483-499.
Cibecchini et alii 2006 = F. Cibecchini et alii, Il relitto medio-repubblicano di Cala Rossa, «Ar-chaeologia Maritima Mediterranea», 3, 2006 [2007], pp. 13-41.
Cibecchini - Principal 2002 = F. Cibecchini, J. Principal Ponce, Alcune considerazioni sul-la presenza commerciale romano-italica nella penisola iberica prima della seconda guerra punica, inL’Africa Romana, 14, 1, Atti del xiv Convegno di Studio (Sassari, 7-10 dicembre 2000), Roma, 2002,pp. 653-663.
Cibecchini - Pricipal 2004 = F. Cibecchini, J. Principal Ponce, Per chi suona la Campana B?in Metodi e approcci archeologici, pp. 159-172.
Cibecchini - Capelli c.s. = F. Cibecchini, C. Capelli, Nuovi dati archeologici e archeometri-ci sulle anfore greco italiche: i relitti di iii secolo del Mediterraneo occidentale e le possibilità di unanuova classificazione, in Itinéraires des vins romains en Gaule (iiième-ier s. avant J.-C.). Confronta-tion de faciès, Actes du colloque (Lattes, 30 janvier-2 février 2007), ed. F. Olmer, Monographies d’Archéologie Méditerranéennes, c.s.
Cifani 1998 = G. Cifani, Caratteri degli insediamenti rurali nell’Ager Romanus tra vi e iii a.C.,in Papers from the EAA Third Annual Meeting at Ravenna 1997, ii, «British Archaeological Reports», International Series, 718, Oxford, 1998, pp. 53-64.
Cipriano - Carre 1989 = M. T. Cipriano, M. B. Carre, Production et typologie des amphoressur la côte adriatique de l’Italie, in arse, pp. 67-104.
Circulació d’àmfores al Mediterrani occidental = La circulació d’àmfores al Mediterrani occidental durant la protohistòria (segles viii-iii a.C.). Aspectes quantitatius i anàlisi de continguts, eds. J.Sanmartí, D. Ugolini, J. Ramon, D. Asensio, «Arqueo Mediterrània», 8, 2004.
102 clementina panella
Clemente 1983 = G. Clemente, Il plebiscito Claudio e le classi dirigenti romane nell’età dell’im-perialismo, «Ktema», 8, 1983, pp. 253-259.
Clemente 1990 = G. Clemente, Basi sociali ed assetti istituzionali nell’età della conquista, in Storia di Roma, 2, 1, Torino, 1990, pp. 39-54.
Cloud 1985 = J. D. Cloud, A Lex de ponderibus (Festus, p. 288 L), «Athenaeum», 63, 1985, pp.405-418.
Coarelli 1983 = F. Coarelli, Il commercio delle opere d’arte in età tardo-repubblicana, «Dialoghidi Archeologia», ser. 3, I, 1, 1983, pp. 45-53.
Coarelli 1986 = F. Coarelli, L’urbs e il suburbio, in Società romana e impero tardoantico, ii, ed.A. Giardina, Bari-Roma, 1986, pp. 1-58.
Coarelli 1989 = Minturnae. Studi e ricerche sul Lazio antico, ed. F. Coarelli, Roma, 1989.Coarellli 1996 = F. Coarelli, Revixit ars. Arte e ideologia a Roma. Dai modelli ellenistici alla
tradizione repubblicana, Roma, 1996.Coarelli 2000 = F. Coarelli, Roma, la città come cosmo, in Mégapoles méditerranéennes, pp.
288-310.Comercio, redistribución y fondeaderos = Comercio, redistribución y fondeaderos. Navegación a vela en
el Mediterráneo, V Jornadas Internacionales de Arqueología Subacuática, Actas (Gandia, 8 a 10 denoviembre de 2006), eds. J. Pérez Ballester, G. Pascual Berlanga, Valencia, 2008.
Comes - Rodà 2002 = Scripta manent. La memòria escrita dels romans. La memoria escrita de losromanos, eds. R. Comes, I. Rodà, Barcelona, 2002.
Corbier 1981 = M. Corbier, Proprietà e gestione della terra: grande proprietà fondiaria ed econo-mia contadina, in srps i, pp. 427-444.
Cornell 1995 = T. J. Cornell, The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age tothe Punic Wars (c. 1000-264 BC), London-New York, 1995.
Corrado 2009 = M. Corrado, Nuovi dati di scavo ed epigrafici sulle manifatture tardo-repubbli-cane di anfore commerciali del versante ionico calabrese gravitanti sul Golfo di Sqillace, www.fa-stionline.org.docs/FOLDER-it-2009-138.
Coviello 2003 = G. Coviello, Roma, gli Italici, l’Adriatico e il mondo ellenistico, «Hesperìa»,17, 2003, pp. 89-103.
Costantini - Ghizzani Marcìa 2004 = A. Costantini, F. Ghizzani Marcìa, Importazioniceramiche a Populonia: due casi esemplari (anfore greco-italiche e ceramica da fuoco), in Méditer-ranée occidentale antique, pp. 29-42.
Cotton - Geiger 1989 = H. M. Cotton, J. Geiger, Masada ii. The Yigael Yadin Excavations1963-1965. Final Reports. The Latin and Greek Documents, Jerusalem, 1989.
Culican - Curtis 1976 = W. Culican, J. E. Curtis, The Pottery from the Wreck, in H. Frost etalii, Lilybaeum, «Notizie degli Scavi di Antichità», ser. 8, 30, Suppl., 1976, pp. 143-189.
Cupitò 2007 = C. Cupitò Il suburbio di Roma antica. La topografia del suburbio tra la Salaria,l’Aniene, il Tevere e la c.d. Salaria Vetus, Roma, 2007.
Cygielman 1982 = M. Cygielman, Cala Barbiere-Punta Ala, in Archeologia Subacquea, «Bollet-tino d’Arte», ser. 6, 67, Suppl. 4, 1982, pp. 46-48.
D’Ambrosio - De Caro 1989 = A. D’Ambrosio, S. De Caro, Un contributo all’architettura eall’urbanistica di Pompei in età ellenistica. I saggi nella casa vii, 4, 62, «Annali di Archeologia eStoria Antica», 11, 1989, pp. 173-215.
D’Arms 1980 = J. H. D’Arms, Senators’ Involvement in Commerce in the Late Republic: Some Ciceronian Evidence, in Seaborne Commerce, pp. 77-89.
D’Arms 1984 = J. H. D’Arms, Ville rustiche e ville di “otium”, in Pompei 79. Raccolta di studi peril decimonono centenario dell’eruzione vesuviana, ed. F. Zevi, Napoli, 1984, pp. 65-86.
De Caro 1991 = Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta, ed. S. De Caro,«Bollettino di Archeologia», 11-12, 1991 [1994], pp. 115-199.
De Caro 2005 = S. De Caro, La situazione in Campania. Cuma e Napoli, in Atti Taranto, 43,2004, Taranto, 2005, pp. 643-662.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 103
De Caro - Miele 2001 = S. De Caro, F. Miele, L’occupazione romana della Campania setten-trionale, in Lo Cascio - Storchi Marino 2001, pp. 501-581.
De Grummond 2005 = N.T. De Grummond, Sestius at Cetamura and Lurius at Cosa?, in Ter-ra Marique. Studies in Art History and Marine Archaeology in Honor of Anna MargueriteMcCann, ed. J. Pollino, Oxford, 2005, pp. 30-39.
Dell’aglio 1988 = A. Dell’aglio, Le “Collezioni” Viola. I bolli anforari: le importazioni greche,in Il Museo di Taranto. Cento anni di Archeologia (Catalogo della Mostra per il centenario dell’isti-tuzione del Museo Archeologico Nazionale di Taranto), Taranto, 1988, pp. 59-70.
Dell’aglio - Lippolis 1989 = A. Dell’aglio, E. Lippolis, Il commercio del vino rodio a Ta-ranto, in arse, pp. 544-547.
Delpace 1993 = C. Delplace, La romanisation du Picenum: l’exemple d’Urbs Salvia, Rome,1993.
Delplace 1996 = C. Delplace, Les élites municipales dans le développement politique et écono-mique de la Région v Auguste, in Élites municipales, pp. 71-79.
De Luca De Marco 1979 = S. De Luca De Marco, Le anfore commerciali della necropoli diSpina, «Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité», 91, 2, 1979, pp. 571-600.
De Marinis 2003 = G. De Marinis, Insediamenti e strutture rurali: aggiornamenti per le Marche,«Rivista di Topografia Antica», 13, 2003 [2005], pp. 77-86.
De Miro 1958 = E. De Miro, Heraclea Minoa. Scavi eseguiti negli anni 1955-56-57, «Notizie degliScavi di Antichità», ser. 8, 12, 1958, pp. 231-287.
De Miro 2000 = E. De Miro, Agrigento i. I santuari urbani. L’area sacra tra il Tempio di Zeus ePorta v, Roma, 2000.
De Miro - Fiorentini 1977 = E. De Miro, G. Fiorentini, Leptis Magna. La necropoli greco-punica sotto il teatro, «Quaderni di Acheologia della Libia», 9, 1977, pp. 5-76.
De Romanis 1993 = F. De Romanis, Puteoli e l’Oriente, in Puteoli 1993, pp. 61-72.Desantis 1991-1992 = P. Desantis, Le anfore della necropoli di Spina-Valle Trebba, in Studi sulla
necropoli di Spina in Valle Trebba, Ferrara, 1991-1992, pp. 157-180.Desbat - Lequément - Liou 1987 = A. Desbat, R. Lequément, B. Liou, Inscriptions peintes
sur amphores: Lyon et Saint-Romain-en-Gal, «Archaeonautica», 7, 1987, pp. 141-166.Desy 1983 = Ph. Desy, Réflexions sur l’économie et le commerce du Sallentin hellénistique à propos
d’amphores inédites de Gallipoli et d’Ugento, «L’Antiquité Classique», 52, 1983, pp. 175-194.Desy 1989 = Ph. Desy, Les timbres amphoriques de l’Apulie républicaine. Documents pour une
histoire économique et sociale, «British Archaeological Reports», International Series, 554, Oxford, 1989.
Desy 1993 = Ph. Desy, Recherches sur l’économie apulienne au iie et au ier siècle avant notre ère, «Latomus», 221, Bruxelles, 1993.
Desy - De Paepe 1990 = Ph. Desy, P. De Paepe, Torre San Giovanni (Ugento). Les amphores commerciales hellénistiques et républicaines, «Studi di Antichità», 6, 1990, pp. 187-234.
De Sena 2005 = E. C. De Sena, An assessment of wine and oil production in Rome’s hinterland. Ce-ramic, literary, art. Historical and modern evidence, in Roman villas around the Urbs, pp. 135-149.
Di Fazio 2004 = M. Di Fazio, Note sulla presenza di bolli laterizi nel territorio di Fondi, in Metodie approcci archeologici, «British Archaeological Reports», International Series, 1262, Oxford,2004, pp. 205-213.
Di Giuseppe 2005a = H. Di Giuseppe, Villae, villulae e fattorie nella Media Valle del Tevere, inRoman villas around the Urbs, pp. 7-25.
Di Giuseppe 2005b = H. Di Giuseppe, Un confronto tra l’Etruria settentrionale e meridionale dalpunto di vista della ceramica a vernice nera, «Papers of the British School at Rome», 73, 2005,pp. 31-84.
Di Giuseppe 2009 = H. Di Giuseppe, Assetti territoriali nella media valle del Tevere dall’epocaorientalizzante a quella repubblicana, in Mercator Placidissimus, pp. 431-465.
104 clementina panella
Di Giuseppe - Patterson 2009 = H. Di Giuseppe, H. Patterson, Il dibattito storiografico intorno alla South Etruria Survey e i nuovi risultati del Progetto Valle del Tevere, in Suburbium ii,pp. 7-26.
Di Giuseppe - Serlorenzi 2009 = H. Di Giuseppe, M. Serlorenzi, La via Campana: aspet-ti topografici e rituali, in Suburbium ii, pp. 573-598.
Di Porto 1984 = A. Di Porto, Impresa collettiva e schiavo ‘manager’in Roma antica (ii secolo a.C.-ii secolo d.C.), Milano, 1984.
D’Isanto 1993 = G. D’Isanto, Capua romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale, Roma,1993.
Domínguez Pérez 2006 = J.C. Domínguez Pérez, Estructuras comerciales romanas en el período pre-anibálico: una lectura crítica interdisciplinar del período medio-repúblicano, «Gerión»,24.1, 2006, pp. 179-194.
Domínguez Petit 2004 = R. Domínguez Petit, Fuentes literarias para la agricultura cartagi-nesa. El tratado de Magon, «Habis. Filología clásica, historia antigua, arqueología clásica», 35,2004, pp. 179-192.
Économie antique = L’économie antique, une économie de marché?, Actes des deux tables rondes tenuesà Lyon (4 fevrier et 30 novembre 2004), eds. Y. Roman, J. Dalaison, Paris, 2008, pp. 215-234.
Egidi 2009 = R. Egidi, Insediamenti, strade e sistemi di bonifica agraria nel suburbio orientale (xMunicipio) tra il v e il ii secolo a.C., in Surburbium ii, pp. 597-507.
Élites municipales = Les élites municipales de l’Italie péninsulaire des Gracques à Néron, Actes de la table ronde (Clermont-Ferrand, 28-30 novembre 1991), ed. M. Cébeillac-Gervasoni, Naples-Ro-me, 1996.
Empereur 1982 = J. Y. Empereur, Les anses d’amphores timbrées et les amphores: aspects quanti-tifs, «Bulletin de Correspondance Hellénique», 106, 1, 1982, pp. 220-233.
Empereur 1998 = J. Y. Empereur, Les amphores complètes du Musée d’Alexandrie: importationset productions locales, in Commerce et artisanat dans l’Alexandrie hellénistique et romaine, Actesdu Colloque (Athènes, 11-12 décembre 1988), «Bulletin de Correspondance Hellénique», Suppl.33, Paris, 1998, pp. 393-397.
Empereur - Hesnard 1987 = J. Y. Empereur, A. Hesnard, Les amphores hellénistiques du bas-sin occidental de la Méditerranée, in Céramiques hellénistiques et romaines, ii, eds. P. Lévêque, J.-P. Morel, Besançon-Paris, 1987, pp. 7-55.
Enei 2001 = F. Enei, Progetto Ager Caeretanus. Il litorale di Alsium. Ricognizioni archeologichenel territorio dei comuni di Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino (Alsium, Caere, Ad Turres, Ceri),Ladispoli, 2001.
Epigrafia della produzione e della distribuzione = Epigrafia della produzione e della distribuzione, Actes de la viie Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain (Rome, 5-6 juin 1992),Rome, 1994.
Epigrafia e Ordine senatorio = Epigrafia e Ordine Senatorio, i-ii, «Tituli», 4-5, Roma, 1982.Étienne 1990 = R. Étienne, Ténos ii. Ténos et les Cyclades du milieu du ive siècle av. J.-C. au milieu
du iiie siècle ap. J.-C, Athènes-Paris, 1990.Farfaneti 2000 = B. Farfaneti, Cesenatico romana. Archeologia e territorio, Ravenna, 2000.Ferrandes 2006 = A. F. Ferrandes, Produzioni stampigliate e figurate in area etrusco-laziale tra
fine iv e iii secolo a.C. Nuove riflessioni alla luce di vecchi contesti, «Archeologia Classica», 57,2006, pp. 115-174.
Ferrandes 2008 = A.F. Ferrandes, Produzioni ceramiche a Roma tra iv e iii secolo a.C. Nuovidati, «Rei Cretariae Romanae Fautorum, Acta», 40, Bonn, 2008, pp. 363-372.
Ferrary et alii 2002 = J.L. Ferrary et alii, Liste des Italiens de Délos, in Les Italiens dans le mondegrec, iie siècle av. J.-C. - ier siècle ap. J.-C., Actes de la Table Ronde, École Normale Supérieure (Paris,14-16 mai 1998), eds. Ch. Müller, Cl. Hasenohr, «Bulletin de Correspondance Hellénique»,Suppl. 41, Paris, 2002, pp. 183-239.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 105
Finkielsztejn 2000 = G. Finkielsztejn, Amphores importées au Levant Sud à l’époque hellénis-tique, in Eã EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ EÏÏËÓÈÛÙÈÎ KÂÚ·ÌÈÎ . XÚÔÓÔÏÔÁÈο ÚÔ‚ÏÌ·Ù·, ÎÏÂÈÛÙ¿ Û‡ÓÔÏ·, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ¶Ú·ÎÙÈο, Aı‹Ó·, 2000, pp. 207-220.
Finkielsztejn 2001a = G. Finkielsztejn, Chronologie detaillée et révisée des éponymes ampho-rique rhodiens, de 270 à 108 av. J.-C. environ. Premier bilan, «British Archaeological Reports», In-ternational Series, 990, Oxford, 2001.
Finkielsztejn 2001b = G. Finkielsztejn, Politique et commerce à Rhodes au ii s. a.C.: le témoi-gnage des exportations d’amphores, in Les cités d’Asie Mineure occidentale au iie siècle a.C., eds. A.Bresson, R. Descat, Bordeaux, 2001, pp. 181-196.
Finkielsztejn 2006 = G. Finkielsztejn, P. Vedius Pollio, producteur de vin à Chios et Cos etfournisseur d’Hérode le Grand, in Grecs, Juifs, Polonais. À la recherche des racines de la civilisationeuropéenne, Actes du Colloque organisé par l’Académie Polonaise des Sciences (Paris, 14 novembre2003), Paris, 2006, pp. 123-139.
Flambard 1982 = J.M. Flambard, Observations sur la nature des magistri italiens à Delos, in De-lo e l’Italia, eds. D. Musti, H. Solin, «Opuscula Istituti Romani Finlandiae», 2, Roma, 1982,pp. 67-77.
Fontana 1993 = F. Fontana, La villa romana di Barcola. A proposito delle Villae Maritimae dellaRegio x, Roma, 1993.
Freed 1994 = J. Freed, Amphoras found North of Skerki Bank: Catalogue, in Deep Water Archaeology: a Late Roman Ship from Carthage and an Ancient Trade Route near Skerki Bank offNorthwest Sicily, eds. A. M. McCann, J. Freed, «Journal of Roman Archaeology», Suppl. 13,Ann Arbor, 1994, pp. 61-88.
Freed - Moore 1996 = J. Freed, J. Moore, New Observations on the Earliest Roman Amphorasfrom Carthage: Delattre’s First Amphoras Wall, «cedac, Carthage Bulletin», 15, 1996, pp. 19-28.
Gabba 1980 = E. Gabba, Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoliii e i a.C., in Seaborne Commerce, pp. 91-102.
Gabba 1981 = E. Gabba, Ricchezza e classe dirigente romana fra iii e i secolo a.C., «Rivista Stori-ca Italiana», 93, 1981, pp. 541-558.
Gabba 1988 = E. Gabba, Allora i Romani conobbero per la prima volta la ricchezza, in E. Gabba,Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico, Milano, 1988,pp. 19-26.
Gabba 1990a = La società romana tra iv e iii secolo, in Storia di Roma, 2, 1, Torino, 1990, pp. 7-17.Gabba 1990b = Il processo di integrazione dell’Italia nel ii secolo, in Storia di Roma, 2, 1, Torino,
1990, pp. 267-283.Galli 1993 = G. Galli, Ponza: il relitto della “secca dei mattoni”, «Archeologia subacquea. Stu-
di, ricerche e documenti», i, 1993, pp. 117-129.Gantès 1978 = L. F. Gantès, Note sur les céramiques à vernis noir trouvées sur l’oppidum de la
Teste-Nègre aux Pennes (Bouches du Rhône), «Archéologie en Languedoc», 1, 1978, pp. 97-103.Gaule interne = Gaule interne et Gaule méditerranéenne aux iie et ier siècles av. J.-C: confrontations
chronologiques, Actes de la table ronde (Valbonne, 11-13 novembre 1986), eds. A. Duval, J.-P. Morel,Y. Roman, «Revue Archéologique de Narbonnaise», Suppl. 21, Paris, 1990.
García Sánchez 1997 = M. García Sánchez, Epigrafía anfórica de Mas Castellar-Pontós: ánforas grecoitálicas y masaliotas, «Pyrenae», 28, 1997, pp. 257-269.
García Sánchez 1998 = M. García Sánchez, Epigrafía anfórica griega de Mas Castellar- Pontós(Segunda parte), «Pyrenae», 29, 1998, pp. 231-236.
García Sánchez 1999 = M. García Sánchez, Epigrafía anfórica griega de Empéries, «Pyre-nae», 30, 1999, pp. 223-242.
García Vargas 1998 = E. García Vargas, La producción de ánforas en la bahía de Cádiz en épocaromana (siglos ii a.C.-iv d.C.), Écija, 1998.
106 clementina panella
Garozzo 1999 = B. Garozzo, Nuovi bolli anforari dalla Sicilia Occidentale (Entella, Erice, Sege-sta), in Sicilia Epigraphica, Atti del Convegno Internazionale di studi (Erice, 15-18 ottobre 1998),«Annuario della Scuola Normale di Pisa. Quaderni 1-2», 1999, pp. 281-383.
Garozzo 2003 = B. Garozzo, Nuovi dati sull’instrumentum domesticum bollato, anfore e la-terizi, dal Palermitano, in Quarte giornate internazionali di studi sull’area elima (Erice, 1-4 di-cembre 2000), Atti, Pisa, 2003, pp. 557-683.
Garozzo 2006 = B. Garozzo, Sicilia occidentale e Campania. Bolli anforari, in Guerra e pace inSicilia e nel Mediterraneo antico (viii-iii sec. a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra,Quinte giornate internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediter-raneo (Erice, 12-15 ottobre 2003), Atti, Pisa, 2006, pp. 719-732.
Garozzo 2008 = B. Garozzo, Bolli anforari, in Segesta 3. Il sistema difensivo di Porta di Valle.Scavi 1990-1993, ed. R. Camerata Scovazzo, Mantova, 2008, pp. 581-604.
Gentili 1958 = G.V. Gentili, I timbri anforari rodii nel Museo Nazionale di Siracusa, «ArchivioStorico Siracusano», 4, 58, 1958, pp. 18-95.
Giampaola 2005 = D. Giampaola, Il mare bagna Neapolis: archeologia urbana del porto antico,in Aequora, pp. 87-92.
Gianfrotta 1980 = P. A. Gianfrotta, Ancore “romane”. Nuovi materiali per lo studio dei traffi-ci marittimi, in Seaborne Commerce, pp. 103-116.
Gianfrotta 1981 = P. A. Gianfrotta, Commerci e pirateria. Prime testimonianze archeologichesottomarine, «Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité», 93, 1, 1981, pp. 227-242.
Gianfrotta 1982 = P. A. Gianfrotta, Archeologia sott’acqua. Rinvenimenti sottomarini in Etru-ria Meridionale, in Archeologia subacquea, «Bollettino d’Arte», ser. 6, 67, Suppl. 4, 1982, pp. 13-36.
Gianfrotta 1994 = P. A. Gianfrotta, Note di epigrafia “marittima”. Aggiornamenti su tappid’anfora, ceppi d’ancora e altro, in Epigrafia della produzione e della distribuzione, pp. 591-608.
Gianfrotta 1998 = P. A. Gianfrotta, Nuovi rinvenimenti subacquei per lo studio di alcuni aspet-ti del commercio marittimo del vino (i sec. a.C.-i sec. d.C.), in ViAnt ii, pp. 105-112.
Gianfrotta 2001 = P. A. Gianfrotta, Fantasmi sottomarini: guerre, pirateria…o chissà cos’al-tro, «Daidalos», 3, 2001, pp. 209-214.
Gianfrotta 2007a = P. A. Gianfrotta, I vasetti di Rullius, di Caesius e la porpora di Aqui-num, in Spigolature aquinati, pp. 49-58.
Gianfrotta 2007b = P. A. Gianfrotta, Il commercio marittimo in età tardo-repubblicana: mer-ci, mercanti, infrastrutture, in Comercio, redistribución y fondeaderos, pp. 65-78.
Giannichedda 2007 = E. Giannichedda, Lo scavo, i residui, l’affidabilità stratigrafica, «Facta»,1, 2007, pp. 51-64.
Giardina 1989 = A. Giardina, Il mercante, in L’Uomo romano, ed. A. Giardina, Bari-Roma,1989, pp. 271-298.
Giardina 1997 = A. Giardina, L’Italia romana. Storia di un’identità incompiuta, Roma-Bari,1997.
Gioia 2008 = Torre Spaccata. Roma S.D.O. Le indagini archeologiche, ed. P. Gioia, Roma, 2008.Gioia - Volpe 2004 = Centocelle i. Roma S.D.O. Le indagini archeologiche, eds. P. Gioia, R. Volpe,
Roma, 2004.Giordani 1990 = N. Giordani, Un complesso produttivo di età romano-repubblicana, «Bolletti-
no di Archeologia», 5-6, 1990 [1992], pp. 130-132.Giordani 2000 = N. Giordani, Territorio e produzioni: gli impianti artigianali, in Aemilia. La
cultura romana in Emilia-Romagna dal iii secolo a.C. all’età costantiniana, eds. M. Marini Cal-vani et alii, Venezia, 2000, pp. 352-363; 365-366.
Giordani 2001 = N. Giordani, L’economia del territorio di Mutina in età romana, in Pondera.Pesi e misure nell’antichità, eds. C. Corti, N. Giordani, Campogalliano (Mo), 2001, pp. 253-270.
Giustolisi 1975 = V. Giustolisi, Le navi romane di Terrasini, Palermo, 1975.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 107
Gorgues - Long - Rico 2004 = A. Gorgues, L. Long, Ch. Rico, Two major trading routes ofthe Roman antiquity in Southern Gaul: the road Narbonne-Toulouse and the Rhône way towardsArles, in Pasquinucci - Weski 2004, pp. 39-52.
Grace 1985 = V. R. Grace, The Middle Stoa dated by Amphora Stamps, «Hesperia», 54, 1985, pp.1-54.
Gualandi - Rizzitelli 2005 = M. L. Gualandi, C. Rizzitelli, Populonia nell’età romaniz-zazione: insediamenti e circolazioni delle merci, in Aequora, pp. 144-154.
Gualtieri 2000 = M. Gualtieri, Figlinae, domi nobiles ed approvvigionamenti di latrizi nel-l’Italia centro-meridionale: due casi di studio, in Brique antique et médiévale, pp. 329-340.
Gualtieri 2001 = M. Gualtieri, Insediamenti e proprietà nella Lucania nord-orientale (i sec. a.C.-iii sec. d.C.), in Lo Cascio-Storchi Marino 2001, pp. 75-103.
Guidobaldi 1996a = M. P. Guidobaldi, La romanizzazione dell’ager Praetutianus (secoli iii-ia.C.), Napoli, 1996.
Guidobaldi 1996b = M. P. Guidobaldi, C. Sornatius C. f. Vel. Barba: una breve nota sul lega-to di Lucullo in Asia, «Cahiers Glotz», 7, 1996, pp. 263-268.
Guidobaldi 2001 = M. P. Guidobaldi, Transformations and Continuities in a Conquered Terri-tory: the case of the Ager Praetutianus, in Italy and the West. Comparative Issues in Romaniza-tion, eds. S. Keay, N. Terrenato, Oxford, 2001, pp. 85-90.
Guitart - Pera - Carreras 1998 = J. Guitart i Duran, J. Pera i Isern, C. Carreras iMonfort, La prèsencia de vi itàlic a les fundacions urbanes del principi del segle i a.C. a l’interiorde Catalunya: l’exemple de Iesso, in ViAnt ii, pp. 39-65.
Habibi - Aranegui 2005 = M. Habibi, C. Aranegui, Lixus-2. Ladera Sur. Excavaciones ar-queológicas marroco-española en la colonia fenicia. Campañas 2000-2003, València, 2005.
Harris 2003 = W. V. Harris, Roman Government and Commerce, 300 BC-AD 300, in Mercanti epolitica, pp. 275-305.
Hatzfeld 1912 = J. Hatzfeld, Les italiens résidants à Délos mentionnés dans les inscriptions del’île, «Bulletin de Correspondance Hellénique», 36, 1912, pp. 5-218.
Hayes - Martini 1994 = Archaelogical Survey in the Lower Liri Valley, Central Italy, eds. J. W. Hayes,I. P. Martini, «British Archaeological Reports», International Series, 595, Oxford, 1994.
Heurgon 1976 = J. Heurgon, L’agronome carthaginois Magon et ses traducteurs en latin et en grec,«Académie des inscriptions et belles lettres. Comptes rendus des séances de l’anné», 1976,pp. 441-456.
Hesnard 1977 = A. Hesnard, Note sur un atelier d’amphores Dr.1 e Dr.2-4 près Terracine, «Mé-langes de l’École française de Rome. Antiquité», 89, 1977, pp. 157-168.
Hesnard et alii 1989 = A. Hesnard, M. Ricq, P. Arthur, M. Picon, A. Tchernia, Aires deproduction des gréco-italiques et des Dressel 1, in arse, pp. 21-65.
Hesnard - Gianfrotta 1989 = A. Hesnard, P. A. Gianfrotta, Les bouchons d’amphore enpouzzolane, in arse, pp. 393-441.
Hopkins 1978 = K. Hopkins, Conquerors and Slaves, Cambridge, 1978.Horvat 1997 = Sermin. A Prehistoric and Early Roman Settlement in Northwestern Istria, ed. J.
Horvat, Ljubljana, 1997.Incitti 1986a = M. Incitti, Recenti scoperte lungo la costa dell’alto Lazio, in Archeologia Subac-
quea 3, «Bollettino d’Arte», ser. 6, 71, Suppl. 37-38, 1986, pp. 195-202.Incitti 1986b = M. Incitti, in Tevere. Un’antica via per il Mediterraneo (Catalogo Mostra, Roma
21 aprile - 23 giugno 1986), Roma, 1986, p. 199.Incitti 1990 = M. Incitti, Alcuni aspetti economici dell’area dei Monti della Tolfa in età romana:
note preliminari, in Caere e il suo territorio da Agylla a Centumcellae, eds. A. Maffei, F. Na-stasi, Roma, 1990, pp. 113-118.
Inscribed Economy = The Inscribed Economy. Production and Distribution in the Roman Empire in theLight of Instrumentum Domesticum, ed. W. V. Harris, «Journal of Roman Archaeology»,Suppl. 6, Ann Arbor, 1993.
108 clementina panella
Isler 1980 = H. P. Isler, Monte Iato. Decima campagna di scavo, «Sicilia Archeologica», 13, 44,1980, pp. 15-30.
Jehasse 1973 = J. et L. Jehasse, Les nécropoles préromaines d’Aléria, «Gallia», Suppl. 25, Paris,1973.
Jehasse 2001 = J. et L. Jehasse, Aléria: Nouvelles données de la nécropole, Lyon, 2001.Jannoray 1955 = J. Jannoray, Ensérune, Paris, 1955.Kirigin 1994 = B. Kirigin, Græko-italske amfore na Jadranu, «Arheološki Vestnik», 45, 1994, pp.
15-24.Kirigin - Katunaric - Šešeli 2006 = B. Kirigin, T. Katunaric, L. Šešeli, Preliminary notes
on some economic and social aspects of amphorae and fine ware pottery from Central Dalmatia, 4th-1st BC, in Rimini e l’Adriatico nell’età delle guerre puniche, Atti del Convegno internazionale di studi(Rimini, Musei comunali, 25-27 marzo 2004), ed. F. Lenzi, Bologna, 2006, pp. 191-225.
Kolendo 1994 = J. Kolendo, Praedia suburbana e loro produttività, in Landuse in the RomanEmpire, pp. 59-71.
Labrousse 1980 = M. Labrousse, Informations archéologiques, «Gallia», 38, 1980, pp. 463-505.Lafon 2001 = X. Lafon, Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de l’Italie Romaine (iiie
siècle av. J.-C.-iiie siècle ap. J.-C.), Paris, 2001.Lahi 2008 = B. Lahi, Ein Drainage-System in Apollonia (Albanien). Vorläufige Ergebnisse, «Rei
Cretariae Romanae Fautorum, Acta», 40, Bonn, 2008, pp. 29-35.Lahi 2009 = B. Lahi, Amfora transporti të shekujve 3-1 pr. Kr. në Shqipëri, Tiranë, 2009.Lamboglia 1961 = N. Lamboglia, La nave romana di Spargi (La Maddalena). Campagna di scavo
1958, in Atti del ii Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina (Albenga, 28 giugno-2 luglio1958), Bordighera, 1961, pp. 143-166.
Lamour - Mayet 1980 = C. Lamour, F. Mayet, Glanes amphoriques: i. Région de Béziers et deNarbonne, «Études sur Pezenas et l’Herault», 11, 1, 1980, pp. 3-16.
Lanciani 1877 =R. Lanciani, Miscellanea epigrafica, «Bullettino della Commissione Archeo-logica Comunale di Roma», v, 1877, pp. 161-183.
Lancioni 2003 = C. Lancioni, Materiali da un saggio stratigrafico lungo le mura dell’acropoli diPopulonia. Ceramica acroma e contenitori da trasporto, «Rassegna di archeologia classica e postclassica», 20, b, 2003, pp. 35-122.
Landuse in the Roman Empire = Landuse in the Roman Empire, Atti del Convegno (Roma, gennaio1993), eds. J. Carlsen et alii, «Analecta Romana Instituti Danici», Suppl. 22, Rome, 1994.
La Torre 1999 = G. F. La Torre, Blanda, Lavinium, Cerillae, Clampetia, Tempsa. Forma Italiae, 39, Firenze, 1999.
La Torre 2003 = G. F. La Torre, Il Mausoleo di Blanda Iulia, Soveria Mannelli, 2003.Laubenheimer 2007 = F. Laubenheimer, À propos de timbres d’amphores de l’atelier d’Albinia
(prov. de Grosseto, Italie). Vin et poisson, in Vitali 2007, pp. 67-80.Laurence 2001 = R. Laurence, Roman Italy’s Urban revolution, in Lo Cascio - Storchi Ma-
rino 2001, pp. 593-611.Licordari 1982 = A. Licordari, Ascesa al senato e rapporti con i territori d’origine. Italia: Regio
i (Latium), in Epigrafia e Ordine Senatorio, i, pp. 9-57.Ligures celeberrimi = Ligures celeberrimi: la Liguria interna nella seconda età del ferro, Atti del Con-
vegno internazionale (Mondovì, 26-28 febbraio 2002), eds. M. Venturino Gambari, D. Gandolfi,Bordighera, 2004.
Lindhagen 2006 = A. Lindhagen, Caleacte. Production and Exchange in North Sicilian Townc. 500 BC-AD 500, Lund, 2006.
Liou 1975 = B. Liou, Informations archéologiques, Direction des recherches sous-marines, «Gallia»,33, 1975, pp. 571-605.
Liou 1982 = B. Liou, Informations archéologiques, Direction des recherches sous-marines, «Gallia»,40, 2, 1982, pp. 437-454.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 109
Lippolis 1997 = E. Lippolis, Fra Taranto e Roma. Società e cultura urbana in Puglia tra Anniba-le e l’età imperiale, Taranto, 1997.
Lippolis 2005 = E. Lippolis, Taranto romana: dalla conquista all’età augustea, in Tramonto del-la Magna Grecia. Magnamque Graeciam, quae nunc quidem deleta est (Cic., Laelius de am.,4,13). Atti del quarantaquattresimo convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto 24 - 28 settembre2004), Taranto, 2005, pp. 235-312.
Lo Cascio 1991 = E. Lo Cascio, Forme dell’economia imperiale, in Storia di Roma, 2, 2, Torino,1991, pp. 313-365.
Lo Cascio 1997 = E. Lo Cascio, Introduzione, in Terre, proprietari e contadini, pp. 15-25.Lo Cascio 1999 = E. Lo Cascio, Popolazione e risorse agricole nell’Italia del ii secolo a.C., in
Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mondo antico, Atti del Convegno Internazionaledi Studi (Parma, 17-19 ottobre 1997), Bari, 1999, pp. 217-245.
Lo Cascio 2006 = Innovazione tecnica e progresso economico nel mondo romano, ed. E. Lo Cascio,Bari, 2006.
Lo Cascio 2009 = E. Lo Cascio, Crescita e declino. Studi di storia dell’economia romana, Roma,2009.
Lo Cascio - Storchi Marino 2001 = Modalità insediative e strutture agrarie nell’Italia meridio-nale in età romana, eds. E. Lo Cascio, A. Storchi Marino, Bari, 2001.
Lombardo 1996 = M. Lombardo, Vite e vini nel Salento antico, in Il tralcio e la vite. La culturadella vite e del vino nell’arte, nella società, nei luoghi di lavoro, ed. A. Marinazzo, Lecce, 1996, pp.3-17.
Long 2004 = L. Long, Les épaves protohistoriques de la côte gauloise et de la Corse (vie-iiie sièclesavant J.-C.), in Circulació d’àmfores al Mediterrani occidental, pp. 127-164.
Long - Ximénès 1988 = L. Long, S. Ximénès, L’épave Riou 3 à Marseille. Un chargement d’am-phores Dressel 1 estampillées en grec et de céramique campanienne A tardive, «Cahiers d’Archéo-logie Subaquatique», 7, 1988, pp. 159-183.
López Mullor - Martín Menéndez 2006 = A. López Mullor, A. Martín Menéndez, Laproduction d’amphores gréco-italiques, Dressel 1, Lamboglia 2 et Tarraconaise 1 à 3 en Catalogne.Typologie et chronologie, in sfecag, Actes du Congrès de Pézenas, 2006, pp. 441-460.
ltur = Lexicon Topographicum Urbis Romae, 1-6, ed. M.E. Steinby, Roma, 1993-2006.Lund 2000 = J. Lund, Transport Amphorae as Evidence of Exportation of Italian Wine and Oil to
the Eastern Mediterranean in the Hellenistic Period, in Between Orient and Occident. Studies in Honour of P. J. Riis, eds. J. Lund, P. Pentz, Copenhagen, 2000, pp. 77-99.
Luni 2002 = La via Flaminia nell’ager Gallicus, ed. M. Luni, «Quaderni della SoprintendenzaArcheologica delle Marche», 10, Urbino, 2002.
Lyding Will 1982 = E. Lyding Will, Greco-Italic Amphoras, «Hesperia», 51, 1982, pp. 338-356.Lyding Will 1987 = E. Lyding Will, The Roman Amphoras, in The Roman Port and Fishery of
Cosa, ed. A. M. McCann, Princeton N.J., 1987, pp. 171-220.Lyding Will 1989 = E. Lyding Will, Relazioni mutue tra le anfore romane. I ritrovamenti in
Oriente, alla luce dei dati ottenuti nell’Occidente, in arse, pp. 297-309.Lyding Will 2001 = E. Lyding Will, Defining the Regna Vini of the Sestii, in New Light from
ancient Cosa. Classical Mediterranean Studies in Honor of Cleo Rickman Fitch, ed. N. WynickGoldmann, New York, 2001, pp. 35-47.
Maggi 2004 = A. Maggi, Problemi di classificazione e terminologia circa le anfore greco-italiche eriflessioni sulla produzione velina, «Orizzonti», 5, 2004, pp. 99-106.
Maggi 2005 = A. Maggi, Errata corrige, «Orizzonti», 6, 2005, pp. 197-199.Maggiani 1982 = A. Maggiani, Cala del Diavolo (Isola di Montecristo), in Archeologia Subacquea,
«Bollettino d’Arte», ser. 6, 67, Suppl. 4, 1982, pp. 65-68.Majdoub 1996 = M. Majdoub, La Maurétanie et ses relations commerciales avec le monde romain,
in L’Africa Romana, 11, Atti dell’xi Convegno di studio (Cartagine, 15-18 dicembre 1994), Ozieri,1996, pp. 287-302.
110 clementina panella
Malfitana 2006 = D. Malfitana, Economia, territorio ed officine ceramiche nella Sicilia tardo ellenistica. Alcune riflessioni su identità, integrazione ed innovazione, in Territorio e produzioni ceramiche. Paesaggi, economia e società in età romana, Atti del Convegno internazionale (Pisa, 20-22 ottobre 2005), eds. S. Menchelli, M. Pasquinucci, Pisa, 2006, pp. 153-164.
Manacorda 1978 = D. Manacorda, The Ager Cosanus and the Production of the Amphorae ofSestius: New Evidence and a Reassessment, «Journal Roman Studies», 68, 1978, pp. 122-131.
Manacorda 1981 = D. Manacorda, Produzione agricola, produzione ceramica e proprietari nell’ager cosanus nel I sec. a.C., in srps ii, pp. 3-54.
Manacorda 1985 = D. Manacorda, Dai Sestii agli imperatori, in Settefinestre 1985, i, pp. 101-106.Manacorda 1986 = D. Manacorda, A proposito delle anfore cosiddette “greco-italiche”, una bre-
ve nota, in Recherches sur les amphores grecques, Actes du Colloque (Athènes, 10-12 septembre 1984),eds. J. Y. Empereur, Y. Garlan, «Bulletin de Correspondance Hellénique», Suppl. xiii, Athè-nes-Paris, 1986, pp. 581-586.
Manacorda 1988 = D. Manacorda, Per uno studio dei centri produttori delle anfore brindisine,in La Puglia in età repubblicana, Atti del i Convegno di studi sulla Puglia Romana (Mesagne, 20-22marzo 1986), ed. C. Marangio, Galatina, 1988, pp. 91-108.
Manacorda 1989 = D. Manacorda, Le anfore dell’Italia repubblicana: aspetti economici e sociali,in arse, pp. 443-467.
Manacorda 1993 = D. Manacorda, Appunti sulla bollatura in età romana, in Inscribed Economy,pp. 37-54.
Manacorda 1994a = D. Manacorda, Produzione agricola, produzione ceramica e proprietà dellaterra nella Calabria romana tra Repubblica e Impero, in Epigrafia della produzione e della distri-buzione, pp. 3-59.
Manacorda 1994b = D. Manacorda, Gli aselli dossuarii di Varrone, in Landuse in the RomanEmpire, pp. 79-90.
Manacorda 1995a = D. Manacorda, Sulla proprietà della terra nella Calabria romana tra re-pubblica e impero, in Du latifundium au latifondo, Actes de la table ronde international (Bordeaux,17-19 décembre 1992), Paris, 1995, pp. 143-189.
Manacorda 1995b = D. Manacorda, A proposito delle anfore della Pannonia romana: appunti eriflessioni, in La Pannonia e l’Impero Romano, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 13-16 gen-naio 1994), ed. G. Hajnóczi, Milano, 1995, pp. 177-191.
Manacorda 1998 = D. Manacorda, Il vino del Salento e le sue anfore, in ViAnt ii, pp. 319-331.Manacorda 2001a = D. Manacorda, Le fornaci di Giancola (Brindisi): archeologia, epigrafia, ar-
cheometria, in 20 ans de recherches à Sallèles-d’Aude, ed. F. Laubenheimer, Paris, 2001, pp. 229-240.
Manacorda 2001b = D. Manacorda La Calabria romana nel passaggio tra repubblica e impero,in Lo Cascio - Storchi Marino 2001, pp. 391-410.
Manacorda 2003 = D. Manacorda, Schiavi e padroni nell’antica Puglia romana: produzione ecommerci, in Archeologia dell’Adriatico, pp. 297-316.
Manacorda 2005 = D. Manacorda, Le anfore di Pompeo Magno, in Studi di archeologia in memoria di Liliana Mercando, ed. M. Sapelli Ragni, Torino, 2005, pp. 137-143.
Manacorda 2007 = D. Manacorda, Il Laterano e la produzione ceramica a Roma; aspetti del paesaggio urbano, in Res Bene Gestae. Ricerche di storia urbana su Roma antica in onore di EvaMargareta Steinby, eds. A. Leone, D. Palombi, S. Walker, Roma, 2007, pp. 195-204.
Manacorda - Panella 1993 = D. Manacorda, C. Panella, Anfore, in Inscribed Economy, pp.55-64.
Mannoni - Giannichedda 1996 = T. Mannoni, E. Giannichedda, Archeologia della produ-zione, Torino, 1996.
Mano - Dautaj 1997 = A. Mano, B. Dautaj, Përpjekje për një katalogizim të amforave antike ngaDimali, «Iliria», 27, 1997, pp. 127-165.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 111
Marchi - Sabbatini 1996 = M. L. Marchi, G. Sabbatini, Forma Italiae, 37. Venusia (igm 187i no / i ne), Firenze, 1996.
Marengo 2000 = S. M. Marengo Nuovi bolli rodii dalle Marche, «Picus», 20, 2000, pp. 312-319.Marini Calvani 1992 = M. Marini Calvani, Emilia occidentale tardoromana, in Felix Tem-
poris Reparatio, Atti del Convegno Archeologico Internazionale “Milano capitale dell’impero ro-mano” (Milano, 8-11 marzo 1990), eds. G. Sena Chiesa, E. Arslan, Milano, 1992, pp. 321-342.
Marlière 2002 = E. Marlière, L’outre et le tonneau dans l’Occident romain, Montagnac, 2002.Marlière 2007 = E. Marlière, Transport et stockage des denrées dans l’Afrique romaine: le rôle
de l’outre et du tonneau, in In Africa et in Hispania. Études sur l’huile africaine, eds. A. Mrabet,J. Remesal Rodríguez, Barcelona, 2007, pp. 85-106.
Márquez Villora - Molina Vidal 2005 = J. C. Márquez Villora, J. Molina Vidal, DelHiberus a Carthago Nova. Comercio de alimentos y epigrafia anfórica grecolatina, Barcelona, 2005.
Martín Camino 1996 = M. Martín Camino, Relaciones entre la Cartagena prebárquida y la Ma-gna Grecia y Sicilia ante de la primera guerra púnica. Consideraciones a partir de algunas marcasen ánfora (I), «Cuadernos de Arqueología Marítima», 4, 1996, pp. 11-37.
Martín Camino 1998 = M. Martín Camino, Un contexto cerámico de finales del siglo iii a.C.:el vertedero púnico de la Plaza de San Ginés (Cartagena), «Arqueo Marítima», 4, 1998, pp. 9-28.
Maselli Scotti 1980 = F. Maselli Scotti, Notiziario, «Aquileia Nostra», 51, 1980, c. 385.Maselli Scotti 1987 = F. Maselli Scotti, La produzione del vasellame fittile nel territorio di
Aquileia, «Antichità Altoadriatiche», 29, 1987, pp. 427-444.Mastino - Spanu - Zucca 2005 = A. Mastino, P. G. Spanu, R. Zucca, Mare sardum. Merci,
mercati e scambi marittimi della Sardegna antica, Roma, 2005.Méditerranée occidentale antique = Méditerranée occidentale antique: les échanges, Atti del iii Semina-
rio anser (Marseille, 14-15 mai 2004), eds. A. Gallina Zevi, R. Turchetti, Soveria Mannelli, 2004.Mégapoles méditerranéennes = Mégapoles méditerranéennes: géographie urbaine rétrospective, Actes
du Colloque organisé par l’École française de Rome et la Maison méditerranéenne des Sciences del’Homme (Rome, 8-11 mai 1996), eds. Cl. Nicolet, R. Ilbert, J. Cl. Depaule, Rome, 2000.
Memorie sommerse = Memorie sommerse. Archeologia subacquea in Toscana (Catalogo Mostra, For-tezza Spagnola di Porto Santo Stefano, 31 maggio-26 ottobre 1997), eds. G. Poggesi, P. Rendini, Pi-tigliano, 1998.
Menchelli 1990-1991= S. Menchelli, Una fornace di anfore Dressel 2-4 nell’ager Pisanus ed alcune considerazioni sui contenitori vinari prodotti nell’Etruria settentrionale in età romana,«Opus», 9-10, 1990-1991, pp. 169-184.
Menchelli 1994 = S. Menchelli, Le produzioni ceramiche della bassa valle dell’Arno, in Cera-mica romana e archeometria: lo stato degli studi, ed. G. Olcese, Firenze, 1994, pp. 205-215.
Menchelli et alii 2007 = S. Menchelli et alii, Anfore dell’Etruria settentrionale costiera in etàromana: nuovi dati alla luce delle recenti indagini archeologiche ed archeometriche, in Vitali 2007,pp. 141-150.
Mercando 1979 = L. Mercando, Marche. Rinvenimenti di insediamenti rurali, «Notizie degliScavi di Antichità», ser. 8, 33, 1979, pp. 89-296.
Mercando - Brecciatoli Taborelli - Paci 1981 = L. Mercando, L. Brecciatoli Tabo-relli, G. Paci, Forme d’insediamento nel territorio marchigiano in età romana: ricerca prelimi-nare, in srps i, pp. 311-347.
Mercanti e politica = Mercanti e politica nel mondo antico, ed. C. Zaccagnini, Roma, 2003.Mercator Placidissimus = Mercator Placidissimus. The Tiber Valley in Antiquity. New research in
the upper and middle river valley, eds. F. Coarelli, H. Patterson, Roma, 2009.Metodi e approcci archeologici = Metodi e approcci archeologici. L’industria e il commercio nell’Italia
antica. Archaeological methods and approaches. Industry and commerce in ancient Italy, eds. E. C.De Sena, H. Dessales, «British Archaeological Reports», International Series, 1262, Oxford,2004.
112 clementina panella
Molina Vidal 1997 = J. Molina Vidal, La dinámica comercial romana entre Italia y HispaniaCiterior, Alicante, 1997.
Molina Vidal 2009 = J. Molina Vidal, Mercantile trade in the upper Tiber Valley: the villa ofPliny the younger “in Tuscis”, in Mercator Placidissimus, pp. 215-249.
Monsieur 2001 = P. Monsieur, Note préliminaire sur les amphores découvertes à Pessinonte,«Anatolia Antiqua», 9, 2001, pp. 72-84.
Morel 1969 = J.-P. Morel, Études de céramique campanienne, 1. L’Atelier des Petites Estampilles,«Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité», 81, 1969, pp. 59-117.
Morel 1976a = J.-P. Morel, Aspects de l’artisanat dans la Grande Grèce romaine, in Atti Taran-to, 15, 1975, Napoli, 1976, pp. 263-324.
Morel 1976b = J.-P. Morel, Céramiques d’Italie et céramiques hellénistiques (130-50 a.C.), in Helle-nismus in Mittelitalien, ed. P. Zanker, Göttingen, 1976, pp. 471-501.
Morel 1981 = J.-P. Morel, Céramique Campanienne i. Les formes, Rome, 1981.Morel 1983 = J.-P. Morel, Les producteurs de biens artisanaux en Italie à la fin de la République,
in Les “Bourgeoisies” municipales italiennes aux iie et ier siècles av. J.-C., Colloque International (Naples, 7-10 décembre 1981), Paris-Naples, 1983, pp. 21-39.
Morel 1988a = J.-P. Morel, Remarques sur l’art et l’artisanat de Naples antique, in Neapolis, Attidel venticinquesimo convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto 3-7 ottobre 1985), Taranto, 1988,pp. 305-356.
Morel 1988b = J.-P. Morel, Artisanat et colonisation dans l’Italie romaine aux ive et iiie siècles av.J.-C., «Dialoghi di Archeologia», ser. 3, 6, 2, 1988, pp. 49-63.
Morel 1990a = J.-P. Morel, Nouvelles données sur le commerce de Carthage punique entre le viie etle iie siècle avant J.-C., in Carthage et son territoire dans l’Antiquité, ive Colloque International surl’Histoire et l’Archéologie de l’Afrique du Nord (Strasbourg, 5-9 avril 1988), Paris, 1990, pp. 67-100.
Morel 1990b = J.-P. Morel, L’artigianato e gli artigiani, in Storia di Roma, 2,1, Torino, 1990, pp.142-158.
Morel 1990c = J.-P. Morel, Les systèmes chronologiques: la Méditerranée occidentale, in Gaule interne, pp. 327-329.
Morel 1990d = J.-P. Morel, La chronologie des iie et ier siècles en Gaule: le point de vue d’un “sudiste”, in Gaule interne, pp. 339-344.
Morel 1995 = J.-P. Morel, L’économie des peuples latins et latinisés avant la seconde guerre puni-que, in Nomen Latinum. Latini e Romani prima di Annibale, Atti del Convegno Internazionale(Roma, 24-26 ottobre 1995), «Eutopia», 4, 2, 1995 [1997], pp. 213-232.
Morel 1998a = J.-P. Morel, Que buvaient les Carthaginois?, in ViAnt ii, pp. 29-38.Morel 1998b = J.-P. Morel, Le commerce à l’époque hellénistique et romaine et les enseignements
des épaves, in Archeologia subacquea, pp. 485-529.Morel 2002 = J.-P. Morel, Taranto nel Mediterraneo in epoca ellenistica, in Atti Taranto, 41,
2001, Taranto, 2002, pp. 529-574.Morel 2004 = J.-P. Morel, Les amphores importées à Carthage punique, in Circulació d’àmfores al
Mediterrani occidental, pp. 11-23.Morel 2005 = J.-P. Morel, La céramique et la mer: rôle et modalités du commerce maritime dans la
diffusion des produits céramiques, in Aequora, pp. 100-108.Morel 2008 = J.-P. Morel, Les céramiques hellénistiques et romaines et les problèmes de “marchés”,
in Économie antique, pp. 161-189.Morelli - Olcese - Zevi 2004 = C. Morelli, G. Olcese, F. Zevi, Scoperte recenti nelle saline
portuensi (Campus salinarum romanarum) e un progetto di ricerca sulla ceramica di area ostien-se in età repubblicana, in Méditerranée occidentale antique, pp. 43-55.
Morley 1996 = N. Morley, Metropolis and Hinterland. The city of Rome and the Italian Econo-my, 200 BC-AD 200, Cambridge, 1996.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 113
Musti 1980 = D. Musti, Il commercio degli schiavi e del grano: il caso di Puteoli. Sui rapporti tral’economia italiana della tarda repubblica e le economie ellenistiche, in Seaborne Commerce, pp. 197-215.
Musti 1981 = D. Musti, Modi di produzione e reperimento di manodopera schiavile: sui rapporti tral’Oriente ellenistico e la Campania, in srps i, pp. 243-263.
Nolla Brufau 1974 = J. M. Nolla Brufau Las ánforas romanas de Ampurias, «Ampurias», 36,1974, pp. 147-197.
Nolla Brufau 1978 = J. M. Nolla Brufau, Una producció característica, les àmfores “DB”,«Cypsela», 2, 1978, pp. 201-231.
Nolla - Nieto 1989 = J. M. Nolla, F. J. Nieto, La importación de ánforas romanas en Cataluñadurante el periodo tardo-republicano, in arse, pp. 367-391.
Nonnis 1999 = D. Nonnis, Attività imprenditoriali e classi dirigenti nell’Italia repubblicana. Trecittà campione, «Cahiers Glotz», 10, 1999 [2000], pp. 71-109.
Nonnis 2001 = D. Nonnis, Appunti sulle anfore adriatiche d’età repubblicana: aree di produzione ecommercializzazione, in Strutture portuali e rotte marittime, pp. 467-500.
Nonnis 2003 = D. Nonnis, Le implicazioni socio-politiche della produzione e della distribuzione nell’Italia repubblicana: per un repertorio prosopografico, in Mercanti e politica, pp. 249-278.
Nonnis 2007 = D. Nonnis, Merci e mercanti ad Aquileia in età repubblicana. Il contributo dell’epi-grafia, in Aquileia, pp. 363-392.
Olcese 1998 = G. Olcese, Ceramica a vernice nera di Roma e di area romana: i risultati delle ana-lisi di laboratorio, in Indagini archeometriche relative alla ceramica a vernice nera. Nuovi dati sul-la provenienza e la diffusione, Atti del seminario internazionale di studio (Milano, 22-23 novembre1996), Como, 1998, pp. 141-152.
Olcese 2004 = G. Olcese, Anfore greco-italiche antiche. Alcune osservazioni sull’origine e sulla circolazione alla luce di recenti ricerche archeologiche ed archeometriche, in Metodi e appocci archeologici, pp. 173-192.
Olcese 2005-2006 = G. Olcese, The production and circulation of Greco-Italic amphorae of Campania. The data of the archaeological and archaeometric research, «Skyllis», 7, 2005-2006, pp.60-75.
Olcese 2009 = G. Olcese, Produzione e circolazione ceramica in area romana in età repubblicana:linee di ricerca, metodi di indagine e problemi aperti, in Suburbium ii, pp. 143-156.
Olcese - Picon - Thierrin Michael 1996 = G. Olcese, M. Picon, G. Thierrin Michael,Il quartiere ceramico sotto la Chiesa di Santa Restituta a Lacco Ameno d’Ischia e la produzione dianfore e di ceramica in età ellenistica, «Bollettino di Archeologia», 39-40, 1996 [2001], pp. 7-29.
Olcese - Thierrin Michael 2009 = G. Olcese, G. Thierrin Michael, Graeco-Italic amphorae in the region of Ostia: archaeology and archaeometry, in emac ’07, 9th European Meetingon Ancient Ceramics (Budapest, 24-27 October 2007), Budapest, 2009, pp. 159-163.
Olmer 2003 = F. Olmer, Les amphores de Bibracte - 2. Le commerce du vin chez les Éduens d’aprèsles timbres d’amphores. Catalogue des timbres de Bibracte 1984-1998. Catalogue des timbres de Bour-gogne, Glux-en-Glenne, 2003.
Olmer 2008 = F. Olmer, L’aristocratie romaine, le vin et le marché gaulois, in Économie antique,pp. 215-234.
Paci 1998 = G. Paci, Umbria e agro gallico a nord del fiume Esino, «Picus», 18, 1998, pp. 89-118.Palazzo 1988 = P. Palazzo, Le “Collezioni” Viola. I bolli anforari: le produzioni italiche, in Mu-
seo di Taranto. Cento anni di archeologia (Catalogo della Mostra per il centenario dell’istituzionedel Museo Archeologico Nazionale di Taranto), Taranto, 1988, pp. 71-80.
Palazzo 1989 = P. Palazzo, Le anfore di Apani (Brindisi), in arse, pp. 548-553.Palazzo 1994 = P. Palazzo, Insediamenti artigianali e produzione agricola. I siti di Apani, Gian-
cola, Marmorelle, La Rosa, in Scritti di antichità in memoria di Benita Sciarra Bardaro, eds. C.Marangio, A. Nitti, Fasano, 1994, pp. 53-60.
114 clementina panella
Palazzo 1996 = P. Palazzo, Bolli anforari dal sito di Apani, in Élites municipales, pp. 47-53.Palazzo 2005 = P. Palazzo, Bolli di ‘anfore brindisine’ nel Museo di Mesagne, «Epigraphica», 67,
2005, pp. 428-473.Palazzo 2006 = P. Palazzo, Bolli di anfore brindisine rinvenute ad Akoris (Egitto), «Epigraphi-
ca», 68, 2006, pp. 388-408.Palazzo - Silvestrini 2001 = P. Palazzo, M. Silvestrini, Apani: anfore brindisine di produ-
zione “aniniana”, «Daidalos», 3, 2001, pp. 57-107.Pallarés 1975-1981 = F. Pallarés, La nave romana di Spargi (La Maddalena), relazione prelimi-
nare delle campagne 1978-1980, «Forma Maris Antiqui», 11-12, 1975-1981, pp. 5-39.Panella 1998 = C. Panella, Anfore e archeologia subacquea, in Archeologia subacquea, pp. 531-
559.Panella 2006 = C. Panella, La viticoltura e il vino nell’Italia romana, in Il vino. Tra mito e cul-
tura, eds. M.G. Marchetti Lungarotti, M. Torelli, Ginevra-Milano, 2006, pp. 41-54.Paribeni 1982 = E. Paribeni, Follonica, in Archeologia Subacquea, «Bollettino d’Arte», ser. 6,
67, Suppl. 4, 1982, pp. 49-50.Paribeni 2004 = E. Paribeni, Anfore romane sulle Apuane. Materiali da insediamenti liguri del
versante tirrenico, in Ligures celeberrimi, pp. 205-219.Parker 1992 = A.J. Parker, Ancient Shipwrecks of the Mediterranean & the Roman Provinces,
«British Archaeological Reports», International Series, 580, Oxford, 1992.Pascual - Ribera - Finkielsztejn 2007 = G. Pascual Berlanga, A. Ribera i Lacomba, G.
Finkielsztejn, Las ánforas griegas y púnicas de recientes excavaciones en la Regio vii de Pom-peya, in Comercio, redistribución y fondeaderos, pp. 501-517.
Pasquinucci - Del Rio - Menchelli 1998 = M. Pasquinucci, A. Del Rio, S. Menchelli,Produzioni di vino nell’Etruria settentrionale costiera, in ViAnt ii, pp. 357-363.
Pasquinucci - Menchelli 1999 = M. Pasquinucci, S. Menchelli, The landscape and econo-my of the territories of Pisae and Volaterrae (coastal North Etruria), «Journal of Roman Ar-chaeology», 12, 1999, pp. 122-141.
Pasquinucci - Menchelli 2002 = M. Pasquinucci, S. Menchelli, Anfore picene e paesaggioagrario: alcune considerazioni a proposito dell’ager Firmanus, in Vivre, produire et échanger, pp.457-463.
Pasquinucci - Weski 2004 = Close Encounters: Sea- and Riverborne Trade, Ports and Hinterlands,Ship Construction and Navigation in Antiquity, the Middle Ages and in Modern Time, eds. M. Pa-squinucci, T. Weski, «British Archaeological Reports», International Series, 1283, Oxford,2004.
Patané 2002 = R. P. A. Patané, Centuripe in età ellenistica: i rapporti con Roma, in Scavi e ricer-che a Centuripe, ed. G. Rizza, Catania, 2002, pp. 127-167.
Peacock 1982 = D. P. S. Peacock, Pottery in the Roman world, an ethnoarchaeological approach,London-New York, 1982.
Pedroni 2001 = L. Pedroni, Ceramica calena a vernice nera. Produzione e diffusione, Città di Castello, 2001.
Pellegrini 1887 = A. Pellegrini, Iscrizioni ceramiche d’Erice e dintorni, «Archivio Storico Siciliano», n. ser. 12, 1887, pp. 184-303.
Pellegrino 1983 = A. Pellegrino, Ville rustiche a Dragoncello (Acilia), in Archeologia Laziale,v, Quaderni del Centro di Studio per l’archeologia etrusco-italica, 7, Roma, 1983, pp. 76-83.
Pelletier 1966 = A. Pelletier, Les fouilles du “Temple de Cybèle” à Vienne (Isère). Rapport provisoire, «Revue Archéologique», 1966, pp. 113-150.
Percossi Serenelli - Frapiccini 2003 = E. Percossi Serenelli, N. Frapiccini, Potentia:una colonia romana sull’Adriatico, in Archeologia dell’Adriatico, pp. 395-399.
Pérez Ballester 1995 = J. Pérez Ballester, Las ánforas Dressel 1 con datación consular. Unapieza de Cartagena, «Saguntum», 29, 1995, pp. 175-186.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 115
Pérez Ballester 2003 = J. Pérez Ballester, El comercio: rutas comerciales y puertos, in Romanos y Visigodos in tierras valencianas, eds. H. Bonet et alii, Valencia, 2003, pp. 115-130.
Pérez Ballester 2004 = J. Pérez Ballester, La producción y el comercio del vino itálico en elMediterráneo occidental, in Scombraria, pp. 23-29.
Pérez Ballester - Pascual Berlanga 2004 = J. Pérez Ballester, G. Pascual Berlanga,The Adriatic Amphorae Type L. 2 recovered from the Environment of Cartagena (Murcia, Spain), inPasquinucci - Weski 2004, pp. 27-37.
Pesavento Mattioli 2002 = S. Pesavento Mattioli, Una produzione norditalica di anforebollate, in Vivre, produire et échanger, pp. 391-394.
Petracca - Vigna 1985 = L. Petracca, L. Vigna, Le fornaci di Roma e suburbio, in Misurare laterra. Centuriazione e coloni nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Romae dal Suburbio (Catalogo Mostra, Roma, aprile-giugno 1985), Modena, 1985, pp. 131-137.
Pimenta 2003 = J. Pimenta, Contribuição para o estudo das ânforas do Castelo de São Jorge (Lisboa), «Revista Portuguesa de Arqueologia», 6, 2, 2003, pp. 341-362.
Pinedo Reyes - Alonso Campoy 2004 = J. Pinedo Reyes, D. Alonso Campoy, El yacimen-to submarino de la isla de Escombreras, in Scombraria, pp. 128-151.
PIR = Prosopographia Imperii Romani.Poli 2004 = F. Poli, Les timbres amphoriques osques de Spargi, «Studi Etruschi», 70, 2004 [2005],
pp. 384-388.Pomey et alii 1992 = P. Pomey et alii, Recherches sous-marines, «Gallia Information», 1, 1992, pp.
1-85.Pons - Rovira 1997 = El dipòsit d’ofrenes de la fossa 101 de Mas Castellar de Pontós; un estudi inter-
disciplinari, eds. E. Pons i Brun, M. C. Rovira i Hortalà, Estudis arqueològics, 4, Girona,1997.
Poux 2004 = M. Poux, L’âge du vin. Rites de boisson, festins et libations en Gaule indépendante,Montagnac, 2004.
Poux - Nillesse 2003 = M. Poux, O. Nillesse, Le vin, le sang, le fer. Un passage de Polybe (ii,19) e le rôle du vin dans les cultes indigènes de la fin de l’Âge du Fer, «Revue Archéologique del’Ouest», Suppl. 10, 2003, pp. 293-308.
Poux - Savay Guerraz 2003 = Lyon avant Lugdunum, eds. M. Poux, H. Savay Guerraz, Gollion(CH), 2003.
Pridik 1917 = E.M. Pridik, Inventaire des timbres sur anses et cols d’amphores et sur tuiles de la Collection de l’Ermitage, Petrograd, 1917.
Principal 1998 = J. Principal Ponce, Las importaciones de vajilla fina de barniz negro en la Cataluña sur y occidental durante el siglo iii a.C. Comercio y dinámica de adquisición en las socie-dades indígenas, «British Archaeological Reports», International Series, 729, Oxford, 1998.
Profumo 1986 = M.C. Profumo, Rinvenimenti sottomarini lungo la costa marchigiana, in Ar-cheologia Subacquea 3, «Bollettino d’Arte», ser. 6, 71, Suppl. 37-38, 1986, pp. 39-48.
Progetto Durrës = Progetto Durrës. L’indagine sui Beni Culturali albanesi dell’Antichità e del MedioEvo: tradizioni di studio a confronto, Atti del primo incontro scientifico (Parma-Udine, 19-20 aprile2002), eds. M. Buora, S. Santoro, «Antichità Altoadriatiche», 53, Trieste, 2003.
Pucci 1993 = G. Pucci, I bolli sulla terra sigillata: tra epigrafia e storia economica, in InscribedEconomy, pp. 73-79.
Puteoli 1993 = Puteoli, ed. F. Zevi, Napoli, 1993.Py - Adroher Auroux - Sanchez 2001 = M. Py, A. M. Adroher Auroux, C. Sanchez, Di-
cocer2. Corpus des céramiques de l’âge du Fer de Lattes (fouilles 1963-1999), «Lattara», 14.1, Lattes,2001.
Raepsaet Charlier 1987 = M. T. Raepsaet Charlier, Prosopographie des femmes de l’ordresénatorial (ier-iie siècles), i-ii, Louvain, 1987.
Ramon 1991 = J. Ramon, Las ánforas púnicas de Ibiza, Eivissa, 1991.
116 clementina panella
Ramon Torres 1995 = J. Ramon Torres, Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo central yoccidental, Barcelona, 1995.
Rauh 1993 = N. K. Rauh, The Sacred Bonds of Commerce: Religion, Economy and Trade Societyat Hellenistic Roman Delos, 166-87 BC, Amsterdam, 1993.
Rauh 1999 = N. H. Rauh, Rhodes, Rome, and the eastern Mediterranean wine trade, 166 - 88 BC,in Hellenistic Rhodes: politics, culture and society, eds. V. Gabrielsen et alii, Aarhus, 1999, pp.162-186.
Ribera i Lacomba - Marín Jordá 2003 = A. Ribera i Lacomba, C. Marín Jordá, Impor-taciones itálicas del nivel de fundacion (138 a.C.) de Valencia, «Rei Cretariae Romanae Fautorum,Acta», 38, 2003, pp. 287-294.
Righini 1997 = V. Righini, Per una storia del commercio in Adriatico: elementi per l’età romana,in Adriatico. Genti e civiltà, Atti del Convegno (Ravenna-Cesenatico, 25-26 febbraio, 4-5 marzo 1995),Cesena, 1997, pp. 135-198.
Riley 1979 = J. A. Riley, The Coarse Pottery from Berenice, in Excavations at Sidi Khrebish, Benghazi (Berenice), ed. J. A. Lloyd, «Libya Antiqua», Suppl. 5, 2, 1979, pp. 91-467.
Rizzitelli 2006 = C. Rizzitelli, Ceramica d’importazione sull’acropoli di Populonia, in Mate-riali per Populonia, 5, Pisa, 2006, pp. 143-168.
Rizzo 2003 = G. Rizzo, Instrumenta Urbis, i. Ceramiche fini da mensa, lucerne ed anfore a Romanei primi due secoli dell’Impero, Rome, 2003.
Rodríguez Almeida 1984 = E. Rodríguez Almeida, Il monte Testaccio. Ambiente, storia, materiali, Roma, 1984.
Roman villas around the Urbs = Roman villas around the Urbs. Interaction with landscape and environment. Proceedings of a conference at the Swedish Institute in Rome, (September 17-18, 2004),eds. B. Santillo Frizell, A. Klynne, Rome, 2005.
Romualdi 1992 = Populonia in età ellenistica. I materiali della necropoli, ed. A. Romualdi, Firen-ze, 1992.
Rosada 2003 = G. Rosada, Strutture produttive negli insediamenti rurali e residenziali dell’Istria,«Rivista di Topografia Antica», 13, 2003 [2005], pp. 17-48.
Rosada 2004 = Loron-Lorun (Parenzo-Pore©, Istria). Lo scavo di una Villa Maritima nell’agro parentino, ed. G. Rosada, «Quaderni di archelogia del Veneto», 20, 2004, pp. 70-82.
Rossi 2000 = E. Rossi, Anfore greco italiche, in Le navi antiche di Pisa. Ad un anno dall’inizio dellericerche (Catalogo Mostra), ed. S. Bruni, Firenze, 2000, pp. 121-129.
Rossi 2003 = E. Rossi, Anfore “greco italiche”, in Il porto urbano di Pisa antica. La fase etrusca, ilcontesto e il relitto ellenistico, ed. S. Bruni, Cinisello Balsamo (Mi), 2003, pp. 159-166.
rtar i = M. B. Carre et alii, Recueil de Timbres sur Amphores Romaines (1987-1988) i, Aix-en-Pro-vence, 1995.
rtar ii = V. Blanc-Bijon et alii, Recueil de Timbres sur Amphores Romaines (1989-90 et complé-ments 1987-1988) ii, Aix-en-Provence, 1998.
Sáez - Díaz 2007 = M. Sáez Romero, J. J. Díaz Rodríguez, La producción de ánforas de tipoGriego y Grecoitálico en Gadir y el Área del Estrecho. Cuestiones tipológicas y de contenido, «Ze-phyrus», 60, 2007, pp. 198-208.
Salomies 1987 = O. Salomies, Die römischen Vornamen. Studien zur römischen Namengebung,Helsinki, 1987.
Salomies 1996 = O. Salomies, Senatori oriundi del Lazio, in Studi storico-epigrafici sul Lazio antico, ed. H. Solin, Roma, 1996, pp. 23-127.
Sanchez - Adroher Auroux 2004 = C. Sanchez, A. M. Adroher Auroux, Le quartier 30-35 de la ville de Lattara (fin iiie-ier s. av. n. è.): regards sur la vie urbaine à la fin de la protohistoire,«Lattara», 17, ed. M. Py, Lattes, 2004, pp. 319-344.
Sangineto 2001 = A.B. Sangineto, Trasformazioni o crisi nei Bruttii fra il ii a.C. ed il vii d.C.?,in Lo Cascio - Storchi Marino 2001, pp. 203-246.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 117
Sanmartí 1985 = E. Sanmartí Grego, Las ánforas romanas del campamento numantino de PeñaRedonda (Garray, Soria), «Empúries», 47, 1985, pp. 130-161.
Sanmartí 1992 = E. Sanmartí Grego, Nouvelles données sur la chronologie du camp de Renie-blas v à Numance, «Documents d’Archéologie Méridionale», 15, 1992, pp. 417-430.
Sanmartí - Principal 1997 = E. Sanmartí Grego, J. Principal Ponce, Las cerámicas de im-portación, itálicas y ibéricas, procedentes de los campamentos numantinos, «Revista d’Arqueolo-gia de Ponent», 7, 1997, pp. 35-75.
Scardozzi 2007 = G. Scardozzi, Le anfore di Marcus Tuccius Galeo dalla valle del Liri, in Spi-golature aquinati, pp. 59-76.
Schiavone 1989 = A. Schiavone, La struttura nascosta. Una grammatica dell’economia romana,in Storia di Roma, 4, Torino, 1989, pp. 7-69.
Schulze 1904 = W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin, 1904.Scombraria = Scombraria. La historia oculta bajo el mar. Arqueología submarina en Escombreras-Car-
tagena (Catalogo Mostra, Museo Arqueológico de Murcia, 17 marzo-4 junio 2004), ed. M. LechugaGalindo, Murcia, 2004.
Scotti 1984 = C. Scotti, Anfore, in Ricerche a Pompei. L’insula 5 della Regio vi dalle origini al 79d.C., i (campagne di scavo 1976-1979), ed. M. Bonghi Jovino, Roma, 1984, pp. 270-317.
Seaborne Commerce = The Seaborne Commerce of ancient Rome: Studies in Archaeology and History,eds. J. H. D’Arms, E. C. Kopff, «Memoirs of the American Academy in Rome», 36, Rome,1980.
Sebastiani - Serlorenzi 2008 = R. Sebastiani, M. Serlorenzi, Il progetto del Nuovo Merca-to di Testaccio, «Workshop di Archeologia Classica», 5, 2008, pp. 137-171.
Serlorenzi et alii 2004 = M. Serlorenzi et alii, Nuove acquisizioni sulla viabilità dell’Agro Por-tuense. Il ritrovamento di un tratto della via Campana e della via Portuense, «Bullettino dellaCommissione Archeologica Comunale di Roma», 105, 2004, pp. 47-114.
Serra Ridgway 1996 = F. R. Serra Ridgway, I corredi del fondo Scataglini a Tarquinia, Mila-no, 1996.
Settefinestre 1985 = Settefinestre. Una villa schiavistica nell’Etruria romana, i-iii, eds. A. Carandini,A. Ricci, Modena, 1985.
Shatzman 1975 = I. Shatzman, Senatorial Wealth and Roman Politics, Bruxelles, 1975.Shehi 2003 = E. Shehi, I rapporti commerciali di Dyrrachium e di altre città dell’Illiricum del Sud
con i centri del Mediterraneo (iii secolo a.C.-iii secolo d.C.), in Progetto Durrës, pp. 209-220.Shepherd 1985 = J. Shepherd, Testimonianze di commercio marittimo a Populonia in età roma-
na, «Rassegna di archeologia classica e postclassica», 5, 1985, pp. 173-189.Silvestrini 1996 = M. Silvestrini Le élites municipali dai Gracchi a Nerone: Apulia e Calabria,
in Élites municipales, pp. 31-46.Solier 1979 = Y. Solier, Découverte d’inscriptions sur plombs en écriture ibérique dans un entrepôt
de Pech Maho (Sigean), «Revue Archéologique de Narbonnaise», 12, 1979, pp. 55-123.Solin - Salomies 1988 = Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, eds.
H. Solin, O. Salomies, Hildesheim-Zürich-New York, 1988.Spadea 2005 = R. Spadea, Tra Ionio e Tirreno: Terina, Crotone, Petelia, in Atti del quarantaquat-
tresimo convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto 24-28 settembre 2004), Taranto, 2005, pp.505-542.
Spigolature aquinati = Spigolature aquinati. Studi storico-archeologici su Aquino e il suo territorio, At-ti della Giornata di studio (Aquino, 19 maggio 2007), eds. A. Nicosia, G. Ceraudo, Aquino, 2007.
srps = Società romana e produzione schiavistica, i-iii, eds. A. Giardina, A. Schiavone, Bari-Roma,1981.
Staffa 2003 = A.R. Staffa, Impianti produttivi d’età romana nel territorio della provincia di Pe-scara. Le fornaci, «Rivista di Topografia Antica», 13, 2003 [2005], pp. 117-154.
118 clementina panella
Staffa 2004 = A.R. Staffa, Dai Sabini ai Sanniti e oltre. Due millenni di storia dell’Italia centro-meridionale nelle ricerche archeologiche degli ultimi decenni, in Atti della Accademia Nazionale deiLincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti, ser. 9, 15, 2, 2004, pp. 225-301.
Stanco 2001 = E. A. Stanco, I bolli doliari e ceramici nel territorio capenate, parte I, Addenda,«Epigraphica», 63, 2001, pp. 164-193.
Stanco 2004 = E. Stanco, La ceramca a vernice nera della stipe di Lucus Feroniae: analisi prelimi-nare, «Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma», 105, 2004, pp. 29-46.
Stanco 2009 = E. Stanco, La seriazione cronologica della ceramica a vernice nera etrusco-laziale,in Suburbium ii, pp. 157-193.
Starac 2008 = A. Starac, A deposit of Roman amphorae in Pula (Croatia). A preliminary report,«Rei Cretariae Romanae Fautorum, Acta», 40, Bonn, 2008, pp. 121-129.
Stoppioni 1993 = Con la terra e con il fuoco. Fornaci romane nel Riminese, ed. M. L. Stoppioni, Ri-mini, 1993.
Stoppioni 2008 = M. L. Stoppioni, Anfore greco-italiche, in Vetus Litus. Archeologia della foce.Una discarica di materiali ceramici del iii secolo a.C. alla darsena di Cattolica, eds. L. Malnati, M.L. Stoppioni, Firenze, 2008, pp. 131-151.
Strutture portuali e rotte marittime = Strutture portuali e rotte marittime nell’Adriatico di età roma-na, Atti della xxix settimana di studi aquileiesi (Aquileia, 20-23 maggio 1998), ed. C. Zaccaria,Trieste-Roma, 2001.
Suburbium ii = Il suburbio di Roma dalla fine dell’età monarchica alla nascita del sistema delle ville(v-i secolo a.C.), Atti del Convegno (Roma, 16-17 febbraio 2005), eds. V. Jolivet et alii, Roma, 2009.
Tartara 1999 = P. Tartara, Forma Italiae, 39. Torrimpietra (igm 149 i no), Firenze, 1999.Tartari 1982 = F. Tartari, Amforat e Muzeut arkeologjik të Durrësit (përpjekje për një katalog të
tyre), «Iliria», n. ser. 12.2, 1982, pp. 239-279.Tassaux 1982 = F. Tassaux, Laecanii. Recherches sur une famille sénatoriale d’Istrie, «Mélanges
de l’École française de Rome. Antiquité», 94, 1982, pp. 227-269.Tassaux 1983-1984 = F. Tassaux, L’implantation territoriale des grandes familles d’Istrie sous le
Haut-Empire romain, in Problemi storici ed archeologici dell’Italia nordorientale e delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo, Atti dell’Incontro di Studio (Trieste, 28-30 ottobre 1982), eds.G. Bandelli et alii, Trieste, 1983-1984, pp. 193-229.
Tassaux 1998 = F. Tassaux, Apports recents de l’épigraphie et de l’histoire économique et sociale deBrioni, in Epigrafia romana in area adriatica, Actes de la ixe Rencontre franco-italienne sur l’épi-graphie du monde romain (Macerata, 10-11 novembre 1995), ed. G. Paci, Roma, 1998, pp. 77-99.
Tasseaux et alii 2001 = Loron (Croatie). Un grand centre de production d’amphores à huile istriennes(ier-ive s. p. C.), eds. F. Tassaux, R. Matijašic, V. Kova©ic, Bordeaux, 2001.
Tchernia 1968-1970 = A. Tchernia, Premiers résultats des fouilles de juin 1968 sur l’épave 3 de Planier, «Études Classiques», 3, 1968-1970, pp. 51-82.
Tchernia 1969a = A. Tchernia, Informations archéologiques, Direction des recherches archéolo-giques sous-marines, «Gallia», 27, 2, 1969, pp. 465-499.
Tchernia 1969b = A. Tchernia, Une marque d’amphore au nom de P. Vedius Pollio, «Rivista diStudi Liguri», 35, 1969, pp. 145-148.
Tchernia 1986 = A. Tchernia, Le vin de l’Italie Romaine. Essai d’histoire économique d’áprès lesamphores, Rome, 1986.
Tchernia 1990 = A. Tchernia, Contre les épaves, in Gaule interne, pp. 291-301.Tchernia 1999 = A. Tchernia, Une autre hypotèse sur les inscriptions peintes en caractères ibé-
riques de Vieille-Toulouse, in Mélanges C. Domergue, «Pallas», 50, 1999, pp. 101-105.Tchernia 2000 = A. Tchernia, Subsistances à Rome: problèmes de quantification, in Mégapoles
méditerranéennes, pp. 751-760.Tchernia - Pomey - Hesnard 1978 = A. Tchernia, P. Pomey, A. Hesnard, L’épave romaine
de la Madrague de Giens (Var), «Gallia», Suppl. 34, Paris, 1978.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 119
Tchernia - Brun 1999 = Le vin romain antique, eds. A. Tchernia, J. P. Brun, Grenoble, 1999.Tchernia - Viviers 2000 = A. Tchernia, D. Viviers, Athènes, Rome et les avants-ports: “me-
gapoles” antiques et trafics méditerranéens, in Mégapoles méditerranéennes, pp. 761-801.Terre, proprietari e contadini = Terre, proprietari e contadini. Dall’affitto agrario al colonato tardo-
antico, ed. E. Lo Cascio, Roma, 1997.Terrenato - Saggin 1994 = N. Terrenato, A. Saggin, Ricognizioni archelogiche nel territorio
di Volterra. La pianura costiera, «Archeologia Classica», 46, 1994, pp. 465-482.Terrenato - Becker 2009 = N. Terrenato, J. A. Becker, Il sito del Monte delle Grotte sulla
via Flaminia e lo sviluppo della villa nel suburbio di Roma, in Suburbium ii, pp. 393-401.Thierrin Michael 2000 = G. Thierrin Michael, Amphores gréco-italiques de l’oppidum de
Pech-Maho (iiie siècle avant J.-C.). Détermination d’origine par l’étude pétrographique, in sfecag,Actes du Congrès de Libourne (1er-4 juin 2000), Marseille, 2000, pp. 225-231.
Tilloca 2001 = C. Tilloca, Bolli anforari rodii dall’ager populoniensis, «Archeologia Classi-ca», 52, 2001, pp. 229-254.
Tiussi 2007 = C. Tiussi, Importazioni vinarie ad Aquileia in età repubblicana. Le anfore rodie, inAquileia, pp. 479-496.
Tolosa = Tolosa. Nouvelles recherches sur Toulouse et son territoire dans l’Antiquité, ed. J. M. Pailler,Toulouse, 2001.
Toniolo 1998 = A. Toniolo, Le greco-italiche e il vino di Adria, in ViAnt ii, pp. 74-80.Toniolo 2000 = A. Toniolo, Le anfore di Adria (iv-ii secolo a.C.), Sottomarina-Chioggia, 2000.Toniolo - Fayas Rico 2002 = A. Toniolo, B. Fayas Rico, Commerci di contenitori da traspor-
to a lungo corso tra Mediterraneo tirrenico e Mallorca nel iii-i secolo a.C., in L’Africa Romana, 14,1, Atti del xiv Convegno di studio (Sassari, 7-10 dicembre 2000), Roma, 2002, pp. 697-710.
Torelli 1969 = M. Torelli, Senatori etruschi della tarda repubblica e dell’impero, «Dialoghi diArcheologia», 3, 3, 1969, pp. 285-363.
Torelli 1982 = M. Torelli, Ascesa al senato e rapporti con i territori d’origine. Italia: Regio vii(Etruria), in Epigrafia e Ordine Senatorio, ii, pp. 275-299.
Torelli 1990 = M. Torelli, La formazione della villa, in Storia di Roma, 2, 1, Torino, 1990, pp.123-132.
Torelli 2000 = M. Torelli, Domi nobiles et lateres signati, in Brique antique et médiévale, pp.311-321.
Torelli 2003 = M. Torelli, Graffiti, in Il porto urbano di Pisa antica. La fase etrusca, il contestoe il relitto ellenistico, ed. S. Bruni, Cinisello Balsamo (Mi), 2003, pp. 167-168.
Tortorici 2000 = E. Tortorici, Un nuovo relitto di età repubblicana nel mare di Grado, «Ar-cheologia delle acque», 4, 2000, pp. 91-98.
Toynbee 1965 = A.J. Toynbee, Hannibal’s Legacy: the Hannibalic War’s effects on Roman life,London-New York, 1965.
Tresserras - Matamala 2004 = J. J. Tresserras, J. C. Matamala, Los contenidos de las ánforas en el Mediterráneo Occidental. Primeros resultados, in Circulació d’àmfores al Mediterranioccidental, pp. 283-291.
Tronchetti 1996 = C. Tronchetti, in EAA, Suppl. 1971-1994, s.v. Sardinia, Roma, 1996, pp.501-504.
Valenza 1991 = N. Valenza Mele, Ricerche nella Brettia-Nocera Terinese. Risultati degli scavi eipotesi di lavoro, Napoli, 1991.
Vallat 1987 = J. P. Vallat, Structures agraires en Italie centro-méridionale. Cadastres et paysagesruraux, Rome, 1987.
Vallat 2001 = J. P. Vallat, L’économie rurale de la Campanie romaine, in Lo Cascio - StorchiMarino 2001, pp. 583-589.
Van der Mersch 1994 = Ch. Van der Mersch, Vins et amphores de Grande Grèce et de Sicile.ive-iiie s. avant J.-C., Naples, 1994.
120 clementina panella
Van der Mersch 2001 = Ch. Van der Mersch, Au source du vin romain, dans le Latium et laCampania à l’époque médio-républicaine, «Ostraka», 10, 2001, pp. 157-206.
Vegas 1987 = M. Vegas, Karthago. Stratigraphische Untersuchungen 1985: Die Keramik aus derpunischen Sector-Strasse, «Römische Mitteilungen», 94, 1987, pp. 351-412.
Vermeulen et alii 2009 = F. Vermeulen et alii, Investigating the impact of Roman urbanisationon the landscape of Potenza Valley: A Report on Fieldwork in 2007, «Bulletin Antieke Beschaving.Annual Papers on Classical Archaeology», 84, 2009, p. 85 sgg.
ViAnt ii = El vi a la Antiguitat: economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental, ii ColloquiInternacional d’Arqueologia Romana (Badalona, 6-9 de maig de 1998), Actes, Badalona, 1998.
Vidal - Magnol 1983 = M. Vidal, J. P. Magnol, Les inscriptions peintes en caractères ibériques deVieille-Toulouse (Haute-Garonne), «Revue Archéologique de Narbonnaise», 16, 1983, pp. 1-28.
Viola 1885 = L. Viola, Taranto. Note del prof. Luigi Viola sopra nuove scoperte epigrafiche avve-nute in Taranto e nel suo territorio, «Notizie degli Scavi di Antichità», 1885, pp. 258-288.
Virlouvet 1985 = C. Virlouvet, Famines et émeutes à Rome des origines de la République à lamort de Néron, Rome, 1985.
Virlouvet 2003 = C. Virlouvet, L’approvisionnément de Rome en denrées alimentaires de la Ré-publique au Haute-Empire, in Nourrir les cités de la Méditerranée, eds. B. Marin, C. Virlouvet,Paris, 2003, pp. 61-82.
Vivre, produire et échanger = Vivre, produire et échanger: reflets méditerranéens. Mélanges offerts à Bernard Liou, textes rassemblés par L. Rivet et M. Sciallano, Montagnac, 2002.
Vitali 2007 = Le fornaci e le anfore di Albinia. Primi dati su produzioni e scambi dalla costa tirreni-ca al mondo gallico, Atti del Seminario Internazionale di Ravenna (6-7 maggio 2006), ed. D. Vitali,Bologna, 2007.
Vitali - Laubenheimer 2004 = D. Vitali, F. Laubenheimer, Albinia-Torre Saline (prov. Gros-seto): il complesso produttivo con fornaci (ii-i sec. a.C. / i sec. d. C.), «Mélanges de l’École fran-çaise de Rome. Antiquité», 116, 1, 2004, pp. 591-604.
Vitali - Laubenheimer - Benquet 2005 = D. Vitali, F. Laubenheimer, L. Benquet, Albi-nia (prov. de Grosseto), «Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité», 117, 1, 2005, pp.282-299.
Vitali - Laubenheimer - Benquet 2007 = D. Vitali, F. Laubenheimer, L. Benquet, La produzione e il commercio del vino nell’Etruria romana. Le fornaci di Albinia (Orbetello, Gr), in Archeologia della vite e del vino in Etruria, Atti del Convegno Internazionale di studi (Scansano, 9-10 settembre 2005), Siena, 2007, pp. 191-200.
Vivar 2004 = G. Vivar, El transporte de redistribución en el nordeste de la Península Ibérica en épocatardorepublicana: el ejemplo de los yacimientos de Illa Pedrosa y Cala Galladera, in Méditerranéeoccidentale antique, pp. 101-112.
Volpe 1990 = G. Volpe, La Daunia nell’età della romanizzazione. Paesaggio agrario, produzione,scambi, Bari, 1990.
Volpe 2000 = R. Volpe, Il suburbio, in Roma antica, ed. A. Giardina, Roma-Bari, 2000, pp. 183-210.
Volpe 2004 = R. Volpe, Lo sfruttamento agricolo e le costruzioni sul pianoro di Centocelle in età repubblicana, in Gioia - Volpe 2004, pp. 447-461.
Volpe 2008 = R. Volpe, Occupazione e utilizzazione del territorio in età romana, in Gioia 2008,pp. 259-272.
Volpe 2009 = R. Volpe, Vino, vigneti ed anfore in Roma repubblicana, in Suburbium ii, pp. 369-381.Volpe - Arnoldus 2005 = R. Volpe, A. Arnoldus Huyzendveld, Interpretazione dei dati
archeologici nella ricostruzione storica ed ambientale del paesaggio suburbano: l’area di Centocellee del suburbio sudorientale, in Roman villas around the Urbs, pp. 55-64.
Wolf 1986 = S. R. Wolff, Carthage and the Mediterranean. Imported amphoras from the Puniccommercial harbour, in Carthage ix, Actes du Congrès international sur Carthage, 4 (Trois-Riviè-res, 10-13 octobre 1984), «Cahiers des Études Anciennes», 19, 1986, pp. 135-153.
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 121
Yntema 2006 = D. G. Yntema, The Birth of a Roman Southern Italy: a Case Study. Ancient writ-ten sources and archaeological evidence on the early Roman phase in the Salento, southern Italy (3rd-1st century BC), «Bulletin Antieke Beschaving. Annual Papers on Classical Archaeology», 81,2006, pp. 91-133.
Zaccaria 1989 = C. Zaccaria, Per una prosopografia dei personaggi menzionati sui bolli delle anfore romane dell’Italia nordorientale, in arse, pp. 469-488.
Zaccaria - Župan©i© 1993 = C. Zaccaria, A. Župan©i©, I bolli laterizi nel territorio di Terge-ste romana, in I laterizi di età romana nell’area nordadriatica, ed. C. Zaccaria, Roma, 1993, pp.135-178.
Zevi 1995 = F. Zevi, Personaggi della Pompei sillana, «Papers of British School at Rome», 63,1995, pp. 1-24.
Zevi 1996 = F. Zevi, Sulle fasi più antiche di Ostia, in ‘Roman Ostia’ revisited. Archaeological andhistorical papers in memory of Russell Meiggs, eds. A. Gallina Zevi, A. Claridge, Roma, 1996,pp. 68-89.
Zevi 2002 = F. Zevi, Appunti per una storia di Ostia repubblicana, «Mélanges de l’École fran-çaise de Rome. Antiquité», 114, 2002, pp. 13-58.
Zevi 2004 = F. Zevi, Inquadramento storico relativo ai porti di Roma, in Le strutture dei porti e degliapprodi antichi, Atti del ii Seminario anser (Roma-Ostia antica, 16-17 aprile 2004), eds. A. GallinaZevi, R. Turchetti, Soveria Mannelli, 2004, pp. 211-219.
Zevi 2005 = F. Zevi, Considerazioni finali, in Atti del quarantaquattresimo convegno di studi sullaMagna Grecia (Taranto 24-28 settembre 2004), Taranto, 2005, pp. 801-826.
Zifferero et alii 2009 = A. Zifferero et alii, Un sito artigianale con anfore da trasporto Py 3B aMarsiliana d’Albegna (Manciano, Gr), «Officina Etruscologia», 1, 2009, pp. 101-128.
Abstract
Tre sono i principali temi trattati in quest’articolo che prende spunto dalla recente pubblica-zione delle ricerche effettuate nel suburbio di Roma, spettanti ad un periodo compreso tra ilv e il i secolo a.C. (Suburbium ii).
Il primo tema riguarda la cultura materiale della media e tarda- repubblica, così come essapuò essere ricostruita in base a due indicatori: anfore (grecoitaliche, Dressel 1, Lamboglia 2) eceramica fine a vernice nera (atelier des petites estampilles, Campana A, Campana B etrusca,Campana B di Cales). L’esame della documentazione disponibile ha consentito di delineare unquadro articolato della crescita nella lunga durata di queste classi di materiali, dei loro rapporticon i territori di origine, del significato in termini culturali ed economici della loro circola-zione.
Il secondo tema riguarda lo sfruttamento dei territori italici interessati da un’agricoltura in-tensiva (viticoltura, olivicoltura) aperta al mercato in età pre- e post-annibalica, utilizzando lefonti archeologiche, letterarie, epigrafiche nella ricostruzione dei diversi paesaggi agrari del-la penisola, ed affrontando le questioni dello sviluppo dei sistemi produttivi che hanno porta-to nello spazio di poche generazioni al decollo economico dell’Italia romana. Un’attenzioneparticolare è stata rivolta ai protagonisti di questa storia: i proprietari dei fundi, identificabilinelle classi dirigenti urbane e italiche, i commercianti, i consumatori.
Il terzo tema riguarda Roma e i suoi consumi. Le tracce dei vigneti rinvenute nel suburbioinsieme alla scarsa presenza di anfore registrata nelle stratigrafie urbane fanno presumere uncerto grado di autosufficienza della città nell’acquisizione di un bene di largo consumo qualeera il vino. Si discute perciò sul significato di tale fenomeno, individuando nello sviluppo diun’organizzazione fortemente strutturata del territorio suburbano già nel iii a.C. le condi-zioni che hanno assicurato i rifornimenti ad una popolazione consistente e in continuo au-mento.
122 clementina panella
Il saggio si chiude con tre Appendici che riguardano i problemi di definizione e cronologiadelle anfore grecoitaliche, le importazioni di Cartagine, lo sviluppo di un’agricoltura dagli al-ti rendimenti in area adriatica.
The starting point for this paper is a recent publication on Rome’s suburbia, dealing with a pe-riod between the 5th and 1st centuries BC. (Suburbium ii). The paper addresses three themes.
The first concerns the material culture in the Mid and Late Republic, as inferred throughtwo main indicators: amphorae (Graeco-Italic, Dressel 1, Lamboglia 2) and black glazed ware(atelier des petites estampilles, Campana A and B from Etruria and Cales). An analysis of avail-able data enables us to trace a general picture of the emergence and growth of these classesof materials, their origin and territorial distribution, and also of the weight and meaning oftheir commercial flows in economic and cultural terms.
The second theme deals with the exploitation of the italic regions specializing in intensiveagriculture (wine and olives) aimed at markets both before and after the Second Punic War,using epigrahic or archaeological sources for the reconstruction of the different agriculturalenvironments of the peninsula. It also deals with matters related to the emergence of the pro-duction system that enabled the economic take-off of Roman Italy within a few generations.Special attention is given to the leading actors: the owners of the fundi among the leading ur-ban and italic classes, and the merchants and consumers.
The third theme deals with the consumption in Rome. The traces of vineyards in the sub-urbia, and the scarcity of amphorae in urban stratigraphies lead us to think that there was acertain level of self sufficiency in commodities of common use such as wine. The meaning ofthis phenomenon is discussed, and it is suggested that the structured organization of the sub-urban territory that existed since the 3rd BC was able to provide for the needs of the rapidlygrowing population of the metropolis.
The paper ends with three Appendixes dealing with the questions of the identification andchronology of Graeco-Italic amphorae, the imports from Carthago, and the development ofhigh yield agriculture in the Adriatic region.
Roma, 10-1-2010
roma, il suburbio e l’italia in età medio- e tardo-repubblicana 123