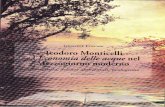L'Italia in frantumi e il problema del Mezzogiorno (Italy's Breakdown and the Problem of...
Transcript of L'Italia in frantumi e il problema del Mezzogiorno (Italy's Breakdown and the Problem of...
Se l’Italia si frantuma, dove va il Mezzogiorno?Riflessioni nella prospettiva della political economy.
Domenico Maddaloni*
In un suo recente lavoro Luciano Gallino ha impiegatola metafora dell’Italia in frantumi1 per evidenziare leconseguenze della globalizzazione economica,dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, delladeregolazione di mercato e rapporti di lavoro, dellaristrutturazione di garanzie e tutele sociali, deldecentramento delle competenze istituzionali, delcambiamento nel sistema politico, sul tessuto sociale delPaese. Un Paese, il nostro, che già vent’anni prima,allorché lo studioso piemontese ne esaminava la transizione“dal premoderno al neoindustriale”, gli era apparso segnatodall’ingovernabilità2 a causa della persistenza, in esso, diuna pluralità di formazioni economico sociali che nonandavano svanendo per effetto della modernizzazione e dellacrescita, ma che piuttosto tendevano a sovrapporsi e adintrecciarsi in forme sempre più articolate e complesse.Dunque, ciò che ancora alla fine degli anni ’80 appariva“ingovernabile”, ma pur sempre parte di un medesimocontesto sistemico, dotato di quei connotati minimi diinterdipendenza e di integrazione (di solidarietà, perdirla con Durkheim) che rendono un insieme di gruppi umaniuna società, sembra essere divenuto al volgere del secolo –se le parole hanno un senso condiviso – una realtàintimamente slegata, sul punto di subire la rottura di quei* Professore associato, Dipartimento di Sociologia e ScienzaPolitica, Università degli studi di Salerno. Per eventuali commenti:[email protected]. Ringrazio gli amici e colleghi, di svariateprovenienze disciplinari, che hanno letto precedenti versioni diquesto lavoro (con una menzione speciale per Paola De Vivo, GiuseppeGalasso, Lidia Greco, Aurelio Musi, Fiorenzo Parziale, MassimoPendenza, Francesco Pirone). Mia, ovviamente, rimane la responsabilitàper le opinioni qui espresse e per le procedure di analisi quiadottate.1 Cfr. L. Gallino, Italia in frantumi, Laterza, Bari, 2006.2 Cfr. L. Gallino, Dell’ingovernabilità. La società italiana tra premoderno eneoindustriale, Comunità, Torino, 1987.
1
rapporti che, per quanto deboli, sotto almeno alcuniprofili la rendono ancora identificabile come un’entitàunitaria.
Un contesto sociale, insomma, nel quale, assai più chealtrove tra i Paesi sviluppati, le spinte centrifugherischiano di prevalere su quelle centripete. Ed è opportunoosservare che il riferimento alla secessione, di continuominacciata dalla Lega Nord, è d’obbligo, ma è soltanto unaparte del problema3. La questione della crescita dellediseguaglianze tra i segmenti della società italiana èinfatti oggi al centro dell’attenzione, sia degli studiosiche si occupano di questa problematica, sia dell’opinionepubblica.
1. I sentieri del cambiamento4
Non c’è dubbio tuttavia che anche oggi, tra ledimensioni dell’ineguaglianza, quelle che si riferisconoalla diversità di percorsi e di condizioni dei contestilocali appaiano di straordinario rilievo per il nostroPaese: in primo luogo quella che nasce dall’opposizione di3 Basti pensare alla crescita dei divari tra i gruppi sociali,che sembra emergere dalle ricerche sui patrimoni, i redditi e iconsumi degli aggregati domestici, o anche da quelle sulla mobilitàsociale a lungo termine (il cui esempio paradigmatico nella sociologiaitaliana è forse il libro di Schizzerotto, a cura di, Vite ineguali.Diseguaglianze e corsi di vita nell’Italia contemporanea, Il mulino, Bologna, 2002),e che ha generato un dibattito sul declino dei ceti medi e lariduzione delle occasioni di mobilità sociale per i giovani. Da citareal riguardo anche i rapporti sul cambiamento sociale in Italia curatidall’Osservatorio del Nord Ovest. Nel terzo di essi, in particolare(L. Ricolfi, a cura di, Le tre società. E’ ancora possibile salvare l’unità dell’Italia?Italia 2006: III rapporto sul cambiamento sociale, Guerini e associati, Milano,2007), proprio a partire dalle analisi di Gallino citate in premessasi avanzano alcune considerazioni sulla divisione del nostro Paese intre “società”, quella “delle garanzie”, quella “del rischio” e quella“della forza”, ciascuna dotata di una specifica, benché non esclusiva,base territoriale (rispettivamente il Nord Ovest, il Nord Est-Centro,le regioni meridionali).4 In questa sezione riprendo i risultati di un’indagine sulmutamento delle strutture economiche nelle ripartizioni del Paese dicui ho discusso più estesamente in un mio precedente lavoro (D.Maddaloni, L’occupazione regolare non agricola e le diseguaglianze territoriali in Italia tra il1991 e il 2001, in E. Pugliese, a cura di, Nord e Sud. Rapporto IRPPS-CNR sulloStato sociale in Italia, Donzelli, Roma, 2006).
2
performance economiche, di condizioni sociali e diprospettive di sviluppo tra Centro Nord e Mezzogiorno. Undato, quest’ultimo, di lungo periodo nella storia enell’identità “di popolo” del nostro Paese5, ostinatamentesopravvissuto ad una stagione postbellica nella qualecomunque molto è cambiato nelle regioni del Sud, in terminidi livello e di qualità della vita, ed in cui la crescitaeconomica del Mezzogiorno ha tenuto il passo, almeno fino atempi recenti, con il ritmo impetuoso assunto da essa neicontesti del Centro e del Nord6.
In queste pagine mi propongo di affrontare laquestione delle diseguaglianze territoriali senza riguardoper l’analisi di breve periodo, quale spesso è quellaprodotta da agenzie come l’Istat, la Banca d’Italia o laSvimez, per cercare di riflettere sui fenomeni sottostantiagli andamenti dei principali indicatori dell’economia,dell’occupazione o delle condizioni sociali. Ciò con unriferimento temporale che risalga almeno al principio deglianni ’90, e cioè al momento in cui è apparsa evidente ladifficoltà complessiva dell’economia italiana nel tenere ilpasso della competizione internazionale di fronte allesfide, ed anche alle opportunità, richiamate in premessa.In particolare, considererò la questione dellediseguaglianze tra le regioni in una prospettiva di politicaleconomy, ovvero guardando alla struttura dell’occupazionenon soltanto in sé, ma anche in quanto rappresentativa dellastruttura del potere economico in Italia, e dunque in quantoespressione di una varietà di interessi sottostantiall’elaborazione ed all’attuazione delle politichepubbliche7.
5 Cfr. A. Schiavone, Italiani senza Italia. Storia e identità, Einaudi, Torino,1998, pp. 60-96; G. Galasso, Il Mezzogiorno da “questione”a “problema aperto”,Lacaita, Manduria, 2005, pp. 15-37.6 Cfr. A. Graziani, Mezzogiorno oggi, “Meridiana”, 1, 1987; alriguardo cfr. anche P. Sylos Labini, Scritti sul Mezzogiorno 1954-2002, a curadi G. Arena, Lacaita, Manduria, 2003.7 L’ipotesi presume che l’elettore sostenga la coalizione, ilpartito o il candidato che interviene in difesa degli interessieconomici suoi, del suo comparto di attività o della sua località diresidenza. Allo stesso modo, l’ipotesi presume che il decisorepolitico tenga conto della struttura degli interessi economici, sulversante sia del capitale che del lavoro, nel definire ed attuare lescelte pubbliche. Ma la ricerca sui gruppi di interesse e le politichepubbliche induce a ritenere ancora più ragionevole che questiinteressi risultino tanto meglio difesi quanto più le organizzazioni
3
A questo scopo ho impiegato i dati dei Censimentidell’industria, del commercio e dei servizi al 1991 ed al20018 per esaminare l’evoluzione dell’occupazione regolarenon agricola nelle ripartizioni NUTS-1 del Paese (NordOvest, Nord Est, Centro, Sud, Isole maggiori) nel corsodegli anni ‘90. In particolare, ho considerato l’ammontaree la distribuzione settoriale e territoriale degli addettialle unità locali delle imprese e delle istituzioni economiche, universosenza dubbio rappresentativo della porzione più importantedelle attività economiche9. In una prospettiva di politicaleconomy non ho considerato le variabili suindicate in sestesse, quali connotati distintivi del mercato del lavoro sul versante delladomanda, ma anche in quanto indicatori della presenza di interessisociali legittimi10 associati all’andamento dell’economia ingenerale e di uno specifico settore di attività o forma diorganizzazione economica in particolare. Quindi levariabili in questione vengono considerate anche qualiindicatori di influenza politica, nel senso di capacità diresistere alle decisioni politiche avverse in materiaeconomica e sociale, o di promuoverne di favorevoli, ed
ed i gruppi che li sostengono possono vantare un’ampia platea disoggetti coinvolti e potenzialmente mobilitabili (cfr. I. Regalia,Capire le politiche pubbliche, Il mulino, Bologna, 2001, pp. 316-365).8 In proposito è da notare che la mancanza di dati più recenti difonte analoga riduce l’ambito di validità dell’esercizio e delleriflessioni ad esso associate. Dove necessario, tuttavia, faròriferimento anche ai risultati di indagini statistiche più recenti(cfr. in particolare Svimez, Rapporto Svimez 2008 sull’economia del Mezzogiorno,Il mulino, Bologna, 2008), allo scopo di aggiornarne i risultati aglianni ’00 e corroborare le ipotesi interpretative da me avanzate.9 Nell’universo così definito infatti rientra anche l’economiaparzialmente sommersa nei comparti extragricoli di attività, checostituisce in realtà una quota preponderante dell’economia sommersa(G. Roma, L’economia sommersa, Laterza, Bari, 2001, pp. 62-90). 10 Con il termine “legittimità” intendo il riconoscimento, daparte dei soggetti che contribuiscono a individuarla, che nell’arenapolitica così definita l’attore x ha eguale diritto ad esistere; aconsiderare con ragionevolezza opportunità e vincoli, costi e beneficidei corsi di azione possibili in ciascun istante di tempo; e adadottare comportamenti che interferiscono con la soddisfazione deilegittimi interessi degli altri attori sociali presenti nella stessaarena. Questi comportamenti possono consistere in decisioni assunte inprima persona (ad esempio lo spostamento di un’attività da un luogo diproduzione ad un altro), o in richieste avanzate all’autorità politica(per esempio, circa uno sgravio fiscale) o ad altri attori (peresempio, circa gli orari di lavoro), o in decisioni circa le richiesteavanzate dalla prima o dai secondi.
4
eventualmente contrattare modifiche che producano unasuddivisione differente dei costi e dei benefici associatia tali decisioni, a livello locale o a livello nazionale11.L’ipotesi su cui si fondano i rapporti di indicazione quidefiniti è che, quanto più grandi le dimensioni del compartoeconomico/della ripartizione geografica, in rapporto aquelle degli altri comparti/delle altre ripartizioni – intermini di numerosità degli addetti alle imprese edistituzioni non agricole –, tanto maggiore la sua forzarelativa nella sequenza di conflitti e mediazioni politicheche conduce all’elaborazione ed all’attuazione di strategiee misure in campo economico e sociale. Filiere di attivitàche hanno, dietro di sé, un grande numero di attoridirettamente, e legittimamente, interessati al “buonandamento” delle attività in oggetto (attori sociali la cuirilevanza politica è qui sinteticamente rappresentata dagliaddetti alle unità locali delle imprese e delle istituzioniextragricole), avrebbero una maggiore probabilità dideterminare o quantomeno di condizionare le decisionipolitiche che più immediatamente le riguardano.
Dalla tabella 1 si ricava (punto 1.1) che nel periodoqui considerato, compreso tra i due Censimenti del 1991 edel 2001, la popolazione residente è stabile nel decenniosia nel suo ammontare assoluto (56,8 – 57,0 milioni diabitanti) che nella sua distribuzione territoriale. L’unicoincremento di qualche significato (+2,5% nel periodo) èconcentrato nelle regioni del Nord Est. Invece gli addettialle unità locali, ovvero l’occupazione regolare extragricola, hanel decennio un incremento di 1,4 milioni di unità,passando da 18,0 a 19,4, con una crescita dell’8,0% alivello nazionale. Qui l’aumento è riscontrabile in tuttele ripartizioni, pur distribuendosi inegualmente tra icontesti territoriali (punto 1.2). Anche l’andamento deitassi di occupazione può confermare il dato, beneficiandoin termini relativi più il Nord Est e il Centro, un po’meno il Nord Ovest e il Sud, e quasi per niente le Isole11 Ciò non implica che questi siano gli unici attori collettivirilevanti per la decisione – ad esempio, in un Paese in rapidoinvecchiamento l’importanza dei pensionati e delle organizzazioni cheli rappresentano non può certamente essere trascurata –, ma soltantoche l’analisi qui presentata delinea una rassegna delle forze che siagitano sullo scenario dell’economia reale, di certo assai importantesia per le c. d. “riforme istituzionali” che per le misure di politicaeconomica e sociale.
5
maggiori. E va ricordato che l’indice in questione siattesta su livelli compresi tra il 20% ed il 25% per le dueripartizioni meridionali, su livelli superiori al 35% perquelle centrosettentrionali.
Da simili dati si ricava la conclusione che nel corsodegli anni ’90 l’occupazione cresce di più laddove c’è giàpiù sviluppo (il Centro-Nord). Gli indici relativi alladistribuzione territoriale dell’occupazione regolare nonagricola mostrano ciò (cfr. sempre il punto 1.2). Pur inpresenza di un campo di variazione limitato, grazie – comesi vedrà – all’effetto di riequilibrio causato dalladistribuzione dell’occupazione pubblica tra i contestiterritoriali, la distanza tra il Centro-Nord e il Meridioneaumenta ulteriormente, per quanto ancora non di molto neglianni ‘90. Si prendano in considerazione le due ripartizionicollocate al vertice ed alla base della graduatoriaterritoriale sia nel 1991 che nel 2001, e cioè il Nord Este le Isole. E’ possibile constatare che il valoredell’indice di distribuzione territoriale degli interessisociali legittimi rappresentati dall’occupazione regolarenon agricola passa nel Nord Est da 124,2 a 125,6, nelleIsole invece da 67,8 a 65,2.
Ma questo è soltanto un livello più generale dianalisi del mutamento nelle strutture economiche dellesingole ripartizioni. In una prospettiva di political economy èopportuno, come si è detto, considerare i mutamenti neirapporti di forza tra specifiche costellazioni di interessi, che possonorisultare di grande rilievo dal punto di vistadell’influenza esercitata dagli interessi in questionenell’arena politica, in vista della determinazione edell’attuazione di strategie e misure economiche e sociali.A questo scopo ho distinto l’occupazione regolare nonagricola in 7 comparti: il sistema dell’edilizia, l’industriatradizionale, l’industria moderna, l’economia postindustriale12, il
12 L’”economia postindustriale” è un comparto definito a partiredalle nozioni più comuni di attività nel contesto delineatosi nellesocietà avanzate a partire dalla crisi del 1973, ed i cui effettisembrano perdurare ed approfondirsi nel tempo (cfr. K. Kumar, Le nuoveteorie del mondo contemporaneo. Dalla società postindustriale alla società postmoderna,Einaudi, Torino, 2000; C. Crouch, Sociologia dell’Europa occidentale, Ilmulino, Bologna, 2001). Rientrano dunque in questa definizionel’editoria, la pubblicità e le imprese di comunicazione, ma anche ilriciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti; le attività creditizie eassicurative ma anche quelle ricreative, culturali e sportive; i
6
sistema del welfare, il sistema politico, più un settore costituitoda attività economiche non altrimenti classificate13. Il prospetto 1riporta i settori ed i rami di attività che ricadono inciascuno dei comparti sopra individuati.
I risultati dell’elaborazione vengono sinteticamenteriportati nella tabella 2, che ricostruisce l’andamento1991-2001 dell’occupazione regolare extragricola nelleripartizioni geografiche per comparti economici. Guardandoalle cifre assolute (punti 2.1, 2.2, 2.3), la tabellaconsente di evidenziare in primo luogo l’enorme crescitadell’economia postindustriale (un milione di addetti in più) e,in secondo luogo, del sistema dell’edilizia (più 0,5 milioni),seguito a distanza dal sistema del welfare (più 0,3 milioni),che compensano ampiamente la flessione dell’industriatradizionale e delle altre attività e la stagnazioneriscontrata dall’industria moderna e dal sistema politico.Ma la tabella mostra anche (punto 2.4) come il dinamismodella struttura dell’occupazione nei comparti in ascesa siaimputabile assai largamente alle tre ripartizionicentrosettentrionali, che mostrano tassi di crescita ugualio superiori alla media del Paese. Un andamento opposto siriscontra a proposito delle due ripartizioni meridionali,che evidenziano una minore crescita dell’occupazione inquesti settori14. All’opposto, nel corso degli anni ’90 ilsettore dell’industria tradizionale sembra subire un autenticocrollo nelle ripartizioni centrosettentrionali, a fronte diuna flessione molto più contenuta in quelle meridionali.
trasporti a lunga distanza e le imprese turistiche ma anche le publicutilities; le attività di consulenza, compresa l’informatica, e la ricercae sviluppo (cfr. anche il prospetto 1). E’ opportuno ricordare che ilconcetto di “economia postindustriale” qui impiegato ha un’estensionepiù ampia di quello, adottato in svariate indagini sulla dinamicadell’occupazione nei Paesi membri dell’Unione Europea, di “economiadella conoscenza”, ed appare invece più vicino a quello di “societàdei servizi”.13 Si tratta di alcuni comparti dell’industria estrattiva, delcommercio all’ingrosso e al dettaglio, dei pubblici esercizi, deitrasporti non aerei. Per ragioni inerenti al processo di costruzionedei dati non è stato possibile separare, all’interno del compartoresiduale in questione, le attività della grande distribuzionecommerciale, riconducibili in sostanza all’economia postindustriale, equelle relative ai trasporti collettivi, che si sarebbe potutoagevolmente collocare nel sistema del welfare.14 L’unica eccezione al riguardo è costituita dal sistema delwelfare, per il quale si riscontra una crescita inferiore alla mediaal Centro ed una invece superiore nelle Isole maggiori.
7
Una redistribuzione dell’occupazione più trasversalerispetto alla variabile geografica si verifica invece perl’industria moderna, che si contrae nel Nord Ovest e nelleIsole ed aumenta invece con grande impeto nel Nord Est.Quanto invece alla distribuzione settoriale (punto 2.5) eda quella territoriale (punto 2.6) dell’occupazione,colpisce il rafforzarsi della specializzazionedell’economia regolare nelle ripartizioni meridionali neicomparti welfare e sistema politico. Ciò proprio mentre il NordOvest si qualifica, nonostante le perdite subite in questosettore, come centro dell’industria moderna e in misuraminore dell’economia postindustriale, il Nord Est confermala sua specializzazione nei comparti dell’industria ingenerale – a ragione dunque può essere ritenuto il “motore”produttivo dell’economia nazionale –, ed il Centro riesce acompensare il declino dell’industria tradizionale con unanuova dinamica del comparto postindustriale.
2. La deriva dei territori
A questo punto è possibile delineare un quadro disintesi. E’ possibile cioè interrogare i risultaticonseguiti dall’esercizio per ricavarne alcune osservazionipiù generali in merito al cambiamento dell’economia edell’occupazione nel nostro Paese, ed alle conseguenze diciò sulla configurazione degli interessi costituiti. Inquale maniera è possibile rappresentare la strutturadell’occupazione nelle ripartizioni territoriali? Qualisono state le sue principali direttrici di mutamento nelcorso degli anni ‘90? I cambiamenti intervenuti descrivonodei modelli distinti di mutamento economico e sociale? Comeciò contribuisce a plasmare gli scenari delle riformeistituzionali e delle politiche economiche e socialiitaliane?
Per quanto riguarda il primo quesito – “in quale maniera èpossibile rappresentare la struttura dell’occupazione nelle ripartizioniterritoriali?” – si può affermare che i risultatidell’esercizio tendono a confermare la validità delleinterpretazioni dualistiche dello sviluppo italiano. Latabella 3 rappresenta, in ordine decrescente, legraduatorie dei valori riportati al 2001 e al 1991 dagli
8
indici di distribuzione territoriale dell’occupazioneregolare non agricola per comparto di attività e perripartizione geografica, e quindi, in linea con l’ipotesidi political economy in precedenza delineata, dell’influenza diciascun settore sulla politica nazionale. Essendo icomparti considerati nell’esercizio 7 e le ripartizioni 5,ne risulta una graduatoria articolata in 35 posizionirelative alle attività presenti nel comparto a della ripartizione x.Al 2001 le prime 17 posizioni in classifica, ad eccezionedell’occupazione in politica nella ripartizione Isole (al12° posto) appartengono ad attività che si svolgono nelleripartizioni centrosettentrionali. Non soltanto, ma nel2001 otto dei primi 11 posti si rivelano occupati daattività relative al Nord Ovest o al Nord Est, le eccezioniessendo i comparti politico e postindustriale del Centro.Al contrario, sia nel 1991 che nel 2001 gli ultimi 10 postiin classifica sono occupati da attività che si svolgono nelMezzogiorno continentale e nelle Isole.
L’unica porzione della graduatoria nella quale simescolano attività presenti al Sud, al Centro o al Nord èquella costituita dalle posizioni di rincalzo, tra il 18° eil 25° posto nella classifica relativa al 2001. In 6 casisu 8 esse si riferiscono all’occupazione nel comparto dellapolitica o nel sistema del welfare, che appaiono pertanto igeneratori di un effetto di perequazione tra le condizionisociali e del mercato del lavoro nelle ripartizioni. Ora,come è noto, nei due comparti suindicati gran parte delladomanda di lavoro regolare è espressa dalle istituzionipubbliche, che definiscono il “circuito secondario”dell’economia15. Si può pensare tutto il male possibile
15 Il “circuito secondario” dell’economia è formato dal settorepubblico e da quello no profit, nella misura in cui non producono, ma siappropriano di una quota del prodotto interno e la redistribuiscono(cfr. E. Wolleb – G. Wolleb, Divari regionali e dualismo economico, Prodotto ereddito disponibile nelle regioni italiane nell’ultimo ventennio, Il mulino, Bologna,1990). Ciò non significa che i settori pubblico e no profit, correlatiin larga misura con i comparti “del welfare” e “politico” esaminatinel paragrafo 1, fungano da parassiti della “buona” economia fondatasull’interesse materiale dei privati, da ostacoli che la societàcivile si ritrova lungo la strada della crescita “virtuosa”. Da unaparte, infatti, le attività di redistribuzione, i settori pubblico ono profit e la produzione di servizi hanno a che vedere con i fini di unprocesso di sviluppo, ovvero con la possibilità di aumentare illivello e la qualità della vita del maggior numero di persone, e conessi la libertà, per il singolo, di scegliere lo stile di vita più
9
delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici nelnostro Paese, ed a giusta ragione, se si guarda soprattuttoall’inefficienza ed all’inefficacia del funzionamento diquesti, o agli effetti di distorsione da questi indottisulle preferenze e sui comportamenti degli attori sociali,dagli imprenditori “assistiti” alle persone in cerca dilavoro16. Ma sembra giusto anche notare che nel secondodopoguerra la crescita dell’occupazione nel settorepubblico – e quindi in primo luogo nei comparti dellapolitica e del welfare – ha prodotto, tanto in manieradiretta che indiretta, e pur senza alterare la strutturadelle diseguaglianze, un avvicinamento tra le condizionimedie di vita e di lavoro delle regioni meridionali einsulari e quelle del Centro-Nord. Fungendo, insieme conalcune delle “altre attività” – ad esempio il commercio aldettaglio –, da “spugna” di una parte della disoccupazionedell’Italia meridionale, l’occupazione nel settore pubblicoavrebbe garantito un equilibrio di lungo periodo, nonsoltanto al livello locale ma anche nel sistema nazionalenel suo insieme, in particolare ampliando gli spazi diinserimento e di mobilità sociale per i ceti medi17. Altempo stesso ciò avrebbe garantito, in nome di unmeridionalismo “risarcitorio”18 o “sudismo”, gli assettieconomici, sociali e istituzionali locali e gli equilibripolitici nazionali19. Questa situazione, a partire daglianni ’90, viene messa in crisi dai vincoli sempre piùstringenti imposti al bilancio pubblico dalla congiuntura
consono alla propria idea di “star bene”. Dall’altra questi fenomenicostituiscono un mezzo indispensabile allo sviluppo medesimo, nelsenso che forniscono alla crescita economica, effetto aggregato dellacrescita del fatturato e delle dimensioni delle attività del settoreprivato, una serie di input non sostituibili attraverso l’iniziativa“libera e spontanea” degli individui (A. K. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perchènon c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano, 2000, pp. 40-58 e 116-149).16 Per il mercato del lavoro un riferimento sociologico classicoin questo senso è al volume di A. Accornero e F. Carmignani, I paradossidella disoccupazione, Il mulino, Bologna, 1986.17 A questo riguardo il riferimento classico nel dibattitosociologico è il saggio di A. Pizzorno, I ceti medi nei meccanismi del consenso,in Id., I soggetti del pluralismo. Classi, partiti, sindacati, Il mulino, Bologna,1980.18 L. Cafagna, Nord e Sud. Non fare a pezzi l’unità d’Italia, Marsilio, Venezia,1994, pp. 50-61.19 F. Barbagallo, La modernità squilibrata del Mezzogiorno d’Italia, Einaudi,Torino, 1994.
10
internazionale, un fattore questo che finisce per gravarein maniera diversificata sulle ripartizioni, colpendo piùduramente l’economia, l’occupazione e la società nelMezzogiorno continentale.
Passando a considerare la seconda domanda – “quali sonostate le principali direttrici di mutamento della struttura dell’occupazione nelcorso degli anni ‘90?” – è possibile osservare che una rispostapiù generale ad essa emerge dal paragrafo precedente.Stando ai dati qui presi in esame, nel decennio aumental’occupazione regolare nell’economia postindustriale, nelsistema dell’edilizia e nel sistema del welfare, in questoordine di grandezze assolute; si mantiene stabilel’occupazione regolare nell’industria moderna e nel sistemapolitico; si riduce l’occupazione regolare nell’industriatradizionale e nel comparto residuale di attività. Perdipiùciò avviene nel contesto di una diffusa, e crescente,parcellizzazione della struttura dell’occupazione, con (a)l’arresto dell’espansione delle istituzioni pubbliche, (b)la drastica riduzione della presenza delle grandi imprese,in particolare per il notevole ridimensionamento delsistema delle partecipazioni statali, e (c) la scarsavolontà delle medie e piccole imprese di procedere verso unaumento di complessità strutturale20. Il quadro che nerisulta è di certo quello di una transizione avanzata alla“società dei servizi”, ma anche in questo caso“all’italiana”, che fa ancora più risaltare le battuted’arresto nel processo di sviluppo dell’apparatoindustriale, e dunque l’incipiente (nel periodo inquestione) perdita di competitività del sistema produttivodel nostro Paese nell’economia globale21.
Ma la risposta alla domanda precedente può risultaremeglio articolata se si introduce nell’analisi un’adeguataconsiderazione per la dimensione territoriale. In questaprospettiva, la tabella 4, rivolta ad un confronto 1991-2001 tra gli indici di distribuzione settorialedell’occupazione regolare non agricola a livello diripartizione, può consentire di evidenziare una notevole20 Rimando qui al mio saggio già citato su L’occupazione regolare nonagricola e le diseguaglianze territoriali in Italia tra il 1991 e il 2001, nel quale laquestione è affrontata in maniera più estesa.21 Fenomeno segnalato, per gli anni ’90 e per gli anni ’00, daldeclino della quota dell’Italia sul totale delle esportazionimondiali, o dalla crescita della produttività del lavoro, inferiore aquella di quasi tutti i Paesi dell’Europa occidentale.
11
diversificazione dei sentieri del mutamento economico tra isingoli contesti territoriali. In particolare, il NordOvest sta virando dalla dominanza industriale a un’egemoniapiù limitata all’industria moderna ma con una presenzasempre più consistente per il postindustriale (punto 4.1),mentre il Nord Est si rivela, con l’avanzata propriodell’industria moderna, il nuovo motore produttivo delPaese ma con un ruolo di grande rilievo anche per ilsistema dell’edilizia (punto 4.2). Il Centro appare ancoralegato ai due comparti “secondari” in precedenza definiti,il sistema politico e il sistema del welfare, con unabattuta d’arresto per l’economia postindustriale che purrimane forte (punto 4.3). La ripartizione con il modellopiù eterogeneo è il Meridione, con l’edilizia e il sistemapolitico in flessione ma ancora “pesanti”, l’industriatradizionale in crescita e un ruolo di rilievo anche per ilsistema del welfare (punto 4.4). Infine, cambiamentialtrettanto rilevanti si possono notare a proposito delleIsole, ma in questa circostanza un ruolo di punta èriservato ai due comparti di attività “secondari”, lapolitica e il welfare, mentre tra i “primari” una funzionedi rilievo ma in profondo declino, nel corso degli anni’90, spetta ancora al sistema dell’edilizia (punto 4.5). Latransizione avanzata alla società dei servizi, di cui siparlava in precedenza, è dunque ben presente nella PrimaItalia, che – disfacendosi di funzioni obsolete dal puntodi vista del big business – sembra avere associato a sé ilNord Est e alcune parti del Centro nel ruolo di motoreproduttivo, per quanto come si è visto in cerca di unanuova identità tra crisi dell’industria tradizionale,impasse dell’industria moderna e crescita squilibrata delsistema dell’edilizia. Questo modello ha qualche propagginenel Mezzogiorno continentale, pur se limitata all’industriadi trasformazione tradizionale (ed al sistemadell’edilizia). Invece la funzione di fulcro politico eamministrativo del Paese è ancora del Centro, e quindi diRoma, che sembra tuttavia essere in difficoltà nella corsaper restare al passo con i sistemi urbani del Nord inquanto sede di un potere economico non limitato al“circuito secondario” dell’economia. Con qualche parzialeeccezione locale, concentrata come è noto soprattutto nelleregioni sottopopolate dell’Abruzzo, del Molise, della
12
Basilicata e della Sardegna22, l’Italia del Sud è tagliatafuori da questo processo di riallocazione delle attività edel potere economico a queste associato, e con riferimentoal big business comincia a scontare, nel periodo inquestione, una perdita di autonomia23 che ne sottolineal’esclusione dalle direttrici più importanti del mutamentostrutturale.
In conclusione, i risultati dell’analisi paionoinnanzitutto sostenere l’ipotesi che a partire dagli anni’90 si sia avviato un sostanziale riallineamento dellastruttura dell’occupazione lungo le linee di un nuovodualismo, che sta concentrando il potere economico dellegrandi imprese del settore privato, e l’occupazionerelativa, in pochi sistemi urbani del Nord Ovest e del NordEst. In secondo luogo, questo dualismo fa di gran parte,pur se non di tutte, le ripartizioni in oggettoun’estensione produttiva funzionale alla sua stabilità edalla sua riproduzione nel nuovo contesto economico globale,con propaggini nell’Italia centrale e nel Meridione masostanzialmente limitate all’industria tradizionale. Interzo luogo, esso tende ad emarginare, probabilmente,svariati contesti locali anche nel Centro-Nord – l’”osso”,la Liguria, il Lazio –, colpiti sia dalla crisi dicompetitività che negli anni ’90 già attraversa l’industriatradizionale ed alcuni settori di quella moderna (inparticolare l’automobile), sia dai vincoli al bilanciopubblico che impediscono di sostenere ulteriormente icomparti di attività e le singole iniziative ad essolegate, nell’industria pubblica, drasticamenteridimensionata, e nel sistema dell’edilizia. In quarto
22 A proposito dello sviluppo dell'Abruzzo e del suo dipenderesoprattutto dal depauperamento delle risorse umane locali dovuto aifenomeni migratori, cfr. le considerazioni a più riprese avanzate daGiuseppe Galasso nel suo Il Mezzogiorno da “questione” a “problema aperto”, cit.23 Dato a più riprese documentato, e denunciato, dagli studiosiche hanno continuato a muoversi nella prospettiva del meridionalismo:cfr. per tutti il già citato lavoro di G. Galasso, Il Mezzogiorno da“questione” a “problema aperto”. In questa prospettiva si può ritenereemblematico il caso della città di Napoli, che ha visto nel corsodegli anni ’90 la scomparsa di tutti i maggiori centri di potereeconomico non dipendenti dall’esterno (l’Isveimer, il Banco diNapoli, la SME) ed anche di alcuni tra i maggiori nodi della rete delpotere economico in Italia (l’Ilva, l’Olivetti). Perfino il maggiorequotidiano della città, “Il mattino”, è dai primi anni ’90 di proprietàdi gruppi industriali ad essa estranei.
13
luogo, queste tendenze di mutamento strutturale lascianoancora al Centro le più rilevanti funzioni di direzionepolitico-amministrativa concernenti gli apparati pubblici,e le consistenti quote di occupazione a ciò legate, ma lacrisi di legittimità di queste funzioni ed apparati sembraaggravarsi24, il che può essere interpretato comeindicatore di una crescente tensione tra la “sferaprimaria” e i “circuiti secondari”. Infine, il nuovodualismo esclude dallo sviluppo italiano parte del Sud (inparticolare la “polpa” delle aree metropolitane) e leIsole, regioni lasciate a baloccarsi con ipotesi dicrescita o dell’industria locale, e come si è visto conqualche successo, o dell’economia postindustriale – glianni ’90 vedono l’ascesa della retorica dello sviluppoturistico “per il riscatto del Mezzogiorno” –, conriscontri invece assai minori.
Tutto ciò mentre si intensifica la competizioneeconomica globale, che perdipiù a partire dagli anni ’90 vaaffrontata senza i paracadute in cui da tempo si riassumonola politica di sviluppo, economica e industriale del nostroPaese. La svalutazione competitiva è impossibile perché nelperiodo in questione la valuta nazionale è ormai pienamenteancorata al Sistema Monetario Europeo, in vista dellacreazione della moneta unica. La crescita del debitopubblico è impossibile sia per l’obbligata adesionedell’Italia al processo di Maastricht, sia per la vigilanzaesercitata dai mercati finanziari globali. E una nuovapolitica di sviluppo, orientata che sia in sensoneokeynesiano, neolistiano, neosocialista, non vienetentata. Errori di valutazione del ceto imprenditoriale edella classe politica, e carenza di risorse appropriabilidal settore pubblico nel contesto di una crisi sempre piùprofonda della sua legittimità ad esistere ed operare,concorrono ad impedire un simile sbocco. In sintesi,dunque, stando ai dati nel corso degli anni ’90 il nuovodualismo produce una deriva dei territori che, nonostante lastagione della “nuova programmazione”, non sembra trovarepiù nella politica opportunità di riequilibrio o dicompensazione.
24 Come è evidenziato dal successo elettorale dei partiti“antisistema”, dalla frequente presenza di “impolitici” (Ciampi,Berlusconi, Dini, Prodi) quali leaders governativi e dai frequentitentativi di “riforma istituzionale”.
14
3. Scenari politici per il presente e per il futuro
Con ciò giungiamo finalmente all’ultima tra le domandeposte in precedenza: “come ciò contribuisce a plasmare gli scenari dieconomia politica delle riforme istituzionali e delle politiche economiche esociali italiane?”. Prima di rispondere ad essa, è doverosopremettere innanzitutto che delineare potenziali scenaripolitici a partire dalla struttura degli interessimateriali non implica negare la rilevanza di linee didivisione o di ricomposizione delle political constituenciesfondate su valori, principi, ideali. Come è noto, i fattoriin questione assumono una grande importanza anche nelnostro Paese, la cui storia politica recente è apparsaprofondamente segnata dalla presenza del Vaticano e dalla“questione cattolica”. Allo stesso modo, in una società cheinizia a divenire multietnica senza avere mai del tuttosuperato i particolarismi regionali, il tema dell’identitàculturale della nazione, dei suoi confini “etnici”, epersino “razziali”, può divenire – come la cronaca diquesto 2008 sta ampiamente mostrando – fondamento didinamiche politiche non riconducibili alla configurazionedegli interessi che scaturiscono dalla distribuzioneterritoriale e settoriale dell’occupazione.
Inoltre, occorre anche ricordare che la deriva deiterritori di cui si parlava in precedenza non è l’unicofenomeno che interviene a cambiare la struttura degliinteressi. Accanto ad esso è opportuno collocare lacrescente rilevanza delle rendite finanziarie, emonopolistiche in generale, sui profitti derivanti dainvestimenti produttivi nell’economia “reale” ed in mercati“aperti”, fenomeno tipico dei periodi di declino nei ciclieconomici di lungo periodo25. Ancora più noto è il divariocrescente che si riscontra nel mercato del lavoropostfordista tra attività qualificate e lavori nonqualificati, e tra core workers e lavoratori precari26. Nelnostro Paese sembra che ciò finisca per rendere più25 Cfr. G. Arrighi, Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostrotempo, Il saggiatore, Milano, 1996.26 Cfr. D. Cohen, Ricchezza del mondo, povertà delle nazioni, Comunità,Milano, 1999; L. Gallino, Globalizzazione e diseguaglianze, Laterza, Bari,2000.
15
stridenti i conflitti spaziali e sociali intornoall’allocazione delle risorse: tra settori protetti e nonprotetti dalla concorrenza; tra capitale e lavoro; traknowledge workers e lavoratori non qualificati; tra occupatistabili e lavoratori precari; tra la sfera primaria equella secondaria del sistema economico; ed infine anchetra Nord, con parti di Centro, “laborioso” e Sud, con partidi Centro, “parassita”. Le vicende economiche, sociali,politiche degli anni ’90 rendono le parti deboli neiconflitti in questione ancora più deboli, aumentando letendenze all’entropia sociale e sistemica presenti nella societàitaliana27. E riducono anche i margini di mediazione e diutile compromesso: il che spiega la fortuna della metaforacitata in premessa, dell’Italia come di un corpo socialeche sembra andare in frantumi; e la sensazione di smarritarassegnazione con la quale buona parte dell’opinionepubblica sembra convivere con questa percezione28.
Le premesse di cui sopra definiscono i limiti divalidità di una riflessione sugli scenari più plausibilidelle riforme istituzionali e delle politiche economiche esociali condotta sulla sola base dell’analisi dellediseguaglianze territoriali nella struttura degli interessimateriali. Ma è anche da sottolineare che una simileconfigurazione è parte essenziale della struttura socialeitaliana29; e che senza un’adeguata considerazione di essanon è possibile produrre delle analisi ben fondate inmerito al mutamento economico e sociale nel nostro Paese edelle riflessioni ben argomentate riguardo alle sue futureprospettive di sviluppo.
Ciò premesso, dunque, quale tra i conflitti elencatinelle premesse può risultare la causa principale di unmutamento profondo degli assetti istituzionali, politici,sociali del Paese? A mio parere, soltanto il contrasto traNord(-Centro) e (Centro-)Sud ha queste potenzialitàeversive. Infatti in tutti gli altri “campi di battaglia” icontendenti si rivelano comunque legati da consolidati27 Cfr. A. Bagnasco, L’Italia in tempi di cambiamento politico, Il mulino, Bologna, 1996.28 Cfr. A. Schiavone, Italiani senza Italia, cit., pp. 3-20. Di“incapacità simmetriche” parla invece A. Scotto di Luzio, Napoli dei moltitradimenti, Il mulino, Bologna, 2008, pp. 95-96.29 Cfr. M. Paci, La struttura sociale italiana. Costanti storiche e trasformazionirecenti, Il mulino, Bologna, 1982; G. Galasso, Il Mezzogiorno da “questione” a“problema aperto”, Lacaita, Manduria, 2005.
16
vincoli sistemici: dopotutto, è Marx a notarlo, non ci puòessere capitale in assenza di lavoro salariato; non si puòfare a meno di almeno un po’ di Stato, osserva Bentham; leferrovie, o la televisione commerciale, vendono servizi adindustrie pienamente coinvolte nella competizione globale;e anche calciatori, stilisti e ballerine hanno necessità diguardie del corpo, cameriere ed autisti. I vincolisistemici risultano invece alquanto indeboliti se li siosserva dal punto di vista territoriale. Il processo diunificazione economica dell’Europa, e ancor più laglobalizzazione, paiono avere incrinato in profondità ilcircuito economico che faceva del Meridione un mercato disbocco per i prodotti dell’industria delle regionisviluppate del Centro-Nord, costituendo dunque una baseimportante per il processo di accumulazione, di crescita edi sviluppo in queste regioni30. Tutto ciò in cambio di unpo’ di trasferimenti diretti o indiretti, in forma diindennità di disoccupazione, di pensioni di invalidità, dilavori pubblici, di consulenze professionali, di posti dilavoro nel settore pubblico o nelle grandi industrie apartecipazione statale o sovvenzionate dallo Stato:talvolta occupazione regolare e davvero socialmente utile,talvolta sinecura, talvolta condivisibile assistenza,talvolta criticabile sussidio, ma quasi sempre con modalitàfamilistiche o clientelari di regolazione che conducevano,e tuttora conducono, alla costituzione di fortuneeconomiche notevoli nello scambio tra affari e politica. Maa partire dalla metà degli anni ’80 i costi deitrasferimenti cominciano a superare i benefici31: inassenza di ostacoli alla penetrazione commerciale delleimprese straniere, i sussidiati meridionali comprano semprepiù spesso merci di provenienza non nazionale, ovvero noncentrosettentrionale32. E poiché
30 Cfr. A. Bagnasco, Tre Italie. La problematica territoriale nello sviluppo italiano,Il mulino, Bologna, 197, pp. 33-111.31 Vi è una singolare coincidenza temporale tra la firma dell’AttoUnico Europeo, nel 1986, e l’elezione del primo rappresentante inParlamento della Lega Nord (allora ancora soltanto Lombarda), cheavviene nel 1987.32 Vale forse la pena di notare che, nel dibattito politico sullafinanziaria 2005, l’argomento più usato dagli analisti economicicontro la riduzione governativa dell’Irpef si riferiva al fatto chel’ipotetico rilancio dei consumi sarebbe andato largamente a beneficiodelle importazioni.
17
l’appropriazione/redistribuzione a favore delle “regionidepresse” si verifica attraverso i medesimi meccanismi diappropriazione/redistribuzione a favore delle istituzioni edelle imprese pubbliche, la polemica contro il Meridioneparassita si salda a quella contro Roma ladrona e lo Statoche opprime cinicamente gli operosi cittadini delle regionisviluppate33. E’ vero che, nel corso degli anni ’90, edancor più nel corso di questo decennio, si è in parteriattivato il secondo dei circuiti che connettevano lasocietà meridionale all’economia del Nord, quello basatosulla mobilità territoriale della forza lavoro34. Ma, come si è detto,sia negli anni ’90 che nel decennio in corso l’effettocomplessivo di simili mutamenti si rivela ancora modesto, eperdipiù – dal punto di vista dei datori di lavoro delleregioni sviluppate – la manodopera proveniente dalMezzogiorno, in particolare quella con scarsaqualificazione, può essere almeno parzialmente sostituitadagli immigrati extracomunitari, con minori aspettative eminori diritti.
Ed ecco che il quadro comincia a comporsi. Nel 2001 lacoalizione di centrosinistra allora al governo realizza,con la riforma del titolo V della Costituzione, ciò chedefinisce federalismo “solidale”, avviando lo spostamentodelle risorse e delle competenze del settore pubblico dallivello centrale alle autonomie territoriali. Ilcentrodestra, proseguendo l’opera, una volta al governopropone le gabbie salariali e la “devoluzione” alle Regionidi ulteriori competenze statali in materia di welfare e disicurezza, per poi concentrarsi, nella legislatura che si èaperta con le elezioni del 2008, sulla questione delfederalismo fiscale, e quindi sul decentramento per viaordinaria di risorse e competenze pubbliche. Non importaqui che le proposte in oggetto vengano effettivamenterealizzate, ed in quale misura: del resto, le pagine deiresoconti parlamentari su queste materie sono piene didiscorsi sull’opportunità di modifiche e correttivi afavore delle parti più arretrate del Paese. Ciò che conta è33 Cfr. A. Bonomi, Il rancore. Alle radici del malessere del Nord, Feltrinelli, Milano, 2008.34 Sul carattere strutturale di questo legame tra i sistemisociali del Centro Nord e del Sud Italia, cfr. A. Bagnasco, Tre Italie,cit., pp. 33-111. A proposito dei fenomeni migratori più recentipiuttosto eloquenti i dati presentati dalla Svimez nel già citatoRapporto Svimez 2008 sull'economia del Mezzogiorno, pp. 169-193.
18
che durante gli anni ’90, ed ancor più nel decennio incorso, nel dibattito politico e nelle scelte di riforma edi governo si afferma una versione del “principio disussidiarietà” per la quale ogni “comunità locale” (Comune?Regione? Ripartizione territoriale?) è legittimata atenersi le sue risorse, salva la possibilità di una“perequazione” a favore di quelle più povere. Usando itermini impiegati a più riprese nei paragrafi precedenti,il senso dei cambiamenti già attuati e di quelli che paionoin itinere può essere scorto in un deciso riallineamento dellastruttura territoriale del potere economico nei circuitisecondari a quella emersa nel corso degli anni ’90 nellasfera primaria. I circuiti secondari dell’economia siriferiscono al sistema politico ed al sistema del welfare,e quindi anche agli unici ambiti di attività economica neiquali le regioni del Sud e delle Isole possono vantare deilivelli e delle condizioni di occupazione ancora oggiparagonabili a quelle delle regioni del Centro e del Nord.
Nel lungo periodo, e cioè una volta andati in pensionegli attuali occupati regolari permanenti a tempo pieno inquesti settori, i cui interessi consolidati per ragioni diopportunità politica non potranno che essere salvati35, nedovrebbe derivare un effetto aggregato di ulterioredivaricazione territoriale a beneficio della parte piùsviluppata del nostro Paese. Le regioni “laboriose” siriprendono, in nome di questa versione del principio disussidiarietà, ciò che è loro in termini di risorse, equindi di capacità di agire, di promuovere la crescitaeconomica e garantire nel contempo anche forme estese diprotezione sociale. Le regioni “parassite” finisconopunite, con una riduzione di trasferimenti diretti eindiretti che si ripercuote sul potere d’acquisto e sulladomanda aggregata locale, ma anche sugli standard diprotezione sociale. Nelle fantasie dei divulgatori delverbo neoclassico ciò si tradurrebbe in una riduzione deilivelli salariali (ma non dicono di quanto: del 20%? Del40%? Del 60%? Dell’80%?) che renderebbe appetibili gliinvestimenti al Sud e pertanto farebbe ripartire lacrescita e rilanciare l’occupazione. La realtà la vediamo
35 Poiché al momento in cui scrivo (autunno 2008) l’età media deidipendenti pubblici è stimata intorno ai 45-50 anni, e l’età dellapensione intorno ai 60-65, è possibile ritenere che il “lungo periodo”in questione sia un arco di tempo di circa 15-20 anni.
19
già oggi nelle periferie di Napoli, di Bari, di ReggioCalabria, di Catania o di Palermo, in cui il crollo delleaspettative di vita connesse all’economia legale si traducenell’esplosione della marginalità e della devianza, conconseguenze disastrose sulla capacità di attrarreinvestimenti dall’esterno. E nella migliore delle ipotesi èpossibile che si traduca nel ritorno dell’emigrazione versole regioni del Centro-Nord, di cui come si è detto sicominciano in effetti ad intravedere dei prodromi, generatisoprattutto dalle forze di lavoro meridionali in possessodi elevate competenze36. Quanto alla persistenzadell’industria tradizionale nel Sud degli anni ’90, unapersistenza non priva di episodi di autentico sviluppolocale, che la letteratura sui sistemi locali del lavoro haopportunamente segnalato37 e che ha generato aspettativedi rilancio economico dell’intero Meridione a partireproprio da questo comparto, è opportuno ricordare che, comeè noto, questa ha subito nel decennio in corso l’impattocrescente della concorrenza internazionale, di provenienzasia cinese che europea orientale, con esiti ancora incertima comunque apparentemente negativi38.
Guardiamo adesso a questo scenario dal punto di vistadelle classi dirigenti nelle due ripartizioni territoriali. Perquella del Nord (con porzioni di Centro), in cui come sipuò ricavare dall’analisi precedente è assai più rilevanteil peso degli interessi che emergono dai comparti privatidell’economia, i mutamenti suindicati possono consentire discaricare sulla solidarietà territoriale i costi sempre piùnotevoli della competizione internazionale, ma salvandoalmeno la coesione sociale e spaziale interna, e con essela legittimità a governare: per quanto su una baseterritoriale più ristretta, il che implica la rinuncia a36 Cfr. le parti del Rapporto Svimez 2008 sull’economia del Mezzogiorno giàcitate alla nota 34.37 Due tra gli ultimi esempi a questo riguardo: D. Farinella – F.Parziale, Processi di terziarizzazione e diseguaglianze socio-occupazionali in Italia:un’analisi a partire dal locale, Università degli studi di Messina, Centrointeruniversitario per le ricerche sulla Sociologia del diritto edelle istituzioni giuridiche, working paper n. 30, 2007; G. Viesti, acura di, Le sfide del cambiamento. I sistemi produttivi nell'Italia e nel Mezzogiorno d'oggi,Donzelli, Roma, 2007.38 Cfr. F. Pirro, Mezzogiorno e industria: tra passato e futuro, “L'Acropoli”,VII, 1, 2006. Di recente la crisi dei sistemi locali sembra essersipersino aggravata: cfr., per il caso della Basilicata, G. Visetti, Laregione chiusa con un fax, “La repubblica”, 25 novembre 2008.
20
svolgere un ruolo economico e politico di rilievo nelcontesto del sistema europeo e ancor più globale. La classedirigente del Sud, con qualche porzione di Centro, cheinvece fonda la propria supremazia sociale essenzialmentesul controllo della sfera secondaria dell’economia39,all’esterno della sua area di riferimento non sembraricavare nulla da tali processi, anzi sconta una radicaleriduzione della sua rilevanza nelle vicende politiche delPaese40. Ma, a parziale compensazione di ciò, all’internopuò ricavare un relativo beneficio dall’espansione dellafascia della povertà e dell’emarginazione conseguente allariduzione dei trasferimenti di reddito diretti e indirettidalle regioni avanzate a quelle arretrate. Come puredall’incremento dell’importanza relativa delle “sue”attività in un contesto nel quale si è assistito ad unprofondo declino della grande industria e gli investimentidall’estero si rivelano pressoché inesistenti41. Da unaparte, infatti, la “stagione delle riforme” che si è apertanegli anni ‘90 riduce le risorse a disposizione dellaclasse dirigente meridionale, colpita dai vincoli impostialla crescita della spesa pubblica, pur in parte compensatisia dal maggiore ricorso ai fondi strutturali dell’UnioneEuropea che dai maggiori margini di autonomia indotti daldecentramento delle competenze42; ma dall’altra ciò avvienein un contesto nel quale si riducono le opportunità dioccupazione stabile in numerosi segmenti del settoreprivato, e cioè proprio della “sfera primaria” che nondipende direttamente e/o totalmente dal potere pubblico che39 Come riconosciuto anche, implicitamente, da Fabrizio Barca inun suo recente accenno ad una political economy delle riformeistituzionali e delle politiche di sviluppo (Id., Un commento a Galasso:in tema di “progetto silenzioso” per il Mezzogiorno, “L'Acropoli”, IX, 2, 2008.40 Forse non è casuale che proprio a partire dal 1992-1993 laclasse politica del Sud perda, in termini di presenza nella compaginegovernativa, quella parità che aveva strappato grazie tanto allaretorica dell’arretratezza “sudista” che al suo rappresentareimportanti interessi economici, con ricadute significative in terminidi consenso elettorale e dunque di sostegno al governo 41 Stando agli ultimi rapporti della Svimez, il Mezzogiorno haattratto tra lo 0,6 e lo 0,7% del volume totale degli investimentidiretti esteri (IDE) nel nostro Paese, che peraltro attira, nel suoinsieme, una quota degli IDE minore della media europea – meno dellametà, in termini di rapporto tra IDE e PIL (cfr. al riguardo il giàcitato Rapporto Svimez 2008 sull’economia del Mezzogiorno).42 Cfr. A. La Spina, La politica per il Mezzogiorno, Il mulino, Bologna, 2003, pp. 351-372.
21
costituisce invece la risorsa principale della classedirigente del Sud.
Nello stesso tempo, il tendenziale declino degliinvestimenti pubblici in istruzione e formazione el’assenza di una politica di sostegno pubblico allamobilità territoriale dei cittadini residenti – in primoluogo di una politica della casa – si traducono, come si ènotato, in un'incipiente divaricazione degli orientamentidella popolazione meridionale nei confronti della mobilitàlavorativa e residenziale: semplificando drasticamente, ifigli delle classi elevate e dei ceti medi se ne vanno,quelli della piccola borghesia, delle classi lavoratrici edegli strati marginali restano: il che aumenta l’incidenzarelativa delle fasce deboli sul totale della popolazione, edel corpo elettorale, del Sud. Non soltanto, ma ladiffusione dei rapporti di lavoro atipici nei comparti delpubblico impiego, e l’estensione del principio della delegaad imprese private e no profit nella gestione dei servizipubblici, offrono alla classe dirigente del Mezzogiorno lapossibilità di mutare tattica senza cambiare la strategiaper l’acquisizione di consenso politico a breve termine. Sein passato ciò che veniva scambiato nel mercato politico,in cambio del voto, non era già più il posto di lavoro,bensì la promessa di ottenerlo43, in particolare in ciò cheho definito “sistema del welfare” e “sistema politico”, oraoggetto dello scambio diviene un’opportunità di lavoro atermine, che vincola il beneficiario attuale o potenziale –sia esso un singolo o invece un’impresa – a sostenereattivamente il candidato che l’ha procurata – e il grumo ditecnici e di affaristi che si coagula intorno a costui –,pena la sua sostituzione con altri potenziali beneficiari,legati ad altri candidati44. Ciò dovrebbe infine tradursi43 Cfr. F. Cazzola, L’Italia del pizzo. Fenomenologia della tangente quotidiana,Einaudi, Torino, 1992. La ragione è che mentre la concessione delposto definisce un accordo di scambio politico che vincola soltantogli effettivi beneficiari, l’elargizione della promessa consente diespandere la platea dei potenziali interessati all’accordo a tutti icandidati alla copertura del posto. E’ per questo motivo che, nelcorso degli anni ’80, quando questa prassi si era ormai consolidata ediffusa, i concorsi pubblici negli enti locali e nelle agenziecontrollate venivano avviati, ma conclusi soltanto se strettamentenecessario.44 Uno storico potrebbe facilmente osservare che un simileadattamento istituzionale non costituisce un’innovazione, bensì unritorno ad una situazione già osservata e denunciata da Gaetano
22
in un’incidenza sempre più elevata del voto di scambio: epertanto consoliderebbe, piuttosto che incrinare, gli spazidi manovra del ceto dirigente, rendendolo di fatto legibussolutus (per quanto, naturalmente, simili mutamenti non loaiutino a conquistare un reale, condiviso e stabile mandatoa governare, anzi lo rendano ostaggio di poteri criminali emoti di piazza)45. Non è chiaro, tuttavia, come siapossibile giungere ad una qualche sintesi tra gli interessiancora comuni a due porzioni così lontane della stessacompagine statale. Il tema, peraltro, esula dai confini delpresente lavoro, per cui ci si limiterà a richiamare quil’etichetta di secessione temperata dalla tirannia (o si trattavainvece di tirannia temperata dalla secessione?) proposta daGiovanni Sartori a proposito di alcuni progetti direvisione costituzionale.
Conclusioni. Quali alternative?
Lo scenario emergente da questo esercizio è abbastanzadeprimente. Al lettore incredulo conviene ricordare i caveatenunciati nei capoversi iniziali di questa sezione:l’esistenza di molteplici linee di scontro politico apre lastrada ad una grande varietà di mediazioni e di compromessitra interessi sostanzialmente opposti; e così le tendenzedi fondo possono trovare dei fenomeni di controtendenza chemutano il quadro qui sopra delineato. Ma conviene anchericordare che i processi e gli effetti qui richiamati sisono già verificati in alcuni Paesi del Sud del mondo
Salvemini nelle sue analisi relative al clientelismo ed ai poterilocali nel Mezzogiorno. Un sociologo potrebbe ricordare le riflessionianticipatrici di Ugo Ascoli (in Id., a cura di, Azione volontaria e WelfareState, Il mulino, Bologna 1987) intorno al potenziale di collusione, diclientelismo e persino di corruzione generato dalla tendenza delleistituzioni pubbliche a delegare totalmente la responsabilità dellepolitiche sociali al volontariato ed alle organizzazioni no profit.45 Il che può forse contribuire a spiegare perché siano andatefinora deluse le aspettative riposte da molti studiosi (tra i quali adesempio C. Trigilia, Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi delle politiche per ilMezzogiorno, Il mulino, Bologna, 1992) nel decentramento dellecompetenze citato in precedenza. Al riguardo cfr. anche P. Craveri,Nord Est e Mezzogiorno, “L'Acropoli”, IX, 4, 2008, che lamenta la mancanzadi qualunque segno di ripresa di efficacia delle istituzioni politichee amministrative nel Sud.
23
colpiti dalla “crisi del debito” e dalle conseguentipolitiche di aggiustamento strutturale e di stabilizzazionemacroeconomica consigliate dalle istituzioniinternazionali46. Perdipiù senza nessun Nord internodisposto ad elargire beneficenza o contributi disolidarietà: e spesso, pertanto, con conseguenzecatastrofiche.
E’ possibile immaginare una prospettiva diversa (apartire dai medesimi dati del problema)? Il sentieroargomentativo più frequentato dagli studiosi italiani inproposito evidenzia, innanzitutto, che l’immagine di unMeridione “a macchia di leopardo” corrisponde ai dati dellastoria economica delle regioni del Sud47, per ricordare ilrovesciamento dei divari interni al Mezzogiorno durante ilperiodo repubblicano48, e passare quindi ad esaminare leprocedure ed i risultati non sempre negativi dellepolitiche di sviluppo locale e le trasformazioniverificatesi nei contesti economici locali49, non senzaricordare che il clientelismo non è necessariamente unfenomeno dannoso, e può persino avere effetti positivi suipercorsi di crescita50. La linea di riflessione proposta daquesti studiosi ha certamente il merito di richiamarel’attenzione generale su quanto di buono è stato fatto,nelle regioni del Sud, sia nei comparti privati che nelsettore pubblico, dall'epoca dell'intervento straordinarioa quella della “nuova programmazione”; sulla presenza di untessuto di piccole e medie imprese dinamiche; sullapersistente vitalità di forme economiche nonnecessariamente antiquate, o “banali”, o confinateall’ambito locale – dall’agricoltura biologicaall’industria dei salotti, dall’artigianato artistico al46 Cfr. M. Chossudovsky, La globalizzazione della povertà. L’impatto delle riformedel Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, Gruppo, Abele, Torino,1998.47 Cfr. P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale. Dall’ottocento ad oggi,Donzelli, Roma, 1993.48 Cfr. G. Bottazzi, I Sud del Sud. I divari interni al Mezzogiorno e ilrovesciamento delle gerarchie spaziali, in “Meridiana”, 10, 1990.49 Cfr. P. De Vivo, Sviluppo locale e Mezzogiorno. Piccola impresa, territorio eazione pubblica, Angeli, Milano, 1997; G. Viesti, Abolire il Mezzogiorno,Laterza, Bari, 2003; C. Trigilia, Sviluppo locale. Un progetto per l'Italia,Laterza, Bari, 2005.50 Cfr. A. Mutti, Sociologia dello sviluppo e questione meridionale oggi, in“Rassegna italiana di Sociologia”, 2, 1991; S. Piattoni, Il clientelismo.L’Italia in prospettiva comparata, Carocci, Roma, 2005.
24
turismo di lusso –, in grado di rinnovarsi e di offrireopportunità di crescita e di occupazione; sul generaleinnalzamento dei livelli di istruzione e di competenzeprofessionali; sull'effettivo conseguimento di livellirelativamente elevati di reddito pro capite in alcuneregioni – Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna –, non acaso già oggi collocate dall’Unione Europea al di fuoridell’area “obiettivo 1” (ora Obiettivo Convergenza), ed insvariati contesti locali. Ma trascura forse troppo ilversante negativo del bilancio, che si esprime ad esempionegli enormi sprechi di risorse pubbliche per finalitàdiverse dalla promozione della crescita economica o dellosviluppo umano della popolazione; nella generalesottodotazione di infrastrutture e servizi pubblici;nell'enorme quantità di risorse umane sprecate nellasottoccupazione, nell'inoccupazione o in un'inattivitàsostanzialmente forzata; nel degrado ambientale e socialedelle metropoli e dei centri urbani di media grandezza (conqualche eccezione: Salerno, Lecce), i quali rappresentanopur sempre una quota preponderante della popolazione e che,per le ragioni sopra elencate, drenano improduttivamenterisorse tuttora considerevoli; nel fatto che quasi nessuno,degli episodi di sviluppo locale che vengono citati edesaminati dalla letteratura, si colloca nella parte dellagraduatoria dei distretti economici stabilmente presidiatadalle aree del Centro-Nord (e ciò anche se appartengonoalle regioni fuoriuscite dalla zona “obiettivo 1”); nellapenetrazione della criminalità organizzata nell'economia,nella politica e nella società delle regioni meridionali51,e non soltanto meridionali. Insomma, una spinta verso ilrilancio delle prospettive economiche e sociali delMezzogiorno non può venire soltanto da questi episodi disviluppo locale: pur se questi indicano, nella creazione diun reticolo di attori istituzionali e di soggetticollettivi motivati al sostegno della crescita, un fattore di granderilievo sia per lo sviluppo di piccola impresa o perl’attivazione di un nuovo flusso di investimentidall’esterno, sia per la riqualificazione delle politiche edei servizi pubblici, sia per la ricostituzione del legamesociale e della civicness.
51 Cfr. G. Galasso, Il Mezzogiorno da “questione” a “problema aperto”, cit.;N. Rossi, Mediterraneo del Nord, cit.
25
A parere di chi scrive, perdurando per le ragionisuindicate le difficoltà dello Stato centrale – e quindidella classe dirigente nel suo insieme – nell'individuareun percorso di riforma e di iniziativa politicasuscettibile di rilanciare e sviluppare l'unità nazionale,un percorso alternativo più plausibile può consistere in unrilancio del processo di integrazione economica e dicostruzione politica dell’Unione Europea, che già sembraavere avuto meriti di qualche rilievo nelle riforme delmercato del lavoro e del sistema di welfare, dellagiustizia e delle medesime politiche di svilupporegionale52. In questa ottica appare indubbio che lacoesione regionale sia un problema cruciale per leprospettive di crescita economica, di sviluppo e disuccesso competitivo dell’intera Unione, in particolare difronte alla questione dell’allargamento ai Paesidell’Est53. E’ dunque al livello dell’Unione Europea chedovrebbero essere reperite risorse in grado di sostenerel’economia, l’occupazione e il sistema del welfare nelleregioni depresse che, come ho cercato di mostrare piùsopra, appaiono ormai emarginate dal potere economico erischiano una notevole caduta nel livello e nella qualitàdella vita. A patto di riformare gli strumenti di sostegnoin maniera da impedire che le risorse economiche cosìreperite vengano sprecate, come spesso si è verificato sianel periodo dell’intervento straordinario che in questo piùrecente, segnato dal ricorso ai fondi strutturali ed alla“nuova programmazione”, in “cattedrali nel deserto”, inopere e lavori di pubblica inutilità, in moleste campagnedi comunicazione sul nulla, o ancora in privilegi e sussidida elargire agli incapaci e agli immeritevoli, spesso nellaforma di trasferimenti diretti ad imprese fuori mercatoquando non addirittura inesistenti, o della creazione
52 Per il primo settore, cfr. M. Ferrera – E. Gualmini, Salvatidall'Europa?, Il mulino, Bologna, 1999; per il secondo, cfr. invece S.Lodato – R. Scarpinato, Il ritorno del Principe, cit.; per il terzo, cfr. A.La Spina, La politica per il Mezzogiorno, cit., pp. 255-349; al riguardo cfr.anche, per quanto in un'ottica orientata ad evidenziare tanto i puntidi forza quanto le carenze dell'azione di Bruxelles,. M. Lo Cicero,Politiche europee e crescita meridionale. Limiti analitici e vincoli istituzionali alla “nuovaprogrammazione”, “L'Acropoli”, IV, 1, 2003.53 Cfr. G. Ponzini, Il sistema di welfare nel Mezzogiorno tra marginalità emodernizzazione, in E. Pugliese (a cura di), Nord e Sud, cit.
26
diretta di occupazione pubblica socialmente inutile54. Mavengano invece concentrate, con le modalità emergenti dallebuone prassi di sviluppo locale sperimentate nella stagionepiù recente ed evidenziate dalla ricerca sull’argomento, inattività più suscettibili di contribuire ad alzare livelloe qualità della vita e per questa via promuovere lacrescita economica e lo sviluppo civile. Mi riferisco, insostanza, alla tutela ambientale, all’igiene, alla sanità, aiservizi sociali, ai trasporti pubblici, all’istruzione e formazione, allaricerca scientifica55; ed anche e soprattutto alla sicurezza dellepersone, delle imprese e degli scambi, dal momento che la garanziadella legalità, in un contesto nel quale questa è apparsatroppo a lungo debole56, appare il fondamentoindispensabile per la ripresa degli investimenti nelcircuito primario dell’economia.
Un possibile scenario politico alternativo consistequindi nel lasciare che la vicenda dell’Italia confluiscain quella più ampia dell’Europa unita, così come a suotempo, secondo Croce, la vicenda del Meridione è confluitain quella più vasta del Regno d’Italia57. Rimane aperta unaquestione importante: il punto a favore di questo scenarioè che trasferisce ad un livello territoriale più elevatoresponsabilità che la classe dirigente del Nord(-Centro)sembra voler rifiutare. Ma il punto debole di esso consiste
54 A parte la letteratura giornalistica sulla “casta”, che sembraormai persino troppo ampia perché se ne possa rendere adeguatamenteconto, svariati esempi di questa deriva delle politiche per ilMezzogiorno e nel Mezzogiorno, specialmente nell'ultima stagione, sipossono trovare in N. Rossi, Mediterraneo del Nord. Un'altra idea del Mezzogiorno,Laterza, Bari, 2005, pp. 53-82. Ancora più efficace, pur se riferitoin prevalenza al “fallimento della politica” nella più grande cittàdel Sud, ed alle opzioni culturali che la sostenevano, già citatolibro di A. Scotto di Luzio, Napoli dei molti tradimenti.55 Cfr. N. Rossi, Mediterraneo del Nord, cit.; C. Donolo, Sostenere losviluppo. Ragioni e speranze oltre la crescita, Bruno Mondadori, Milano, 2007.56 Cfr. A. La Spina, Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, Ilmulino, Bologna, 2005; cfr. anche al riguardo, ma su posizioni piùradicali, il già citato Il ritorno del Principe di Lodato e Scarpinato.57 Cfr. B. Croce, Storia del Regno di Napoli, Adelphi, Milano, 1992. Eforse qui va ricordato come anche Aldo Schiavone (nel già citato Italianisenza Italia, pp. 3-20) rilevi che nel percorso storico dell’Italia unitale discontinuità vengano determinate da fattori esogeni alla societàitaliana: la I Guerra Mondiale e il “biennio rosso”; la II GuerraMondiale, la sconfitta e la Resistenza; il crollo del comunismo el’innesco del processo di integrazione economica e politicadell’Europa .
27
nel fatto che rischia di sottrarre alla classe dirigentedel (Centro-)Sud gli strumenti principali mediante i qualiessa esercita il suo potere e ricava la sua opulenza58. Perevitare, allora, di ingrassare i soliti gatekeeper dellaspesa pubblica nelle regioni meridionali non finiremo perinvocare una qualche forma di “ingerenza umanitaria” dellaGrande Europa che ci salvi da noi stessi?
Riferimenti bibliografici
Accornero, A. – Carmignani, F. 1986I paradossi della disoccupazione, Il mulino, Bologna.Arrighi, G. 1996Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo, Il saggiatore, Milano(ed. or. 1994).Ascoli, U. (a cura di) 1987Azione volontaria e Welfare State, Il mulino, Bologna.Bagnasco, A. 1977Tre Italie. La problematica territoriale nello sviluppo italiano, Il mulino, Bologna.Bagnasco, A. 1996L’Italia in tempi di cambiamento politico, Il mulino, Bologna.Barca, F. 2008Un commento a Galasso: in tema di “progetto silenzioso” per il Mezzogiorno,“L'Acropoli”, IX, 2.Barbagallo, F. 1994La modernità squilibrata del Mezzogiorno d’Italia, Einaudi, Torino.Bevilacqua, P. 1993Breve storia dell’Italia meridionale. Dall’ottocento a oggi, Donzelli, Roma, 2003.Bonomi, A. 2008Il rancore. Alle radici del malessere del Nord, Feltrinelli, Milano.Bottazzi, G. 1990
58 Con il rischio di ricadere in un nuovo “sviluppo senzaautonomia” quale prezzo da pagare per ridurre le interferenze dellaclasse dirigente meridionale sulle politiche sociali e per la crescitaeconomica. D'altro canto, il ruolo positivo dell'Unione Europeanell'influenzare la legislazione nazionale rallentando potenzialiderive “latinoamericane” è stato già evidenziato per quanto riguardadue settori importanti quali il welfare e la giustizia (cfr. sopra neltesto). In questa prospettiva occorrerebbe dunque una traslazione diquesta attività al livello delle autonomie regionali e locali. Allaclasse dirigente del Mezzogiorno non resterebbe che l'avventura dellasecessione e della trasformazione delle regioni del Sud in un immensoporto franco per traffici e mercati di ogni tipo, un progetto questoche non casualmente sembra essere stato ventilato dalla mafiasiciliana sia nel secondo dopoguerra che negli anni delle stragi (cfr.S. Lodato – R. Scarpinato, Il ritorno del Principe, cit., pp. 287-297).
28
I Sud del Sud. I divari interni al Mezzogiorno e il rovesciamento delle gerarchie spaziali, inMeridiana, 10.Cafagna, L. 1994Nord e Sud. Non fare a pezzi l’unità d’Italia, Marsilio, Venezia.Cazzola, F. 1992L’Italia del pizzo. Fenomenologia della tangente quotidiana, Einaudi, Torino.Cerase, F. P. (a cura di) 1992Dopo il familismo cosa? Tesi a confronto sulla questione meridionale negli anni ’90, Angeli,Milano.Chossudovsky, M. 1998La globalizzazione della povertà. L’impatto delle riforme del Fondo monetario internazionale edella Banca mondiale, Gruppo Abele, Torino.Cohen, D. 1999Ricchezza del mondo, povertà delle nazioni, Comunità, Milano (ed. or. 1997).Craveri, P. 2008Nord Est e Mezzogiorno, “L'Acropoli”, IX, 4.Croce, B. 1992Storia del regno di Napoli, Adelphi, Milano (ed. or. 1925).Crouch, C. 2001Sociologia dell’Europa occidentale, Il mulino, Bologna.De Vivo, P. 1997Sviluppo locale e Mezzogiorno. Piccola impresa, territorio e azione pubblica, Angeli,Milano.Donolo, C. 2001Disordine. L’economia criminale e le strategie della sfiducia, Donzelli, Roma.Donolo, C. 2007Sostenere lo sviluppo. Ragioni e speranze oltre la crescita, Bruno Mondadori, Milano.Farinella, D., e Parziale, F. 2007Processi di terziarizzazione e diseguaglianze socio-occupazionali in Italia: un’analisi a partiredal locale, Università degli studi di Messina, Centro interuniversitarioper le ricerche sulla Sociologia del diritto e delle istituzionigiuridiche, working paper n. 30.Ferrera, M., e Gualmini, E. 1999Salvati dall’Europa?, Il mulino, Bologna.Galasso, G. 2005Il Mezzogiorno da “questione” a “problema aperto”, Lacaita, Manduria.Gallino, L. 1987Dell’ingovernabilità. La società italiana tra premoderno e neoindustriale, Comunità,Torino.Gallino, L. 2000Globalizzazione e diseguaglianze, Laterza, Bari.Gallino, L. 2006Italia in frantumi, Laterza, Bari.Graziani, A. 1987Mezzogiorno oggi, “Meridiana”, 1.Kumar, K. 2000Le nuove teorie del mondo contemporaneo. Dalla società postindustriale alla societàpostmoderna, Einaudi, Torino (ed. or. 1995).La Spina, A. 2003La politica per il Mezzogiorno, Il mulino, Bologna.La Spina, A. 2005Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, Il mulino, Bologna.
29
Lodato, S. e Scarpinato, R. 2008Il ritorno del Principe, Chiarelettere, Milano.Lo Cicero, M. 2003Politiche europee e crescita meridionale. Limiti analitici e vincoli istituzionali alla “nuovaprogrammazione”, “L'Acropoli”, IV, 1.Maddaloni, D. 2006L’occupazione regolare non agricola e le diseguaglianze territoriali in Italia tra il 1991 e il2001, in E. Pugliese (a cura di), Nord e Sud. Rapporto IRPPS-CNR sullo Statosociale in Italia 2005-2006, Donzelli, Roma.Mutti, A. 1991Sociologia dello sviluppo e questione meridionale oggi, in Rassegna italiana di Sociologia,2.Paci, M. 1982La struttura sociale italiana. Costanti storiche e trasformazioni recenti, Il mulino,Bologna.Paci, M. 1992Il mutamento della struttura sociale in Italia, Il mulino, Bologna.Piattoni, S. 2005Il clientelismo. L’Italia in prospettiva comparata, Carocci, Roma.Pirro, F. 2006Mezzogiorno e industria: tra passato e futuro, “L'Acropoli”, VII, 1.Pizzorno, A. 1980I ceti medi nei meccanismi del consenso, in A. Pizzorno, I soggetti del pluralismo. Classipartiti sindacati, Il mulino, Bologna (ed. or. 1974).Ponzini, G. 2006Il sistema di welfare nel Mezzogiorno tra marginalità e modernizzazione, in E. Pugliese(a cura di), Nord e Sud. Rapporto IRPPS-CNR sullo Stato sociale in Italia 2005-2006,cit.Regalia, I. 2001Capire le politiche pubbliche, Il mulino, Bologna.Ricolfi, L. (a cura di) 2007Le tre società. E’ ancora possibile salvare l’unità dell’Italia? Italia 2006: III rapporto sulcambiamento sociale, Guerini e associati, Milano.Roma, G. 2001L’economia sommersa, Laterza, Bari.Rossi, N. 2005Mediterraneo del Nord. Un'altra idea del Mezzogiorno, Laterza, Bari.Schiavone, A. 1998Italiani senza Italia. Storia e identità, Einaudi, Torino.Schizzerotto, A. (a cura di) 2002Vite ineguali. Diseguaglianze e corsi di vita nell’Italia contemporanea, Il mulino,Bologna.Scotto di Luzio, A. 2008Napoli dei molti tradimenti, Il mulino, Bologna.Sen, A. K. 2000Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano (ed.or. 1999).Svimez 2008 Rapporto Svimez 2008 sull’economia del Mezzogiorno, Il mulino, Bologna.Sylos Labini, P. 2003Scritti sul Mezzogiorno 1954-2002, a cura di G. Arena, Lacaita, Manduria.Trigilia, C. 1992
30
Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno, Il mulino,Bologna.Viesti, G. 2003Abolire il Mezzogiorno, Laterza, BariViesti, G. (a cura di) 2007Le sfide del cambiamento. I sistemi produttivi nell'Italia e nel Mezzogiorno d'oggi, Donzelli,Roma.Visetti, G. 2008La regione chiusa con un fax, “La repubblica”, 25 novembre.Wolleb, E. – Wolleb, G. 1990Divari regionali e dualismo economico. Prodotto e reddito disponibile nelle regioni italianenell’ultimo ventennio, Il mulino, Bologna.
31