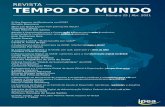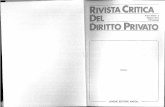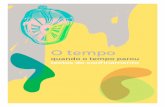Una macchina del tempo per l'archeologia (1-42)
Transcript of Una macchina del tempo per l'archeologia (1-42)
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
Insulae DiomedeaeCollana di ricerche storiche e archeologiche
20
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
In copertina: Quattro momenti del viaggio nel tempo con la TimeMachine.Sul retro: Piante di fase tridimensionali.
UnIversItÀ DeglI stUDI DI FoggIa
Dipartimento di Studi Umanisticilettere, Beni culturali, scienze della formazione
Corso di Dottorato in Storia e Archeologia Globale dei Paesaggi
(scuola di Dottorato di ricerca in Le Culture dell’Ambiente, del Territorio e dei Paesaggi)
Insulae DiomedeaeCollana di ricerche storiche e archeologiche
Collegio dei docenti - Comitato scientifico della Collana
giuliano volpe (coordinatore)giuliano De Felice, riccardo Di Cesare, silvia evangelisti, Pasquale Favia, roberta giuliani,
niccolò guasti, Danilo leone, Daniela liberatore, Maria luisa Marchi, vincenza Morizio,giulia recchia, giunio rizzelli, saverio russo, Maria turchiano, Francesco violante (Università di Foggia),
Massimo osanna (Università della Basilicata), Franco Cazzola (Università di Bologna),rossano Pazzagli (Università del Molise), gert-Jan Burgers (Reale Istituto Neerlandese di Roma),
girolamo Fiorentino (Università del Salento), Franco Cambi (Università di Siena)
Comitato scientifico internazionale
Javier arce (Université de Lille 3), gian Pietro Brogiolo (Università di Padova),Michael Crawford (University College London), Francesco D’andria, Francesco grelle (Università del Salento),
richard Hodges (University of East Anglia), Daniele Manacorda (Università di Roma 3), Biagio salvemini (Università di Bari A. Moro), alastair small (University of Edinburgh),
enric tello (Universidad de Barcelona), Maria José strazzulla (Università di Foggia), Domenico vera (Università di Parma), roger Wilson (University of British Columbia)
Segreteria di redazione
Maria turchiano(Dipartimento di studi Umanistici, via arpi 176, 71121 Foggia - [email protected] - http://www.archeologia. unifg.it)
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
giuliano De Felice
Una MaCCHIna Del teMPoPer l’arCHeologIa
Metodologie e tecnologie per la ricerca e la fruizione virtuale del sito di Faragola
Bari 2012
Università degli studi di FoggiaDipartimento di studi Umanistici
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
© 2012 - Edipuglia srl, via Dalmazia 22/b - 70127 Bari-S. Spiritotel. 080. 5333056-5333057 (fax) - http://www.edipuglia.it - e-mail: [email protected]
Redazione: Valentina NataliCopertina: Paolo Azzella
ISBN 978-88-7228-617-3http://dx.medra.org/10.4475/617
volume pubblicato con il contributodel Dipartimento di studi Umanistici dell’Università degli studi di Foggia
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
A Velia, Libero e Marino
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
1 la bibliografia sugli scavidi Faragola è assai ampia; si ve-dano, in generale, volpe, tur-chiano 2009, che raccoglie unaserie di saggi, e la guida all’areaarcheologica volpe, turchiano2010; sulle fasi altomedievalicfr. ora volpe et alii 2012.
2 Cfr. la bella guida agli scavipensata per i bambini di Balda-sarre 2011.
3 sibilano 2009.
lo scavo archeologico di Faragola nel territorio di ascoli satriano 1 non harappresentato e non rappresenta ancora soltanto una straordinaria occasione perindagare sistematicamente un sito rurale pluristratificato di grande interessestorico e archeologico, occupato per oltre un millennio, con fasi relative ad unabitato di età daunia preromana, ad una fattoria e una villa romana e, in parti-colare, ad una ricchissima villa tardoantica e, infine, ad un articolato e vitale abi-tato di età altomedievale. Ha rappresentato e rappresenta anche l’opportunità perla formazione di giovani archeologi, per la contestuale analisi dei paesaggi dellavalle del Carapelle, per la sperimentazione di nuove forme di indagini diagno-stiche, di restauro e di valorizzazione in situ, per la realizzazione di innovativestrutture di copertura e di musealizzazione dei resti archeologici, per la crea-zione di supporti didattici destinati anche ai bambini 2 e, infine, per la raccolta,l’elaborazione e la gestione informatizzata di una ingente massa di dati e per lapredisposizione di innovativi sistemi di fruizione e comunicazione digitale. Unapresenza, quella dell’informatica a Faragola, fortemente voluta e pensata per ga-rantire un livello qualitativo più elevato del lavoro archeologico, per porre mi-gliori e diversificate domande storiche ai dati archeologici e per tentare di offrirerisposte più convincenti e articolate, per sostenere un progetto di comunica-zione archeologica ad ampio spettro.
Queste attività, coordinate da giuliano De Felice, hanno visto impegnatimolti giovani archeologi, dottori, dottorandi di ricerca e studenti, come giusysibilano, che a questo tema ha dedicato la sua tesi di dottorato 3, lorenzo Bal-dassarro, andrea Fratta, Fabio gagliardi ed altri ancora.
giuliano De Felice, che nelle prime campagne di scavo tra il 2003 e il 2005è stato co-responsabile delle ricerche sul campo, insieme a Maria turchiano(che segue fin dagli inizi questo progetto, condividendo con me la direzionescientifica dello scavo di Faragola), ha deciso, anche con il convinto sostegnodi chi scrive, di indirizzare sempre più i suoi interessi scientifici all’informaticaapplicata all’archeologia, curando una serie di progetti innovativi e dando vitaad uno specifico laboratorio, il laboratorio di archeologia Digitale, nel qualesi è venuto a creare negli anni un gruppo di entusiasti e abili giovani archeologiche si sono andati specializzando in questo campo, proponendo varie soluzionicreative e innovative.
Da molti anni, peraltro, nella nostra équipe cerchiamo di dedicare grandeattenzione ai temi e alle prospettive dell’informatica applicata all’archeologia,nell’ambito del più generale approfondimento degli aspetti metodologici dellanostra disciplina, nella duplice convinzione che l’innovazione metodologicanon possa prescindere dall’informatica, e che la vera sfida sia prima di tutto diordine metodologico e non tecnologico, diversamente da quanto spesso si ri-tiene e si riscontra in tanti musei, mostre e parchi archeologici. ancora troppospesso, infatti, si attribuisce un’eccessiva importanza all’ultimo ritrovato tec-nologico, all’ultimo software, all’apparecchiatura tanto costosa quanto rapida-mente obsoleta, all’effetto scenografico e schioppettante dal punto di vistacomunicativo, e molto meno ai contenuti, ai bisogni reali, ai risultati, ai me-todi, all’utilità di una ricerca. I computer sono macchine ormai indispensabili,
7
Presentazione
di Giuliano Volpe
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
ma pur sempre macchine, le cui potenzialità possono realmente essere valoriz-zate solo con buone idee e con la capacità di proporre un racconto storico fon-dato, chiaro e convincente.
Utilizzare un computer di ultima generazione o un laser scanner 3D sofi-sticato non significa necessariamente applicare correttamente l’informatica al-l’archeologia. l’affinamento delle procedure di scavo e, in generale, del lavorosul campo, delle tecniche diagnostiche, delle possibilità di acquisizione di in-formazioni inimmaginabili alcuni anni fa, ha creato situazioni preoccupanti digestione dei dati, dei reperti di origine antropica e naturale, della documenta-zione, che impongono necessariamente il ricorso a trattamenti sistematici me-diante l’informatica e i metodi dell’archeologia quantitativa. si pensi alleapplicazioni informatiche ormai consuete nelle analisi territoriali, nello scavodi grandi insediamenti, soprattutto urbani, ai sistemi GIS, alle tecniche aerofo-tografiche, fotogrammetriche, satellitari, geofisiche, ai rilievi con stazioni in-tegrate e ai sistemi CAD e laser scanner 3D, alle banche-dati, alla gestione direti telematiche, alla realtà virtuale, alle nuove tecniche di ricostruzione 3D, divalorizzazione, fruizione, comunicazione del patrimonio archeologico.
È con questo spirito che si è avviata la sperimentazione i cui risultati sonoillustrati in questo volume, che tiene conto e si inserisce a pieno titolo nel vi-vace dibattito sviluppato a livello nazionale e internazionale. la TimeMachine
è stata concepita come una componente intrinsecamente interna al progetto discavo archeologico, strettamente legata alle domande storiche che hanno ispi-rato le ricerche stratigrafiche, ai problemi legati all’acquisizione, alla gestionee all’interpretazione dei dati, alle esigenze di una comunicazione sempre piùchiara, attiva ed efficace: è parte integrante, cioè, di un approccio globale, fon-dato sull’impiego integrato di fonti, di strumenti e di competenze multidisci-plinari, che oggi non può prescindere anche dall’impiego intelligente e correttodell’informatica in tutte le sue ampie articolazioni.
Il progetto elaborato si caratterizza per significative innovatività e speri-mentalità non solo per i risultati raggiunti ma anche per le stesse modalità chehanno caratterizzato tutte le fasi del lavoro svolto, attraverso un approccio for-temente interdisciplinare, il continuo scambio di informazioni, di dati e di in-terpretazioni tra i vari collaboratori.
sotto il profilo comunicativo, la scommessa principale è stata, infatti, quelladi contribuire a rendere la visita dello scavo, virtuale e reale, piacevole, unavera occasione di crescita personale, di approfondimento, di curiosità, di par-tecipazione attiva: abbiamo potuto verificare sul sito il grande interesse dimo-strato dai visitatori, e non solo dai più giovani, ovviamente più predisposti versostrumenti a loro assai familiari. Questi ultimi, inoltre, hanno subito compresoche la TimeMachine non fosse un semplice ‘videogioco’ ma uno strumento ef-ficace e divertente per ripercorrere la storia dell’insediamento e le fasi del la-voro degli archeologi, le loro ipotesi ricostruttive, i dati in base ai quali quelleipotesi erano state formulate.
giuliano De Felice, avvalendosi dell’apporto di vari collaboratori, ha sa-puto costruire un sistema di facile e piacevole utilizzazione, fortemente inte-
8
Una macchina del tempo per l’archeologia
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
4 volpe 2012; Dattolo et alii2012.
5 volpe 2008.6 Manacorda 2008, 245.
rattivo e graficamente accattivante, con contenuti scientificamente solidi maresi con ricostruzioni tridimensionali e strumenti comunicativi semplici e im-mediati, senza alcun cedimento alla banalizzazione, continuamente aggiornabilee modificabile, che rappresenta al momento, a nostro parere, uno dei risultati piùinnovativi in questo campo. Un’analoga esperienza positiva abbiamo potuto vi-vere insieme recentemente nella elaborazione di un innovativo progetto di frui-zione multimediale che accompagna il nuovo allestimento della collezionearcheologica della Fondazione sicilia a Palazzo Branciforte splendidamente re-staurato da gae aulenti e restituito alla città di Palermo: una esperienza nellaquale ho potuto verificare ancora la maturità metodologica e le capacità di giu-liano De Felice nel proporre, insieme agli altri collaboratori, nuove interessantisoluzioni 4.
lo scavo di Faragola, le indagini sistematiche nella valle del Carapelle, lostudio dei manufatti, le analisi bioarcheologiche e archeoambientali, e, in que-sto contesto, anche l’approccio digitale e la TimeMachine, sono pezzi di un veroprogetto di archeologia globale dei paesaggi 5, che si pone anche l’obiettivofondamentale di contribuire “all’arricchimento di quella che chiamiamo ‘me-moria sociale’. Ma questi materiali devono tradursi in memoria collettiva, inimmagini che contribuiscano alla conservazione dell’identità dei gruppi sociali.e ciò comporta una maggiore capacità di prenderci le nostre responsabilità nellescelte che inevitabilmente operiamo, quando inevitabilmente selezioniamo, perdare un senso a quella selezione. Per trasmettere l’eredità del passato non ba-stano infatti le soluzioni tecniche, e il supporto di tecnologie sempre più sofi-sticate, occorrono anche strumenti culturali” 6. ecco espresso, in poche denseparole, il senso più profondo di questa articolata operazione scientifica e cul-turale.
sono, quindi, assai felice di salutare la pubblicazione di questo bel volume,prodotto di un impegno metodologico e scientifico ormai ventennale, maturatonell’esperienza di giuliano De Felice fin dagli anni della sua formazione uni-versitaria e della partecipazione ai seminari di metodologia archeologica da metenuti nell’Università di Bari e agli scavi di Herdonia, di san giusto e infine diFaragola, e poi nella costruzione dell’attivo gruppo di ricerca archeologica nellagiovane Università di Foggia, gruppo del quale giuliano è parte integrante eattiva con le sue specifiche competenze, con la sua passione e la sua intelli-genza.
Foggia, ottobre 2012
9
Presentazione
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
Che le tecnologie digitali costituiscano strumenti eccellenti per veicolaremodalità dense e innovative di fruizione di oggetti culturali non è certo un’af-fermazione che necessita di essere ribadita. le straordinarie potenzialità espres-sive, la possibilità di simulare dimensioni virtuali e di renderle immersive einterattive costituiscono un valore enorme nella restituzione di oggetti fram-mentari e ‘desueti’ e nella descrizione di mondi cronologicamente e cultural-mente lontani.
Quel che appare più incerta è invece la prospettiva di innestare l’utilizzodelle tecnologie nella valorizzazione del grande e invisibile patrimonio di co-noscenza insito nei processi di documentazione e analisi, rendendolo parte in-tegrante dei progetti e dei prodotti di comunicazione. anche dal punto di vistadelle modalità di utilizzo delle tecnologie infatti, ricerca e valorizzazione, puressendo due elementi complementari all’interno di una catena del valore deibeni culturali fortemente unitaria, risultano due ambiti ancora nettamente se-parati: le tecnologie digitali sono diffuse in maniera capillare nei processi di ri-cerca, sia come strumenti per la gestione e l’analisi dei dati nelle fasi di studioche come supporto in quelle di comunicazione e diffusione dei risultati, ma unavisione organica che superi la prospettiva delle ‘applicazioni’ rimane ancoratutta da conseguire.
In ambito archeologico, la mancanza di una visione unitaria risulta partico-larmente evidente nella marcata separazione che si registra fra l’utilizzo delletecnologie digitali funzionali alla classificazione dei dati, alla realizzazionedella documentazione e a supporto dell’interpretazione da un lato e la veicola-zione delle ipotesi ricostruttive dall’altro. ne consegue ad esempio che la com-plessità e la densità delle informazioni raccolte e gestite dagli strumenti dianalisi e documentazione utilizzati sul campo raramente rimangono visibili allafine del processo di ricerca, e contribuiscono solo in minima parte alle fasi dicomunicazione e divulgazione dei risultati. la precisione, o la tridimensiona-lità di un rilievo non costituisce infatti di per sé una garanzia della qualità di unprodotto di comunicazione, ma piuttosto un prerequisito essenziale di validitàscientifica.
Per raccontare in modo coinvolgente e non solo freddamente spettacolareuna realtà distante è necessario spingersi oltre, riappropriarsi delle specificitàdella metodologia e riaffermare il valore della ricerca analitica non solo comestrumento per l’acquisizione di conoscenza o indicatore della qualità di un pro-dotto, ma come parte integrante dei contenuti da inserire in ogni progetto di co-municazione che riguardi l’archeologia. anche il più spettacolare deiritrovamenti, privo di contesto, ha meno cose da dire di un piccolo sito indagatoscientificamente, perché poche cose si potrebbero raccontare del sottile pro-cesso di ricomposizione di tracce che permette di rendere eloquente un insiemedi componenti di per sé muti.
Un racconto al contempo corretto e accattivante può essere scritto solo ad-dentrandosi nell’intricato mondo dei linguaggi, sia quelli di dominio (il lessicoarcheologico, spesso involuto fra esasperati tecnicismi e vezzi esoterici, non ècerto facile da interpretare per il grande pubblico!) sia quelli tecnologici, che,
11
Introduzione
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
in mancanza di una guida spesso identificano nell’innovatività della tecnologial’obiettivo stesso della comunicazione. ascoltando i suggerimenti delle meto-dologie di dominio piuttosto che confidando in modo aprioristico nelle tecno-logie di comunicazione si può giungere a costruire prodotti più coinvolgenti, incui il ritmo narrativo sia dettato dalla necessità di adattamento alla spettacola-rità dei media e in cui la creatività contribuisca in maniera determinante alladefinizione del racconto e dei linguaggi più adatti ad esprimerlo. Quel che servein definitiva è un avvicinamento fra diversi specialismi, sul terreno comunedella comunicazione: una convergenza non tanto verso una multidisciplinarietàche spesso significa banalizzazione dei risultati, ma piuttosto verso una inte-grazione delle competenze in team specializzati in comunicazione dei beni cul-turali.
Da queste considerazioni preliminari hanno preso le mosse le azioni e lesperimentazioni che si presentano in questo volume, finalizzate alla ricerca diun possibile percorso integrato che collegasse, nel dominio specifico dell’ar-cheologia stratigrafica, l’analisi scientifica alla narrazione, e in cui le tecnolo-gie digitali, e la computer graphic in particolare, potessero costituire un puntodi riferimento costante, in grado di supportare singoli momenti applicativi, invista dell’obiettivo fortemente unitario di valorizzare l’intero processo di ri-cerca, dalle metodologie impiegate ai risultati conseguiti in termini di inter-pretazione e ricostruzione.
la TimeMachine, il prototipo che si presenta in queste pagine, mostra i ca-ratteri di un modello di comunicazione scientifica a carattere divulgativo piut-tosto che un sistema di realtà virtuale fruibile in realtime. Questa definizionespiega il carattere tecnico e tecnologico del prodotto, ma non rende giustiziadel lavoro di analisi realizzato con l’obiettivo di raccontare in tutta la sua com-plessità l’articolato processo di ricerca sotteso ad una indagine archeologicastratigrafica. nel corso della lavorazione è risultato evidente infatti che se la3D computer graphic poteva costituire uno strumento eccellente di narrazioneper un sito archeologico, la validità del suo utilizzo rischiava di risultare pres-soché nulla in assenza di un soggetto e di una sceneggiatura idonee. In parti-colare la scelta di utilizzare il realtime è stata immediata, in linea con la libertàdi fruizione che normalmente connota la visita ad un parco archeologico, e lapossibilità di fornire al pubblico un’esperienza al tempo stesso intensa e per-sonalizzata, caratteristiche ampiamente acquisite da una lunga serie di speri-mentazioni nel settore archeologico. se quindi la scelta della tecnologia difruizione è stata quasi obbligata, l’individuazione del soggetto e la costruzionedi una sceneggiatura è stata un’operazione complessa, dato che una semplice ri-proposizione dell’alternanza stato di conservazione/ricostruzione avrebbe datovita ad un prodotto poco innovativo, inadeguato a trasmettere la componentediacronica e multidimensionale di un bacino stratigrafico e la dialettica ana-lisi/interpretazione/ricostruzione che costituisce l’evidenza più interessantedella metodologia di indagine stratigrafica.
la ricerca di un soggetto e di una sceneggiatura, nonché di temi, contenuti,
12
Una macchina del tempo per l’archeologia
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
stili narrativi e linguaggi espressivi idonei, ha richiesto la discussione di unaserie di interrogativi mirati all’individuazione dei caratteri salienti e degli spuntinarrativi offerti dall’oggetto-sito.
Quali sono le storie che un sito archeologico permette di raccontare? Qualii linguaggi migliori per dare loro visibilità? Quali le soluzioni tecniche in gradodi valorizzarle e renderle comprensibili?
la ricerca di una risposta a questi interrogativi ha richiesto il compimentodi un itinerario che è partito dalla disamina delle metodologie d’indagine e do-cumentazione sul campo, passando attraverso l’analisi del rapporto fra ICT e ar-cheologia nel processo di ricerca stratigrafica e sfiorando il più ampio temadell’archeografia.
Questo lungo percorso di ricerca ha portato al riconoscimento degli elementicostitutivi di un possibile racconto all’interno dello stesso processo di acquisi-zione della conoscenza e nella prospettiva delle metodologie di documentazione:è nel viaggio che porta i dati grezzi a trasformarsi in documenti e infine in ideeche si nasconde la storia di un sito. Dal punto di vista narrativo è risultato evi-dente che il prototipo dovesse confrontarsi con la sfida di evidenziare il processointerpretativo, e sottolineare il passaggio fra tracce e interpretazione, fra docu-mentazione e ricostruzione. la TimeMachine è stata pertanto progettata non soloper offrire la visita in piena libertà nelle ricostruzioni di ciascuna delle fasi divita del sito di Faragola, ma anche la possibilità di entrare nella dimensione, piùsurreale che virtuale, delle piante di fase, trasportando il fruitore in una realtàalternativa in cui i documenti utilizzati per immaginare le ricostruzioni mostranole fondamenta del processo interpretativo. la libertà di visita garantita dalle tec-nologie digitali lascia il fruitore nelle condizioni di effettuare il ‘salto’ dimen-sionale o cronologico in qualsiasi momento, verificando in prima persona il pas-saggio fra documenti e ricostruzioni, partecipando così al processo deduttivo incui si sussume l’intera analisi, documentazione e interpretazione operate dal-l’archeologo.
In questa prospettiva abbiamo immaginato di avvicinarci alla sfida di di-mostrare che l’impiego delle tecnologie digitali trovi le sue più profonde mo-tivazioni solo nella prospettiva globale di accompagnare l’intero percorso diconoscenza, come supporto per documentare, come sostegno all’analisi, comestrumento per immaginare in fase di sintesi e, solo in ultima istanza, comemezzo di comunicazione. la realizzazione del prototipo è stata in definitivaun viaggio che ha messo in evidenza quanto sia ardua, e appassionante, lascelta di rendere fruibile la complessità della struttura di conoscenza sottesaad un progetto di ricerca sui beni culturali, ben più affascinante del ritualedel mistero che spesso si consuma intorno alla pretesa di valorizzazione delpatrimonio culturale. e’ una complessità straordinaria, normalmente poco vi-sibile, se non completamente nascosta, al pubblico, che invece può divenireprotagonista del racconto digitale, a patto di essere in grado di raccontare nonsolo le conclusioni del percorso di ricerca (nel nostro caso le “ricostruzioni”),ma anche le tappe del processo stesso di acquisizione e costruzione della co-
13
Introduzione
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
noscenza indispensabili per immaginare, realiz-zare e descrivere le stesse ricostruzioni.
la TimeMachine (fig. 1) è un prototipo, il cuisviluppo è stato portato fino ad un punto ben lon-tano dal poter essere considerato definitivo. al dilà delle caratteristiche tecniche e della qualità delprodotto, condannate, come è destino comune nelmondo della produzione di contenuti digitali, adessere superate in tempi brevi, spero rimanga in-tatto il valore reale della sperimentazione, insitonel legame indissolubile con la ricerca archeolo-gica sul campo, e nel tentativo di sottoporla diret-tamente al giudizio del grande pubblico.
tutto il lavoro descritto, infatti, comprese leriflessioni teoriche e metodologiche, nasce dallasperimentazione di un caso concreto, strettamentelegato all’attività di ricerca archeologica sulcampo, e dai molteplici stimoli che possono es-sere forniti da un progetto articolato e complessoquale è quello di Faragola.
Per una felice coincidenza la sperimentazionee la produzione si sono concluse contestualmentealla realizzazione del Parco archeologico e la Ti-
meMachine è a disposizione dei visitatori diretta-mente sul sito; inoltre il prototipo può essereliberamente scaricato all’indirizzo www.archeolo-giadigitale.it, e fruito da chiunque non possa visi-tare in prima persona il Parco.
14
Una macchina del tempo per l’archeologia
1. - La Time Machine sul sito di Faragola.
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
Il prototipo è stato ideato e realizzato interamente presso il laboratorio di archeologia Digitale dell’Università di Fog-gia (www.archeologiadigitale.it); la concezione, la grafica, i suoni e le immagini sono frutto di un lavoro comune e for-temente integrato, durato oltre un anno. le illustrazioni che accompagnano il testo, a parte quelle per cui è indicatoespressamente l’autore, sono state realizzate da lorenzo Baldassarro.l’impegno, la dedizione e la passione dei giovani ricercatori coinvolti nel progetto sono stati supportati dalle compe-tenze e dall’amicizia di molti:Mario Brambilla e giancarlo D’Incognito che ci hanno mostrato la strada della creatività digitale e aiutato a muoverei primi passi in questo mondo; eva Pietroni e Claudio rufa, pionieri del realtime per l’archeologia; vito santacesaria,che ci ha insegnato quanto sia al contempo faticoso e gratificante lavorare ai dettagli; giuliano volpe, maestro e ispi-ratore da quasi venti anni, Mariuccia turchiano e tutti gli archeologi dell’Università di Foggia impegnati nelle ricerchein Daunia perché siamo cresciuti insieme, scavo dopo scavo. ernesto ancona e i colleghi della segreteria del Diparti-mento di scienze Umane dell’Università degli studi di Foggia per il costante apporto amministrativo e la proverbialepazienza. giovanna Baldasarre, anna Dattolo, alessandra De stefano, anna Introna, alessandra Moro e Marida Piernoper l’apporto alla gestione del progetto. Fabio gagliardi, la cui competenza nel campo della computer graphic è stataun costante punto di riferimento in tutta la lavorazione del prototipo che si presenta in questo volume, pur non essendoil suo nome presente fra gli autori.
Infine un ringraziamento a velia, e certo non solo per aver pazientemente riletto tutto più volte. naturalmente la re-sponsabilità di quanto scritto è solo mia, ma è suo il merito se la lettura risulterà piacevole.
Le attività descritte in questo volume prendono spunto dai risultati del progetto ITINERA (www.itinera.puglia.it), fi-
nanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia, nell’ambito della programmazione regionale per lo sviluppo delle
ICt applicate ai beni culturali (POR Puglia 2000-2006; misura 6.2 azione c), sotto il coordinamento scientifico del prof.
Giuliano Volpe (sul progetto Itinera cfr. De Felice et alii 2007 e De Felice 2008). L’équipe del Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università degli Studi di Foggia è stata capofila del progetto, e ha coordinato il lavoro di un vasto parte-
nariato, composto da enti pubblici (Dipartimento di Studi Giuridici Privatistici, Provincia di Foggia e Agenzia per il
Patrimonio Euromediterraneo), enti di ricerca (Scuola Superiore ISUFI, Dipartimento di Scienze Giuridiche Privati-
stiche e Politecnico di Bari) e imprese private specializzate in computer grafica, web management, editoria e comuni-
cazione.
15
Introduzione
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
An archaeological site is something to be explained
(Barceló 2009, 7)
L’archeologia ha sempre potuto contare su una costante riflessione me-todologica orientata all’affinamento ed al rinnovamento delle proprie pos-sibilità euristiche, perseguite anche attraverso strumenti e tecnicheinnovative, utilizzabili per migliorare i diversi processi di conoscenza. Negliultimi anni non sono mancati importanti apporti che hanno contribuito a de-finire la dimensione globale dell’archeologia del nuovo millennio (Mana-corda 2008, 165). E tuttavia in questo scenario di profondo rinnovamentometodologico, il ruolo attribuito alle tecnologie – e alle ICT soprattutto – ap-pare limitato e circoscritto al miglioramento di alcune procedure operative,quali la gestione di dati e le tecniche di documentazione. Le tecnologie in-formatiche non sembrano ancora dialogare efficacemente con il mondo dellaricerca, relegate come sono, in primis nella didattica universitaria, al ruolodi ‘applicazioni’, quasi come un corpo estraneo che non riesce ad interagirefattivamente nella definizione di un nuovo orizzonte metodologico.
La scarsa maturazione di questo rapporto risalta in modo particolare nelcampo dell’archeologia stratigrafica: se da un lato la nuova visione globaleha ribadito la validità dello scavo stratigrafico, nonché la capacità di analisi,di lettura ed interpretazione delle tracce materiali e della loro ricomposi-zione, dall’altro il contributo delle tecnologie informatiche al miglioramentodelle tecniche di intervento, pur rilevante e innegabile, rimane sostanzial-mente limitato. Ad esse resta di fatto precluso un ruolo attivo in un rinno-vamento più profondo, che coinvolga i processi di indagine, analisi ecomunicazione. È evidente ad esempio come le procedure di intervento sulcampo non siano cambiate di molto, se si escludono i miglioramenti in ter-mini di velocità, reperibilità, accuratezza e sicurezza di dati e informazionie il rinnovamento ‘tecnologico’ che ha interessato ogni équipe di scavo, gra-zie all’uso di strumenti quali i DBMS, i GIS e i CAD che sono ormai il pa-trimonio di base di qualunque archeologo.
Il punto di partenza fondamentale per comprendere i limiti attuali delrapporto fra ICT e archeologia e progettare per il futuro uno scenario di mag-giore interazione è la consapevolezza della necessità di rinnovare i metodioperativi della ricerca, aggiornando anch’essi alla nuova dimensione glo-bale dell’archeologia.
Nel circoscritto orizzonte del metodo della stratigrafia, l’opportunità dirinnovare i processi di analisi e di documentazione archeologica appare ine-ludibile se solo si considera che lo scavo archeologico, nonostante l’evolu-zione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti impiegati, rimaneun’operazione eminentemente distruttiva e irreversibile. Non esiste alcunsistema che possa ricreare l’informazione perduta durante lo scavo e ripa-
17
1.Lo scavo archeologico
fra archeografia digitale e fruizione virtuale
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
rare la distruzione di una sequenza stratigrafica, la cui lettura è sempre con-dizionata dall’ineludibile conseguenza della distruzione del testo stesso (Ca-randini 1991).
È proprio l’impossibilità di riscavare uno strato, riquotare un taglio oripristinare un riempimento, a mostrare quanto sia indispensabile la defi-nizione di una metodologia innovativa di documentazione, capace di ri-durre drasticamente lo spazio vuoto esistente fra il dato stratigrafico e la suaregistrazione. Se infatti si considera il ruolo fondamentale rivestito dal-l’acquisizione dei dati nei processi conoscitivi, non si può non dedurne cheproprio le metodologie e le tecniche di documentazione costituiscono losnodo cruciale nei possibili processi di innovazione dell’archeologia stra-tigrafica.
La documentazione s’impone infatti come il primo livello di astrazionee di ‘alleggerimento’ della realtà materiale, di trasposizione della realtàstratificata in oggetti codificati e in quanto tali comprensibili e confronta-bili. Intervenendo nel processo di documentazione si può ottenere la con-servazione della maggior quantità di informazione, senza stravolgere lametodologia stratigrafica nei suoi principi più profondi. Il problema è chealla così larga condivisione della tecnica di indagine non fa eco un’altret-tanto diffusa e praticata condivisione delle tecniche di documentazione. Gliarcheologi, siano essi specialisti di preistoria e protostoria, classici o me-dievisti, pur concordando con le linee generali di un impianto metodologicoche vede nelle leggi della stratigrafia il minimo comun denominatore delproprio lavoro, si diversificano fortemente nelle metodologie di documen-tazione, in cui invece continua a prevalere largamente una prassi operativa‘artigianale’, particolarmente evidente nelle esperienze di informatizza-zione, spesso autoprodotte e autogestite all’interno delle singole comunitàdi ricerca.
Proprio attraverso il recupero di queste infinite metodologie e la lorocondivisione, resa possibile da reti per la circolazione delle informazioni edall’apertura degli archivi, passa la concreta possibilità di elaborare buonepratiche universali, e di iniziare realmente, dal basso, un percorso di condi-visione che possa portare in futuro alla standardizzazione dei processi didocumentazione (Valenti 2009, 25), magari in maniera meno invasiva e piùefficace rispetto a quanto sperimentato in passato.
È certamente una sfida ampia e problematica, al cui conseguimento èperò legato il futuro della disciplina e la sua capacità di rinnovarsi.
Ma qual è stato il contributo dell’informatica alla definizione e allo stu-dio di possibili soluzioni a questi problemi? E soprattutto, esiste una possi-bilità concreta di immaginare uno scenario futuro diverso, caratterizzato dauna maggiore interazione fra informatica e archeologia?
Se è infatti innegabile che proprio dal rapporto con le tecnologie in-
18
Una macchina del tempo per l’archeologia
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
formatiche siano scaturite le principali novità metodologiche degli ultimianni, non è tuttavia facile estrarre delle linee di tendenza ed evoluzioneda uno scenario in cui la diffusione dell’informatica riguarda tutti gliaspetti della pratica archeologica, senza che si possano individuare unfilo logico o una guida unitaria. Seguendo l’evoluzione di questo rap-porto dalle sue fasi pioneristiche alla situazione odierna (Djindjian 2009,Orlandi 2009) si coglie il passaggio da una situazione in cui l’applica-zione dell’informatica alla ricerca archeologica ha significato soprattuttoun’attenzione concentrata sulle fasi di raccolta e analisi dei dati versouno scenario caratterizzato da un’‘esplosione’ di sperimentazioni ed espe-rienze applicative.
La fiducia nelle infinite capacità di calcolo delle macchine ha portatoalla creazione di sistemi che hanno facilitato la gestione dei dati e semplifi-cato le attività di documentazione, ma nel contempo l’informatica ha con-tinuato ad essere considerata uno strumento rapido e potente di gestione,archiviazione ed elaborazione, nulla di più. Di recente essa ha iniziato a ri-vestire un ruolo decisamente più ampio dell’aiuto nella catalogazione, purragionata e potente, della massa di dati che la parte analitica del percorso dicreazione di conoscenza tipico dell’archeologia prevede, e ad avere un pesodeterminante nei processi di interpretazione e nei modi di percezione deidati (Forte 2007, 6). Se i sistemi GIS hanno introdotto in campo archeolo-gico la possibilità di generare conoscenza, attraverso processi di sintesi ge-stiti con l’aiuto di tecnologie informatiche, lo sviluppo dell’archeologiavirtuale ha portato alla sperimentazione di nuovi approcci cognitivi semprepiù ‘densi’.
Una caratteristica comune a tutti i sistemi ed esperimenti è tuttavia un so-stanziale disordine metodologico, cui corrisponde quella polverizzazionedelle esperienze visibile nello sviluppo di database, di sistemi GIS e di al-tri strumenti, creati in modo autonomo all’interno di singole équipe o per sin-goli progetti di ricerca, che, lungi dal contribuire a sistematizzare le prati-che di indagine, hanno viceversa contribuito a rendere più complesso il giàarticolato mondo delle metodologie di dominio. L’evoluzione tecnologica hamesso a disposizione del singolo utente/ricercatore una potenza di calcolosempre maggiore, e parallelamente al compattarsi delle macchine si è veri-ficato un ridimensionamento della scala delle applicazioni (Zubrow 2006).In altri termini la disponibilità di elaboratori potenti e la conseguente proli-ferazione di approcci ed esperimenti ha aperto le porte ad un’introduzionemassiccia dell’informatica come supporto alla ricerca, ma ha aggiunto aglistorici problemi di identificazione e adozione di standard di documentazionenuovi problemi legati a nuovi standard (D’Andrea 2006), a livello di formato,metodi di codifica e trattamento dei dati. Paradossalmente le tecnologie in-formatiche hanno contribuito a diversificare e complicare ulteriormente un
19
1. Lo scavo archeologico fra archeografia digitale e fruizione virtuale
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
quadro caratterizzato da un livello già alto di moltiplicazione delle espe-rienze.
Questo contributo intende andare nella direzione di una possibile esten-sione del nesso archeologia-informatica all’intero processo di conoscenza ar-cheologica, verso un progresso metodologico che si possa definire globale.Il punto di partenza di un nuovo approccio, dovrà necessariamente essere ilsuperamento dell’attuale fase di ‘trionfo’ (Orlandi 2009, 18-19) della tec-nologia nei rapporti fra informatica e discipline umanistiche, e la riproposi-zione della centralità del ‘discorso sul metodo’ che ne eviti rischioseemarginazioni a favore della cattiva pratica (Forte 2007, 5-6).
In altre parole la scelta di suggerire riflessioni teoriche e concrete speri-mentazioni in vista di un rinnovamento in chiave tecnologica delle meto-dologie archeografiche, o almeno di parte di esse, vuole esseretestimonianza di un nuovo possibile rapporto fra metodo della stratigrafiae ICT che preveda un “maggiore riguardo agli aspetti metodologici” (Or-landi 2009, 12). Solo attraverso la revisione dei processi di documentazioneattualmente in vigore sui cantieri di scavo sarà possibile rendere l’attivitàarcheografica un supporto sempre più utile alla ricostruzione storica e anuovi paradigmi di percezione, che superi l’attuale modello, creato in pre-valenza per compiti di tipo amministrativo e gestionale, e pertanto privo diuna prospettiva aperta agli aspetti di contestualità, interattività e multivo-calità.
Registrare la distruzione
Nella metodologia stratigrafica corrente, il risultato finale dell’indaginesul campo è costituito da un insieme di documentazione che organizza daticlassificati secondo criteri tipologici e contestualizzati. Questo “primo set diinformazione” (Forte 2006, 29) offre l’input per costruire le principali rela-zioni di spazio e tempo che legano tutti gli elementi raccolti con la sequenzastratigrafica di un intero sito. Il processo di interpretazione, che conduceverso momenti successivi di sintesi storica, non parte infatti soltanto dal-l’analisi dei dati raccolti durante le operazioni di scavo, ma anche e in granparte dalla lettura critica della raccolta dei documenti che li descrive, clas-sifica e contestualizza. Sono infatti i prodotti scritti, grafici e fotografici, acostituire ancora oggi la base dell’operazione di sintesi, in quanto lo svi-luppo di forme innovative di gestione (ad esempio la comunicazione intempo reale tramite tecnologie web), non ha messo in discussione il nessofra metodo stratigrafico e procedure tradizionali di documentazione.
Gli importanti tentativi, mai portati a compimento, di normalizzare e for-malizzare la pratica di documentazione sono stati eseguiti in passato a valle
20
Una macchina del tempo per l’archeologia
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
1 www.londoncharter.org. Cfr.Beacham, Denard, Niccolucci2006. Il corso di e-learning fi-nalizzato alla realizzazione di do-cumentazione 3D compliant èstato realizzato nell’ottica di re-digere buone pratiche diretta-mente funzionali rivolte a quan-ti operano sul campo. Cfr. infra,Materiali 1.
della definitiva affermazione in Italia della metodologia stratigrafica (Ca-randini 1990, Manacorda 1990, Carandini 1991, 86-99): la stagione della si-stematizzazione, iniziata in epoca predigitale con la redazione di alcuni do-cumenti schedografici, è finita precocemente, né l’avvento dell’informatiz-zazione anche in campo umanistico è riuscito a imporre standard o quanto-meno pratiche condivise nella realizzazione e gestione della documentazione,ma ha avuto piuttosto, come si diceva, l’effetto opposto di moltiplicare le spe-rimentazioni.
L’utilizzo delle tecnologie di gestione dell’informazione ha in fin deiconti fatto risaltare quanto il dominio della conoscenza archeologica sia an-cora (o forse definitivamente?) poco formalizzabile. L’informatizzazionedelle attività di scavo si è tradotta in un aiuto fondamentale nella gestionedi dati e informazioni, esercitando anche una (parziale) spinta all’innova-zione della pratica della documentazione, che continua a rappresentarel’unica immagine delle fonti primarie nell’indagine stratigrafica. Gli stru-menti di gestione informatici hanno migliorato notevolmente la qualità deiprocessi esistenti, ma non hanno modificato in profondità le fasi di indaginee di registrazione dei dati.
Se è vero che i database e i GIS di scavo aiutano nella gestione e sonodi per sé sufficienti a trattare correttamente i dati archeologici (Valenti 2009),è anche vero che la ‘vecchia’ documentazione, sia essa scritta, grafica o fo-tografica, rimane nella maggior parte dei casi il fulcro dell’attività descrit-tiva della stratigrafia.
Nel settore della documentazione grafica, o più in generale di quella vi-suale, le innovazioni riguardano soprattutto la speditività e affidabilità, maanche in questo ambito si è ancora lontani dal definire buone pratiche con-divise per la realizzazione di set di documentazione innovativi. Le principalinovità in questo campo sono legate al progressivo utilizzo di soluzioni peril rilievo, il disegno e la modellazione tridimensionale. Al momento attualela prospettiva di un utilizzo profondo e diffuso del 3D è ancora ferma a fon-damentali ma ancora molto generiche linee guida 1, cui fanno da contraltareuna enorme serie di sperimentazioni. Negli ultimi anni si è discusso mol-tissimo, ad esempio, di uso di nuovi strumenti, misurando la loro innovati-vità in base alla tecnologia di funzionamento, che pure rimane caratteristicaassolutamente astratta e secondaria se considerata dal punto di vista del-l’operatore sul campo.
Le tecnologie di rilievo tridimensionale, a cominciare dalla scansionelaser, hanno avuto l’indubbio merito di portare il 3D nel dibattito metodo-logico, ma una fase di valutazione orientata a importare nella metodologiadi ricerca sul campo le potenzialità di un processo di documentazione tridi-mensionale è solo agli inizi; e questo nonostante risulti evidente una que-stione di fondo, relativa alla sostenibilità dell’utilizzo di strumentazioni quali
21
1. Lo scavo archeologico fra archeografia digitale e fruizione virtuale
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
il laser scanner nelle fasi di documentazione stratigrafica (Laurenza, Putzolu2008, Sibilano 2008), legata a problemi di accesso (ed eccesso!) ai dati.
Se si considera ad esempio la mole di dati prodotta da questo tipo di stru-menti per caratterizzare gli oggetti rilevati (le nuvole di punti), balza agliocchi la necessità di una profonda riflessione sui termini di utilizzo, all’in-terno di quel percorso di ‘alleggerimento’ affidato alla documentazione, checonduca verso la sintesi. Gli output prodotti dai sistemi di scansione tridi-mensionale non rappresentano, dal punto di vista stratigrafico, oggetti inte-ressanti in sé, ma necessitano di una lunga fase di adattamento, tale, a volte,da metterne in discussione l’utilità stessa. Poiché il rilievo, in quanto ope-razione funzionale all’intero sistema conoscitivo (Medri 2000; Medri 2003,IX), è una componente fondamentale nei processi archeografici, anche inquesto caso ogni innovazione tecnica e tecnologica deve essere sempre va-gliata dal punto di vista dell’archeologia, e non dell’innovatività fine a sestessa (De Felice et alii 2008a).
Ben consci della natura multidimensionale della stratigrafia e della ne-cessità di una metodologia di documentazione che sia in grado di registrarlaadeguatamente, siamo giustamente attirati dalle possibilità offerte dalle tec-nologie di rilievo che riescono a preservare la fisicità della realtà, evitando icompromessi inevitabili nel processo di ‘compressione’ bidimensionale. Nonsi tratta però di stravolgere una corretta metodologia, che rimane sempre fon-data sulle competenze stratigrafiche degli archeologi e sulla capacità di saperdeterminare le giuste tecniche e i giusti metodi, ma di ampliare i campi di ap-plicazione del 3D andando oltre il rilievo o la modellazione finalizzata allaricostruzione, e porre le basi per lo sviluppo di tecniche di visualizzazionescientifica, profondamente legata alle istanze del dominio.
Le riflessioni metodologiche hanno da tempo messo in piena luce la na-tura multidimensionale della stratigrafia, mostrando quasi profeticamentein un’epoca ancora lontana dalle conquiste della virtualità digitale, come tredimensioni siano del tutto insufficienti a descrivere una realtà densa e com-plessa come una sequenza stratigrafica (Carandini 1991). Ma l’indicazionenon è stata ancora recepita dalle tecniche archeografiche, che continuano afondarsi sulla produzione di elaborati bidimensionali, affidando la profon-dità e il tempo a criteri di rappresentazione ormai obsoleti, che comportanouna drastica riduzione dal punto di vista qualitativo e quantitativo dei datidisponibili.
Per raggiungere un risultato realmente innovativo e significativo sarebbeopportuno stabilire soluzioni universali per la realizzazione di una docu-mentazione complessiva tridimensionale, resa necessaria dalla perdita di in-formazioni che ogni elaborato grafico bidimensionale fatalmente comporta,quasi che le piante, i prospetti e le sezioni rappresentino per gli archeologi
22
Una macchina del tempo per l’archeologia
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
un insieme di archetipi, oltre i quali non si può risalire, data l’impossibilitàdi riaccedere agli originali.
La realizzazione di forme di documentazione tridimensionale che per-mettano di superare questo limite è ancora nella fase sperimentale, l’atten-zione è più concentrata sull’individuazione della tecnologia più adatta chesul problema globale della gestione dei dati, la cui centralità non è affatto datrascurare. È facile prevedere come le maggiori problematiche che si do-vranno affrontare nel prossimo futuro riguarderanno infatti, più che la sceltadel miglior metodo di misurazione, che rimarrà sempre prerogativa dell’ar-cheologo (Bohler 2005), la gestibilità dei dati e la compatibilità fra differentisorgenti.
L’esigenza che si pone è quella di impostare processi di produzione e ge-stione della documentazione tridimensionale che non siano esclusivamentefini a se stessi, ma realmente innovativi e migliorativi. Affinché essi possanodiventare a tutti gli effetti parte integrante di un nuovo modo di documentaredevono necessariamente risultare impraticabili per tutti, come lo sono le tec-niche e gli strumenti attualmente in uso. Questi processi ad esempio non pos-sono essere legati a tecnologie impraticabili per costo, complessità e onerositàdi gestione, che finirebbero col rendere l’innovazione metodologica scarsa-mente diffusa e quindi ampiamente inefficace; dovrebbero essere consoni allaattività di scavo, speditivi e funzionali affinché non divengano protagonistima affianchino e supportino il lavoro quotidiano; devono infine essere fina-lizzati ad una condivisione libera e aperta dei dati e delle informazioni, evi-tando soluzioni proprietarie e chiuse che vanno nella direzione opposta rispettoalla prioritaria istanza di condivisione del patrimonio culturale.
Si evince chiaramente come questo discorso sia in definitiva solo unaparte di un problema più ampio che coinvolge il complesso di conoscenzalegato ai processi di ricerca archeologica, sia quello accumulato nel corsodelle indagini sia quello – molto più imponente – depositato negli archivi.‘Scavare in archivio’ è infatti un’operazione fondamentale, ed è necessarioche una nuova metodologia preveda opportuni meccanismi di digitalizza-zione, mirati non solo alla preservazione, alla gestione ed all’accesso dellerisorse, ma anche ad una loro predisposizione per l’inserimento in ambientidigitali in cui possano convivere con i documenti digital born.
Ricomporre i frammenti
Nel percorso di acquisizione della conoscenza proprio dell’archeologiastratigrafica gli elaborati, esito delle operazioni di documentazione, sono iprincipali strumenti utilizzabili per l’avvio delle fasi di interpretazione. È in-fatti proprio a partire dall’abbandono della materialità e dalla ‘relativa’ og-
23
1. Lo scavo archeologico fra archeografia digitale e fruizione virtuale
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
24
Una macchina del tempo per l’archeologia
2. - Ricerca, ricostruzione, ipotesi di interpretazione. Esempio della cenatio di Faragola.
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
gettività dei documenti redatti sul campo che prende le mosse un processoteso alla ricostruzione storica, attraverso momenti di sintesi crescente, checondurrà al “racconto delle vicende umane” (Carandini 1991, 138). Ognitappa di questo flusso deduttivo produce interpretazioni e ricostruzioni: im-maginare l’articolazione degli spazi di un insediamento o l’utilizzo del ter-ritorio in una data epoca è infatti un’operazione creativa, costantementeispirata dalla documentazione disponibile, una lenta e laboriosa pratica di ri-composizione condotta a partire da tracce ed elementi parziali, resi eloquentidalla loro collocazione in una sequenza logica e temporale. Radicato nelmetodo di lavoro dell’archeologo, il processo deduttivo di interpretazione di-venta pratica scientifica solo se condotto all’interno di coordinate metodo-logiche precise e se supportato da tecniche di documentazione adeguate.
In questa luce l’imbarazzo dell’impossibilità di ricostruire bene, o inmodo attendibile, finisce con l’essere un problema più apparente che reale,se si considera l’ampio sostrato di interpretazione sotteso ad ogni ricostru-zione: ogni ipotesi è il frutto di una serie di scelte, e non è quasi mai possi-bile scartarle tutte per privilegiarne una (fig. 2).
Quale potrebbe essere il ruolo dell’informatica, ed in particolare dellacomputer graphic, in questo processo, costantemente in bilico fra analisi edimmaginazione? I risultati di un’indagine stratigrafica, frutto di un percorsodi astrazione crescente verso la sintesi e l’interpretazione che trasformatracce labili e apparentemente prive di significato in complesse ipotesi diricostruzione storica, sono destinati a rimanere “verità incerte” (Carandini2012, 25). La natura frammentaria, fragile ed evanescente del dato strati-grafico rende infatti straordinariamente complesso e delicato il processo diinterpretazione e ricostruzione che rappresenta il risultato più importante –e avvincente – del mestiere di archeologo. La possibilità di interpretare, e diconseguenza di rappresentare adeguatamente, un sito archeologico è quindistrettamente connessa con la metodologia applicata nelle diverse fasi di ri-cerca e con le tecniche di documentazione utilizzate per registrare i dati.
Che l’uso della computer graphic nei processi di interpretazione costi-tuisca uno strumento dalle enormi potenzialità risulta evidente se si consi-dera come gran parte del processo deduttivo-ricostruttivo riguarda una realtàtangibile, ma avviene in definitiva in uno spazio virtuale multidimensionalequale è l’immaginazione.
Soprattutto l’introduzione di tecniche di documentazione innovative po-trebbe apportare novità sostanziali, avviando il superamento di una praticaarcheografica bidimensionale e per forza di cose fortemente simbolica qualeè fondamentalmente quella vigente. Si tratta di portare ulteriormente avantiil processo di liberazione dagli artifici della rappresentazione, già iniziatocon l’avvento dei sistemi CAD ed affrancare le tecniche di documentazionedalla necessità di ragionare in ‘spazio carta’ (De Felice 2008, 14).
25
1. Lo scavo archeologico fra archeografia digitale e fruizione virtuale
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
26
3. - Piante di fase tridimensionali elaborate per la costruzione della TimeMachine.
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
Solo se abilitate ad intervenire già nella fase di lavoro sul campo, nelmomento cioè in cui le fonti diventano archetipi, le tecnologie di visualiz-zazione tridimensionali possono giocare un ruolo realmente innovativo edeterminante nell’intero processo di ricerca stratigrafica, radicandosi pro-fondamente nel meccanismo di conoscenza in tutte le tappe del lungo per-corso di lavoro dell’archeologo, “dallo scavo all’edizione”. È in unoscenario del genere che le possibilità offerte da una gestione della docu-mentazione di scavo su base tridimensionale e realmente integrata nei pro-cessi archeografici possono portare il ruolo della virtual archaeology oltrel’orizzonte delle ricostruzioni monumentali. Ad esempio, generando elabo-razioni di quei pilastri del ragionamento deduttivo quali sono le piante distrato o le piante di fase che, proprio in quanto tridimensionali siano nonsolo più espressive e comunicative, ma anche più ‘vere’ (fig. 3).
In questa prospettiva le problematiche relative alla pratica del rilievo tri-dimensionale appaiono solo uno degli aspetti legati al più vasto problema didefinire ruolo e finalità della virtual archaeology superandone definitiva-mente la concezione riduttiva che ne fa un sinonimo di ricostruzione di mo-numenti e siti. In un’ottica più ampia, che coinvolga il più completo concettodi visualizzazione e virtualizzazione dell’intera realtà archeologica, anche imodelli ricostruttivi tridimensionali possono svolgere un ruolo fondamen-tale, proponendo ambienti di sperimentazione e di analisi spaziale fondati sunuovi paradigmi di percezione (Forte 2007, 23-31; Stanco, Tanasi 2009;Maschek, Schneyder, Tschannerl 2009).
Nello scenario attuale invece l’interesse verso le tecnologie di com-
puter graphic e la loro applicazione all’archeologia sembra guidato da unavisione obsoleta e riduttiva del principio di ricostruzione, assimilato spessoin modo apodittico al più banale concetto di anastilosi monumentale. A do-minare la scena è soprattutto la ricerca del realismo, che porta inevitabil-mente ad uno stallo fra le lacune di ogni ricostruzione e le potenzialitàrappresentative delle nuove tecnologie, queste ultime pronte a restituire ildettaglio più minimale nel modo più verosimile, anche quando giungere aduna ricomposizione realistica si riveli fin dall’inizio un’impresa utopistica,destinata a confezionare veri e propri falsi.
Sembra di ritrovare spesso, sottesa ai progetti di ricostruzione virtuale,un’idea anacronistica di archeologia, che tende a privilegiare l’aspetto mo-numentale, in contrasto con la realtà di quanti operano quotidianamente sulcampo, in cui non solo la maggior parte dei siti archeologici non restituiscetracce sufficienti a ricostruire in modo organico le sue diverse fasi di vita,ma raramente conserva resti significativi. Il ‘valore’ di un sito archeologiconon è espressione della grandiosità delle sue vestigia, ma va cercato piutto-sto nella possibilità di ricomporre i frammenti di storia nascosti in quelletracce che il metodo stratigrafico è capace di leggere (Manacorda 2007, 76-
27
1. Lo scavo archeologico fra archeografia digitale e fruizione virtuale
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
81; De Felice, Sibilano, Volpe, 2008a); sarebbe un errore imperdonabile se-lezionare l’interesse di un sito da analizzare – e ricostruire – solo in virtù del-l’imponenza dei suoi resti, ripristinando, questa volta su basi digitali, quellasorta di ‘ossessione’ di antica memoria verso singoli e predeterminati pe-riodi storici (Manacorda 2004, 112).
Prima che sul virtuosismo realistico, la qualità e attendibilità del modellosi fonda infatti sulle capacità interpretative degli archeologi, filtrate dalladocumentazione realizzata, portatrice dell’informazione necessaria per de-cifrare e ricostruire. Riportato in queste coordinate, il momento della rico-struzione si manifesta in tutto il suo valore di passaggio logico, verso livellidi astrazione crescenti, e, inevitabilmente, crescenti elementi di dubbio.
In definitiva, da un punto di vista prettamente archeologico, la possibi-lità di immaginare un modello ricostruttivo di un sito archeologico, e di rea-lizzarlo in computer graphic, va ricercata nella metodologia impiegatadurante le procedure di indagine, e quindi anche nei dati registrati dalla do-cumentazione. E se nella pratica dello scavo archeologico l’uso di strumentie soluzioni innovative è destinato a modificare il modo di redigere la docu-mentazione, più complessa e tortuosa appare invece la strada verso la loroapplicazione alle fasi di interpretazione e ricostruzione, in cui le tecniche dirilievo e la modellazione tridimensionale non esprimono ancora pienamentela loro aspirazione a divenire la risposta alla ‘sfida’ perenne della ricostru-zione in archeologia.
Raccontare l’incertezza
Le considerazioni espresse finora ci conducono verso il punto centraledel nostro ragionamento, ovvero il problema della fruizione nel settore del-l’archeologia stratigrafica: come conservare intatta e rendere comprensibileall’esterno del mondo scientifico la quantità di informazioni e dati che co-stituisce la ricchezza e la peculiarità del complesso di conoscenze insito inogni processo di indagine stratigrafica?
Diffondere i risultati delle proprie ricerche è più che una possibilità, un do-vere civico dell’archeologo nei confronti della società (Carandini 2000, 149;Vannini 2011) ma anche una delle sfide più complesse e delle ragioni piùprofonde del fare archeologia (Manacorda 2007, 100-105). Lungi dall’essereuna disciplina neutra, l’archeologia ha sempre sviluppato un enorme poten-ziale nella possibilità di costruzione dei rapporti tra una società e il suo pas-sato, conoscendo momenti di altissima divulgazione e anche tragici episodidi manipolazione. Un potenziale che è rimasto a lungo inespresso, a vantag-gio dell’atteggiamento erudito, non ancora totalmente estinto, che per de-
28
Una macchina del tempo per l’archeologia
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
cenni ha portato a considerare le scoperte archeologiche, ed il bagaglio co-noscitivo ad esse connesso, appannaggio esclusivo degli addetti ai lavori.
Ancora troppo spesso si opera secondo una distinzione del tutto anacro-nistica fra comunicazione scientifica e divulgativa, che paradossalmente fi-nisce per consegnare gli strumenti più innovativi e potenti in mano a‘cacciatori di tesori’ (Carver 2011, 163) e professionisti della comunica-zione, incapaci di garantire anche l’attendibilità dei contenuti (D’Agata2009, 21-22). Si spiega così ad esempio il proliferare in rete, nelle edicolee nelle librerie, di prodotti multimediali fortemente appetibili e tecnicamenteineccepibili, che finiscono con l’alimentare in maniera latente un’idea ‘ro-mantica’ di archeologia e con l’avallare la separazione fra divulgazione e ri-cerca.
Negli ultimi decenni in Italia è cambiato radicalmente il rapporto tra icittadini e l’archeologia: oggi appare scontato che ogni intervento sul patri-monio storico-archeologico sia oggetto di interesse per l’opinione pubblicae venga di conseguenza trattato come un evento da diffondere attraverso ap-propriati modelli e canali di comunicazione. L’atteggiamento del mondodella ricerca rimane su questo versante passivo e colpevole di scarsa atten-zione, quasi che si sia persa la coscienza delle potenzialità culturali, civili,formative dell’archeologia nei confronti della società. Imparare a esprimersiin maniera moderna ed evoluta, senza separare conoscenza e comunicazione(Forte 2007, 23), o dati e interpretazione, può e deve essere invece unanuova frontiera anche per il mondo della ricerca, depositario di saperi chesoli, permettono di trasmettere accanto ai risultati anche il processo funzio-nale ad acquisirli.
Ogni sito archeologico è un oggetto complesso, visitabile in una plura-lità di momenti, ma anche in diversi modi, che possono rappresentare i pre-supposti di molteplici e significativi percorsi di fruizione. Raramente infattiun sito archeologico è ascrivibile ad una sola fase di vita, e ancora più rara-mente il suo stato di conservazione rappresenta uno stadio indicativo dellasua evoluzione. Ogni sito ha vissuto lunghe fasi di vita, accumulando e so-vrapponendo tanti capitoli di una storia, la cui ricostruzione merita di es-sere raccontata pagina per pagina. Le tecnologie di visualizzazione possonosvolgere un ruolo importantissimo nel descriverla, rendendo viva una di-mensione immaginaria che non è possibile cogliere nella realtà. Esse pos-sono essere impiegate non solo per mirare a ricostruzioni più realistiche (manon per questo più ‘vere’), ma piuttosto per una comunicazione coinvol-gente e densa del rapporto fra tracce oggettive e interpretazione soggettivae per la restituzione della sovrapposizione di una molteplicità di fasi in unamedesima unità di luogo.
Ogni sito archeologico è quindi un luogo multidimensionale, caratteriz-
29
1. Lo scavo archeologico fra archeografia digitale e fruizione virtuale
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
zato da una pluralità di evidenze, che può essere decifrato a partire da di-verse chiavi di lettura:
– la documentazione: sempre alla base dei lavori di analisi e di inter-pretazione di ogni fase di vita, a sua volta costituisce una dimen-sione, che, per quanto astratta, rappresenta il punto più vicino aduna realtà materiale non più integralmente esistente;
– la dimensione diacronica, costituita dalla successione di fasi di vitasovrapposte nello stesso luogo, ognuna ricostruita sulla base del-l’interpretazione di tracce parziali;
– le diverse ipotesi formulate, dato che spesso il lavoro di interpreta-zione porta all’elaborazione di vari modelli, senza che sia possibileprivilegiarne alcuno, o validarlo come ‘vero’;
– infine, solo in ultima istanza, i resti che rimangono visibili sul sito.
Ciascuna di queste dimensioni è parte di un multiforme sistema cono-scitivo a cui le moderne tecnologie di visualizzazione possono fornire stru-menti estremamente persuasivi, e la cui complessità reclama una fruizionevirtuale, che consenta di utilizzare livelli di astrazione adeguati alla rappre-sentazione di una materialità diacronica, ipotetica e frammentaria. L’inda-gine stratigrafica implica infatti una continua valutazione di quanto indagare,quanto conservare e quanto occultare o, al peggio, distruggere, e l’obbligoconseguente di attuare una organica strategia di intervento, conservazione evalorizzazione, che tuttavia non potrà che essere selettiva.
Non si tratta di sfruttare i modelli virtuali per poter uscire agevolmentedall’imbarazzo di selezionare cosa preservare, confortati dalla consapevo-lezza che nello spazio virtuale si può conservare tutto e cancellare tutto, mapiuttosto di sfruttare pienamente le tecnologie di visualizzazione per rac-contare con estrema efficacia quella straordinaria complessità che caratte-rizza un sito a continuità di vita, che nessuna strategia di valorizzazione‘fisica’ sarà mai in grado di offrire. Esse permettono infatti di conoscere intempo reale ciascuna delle fasi di vita che hanno interessato un sito, senzaoperare alcuna selezione a priori, ma esaltando nella sua profondità il con-
tinuum temporale che costituisce la quarta dimensione di ogni ricostruzionearcheologica; allo stesso tempo consentono di navigare liberamente in unadimensione astratta e surreale quale è quella della documentazione. Ren-dere chiara, fruibile e affascinante una dimensione come la stratigrafia èquindi una sfida ambiziosa (Manacorda 2007, 102) che richiede un approc-cio ampio, in grado di andare oltre la banale sovrapposizione fra layer vir-tuale ricostruttivo e stato di conservazione, poco efficace non solo perchéselettivo, ma perché rischia di avallare una visione piatta e semplicistica delprocesso analisi/interpretazione.
30
Una macchina del tempo per l’archeologia
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
Le possibilità offerte dalle tecnologie di computer graphic sono pratica-mente infinite e invitano a immaginare nuovi modelli di fruizione e nuovilinguaggi di narrazione, che possano raccontare l’intera serie di informa-zioni che un sito porta con sé, e che solo in minima parte sono leggibili au-topticamente. Esse reclamano in altre parole la necessità di elaborare unastrategia per la comunicazione, che comprenda la scelta dei temi e dei lin-guaggi più opportuni (Paolini, Di Blas 2009), e che le includa sin dalla fasedi progettazione delle attività di conservazione e valorizzazione. Trascurarele possibilità offerte dai nuovi strumenti e dalle nuove tecnologie, impedirecioè il dialogo fra questi e il sostrato metodologico, rischia di implicare il de-finitivo abbandono delle istanze più profonde della ricerca archeologica.Ben vengano dunque strumenti che possono aumentare le possibilità di com-prendere e di comunicare dati e immaginazione, se è vero che “l’osserva-zione archeologica non può fare a meno di pensare anche a ciò che è statoe non è rimasto, come l’impeto dei cavalli a Waterloo e il lampo della bombache distrusse Hiroshima o gli sguardi stupiti dei nativi d’America verso lecaravelle di Colombo” (Manacorda 2004, 7).
In conclusione, nei modelli ricostruttivi, in cui l’uso delle tecnologie divisualizzazione tridimensionali è ormai una realtà consolidata, ancora tropporaramente si stabilisce un collegamento con le fasi di acquisizione dei datiche costituiscono il fondamento della ricostruzione. Spesso i modelli risul-tano slegati dal processo di ricerca e documentazione che li ha generati,quasi che seguano una logica obsoleta finalizzata allo studio del singolo ma-nufatto piuttosto che di interi contesti e di complessi processi di trasforma-zione. In questo scenario negli ultimi anni alcune soluzioni tecnologiche ealcuni importanti progetti si sono imposti per la loro capacità di trasportareil grande pubblico in quella dimensione virtuale che è il passato, e non sonomancati esempi di forte impatto e grande valenza comunicativa.
La strada su cui proseguire passa obbligatoriamente attraverso il defini-tivo affrancamento dalla ambigua prospettiva di ‘classicità’ dell’antico (Set-tis 2004) e il superamento della semplicistica identificazione fra archeologiae monumento, retaggio di una logica antiquaria che si immaginerebbe tra-montata da secoli. Una disciplina che lavora su frammenti non può non darsicome obiettivo prioritario quello di comprendere, ricostruire, rendere vivoe leggibile il passato. È in questo spazio fra tracce e immaginazione, fra “ri-produzione del mondo e creazione di mondi possibili” (Moscati 2009, 191)che opera l’archeologo, e dove le metodologie trovano il loro vero e pro-fondo significato.
31
1. Lo scavo archeologico fra archeografia digitale e fruizione virtuale
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
Long ago I had a vague inkling of a machine (...) that shall travel indifferently in any direction of Space and Time,
as the driver determines.
(H.G. Wells, The Time Machine, 1895, c. 1)
Il metodo
La TimeMachine è il prototipo virtuale di un’esperienza archeologica,progettato con lo scopo di rendere fruibile e coinvolgente il sistema di co-noscenza complesso, sotteso ad un processo di indagine archeologica stra-tigrafica.
Le caratteristiche di questo sistema di conoscenza sono molteplici:
– Complessità. Componenti di natura diversa concorrono alla descri-zione di un sistema unitario; diversi tipi di oggetti (stratigrafie di ac-cumulo, negative e murarie, reperti, ecc.) richiedono metodi e tecnichedi elaborazione differenti, che da un lato rispettino il valore scientificoe dall’altro ne permettano la fruibilità.
– Lacunosità. Una forte cesura separa le tracce residue degli oggetti dalloro aspetto e dalla loro funzione originari. Nessun elemento del si-stema di conoscenza è utilizzabile attraverso un semplice rilievo delsuo stato di conservazione, ma richiede una elaborazione ricostruttivamediata fra attendibilità e istanze di comunicazione che ne restituiscaun’immagine comprensibile.
– Astrazione. La lacunosità della base di conoscenza implica l’impossi-bilità di giungere a risultati certi e di proporli per la fruizione. Gli esitidi interpretazione e ricostruzione sono sempre contraddistinti da unacomponente ipotetica che costituisce parte integrante ed ineliminabiledel sistema stesso.
– Diacronia. La sovrapposizione topografica non è di per sé sinonimo diidentità di forma e funzione; la dimensione temporale costituisce unacoordinata imprescindibile e fortemente caratterizzante del sistema diconoscenza, e richiede l’elaborazione di una strategia di comunica-zione in grado di esprimerla in modo adeguato.
– Metodologia. La quantità e la qualità degli elementi che compongonoil sistema di conoscenza è espressione diretta delle metodologie e delletecniche impiegate durante le fasi di analisi ed elaborazione, che co-stituiscono un elemento del sistema stesso. In particolare è il confrontofra fonti e interpretazione a costruire i nessi che collegano le tracce in-dividuate con la ricostruzione delle fasi di vita di un insediamento e arendere il sistema in grado di produrre nuova conoscenza.
La progettazione del prototipo ha inteso espressamente sperimentare lapossibilità di un processo, fondato sul rapporto dialettico fra ricerca e crea-tività, innovativo non solo nelle tecnologie utilizzate ma anche nei contenutidi fruizione erogati.
33
2. La TimeMachine
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
Le principali sfide che ci si è trovati ad affrontare sono state da un latola definizione di una regia e di uno stile in grado di valorizzare le caratteri-stiche del sistema di conoscenza e dall’altro la determinazione di un rap-porto costantemente vivo e visibile fra fruizione e ricerca, nel tentativo dirispondere alla necessità di raccontare, trasmettere e rendere affascinanti icaratteri che ogni sito archeologico possiede.
Il punto di avvio nella realizzazione del prototipo è stata l’analisi dellaconoscenza formale di dominio e delle tante competenze insite nella ricercaarcheologica, finalizzata a delineare un percorso di creazione di contenuti ra-dicati in questo straordinario patrimonio. Tale percorso si è mosso dall’os-servazione delle metodologie di ricerca sul campo, e soprattutto dall’analisidelle fonti formali – la documentazione stratigrafica – finalizzate a speri-mentare la loro utilizzabilità ai fini della creazione di un prodotto di comu-nicazione digitale.
Ne è risultato un set di fonti elaborate (la documentazione grafica tridi-mensionale) sviluppato a partire da strumenti e soluzioni che garantisserouna integrazione fluida e continua dei dati raccolti e analizzati nelle proce-dure di ricerca scientifica all’interno del prodotto di comunicazione; è statopertanto prioritario assicurarsi che la fonte elaborata da un lato conservassesignificatività e fosse pienamente rappresentativa del suo modello formale,e dall’altro risultasse ottimizzata per una sua implementazione in un pro-cesso di produzione. Il sistema di digitalizzazione della documentazionepermette infatti la conservazione di un significativo rapporto con il suo ar-chetipo formale e la piena compatibilità con le soluzioni tecnologiche scelteper trasformarle in un prodotto di comunicazione efficace.
L’ultima tappa del processo è stata la scelta di un linguaggio narrativoadeguato a supportare un insieme articolato della documentazione e a ren-dere visibili le “infinite prospettive” (Forte 1996) generate da un modello tri-dimensionale, valorizzando un dominio di conoscenza ben più complesso diquanto il dualismo stato di conservazione/anastilosi sia in grado di rappre-sentare.
Nel percorso che conduce l’archeologo dalla ricerca alla ricostruzione diun sito pluristratificato, esiste infatti una componente fortemente virtuale,connessa alla natura multidimensionale della realtà stratigrafica, che emergein ogni momento della ricerca, dalle fasi di indagine sul campo a quelle dianalisi e di documentazione, in particolare quando il procedere delle opera-zioni di scavo genera momenti paradossali, in cui coesistono tracce di statidiversi, non necessariamente ‘vissuti’ insieme. Nei momenti dell’interpre-tazione, della sintesi e della narrazione, l’archeologo spazia fra documenta-zione e segni residui, inseguendo una ricostruzione delle fasi di vita che nonpotranno mai essere percepite integralmente nella realtà.
Il prototipo di TimeMachine intende rispondere alla doppia sfida di ren-
34
Una macchina del tempo per l’archeologia
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
dere evidenti e fruibili in modo pieno e denso le molteplici componenti chepopolano questa dimensione virtuale: tracce archeologiche, documenta-zione, ipotesi interpretative, modelli ricostruttivi, nonché i nessi stringentiche sussistono fra di essi.
Alla sfida della piena fruibilità si è inteso rispondere utilizzando la tec-nologia del realtime, la cui potenzialità in campo archeologico, ampiamenteacquisita grazie a importanti progetti attuati nel recente passato, risiede nellacapacità di realizzare spazi di simulazione in cui coesistano tridimensiona-lità, immersività e interattività (Forte 2007, 4). La tecnologia di navigazionein realtime è stata scelta nell’intento di stimolare la curiosità del fruitore,predisponendolo cioè ad affrontare una situazione nuova e non prevedibile,corrispondente alla comprensione dei contenuti da erogare: messo nelle con-dizioni di interagire con l’oggetto, egli potrà intraprendere un percorso di co-noscenza interattivo e trasformare la visita in esperienza. Coinvolto in primapersona, il viaggiatore dello spazio e del tempo mantiene in ogni momentola completa libertà di movimento e può costruire il proprio percorso di vi-sita in maniera del tutto autonoma.
Per dare evidenza al rapporto documentazione-ipotesi ricostruttiva si èvoluto dotare il prototipo di una doppia modalità di visita: la prima, rico-
struttiva, in cui il viaggiatore potesse interagire direttamente con le rico-struzioni del sito nelle sue diverse fasi, ed una seconda, documentaria, incui potesse, con altrettanta libertà, muoversi in una dimensione virtuale ditipo diverso, che donasse piena visibilità alle evidenze stratigrafiche. Alledue modalità di visita corrispondono due diversi quadri: le scene rico-
struttive, con i modelli tridimensionali relativi alle anastilosi, e le scene
stratigrafiche, in cui i modelli tridimensionali sono ricavati dalla digita-lizzazione delle piante di fase, strumento basilare per l’elaborazione delleipotesi.
Grazie alla doppia modalità di visita e all’uso del realtime, l’esperienzadi navigazione si configura come un viaggio multidimensionale, in cui, allalibertà di movimento nel tempo attraverso diversi momenti di vita del sito(come lo immaginano gli archeologi?), si unisce la possibilità di toccare davicino i dati alla base del processo dell’immaginazione ricostruttiva (qualisono le tracce residue?), portati al centro del rapporto simbiotico tra strati-grafia e interpretazione.
La costruzione del prototipo
Il caso di studio è costituito da un settore del sito di Faragola (pressoAscoli Satriano, FG), oggetto a partire dal 2003 di ricerche archeologiche si-stematiche, che hanno portato alla scoperta di uno dei più particolari inse-diamenti rurali dell’Italia meridionale, vero e proprio paradigma della storia
35
2. La TimeMachine
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
delle campagne della Puglia centrosettentrionale per un arco cronologicoche supera i mille anni di vita (cfr. infra, p. 51, nota 3). L’inaugurazione nel2009 del Parco archeologico ha permesso di rendere il sito fruibile e di in-stallare il prototipo, ora a disposizione dei visitatori.
Nella realizzazione della TimeMachine è stato coinvolto un gruppo dicirca 15 persone, organizzate in cinque diversi team, dedicati allo svolgi-mento di specifici task:
– redazione dei contenuti;– documentazione digitale;– realizzazione dei modelli in computer graphic;– costruzione della piattaforma di realtime;– creazione del concept e gestione del progetto.
L’organizzazione in team di lavoro ha facilitato la gestione della com-plessità globale del progetto attraverso un workflow che ha valorizzato ilconfronto fra esperti di diversi settori, dotati di specifiche competenze (fig.4). Caratteristica decisiva del lavoro è il profondo legame fra gli svilup-patori del prototipo (molti dei quali partecipavano in prima persona alleattività sul campo) e gli archeologi impegnati nelle indagini a Faragola,che, a cominciare dalle fasi di progettazione, ha dato vita ad un continuoconfronto fra contenuti e struttura. L’équipe di scavo ha infatti rappresen-tato per tutta la durata delle operazioni di produzione un riferimento co-stante per l’elaborazione dei contenuti del prototipo: la ricostruzione dellasequenza stratigrafica e la periodizzazione dell’insediamento è alla basedell’elaborazione delle scene ricostruttive; l’interpretazione delle strutturemurarie, dei piani pavimentali, delle componenti degli interri e delle traccedi frequentazione delle fasi più tarde sono esempi dei risultati che i teamdi sviluppo hanno potuto utilizzare per l’implementazione del prototipo(fig. 5).
Il team contenuti (responsabili Anna Introna e Alessandra Moro, con ilcontributo di Giovanna Baldasarre, Giovanni De Venuto, Giusy Sibilano,Maria Turchiano, Giuliano Volpe) ha raccolto la base documentaria perl’elaborazione delle piante di fase tridimensionali utilizzate nelle scenestratigrafiche ed ha elaborato, a partire dalla documentazione scientifica edalle pubblicazioni, i contenuti testuali divulgativi implementati nella Ti-
meMachine.Il team documentazione digitale (responsabile Andrea Fratta, con la
collaborazione di Raffaele Fanelli, Mario Lo Muzio, Nancy Mangialardi,Giusy Sibilano e Feliciano Stoico) è stato impegnato nel lavoro di restitu-zione tridimensionale della documentazione grafica e nell’implementazionedi un ambiente di gestione utilizzabile come base dati nei successivi step dimodellazione (fig. 6). Il risultato prodotto dal team è stato quindi un repo-
36
Una macchina del tempo per l’archeologia
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
37
2. La TimeMachine
4. - I team di lavoro e il workflow di produzione.
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
sitory di tutte le unità stratigrafiche raccolte nelle fasi destinate ad essereinserite nel prototipo.
L’attività di digitalizzazione ha stimolato una riflessione sulla possibi-lità di semplificare la tecnica di esecuzione delle piante di strato in vistadella restituzione (cfr. infra, Materiali 1).
Sono state elaborate delle linee guida per la realizzazione di documen-tazione archeologica 3D compliant, il cui obiettivo è quello di estendere lapossibilità di documentare in tre dimensioni anche continuando il lavoro‘tradizionale’, nel caso in cui non siano disponibili sul cantiere strumenta-zioni adatte a realizzare rilievi tridimensionali.
Al team modellazione (responsabile Fabio Gagliardi, con la collabora-zione di Donato Vero e Antonello Fino) è stata affidata l’elaborazione deimodelli tridimensionali da inserire nel prototipo (fig. 7). I suoi compiti sonostati molteplici:
– il disegno delle ipotesi di ricostruzione degli elevati, che è stato allabase della realizzazione dei modelli delle scene ricostruttive e si è gio-vato a questo fine della presenza nel team di esperti di architettura clas-sica;
– la scelta delle procedure più idonee per trasformare le superfici gene-
38
Una macchina del tempo per l’archeologia
5. - Attività di scavo e documentazione (campagna 2004).
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
39
2. La TimeMachine
6. - Il lavoro del team documentazione.
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
rate dalla documentazione tridimensionale in oggetti geometricamentevalidi, utilizzabili nei processi di modellazione;
– la realizzazione dei character e dell’avatar;– lo studio e l’implementazione delle modalità stilistiche delle scene e
degli aspetti grafici del prototipo, quali la scelta delle texture, delleluci, nonché le soluzioni tecniche per la produzione delle scene deri-vanti dalla opzione del realtime.
Il team realtime (responsabile Lorenzo Baldassarro, con la collabora-zione di Fabio Gagliardi, Andrea Fratta e Donato Vero) ha curato le diverseoperazioni necessarie all’assemblaggio del prototipo:
– ha definito l’architettura dell’applicazione, le relazioni fra le scene e icomportamenti degli oggetti e dei personaggi presenti in esse (fig. 8);
– ha implementato gli elaborati realizzati dal team modellazione (mo-delli, character e texture);
– ha elaborato i meccanismi di interazione fra viaggiatore e scene, e l’in-terfaccia di navigazione.
Le attività di assemblaggio hanno comportato una lunga elaborazione di
40
Una macchina del tempo per l’archeologia
7. - Il lavoro del team modellazione.
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
un grande numero di oggetti realizzati dal team modellazione e dagli altri
team di progetto (cfr. infra, Materiali 2).
Un team di progetto (fig. 9, responsabile Giuliano De Felice, con la col-
laborazione di tutti i componenti degli altri team) ha elaborato il concept
41
8. - Il lavoro del team realtime.
9. - Brainstorming.
una macchina del tempo per l’archeologia- iSbn 978-88-7229-617-3 - © 2012 · edipugl ia s . r. l . - www.edipugl ia . i t
1 La realizzazione di un set didocumentazione grafica digitale3D è stata l’obiettivo di nume-rose ricerche portate a terminepresso il Laboratorio di Archeo-logia Digitale negli ultimi anni.Oltre alla descrizione dettagliatadel processo utilizzato per la Ti-meMachine, si rimanda ad al-cuni contributi: De Felice, Sibi-lano, Volpe 2008c; De Felice etalii 2008a. A partire dalle buonepratiche attuate per questo pro-getto è stato realizzato recente-mente un lavoro di più ampiorespiro dedicato integralmentealla redazione di documenta-zione digitale su un cantiere discavo archeologico. Cfr. Sibi-lano 2008 e 2009.
generale del prototipo negli aspetti creativi (stile grafico, ambientazione)e curato nel corso della produzione gli aspetti gestionali (produzione erelazioni fra i team). A cura dello stesso team sono stati prodotti i suonie i rumori che caratterizzano le scene, a partire da librerie presenti in reteliberamente utilizzabili. Anche le musiche di sottofondo che accompa-gnano l’esperienza di visita sono state realizzate appositamente per il pro-totipo.
Il rilievo e la documentazione tridimensionale
La realizzazione del prototipo è iniziata quando le attività di scavo e va-lorizzazione del sito di Faragola erano ormai in corso già da quattro anni, esi avvalevano di un profilo di documentazione caratterizzato dal predomi-nio delle tecniche tradizionali (documentazione schedografica, documenta-zione grafica su base CAD, documentazione fotografica digitale). Lamaggior parte delle fonti era conservata in formato cartaceo e digitale, nondirettamente utilizzabile per la produzione di un prototipo di realtà virtuale.Si è reso pertanto necessario mettere a punto opportuni processi per la digi-talizzazione delle fonti di archivio, finalizzati alla trasformazione dei docu-menti in formati direttamente utilizzabili nel prototipo.
Le procedure di digitalizzazione hanno interessato in maniera partico-lare la documentazione grafica, ma, contestualmente alla definizione dellaTimeMachine, sono state avviate, all’interno del progetto di ricerche a Fa-ragola, una serie di attività finalizzate alla trasposizione su base digitale del-l’intero processo di documentazione (fig. 10). Ad oggi è stato digitalizzatol’archivio delle schede, fruibile attraverso un database fondato su piatta-forma open source, che contiene anche i collegamenti ai dati fotografici(IReMaS: cfr. De Felice et alii 2010).
L’apparato grafico ha richiesto invece la realizzazione di un intero set didocumentazione digitale, sia attraverso la conversione in formato digitaledegli archivi delle campagne di scavo concluse, sia con la creazione ex novo
di percorsi digitali 1 (per un’analisi dettagliata cfr. infra, Materiali 1). Sulla scorta della considerazione che documentare in tre dimensioni im-
plichi un significativo potenziamento conoscitivo del metodo stratigrafico,sono stati infatti definiti e sperimentati alcuni percorsi capaci di preservarela tridimensionalità della realtà indagata durante uno scavo e di suggerirepossibili risultati di una impostazione nuova. La consapevolezza dell’in-compatibilità rappresentativa tra contenuto multidimensionale e contenitorebidimensionale, è stata infatti all’origine di una sperimentazione rivolta al-l’uso di nuove tecnologie di rilievo sul campo, e all’elaborazione di un mo-dello suscettibile di tradursi in più immediati set di documentazione graficatridimensionale (cfr. infra, Materiali 1).
42
Una macchina del tempo per l’archeologia