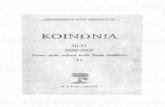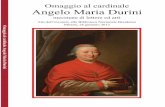Un inedito grammaticale castelvetrino tra le carte Barbieri in Omaggio a Lodovico Castelvetro...
Transcript of Un inedito grammaticale castelvetrino tra le carte Barbieri in Omaggio a Lodovico Castelvetro...
MATTEO MOTOLESE
UN INEDITO GRAMMATICALE CASTELVETRINO TRA LE
CARTE BARBIERI
Haveva in sua gioventù fatto grandissimo studiosopra i libri di Gio(vanni) Boccaccio, especialmente sopra le Novelle, le quali si vantavad’havere lette più di cento volte, e sempre avevatrovato cose nuove e non più considerate l’altrevolte, le parole delle quali haveva notato tutte nonve ne lasciando pur una, in diversi squarzi, ed ilsimile haveva fatto molte fatiche sopra il Petrarca,le quali per quanto si può giudicare andarono amale coll’altre scritture perdute in Lione.
1. La citazione posta in epigrafe è ben nota agli studiosi di Castelvetro: èricavata dalla biografia che il nipote Lodovico jr. dedica all’omonimo zio,pubblicata da Tiraboschi nella sua Biblioteca Modenese.1 Ci dice della centralitàdel Decameron, fin dall’età giovanile, per quanto riguarda lo studio dell’italianoantico; ci offre uno spaccato del modo di lavorare del filologo modenese; ciinforma anche circa il destino di quei lavori nati marginalmente alla letturaboccacciana.2 L’importanza del Decameron nella mappa di interessi castelvetriniè d’altronde confermata dagli scritti stessi del filologo modenese giunti fino anoi: il capolavoro trecentesco viene non solo setacciato a fini di ricostruzionedella fisionomia grammaticale dell’italiano antico, il che è ovvio, ma èanalizzato anche negli scritti teorici che riflettono su temi collegabili allaPoetica aristotelica.3
1 Vita di Lodovico Castelvetro 1786: 77.2 Per le vicende delle carte castelvetrine a seguito dell’esilio si vedano almeno FRASSO
1991 e ROZZO 1997. Mi permetto poi di rimandare, una volta per tutte, anche aMOTOLESE 2006b, in cui si fornisce un quadro dei principali materiali del modenese(autografi, copie, postillati).3 Per la presenza boccacciana nel volgarizzamento della Poetica, basti il rinvio all’indicedell’edizione curata da Werther Romani (CASTELVETRO 1978-1979). Nella stessaprospettiva si collocano anche le porzioni boccacciane presenti ai ff. 78r-84v del ms.a S. 5. 1. della Biblioteca Estense di Modena; i brani sono stati modernamentepubblicati da PEROCCO DONADI (1977), essendo stati esclusi da MURATORI 1727.Tra i contributi recenti si vedano BIANCHI 1991; CRISCIONE 1992: 144-145;GROHOVAZ 1993. Per un esame del manoscritto e di alcuni problemi ad essoconnessi rinvio a MOTOLESE 2006c. Sul ruolo di Boccaccio nel volgarizzamento dellaPoetica e negli altri scritti in generale, oltre alle indicazioni di Romani nella sua
MATTEO MOTOLESE28
Per tutti questi lavori Castelvetro si serve, come testo di riferimento,dell’edizione pubblicata dai Giunti nel 1527.4 L’indicazione si ricavadall’ormai ben noto sistema di rinvii bibliografici con cui il modenese erasolito precisare le citazioni nei propri scritti e che permette di seguire lamappa variabile delle biblioteche che ruotano attorno alle sue opere.5 Il primorinvio autografo a me noto all’edizione giuntina è in una lettera a GiovanniBattista Busini del 1538: Castelvetro chiede all’amico un chiarimento riguardoal titolo del capolavoro boccacciano; per farlo, allega una citazione a cui faseguire il rimando di numero di pagina e di riga che coincide con l’ed. del1527.6 Rinvii a questa edizione si trovano poi, senza eccezione, in tutti i casiin cui compaia una citazione dotata di rinvio alfanumerico: così, ad esempio,nel postillato estense della Ragione,7 in quello palatino delle Prose della volgarlingua (ed. 1549),8 nei rinvii presenti nel cosiddetto zibaldone estense,9 finoalle postille in un altro esemplare delle Prose bembiane (ma dell’ed. 1538), oggiconservato nella Beinecke Library dell’Università di Yale (New Haven,Connecticut, U.S.A.), annotato negli ultimi anni dell’esilio.10 Benché un buon numero di postillati castelvetrini sia stato individuato, nonsi ha purtroppo alcuna traccia dell’esemplare del Decameron (ammesso che edizione (CASTELVETRO 1978-1979), si vedano BRAGANTINI 1983; RONCACCIA
2006: ad indicem.4 Ossia: Decamerone 1527; l’individuazione dell’edizione è in BIANCHI 1991: 492.5 Si tratta di una modalità, com’è noto, segnalata già dal nipote Giacopo nella suaintroduzione al commento castelvetrino a Petrarca (Le rime del Petrarca 1582: 3r). Inmerito si vedano: BIANCHI 1991: 484 e 492-493; TROVATO 1999: 261-262;MOTOLESE 2001: 513-514.6 La lettera al Busini, datata 1 gennaio 1538, è conservata presso la BibliotecaNazionale Centrale di Firenze (Autografi Palatini. Varchi, I 71; vedi oltre, Tav. 4); unatrascrizione si può leggere in BIANCHI 1991: 521-522.7 Si tratta dell’esemplare conservato presso la Biblioteca Estense di Modena consegnatura a &. 2. 10. In merito si veda FRASSO 1991: 475. Segnalo qui, pur senza averancora potuto leggere il contributo, che il volume è stato oggetto di una tesi didottorato presso l’università di Venezia da parte di Elisabetta Arcari (titolo: Edizionecritica dell’opera di Ludovico Castelvetro Ragione delle cose segnate nella canzone di Annibal CaroVenite all’ombra de’ gran gigli d’oro, analisi del postillato estense alfa &. 2. 10 di mano dellostesso Castelvetro; tutor: Gino Belloni, a.a. 2004-2005).8 Si veda, per questo, MOTOLESE 2001. Per l’utilizzo di questo postillato come baseper il commento bembiano rimando a quanto detto nell’introduzione alla miaedizione della Giunta (CASTELVETRO 2004: XXXIII).9 Mi riferisco, in particolare, alla sezione pubblicata in BIANCHI 1991.10 Si tratta dell’esemplare proveniente dalla collezione Rosenthal schedato come dimano ignota in ROSENTHAL 1997: 65. Per l’attribuzione e descrizione delle postillerinvio a MOTOLESE 2006a.
UN INEDITO GRAMMATICALE CASTELVETRINO 29
fosse solo uno, e sempre lo stesso negli anni). È possibile però ricavarequalche indicazione in merito da ciò che si legge nella lista di libri conservatatra le carte di Gian Vincenzo Pinelli, in cui si descrive una copia ricca diannotazioni, con ogni probabilità appartenuta proprio a Castelvetro:
Il Decamerone, o le Novelle di Gio(vanni) Bocc(accio), della stampa di Firenze del1527, raffrontate con assaissimi testi antichi tutti a mano; e in margine v’eranosegnate tutte le varietà delle letture e tutti i luoghi degli autori latini, e altri ondehaveva preso o pareva haver preso il Bocc(accio) cosa alcuna. In fine del libroera scritta la canzone Questo mio nicchio, s’io nol picchio ecc., con certe altre cosettedel Bocc(accio) e v’erano molte materie poste in certi capi, come tutte letempeste, tutte le pestilentie, quante persone in iscambio d’altre sieno giaciutecon altre persone, quante persone religiose habbiano ottenuta la lorointentione, quanti motti si dicono di città o di popoli e simili cose.11
Non è necessario insistere sull’importanza della lista Pinelli per laricostruzione della biblioteca del modenese, soprattutto degli anni dell’esilio, esulla sua congruenza con i materiali castelvetrini noti.12 Sottolineo solo quicome la descrizione appena riportata si dimostri compatibile con le diverseangolature analitiche con cui Castelvetro mostra di aver lavorato sulDecameron: dal punto di vista della ricostruzione dell’italiano antico e dellariflessione grammaticale (varianti e spogli lessicali → commento a Bembo estudio dell’italiano antico); dal punto di vista che oggi chiameremmo‘narratologico’ (catalogazione delle materie → riflessioni nel volgarizzamentodella Poetica; appunti nello zibaldone estense). L’esemplare descritto apparecongruente, inoltre, anche con il metodo di lavoro del modenese ricostruibiledai frammenti del suo laboratorio. I postillati fino ad ora individuati mostranoche Castelvetro, come molti suoi contemporanei,13 annotava i classici volgari,e non solo, della sua biblioteca con postille soprattutto di tipo variantistico;14 i 11 Traggo la citazione da FRASSO 1991: 472-473.12 Oltre alle notazioni di Frasso, sulle vicende dei materiali censiti nella lista Pinelli (enon solo) si veda ROZZO 1997: 159-186. Sulla questione mi permetto inoltre dirinviare all’introduzione alla Giunta (CASTELVETRO 2004: XXIX-XXXII) e a MOTOLESE
2006a.13 Basti ricordare, proprio in relazione al Decameron, la testimonianza bembianariguardo all’edizione Dolfin del 1516 (si veda, in merito, TAVOSANIS 2002: 116-117).14 Sono di tipo eminentemente variantistico le postille presenti nei seguenti esemplari:VILLANI 1537, conservato presso l’Estense di Modena (a Z. 4. 24; per cui si vedanoalmeno: FRASSO 1991: 468 e 474; BIANCHI 1991: 492-493), per il quale ricordoquanto scrive Lodovico jr. nella sua biografia: «haveva posta molta fatica incorreggere Gio(vanni) Villani, il qual haveva molto bene ridotto coll’aiuto de’ testiantichi, de’ quali haveva gran copia» (Vita di Lodovico Castelvetro 1786: 77); l’esemplare
MATTEO MOTOLESE30
libri a stampa divenivano così libri multipli, collettori della tradizione di quellasingola opera, in cui – in taluni casi – a contare era piuttosto il testo posto suimargini che non quello stampato.15 Ma la copia del Decameron descritta nellalista si presenta anche come una sorta di libro deposito: nelle ultime paginerisultano infatti schedati elementi contenutistici e una serie di altri testiboccacciani. Un uso bipartito (margini/carte di guardia) registrabile anche nelpostillato palatino delle Prose.16 D’altronde le stesse testimonianze sul suo metodo di lavoro ci dicono di unmodo di lavorare che tendeva a separare la fase della raccolta dei materiali(varianti; individuazione delle fonti), dalla riflessione vera e propria (analisidelle singole forme; commento di glossa al testo). Indicazioni in tal senso siricavano, ad esempio, dalle note considerazioni che Jacopo Corbinellicomunica in un paio di lettere a Giovan Vincenzo Pinelli, riguardo al fattoche Castelvetro non usasse «postillar gran che» ma che il suo «ordine» era di«far quadernucci».17 Ma anche da quanto Lodovico jr. racconta nel branoposto in epigrafe in cui si nota come, lavorando sul Decameron, la schedatura
delle Rime antiche 1532 conservato alla Bibliothèque Nationale de France di Parigi(Rés. P. Yd. 155; per cui si vedano: FRASSO 1982: 255 nota 9; FRASSO 1991: 468;BOLOGNA 1993: I 272; CASTELVETRO 2004: ad indicem). Dello stesso tipo dovevanoessere anche alcuni esemplari, ancora non rintracciati, presenti nella lista Pinelli, ossia:l’aldina di Petrarca del 1514, l’Ameto, la Fiammetta e il Teseida (per l’individuazionedelle edizioni relative si veda FRASSO 1991: 473-474). Diverso il tipo di postillaturariscontrato in testi “teorici” quali i due esemplari delle Prose (per cui si vedaMOTOLESE 2001 e MOTOLESE 2006a) o anche l’esemplare estense della Ragione giàcitato (FRASSO 1991: 475) che presentano soprattutto postille alfanumeriche per rinviiinter- ed extratestuali relativi alle citazioni presenti.15 Lo si vede incrociando i rinvii alfanumerici con il riutilizzo dei medesimi luoghinelle varie opere. Sulla questione mi permetto di rinviare di nuovo a MOTOLESE
2006a.16 MOTOLESE 2001: 544-545. Il parallelo tipologico con l’esemplare del Decamerondescritto nella lista Pinelli mi pare ridimensioni l’ipotesi che facevo al tempo riguardoall’originaria autonomia delle carte di guardia del postillato palatino; anche ladescrizione dell’esemplare del Decameron nella lista sembra presentare infatti diversitipi di schedatura tra margini e carte di guardia.17 Il carteggio è stato oggetto di due tesi di laurea da parte di M. G. BIANCHI e M.GAZZOTTI (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a.a. 1981-1982, rel. G.Frasso, per entrambe). Benché il materiale sia ancora inedito, sono da tempo agli attidegli studi castelvetrini le porzioni che interessano direttamente il filologo modenese;ampi stralci sono stati infatti pubblicati in FRASSO 1991: 463-472 (da cui ricavo anchela mia citazione, tratta da una lettera datata 5 aprile 1578).
UN INEDITO GRAMMATICALE CASTELVETRINO 31
delle forme avvenisse non sull’esemplare stesso ma in diversi squarzi, ossia infascicoli separati.18
2. Tra le carte Barbieri conservate nel fondo Savioli della Bibliotecadell’Archiginnasio di Bologna, raccolte oggi in una cartellina sotto lasegnatura mss. B 3467, è contenuta una nuova testimonianza del lavoro diCastelvetro sul testo del Decameron. Si tratta di una trattazione dedicata agli usifunzionali di alcuni avverbi basata quasi interamente su una schedatura delcapolavoro boccacciano. Benché la cartellina sia una tra le più note di quelleconservate all’Archiginnasio,19 vale la pena di richiamare le caratteristichemateriali del fascicolo che qui interessa.
Si tratta di un fascicolo ternio, cartaceo, di circa mm 290 x 200, rilegatomodernamente con una carta azzurrina. In alto a sinistra si ha la segnaturafascicolare (3), a matita sulla prima carta, e una numerazione, sempre a matita(9-14), segnata contando progressivamente le carte di tutti i fascicoli dellacartellina. La filigrana è presente ai ff. 11, 13 e 14 e rappresenta un giglio difigura compatibile con il tipo della serie 358-72 di Piccard (dimensioni mm 20x 23 circa).20 Il testo è vergato in un inchiostro ocra, su uno specchio discrittura di circa 45 righe, ad eccezione della prima carta (f. 9r) che arriva a 61;lo stesso inchiostro è presente anche nelle correzioni e aggiunte marginali(tranne a f. 12r, in cui si ha un’integrazione di inchiostro sensibilmente piùchiaro). Nel testo, come anche in altri fascicoli della cartellina, compaionosottolineature moderne a matita nera, diversa da quella che ha segnato i numeridelle carte e della fascicolazione.
Nel suo studio dedicato alle carte dell’Archiginnasio, Vincenzo DeBartholomaeis inserì questo fascicolo tra gli autografi di Giovanni MariaBarbieri, descrivendolo come «frammento di sei carte con Note
18 Per quest’uso di squarzo si veda la documentazione nel GDLI s.v. squarcio § 14.19 Per i problemi connessi alle carte Barbieri basti qui il rinvio a BOLOGNA 1993: I129; CARERI 1996; DE CONCA 2001.20 PICCARD 1980: vol. XIII; filigrana assente nel repertorio di BRIQUET 1907. Hocompiuto confronti della filigrana, oltre che con i fascicoli 1 e 5 della cartellinaBarbieri (per cui vedi oltre), con quelle dei seguenti autografi castelvetrini: Mss. VariC 20 (Biblioteca ‘Antonio Panizzi’, Reggio Emilia); il codice a S. 5. 1 e quello segnatoDeposito Collegio di San Carlo, F. 2. 1 (Biblioteca Estense Universitaria, Modena); latraduzione di Melantone tràdita dal Vat. lat. 7755 (Biblioteca Apostolica Vaticana;codice di formato però diverso). In nessuno di questi casi la filigrana è risultatacompatibile.
MATTEO MOTOLESE32
lessicografiche sopra le voci Qui, Quivi, Quinci, Qua, Là, Là ove, Là su».21 Unadecina di anni fa Maria Careri, riesaminando l’intero dossier, ha avanzatoinvece la proposta di attribuire il fascicolo alla mano di Castelvetro.22Un’attribuzione che un riesame del materiale mi pare permetta ora dicircostanziare e, quindi, confermare. Oltre alla piena compatibilità grafica degli appunti del fascicoletto con gliautografi noti del modenese (Tavv. 1-4), conferma l’attribuzione anche laconvergenza di altri elementi. In primo luogo la corrispondenza con ilmetodo di lavoro castelvetrino quale appare dalle porzioni del suo laboratorionote fino a noi: mi riferisco all’uso dei caratteristici rinvii alfanumerici allegatialle citazioni; alla compatibilità di quei rimandi con le edizioni da luisolitamente utilizzate, a partire dal Boccaccio del 1527 di cui si è detto. Maanche a dettagli più minuti: l’adozione delle lettere capitali per le formeoggetto;23 l’uso di scrivere dio con la minuscola anche nei casi in cui il branodel Decameron rechi la maiuscola;24 l’adozione di forme come seperare,
21 DE BARTHOLOMAEIS 1927: 6; l’autografia viene ribadita dal catalogo relativo aimanoscritti dell’Archiginnasio (FANTI-SIGHINOLFI 1982: 125-126). Ma già nel 1964Gianfranco Folena, nel suo articolo sul Barbieri per il Dizionario biografico degli italiani(FOLENA 1964), non aveva compreso questo materiale tra gli autografi.22 CARERI 1996: 266. Il fascicoletto non è, peraltro, l’unico pezzo castelvetrinopresente nella cartellina siglata B 3467. Mi pare sia da attribuire alla mano diCastelvetro infatti anche il frammento di libro di famiglia, pubblicato in parte da DE
BARTHOLOMAEIS (1927: 7) e poi integralmente da BORTOLUCCI (1929), come dimano di Barbieri (attribuzione ripresa in FANTI-SIGHINOLFI 1982: 125). Anche inquesto caso l’autografia del Barbieri era stata già esclusa (ma questa voltaesplicitamente) da Folena nell’articolo citato (FOLENA 1964: 227). Il confronto con lagrafia non mi pare lasci dubbi circa l’attribuzione anche di queste carte alla mano diCastelvetro: un’attribuzione che, di là dagli aspetti puramente biografici, fa dunqueacquisire alla critica castelvetrina anche i giudizi pungenti su Aretino e Alamanni ivicontenuti. Più cauto sarei invece per quanto riguarda la paternità del frammento checostituisce il primo fascicolo della cartellina. Su questo materiale, già segnalato daCARERI (1996: 266), mi propongo di tornare in altra sede. In ogni caso, la presenza dimateriali castelvetrini tra le carte Barbieri non deve stupire: è noto da tempo infatti ilruolo che il figlio di Barbieri, Lodovico, ha avuto nel raccogliere le carte diCastelvetro dopo la morte del modenese (si veda, da ultimo, BIANCHI 2003: 124-125).23 L’uso delle lettere capitali, già bembiano, è evidente dall’analisi delle diversemodalità di mise en page dello zibaldone modenese, in cui esse compaionoesclusivamente negli scritti grammaticali (si veda su questo MOTOLESE 2006c).Sull’uso delle lettere capitali in Bembo si veda VELA 1999: 17; si veda inoltreTAVOSANIS 2001; per altri grammatici, basti l’esempio di DOLCE 2004.24 Lo stesso uso è registrato, ad esempio, anche nell’autografo della Giunta(CASTELVETRO 2004: LXXII). Riguardo alla fedeltà con cui Castelvetro riutilizza le
UN INEDITO GRAMMATICALE CASTELVETRINO 33
comperatione, proprie dell’usus scribendi castelvetrino.25 Elementi non distintivi, èovvio, ma la cui compatibilità con le abitudini del filologo modenese, inaggiunta al dato decisivo della grafia, mi pare avvalori l’attribuzione del testo aCastelvetro. È chiaro che un elemento decisivo per l’attribuzione deriva poidalla lettura del testo stesso, e dunque dal suo contenuto.
3. Come abbiamo visto, le sei carte del fascicolo contengono una trattazionerelativa agli avverbi qui, quivi, quindi, qua e là, ossia a un settore non moltovalorizzato dal pensiero grammaticale del tempo. Il tema degli avverbi «locali»era stato rapidamente trattato da Fortunio;26 più spazio vi aveva dedicatoBembo nelle sue Prose, ritornando più volte sulla trattazione della questionesia in fase di composizione sia di revisione delle varie edizioni;27 la trattazionebembiana era stata poi ripresa da grammatici successivi come Acarisio, Dolce,Corso, i quali di fatto non avevano aggiunto molto sulla questione,limitandosi più che altro a correggere il tiro su questioni marginali; anche un
proprie fonti linguistiche, segnalo che un confronto tra le citazioni di Dante, Petrarcae Boccaccio presenti nella Giunta e i brani corrispondenti delle edizioni di riferimentomostra come egli tenda a tenere in poco conto gli aspetti paragrafematici e diinterpunzione in questo tipo di riprese (mentre è attentissimo nel riportare il testobembiano; riguardo all’uso degli accenti nel testo boccacciano si veda anche laCorrettione: CASTELVETRO 1999: 168-171). Non solo. L’analisi delle citazioni mostraanche come egli intervenisse su alcune lezioni in modo sistematico: così, ad esempio,sostituendo la forma disio e corradicali con desio (bastino un paio di riscontri: perDante, CASTELVETRO 2004: 88 e commento nota 57; per Boccaccio, CASTELVETRO
2004: 198 e commento alle note 507, 508, 511); oppure core con cuore (come giàsegnalato in CRISCIONE 1992: 148).25 Si vedano in merito anche le notazioni di Valentina Grohovaz in CASTELVETRO
1999: 51.26 Rinvio per questo all’edizione curata da Brian Richardson (FORTUNIO 1999), inparticolare alle pp. 122-124.27 Si tratta del passo corrispondente a Prose III 56-57, secondo la paragrafatura oramaiconsolidata. Un esame dell’autografo, ms. Vat. lat. 3210 della Biblioteca ApostolicaVaticana, mostra come Bembo avesse inizialmente trattato degli avverbi qui/quivi inmodo rapido (f. 151v); non soddisfatto, avesse cancellato il passo e ripreso laquestione su un foglio separato e non numerato, inserito nel ms. al puntocorrispondente, in cui la trattazione si presenta ricca di ripensamenti. Non moltiinvece gli interventi in questo passo tra le edizioni del 1525 e del 1549 (ma su questosi veda anche oltre). Per le diverse stesure nell’autografo si veda TAVOSANIS 2002, inparticolare pp. 45-46 e 322-326; per il rapporto con la princeps, VELA 2001, inparticolare pp. 214-218; uno studio sulle edizioni delle Prose, con particolare rilievoall’ultima, è stato promesso da Antonio Sorella (i primi risultati si leggono inSORELLA 2001).
MATTEO MOTOLESE34
grammatico come Giambullari, benché con un assetto differente rispetto aBembo, non compie significativi approfondimenti su questo punto.28 Il fascicolo Barbieri si stacca nettamente rispetto a questo panorama: nonsolo per l’ampiezza degli esempi censiti (in appena sei carte si contano circaquattrocento citazioni dal Decameron), ma soprattutto per il tenore delragionamento. Castelvetro fornisce infatti una disamina molto articolata dellefunzioni dei singoli avverbi, prestando particolare attenzione alle lorovariazioni in relazione al contesto; si sforza cioè di individuare le logicheinterne che soggiacciono al loro uso deittico, tracciando, attraverso unospoglio analitico del Decameron, una mappa virtualmente completa degli usi diqueste forme.29 La trattazione castelvetrina parte dall’avverbio qui: dopo una notazioneetimologica, si distingue tra forma «simplice» (qui) e forme «composite» (quivi,quindi, quinci). Il ragionamento si concentra prima sulla forma semplice,rimandando oltre la trattazione sulle forme composte. Di qui si individuanotre valori funzionali: quello che chiameremmo oggi di deissi spaziale(«presentia di luogo»), di deissi temporale («presentia di tempo»), e di deissidel discorso («presentia di cosa ossia né tempo né luogo»). Per ognuna diqueste articolazioni funzionali, Castelvetro si sforza di rendere visibili regoled’uso implicite presenti nel testo boccacciano, cercando in particolare dicogliere gli elementi che permettano di distinguere i differenti valori assuntida qui in relazione al contesto (in particolare: ‘stato in luogo’, ‘moto a luogo’).La trattazione prosegue soffermandosi poi sui relativi sintagmi preposizionali:di qui «locale» o «temporale»; fra qui a, fra qui et, infino a qui. Questo schemaragionativo, per singoli blocchi, è ripetuto anche per le forme «composite» diqui: ossia quivi e quindi, quinci. Di ognuna si fornisce prima una trattazionedella forma singola, individuandone i significati rispetto al contesto, e poi sianalizzano partitamente i relativi sintagmi preposizionali o avverbiali: di quivi;di quindi, e poi quindi giù, quindi giuso, per quindi, da quindi innanzi; quinci giù
28 I passi relativi si possono leggere nella silloge sansoviniana (CORSO 1562: 415r-416v; ACARISIO 1562: 443v-446v, da cui cito). Per Dolce si dispone ora di un’edizionemoderna (DOLCE 2004: in particolare 350-351); per le Regole della lingua fiorentina sirimanda all’edizione curata da Ilaria Bonomi (GIAMBULLARI 1986: 91-92). Unavalutazione delle posizioni dei principali grammatici su questo argomento inPOGGIOGALLI (1999: 211-224, in particolare: 218-221); sul rapporto tra Acarisio eBembo si veda anche quanto scrive Paolo Trovato nell’introduzione ad ACARISIO
1988.29 Per un quadro della deissi nell’italiano antico rinvio ai saggi della VANELLI (2002 e2006). Si vedano inoltre VANELLI 1981, CONTE 1984; VANELLI 1995: 283-324;BERTINETTO 1991.
UN INEDITO GRAMMATICALE CASTELVETRINO 35
dinanzi a, quinci su, di quinci, di quinci innanzi, qui(n)centro. Lo stesso avvieneanche per qua e là. Il ragionamento si interrompe con la schedatura di alcune forme collegateall’avverbio là, senza dunque che vengano trattati altri avverbi o locuzioniavverbiali censiti dalle grammatiche del tempo (nelle Prose, ad esempio, sonotrattati anche laonde, indi, linci, costì, costinci, dove, ove, onde, donde, ecc.). Lamancanza di completezza nella trattazione di questa parte del discorso porta aipotizzare che il fascicolo Barbieri possa essere mutilo delle carte finali per losmarrimento di uno o più fascicoli.30 Inutile dire che l’aspetto materiale delmanoscritto non osta a questa ipotesi: lo specchio di scrittura dell’ultima cartaè utilizzato quasi sino alla fine;31 normale al tempo, e documentabile per lostesso Castelvetro, l’utilizzo di quaderni successivi per la stesura di un testo.32 Di certo, il frammento Barbieri appare a uno stato di definizione differenterispetto a molti autografi che presentano una mise en page accurata edefinitiva.33 Il testo rivela infatti ancora tracce di lavorazione: cancellature,sviste, interventi interlineari e marginali, che ci dicono che Castelvetro mentreprepara questo testo ha sotto mano una stesura precedente;34 nell’atto dicopiarla, come è normale che accada, continua a lavorarci, inserendo citazioninuove, autocorreggendosi. Nella sua forma finale, tuttavia, si può dire che iltesto si presenti in un assetto stabile, pronto per un’ultima stesura in pulito.
4. La porzione tramandata dalle poche carte del fascicolo Barbieri appare,anche nella sua brevità, come del tutto coerente con il resto della riflessionegrammaticale castelvetrina. Esistono forti elementi di convergenza sia susingoli punti sia, più ampiamente, a livello di impostazione. Mi riferisco, inparticolare, all’etimologia di qui da hicqui avanzata nel trattatello e che si haanche in un passo della Giunta agli articoli; alle riflessioni sul latino della
30 Va registrato, però, che nessuno dei rimandi cataforici presenti nel testo rinvia aporzioni mancanti.31 La limitazione è dovuta al fatto che la scrittura termina avendo a disposizionealmeno un’altra riga disponibile. Si tenga conto però che l’esaurimento di un ‘lemma’avrebbe previsto comunque uno spazio bianco prima dell’indicazione del successivo.Lo stesso accade infatti nel passaggio da 12r a 12v.32 L’utilizzazione di fascicoli terni è riscontrabile, ad esempio, nella composizionedello zibaldone modenese (si veda, per questo, MOTOLESE 2006c).33 Così, ad esempio, le stesure in pulito dei mss. di Reggio Emilia che tramandano laGiunta del 1563 (Mss. Vari C 20; una descrizione in CASTELVETRO 2004: LVII-LXI) oil cosiddetto zibaldone estense (BIANCHI 1991; MOTOLESE 2006c).34 L’uso di una stesura precedente si ricava, se ce ne fosse bisogno, anche dagli erroridi lettura dei numeri nei riferimenti alfanumerici (per cui si rimanda alle note in calceall’edizione del testo).
MATTEO MOTOLESE36
decadenza, centrali nelle indagini linguistiche del modenese, e che quiaffiorano anche attraverso un richiamo apuleiano; alle molte convergenze ditipo terminologico. Nel testo compare inoltre un rimando compatibile con unpasso della Giunta ai verbi, riguardo alla funzione dei participi passati inBoccaccio.35 Parallelismi tra il frammento Barbieri e il resto della produzionegrammaticale castelvetrina emergono poi anche a livello più generale, diorganizzazione del testo. Normale in Castelvetro, ad esempio, la costruzionedel ragionamento con un’ampia allegazione di esempi36 ma soprattutto ilricorso a una progressiva ramificazione del discorso con accumulo disottocategorie e specificazioni puntuali. Proprio questa modalità argomentativa appare nel fascicolo particolarmenteevidente. La schematicità tipica del dettato castelvetrino si fa in queste pochecarte, se possibile, ancora più marcata del solito. Si osservi ad esempio come,dopo la divisione iniziale tra forme semplici e composte, il discorso si dedichiprima ad un ramo della distinzione, esaurendone le possibilità, e poi all’altro,procedendo in modo analogo. E come, nella trattazione della prima serie diforme correlate a qui, la trattazione progredisca per articolazioni successive difattispecie punteggiate da anchora, appresso, ecc. Una progressione geometricadel ragionamento che mi pare risentire fortemente dei moduli ragionativi ditipo visivo, tanto da lasciare quasi supporre la sinopia di un’organizzazionegrafica degli aspetti funzionali degli avverbi, preesistente alla stesura. Unasoluzione che, peraltro, non stupirebbe. È nota infatti l’utilizzazione da partedi Castelvetro di tali forme di visualizzazione del sapere: i suoi stessi autografipresentano tracce di questa dimensione spaziale del discorso, largamentecondivisa dalla cultura del tempo.37 Quello che nella Sposizione o nellaEsaminazione diviene esplicito attraverso uno schema inserito all’interno dellatrattazione, sembra però restare qui implicito, leggibile solo compiendoun’opera di recupero, di ulteriore astrazione. D’altronde qualche traccia di 35 Per la precisazione dei riscontri degli elementi di convergenza citati si veda ilcommento del testo più avanti.36 Si tratta di una modalità di costruzione del discorso grammaticale che, ovviamente,non è esclusiva di Castelvetro, anche se molto presente nei suoi scritti. Lo stessoaccumulo di loci si ha, per fare un solo esempio, nella grammatica di Acarisio, cherisente per questo aspetto però del Vocabolario (sul rapporto tra vocabolario egrammatica rinvio ancora all’introduzione di Paolo Trovato a ACARISIO 1988).37 Di «forma di pensiero spaziale» ha parlato, con il solito acume, Ezio Raimondi,soffermandosi sull’uso di schemi all’interno della Spositione e della Poetica, inparticolare in merito alla «mappa funzionale di Malebolge» (RAIMONDI 1980, citazionialle pp. 9 e 11). L’uso di schemi di visualizzazione del sapere da parte di Castelvetro,con particolare attenzione alla Esaminatione, è stato poi studiato da BOLZONI 1996:43-51.
UN INEDITO GRAMMATICALE CASTELVETRINO 37
utilizzazione di schemi da parte di Castelvetro anche in àmbito grammaticaleesiste: mi riferisco alla visualizzazione presente al f. 164r-v del cosiddettozibaldone modenese, in cui le sequenze pronominali vengono organizzate ingruppi;38 un semplice abbozzo se paragonato alle tracce di organizzazionegrafica presenti in altri testi del modenese, ma forse l’indizio di un modo diprocedere che può essere utile tenere d’occhio. E questo non tanto perrintracciare, per così dire, i «cartoni» testuali del dettato castelvetrino al fine diricostruire un modo di lavorare, ma soprattutto per portare a leggibilità unadimensione ragionativa. È evidente infatti il peso che tali forme diorganizzazione spaziale del ragionamento, pur spogliate delle loro valenzemnemotecniche, possono avere nella valorizzazione delle funzioni e dellesimmetrie interne della lingua verso cui Castelvetro si mostra sensibile (sipensi solo alle notazioni riguardo all’analogia)39 nonché rispetto all’idea stessadi lingua come sistema che emerge da molti suoi scritti.40
5. Dopo aver confermato l’attribuzione a Castelvetro del fascicolo Barbieri eaver rilevato le convergenze con la produzione del modenese di ordinespecificamente grammaticale, è necessario valutarne il rapporto con ilcommento alle Prose. Come è noto il commento è giunto sino a noi in modo frammentario esenza indicazioni certe che ci permettano di ricostruirne l’intero assetto.41 Trale porzioni mancanti, quelle relative agli avverbi sono sicuramente le piùsignificative. Le carte castelvetrine ci tramandano tuttavia frammenti dellariflessione del modenese anche su questo settore. Mi riferisco, oltre che ad
38 In un passo, peraltro, che presenta diverse affinità con il frammento Barbieri, comeemergerà anche dal commento. Quelli relativi ai pronomi non sono comunque gliunici schemi presenti nel ms. a S. 5. 1; altri, e più articolati, si hanno ai ff. 72v-73r (siveda, per questo, MOTOLESE 2006c).39 Su questa dimensione della riflessione grammaticale castelvetrina rinvio a TAVONI
1990: 219 e alle notazioni preliminari alla Giunta (CASTELVETRO 2004: XLV-XLIX).40 Si tenga conto, poi, che anche l’accumulo di citazioni avrebbe, nellapresupposizione di uno schema visivo, un riscontro nelle carte del modenese: nellevarie componenti dello schema tracciato alle pp. 138-139 del codice segnato Mss.Vari B 26 della Biblioteca Panizzi di reggio Emilia contenente l’Esaminatione(corrispondenti alla p. 121 della stampa) ritroviamo, ad esempio, un accumulo diindicazioni alfanumeriche nei vari elementi che compongono la figura, che può darel’idea di come – forse – si presentava lo schema preparatorio della trattazionegrammaticale sugli avverbi. Sul manoscritto estense e le vicende compositivedell’Esaminatione si veda GROHOVAZ 1995.41 Per le porzioni superstiti del commento si veda la tavola riassuntiva inCASTELVETRO 2004: LXXXIII-LXXXIV.
MATTEO MOTOLESE38
alcuni passaggi delle Giunte relative ai pronomi,42 soprattutto alla trattazionesugli avverbi indefiniti conservata all’interno del ms. estense a S. 5. 1. sotto iltitolo De’ nomi significativi del numero incerto.43 Si tratta, come si ricorderà, di untrattatello dedicato agli avverbi indefiniti di cui lo zibaldone modenesetestimonia l’autonomia rispetto al commento a Bembo. Non voglio affrontarequi la questione se anch’esso potesse essere virtualmente destinato a esserecompreso nel commento a Bembo, come accaduto ad altri testi di cui èattestata una circolazione autonoma e che sono stati poi riutilizzati daCastelvetro in opere più grandi (penso, in particolare, al trattato de’ preteritiinserito all’interno della Giunta ai verbi,44 all’opuscoletto Della intitulazione de’libri a spezial persona, compreso nella Giunta al primo libro delle Prose, o agliopuscoli relativi al Bembo e al Decameron del Ruscelli riutilizzati all’internodella Correttione).45 Mi interessa piuttosto rilevare come gli stessi autograficastelvetrini ci mostrino un doppio modo di lavorare attorno a Bembo: da unlato il commento passo per passo delle Prose; dall’altro l’approfondimento disingoli settori, tangenzialmente al testo bembiano.46 Mi pare che le carte Barbieri possano rientrare in questa seconda categoria,ossia di un approfondimento autonomo di un settore specifico dellagrammatica. Vanno rilevate però una serie di differenze: mentre nel trattatopubblicato dalla Bianchi e in quello dei “preteriti”, oltre che più generalmentenelle Giunte, il tessuto di citazioni è esteso almeno quanto quello delle Prose(da Villani alle Rime antiche, per intenderci), qui il ragionamento è limitatosostanzialmente al solo Decameron. È possibile che ciò vada ricondotto al fattoche il capolavoro boccacciano è il testo guida nella trattazione grammaticale
42 Si vedano, in particolare, le notazioni ricavabili dalle GiunteMs, in cui compaionoriferimenti alle forme di costì, lì, onde, ove (qui e in seguito con GiunteMs mi riferisco aquelle porzioni del commento castelvetrino al secondo e al terzo libro delle Prosecontenute nello zibaldone estense e pubblicate solo nel Settecento in CASTELVETRO
1714; si veda ancora la tavola sinottica proposta in CASTELVETRO 2004: LXXXIII-LXXXIV). Per i riscontri puntuali, rinvio al commento più avanti.43 Il trattatello, già presente nell’edizione curata dal Vitaliano (CASTELVETRO 1714), èstato studiato dalla BIANCHI (1991).44 Rinvio anche per questo a CASTELVETRO 2004: XLIX. Il carattere autonomo dellatrattazione sui preteriti e la sua successiva inclusione all’interno del testo emergonocon chiarezza anche dal manoscritto che tramanda la giunta ai verbi, in cui si ha ildoppio titolo (Mss. Vari C 20, f. 12r della porzione relativa ai verbi). Per unadescrizione dell’autografo rinvio alla nota al testo dell’edizione, pp. LVII-LXI.45 Si veda in merito anche CASTELVETRO 1999: 31-35.46 La differenza tra le porzioni del commento e, nella fattispecie, il trattatello De’ nomisignificativi appare chiaramente dalla stessa mise en page dello zibaldone modenese (siveda, su questo, MOTOLESE 2006c).
UN INEDITO GRAMMATICALE CASTELVETRINO 39
per questo settore, a partire dall’esempio bembiano. È innegabile però che ilfascicolo Barbieri ci presenta una sorta di dissimmetria interna. Se si escludeuna citazione da Petrarca (e, ovviamente, il Decameron), tutte le altre citazioni(Prose, Asolani, Commedia, Asino d’oro) sono prive di rinvii alfanumerici.Sappiamo che Castelvetro non sempre è sistematico nell’indicare le citazioni,in particolare in alcuni autografi del periodo dell’esilio.47 Non mi risultanoperò casi paragonabili al fascicolo Barbieri, ossia di una trattazione ricavata, difatto, da un’unica fonte. Gli elementi su cui riflettere non sono però solo di ordine contenutistico. Siha infatti all’interno della trattazione un dettaglio che porta a credere cheCastelvetro avesse sotto mano un esemplare delle Prose del 1538 e non del1549, come invece è certo sia avvenuto almeno per le porzioni del commentoa Bembo andate in stampa.48 Trattando della forma di qui, egli critica infattil’interpretazione bembiana di un passo boccacciano che compare nelleedizioni del 1525 e del 1538 ma che è assente da quella successiva, edita daTorrentino.49 È un dettaglio minimo che porterebbe automaticamente adatare il testo a prima del 1549, se non fosse che esistono altri elementi chespingono a considerare una datazione differente. Abbiamo già detto che nel fascicolo Barbieri compare un rinvio compatibilecon un passo della Giunta ai verbi (sicuramente successiva al 1549). A questosi può aggiungere che un confronto con il postillato delle Prose conservato aYale mostra interessanti segnali di convergenza. Nell’esemplare – databile,
47 È quanto accade, ad esempio, nell’autografo della Spositione in cui si hanno rinviiper la Commedia ma non per Villani; oppure nello zibaldone modenese, in cui lapresenza dei rinvii è presente solo in alcune parti (ma su questo, rinvio a MOTOLESE
2006c).48 L’utilizzo dell’edizione Torrentino risulta evidente da una serie di dati materiali. Perla Giunta del 1563: come è ricordato nella nota al testo dell’edizione (CASTELVETRO
2004: LVII e LXXII), sia nei manoscritti autografi sia nella stampa si ha il riferimentoalla terza edizione delle Prose attraverso il numero di pagina e di riga. A questo siaggiunge che il confronto del testo riportato nel manoscritto con quello del 1549 nonlascia incertezze sul fatto che Castelvetro abbia utilizzato l’edizione Torrentino.L’indicazione del numero di pagina e riga dell’edizione del 1549 si ha anche neimargini della particelle bembiane presenti nella Giunta del 1572 (una descrizionedell’edizione in CASTELVETRO 1999: 71-72). Anche per queste ragioni sono, a miogiudizio, prive di basi filologiche le riserve rispetto alla datazione della Giuntaavanzate da COLOMBO 2005 nella sua recensione alla mia edizione.49 L’utilizzazione di un’edizione del 1525 sembra da scartare. Nel testo si fa infattiriferimento a una citazione dantesca presente solo a partire dal 1538: «e Dantemedesimamente disse: Ma là dove fortuna la balestra / quivi germoglia, come gran di spelta»(Prose 1538: XCVIIr).
MATTEO MOTOLESE40
come s’è detto, agli ultimi anni di vita del modenese – si contano infatti, incorrispondenza della trattazione degli avverbi che qui interessa, ben ventinoverinvii alfanumerici, quasi tutti al Decameron (nel postillato palatino, invece, irinvii sono soltanto due e per giunta non al capolavoro boccacciano).50L’utilizzazione del postillato di Yale come edizione di riferimentopermetterebbe anche di giustificare il fatto che Castelvetro non segnali l’usodi un’edizione non definitiva (cosa che fa invece per gli Asolani, come sivedrà). Il postillato della Beinecke Library reca infatti sui margini postilleautografe che “aggiornano” la stampa del 1538 con le principali integrazioniintrodotte nell’edizione del 1549, ma non eliminano le porzioni cassate daBembo per l’ultima edizione. Così accade anche nei paragrafi in cui si trattadegli avverbi che qui interessano, in margine ai quali Castelvetro annota i suoisoliti rinvii alfanumerici ma non segna alcun cambiamento testuale. Normale,dunque, che lavorando su un esemplare che considerava “aggiornato” eglipotesse non avvertire l’esigenza di segnalare che l’edizione utilizzata non eraquella definitiva. Si tratta di un dettaglio che può apparire secondario ma non lo è. Unarecente indagine sul ms. estense a S. 5. 1. ha mostrato infatti comel’esemplare di Yale sia, con ogni probabilità, il testo da cui Castelvetro copiale particelle delle Prose per le giunte al terzo libro che compaiono nelle ultimecarte del codice.51 Poiché sia il manoscritto estense sia l’esemplare di Yalesono databili agli ultimi anni di attività del modenese, mi pare verosimile cheanche la trattazione sugli avverbi conservata tra le carte Barbieri appartenga almedesimo periodo.52 D’altronde come si mise a rifare il commento a Dante, è
50 Ossia la citazione dalla Fiammetta per la simmetria tra qua e costà, e il passo di If XIII
98-9 in cui si ha là dove. Sui due postillati si veda MOTOLESE 2001 e MOTOLESE
2006a. Per i riscontri delle singole citazioni con i postillati rinvio al commento.51 Che presenta dunque sia porzioni bembiane ricavate dall’edizione 1549 – ossia legiunte ai primi due libri, come è evidente dai rinvii di paginazione in margine a ogniparticella bembiana – sia porzioni ricavate da un’edizione “aggiornata” del 1538(mancano, per questa parte, le indicazioni di paginazione). Per questo, mi permetto dirinviare ancora a MOTOLESE 2006c.52 La mancanza del rinvio alfanumerico relativo a Dante ci priva, purtroppo, di unimportante indizio che sarebbe stato molto utile ai fini di una datazione. L’aldina diDante può infatti essere vista come una sorta di fossile spia dell’attività castelvetrina.E questo in quanto i manoscritti portano a credere che Castelvetro abbia utilizzatol’aldina del 1502 (= Commedia 1502) almeno sino al periodo lionese (rimandi a questaedizione compaiono infatti in tutti i manoscritti e postillati modenesi e nell’autografodel volgarizzamento della Poetica), ma che si sia servito, negli ultimi anni, di un’aldinadel 1515: oltre che nella Correttione (CASTELVETRO 1999: 229), l’edizione dellaCommedia del 1515 (= Commedia 1515) è utilizzata infatti nella Spositione (Modena,
UN INEDITO GRAMMATICALE CASTELVETRINO 41
possibile che Castelvetro abbia rifatto anche porzioni del commento a Bembo(come le giunte al terzo libro presenti alla fine del codice estense) o sezioni dilavori paralleli alle Prose andati perduti;53 oppure, più semplicemente, abbiadeciso di approfondire sezioni della grammatica volgare non ancoradebitamente trattate, come quelle sugli avverbi. Di certo, quale che sia la sua collocazione all’interno del laboratoriocastelvetrino, il frammento Barbieri costituisce un’importante aggiunta allariflessione linguistica del modenese, e anche – per ampiezza di analisi su unsettore così poco battuto – un tassello significativo per la ricostruzione delpensiero grammaticale cinquecentesco più in generale.
Biblioteca Estense Universitaria, Deposito Collegio di San Carlo, F. 2. 1, f. 1r), in unasezione dello zibaldone estense (ad es. f. 88r, là dove si parla di «Alcune cosette delprimo canto del purgatorio» e «del secondo canto del purgatorio») e nel postillatodelle Prose di Yale.53 Ricordo quanto scrive lo stesso Lodovico jr. in un passo, anch’esso molto noto,della Vita: «Si perdé ancora un Commento o Discorso sopra la maggior parte delliDialoghi di Platone, un giudizio sopra le Comedie di Plauto e di Terenzio, tutte cosescritte in lingua italiana. Andò ancora a male un giudizio fatto sopra le Novelle delBoccaccio, il quale fu poi rifatto da lui essendo in Chiavenna. Si perdettero le fatichefatte sopra Dante, benché poi a Vienna d’Austria si desse di nuovo a rifare quelCommento, il quale non tirò più oltre dell’Inferno» (Vita di Lodovico Castelvetro 1786:71-72; corsivi miei). Il riferimento boccacciano è, a mio giudizio, da collegare alleporzioni boccacciane ospitate nel già citato ms. a S. 5. 1. dell’Estense di Modena enon al frammento Barbieri. In merito mi permetto di rinviare ancora a MOTOLESE
2006c.
MATTEO MOTOLESE42
CRITERI DI EDIZIONE
Benché il manoscritto presenti numerosi interventi di correzione, si èpreferito fornire l’edizione del testo nel suo assetto finale. Le correzionicastelvetrine infatti non lasciano dubbi riguardo alla versione definitiva deltesto e la natura degli interventi non è parsa significativa al punto dagiustificare un’edizione genetica, almeno in questa sede. Per la trascrizione si adottano criteri conservativi, rispettosi – per quantopossibile in una riproduzione a stampa – degli elementi funzionali della mise enpage del fascicolo. In particolare, si sono riportati gli elementi di scansionecontenutistica (ad es.: 1a diferenzia, ecc.) apposti in margine da Castelvetro,posizionati nei luoghi corrispondenti, pur con le ovvie differenze dovute aldiverso assetto delle righe tra versione dattiloscritta e originale;54 si sonoinoltre conservate le forme che Castelvetro aveva scritto in capitali siaall’inizio dei lemmi sia all’interno del testo per alcune forme oggetto (per lequali si adotta il maiuscoletto corsivo; si utilizza invece il semplice corsivominuscolo per le altre forme oggetto per le quali Castelvetro aveva usato lasola iniziale maiuscola). Per il resto si sono adottati, con minime integrazioni,i criteri già utilizzati nell’edizione della Giunta (CASTELVETRO 2004), a cuirimando per una giustificazione puntuale delle scelte grafiche. Riepilogo però,per comodità, le scelte editoriali adottate. Nella trascrizione del testo si sono mantenute:
a) le grafie dotte, etimologiche e pseudoetimologiche, con h, con i digrammi ch,ph e th e così l’uso dei nessi -ti- e -tti- per l’affricata alveolare. Si sonoovviamente mantenuti i casi di oscillazione -ti-, -z-, -zi-.
b) la scrizione univerbata delle preposizioni articolate e delle parole peraventura,percioché, anchoraché congiunzione, accioché, laonde, cene pronominale, cheCastelvetro scrive univerbate.
c) la scrizione analitica di ciò è, a ciò, conciosia cosa che, non dimeno, per lo più, sì come,sì che, più tosto, per tanto, hoggi dì, che Castelvetro nel manoscritto sembrascrivere staccati.55
d) la grafia aferetica in forme come allo ’ncontro, ecc.
Si è invece intervenuti normalizzando il testo secondo l’uso moderno, esenza indicazioni nel testo, nei seguenti casi:
54 Per ragioni editoriali, inoltre, in corrispondenza dei marginalia si è spesso resanecessaria una scansione del testo con degli a capo, assenti nel ms. (si veda per unconfronto la Tav. 1).55 Sono rispettati invece i casi di certa oscillazione come tra forma analitica (se non) esintetica (senon).
UN INEDITO GRAMMATICALE CASTELVETRINO 43
1) divisione delle parole non rientranti nei casi b e c, secondo l’uso moderno:ilquale → il quale.
2) -ij che si trascrivono -ii : varij → varii3) adeguamento all’uso moderno della punteggiatura, nonché l’uso degli altri
segni paragrafematici. In particolare:3.1. sono ricondotte all’uso moderno le maiuscole. Un discorso a parte vale
per le lettere capitali nelle forme oggetto e per dio/iddio, su cui si è giàdetto.
3.2. si normalizzano gli accenti. Si è uniformata all’uso modernol’accentazione anche di né sebbene allora fosse pronunciato con la vocaleaperta.56
3.3. gli apostrofi (ad es. de popoli → de’ popoli).3.4. si indicano con i due punti il punto di separazione che Castelvetro
adotta per separare l’entrata del lemma e la spiegazione relativa; nei casidi omissione, vista la presenza dello spazio bianco, che marca comunqueuna separazione, si inseriscono i due punti senza indicazioni, peruniformità con il resto.
4) distinzione di u/v secondo l’uso moderno;5) introduzione degli apici per indicare il significato di una parola o di una
frase; lo stesso per i significati ‘a luogo’, ‘di luogo’.6) scioglimento dei compendi. Si mantiene però etc per il quale si introduce il
punto finale come nell’uso moderno e si eliminano i due puntinid’abbreviatura sopra la c; si rende con messere la M. del manoscritto, senzaindicazioni.
7) scioglimento delle abbreviazioni dei nomi di autori (Pet. o Petrarc. inPetrarca).
Tali criteri si sono adottati anche per le citazioni dalle Prose bembiane e daglialtri trattati grammaticali da edizioni antiche. Per le citazioni d’autore sia atesto sia nelle note di commento si è adottata invece una trascrizionemaggiormente conservativa. Anche se infatti Castelvetro si dimostra pocoattento agli aspetti paragrafematici nelle citazioni, l’indicazione dello scarto –anche solo di punteggiatura – è parsa comunque da mantenere. Si rispettanodunque l’interpunzione e gli altri segni paragrafematici originari conl’esclusione delle lettere maiuscole a inizio di citazione; tuttavia, per ridurre ildislivello tra testo discorsivo ed esempi d’autore creato dall’adozione di criterieditoriali differenti, nel riportare le citazioni si interviene nei seguenti casi:
I) si normalizzano gli accenti perché sistematicamente assenti sia nelle fonti sianelle citazioni castelvetrine, tranne che sulla terza persona del verbo essere
56 Si vedano FIORELLI 1953: 33-36 e Trattati ortografia 1984: 164.
MATTEO MOTOLESE44
(sempre è sia nel ms. sia nella stampa usata per il confronto dei passidecameroniani). L’accento compare poi, solo nel ms., in alcune forme dipassato remoto. Nei casi in cui compaia se ne dà notizia nelle note.57
II) si introduce la maiuscola/minuscola per la prima parola delle citazionipoetiche secondo l’uso moderno; si adotta invece sempre la minuscola, pergli esempi in prosa, anche se nel manoscritto tutte le citazioni iniziano conla maiuscola.
III) si divide modernamente l’articolo/pronome dalla parola seguente (ad es.laquale > la quale).
IV) si sciolgono i consueti compendi grafici, senza indicazione.
Nelle note si riportano, in generale, solo le porzioni di testo differentirispetto a quello presente nella Giunta, intendendo che la parte omessa siaidentica a quella castelvetrina.
Segni diacritici e altri interventi editoriali. Le integrazioni testuali sono indicate traparentesi uncinate ‹ › (tra quadre [ ] se rese necessarie da guasti meccanici) emotivate nelle note; le espunzioni tra parentesi uncinate inverse › ‹ . Si indicano in corsivo le forme o i sintagmi discussi, rendendo con ilmaiuscoletto, come s’è detto, le forme scritte nel ms. in capitali (ad eccezionedelle lettere singole – ad es. a – per cui si adotta il semplice corsivo nei casi incui il contesto porta a credere che l’adozione della capitale sia dovuta soloall’abitudine castelvetrina di impiegare la maiuscola iniziale per tutte le formeoggetto); in tondo, le citazioni d’autore più estese, con questa distinzione: nelcorpo del testo e racchiuse tra « » le citazioni da testi in prosa; staccate con una capo, in corpo minore e senza altri segni, quelle da testi in poesia. Come giàsegnalato, si indicano tra apici le notazioni metalinguistiche. Ho inseritoinoltre tra due barrette la numerazione delle carte secondo l’indicazioneprogressiva che compare sul manoscritto.
57 A differenza di quanto fatto nella Giunta, intervengo anche su ne/né differenziandoin senso moderno, e questo in quanto Castelvetro, nonostante quanto dice inCASTELVETRO 1999: 233-234, omette sistematicamente l’accento nelle citazioni inquesto caso.
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› ∗
Qui: è presa dalla voce latina hic che con grassa proferenza, quale fuperaventura quella delle genti straniere, mandandosi fuori suona hicqui,che, dileguatosi hi, è rimasa qui.1 S’usa simplice et composta.2 Primaparleremo di lei come simplice, poscia come composta. Simplice adunquechiamo la qui3 quando non è congiunta con altre voci in guisa che siadivenuta di più una voce sola, come è quindi et quinci et simili. Horsimplice significa presentia di luogo et presentia di tempo havendoriguardo alla persona del parlante, et presentia di cosa havendo riguardo alparlare del parlante. Presentia di luogo si constituisce con QUI etlarghissima et mezzana et strettissima secondo che richiede la necessitàdella cosa di che favella altri. Percioché di questo mondo parlando si dicequi: «va dunque figliolo, poscia che iddio t’ha qui rimandato, et consola ladonna tua la quale sempre poi che tu di questa vita passasti è stata in
∗ Il titolo, proposto per comodità editoriale, è congetturale e modellato su quellod’autore utilizzato per l’excursus sulla morfologia verbale del passato che comparenella Giunta ai verbi, ossia Trattato de’ preteriti.1 Sull’etimologia di qui Castelvetro si sofferma in un passaggio della quarta Giunta agliarticoli, in cui è più preciso anche il riferimento alle «genti straniere»: «Percioché de’vicenomi essendone alcuni sustantivi, come io, tu, egli et simili, et certi altri aggiunti,come quello, quella, esto, esta et simili, è da sapere che quello fu composto da’Longobardi da prima d’hoco et d’illo lasciato ho, et tramutato co in qu et i in e; le qualimutationi sono agevolissime. Né, presuponendo io essersi detto da principio hocod’hoc, presupongo cosa fuori del ragionevole se altri havrà riguardo che d’hic,dicendosi hiqui, è poi rimaso qui, et d’hac, dicendosi haqua, è poi rimaso qua»(CASTELVETRO 2004: 16). Segnalo che sul ms. autografo della Giunta conservato aReggio Emilia, a f. 2r, Castelvetro scrive, in capitali, prima HICQUI, cancellando poi laC con un segno, probabilmente per omologare la forma alla successiva HAQUA.Nessun segno di correzione nel frammento Barbieri su questo punto. Da avvicinare aquesto passo, non solo per i rilievi etimologici ma per l’esposizione stessa delragionamento in merito alla deissi, anche quanto si legge in un passo delle GiunteMsrelativo ai pronomi: «ancora ci è Vicenome della prima persona, e significa il terzo, equarto caso del numero del più; e ha forza di fare, che il Verbo possa essere per sépassivo, come hanno mi, vi e ti; e non veggo al presente, onde sia preso. Ma oltracciòè Vicenome di luogo presente a colui, che parla; ed è preso dal latino hic proffertolevemente prima da’ Barbari, così, hici, e poi lasciato hi. E appresso è Vicenome ditempo presente a colui, che parla; essendo la sua significazione trasportata da luogopresente a tempo presente; sì come ancora si trasporta la significazione dal luogolontano in vi in tempo lontano» (cito da CASTELVETRO 1714: II 89).2 La distinzione tra forme simplici e composte è tradizionale (si veda POGGIOGALLI
1999: 313) e ritorna più volte anche nella Giunta (ad es. Verbi X 3 in CASTELVETRO
2004: 101).3 L’uso del femminile, in quanto voce o particella, è già bembiano.
LODOVICO CASTELVETRO46
lagrime» 97 a 24;4 «se tu l’hai qui perduto uccidendoti anche nell’altromondo il perderesti» 122 b 5;5 et di purgatorio: «che hai tu più che gli altriche qui sono» 196 b 24;6 et della metà del mondo ponendo il mare pertramezzatore:7 «io son vivo la dio mercé, et qui d’oltre mar ritornato» 276a 39;8 et d’un reame: «sarebbemi stato carissimo poi che la fortuna quin’havria mandato che quel tempo che voi et io viver dobbiamo nelgoverno del regno che io et voi parimente signori venuti fossimo insieme»274 b 26,9 et d’una provincia: 20 a 28;10 et di città: «percioché quantunquequivi così muoiano i lavoratori come qui fanno i cittadini» 7 a 18;11 etd’una chiesa: 6 a 34;12 et d’una casa et d’una camera: 18 b 17;13 etd’un’arca: 130 b 5;14 et d’una villa hora ponendo i confini più larghi: 90 a18,15 et hora più stretti: 9 a 20.16 Et per questa libertà di constituirsipresentia larga di luogo aviene alcuna volta che il terzo luogo17 sicomprenda sotto qui: «come sapeste voi che io qui fossi?» 39 a 27,18 ciò è
4 Dec. III 8: «Iddio […] la tua donna, la qual sempre, poi che tu di questa vita passasti,è stata». Traggo questa e tutte le altre citazioni boccacciane che seguono da Decamerone1527.5 Dec. IV 6: «perduto, uccidendoti».6 Dec. VII 9: «gli altri, che».7 Sull’uso di questi suffissati in –tore da parte di Castelvetro si vedano le notazionidella Grohovaz in CASTELVETRO 1999: 64.8 Dec. X 9: «Dio mercé et».9 Dec. X 9: «carissimo, poi […] mandato, che quel tempo, che voi et io viverdobbiamo, nel governo del regno, che io tengo, parimente».10 Il riferimento è a un passaggio di Dec. I 5 in cui si legge: «ma le femine, quantunquein vestimenti et in honori alquanto dall’altre variino, tutte perciò son fatte qui, comealtrove».11 Dec. I intr.: «percioché, quantunque […] lavoratori, come». La citazione ricorre piùvolte nel testo.12 Dec. I intr.: «noi dimoriamo qui al parer mio».13 Dec. I 4: «costei è una bella giovane et è qui che niuna persona del mondo il sa»; maalla riga 27.14 Dec. IV 10: «sarebbe il medico tornato, o altro accidente sopravenuto, perloquale ladonna dormendo io qui m’havesse nascoso?».15 Dec. I intr.: «qui sono giardini, qui sono pratelli, qui altri luoghi dilettevoli assai». Maalla c. 9r.16 Dec. I intr.: «come terza suona, ciascun qui sia».17 L’espressione è glossata in un passo delle GiunteMs relativo ai pronomi: «vi […] èVicenome ancora di terzo luogo, cioè di luogo lontano da colui, che parla, e da colui,a cui è parlato» (cito da CASTELVETRO 1714: II 86).18 Dec. II 5: «voi, che».
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 47
all’albergo et non in casa; et simile è: 62 b 10,19 122 b 13,20 131 b 30,21 240a 27.22 Et di più vi si comprende anchora il luogo della persona con cui siragiona: «oimè madonna et chi vi portò costà su? La fante vostra v’è tuttodì hoggi andata cercando ma chi havrebbe mai pensato che voi dovesteessere stata qui» 218 a 10,23 comprendendo non pure il battuto dellatorricella24 ma tutto il contorno col qui, in quanto venuto egli qui la trovò.La presentia del luogo significata per qui è alcuna volta fine di movimentodal di fuori et alcuna volta stanza et quasi campo dell’operatione in dettoluogo operata.25 La prima qualità è chiamata da’ grammatici ‘a luogo’, laseconda ‘in luogo’.26 Hora, altri non si maravigli che qui appo i volgarisignifichi ‘a luogo’ anchora avegna che appo i latini non significhi se non‘in luogo’, ché da principio quando la lingua latina si cominciò atrasformare nella nostra si posero per l’ignorazia de’ popoli nuovi gliadverbi pertinenti de’ luoghi l’un per l’altro ciò è que’ ‘in luogo’ per ‘aluogo’, sì come anchora nel nono libro dell’asino d’oro d’Apuleio ne ‹è›27uno evidente argomento le cui parole qui scriverò: «nam qui procerus, etut indicabat habitus atque habitudo, miles è legione factus nobis obviussuperbo atque arroganti sermone percontatus est, quorsum vacuumduceret asinum? At meus dominus adhuc maerore permixtus et alias latinisermonis ignarus tacitus praeteribat. Nec miles ille familiarem cohiberequivit insolentiam, sed indignatus silentio eius ut convitio, vite quamtenebat obtundens eum dorso meo proturbat. Tunc hortulanus supplicue
19 Dec. II 9: «io non so, come la mia si fa, ma questo so io bene, che quando qui miviene alle mani alcuna giovinetta, che mi piaccia».20 Dec. IV 6: «mettiamolo qui fuori in giardino».21 Dec. IV 10: «messere voi havete qui Ruggieri».22 Dec. IX 5: «vattene nella casa della paglia, ch’è qui dallato».23 Dec. VIII 7: «Madonna […] cercando, ma […] pensato, che».24 In riferimento a quanto detto in un passo della novella: «Quando la fante l’udìparlare quasi tutta riconfortata salì su per la scala, già presso che racconcia dallavoratore, et aiutata dallui in sul battuto pervenne» (c. 218r).25 L’opposizione terminologica stanza / movimento è già bembiana: «sono adunque diqueste voci, che io dico, qui et qua, che hora stanza et hora movimento dimostrano, etdannosi al luogo, nel quale è colui che parla» (Prose 1538: XCVIr; Prose 1549: 188).26 Si vedano ad esempio Gabriele: «qui, et qua, che nel luogo, et al luogo ove l’huomodimora, si danno»; e Corso: «di quelli [scil. gli avverbi], che a certi luoghi servono,faccio in tre parti in questo modo. Alcuni significano ‘in luogo’. Alcuni ‘a luogo’. Altri‘di luogo’, overo ‘per luogo’» (SANSOVINO 1562: 197v e 315v).27 La mancanza del verbo è il prodotto di un’autocorrezione incompiuta: Castelvetroaveva prima scritto ne sono, poi ha cancellato sono senza aggiungere nuovamente ilverbo.
LODOVICO CASTELVETRO48
respondit sermonis ignorantia se, quid ille diceret, scire non posse. Ergoigitur aegre subiiciens miles ubi inquit ducis asinum istum? Respondithortulanus petere se proximam civitatem».28 Vedi dunque il soldato usò,condescendendo alla ignoranza dell’hortolano non italiano, ubi adverbio‘in luogo’ per quorsum adverbio ‘a luogo’. Per la qual cosa malagevolemente29 si può assegnare diferenzia tra qui quando è ‘a luogo’ et quiquando è ‘in luogo’ che apparente sia.30
Prima diferenzia Diciamo non dimeno che ecco senza altro verbos’aggiugne a qui quando è ‘in luogo’: 62 a 3;31 211 b 20,32 che ‘a luogo’ nons’aggiugnerebbe.
2a diferenzia Appresso diciamo che il manifestamento del luogoquando qui è ‘in luogo’, si manifesta con IN: «qui in questo giardino» 122 b11;33 «qui in camera» 275 a 16.34 Ma quando è ‘‹a› luogo’35 si manifesta conA: «qui alla mia povera casa venuta» 156 a 36,36 la quale diferenzia è dellenovelle.37
3a diferenzia Oltre acciò quando qui è ‘in luogo’ si manifesta con moltiadverbi come «qui vicino» 181 b 8;38 «qui fuori» 122 b 13;39 «qui appresso
28 In assenza di indicazioni alfanumeriche, ho confrontato il testo castelvetrino conl’edizione APULEIUS 1521; il testo, alle cc. 102v-103r, coincide con quello citato daCastelvetro, a parte le solite divergenze di interpunzione, e la lezione quidam inveceche qui all’inizio della citazione.29 In questo punto, la grafia di mente non è chiarissima; la lezione, per la logica deldiscorso, mi pare tuttavia la più probabile. Va rilevato però che Castelvetrotendenzialmente non usa la forma analitica degli avverbi in mente e che la formauniverbata è attestata almeno in un punto nell’ed. 1527 (ad es. c. 24r:«malagevolmente»).30 Ossia: ‘che sia evidente’.31 Dec. II 8: «Monsignor ecco qui il padre e ’l figliuolo».32 Dec. VIII 7: «eccomi qui Madonna».33 Dec. IV 6.34 Dec. X 9.35 Il ms. reca qui ‘in luogo’. Emendo in quanto si tratta di una svista di copiatura datadalla vicinanza della forma nella riga sopra.36 Dec. V 9.37 È il termine con cui Castelvetro, come già Bembo, solitamente rinvia al Decameronsia nei suoi scritti (ad es. BIANCHI 1991: 492; Art., XIII 6-7 in CASTELVETRO 2004: 45)sia nei suoi postillati (MOTOLESE 2001: 514 e 516). Rispetto la scrizione con laminuscola che è nel manoscritto (mentre nell’ed. 1538 delle Prose di Bembo, adesempio, si ha la maiuscola).38 Dec. VII 4.39 Dec. IV 6.
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 49
di me» 34 b 37;40 270 a 4;41 «qui davanti» 118 b 20;42 «qui dinanzi» 203 a4;43 251 b 1544; «qui con esso meco» 45 b 15;45 86 b 13;46 142 b 16;47 177 a1;48 178 a 14;49 208 a 21;50 236 a 3;51 «qui dallato» 240 a 27;52 «qui presso»41 a 28;53 che quando è ‘a luogo’ non si manifesta con alcuno di questiadverbi nelle novelle.
4a diferenzia Anchora. Quando qui risponde a LÀ, sempre qui è ‘inluogo’: «pensa che tali sono là i prelati quali tu gli hai qui potuti vedere» 15b 17;54 «senza che tu diventerai molto migliore et più costumato, et più dabene là, che qui non faresti» 126 a 7,55 et il medesimo sarebbe se quiprecedesse là, anchora che il Bembo non creda trovarsi:56 «questocattivello che qui è là vidi io che dormiva» 269 b 29;57 «et assai conosco
40 Dec. II 3; ma la riga è la 27 e non la 37.41 Dec. X 8: «Gisippo a te sta homai o il volerti qui appresso di me dimorare o volerticon ogni cosa, che donata t’ho, in Achaya tornare».42 Dec. IV 4.43 Dec. VIII 3; ma la riga è la 24.44 Dec. X 2: «elle sono interamente qui dinanzi da voi tutte».45 Dec. II 6.46 Dec. III 6: «m’ha più di carezze et d’amorevolezze fatte in questo poco tempo, chequi stata son con lui».47 Dec. V 3: «tu dimorerai qui meco infino attanto, che fatto mi verrà di potertenesicuramente mandare a Roma».48 Dec. VII 1: «et io son qui con Giannino mio».49 Dec. VII 2: «che ho venduto a costui, che tu vedi qui con meco».50 Dec. VIII 6: «qui si vuole usare un poco d’arte».51 Dec. IX 3: «voi vi rimanete qui con lui».52 Dec. IX 5.53 Dec. II 5.54 Dec. I 2: «pensa, che tali sono là i prelati, quali tu gli hai qui potuti vedere». Lacitazione è però a riga 23. L’esempio è già in Prose III 56 (Prose 1538: XCVIv; Prose 1549:189); in margine al passo bembiano, nel postillato di Yale, si ha un rinvioalfanumerico al medesimo luogo boccacciano.55 Dec. IV 8: «costumato et più da bene». L’esempio è già in Prose III 56 (Prose 1538:XCVIv; Prose 1549: 189); anche in questo caso si ha un rinvio nell’esemplare di Yale.56 Il riferimento è a quanto si legge nelle Prose III 56: «È anchor da sapere che, quandoquesta particelle qua et là, insieme si pongono, non si dice qui; ma dicesi qua, per nonfare l’una dall’altra dissomigliante» (Prose 1538: XCVIr; Prose 1549: 189). Ma riguardoalla contrapposizione tra là/qua si veda oltre.57 Dec. X 8: «questo cattivello, che qui è, là vidi io, che si dormiva».
LODOVICO CASTELVETRO50
che egli v’era qui et dovea» etc. «considerando che di me là havrete ottimohoste» 268 a 1.58
5a diferenza Di più. A qui ‘in luogo’ risponde quivi: «perciochéquantunque quivi così muoiano i lavoratori come qui fanno i cittadini» 7 a18.59 Di che nel qui ‘a luogo’ non è essempio nelle novelle.
6a diferenzia Parimente a qui ‘in luogo’ risponde fuori di qui, che nonrisponde a qui ‘a luogo’: «per le quali cose et qui et fuor di qui et in casa misembra star male» 6 b 18.60
7a diferenzia Oltre acciò a qui ‘in luogo’ s’accompagna altrove ‘in luogo’et ‘a luogo’, che non s’accompagna con qui ‘a luogo’: «ma le femmine» etc.«tutte perciò son fatte qui come altrove» ‹20 a 27›;61 «piacerebbev’egli poiche altrove» etc. 141 b 34.62
Prima communità Hanno di comune insieme qui ‘a luogo’ et ‘in luogo’ chedove segue all’uno et all’altro in natura contraria: ciò è a qui ‘in luogo’ il dove‘a luogo’: «non voglio gridar qui dove la mia simplicità et soperchia gelosiami condusse» 87 b 2;63 et a qui ‘a luogo’ il dove ‘in luogo’: «qui me ne vennidove mercé d’iddio, et di questa gentil donna scampato sono» 186 b 1;64
8a diferenzia et nota che qui ‘a luogo’ non ha dopo sé dove ‘a luogo’, etnon dimeno qui ‘in luogo’ ha dove dopo sé ‘in luogo’: «in questa manierason qui dove io la buona mercé d’iddio, et non tua fratel mio dolce tiveggio» 39 a 9.65
9a diferenzia Anchora. Precedendo dove domandativo66 si sottogiugnequi ‘in luogo’ et non qui ‘a luogo’: «dove ha maggiori maestri et più savi inquella che qui?» 15 b 23.67 |9v|
58 Dec. X 8: «conosco, che egli v’era qui, et dovea essere et dee caro d’haver perparente Gisippo, ma io non vi debbo per alcuna cagione meno essere a Roma caro,considerando, che di me là havrete ottimo hoste».59 Dec. I intr.: «percioché, quantunque quivi così muoiano i lavoratori, come».60 Dec. I intr.: «per le quali cose, et qui».61 Dec. I 5: «ma le femmine, quantunque in vestimenti et in honori alquanto dallaltrevariino, tutte perciò son fatte qui, come altrove». Nel ms. manca il rinvioalfanumerico; poiché la citazione che segue è frutto di un’integrazione postanell’interlinea, è chiaro che si tratta di una banale dimenticanza.62 Dec. V 3: «piacerebbev’egli, poi che». La citazione ritorna poco più avanti.63 Dec. III 6: «qui, dove».64 Dec. VII 6: «venni, dove mercé d’Iddio et di questa».65 Dec. II 5: «son qui, dove».66 Nella Giunta Castelvetro adopera il termine col significato di ‘vocativo’ (ad es. Art.XV 28 in CASTELVETRO 2004: 68 ); qui vale, ovviamente, ‘interrogativo’.67 Citazione leggermente diversa in Dec. I 2: «savi huomini in quella, che son qui, dapoterti di ciò, che tu vorrai o domanderai, dichiarire?».
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 51
10a diferenzia Appresso. Quando qui è ‘in luogo’ si reitera e vis’aggiugne colà in compagnia: «radi qui, et qui, et anche colà, et vedine quirimaso un micolino» 178 b 4.68 Il che non aviene a qui […].69
11a diferenzia Et di più senza aggiungervi colà ma di due persone: «l’unadiceva pon qui questo, et l’a[ltra]diceva pon qui quello» 72 b 22.70
2a communità Hanno di commune che il qui così ‘in luogo’ come ‘aluogo’ si trapone tra la propositione71 et il verbo: «per qui venire acciochéla vostra santità mi marita[sse] mi misi in via» 34 b 18:72 «piacerebbe eglipoiche altrove andar non posso di qui ritenermi» 141 b [34].73
3a communità Hanno di commune qui ‘in luogo’ et qui ‘a luogo’ dimanifestarsi con questo adverbio di fuori: «io ho ogni dì veduto dar qui difuori a molta povera gente» etc. 21 a 27;74 «quando udirete sonare lecampanelle verrete qui di fuor della chiesa» 170 a 3.75
Locale DI QUI.76Di qui: significa, colla presentia di luogo dove è il parlante, movimentoinditerminato o movimento diterminato da quel cotal luogo a certoluog[o],77 o seperamento78 indeterminato o seperamento diterminato daquel cotal luogo in certo luogo, o principio di spazio in luogo diterminatoa certo luogo.79 Movimento indeterminato si dimostra col verbo ritrarsi:
68 Ancora parzialmente differente il passo nel Dec. (VII 2): «radi quivi, et quivi, etanche».69 Qui e alla riga successiva si ha una porzione mancante in fine di foglio.70 Dec. III 1: «l’una diceva, pon qui questo, et l’altra, pon qui quello». L’integrazionetestuale ricavata dal testo boccacciano colma la lacuna materiale della carta, giàsegnalata.71 Per l’uso di questa forma da parte di Castelvetro si veda il commento a Art. I 5 inCASTELVETRO 2004: 5-6.72 Dec. II 3: «per qui venire, acciò chella vostra santità mi maritasse, mi misi in via».Qui e nella citazione che segue intervengo per sanare la lacuna materiale sulmanoscritto sulla base della giuntina.73 Dec. V 3: «piacerebbev’egli, poi che altrove andar non posso, di qui ritenermi».74 Dec. I 6: «ho io ogni dì veduto dar qui di fuori a molta povera gente».75 Dec. VI 10: «campanelle, verrete».76 Il termine locale era tradizionale; pur se assente in Bembo, compare, ad es., inFORTUNIO 1999: 64, Acarisio (SANSOVINO 1562: 443v-445v), DOLCE 2004: 350.77 Anche in questo caso, intervengo per sanare una lacuna materiale dovuta a unaporzione mancante del foglio.78 Come si è detto, la forma con passaggio -ar- > -er- è costante in Castelvetro (ad es.CASTELVETRO 1999: 221).79 Così, invece, Castelvetro fa riferimento alla forma nelle GiunteMs: «Significaadunque ne predetto due casi, cioè il secondo, e ’l sesto dell’un numero, e dell’altro,
LODOVICO CASTELVETRO52
«io sono per ritrarmi del tutto di qui» 11 a 8;80 col verbo partire: «tantostodi qui ti parti» 34 a 35;81 col verbo mutarsi: «reputo opportuno di mutarci diqui» 70 a 26.82 Movimento diterminato si dimostra col verbo andare et conla propositione a: «io andassi di qui a perettola» 222 b 13;83 «d’andare diqui a Roma» 15 b 20;84 o col verbo mandare et la propositione IN: «voi ildoveste in alcuna parte mandare lontano di qui» 125 b 37.85 Seperamentoindeterminato si dimostra con l’adverbio fuori et il verbo essere: «et qui etfuor di qui et in casa mi sembra star male» 6 b 18;86 «se io di qui fossifuori» 45 a 24.87 Ma che diremo in questo caso di messer Pietro Bembo88 ilquale stima di qui nell’ultimo essempio addotto essere il medesimo che diqua,89 se non che di qua si dice quando s’accompagna con di là o veroquando significa ‘questo mondo’, quasi non dica: «Giotto a che horavenendo di qua allo ’ncontro di noi» etc. 166 a [7],90 et «il qual mottopassato di qua damare» etc. 103 a 5;91 o quasi di qui non sia ‘da luogo’ et diqua ‘in luogo’, o vero significa cis sì come a suo luogo mostreremo,92 dellequali significatione niuna ha di qui. Seperamento diterminato si dimostracon l’adverbio o nome93 lontano et col verbo essere: «il luogo è assai lontano
del terzo Vicenome; e appresso tre avverbi di luogo, onde altri si muove dove è colui,che parla, a cui si parla, e di cui si parla: cioè di qui, di costì e di quindi» (CASTELVETRO
1714: II 92).80 Dec. I 1.81 Dec. II 3 : «ti diparti».82 Dec. II 10.83 Dec. VIII 9 : «Peretola».84 Dec. I 2.85 Dec. IV 8.86 Dec. I intr.87 Dec. II 6. Si tratta della citazione presente nell’ed. 1538: XCVIv ma espunta dall’ed.1549 a cui si è fatto riferimento nell’introduzione. Nell’esemplare di Yale è presente ilrimando alla giuntina in corrispondenza del passo.88 Nei suoi scritti Castelvetro usa spesso questo modulo con messere (ad es. in Verbi I 2in CASTELVETRO 2004: 74).89 Il riferimento è al seguente passo delle Prose: «Fassi il somigliante nella di quaquando con la di là è posta: “acciò che io di là vantar mi possa che io di qua amato siadalla più bella donna, che mai formata fosse dalla natura”; che senza essa parlandosidi qui, et non di qua si dice: “di qui alle porte di Parigi”; “villa assai vicina di qui”; “saio di qui fossi fuori” et simili» (Prose 1538: XCVIv). Nell’esemplare di Yale, Castelvetrosegna in margine i rinvii corrispondenti.90 Dec. VI 5. Integro la lacuna materiale sulla base della impaginazione della giuntina.91 Dec. III 10.92 Si veda più avanti, nel passo relativo a di qua da.93 Ossia, in questo caso, ‘aggettivo’, come normale nella grammaticografia del tempo
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 53
di qui» 73 a 3;94 «non guari lontano di qui è un santo huomo» 101 b 12;95col verbo tenere et il nome lontano: «un pensiero molto di qui m’ha tenutogran pezza lontana» 168 a 12;96 con essere et con vicino nome et con lapropositione a: «a Varlungo villa assai vicina di qui fu un valente prete»199 b 20;97 con vedere et con vicino adverbio: «tu puoi di quinci vedere forseun miglio vicin di qui un boschetto» 253 a 30;98 col verbo trovare et conpresso adverbio: «io ho trovata una giovane assai presso di qui» 277 b 27.99Principio di spatio in luogo diterminato a certo luogo si dimostra con lapropositione a rispondente et con havessero o con trovassero: «di qui allaporta della sua casa ha poca via» 122 b 27;100 «ne troveresti un altro di quialle porte di parigi» 224 a 13.101
Temporale QUI quando significa tempo.Sono alcuni che hanno stimato qui significare tempo et valere quantoallhora: «et qui si tacque» 14 b 40,102 ciò è ‘allhora si tacque’, o valerequanto al presente: «figliuola qui non è altro da dire» 79 b 11,103 ciò è ‘alpresente’. La quale opinione sì come non è vera è da rifiutare, percioché ilprimo essempio non di fine di tempo ma di fine di parole ha luogo etsignifica che in queste parole si tacque, né il secondo riguarda tempoalcuno che altrove: 84 a 4 «hor qui non resta al presente altro»,104 doveseco s’accompagna al presente; per la qual cosa vale quanto nel presente stato.Della qual cosa si parlerà poco appresso.
Temporale Di quiDi qui temporale adverbio al quale risponde a: significa tempo presente delparlante. Ma ha tre diferenze. Percioché significa principio di tempopresente, et a fine di tempo futuro tra il quale principio et fine ha spatio, il
(basti, in proposito, il rinvio a Bembo, Prose III 7).94 Dec. III 1.95 Dec. III 10.96 Dec. VI 8: «un lungo pensiero».97 Dec. VIII 2; nella citazione Castelvetro omette un inciso tra parentesi. L’esempio ègià in Prose III 56; rinvio presente nell’esemplare di Yale (Prose 1538: XCVIr).98 Dec. X 3: «un mezzo miglio».99 Dec. X 10: «una giovane secondo il cuor mio assai».100 Dec. IV 6.101 Dec. VIII 9: «un’altro di qui alle porti di Parigi». L’esempio è già in Prose III 56;rinvio presente nell’esemplare di Yale (Prose 1538: XCVIr).102 Dec. I 1.103 Dec. III 3: «non ha altro».104 Dec. III 5: «resta ad dire al presente».
LODOVICO CASTELVETRO54
quale è tutto alcuna volta occupato dall’attione, et alcuna volta in parte, etaviene alcuna volta che non tutto o parte dello spatio ma il fine solamentedel tempo è occupato dall’attione. Gli essempi manifesteranno questadistintione. Lo spatio è tutto occupato: «quantunque il dì paia di qui allanotte durare» 26 a 3,105 percioché l’attione del durare del dì occupava dalvespro in fino alla notte che era lo spatio rinchiuso tra di qui et a; simile è:«io andavo (di male in peggio) di qui alla morte» 103 a 35,106 et: 232 a 5.107Parte dello spatio è occupato: «dinanzi al giudicio del quale (dio) di qui apicciola hora s’aspetta di dovere essere» 14 a 14,108 percioché non potevastare molto a morire ma la morte, però che è atto di momento, nonoccupava tutto lo spatio ma una particella. |10r| Il fine del temposolamente è occupato: «la festa di san Lorenzo fia di qui a due dì» 172 a26,109 ciò è passati i due dì; simile: «dove voi crediate potermegli rendere diqui a quindici dì» 228 b 2;110 «indugiandosi pur di qui a domane non nemorrà meno di trenta otto» 237 b 22.111Di qui: con domane senza a si governa come se a vi fosse, et focalemente112s’occupa il fine dalla attione: «non ci può essere di qui domane» 128 a26.113Fra qui a: significa pure presentia di tempo del parlante et spatio et fine intra il quale spatio si faccia l’attione che non occupi senon una particella deldetto spatio: «io intendo di menarlami fra qui a pochi dì a casa» 277 b28.114Fra qui et: di’ come di fra qui a: «scrivemi mio fratello» etc. «che senza alcunfallo gli habbia fra qui et otto dì mandati mille fiorin d’oro» 228 a 30.115Infino a qui: è da sapere che infino a qui non si trova nelle novelle ‘di luogo’ma ‘di tempo’ et ‘di cosa’, sì come sotto mostreremo.116 Hor parliamo
105 Dec. I 10.106 Dec. III 10: «poi non sia sempre di male in peggio andato, et così credo, che andròdi qui alla morte».107 Dec. IX 1: «di qui a un anno». Ma alla riga 15.108 Dec. I 1. La parentesi è nel ms.; integro il soggetto (con la maiuscola nella stampa).109 Dec. VI 10: «sia di qui».110 Dec. VIII 10.111 Dec. IX 4: «trentotto».112 Così nel ms.; ma la forma è assente dai repertori. È possibile si tratti di un lapsuscalami per localemente, da confrontarsi con la denominazione degli avverbi deittici come“locali” circolante al tempo e accolta dallo stesso Castelvetro (supra, p. 51 e nota 76).113 Dec. IV 9. Citazione presente in Prose III 56; rinvio presente nell’esemplare di Yale.114 Dec. X 10: «io intendo di tor per moglie, et di menarlami».115 Dec. VIII 10.116 Nel ms. i due paragrafi dedicati a infino a qui sono uniti da un tratto di penna.
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 55
quando significa tempo. Significa dunque presentia di tempo del parlantema contraria di quella che significava di qui, percioché di qui è principio ditempo riguardante il futuro, et infino a qui è fine di tempo riguardante ilpreterito, il quale preterito si continua infino al termine presente. Laondeanchora il Boccaccio sempre accompagnò con lui il verbo presente ho colpartefice preterito che hanno117 altresì questa medesima virtù come altroveparlammo:118 «sono io per quello che infino a qui ho fatto a tale venuto»74 a 35;119 80 a 7;120 147 a 22;121 251 b 24;122 257 b 12.123 Vedi in in quaqual diferenzia tra l’una et l’altra.
QUI non significante né luogo né tempo.Qui: significa termine di parlare già tenuto da persona lontana et dipresente recitato: «et qui si tacque» 14 b 40;124 263 b 19.125 Nella qual cosail Bembo errò negli Asolani primi, che i secondi non ho veduti, dicendoquivi stimando che così come di luogo lontano parlandosi si dice quiviparimente dir si dovesse di parlare lontano.126 Qui anchora significa statoet conditione delle cose presenti della persona parlante: «hor qui non restaad dire al presente altro» 84 a 4;127 «figliuola mia qui non ha altro da dire»79 b 11,128 265 a 7,129 ciò è nella presente conditione et stato delle cose.Significa anchora stato et conditione et stato di cose lontane et passatenarrate: «che adunque qui benigne donne direte» 257 a 3;130 258 b 3;131 281
117 Si riferisce ai partefici preteriti ossia ai ‘participi passati’; la costruzione ad sensumcompare altre volte negli scritti castelvetrini (ad es. Verbi LXVII 33 in CASTELVETRO
2004: 306).118 Come anticipato nell’introduzione, si tratta di un rinvio compatibile con quanto silegge nella Giunta ai verbi (Verbi XXXIX 4-13 in CASTELVETRO 2004: 191-193).119 Dec. III 1: «quello, che […] fatto, a tale venuto».120 Dec. III 3: «ella ha infino a qui».121 Dec. V 5: «et infino a qui creduto habbiamo».122 Dec. X 2: «che infino a qui paruta m’è».123 Dec. X 5: «come infino a qui».124 Dec. I 1; già citato in precedenza.125 Dec. X 7: «et qui si tacque».126 Vedi, ad esempio, Asolani, III 2 (c. k4r: «et quivi dettone questo»). I rinvii alle cartenelle mie citazioni sono ad ASOLANI 1505. Com’è noto, i secondi Asolani uscirononel 1530. Castelvetro racconta di averne avuto in mano una copia nella lettera alFalloppia edita da Valentina Grohovaz in questo stesso volume (vedi supra, p. 18).127 Dec. III 5; già citato in precedenza.128 Dec. III 3: «figliuola qui».129 Dec. X 8: «qui pecca la fortuna».130 Dec. X 4: «Benigne Donne».131 Rinvio non identificato.
LODOVICO CASTELVETRO56
a 15.132 Significa anchora cosa come rubamento ragionato: «qui si vuoleusare un poco d’arte» 208 a 22;133 come scrivere già fatto: «il che qui nonmi par assai convenevolemente bene haver fatto» 282 b 18;134 comenovellare: «se qui l’animo havessi havuto» 168 a 14.135Infino a qui non significante tempo.136Significa termine o di parlare o di scrivere presente della persona parlanteo scrivente riguardante il preterito come fu di sopra detto: «ma havereinfino a qui detto della presente novella voglio che mi basti» 105 b 37.137
QuiviIl Bembo dice che quivi vale quel medesimo che vale là et colà.138 Dellaquale cosa io ne dubito per molte differenzie che tra questi mi paretrovare.
Prima diferenza Primieramente troviamo là et qui, et quivi et qui. Ma nontra quivi et là dimeno dove si dice là non si potrebbe dire quivi, né allo
’ncontro dove si dice quivi si potrebbe dire là, percioché quivi in questocaso referisce139 il luogo dove è la cosa di che si parla allhora che si parla,et là referisce il luogo dove non è la cosa di che si parla allhora che siparla: «percioché quantunque quivi così muoiano i lavoratori come quifanno i cittadini» 7 a 18,140 quivi ciò è in contado dove erano lavoratori;«diventerai molto più migliore et più costumato, et più da bene là che quinon faresti» 126 a 7,141 là ciò è a Parigi dove non era Girolamo, et così è da
132 Dec. X 9: «che si potra dir qui?»133 Dec. VIII 6.134 Dec. concl.135 Dec. VI 8.136 Nell’autografo questa porzione di testo è collegata con un segno alla parte dedicataa infino a qui che precede.137 Dec. VI intr.: «voglio, che».138 Il riferimento è al seguente passo delle Prose III 56: «et è là, che si dà al luogo; nelquale né quegli che parla è né quegli che ascolta; et talhora stanza segna, et talhoramovimento, che poscia lì, sí come qui, non si disse se non da’ poeti. La qual particellanondimeno s’è alle volte posta da’ medesimi poeti in vece di costà: “Pur là su nonalberga ira né sdegno”. Dissesi eziandio colà, cioè ‘in quel luogo’ et ‘a quel luogo’»(Prose 1538: XCVIr; Prose 1549: 188-189).139 L’uso della forma referire è documentato anche nella Giunta, ad es. Art. XV 27 inCASTELVETRO 2004: 67. Più avanti, nel testo, in un unico caso, compare però anchela forma riferire.140 Dec. I 1: «percioché, quantunque […] lavoratori, come». Già citata più volte.141 Dec. IV 8: «migliore, et più». Già citata più volte.
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 57
intendere;142 «pensa che tali sono là i prelati quali ha potuti vedere» 15 b26,143 là ciò è a Roma, dove non sei, a cui s’ha riguardo;144 altrimenti ses’havesse riguardo a’ prelati si dovrebbe dire quivi.
2a diferenzia Raccontiamo alcuna volta il ragionamento d’alcunolontano non per parole in persona sua ma per conclusione in personanostra, et diciamo quivi fece punto, che non potremmo dire là fece fine: «dichehavendo già detti cento de suoi paternostri fatto punto quivi chiamò» etc.81 b 29;145 che se si dicesse fatto punto là referirebbe forse il termine d’altricento prima detto, dopo il qual punto havesse detto questi cento, ma quividimostra il termine di questi cento. Ma qui in passando146 è da dire perchél’autore scrivendo dica «detti cento de suoi paternostri fatto punto quivi»ove havendo scritta la novella di Pamphilo disse «et qui si tacque» 14 b40;147 et simile: 263 b 19.148 Hor dei sapere quando altri |10v| recita leparole, come si dice, formali149 fa la cosa presente in existenzia,150 laondesi può dire qui; ma quando per altre parole151 et per conclusione non la fapresente come è in existenzia, laonde152 si dee dire quivi; sì come altrinominando città lontana deve dire quivi perché il nome non la fa presentein existenzia.
3a diferenzia Quivi quando è ‘a luogo’ non s’accosta mai a dove: «quiviarrivò un legnetto de Pisani dove» 43 b 5;153 «quivi venne dove era ilconte» 60 b 33;154 «quivi venne dove» 69 b 4.155 Ma là et non vi
142 La precisazione è rispetto all’interpretazione che Bembo ne dà nel passo delle ProseIII 56.143 Dec. I 2: «pensa, che tali sono là i prelati, quali tu gli hai qui potuti vedere». Lacitazione è a riga 23. Già citato in precedenza.144 Ossia ‘riferimento’; altrove, ad es. in Art. XIV 7 in CASTELVETRO 2004: 50,Castelvetro usa il termine con il significato specifico di ‘relazione sintattica’.145 Dec. III 4: «paternostri, fatto punto quivi, chiamò»146 L’espressione ricorre frequentemente nella scrittura di Castelvetro: ad es. in VerbiLXIV 3: «Et in passando è da notare che...» (in CASTELVETRO 2004: 287).147 Dec. I 1.148 Dec. X 7: «et qui si tacque». Entrambi gli esempi già citati in precedenza.149 Ossia: ‘esatte, precise’. Il GDLI s.v. § 4 fornisce una serie di esempi, a partire dalSannazaro e almeno sino a Galilei, in cui ricorre l’espressione parole formali prima diuna citazione, ad indicare che il passo che viene riportato è riprodotto esattamente.150 Ossia: ‘come se fosse riportata nel momento preciso in cui fu pronunciata’.151 Ossia attraverso una citazione non letterale.152 Ossia: ‘in quel caso’.153 Dec. II 6.154 Dec. II 8. L’es. è già presente in Prose III 57; nell’esemplare di Yale si ha un rimando.155 Dec. II 10: «quivi venne, dove».
LODOVICO CASTELVETRO58
s’accosta:156 «là s’andò dove» 60 b 10;157 et vi s’accosta: «andati tutti làdove giacea» 14 a 13.158
4a diferenzia Quivi in compagnia di dove ‘a luogo’ non è mai sponitivodi luogo precedente;159 ma là ‘a luogo’ in compagnia di dove alcuna voltanon è spositivo:160 «andati tutti là dove giacea» 14 a 33;161 et alcuna volta èspositivo: «menarlo in questo capanetto là dove si fugge l’acqua» 73 b34;162 «a casa tornata là dove» 168 a 29;163 «verrete qui di fuori della chiesalà dove» 170 a 3.164 Et nota che quando là dove è spositivo là non si scostamai da dove.
5a diferenzia Là dove ‘a luogo’ significa lontananza della persona di chesi parla o prima o seconda o terza che si sia: «va tornati là dove infino adhora se stata» 181 a 33;165 «andati tutti là dove giacea» 14 a 33.166 Ma quividove ‘a luogo’ significa presentia della persona terza di che si parla, nellapersona novamente nominata s’intende essere in consideratione.Essempio: «per fortuna similmente quivi un legnetto de Pisani dove ellaprima era arrivata» 43 b 5,167 un legnetto de Pisani è la persona novamentenominata, alla quale è lontano il luogo dove era Madonna Beritola; et nondimeno havendo riguardo a lei, la quale prossimamente s’era nominata, etpiù volta, si dice quivi; che se prossimamente si fosse nominato il legnetto,et altravolta, si direbbe là, sì come: «gli altri frati creduli s’accordarono, etla sera andati tutti là dove il corpo di ser Ciappelletto giacea» 14 a 33,168perché ‹a› lungo mentione s’era fatta di frati, et così solverai i luoghi: «lagiannetta ciò sentendo uscì d’una camera, et quivi venne dove era il conte»
156 La notazione sul diverso comportamento tra quivi e là va collegata all’affermazionebembiana sull’identità tra le due forme, criticata in apertura di questo paragrafo suquivi.157 Dec. II 8: «là se n’andò dove».158 Dec. I 1: «andati tutti là, dove il corpo di Ser Ciappelletto giaceva». Ma a riga 33invece di 13.159 Ossia, in termini moderni, non ha valore anaforico.160 L’alternanza tra le due forme (sponitivo/spositivo) è sul ms.161 Dec. I 1. Vedi nota 213.162 Dec. III 1: «menarlo in questo capannetto là, dove egli fugge l’acqua».163 Dec. VI 8: «in casa».164 Dec. VI 10: «fuor […] là, dove».165 Dec. VII 4.166 Dec. I 1; passo più volte citato.167 Dec. II 6: «quivi arrivò un legnetto di».168 Dec. I 1: «gli altri frati creduli s’accordarono, et la sera andati tutti là, dove il corpodi ser Ciappelletto giaceva». Più volte citato.
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 59
60 b 33,169 perché s’era fatta mentione prossimamente del conte etGiannetta è persona nominata novamente; et il medesimo di: «ellaacconcia et vestita s’uscì d’una camera, et quivi venne dove M. Ricciardocon Paganino era» 68 b 4.170 Et questa, per dire così, è la diferentiaessentiale.
6a diferenzia Là dove ‘a luogo’, anchora che si sia fatta mentioneprossimamente, s’usa quando non s’è specialmente diterminato il luogodove era, et non si potrebbe dire quivi: «et di lui s’udì dire maravigliose etmagnifiche cose in tener sempre corte et non esser mai ad alcuno cheandasse là dove egli fosse negato, né mangiare né bere» 22 a 24,171percioché era incerto il luogo dove dimorasse a Primasso, onde nedomandò.
7a diferenzia Là dove ha là superfluo, ciò è che non ha verbo onde siregga: «domandò là dove esso potessi dormire» 33 b 31;172 «conoscendo làdove io era» 53 a 37.173 Ma quivi dove non può havere quivi superfluo inquesta guisa.
8a diferenzia Quivi è sposto da là dove, come Dante:
Ma là dove fortuna la balestraQuivi germoglia come gran di spelta.174
Ma là non è mai sposto da quivi dove.9a diferenzia Quando raccontiamo le parole d’alcuno in terza persona
parlante, del luogo a lui presente diciamo quivi et non là: «dopo moltiprieghi la pregarono adire chi ella fosse, et che quivi facesse» 43 b 21.175
169 Dec. II 8: «Giannetta [...] venne, dove». L’esempio è già in Prose III 57 (Prose 1538:XCVIIr; Prose 1549: 191).170 Dec. II 10: «ella vestita et acconcia s’uscì d’una camera, et quivi venne, dove MesserRicciardo con Paganino era».171 Dec. I 7: «corte, et non esser mai ad alcuno, che andasse là, dove egli fosse, negato,né mangiare né bere».172 Dec. II 3: «domando l’hoste là dove».173 Dec. II 7. Ma a pagina 55r. Su questo uso di là, con valore definibile comeappositivo, si veda VANELLI 2004: 3.174 If XIII 98-99; l’aldina del 1502 legge: «Ma là, dove fortuna la balestra: / Quivigermoglia; come gran di spelta» (c. d6v). Cito dall’esemplare conservato alla BibliotecaApostolica Vaticana segnato Aldine III, 8, con postille di Alessandro Tassoni.L’esempio è anche in Prose III 57 (Prose 1538: XCVIIr e Prose 1549: 191 recano: «quivigermoglia, come gran di spelta»). Il rinvio, scalato di una pagina (Prose 1538: 30 b 17;Prose 1549: 29 b 17), è presente in entrambi gli esemplari postillati delle Prose. Lacitazione è assente nell’ed. 1525.175 Dec. II 6: «doppo […] ad dire chi ella fosse, et che quivi facesse».
LODOVICO CASTELVETRO60
10a diferenzia Quivi è repetitivo di laonde: «fattisi menare al matto là,onde tratto l’havea, quivi con grandissimo dolore» etc. 51 b 31,176 che néquivi onde non si direbbe, né se si dicesse là il repitirebbe.
11a diferenzia Quivi si trappone tra il verbo infinito et il di: «insieme perpartito presero di quivi non aspettarlo» 53 b 5;177 si trapone178 anchora tral’infinito et il per: «per quivi disporre ogni cosa» 175 a 11.179
12a diferenzia Quivi referisce il dove quando è in vece di nome: «reputoopportuno di mutarci di qui et andarne altrove, et il dove io ho giàpensato, et proveduto, quivi quando noi saremo» etc. 70 a 28;180 o pureanchora quando non è in vece di nome: «dove noi andar ne vorremo neverranno, et quivi ciascun con la sua a guisa di tre fratelli viver potremo»155 b 32;181 et senza copola anchora: «dove meno era di forza sì come noinelle dilicate donne veggiamo quivi più avara fu di sostegno» 1 b 26.182
13a diferenzia Là espone il luogo precedente in questa guisa essendo poiesso esposto da altro luogo: «la nostra nave sdruscita percosse a certepiagge là in ponente vicine ad un luogo» 55 a 15,183 che non si potrebbe inquesto luogo dir quivi.
14a diferenzia Si pone là o là dove et con la copola si dice quivi, così:«perché voltati i passi là se ne vennero, et quivi essendo già le tavolemesse» 161 a 17,184 51 b 31,185 che non si potrebbe fare il contrario. |11r|
15a diferenzia Si dice dove là: «vennesene dove là usavano gli altrimercatanti» 228 a 7,186 che non si direbbe dove qui.
16a diferenzia Si dice quivi dentro: «et quivi luna si stea dentro collui» 73 b35;187 quivi d’intorno: «et quivi d’intorno alla chiara fonte fatti risciacquare ibicchieri» 249 a 18;188 quivi davanti: «et quivi davanti a tutti coloro» etc. 93 a9;189 quivi dinanzi: «essi quivi dinanzi alui mai a tale atto non si dovessero
176 Dec. II 7177 Dec. II 7.178 L’alternanza tra le due forme (trappone/trapone) è nel ms. Nella Giunta è presente lasola forma con la scempia, come già in Bembo.179 Dec. VII intr.180 Dec. II x: «di qui, et andarne […] proveduto. Quivi».181 Dec. IV 3: «vorremo, ne verranno». Ma a c. 115v.182 Dec. proemio: «forza, sì come […] veggiamo, quivi».183 Dec. II 7: «d’un luogo».184 Dec. VI intr.: «vennero. Et quivi, essendo».185 Dec. II 7; già citata in precedenza.186 Dec. VIII 10.187 Dec. III 1: «l’una».188 Dec. X intr.189 Dec. III 7.
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 61
esser condotto» 195 a 27;190 quivi vicino: «quivi vicino alla maggior chiesahebbe già una gentildonna» 204 b 25,191 che non si dice appresso ilBoccaccio né là dentro né là dintorno, né là davanti, né là dinanzi, né làvicino.192
17a diferenzia Quivi significa tempo: «quivi intorniando quella (valle) etriproveggiando tutta da capo tanto parve loro più bella» etc. 175 a 20,193ciò è ‘allhora’,194 salvo se noi non vogliamo dire non quivi significhi laparte di dentro, ciò è essendo di dentro della valle la intorniarono, il chepiù mi piace che là non significa tempo.
18a diferenza Si dice più là, più là che, là ove, là onde, là entro, là giù, là giuso,di là entro, di là dove, di là onde, di là ove, da indi in là, pertutto là dove, qua et là, inqua et in là, delle quali particolarmente si parlerà di sotto,195 ché non si dicené più quivi, né più quivi che, né quivi ove, né quivi entro, né quivi giù, né quivigiuso, né di quivi entro, né di quivi dove, né di quivi onde, né di quivi ove, né daindi in quivi, né in qua et in quivi, né già a quivi, né per tutto quivi dove.
Prima communità Hanno di commune insieme che quivi su si dice: «et quivisu mal grado di quanti ve n’erano montato» 119 a 18,196 et là su parimente:«in sul vespro se n’andò là su».197 Considera non dimeno che duediferenzie possono essere da quivi su a là su.
Prima diferenzia della prima La prima si è che quivi su può significare non2a diferenzia communità ‘sursum’ ma ‘supra’: «ella occultamente
disotterra la testa, et mettela in un testo di bassilisco et quivi su piangendo
190 Dec. VII 9: «allui […] condotti».191 Dec. VIII 4.192 Le concordanze decameroniane confermano la notazione castelvetrina. A riprovadell’uso del Decameron quale repertorio virtualmente esaustivo per questo settore, sinoti che, sulla base dell’archivio LIZ4 [limitazione corpus ’200-’500], solo un paio dilocuzioni avverbiali sono attestate anche nel ristretto canone trecentesco (così làdentro ricorre in If XXVI 55; là vicino in If XXII 67, ma in sequenza di là vicino); le altreappaiono più marginali: là davanti risulta solo in Boiardo (Orlando innamorato, II 18 53);là dintorno compare solo quattro volte, di cui una però nel Filostrato (VIII 9, là d’intorno,secondo l’ed. utilizzata dalla LIZ); nessun caso di là dinanzi (o d’inanzi).193 Dec. VII intr.: «quella, et […] da capo, tanto». Tra parentesi sul ms. il riferimentodel pronome, ovviamente assente nel testo boccacciano.194 In proposito, ricordo che il significato temporale di quivi è annotato, tramite unacitazione dantesca, nella carta di guardia dell’esemplare palatino: «Quivi invece diallhora D. Inf. 92 a 15» (ma il rinvio è a Pg V 54; si veda MOTOLESE 2001: 534).195 Si veda, per questo, più avanti.196 Dec. IV 4: «n’eran».197 Dec. VII 1: «in su’l vespro». La citazione torna più avanti.
LODOVICO CASTELVETRO62
ogni dì» etc. 119 b 2,198 che là su sempre significa ‘sursum’. La 2a diferenziasi è che, secondo il Bembo, secondo i poeti s’è posta là su in vece di costàsu: «pur là su non alberga ira né sdegno» 130 b 8,199 quantunque io sia didiversa opinione come mostreremo,200 et è usata da’ prosatori nonsolamente in chi è là?, ma anchora il Boccaccio disse alla guisa del Petrarca:«chi piagne lasù?» 228 a 5.201
2a communità A quivi quando è ‘in luogo’ si può accostare il dove:«conciofosse cosa che da quivi dove erano non haveano essi affar più chetutti gli altri cittadini» 169 a 27,202 il che parimente fa là dove: «io sono statopiù volte già ladove io ho veduto merendarsi le donne» 25 b 29.203
3a communità Si dice quivi a cui s’accompagna qui: «quantunque quivicosì muoiano i lavoratori come qui fanno i cittadini» 7 a 18;204 parimente alà s’accompagna qui: «tali sono là i prelati quali tu gli hai qui potuti vedere»15 b 17.205
Diferenza della 3a communità Ma ha una diferenza: che si può dire qui a cuis’accompagna là dopo, come è veduto di sopra,206 che non n’ho essempiodi qui a cui dopo seguiti quivi.
4a communità Quivi riceve restrignimento da luogo con la propositioneIN: «et quivi peraventura arrivata in alberghetto» 99 a 38;207 «quivi con
198 Dec. IV 5, nella rubrica: «testa et mettela […] piagnendo».199Rvf CCCXL 8. L’aldina del 1514, cui si riferisce il rimando a testo, legge: «Pur lassùnon alberga ira, né sdegno». La forma analitica dell’avverbio e l’assenza della virgola sihanno però nella citazione del verso presente nelle tre edizioni delle Prose (Prose 1525:LXXXIXv; Prose 1538: XCVIr; Prose 1549: 189). A partire dalla citazione bembianal’esempio era entrato nel repertorio tradizionale delle citazioni grammaticali; lo sitrova, ad es., anche in Giacomo Gabriele (SANSOVINO 1562: 198, nella stessa lezionebembiana). Nessun rinvio è presente nell’esemplare palatino delle Prose; si ha inveceun rimando nell’esemplare di Yale del 1538.200 Anche per questo, si veda più oltre.201 Dec. VIII 7. La parzialità della regola bembiana era già stata notata da ACARISIO
(SANSOVINO 1562: 445): «la particola là vale a le volte la costà et ne’ versi et ne leprose, benché il Bembo dica essere usata solamente da’ poeti».202 Dec. VI 9: «conciofosse cosa, che da quivi dove erano, non haveano essi affar più,che tutti gli altri cittadini».203 Dec. I 10: «già, là dove». Ma a riga 20.204 Dec. I 1: «percioché, quantunque […] lavoratori, come». Già citata in precedenza.205 Dec. I 2: «pensa, che tali sono là i prelati, quali». La citazione è a riga 23. Già citatain precedenza.206 Si veda supra, nella parte relativa a qui.207 Dec. III 9: «peradventura […] in uno alberghetto».
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 63
questa testa nella sua camera rinchiusasi» 120 b 8.208 Parimente là siristrigne da luogo con IN: «questi là pervenuto in luogo rilevato et alto»114 b 10.209
5a communità Là o altrove si dice: «non sappiendo perciò che il suo fantelà o altrove si fosse fuggito» 30 b 11;210 et parimente quivi né altrove: «ma ionon la trovai né quivi, né altrove» 217 b 29.211
|11v|DI QUIVI: significa dal luogo dove è la terza persona movimentoindeterminato: «prima che di quivi si partissono» etc. 167 b 36.212 Oseperamento diterminato, che sì dimostra l’averbio lontano o nome che sisia:213 «castello non molto di quivi lontano» 47 a 14;214 «la quale nave eraalquanto di quivi lontana in alba» 65 a 20;215 «la casa non guari di quivi eralontana» 181 a 14;216 o con presso: «il quale amico ella sotto la cesta assaipresso di quivi havea» 159 a 12;217 o con distante: «et quanto fosse il luogodi quivi distante» 174 a 22.218 O significa principio di spatio in luogoditerminato a certo luogo con la propositione a rispondente con havere:«quanto anchora havesse di quivi a Pavia».219
DI QUINDI che secondo il Bembo è una cosa medesima con DI QUIVI, diche poco appresso apparirà la verità:220 significa alcuna volta il luogo perlo quale si passa di terza persona, che i latini dicono illac: «avenne chepassando costoro che mi tiravano, una strada per entrare in uno
208 Dec. IV 5.209 Dec. IV 2.210 Dec. II 2.211 Dec. VIII 7.212 Dec. VI 7.213 Si ricordi, già prima, la notazione: «seperamento diterminato si dimostra conl’adverbio o nome lontano».214 Dec. II 6: «n’andò ad uno castel di Currado non molto».215 Dec. II 9: «il quale d’una sua nave, la quale alquanto di quivi era lontana in Alba,disceso era».216 Dec. VII 4: «non solamente havea preso ardire di menarsi il suo amante in casa, maella talvolta gran parte della notte s’andava con lui a dimorare alla sua, la quale diquivi non era guari lontana».217 Dec. V 9: «poi ricordandosi dell’amico, il quale […] haveva».218 Dec. VI 10: «come era fatto il luogo, et quanto di quivi distante».219 Dec. X 9. La citazione ricorre identica a c. 270v dell’edizione 1527, ultima riga.220 Per l’accenno alla forma di quindi nelle GiunteMs, vedi supra nota 79.
LODOVICO CASTELVETRO64
grandissimo bosco quattro huomini in quell’hora di quindi passavano acavallo» 55 a 25.221 La qual cosa non significa DI QUIVI.
P(rim)a diferenzia Significa anchora dal luogo terzo movimento diterminatocol verbo venire et la propositione A: «poi di quindi se ne venne a Firenze»230 a 37;222 con pervenire et IN: «et di quindi pervenne in Parione» 171 b8;223 con condurre et INFINO: «et quindi di Marina in marina si condusseinfino a Trani» 37 a 31;224 con rimandare et A: «et di quindi buona et interaragione rimandò a Firenze a suoi maestri» 230 a 33;225 con menare et IN: «etdi quindi» etc. «Cimone et i compagni menò in prigione» 135 b 5;226 convenire et verso: «et quindi verso la casa sene vennero» 241 b 18.227 La qualcosa non si trova usata in DI QUIVI.
2a diferenzia Significa anchora movimento indeterminato di luogoterzo: «dubito forte, che morta non fosse o di quindi mutatasi» 88 a 29;228et con verbo uscire: 114 a 25;229 con ritrarre: 120 b 36;230 con venire: 158 b10;231 con levarsi: 31 b 32.232
Sola communità Il che parimente fa di quivi.3a diferenzia Non significa seperamento diterminato, né significa prin-4a diferenzia cipio di spatio in luogo diterminato a certo luogo come fa
DI QUIVI.
221 Dec. II 7: «avenne, che passando costoro, che mi tiravano una strada per entrare inuno grandissimo bosco, quattro huomini».222 Dec. VIII 10: «poi di quindi, non volendo più mercatante essere, se ne venne aFirenze».223 Dec. VI 10: «et di quindi per lo reame del Garbo cavalcando et per Baldacca,pervenni in Parione».224 Dec. II 4.225 Dec. VIII 10.226 Dec. V 1: «et di quindi venuto alla città Lisimaco, appo il quale quello anno era ilsommo maestrato de rhodiani, con grandissima compagnia d’huomini d’armeCimone e’ suoi [sic] compagni». La pagina è la 136v. L’accento sul passato è sul ms.Come si vedrà, Castelvetro tende a segnare l’accento sui passati remoti in –ò,distaccandosi dunque dalla stampa.227 Dec. IX 5: «et di quindi come se di Romagna tornassero, data la volta verso la casase ne vennero».228 Dec. III 7: «non fosse, o di quindi mutatasi».229 Dec. IV 2: «disiderando frate Alberto d’uscire di quindi».230 Dec. IV 5: «ordinato come di quindi si ritrahessono».231 Dec. V 9: «che di quindi venisse il suono».232 Dec. II 2: «levatisi di quindi nella camera se ne andarono».
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 65
QUINDI: primieramente significa movimento indeterminato da terzoluogo: «avanti che quindi si dipartirono» 74 a 7;233 anchora col verbo levare:66 b 33;234 levarsi da sedersi: 7 a 39;235 andare: 42 a 31;236 uscire: 136 a 31;237trarsi: 162 b 16;238 trarre: 233 b 39.239 Significa anchora da terzo luogomovimento diterminato con la propositione a et il verbo andare: «et quindin’andò ad un altro uscio» 84 a 36;240 con richiamare: 133 b 33;241 con venire:246 a 29;242 et con la propositione in et il verbo andare: «quindi andarono idue cavallieri in Inghilterra» 35 a 28;243 con passare: 171 b 17;244 con gittarsi:114 a 5;245 et con la propositione IN SU et il verbo rimontare: «quindirimontati in su la nave» 53 b 33;246 con la propositione per et il verbodiscorrere: «quindi per canaletti simili quasi per ogni parte discorrea» 71 b25;247 con la propositione verso et discendere: «quindi verso il pianodiscendendo» 71 b 27.248 Significa anchora terzo luogo per lo quale sipassa: «in sulla nona peraventura da uno suo luogo tornando passò quindiun gentilhuomo» 43 a 3;249 «avisando quindi la nave della donna passare»118 b 11.250 Ci pare d’ammonire il lettore251 che sono altresì nomi chehanno in sé incluso il luogo naturalmente, sì come romito, ciò è la persona
233 Dec. III 1.234 Dec. II 9: «né quindi mai, infino attanto, che per sé medesimo non cadesse, levatofosse».235 Dec. I intr.: «quindi levandosi da sedere».236 Dec. II 5: «andando alla ventura pervenne alla marina, et quindi al suo albergo sirabbatté».237 Dec. V 1: «comando, che ogni forza si mettesse ad uscir quindi».238 Dec. VI 2: «et quindi ne maggior bisogni le traggono».239 Dec. IX 1: «avisando la famiglia quindi averlo tolto, dolente a casa se ne tornò».240 Dec. III 5. Anche in questo caso l’accento sul verbo è nel ms.; assente nella stampa.241 Dec. V 1, rubrica: «Lisimacho il trahe et da capo con lui rapisce Ephigenia etCassandra nelle lor nozze, fuggendosi con esse in Creti, et quindi, divenute mogli,con esse a casa loro sono richiamati».242 Dec. IX 9: «quindi dopo alquanti divenuti ad antiochia».243 Dec. II 3: «cavalieri in Inghiltera».244 Il rinvio contiene un errore che non permette di rintracciare la citazione.245 Dec. IV 2: «et quindi si gittò nell’acqua».246 Dec. II 7 : «quindi rimontati in sulla barca». La pagina è la 52v.247 Dec. III intr.: «parte del giardino discorrea».248 Dec. III intr.249 Dec. II 7: «peradventura». Ma a c. 49r .250 Dec. IV 4: «quindi dovere la nave».251 Il richiamo al lettore è indizio di una destinazione non solamente privata deltrattatello. Per questa notazione e, più in generale, per la circolazione manoscrittadegli opuscoli castelvetrini si veda quanto già detto nell’introduzione.
LODOVICO CASTELVETRO66
che sta nell’heremo, a cui s’accompagna quindi et s’intende dall’heremo:252«Alibech diviene romita, a cui rustico monaco insegna a rimettere ildiavolo in inferno, poi quindi tolta» etc. 101 a 14.253 Significa anchoraordine, poi;254 et alcuna volta né precede né seguita niuna particellad’ordine come: «quindi fatto il corpo della bella donna ricoglier di mare»etc. 119 a 26;255 alcuna volta precede primieramente et appresso et nel 3o luogoquindi: 270 a 3;256 alcuna volta precede appresso et seguita quindi: 197 a 8,257alcuna volta precede et oltre a questo, seguita et quindi: 103 a 29;258 alcunavolta niuna particella d’ordine precede ma seguita, come quindi et seguitaappresso: 47 b 8;259 alcuna volta è preceduta et seguita con questo ordine:appresso, quindi, oltre a questo, et poi, et questo fatto: 275 b 5;260 anchora con
252 Ossia: ‘rispetto all’eremo’.253 Dec. III 10: «Rustico»254 Costrutto ellittico che vale: ‘ossia poi’, come, più avanti: «significa anchora ordinecio è poi». Utilizzo il corsivo e non le virgolette metalinguistiche perché non è ilsignificato cui Castelvetro fa riferimento ma la forma stessa, come mostra anchel’adozione del maiuscolo che, nel ms., contraddistingue le forme oggetto. Riguardo alconcetto di ordine nel senso di ‘sequenza logico-temporale’ si veda ad es. Corso, cheinclude quinci tra gli avverbi utili ad «ordinare» ma non quindi (SANSOVINO 1562: 417).Il significato è da aggiungere alla documentazione presente in POGGIOGALLI (1999:336-338).255 Dec. IV 4.256 Dec. X 8: «primieramente con lui ogni suo thesoro, et possessione fece commune,et appresso una sua sorella giovinetta chiamata Fulvia gli diè per moglie, et quindi glidisse».257 Dec. VII 10: «et appresso ciò, che afare havesse, mentre il suo reggimento durassegli diviso. Quindi rivolta alla compagnia disse».258 Dec. III 10: «et oltre a questo secondo che avisò, che bene stesse, et che dovessesodisfare alla compagnia per quanto la sua signoria dovea durare, discretamenteordinò, et quindi rivolto alle donne disse».259 Dec. II 6: «quindi a Messer Guasparino rivolti, il cui beneficio era inopinato, disserose essere certissimi, che qualora ciò, che per lui verso lo Scacciato stato era fatto,d’Arrighetto si sapesse che gratie simiglianti et maggiori rendute sarebbono. Appressoquesto letissimamente nella festa delle due nuove spose et con gli novelli sposimangiarono».260 Dec. X 9: «appresso mise in dito a Messer Torello uno anello, nel quale era legatoun Carbunculo tanto lucente, che un torchio acceso pareva, il valor del quale appenasi poteva stimare. Quindi gli fece una spada cignere, il cui guernimento non si saria dileggieri apprezzato. Et oltre a questo un fermaglio gli fe davanti appiccare, nel qualeerano perle mai simili non vedute, con altre care pietre assai. Et poi da ciascun de latidi lui due grandissimi bacin d’oro pieni di doble fe porre, et molte reti di perle et
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 67
questo altro ordine: poi, quindi, appresso la qual cosa: 71 a 28.261 Si diceanchora: Quindi appresso.Quindi appresso: |12r| per lo medesimo che è quindi, et precede primieramente,et seguita quindi appresso: 37 a 21.262
QUINDI GIÙ: significa movimento indeterminato da luogo terzo alto versoil basso: «et poi gli gittavano quindi giù» 202 a 2.263QUINDI GIUSO: significa il medesimo: «per la qual cosa capo levandoquesta tavola sen’andò quindi giuso» 37 b 37.264PER QUINDI: significa terzo luogo per lo quale si passa, col verbo andare ovenire: «a chi andava o veniva per quindi» 252 b 6;265 con portare: «qualbisogno per quindi il portasse» 255 a 6;266 con uscire: «alessandro levatosi,
PER QUINDI = DONDE et per quindi della camera uscendo donde eraentrato» 34 b 6.267DA QUINDI INNANZI: adverbio temporale, significa principio certo ditempo passato onde si muova l’attione verso il futuro indeterminato: «ilche da quindi innanzi ciascuno fece» 274 a 6.268 Et nota che il Bembo nonfa mentione di questo adverbio.269
anella, et cinture et altre cose, le quali lungo sarebbe a raccontare, gli fece metterdatorno. E questo fatto da capo bascio Messer Torello».261 Dec. III, intr.: «poi a basso discesi et veduta l’ampissima et lieta corte di quello, levolte piene d’ottimi vini, et la freddissima acqua et in gran copia, che quivi surgea, piùancora il lodarono. Quindi quasi di riposo vaghi, sopra una loggia, che la corte tuttasignoreggiava, essendo ogni cosa piena di que fiori, che concedeva il tempo, et difrondi, postesi a sedere, venne il discreto siniscalco, et loro con pretiosissimi confettiet ottimi vini ricevette, et riconfortò. Appresso laqual cosa fattosi aprire un giardino,che di costa era al palagio, in quello, che tutto era datorno murato, se n’entrarono».262 Dec. II 4: «questi non potea favellare, et poco vedea, et perciò niente le disse, mapur mandandolo verso la terra il mare costei conobbe la forma della cassa, et piùsottilmente guardando, et vedendo conobbe primieramente le braccia stese sopra lacassa, quindi appresso raviso la faccia, et quello essere, che era, s’immaginò».263 Dec. VIII 3: «gittavan».264 Dec. II 5: «questa tavola con lui insieme». Anche in questo caso l’accento è già sulms.; senza accento, come al solito, la stampa.265 Dec. X 3: «a chi andava, o veniva». Rinvio a questo passo presente nell’esemplare diYale in margine a per quindi di Prose III 57.266 Dec. X 3; a riga 16, però.267 Dec. II 3: «Alessandro levatosi et per quindi della camera uscendo, donde».L’esempio è già in Prose III 57; rinvio presente nell’esemplare di Yale.268 Dec. X 9 : «ciascun».269 Oltre che assente nelle Prose, la locuzione avverbiale non è trattata nemmeno, adesempio, da Dolce, Acarisio e Corso.
LODOVICO CASTELVETRO68
QUINCI: significa movimento indeterminato dal luogo dove è la personaparlante, col verbo levare: «quinci levatici» 26 a 30;270 uscire: 92 a 18;271smontare: 216 b 4;272 partire: 242 a 32.273 Significa anchora seperationedell’attione dal luogo della persona parlante senza moversi la personaoperante del luogo: «Fiesole il cui poggio noi possiamo quinci vedere» 204b 23,274 seguendo quella opinione che la vista si faccia col mandare i raggivicini alla cosa veduta. Significa anchora ordine, ciò è poi, ma è da sapereche non admette particelle ordinatrici né davanti né dopo sé et gli deesempre precedere la copola et in questa guisa: «et quinci fatta laconfessione» etc. 77 b 31;275 «et quinci tacendo» etc. 83 a 32.276 Significaanchora da questa cosa della quale si sia parlata: «perciò che se quinci noncomincia la cagione del mio bene potere adoperare» 94 b 13,277 et havevadetto: «vi prego che sopra questo vi piaccia di darmi alcun consiglio».278QUINCI GIÙ DINANZI A: significa movimento da luogo alto dove è lapersona parlante verso il basso in presenzia di chi che sia: «come sarebbe ilgittarmi a guisa di disperata quinci giù dinanzi agli occhi tuoi» 255 b 14.279QUINCI SU: secondo la proportione280 delle compagne dovrebbesignificare seperatione dell’attione del luogo verso l’alto, diterminata, ov’èla persona parlante senza muoversi l’operante: «mi disse che tu haveviquinci su una giovinetta che tu tenevi a tua posta» 209 b 19,281 ciò è che tustandoti qui operava questo: che tenevi fuori di qui verso l’alto unagiovinetta.DI QUINCI: significa movimento indeterminato dal luogo dove è la personaparlante, col verbo uscire: «et se di quinci usciamo» 6 b 1;282 discendere, 215 b6.283 Significa anchora seperatione dall’attione del luogo dove è la persona
270 Dec. I concl.271 Dec. III 7: «se io quinci esco vivo».272 Dec. VIII 7: «et quinci mi fa smontare».273 Dec. IX 5: «poscia che io mi parti quinci».274 Dec. VIII 4: «Fiesole, il cui».275 Dec. III 3.276 Dec. III 5.277 Dec. III 8.278 Dec. III 8: «vi priego, che».279 Dec. VIII 7.280 È espressione che, con il medesimo significato di ‘rapporto simmetrico’, ricorrediverse volte nella Giunta (ad es. Verbi, XXVI 15 o XLII 10, rispettivamente inCASTELVETRO 2004: 172 e 209).281 Dec. VIII 6: «mi disse, che […] giovinetta, che».282 Dec. I intr.283 Dec. VIII 7 «quando tu perdonar mi vogli, et di quinci farmi discendere».
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 69
parlante senza muoversi la persona operante: «tu puoi di quinci vedereforse un miglio vicin di qui un boschetto» 253 a 29.284 Significa anchoraquesta cosa della quale si sia parlato: 285 «noi altresì mentiamo altrui, et diquinci venne, et non da altro difetto» 229 b 6.286DA QUINCI INNANZI: adverbio temporale, significa principio di tempopresente onde si muova l’attione verso il futuro indeterminato: «sii daquinci innanzi amico et servitore di dio» 97 a 25;287 «guarda che per la tuavita da quinci innanzi simili novelle noi non sentiamo più» 191 b 14.288 Nédi questo adverbio fa mentione il Bembo.289 |12v|QUINCENTRO: appresso il Boccaccio, che che si dica il Bembo290 significastanza senza movimento dove è la persona parlante: «i cognati della donnaavisando che voi in alcun luogo quincentro siate» 114 a 34. Vero è chealcuni testi et buoni leggono quicentro;291 et così l’altro essempio: «io soncerta che ella è anchora quicentro» 110 b 12.292 Né sarebbe cosa senzaragione che hic latino havesse mutato H in QU, et servato il C: hicentro
284 Dec. X 3: «mezzo miglio».285 Ossia : ‘una determinata cosa di cui si è detto precedentemente’.286 Dec. VIII 10: «venne, et non».287 Dec. III 8: «d’iddio».288 Dec. VII 8: «vita tua».289 La locuzione avverbiale è invece presente in Prose III 60: «da quinci innanzi et da indiinnanzi; la qual si disse alcuna volta da indi in avanti: ma tuttavia di rado» (Prose 1525:LXXXIIr; Prose 1538: XCIXr; Prose 1549: 195). Nel postillato di Yale si haun’annotazione marginale in cui si rinvia a un passo del Decameron (II, 10; c. 70r, riga21) in cui compare la locuzione da indi in avanti.290 Si veda Prose III 57: «Sono quincisu e quindigiu et quincentro, che tanto alcuna voltavale quanto per qua entro; sì come la fe valere, non solo Dante nelle terze rime sue piùvolte, ma ancora il Boccaccio nelle sue Novelle quando e disse: “Io son certo, che ellaè ancora quincentro, e risguarda i luoghi de’ suoi diletti”» (Prose 1538: XCVIIv). Inmargine, nell’esemplare di Yale, si ha il rinvio a Dec. IV 1 che comparirà poco oltre.291 Dec. IV 2: «avisando, che». Anche l’Hamilton 90 legge quincentro (ed. Singleton, p.281; ed. Branca, p. 274: c. 50rB, senza indicazioni di varianti).292 Dec. IV 1: «certa, che». L’esempio è anche nelle Prose III 57: la forma quincentro nonpresenta varianti dall’autografo (Vat. lat. 3210, f. 153r) sino all’ed. 1549. La formaquincentro in questo punto è anche nell’Hamilton 90 (ed. Singleton, p. 291; ed. Branca,p. 283: c. 52rA, senza indicazioni di varianti). Quicentro è però, come nota Castelvetro,presente in buoni testi a penna; così ad esempio nel Mannelli. Non a caso su di essa sisoffermeranno, qualche anno più tardi, i deputati fiorentini che prepareranno l’ed.decameroniana del 1573, i quali definiranno la forma «pura et natia di questa lingua etin questo luogo proprissima», sostenendone l’adeguatezza al passo boccacciano graziea una differenziazione semantica (si veda Annotazioni 2001: 187-190). Su questavariante, in relazione alle Prose, si veda TAVOSANIS 2002: 139.
LODOVICO CASTELVETRO70
QUICENTRO ⁄ 293
QUA: significa stanza in luogo dove è la persona parlante, ma largo largo,come d’una città et d’un paese: «egli è qua un malvagio huomo che m’hatagliata la borsa» 28 b 36,294 ciò è nella città; «le donne qua chiamano rose»151 a 32,295 ciò è in Thoscana; «non vi voglio qua donare né castel nécittà» 250 a 23,296 ciò è in Ispagna. Né riceve giunta di manifestamento diluogo.297 Significa movimento a luogo dove è la persona parlante quandolargo et quando stretto. Largo: «qua picciol fanciul trasportato da non soche gente» 151 b 7298 ciò è in questo paese; stretto: «venite qua» 180 a29.299 Et riceve giunta di manifestamento di luogo con IN: «sereandiamcene qui nella capanna» 200 b 18,300 nella quale non era néBelcolore né il sere, in guisa è301 largo il qua con a: «digli che qua se nevenga al fuogo» 31 a 31;302 «era disposto a venir qui a grandissimeheredità» 224 a 9.303
Hor qua, hor là overo hor qua et hor là: par che significhi in parte luogo doveè la persona parlante et luogo secondo tempo diviso in due partisolamente ma non è così, ché significa terzo luogo solamente etmovimento, o attorno, d’un solo, secondo tempo in più parti del luogo:«andando il prete di fitto meriggio per la contrada hor qua, hor là zazeato»200 a 13;304 «volgendosi intorno, et hor qua et hor là riguardando rispose»203 a 23;305 «guardando hor qua hor là se alcuna persona venir vedesse»
293 Riproduco in questo modo il segno che, sul ms., collega la forma in capitaliquicentro al brano che precede su quincentro.294 Dec. II 1: «huomo, che».295 Dec. V 7. L’esempio è già in Prose III 57, anche se non nell’ed. 1538. Si tratta dunquedi un semplice caso di convergenza tra la trattazione castelvetrina e quella bembianadata dalla comune fonte spogliata.296 Dec. X 1.297 Ossia: ‘aggiunta’, di una preposizione che indichi lo stato in luogo.298 Dec. V 7: «fanciullo».299 Dec. VIII 3.300 Dec. VIII 2; il passo è alla riga 38, non 18.301 Ossia: ‘nel modo in cui è’.302 Dec. II 2: «fuoco».303 Dec. IX 9.304 Dec. VIII 2: «contrada, hor qua hor là».305 Dec. VIII 3: «riguardando, rispose».
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 71
243 b 6;306 «hor qua et hor là saltando dovunque alcuna pietra neravedeva» 203 a 11.307
Chi qua et chi là overo qual qua et qual là: significa divisione di più persone etdi più parti di terzo luogo, o di più terzi luoghi, et significa movimento:«essi a rubar corsi chi qua con una, et chi là con un altra cominciarono afuggire» 55 a 21;308 et significa stanza: «la brigata chi qua et chi là cotti lorocavretti» 142 a 32.309 Sempre ha la copola et in mezzo chi qua et chi là et lepiù persone che si dividono sempre si pongono in caso primo: «gli altrihuomini chi qua et chi là vanno fuggendo quello» 7 b 13.310 Alcuna voltachi qua et chi là311 ha davanti a sé parte et parte divisiva:312 «costoro adunqueparte per lo giardino» etc. «et parte verso le mulina, che fuor di quellomacinavano et chi di qua et chi là a prender diversi diletti si diedono» 132b 5;313 qual qua et qual là ha davanti a sé qual divisiva: «le lor donne, etfiglioli piccioletti qual se n’andò in contado et qual qua et qual là» 33 a21,314 et nelle novelle non ha altro essempio di qual qua et qual là.315
PIÙ QUA: significa movimento a luogo più vicino et più ristretto allapresente persona: «maestro fate un poco il lume più qua» 233 a 5.316
PIÙ QUA, NÉ PIÙ LÀ: significa ristringimento et limitatione di terzo luogo:«di lei s’innamorò sì forte il proposto della chiesa che più qua né più lànon vedea» 204 b 32.317
306 Dec. IX 8: «hor qua, hor là, se».307 Dec. VIII 3: «saltando, dovunque».308 Dec. II 7: «essi a rubar quella di tutta la contrada corsi, io con due delle miefemmine prima sopra il lito poste fummo, et incontanente da giovani prese chi quacon una, et chi con una altra cominciarono a fuggire». La citazione è già in Prose III56; si ha un rimando nell’esemplare di Yale.309 Dec. V 3: «là, cotti lor cavretti».310 Dec. I 1: «gli altri, che vivi rimasi sono, chi qua, et chi là in diverse brigate, senzasaper noi dove vanno fuggendo quello».311 Correggo il ms. che reca, in questo punto, la ripetizione di qua, per un’evidentesvista.312 Ossia: ‘disgiuntiva’, come – a proposito delle congiunzioni – in Verbi, XIII 15 (inCASTELVETRO 2004: 109).313 Dec. IV 10: «a prender secondo i diversi appetiti, diversi diletti».314 Dec. II 3: «contado, et qual qua, et qual là».315 Le concordanze confermano la notazione castelvetrina.316 Dec. VIII 9. La citazione è però a c. 223r.317 Dec. VIII 4: «chiesa, che».
LODOVICO CASTELVETRO72
IN QUA ET IN LÀ: significa stanza di più terzi luoghi divisi nel medesimotempo: «sentendo egli i fatti suoi molto intralciati in qua et in là» 10 a 37;318significa movimento a più luoghi diversi nel medesimo tempo: «sparte lemani in qua et in là» 130 a 39;319 significa anchora movimento |13r| a piùterzi luoghi divisi secondo diverso tempo: «cominciò a portaremercantantia in qua et in là per le fiere» 247 a 17.320 È diferente da chi quaet chi là o da qual qua et qual là in più cose. In qua et in là si dice d’un solo etdi più come d’un solo: «et andate di qua et in là senza sentirvi» 242 b 14,321come nell’essempio ultimo; et si dice di cose inanimate come nel primoessempio;322 et si dice di animali bruti come di pesci: «ma vider tanto pescein qua et in là andar discorrendo» 173 b 36;323 et quegli altri non si diconose non d’huomini et di più.324 Et dicesi in qua et in là, di dietro a:«cominciarono in qua et in là di dietro a pesci» 174 a 11.325Hora in qua et hora in là: significa attione d’un solo in diversi luoghi secondotempo: «et hora in qua et hora in là ricadendo» 225 b 18;326 et è diferenteda hor qua hor là in due cose. L’una che non si pone senza copola in mezzo;l’altra che si dà alle cose inanimate: «in questa maniera gittato dal marehora in qua et hora in là» 36 b 27;327 «veggendosi sospinto dal mare horain qua et hora in là» 36 b 12.328L’uno in qua et l’altro in là: significa alcuna volta divisione di più persone adiverse parti de’ luoghi, come: «essendo l’una donna andata in qua et l’altrain là» 85 a 18.329 Alcuna volta significa la divisione solamente di duepersone: «et uno in qua, et l’altro in là come più tosto possono sipartirono» 207 b 8.330
318 Dec. I 1. Castelvetro nella citazione salta l’inciso «sì come le più volte son quegli demercatanti». 319 Dec. IV 10.320 Dec. IX 10 «in qua, et in là».321 Dec. IX 7.322 Ossia ai fatti di Dec. IV 10.323 Dec. VI 10: «ma tanto pesce in qua et in là».324 Ossia non di un singolo.325 Dec. VI 10: «cominciarono, come potevano, ad andare in qua et in là di dietro apesci».326 Dec. VIII 9: «et hora in qua, et hora in là».327 Dec. II 4: «hora in qua, et hora in là».328 Dec. II 4: «veggendosi sospinto dal mare et dal vento».329 Dec. III 6: «in qua, et l’altra in là».330 Dec. VIII 5: «et uno in qua, et l’altro in là, come più tosto poterono, si partirono».
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 73
IN QUA: significa termine di presente tempo nel quale si termina il tempopreterito diterminato da DA tra ’ quali spatio331 si continua l’attione di cuisi ragiona: «dello ’mperadore federigo in qua» 21 b 24,332 ciò è dal tempoche imperò Federico; «da poco fa in qua» 29 a 23;333 «da non troppotempo in qua» 85 b 4;334 «da quella hora in qua» 185 b 24;335 «da poco inqua» 211 b 30;336 «da gran tempo in qua» 249 a 34;337 «da nona in qua» 263a 2.338 Né ha un’altra diferenzia tra IN QUA et infino a qui senon che in quariguarda tempo passato diterminato da DA, et infino a qui tempoindeterminato.
QUAGIÙ: significa questo mondo havendo riguardo al cielo che è alto ets’usa per istanza:
per dar qua giù ad ogni alto intellettoalcun segno di quellabeltà 103 b 28.339
Significa luogo più basso che non è la persona parlante ma presente però:«M. Lambertuccio è quagiù tutto solo» 185 b 16;340 «egli è una giovanequagiù» 239 a 5.341
QUASÙ: significa luogo alto dove è la persona parlante et talhora segnamovimento: «ti prego per solo dio che quasù salghi» 217 a 27;342 «fa sì cheella qua a me possa venire» 218 a 7;343 et talhora stanza: «o sirocchia mia iosono quasù» 218 a 15.344
331 Castelvetro aveva precedentemente scritto termini, poi corretto in spazio. Di qui lasconnessione del senso di questo passaggio.332 Dec. I 7: «dello imperadore Federigo secondo in qua».333 Dec. II 1.334 Dec. III 6.335 Dec. VII 5. Ma a c. 184v.336 Dec. VIII 7.337 Dec. X 1.338 Dec. X 7.339 Dec. III canz.: «ad ogn’alto […] biltà».340 Dec. VII 6: «Messer […] qua giù».341 Dec. IX 5: «eglie».342 Dec. VIII 7:«per solo Iddio, che qua su».343 Dec. VIII 7: «fa sì, che possa qua su a me venire».344 Dec. VIII 7: «qua su».
LODOVICO CASTELVETRO74
QUAENTRO: significa movimento a luogo serrato dove ‹è›345 la personaparlante, come monastiero:346 «mai quaentro homo niuno osa entrare» 73b 12;347 o camera: «egli et io qua entro ce n’entrammo» 180 a 16;348 «quaentro si fuggi un giovane» 186 a 17;349 «qua entro non potrai tu tornare»181 a 32.350 Significa anchora stanza: «se persona fosse stata qua entrouccisa» 186 a 28.351
DI QUA: significa propriamente quel luogo dove è la persona parlante che èseperata da un altro o per mare o per muro o per altro spacio non agevolea caminarsi come è esso luogo. Sicome è questo mondo in comperationedell’altro, alcuna volta gli precede di là: «acciò che io di là vantar mi possache io di qua amato sia» 53 b 27;352 «se di là come di qua s’ama» 83 a 3;353|13v| alcuna volta seguita: «della comare colla quale tu giacevi quando eridi qua che pena t’è di là data?» 195 b 15.354 Alcuna volta gli precede cosache tanto vaglia: «se nell’altra vita s’ama et voi v’amate come di quafaceste» 125 a 11.355 Alcuna volta niuna cosa né gli precede né seguita:«portò subitamente l’anima mia tra tanti fiori, et tra tante rose, che mainon se ne videro di qua tante» 113 b 2.356 Per questa medesima ragionequando s’introduce persona nell’altro mondo, dicendo di qua s’intendedell’altro mondo: «di qua non si tiene ragione alcuna delle comari» 196 b29.357 Si intende di luogo seperato da mare: «la qual fu poi di qua stimatagrandissimo thesoro» 175 a 6;358 «le quali cose io tutte di qua con meco
345 Intervengo editorialmente; il ms. ha solo dove, per una svista.346 Segnalo che l’ed. 1527, c. 55r legge monastero l’unica attestazione della forma nelDecameron.347 Dec. III 1: «qua entro».348 Dec. VII 3: «egli, et io qua entro ce n’entramo».349 Dec. VII 6.350 Dec. VII 4.351 Dec. VII 6.352 Dec. II 7: «possa, che». L’esempio è già in Prose III 56 (Prose 1538: XCVIv; Prose 1549:189); rinvio presente nell’esemplare di Yale (ma 53 b 26).353 Dec. III 5: «se di là, come di qua, s’ama». L’esempio è già in Prose III 56 (Prose 1538:XCVIv; Prose 1549: 190).354 Dec. VII 10: «comare, colla quale tu giacevi, quando eri di qua, che pena». La paginaè però la 196.355 Dec. IV 7: «se nell’altra vita s’ama, et voi v’amate, come di qua faceste».356 Dec. IV 2: «fiori et tra tante rose, che».357 Dec. VII 10.358 Dec. X 9: «stimata infinito thesoro». Anche in questo caso Castelvetro legge male iltesto da cui sta copiando; mentre la riga è esatta, la carta è la 275r.
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 75
devotamente recai» 172 a 12.359 S’intende di luogo seperato da muro: «tuvenghi ista notte di qua sì che noi ci troviamo insieme» 184 a 28.360 Parche significhi stanza, alcuna volta et quanto quientro: «et entrato dentrodisse: Dio ci mandi bene, chi è di qua?». Pare anchora che significhi luogoper ‹lo› quale361 si passi dove è la parlante persona: «a chi hora venendo diqua allo ’ncontro di noi un forestiero» 166 a 7.362
DI QUA DA: vale quanto cis latino: «il qual motto passato di qua da mare»103 a 5.363
DI QUA ET DI LÀ: dall’una parte et dall’altra, utrinque: «gli usolieri dellebrache che di qua et di là pendevano» 235 a 6.364
DI QUAGIÙ: significa movimento di questo mondo verso l’alto:«argomento assai evidente che le virtù di quagiù dipartitesi hanno nellafeccia de vitii i miseri viventi abandonati» 23 b 30.365
DI QUASÙ: movimento significa da luogo alto verso il basso dove è lapersona parlante: «et che io possa di qua su discendere» 214 b 4.366
DI QUAENTRO: significa movimento da luogo dove è la persona parlanteche sia serrato come monastiero: «come tu eschi di quaentro senza esserveduta» 18 a 38;367 come casa: «non si suspichi domattina chi qua entro siastato tratto» 130 a 8;368 «non so perché più di qua entro chi daltronde vi selcreda messo» 130 a 14.369 Significa anchora dove è la persona parlante opossessione di quel luogo serrato, o dimostramento370 d’habitatione: «se ifrati di qua entro alle debite hore cantino i loro uffici» 6 a 36.371
359 Dec. VI 10: «divotamente».360 Dec. VII 5: «sì, che».361 Il ms. ha per la quale, che correggo, sanando quella che pare una banale svista.362 Dec. VI 5.363 Dec. III 10: «damare»; a pagina 102r, però.364 Dec. IX 2: «brache, che».365 Dec. I 8.366 Dec. VIII 7.367 Dec. I 3: «come tu esca».368 Dec. IV 10. Castelvetro elimina un inciso nella trascrizione: «quando veduto sarà».369 Dec. IV 10: «che d’altronde vi selcreda».370 Ossia: ‘indicazione’; la forma è usata altrove da Castelvetro: ad es. Art. II 2 inCASTELVETRO 2004: 6.371 Dec. I 1: «se i frati di qua entro, dequali il numero è quasi venuto al niente, alledebite hore cantino i loro ufici».
LODOVICO CASTELVETRO76
Là: riferisce luogo terzo già nominato, et la natura sua è di significaremovimento a luogo, per la qual cosa non si trova ‘in luogo’ senon in dueluoghi del Boccaccio per fuggire dubbioso sentimento:372 «il Re fattosivenire il siniscalco gli comandò che la seguente mattina la facesse chefosse apparecchiato» 174 a 33,373 percioché se avesse detto quivi non sisarebbe inteso se havesse voluto che si fosse inteso del luogo dove era ilRe o della valle delle donne; «Maso del saggio il quale gran mercatante iotrovai là» 171 b 25,374 sarebbe stato dubbio se havesse mezzo di Firenzedove al presente era o in India Pastinacca. Et significa sempre, quando hadue luoghi vicini, il più lontano, sì come quivi par che dimostri il piùvicino: «questi là pervenuto» etc. 114 b 10,375 intendi in piazza di s. Marco,che ‹è›376 più lontana che Rialto prossimamente nominato. Quando si parladi persona presente che debba andare a terzo luogo si dice là: «tu sai daqual parte io dormo verrai là» 187 b 28.377 |14r| Pare anchora che significhipiù tosto cominciamento di movimento a luogo che cessamento dimovimento a luogo, laonde anchora ama volentieri di accompagnarsi colverbo andare, col quale quivi mai non s’accompagna, se non una volta: «cheella andasse ad altra chiesa che alla cappella loro, et quivi andasse lamattina per tempo et confessassesi» 183 a 32,378 il che forse aviene perchéseguita confessassesi che ‹è›379 ‘in luogo’. S’accompagna anchora con fuggire:30 b 11,380 col quale non s’accompagna quivi; et calare: 170 b 14;381 etgiugnere: 238 a 12;382 comuni sono: menare, venire, correre, tornare; speciali diquivi: arrivare, chiamare, discendere, sumontare, portare, ragunare, concorrere,dismontare, tornare, entrare, accostare.
372 Ossia: ‘significato’. Il termine è già bembiano e normale in Castelvetro (ad es. Art.V 8 in CASTELVETRO 2004: 27).373 Dec. VI 10: «la facesse, che fosse». Accento presente nel ms., assente nella stampa.374 Dec. VI 10: «Maso del Saggio, il quale».375 Dec. IV 2.376 Nel ms. si ha che più; intervengo editorialmente per ripristinare il senso.377 Dec. VII 7: «da qual parte del letto io dormo, verrai là».378 Dec. VII 5: «che ella andasse ad altra chiesa, che alla cappella loro, et quivi andassela mattina per tempo, et confessassesi».379 Nel ms. si ha la forma che; intervengo editorialmente come precedentemente.380 Dec. II 2: «non sappiendo perciò che il suo fante là o altrove si fosse fuggito».381 Dec. VI 10: «lasciata la camera di frate Cipolla aperta, et tutte le sue cose inabbandono, là si calo».382 Dec. IX 4: «ma il Fortarrigo giunto là con un mal viso».
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 77
PIÙ LÀ: significa più oltra del terzo luogo di che parliamo: «et più là trovaigenti» 171 b 19.383
PIÙ LÀ CHE: «dunque dee essere più là che Abruzzi» 202 a 10.384
CHI È LÀ?: par che parlandosi con seconda persona che si dovesse dire chiè costì.385 Ma non è così che parliamo o con noi o con una seconda personaalla quale domandiamo chi è colui che è là nel terzo luogo: «stupefattidomandar chi è là?» 41 a 3;386 «cominciò a dir chi è là?» 130 b 18.387
Verso là: «della quercia disceso verso là si drizzò» 142 b 30;388 «io vo versolà» 244 b 10.389
LÀ IN: «la nostra nave sdruscita percosse a certe piaggie là in ponente» 53a 15.390
LÀ a cui risponde QUI: «diventerai molto migliore, et più costumato et dabene là che qui non faresti» 126 a 7;391 268 a 4.392
QUI a cui risponde LÀ: «questo cattivello che qui è là vidi io» 269 b 29,393di sopra ne fu parlato a sufficienzia.394
LÀ DOVE: è composto di tre parole: di illac, di ad et d’ubi, ma per la ragionedetta di sopra significa altro che non fa in latino.395 Percioché dalla partedel LÀ significa movimento a luogo, o stanza, et parimente dal DOVE; ma
383 Dec. VI 10.384 Dec. VIII 4: «dunque dee egli essere più là, che Abruzzi».385 Nel ms. Castelvetro aveva prima scritto costà; la correzione si motiva, a mio parere,con il fatto che costì – come nota lo stesso Bembo (Prose, III 56) – è relativo allo statoin luogo. La scrizione iniziale costà sarà stata dovuta al parallelismo con là, giàespresso sopra.386 Dec. II 5.387 Dec. IV 10: «cominciarono ad dire, chi è là?».388 Dec. V 3.389 Dec. IX 8.390 Dec. II 7; già citata. Mentre però nel rimando precedente il numero di carta eraesatto, qui Castelvetro scrive 53 invece che 55.391 Dec. IV 8: «migliore, et più».392 Dec. X 8: «et assai conosco, che egli v’era qui et dovea essere et dee caro d’haverper parente Gisippo».393 Dec. X 8: «questo cattivello, che qui è, là vidi io».394 Si veda supra, la trattazione di là dove in relazione a quivi.395 Si vedano le riflessioni sul latino della decadenza che aprono il frammento.
LODOVICO CASTELVETRO78
dalla parte del dove è relativo et ristrettivo et dalla parte del là è generale etincerto, senon quando procede nome di luogo o d’averbio, del quale siaspositivo: «et la sera andati tutti là (ecco la incertezza et generalità delluogo et del movimento a luogo) dove il corpo di ser Ciapelletto giaceva»14 a 33;396 «et datorno guatatosi conobbe se manifestamente là dove alsaladino domandato havea» 275 b 31,397 ecco la stanza. Et si può tra là et ildove traponere verbo: «et là se ne andò dove Perotto havea lasciato» 60 b10;398 «et là se n’andò dove veduto haveva che la Salvestra coricata s’era»126 a 37;399 et si può, dopo il dove, allogare il verbo del LÀ:400 «iocomprendo che in cotal guisa Ruggieri là, dove trovato fu, trasportatofosse» 131 a 30.401 È spositivo di nome di luogo: «che habbiamo noi a farese non a menarlo in questo capannetto là dove egli si fugge l’acqua» 73 b34;402 «ella trovasse modo di poter venire ad un giardino là dove eglimenar la volea» 124 a 32;403 et quando è spositivo si può posporre il verboal dove: «a campi là dove il suo poderetto era, se n’andò a stare» 155 a 4;404si può tra il nome et il là dove traporre il verbo: «sì come in Creti senti làdove io rimasi» 274 a 37.405 È spositivo di QUI di fuori: «verrete qui di fuoridella chiesa là dove io al modo usato vi farò la predicatione» 170 a 3.406|14v| Hor perché habbiamo che là congiunto con dove significa ‘in luogo’ o‘a luogo’, è da sapere che oltre acciò significa anchora ‘luogo’ nel 4o caso,ciò è quem, non ad quem o in quo. Esempio come: «Alessandro domandòl’hoste là dove esso potesse dormire» 33 b 31;407 «io conoscendo là doveera» 55 a 37;408 «et spiato là dove ella stesse a casa» 126 a 24.409 Et di più è
396 Dec. I 1: «et la sera andati tutti là, dove il corpo di Ser Ciapelletto giaceva». Traparentesi, ovviamente, la notazione castelvetrina, così indicata anche nel ms.397 Dec. X 9: «et datorno guatatosi conobbe manifestamente se esser là, dove alSaladino domandato havea».398 Dec. II 8.399 Dec. IV 8: «et là se n’andò, dove veduto haveva che la Salvestra coricata s’era».400 Ossia: ‘relativo al là’.401 Dec. IV 10: «io comprendo, che in cotal guisa Ruggieri là dove trovato fu,trasportato fosse».402 Dec. III 1: «che habbiamo noi affare, senon non a pigliarlo per mano, et menarlo inquesto capannetto là, dove egli fugge l’acqua». Già citato.403 Dec. IV 7: «là, dove egli menar la voleva».404 Dec. V 9: «là, dove».405 Dec. X 9: «là, dove»406 Dec. VI 10: «di fuor della chiesa là, dove».407 Dec. II 3.408 Dec. II 7: « io conoscendo là dove io era»409 Dec. IV 8: «spiato là, dove».
‹TRATTATO DEGLI ADVERBI› 79
in questa maniera spositivo: «et come che il Re conoscesse il luogo là doveera dovuto essere tale» 20 a 17.410 È anchora spositivo non di luogo mad’ufficio: «l’haveva messo ad essere con altri gentili huomini al servigio delRe di Franzia là dove egli assai di be costumi» etc. 186 b 26.411 Hor non hadubbio che dove in là dove significa stanza, come si può vedere negliessempi sopraposti, et movimento a luogo.
PRESSO LÀ DOVE Evvi presso là dove ma si trapone il verbo tra presso et là dove:«ser Ciappelletto il quale come dicemmo presso giaceva là dove costororagionavano» 11 b 15.412 Evvi anchora LASÙ DOVE pur con il verbotraposto il lasù et il dove: «con le cose addomandate lasù n’andò doveansando giunto» 171 a 33.413 LÀ DOVE è legame et col soggiuntivo414significa conditione, che i latini dicono modo, noi pur che: «questo montaniente là dove io honestamente viva, né mi rimorda d’alcuna cosa lacoscienzia» 8 a 5,415 et è essempio solo. Ma quando è collo indicativo èlegame significativo di stato di cose contrario o alle precedenti o alleseguenti cose, et quasi comparativo di cose contrarie. Ha riguardo alleprecedenti in questo: «Giannotto tu sai quanta, et quale sia la ingiuria, laquale tu mi hai fatta nella mia propria figliuola, là dove trattandoti io bene»etc. «tu dovevi il mio honore sempre cercare et operare» 45 b 1.416Riguarda alle seguenti in questo: «là dove io per molto savio t’haveva iot’harò per uno scioccone» 192 b 24;417 «et là dove a que tempi solevaessere il lor mestiere» etc. «hoggi dì rapportar male dall’uno all’altro» etc.«s’ingegnano il lor tempo di consumare» 23 b 16.418
410 Dec. I 5: «là, dove era, dovere».411 Dec. VII 7: «l’havea […] Francia. Là dove».412 Dec. I 1: «ser Ciappelletto, il quale, come dicemmo, presso giaceva là, dove costorocosì ragionavano».413 Dec. VI 10: «là su n’andò, dove». La riga è però la 23. L’accento su andò è nel ms.;assente sulla stampa (la sua presenza nella variante giuntina appena riportata è dovuta,come si ricorderà, ai criteri adottati).414 Per l’uso di questo termine da parte di Castelvetro si veda il commento a Verbi III3 in CASTELVETRO 2004: 86.415 Dec. I intr.: «questo non monta niente là, dov’io honestamente viva, né».416 Dec. II 6: «Giannotto tu sai quanta et quale sia la ingiuria, la quale tu m’hai fattanella mia propria figliuola, là dove trattandoti io bene, secondo che servidor si deefare, tu dovevi il mio honore et delle mie cose sempre et cercare et operare».417 Dec. VII 9.418 Dec. I 8: «il lor tempo». Nella citazione Castelvetro opera numerosi tagli da unbrano di una decina di righe.
LODOVICO CASTELVETRO80
LAOVE: là in ove significa ‘il luogo’, ‘a luogo’ et ‘in luogo’ come faceva làdove. ‘Il luogo’ ciò è il 4o caso: «laov’io son giunto amore non si poriacontare» 260 a 19;419 ‘a luogo’: «là pervennoro ove il corpo di santo Arrigoera posto» 28 b 1;420 ‘in luogo’: «essendo adunque et Phineo et M.Amerigo in concordia laove Theodoro era anchora tutto pauroso» etc. «ildomandarono intorno a questa cosa» 152 a 4.421 Sappi non dimeno che inalcuni testi in questi due ultimi essempi si trova dove in luogo di ove.422
LASÙ: significa movimento terzo luogo che habbia rispetto al luogo bassoonde altri si muova: «mandò a Guccio imbratta che lasù con le campanellevenisse» 171 a 20;423 «un dì che imposto gli fu in sul vespro se n’andò lasù»176 a 1.424 Significa anchora ‘in luogo’ 2o luogo secondo che mostra:«gridò chi piagne lasù?» 218 a 5.425 Il che si confà con quel del Petrarca:
pur là su non alberga ira né sdegno 130 b 8.426
Il che non è privilegio de’ poeti, come stima il Bembo, bene è vero chesempre il parlare è volto alla terza persona et non alla 2a. Si dice anchora làsu dove come s’è veduto in là dove.
419 Dec. X 6: «là ov’io son giunto amore, non si poria contare».420 Dec. II 1: «pervennoro, ove».421 Dec. V 7: «Messer Amerigo in concordia là, ove». Anche in questo caso non riportoil taglio dell’inciso compiuto da Castelvetro.422 La notazione castelvetrina è confermata dagli studi recenti. La variante ove è infattitràdita sia dall’Hamilton 90 sia dal Mannelli di contro a quella del parigino (si vedanole notazioni di Vitale, anche riguardo ai due passi citati, in BRANCA-VITALE 2002: I420-421).423 Dec. VI 10: «ad Guccio Imbratta, che là su».424 Dec. VII 1: «un dì, che imposto gli fu, in su ’l vespro [...] là su».425 Dec. VIII 7: «là su».426Rvf CCCXL 8. Il rinvio è all’aldina del 1514. Nel postillato palatino e in quello diYale si ha il relativo rinvio.
APPENDICE FOTOGRAFICA 81
Tav. 1. BOLOGNA, Biblioteca dell’Archiginnasio (B 3467, f. 9r).
Tav. 2. BOLOGNA, Biblioteca dell’Archiginnasio (B 3467, f. 14v).