Un epigramma encomiastico "alessandrino" per Augusto (SH 982), in "Aevum Antiquum" 11 (1998),...
Transcript of Un epigramma encomiastico "alessandrino" per Augusto (SH 982), in "Aevum Antiquum" 11 (1998),...
In una prima sezione.to critico u prour"*url"ìr:T#.1;
l-T::n" ""ku:lrj, generi tenerari,sulgole personalità di aulor-i classi-ci intencle offrire un quadro deinuovi orientamenti metocìologici.:"
"",r' si affronrarro gu"lì" qr"#o_
nr: nel la secorrda seziorre. arra l is ipun tua l i d i ca ra t t e re s to r i co_filologico e archeologico_antiquariosu.testi e rnomerirj sigriilìcativi dellacultura classica llresentano conte_nuti lruibili ìn sede scientifica e inambito didattico.
i!..: 7994 Vita e Pensiero - Largo A. Gemelli, 1 ^ 20123 MlanoFinito d^i .lTp1l._ nel settembre I999Presso Aru (rrafiche TiL;t-.": _
11"19 9 e ,
Aevum Antiquum I I (1998), Pp. 255-344
Srrvn BansANTANT
TIN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO ..ALESSANDRINO,PER AUGUSTO (Sr1982)
La poesia encomiastica in distici, fiorita alla corte dei Lagidinel III secolo e portata alla sua piìr perfetta espressione da Cal-limaco, si piega a partire dal I secolo all'ossequio del princepsromano sostituitosi ai dinasti grecomacedoni. LEgitto tole-maico, uno degli ultimi regni ellenistici ad.essere fagocitato dalnascente impero, associa alla debolezza politico-militare, che lorende facile preda di Ottaviano dopo la fine di Antonio e del-I'ultirrta lagide, Cleopatra, la tradizione letteraria ed erudita piùrricca e originale tra tutti gli Stati sorti dalla spedizione di Ales-sandro. E naturale che gli Alessandrini abbiano cercato dicompiacere e blandire anche con omaggi poetici colui cheavrebbe preso il posto degli estinti Tolomei, benché egli stes-so fosse la causa della fine della dinastia. Il deserto egiziano,abbastanza generoso nel restituire esemplari di poesia enco-miastica prodotta nell'ambito del Museo tolemaico, non sem-bra altrettanto ben disposto, finora, a farci conoscere gli sfor-zi adulatori dei poeti alessandrini all'alba dell'impero. Se que-sto ha fortunatamente evitato imbarazzanti confronti con i ca-polavori callimachei o teocritei, ci ha impedito però anche diconoscere un anello mancante nella tradizione di un genere let-terario, I'encomio in versi dattilici appunto, coltivato nell'Egitto ellenofono dal III secolo a.C. fino alla fine dell'età im-periale, oltre che privarci di utili termini di confronto con lapoesia latina coeva in onore di Augusto.
Un brano di notevole interesse, anche se non proprio uncapolavoro poetico, in quanto unico esempio greco di enco-mio per il trionfatore di Azio, composro probabilmente pochianni dopo la battaglia e ancora circolante nell'ambiente deifunzionari imperiali della 1ópa egiziana quarant'anni dopo I'e-vento, è conservato in un papiro londinese, PBrit.Mus. II inv.
256 SILVIA BARBANTANIUN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO .ALESSANDRINO. PER AUGUSTO 257
è la sezione di un cópog oùTKol.l,{otpoq (28 x L27 cm. ca.),composto da cinque documenti, di cui almeno tre (il secon-do, il terzo e il quinto da sinistra) decifrabili come indirizzatia un tale Acusilao, otîoî,óTog òr1póotog dei due villaggi diLisimachide, situati secondo I'editor princeps nella pepíg Era-clide del nomo arsinoite3; è probabile che tutti o gran partedei documenti che componevano il uolumrz fossero materialedi scarto proveniente dall'
'archivio' del sitologo in questione.
Il primo documento da sinistra è quasi illeggibile; il secondofoglio contiene la ricevuta di un pilota incaricato del traspor-to ad Alessandria di un cargo di cereali, datata al 15 d.C.n; sulterzo si trovano un ordine per la consegna di grano ai òqpo-otot yeopyoí, da parte dégli ufficiali Ael noÀo arsinoite (lostratego e il Bao'tl,tròE ypoppo(îeóg), datato all'l1 d.C.5, eI'epigramma; il quarto documento, danneggiato, è datato al 5-6 d.C.; il quinto è quasi contemporaneo al terzo e contienedisposizioni per la medesima operazione da parte delle auto-rità del villaggio. AIla fine del I secolo il tópo6 è stato utiliz-zato per la trascrizione di esercizi retorici, tre orazioni giudi-ziarie (P.Lit.Lond.138; Pacr2 2515)6, che vennero quindi a tro-varsi sul uerso dei documenti di Acusilao (tutti i tesd docu-mentari e I'epigramma sono stati compilati con la scrittura checorre p.arallelamente alle fibre)7. Non è chiaro se il rotolo fumesso insieme espressamente per scriverci sopra le orazioni, ofu acquistato da un aspirante retore già formato; la questione
3 In realtà pare dal confronto con altri documenri che questi villaggi si tro-vassero in unaltra sezione dell'Arsinoite. V Appendice.
a Per il testo v. Appendice.5 Per il testo v. Appendice.6 Ker. iyoN 1898b; CnoNsnr 1901, pp. 117-118; J,woen 1913, pp.23-25t
Powru - Bensen 1929,pp. l2l-122. Anche P.Vindob.Tandem 9, che reca un do-cumento molto simile a Plond. 256d (v. Appendice), è stato utilizzato sull'altrafacciata per trascrivere testi semi-letrerari in gieco (due delle rre colonne di scrrt-tura sonò occupate da lisre di libri; sulla prinia colonna è staro sovrascritto un do-cumenro in demorico, v. Sr;lrsrel;u - Vóru 1974, pp. 324-331 e soprattutto Pu-clrn 1998); è possibile che I'inventario di libri del papiro viennese piovenga dallostesso ambiente in cui sono srare composre le orazioni del P.Lond. (Pucr-re. 1998,D . u ) ) .
7 I termini recto e oerso sono ambigui, soprarrurro nel caso di mareriale riu-tilizzato come questo. Mi riferisco qui al rapporto tra senso in cui corrono le fibree la linea di scrittura, non a'interno' ed 'esterno' del rotolo: nel caso di un tóuocoulrol,l"riotpoq, il recto dei documenti che lo compongono verrà consideraro
'zerl
ro in relazione d modo in cui si arrotolerà il uolumen, con la nuova scrittura al-l'interno; v. in proposito TuRrvsn 1994, cep. 3.
256 recto, b = P.Lit.Lond. 621. Al testo è stata Prestata atten-
zione, in passato, nell'ambito degli studi sul culto imperiale,
ma raram;nte è stato considerato come Pezzo letterario (Key-
dell, Opelt, \Williams), mentre è stato generalmente ignorato o
citato àlo fuggevolmenre negli studi piir recenti sulla vittoria
aziaca e sulla -piop"gand"
augusrea2, malgrado la sua unicità di
documenro sioriio.-Poiché non sappiamo dove esattamente il
poemetto sia stato composto né se quella in nostro possesso,
,,., ,rn documento arsinoitico, sia una copia d'autore, solo con-
venzionalmente e Per brevità chiameremo I'epigramma 'ales-
sandrino'. Lautore è ignoto, ma il fatto che il componimento
non sia stato incluso iell'Anthologia Graeca e non sia stato ci-
raro da fonti indirerte non depone a sfavore di una 'paternità'
celebre, dato che anche epigrammi posidippei Per monumen-
ti tolemaici hanno subìto la stessa sorte.
Euidenza papirologica. Ipotesi sull'epoca e sulle circostanze della
comp o s izi o ne de ll'ep igramma.
Lepigramma è stato pubblicato da KENvoN 1895 (con sugge-
rimeiti di Búcheler),-contemporaneamente ad alcune note da
parte di \ffeil sulla stessa rivista (1895); ne è stata data segna-
Îazione dallo stesso Kenyon qualche anno dopo nel catalogo
dei papiri del British Museum, da OI-nEATHER 1923, p' 19 e
da MriNe 1927, n" 62, p. 47. Pin recenti sono le edizioni di
Pecn (GZP 113, pp. 468-471; FGE anon. CLXIII' pp. 483-
486), e di PnnsoNs - Lroro-JoNES (.t11982, pp. 496-497).Il papiro P.Lond. 256, ora conservato alla British Library
I Il papiro è stato acquistato nel 1893. Il aolumen è descrimo e pubblicatoparzialmenie da Krnvou 1898a, p. )OilV n' CCL\4; pp.95-99' Ho potuto con-irollare il tópog ouyrol'l{orp<iq alla British. Library nel luglio 1997. Lattualemontassio dll óapiro in cornice privilegia il lato contenente gli esercizi retorici,co ns idEi"to u rei to,i nella catal ogazióne foto grafi ca'
2lJepigramma è trattato-ad es' da Rltv,qro l9l?:P;287; Tavlon 1931, p.144 norc.7;"Powlrr- 1933, pp. 189-19O; Klvotlr- 1934; OpEr-r 1960' p. 46;MEnx-eLs,AcLr 1963, p.25; Bor.:N-gau 1964' W. 93-94;-Benr'raNo 1969b, p. 80 tto-ra 3; RoNcur 1974, p. 396; tùfrr-r-lcMs 1978'.pp. 124-125; THotutpsoN-Kor,NaN1984; Gunver- 1995, i. 14 (pur limitandosi. all'esame delle fonti latine, ammetreche le testimonianze poetiche greche sul vincitore di Azio, tra cui Sl1 984, sono uasubiecr that has not yet been cxplored in any serious fashion"). In qenerale sullapoesia e.,.omiastica greca per imperatori romani v. Opprr 1960.
258 SILVIA BARBANTANI UN EPIGRAMMA ENCOMTASTICO "ALESSANDRINO. PER AUGUSTO 259
non è senza impo Ítanza, dato che risolverla ci aiuterebbe a col-
locare I'epigramma nel suo esatto contesto storico e cronolo-
gico. Non é possibile conoscere con cettezza il luogo in. cui il
iotolo fu riuiihzz*o, dove aveva sede, cioé, la scuola di reto'
rica frequentata da chi usò il lato bianco per prendervi ap-
punti; q.t.tt" non doveva trovarsi necessariamente nel F"ytTt.' tieirigramma campeggia in un ampio spazio bianco nella
parte inhiiore del terzo documento, che è stato però capovol-
io al momento della trascrizione del poemetto, e in questa Po-sizione, unico tra tutti quelli soprawissuti del volume, è statounito agli altri documenti che formano il tópogoDTKoì"l"tlotpoq. Ciò potrebbe significare che a) l' epigrammafu scritto sul documento, forse da qualcuno della cerchia diAcusilao, quando questo era già considerato papiro da ricicla-re, ma il documento riutTlizzato rimase nell' 'archivio' fino aquando I'intero lotto fu rilevato per formare il îolrogooTKol"l.úotlrog; b) chi incollò i documenti a formare il nuo-vo rotolo notò I'epigramma e ne fu aftratto tanto da capovol-gere quel solo róì,l"r1pa rispetto agli altri, pur sapendo che iluolurnen sarebbe stato utilizzato e letto solo sull'altra facciata eche ben presto la scrittura all'esterno si sarebbe rovinata; il poe-metto doveva suonare ancora interessante, in Egitto almeno enell'fusinoite in particolare, anche parecchi anni dopo la suacomposizione: è possibile che il testo, come gli epigrammi diPosidippo copiati a Memfi nel II secolo, fosse associato ad unmonumento celebre, forse alessandrino, commemorante lanaumachia aziaca, ben noto anche ai burocrati della Xuopo'.
Ritengo meno plausibile I'ipotesi secondo cui I'epigram-ma sarebbe stato scritto nello spazio bianco del documento do-po che il rópoq era già stato messo insiemc .il fatto che queliolo foglio sia stato incollato capovolto sarebbe allora sempli-cementè un caso fonuito. Lautore o [o scriba dell'epigramma
in questo caso andrebbe cercato verosimilmente nell'ambitodellà scuola da cui provengono le esercitazioni retoriche del
8 Non è possibile sapere se il papiro deriva da scavi nel Faprm, uffìciali oabusivi. Come alternariva, D. RarrinouE (in una lettera del 2l gennaio 1998) sug-gerisce ipoteticamente come luogo di provenienza Hawara o Abusir el-Melek (à'aIui derivano documenti augustei: v. BGU IV ScnusARr l9l3), oppure (17 lugìio1998) Karanis.
uerso; rl pezzo encomiastico non avrebbe quindi alcuna rela_zlone con monume_nti.augustei e sarebbe una pur" esercitazio_ne epidittica. Benché I'aritore del componimàto riveli certa-mente una buona formazione letteraria'e retorica, I'interpreta-zione qui proposra si basa sul presupposto che I'epigramÀa siastato scritto sul documento pri*aìhe q,r.sto fosse utilizzatoper:o-Tpgre il rópoE, comè è stato suggerito già da Cunys_sE 1983. Ce*o, non possedendo l'interJ-rotoloJnon sapremomai se il documenro con I'epigramma era I'unico i.r.ollaio sot-tosopra tra tutti i fo.fi (non è raro rrovare tópot composri dadocumenti atraccati.disordinatamente) ; vorrei però attir'are I'at-tenzione sul fatto che, di cinque rol,l,rlpcrta, proprio quellocon I'epigramma si
Tova.in questa porùiorr.,-lt.pig."-ir", .non I'ordine ad Acusilao, è staio ordinato n.llo ,tósJ verso de-gli altri documenti, probabilmente perché chi stava .o-oi.n-do il noioso lavoro.ài incollare i fogli
" for-"r. ii
"à}'íi-r.,colpito_dal. componimenro, o Io riteine Io scritto pi,:-iÀior-tante. Evidente è inoltre il contrasto tra ra trascu rat rra àdr^scrittura . d..!." disposizione degri esercizi retorici (trascritti di-rettamenre dalla voce dell'istrutóre, secondo poweli in powslr_-Benspn 1929) e I'esrrema cura - degna di un rotor" lib;; -con cui I'ep^igramma è stato scritto é
".rrtr"to nel foglio----
.. !l grafia dell'eplgr.amma è della prima metà dei I secolo,più vicina a quelle dei documenti der iopoE (con cui però noncoincide) che a quella delle orazioni sul' ueiso: la scritJura è ve-loce e chiara, il trarto è abbastanza somile, più di quello deldocumento sul cui margine è trascritto il ó;-.; Ì.1r. *ii epiir sottile in confronto-a quelre degri artri ao."À.*i tf;lume). Si norano delle legature "(evide"ri
"J .r.Àoi.
'i,
rcxpútcrlv al v. 2) e una t.id.rr"" "
.o-p.nJi;r.;;ìl;""_cano segni di interpunzione e iota ascrittì. Indiscutibiimenr.
lll ::gl"izzeta; considerando che non si tratta di una copia
llbra'a, è la rnise en pag€ del componimento, che non ,.*br"affatto I'improwisaziàné a,. un giorrane stud.ente. f p."i"-.1risono- regolarmenre rientrati di óa. Z-g mm. rispetà agfi esa_metri (v' Thv. II); I'eío0eorg dei pentametri noi rrova-Drece-denti tra i papiri greci, docu-..rr"ri o librari, | ,.Ài"r.i, arsposizione di un componimento latino in distici,
" ."i *i_
dentemente lo scriba dioveva essere abituato: il t;r-; .r.;;"noto finora di rientro dei pentametri è appurrtó il p"pi- .L
Il
260 SILV]A BARBANTANì UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO .ALESSANDRINO, PER AUGUSTO 261
eoisrammi in distici di Gallo (P.Qasr Ibrîm inv. 78-3-llll'iltT)u, probabilmente contemPoraneo all'autore (ultimi de-
;# a.i I a.C.). Ilepigramma per Augusto è stato scritto nel-
i"-o"t* ..rrtr"l. del'dócum.tttb, che non era occupata dalla
,.riri rt", formando un reftangolo quasi perfetto di circa 10
cm. in larghezza per 9 in altezza, con un marglne dl I cm' rl-
;;; J Éotdo iirferiore del documento (v' Thv' I); benché il
*ló1"1,'t1po su cui è scritto il documento fosse formato a sua
Irot," origi"ariamente da due fogli di papiro, di cui si vede be-
ne la giu"ntura (con sovrapposizione dei fogli in senso oPPosto
" qr'r.ii" degli altri rol,l"fputcx del tópo6, essendo il docu-
-.rrto capovolto), I'epigramma non è stato centrato trascura-
tamenre ,opr" l" róì,ir1otq, ma con affenzione è stato scritto
a un centiÀetro ca. di disianza dalla medesima, in modo da
l-ror, "lt.r"re
la regolarità della gld". Sempre. sullo stesso do-
cumento e sempre nella stessa direzione delfepigramma' .masull'altro róì"l,qpcx, una mano simile a quella che ha s.critto
l'epigramma ha'vergato in modo -91" T-.:i"9gt^"-pfi di let-
t.i.'"ynNONAEB; poco più sotto HYAPTHMOPON;-piir sot-
to ancora, e a letterè di còrpo maggiore KAK (o KYO), e ap-pena sotto KA^^ (o KAM).^
S..ondo gli editori del Sl1, la copia a noi giunta po.treb-be essere .rr,
"útogr"fo dell'autore dell epigr-amTa, dato che.lo
scriba corregge se-stesso al v. 13 scegliendo-"I qotjg-$t]|"-merico pey&-l,oto (Il.V 907, XIV 417,^/I1409, )O(I 198;Od. IY'27', Xl 255, 268,604, XVI 403) un diverso epiteto di
Zeus: il componimento risalirebbe in tal caso a una data.po-steriore all'lf d.C., quando fu redamo il docum-ento per Acu-silao, e potrebbe addiritt.tra essere successivo alla morte del-I'imperaiore (14 d.C.) . La correzione del v. 13 potrebbe però
e V. ANoERsoN - Pa,RsoNs - Nrsssr 1979, p. 130 (foto alle taw' IV-VI) os-
servano che I'eío0eOtg, è una caratteristica latina è che solo in età imperiale-essa si
estende anche dle isciizioni in greco. I papiri di età ellenistica, come quelli delle
elesie callimachee (TunNen 1987 n" 75: Plille) e il papiro milanese di Posidippo'
noi h*no rientro dei pentametri, così come altri testipiìr tardi (TunNen 1987 n"
45: epigrammi di Posià ippo su Plouvre inv.7172, I I d.C') . Questo,non prova
oerò, necessariamenîe, che I eplgramma su 1\zlo ru vergato alla tlne del I d.L. con-
l"-oor".r."-.nte alle orazioni del uersa' non abbiamo sufficienti termini di con-
f.onìo p., la prima meta del secolo né conosciamo il contesto in cui I'epigramma
[u scritio p.. ài-ort."r. un influsso'latino'sulla mise en page (fu mantenuia la di-
iposirione'epigrafica dei versi, se si tratta di un'iscrizione?-Lò scriba apparteneva d-
Itr n.itio Caàaris come molti funzionari attivi in Egino?).
essere dovuta anche a qualcuno che, trascrivendo il brano amemoria e avendo introdotto una variante omerizzante, ri-cordò o controllò poi l'esatta lezione del verso. A meno chenon anticipi in modo informale le decisioni del Senato, poi-ché Ottaviano vi è già designaro come Augustus (>eBaoióq)d, -v. 13, il componimento dev'essere .omunque posteriore al16 gennaio del27 a.C., ma il suo tono enfatiio induce a pen-sare che esso sia srato composto non molto dopo la vitioriaaziaca, come supponeva già PacE FGE, p. 424, o in occasio-ne di una sua rievocazione non molto lontana, ad esempio inconcomitanza dei ludi quinquennali alessandriniro; il'resco,sfacciatamente encomiastico, fu composto per catturare I'at-tenzione del princeps ancoÌa vivente, piumostó che per celebrareun imperatore defunto: gli encomiografi in prosa é in versi so-litamente evirano di esaltare le glorie dei predecessori del di-nasta regnante, esercizio poco utile e talvolta rischioso; unostudente di retorica alla fine del I d.c. si sarebbe eserciraropiuttosto ad adulare uno dei Flavi allora sul trono. una revi-vescenza della propagandl aziaca'apollinea nel regno di Au_gusto si verificò inrorno al 16 a.C.,- ed è intorno a"questa da_ta che alcuni (\flilliams) preferiscono collocare I'epìgr"-ma,che si presexra appunro càme un inno ad Apollo',úiaco; ilfatto però che esso ricordi piir le movenze di ùn l,óyog npo_ogorvî1îrKógtt p.r l'arrivo di un salvarore ameso da tempo,'chenon un encomio ad un sovrano già insediato che ritorna a vi_sitare I'Egitto, o addirittura assen-te dalla provincia (ottavianonon vi tornò più dopo il 29, nemmeno durante il viaesio asia-tico del 22-19), potrebbe suggerire una datazior,. piú"dt".
LAcusilao destinatario dài d.r. ordini dell'l1^d.C. porta
1ii?T. piuttosto diffuso nell'Arsinoite tra il I e il II sàcolod.U.:'. I sitologi svolgevano un ruolo importante nell'ammini_strazione delle ricchezze granarie dell'Egitto romano (non thewhole sitologi seem ro hive been rhe ràl mainsray oi RoÀ"'
t,o, I^!/i pro s1Qtl Caesaris fi)rono celebrari per la prima volta nel 29 a.C.,, . " AIJ';poca di MeN. R".. Tiatt. II 415_4lg'è il dìscorso i' o"c"rion. J.t_l ar'vo o del rrorno dr un governarore, o magisrrato; anche se condivide i raaoidefl'encomio (Tíatt. II 417,1-:j, p. t68 Russarr_-'wr*.^il, J.firù.".;il il3"_.gpi" "."oq tél"etovr, mancenre di alcuni elementi, e concentraro ,.rll. npale.gdel hadandu1 che nell'encomio sono solo uno degli argomenti trattati.12 PnuLus. n".2,G, p. 14; si concano almeno it"i.lnq". o-.r,ì-*i ,,.llo rr.r_so nomo nei primi due secoli d.C.
SILVIA BARBANTANI IIN EPIGRAMMA ENCOMTASTICO dLESSANDRINO" PER AUGUSTO 263262
rule in Egyptr)t3; il servizo al tempo di Acusilao.era,già stato
;; ^lil"dtiorí*uindi
vi avevanò p"tt. cittadini di medta
estrazione . ,.r*t",."ìi geranzie econimiche (cfr' ad esempio
;.é;. xlù-îziil, si "può immaginare che alcuni di questi
,.íót"*i b,rro.,"ti -"o"'
fo"t'o lprowisti di una certa cul-
tura (interessante a lf t*" Jt['"'odito contabile 'callimacheo'
a.irì-a.ó., ,i.ord"to J" yotrttt 1970)' t th9' dovendo ren-
il. ;;'m.ti.oloramenre della gestione delle risorse gfana-
rie che costiruivano la principale licchezza dell'Egitto'.entras-
r.l" ."*tionalmente in contatto diretto con le autorità' cen-
uali del governo . d.[ "--inistrazioner5'
Il carattere ufficiale
del componimento aveva suggerlto gra a Kenyon la possibilità
;È; ;;|il"o-rott. i.,tere'sató"d p"'o encomiastico in quanto
aìi.r,a.rrr. d" -.-b,i della coite: dai documenti conservati
;il^ó]j*-i"à,ri .iri risulta subordinato allo schiavo imperia-
i. prirfotÉ (il cui ìioi;*t, Fausto17, è latore dell'ordine dell'11
13 Ar-v 1g56, p. 22. Sull'attivita di_questi.firnzionari v. POry. )oc{vl-2769
("on .l.r,T'd.ííiàri zu.;."iìll .*-tè di documenti di TuuNerr- 1924, KerÉN
1932, Tovsrr'.r 1977; cIr.î;I'; lilil;ii* rSoC' pp' 274-218 e l9l0' p' 216;
p'ííi;cr<i'$ib, i,b.'aZ-ieió-i* 1 l. !1,^ n9; 250-2ii : caropruNt I e24; warLccsI938, pp. 36-38; Ar-v le5d,ìi5-6 ' i2zlliS*tt:'N 1e52' oo' 215'223; BtNcEN1e69; Shoener r96s-7oi'per i1i-iria'c'l' LEvrs 1983' P?:i6'7:s-..:^t??l':l*-;íff;ì;94' pp.'61-62"i{esponsabile di uno dei.€locropot dt grano der nomo'
iili,.f.e;-h"'if io-pito diiÉu.r. tributi in. cereali. di distribuire sementr' dr sPe-
dire le ilerrate "d
Rt.rr",,à'i"-t'*tiitì"t"t il trasporto fino a Roma (il primo do-
cumento del tópoq e "pf"*"
È fitt""t,'. di, un 'carico
da trasportare ad Alessan-
dria); dipende d"llo ,,r"f{oi;i ;;;; (nel caso.dell'Arsinoiie'-dl^.:::}l'- d*:
;;ít,-'f,i;;d.-i>e, e il"primo documento a indicare uno orpcrrîToq flg
i#iB;d;ì; ;il .i;'dJ;;.r.;. : 4*:ry dal pcrotÀtro6 lpcrppcrteÚq'e dal vopcpplq. AI srtologo sono associati vari assistenti (péto1ot' ùrcr1pétar' érct-
ogpcrr.olcti).,cxr 1g10, pp. 46_47 crede che, essendo Acusilao in carica da solo
o., o,r.,*o "rrrri..onr..,r,l,"i (11-15 d'C'), a qrrel tempo la caricarton fosse anco-
L'ìiìr*rf" Grr. Ò*ttt iil7,'p. 2j2; contta, Òar'oeplNI 1924' p' 77; Lavrs. 196l'
:: ';;t';;
à rgesl, ne -it.gii., "on
è necessario' (l servizio fir reso liturgico nel
iàrro d.l I d.c. (in BGU IV l2OO,2-l a.C. ncop^rono la cafica p_e_rsonag8r_or.ran-
;;:t',i?ii*.'r'-frÎ;*Pfi riJ?JJ'n',!3,:"!;I;.'':i;H,1iÍ31;#'.lr'l--.rio, buroli"r. ai rit"aan" incaricato della riscossione delle tasse a livello locale,
i;,-." alla metà,del. I d'C'""""';V rr.5-6 delquinto documento (Kewou 1898a' d, p.98). Un certo Pri-
sco compare-come,sffatego in PlVien 3l lll _r, 26, inizi I d.C. (PnHsrcre 1915, I,
^; >zlo\t è improbabile però.che.il Prisco uKq,ioo,po.g" d,9i documenti Plond. II
256 d ed a ricoprtsse una callca del genere, attldata dl sollto a Personaggl dt ran-
go "q",?tFiur.o non è, come traduceva Kenyon, il ufiglio, di Prisco (nessuno schia-
vo ha il patronimico), bensì un aicaius, uno schiavó al suo.se.rvizio (per ,un aiu-
.ii.] ài
".ti,o
di condizione libertina, ci aspetteremmo esplicitata Ia qualifìca di
d.C.) e del liberto Lucio Mariors. Non è esplicitato il titolo dicostoro nell'amministrazione locale, ma è probabile che essi la-vorino nell'ufficio dell'Idios Logos, che si occupa delle entratestraordinarie e dei proventi della Baotì,rKù Tî, o presso altriuffici adibiti al controllo delle finanze (quello del praefectus,corrispondente al rttt^, o del procarator)Le, aventi sede ad Ales-sandria. Fausto, che sembra agire invece a livello locale, po-trebbe essere un gopol,óyoE, come suggerisce il confronto conP.O"y. XLI/I 3273 (I d.C.) e soprartutro con P.Vindob. Thn-dem 9, n. 19-2020. Se I'epigramma è stato composro e pub-blicato, come credo, non moki anni dopo la vittoria di Oma-viano, e presumibilmente ad Alessandria, è possibile che unodegli ufficiali inviati da Alessandria nell'Arsinoite abbia porta-p 9on sé in viaggio il testo (cfr. il volume degli epigrammi diGallo scoperto in Nubia), poi copiato sul doCuménio scartaroda qualcuno che lo trovò interessanre, nell'ambiente di Acusi-lao o, secondo I'altra ipotesi, più tardi, nella scuola di retori-ca dove furono elaborati gli esercizi che occupano I'altra fac-ciata del rópog. Liberti imperiali erano coinvólti anche in as-sociazioni dedite al culto di Augusto in Egitto, come arresraad esempio un documento del 6 a.C. prorre-nietrt. da Alessan-
"poq0óg,). Sulla formu-la nKcrioo,poq, e sul doppio genitivo non parronimico v.Bou*-nr 1974, p. 37 nota 215, pp,. 193-t94,')29i-Rr"^, 1975, pp.4_5; Srnaus19.78, pp.259-260; R-EA 1978, comm. a pOxy. XLVI 3273,2-3, i^d.C. Sui uz;a_nr, spesso impiegati in mansioni relative alla géstione dei fondi imoeriali, v. wun-wn 1972,.p-p. 200-202; 212-223; BouLwnr ISZ+, pp. 206-207.18 V. KrwoN 1898a, p. 99, a t 5.-
't Lidiologo è perlopiù di rango equesrre, ma Augusto inviò in provincia an-che procuratori di condizione libertina (Dro LIII 15,3)] presso il suo'uffìcio lavo-rano. schirvi e.liberti imperiali. V. Bourvenr 1970, pp. +b-sz, zo; sui liberti svol-genu mansronl dr procuratori in provincia, v. in generale wEAVEn lg72 e Bout-S* -1?29,: p.r :Tj specifici Bnuun 1990; Ecrc -îrrNmcns 1993 nn" t5t, 152;Ecrc 1994; ${**1?75, pp._ 5-6 (comm. POxy. XLIII 3089,6). Sull'amminisirazio-ne fomqra crelr tgrrro v. MoNrEVEccHr 1973, pp. 152 ss. e lggg; BowvaN _ Rarr_r_soNr 199^2, Fp. lt-0--tr4 1Bgwvar.r 1996, pi.'679-686,689_691,693_698; Rup_pnecHr 1994, pp . 53-6 t ,72-81 .
V REii978, comm. a POxy. XLM 3273,2-3, ove è citato un uEudaimondi Marco Antonio Spendon,, (un liberto detle figrie di ettronioì-oto;ii,,f.,,.-rogoD;. tsMsHFAR 1995, n' 2.605,-p.91: PBjr l . inv.2539g,6 (Eracleopolire, T_514a.C.: lettera di Atenodoro al p!"fsr66 Gaio TLrranio), ove si nomin;"'";A;h;"í""di Cesare, forol"ogon; nel
,I d.C., un (siphilos di Chresimos di C.r".., i;;;l;;""svolge.la.stessa funzione di Fausro: autorizzare un sitologo a consegnare r.-.rrii
"contadini (supesruuN-vopt r97 6, pp. 47 -4\,.:omm. "
Èvind"b.Tina."r l, r s), rtitolo, atresrato finora raramenre, compÍue nella.prima eta tolemaica. i" q"Lir" ui-zantina e si riferisce alla riscossione delle tasse (v. ad es. psl ul 792, corisegna digrano allo
'Eppo0 ltpropóv).
264 SILVIA BARBANTANILII.I EPIGRAMMA ENCOMIASTICO ..AIESSANDRINO. PER AUGUSTO 265
dri*\, e in questo contesto il ritratto del princep.i come divi-
nità proposto dall'epigramma sembra perfettamente adeguato'
È .'hi"to che un membro della burocraziaimperiale a co-
sì alti livelli poteva conoscere22 o addirittura comPorre egli stes-
so l'epigramma piùr facilmente di un impiegato di un villaggio
oggi i.ónotciuto dell'Arsinoite, forse nella sPeranza di farlo. co-
,-róf..t direttamente all'imperatore (anche se la composizione
del piccolo panegirico non àvrebbe apportato né all'uno né al-
l'^ltio ,rr, ,ort"ttiia1e avanzamento di carriera): è assolutamen-
te escluso però che I'ep-igramma fosse {3 .presente sul docu-
mento quando questo fu consegnato ufficialmente ad Acust-
laot3; esio fu scrìtto dopo che l-ordine di consegna di grano
era considerato ormai ìolo carta da riciclare. Ammettiamo
dunque che I'epigramma abbia origine nella'capitale' egiziana'
o ,r.i ."poluofo-del nomo; dato che i legami tra le Lisima-
chidi e Al.rr"Àdri", artraverso lo scambio di merci e materia-
le burocratico, sono arrestati dagli stessi documenti del tópog,
esistevano comunque dei canali attraverso cui un componi-
menro ,alessandrinà' pot..,r" giungere fino ai villaggi dell'Arsi-
noite. più che una cópi" d'attorè, preferirei considerare I'epi-
gramma di P.Lond. 256 una copia.privata vergata da .un im-
f,i.g"ro di Acusilao, dallo stesso iimlbgo o comunque da qual-
",ró .h. aveva accesso al mareriale pioveniente dal suo
'uffi-
cio', forse interessato ad avere dei modelli Per comporre a sua
volta poemetti encomiastici per i suoi suge.ligi, Aug-usto e i
suoi àppresenranti nell'amministrazione dell'Egitto. E verisi-
mile che componimenti adulatori di questo tipo foss.ero di-
vulgati .o-,rtè*.nte nell'ambiente dei funzionari statali, a co-
miiciare dalla scuola frequentata dai futuri uffìciali e burocra-
ti della provincia (lo stesio si verificava già nel III secolo a'C',
.ome dimostrano le èrqpúoetq di *oÀ,r-.ttti lagidi nel "li-ure d'écolien del primo periodo tolemaico, 5H978-97q)'Q""1-lo trascritto sul papiro londinese resta comunque uno dei rari
2r'W'tLcKEtl 1912, n' 112, p. 143 (BGU IV l l37).22 I rapporti tra i poeti di corte e i fi-rnzionari statali sono documentati: l'?
IX 350 è d.ài""to da Lànida di Alessandria a-l grammatico alessandrino Dionisio'
iroii*, Bibliothecae che ricoprì poi la carica ir ab episnulis (v' CtcuoYys 1922'
i.-àZCll f"rr. oadre dell'omoni-o'oo.," adrianeo (v. Bowre 1990' pp' 77-78).v''""ii
\ :.;#,";iiri^à.C.'4.,í"r-;;ai;;;.*'idi scatto sono utilizzati per Ia-^"i 'nnnrìenza amministrat iva (RernsoNr 1991' pp' 1 1-13)'
casi di testo letterario proveniente da un ufficio governarivo24.È curioso, e anche amaramenre ironico, che profirio ,r.l .,.ro-re dell'Arsinoite, in cui grazie alle fatiche dei'contadini e allaroutine burocratica degli impiegati locali (spesso in vena di lu-cro' ma soggetti essi stessi a responsabilità pecuniarie) venivaraccolta e conservara la ricchezza granaria dell'Egitto, qualcu-no si compiacesse di leggere una descrizione 'dll'esteino'
diquesta situazione con espressioni altisonanti come oEùOevicx,e ngóptog, porraro dal princeps conquistatore2i!
Lepigramma, che sal,tta- entusiàsticamenre l' aduentus diAugusto nella terra del Nilo come Zeus Liberatore e appoma-
:.r: qi p"... ^. p_rosperità dopo la vittoria concessagli dà Apol-lo Aziaco (cfr. Hon. carm. I37; VEnc. Aen. WIl675 ss.), èevidentemente ispirato dall'arrivo del princeps ad Alessandrianel 30, anche se può essere staro scritìo dopo il 27 in occa-sione dell'erezione di una srarua nella stessa città (come sup-posto già da PacE 1942 e Koenen, in Trior,,rpsoN - KosNsNr1984) o di.festeggiamenti in onore di Augusto, ormai salda-mente. insediato { por.r.. Per i sentimenti di speranza che loperS{o1o e.per la dgmin-ante presenza di Apoilo, già parro-no dei Baorî,sîg lagidi (cfr. Cttr. Ap., Det)) lo si iuò'para_gonare al brano celebrante I'awenio al trono di adii".r"(PGiss. 3)26, che piùr tardi visiterà I'Egitto, suscitandovi peròassai meno entusiasmi di ottaviano, i-n sfortunata concàmi-tanza con un periodo di secca nilotica: nel brano supersrire,Ap.ollo, our cÍyvcooroE Oeóq per gli abitanti dell'Apollono_polite o.dell'Egitto in generale, ànnincia al Afrpog I'assunzio_ne al cielo di riaianò e I'arrivo (il7 d.c.) iell'civcrrrsKqtvòv 'Aòptovóv;
sono soprawissute anche monere com_memoranri l'aduentus di Adriano in Egitto, in nave o in qua_
2a cLaRysse. r 983, p. 46. Anche ir pezzo per Adriano di cui sotto è oroba-otr-:l!.^ll" copla privata, rrovara rra le carte di uno srrarego (Komevalr.r,l907,pp. 281.-282; RerrzeusrrrN 1908, p. 366).25 Losservazione è del Dr. D. OUUint .26 GDRK I n" XII; Prcrcz l74B; KonNeri,raNu 1907; Rgrzr.NsrerN i!gg;\f*crcrN l9l3; cnoNrrr 1925, pp.460_470. per Reiuenstein si rra*a forr. ùi u'brano recrtativo destinato ad.aprìie un festival in onore d.ll'i-;;;;;;, ;; è;.-",.*,9.1
vorspieldi,un mimo leiterario. Accanto alfimperatore, iíu."."i.i.-irJ""-che l'eúoÉpera e la grl,otrpíc dello stratego che próbabilmente ha
".*"r,irr"à i
testeggl.unentl, secondo la scala gerarchica imposta anche dei manuali ietorici (v.nota 51).
266 SILVTA BARBANTANI LtN EPIGRAMMA ENCoMTASTICo "ArEssANDRrNo,
pER AUGUSTO 267
driga, o accolto da Alessandria-Eutheni*7, una personificazio-n.
"eil presente nell'epigramma Per I'arrivo di Ottaviano' Se
oerírno'l'aduentus di tt"t,t. imperiali, Per tutta la durata del-
i'i-p.ro romano, ispirerà i poeti cortigiani e attirerà I'interes-
,. d.ll. masse, ,op.àtt,rtto nelle zone órientali, la presenza fi-
sica del sovrano nella provincia doveva suscirare, specialmente
nell'Egitto appena conquistato-,- un'emozione che rende com-
pr.rrri"bili ..itè .r"g.r yi"!i dell'epigrammista alessandrino.^
Lignoto ",ttoÉ
di Sl/ 982, benché non brilli per genia-
lità artiitica, non è sicuramente un improwisatore, ma dimo-
stra una buona conoscenza dei topoi della poesia encomiastica,
un gusto per l'espressione fiorita e per l'immagine ridondante'
Kenlyon, i.tt "ttttorr.rando prudentemente il brano fra gli ade-
spoti, ricórda che Bùchelei aveva ProPosto come autore Cri-
n"gor" di Mitilene, diplomatico e Poeta legato ad Augusto e
alll sua famigliazs, in base ad un debole indizio stilistico: Dio-
timo nomina un guerriero Crinagora in A.P. WI 227, conte-
nente al v. 2 e nella stessa sede metrica dell'epigramma augu-
steo I'espressione ocrréov nurayogze; non è detto però che si
tratti di-un'allusione all'epigramma encomiastico, essendo que-
sto giàr un nesso callimacheo (C,qrr-. Lau.Pall. 44; cfr. anche At.
Ach. 539; Eux. Heracl. 832). Lambientazione egiziana delcomponimento suggerisce un autore proveniente o residente in
quella provincia, piuttosto che un poeta della Grecia conti-nentale-o microasiatico, come molti di quelli raccold nella Co'rona di Filippo. \Xtil si limita ad iporizzare che l'autore sia unAlessandrin-o: in effetti la capitale tolemaica diede i natali ad
27 PooLr. rav. )OOIII 669, 868,870,871.28 V. Crcuoruus 1922, pp.306-323; Gov - Pncs, GPII, pp.210-212;\Itr-
r-rerrs 1978, pp. 129-137.In alcuni suoi componimenti trionfa l'adulazione nei con-fronti del pi;Àceps (A.P IX 224, 562); altri iono dedicati alle guerre contro i Cer-mani; altri ancoia, ad es. quelli per Marcello (VI 161, lX 545) e Antonia (A.P lX239: bigliemo di accompagnam.Àto p.. un libro di Anacreonte; \1 24,4: per il par-to) dimbstrano un rappoito più personale con i membri della famiglia di Cesare.Tia le sue conoscenze-spicca anchè Cleopatra-Selene, figlia della regina egiziana e diAntonio (IX 235).I suoi epigrammi contano solitamente due o tre distici, al mas-simo si estendono per otto versi, ma non raggiungono le dimensioni di Sll 982.
2e Il termine^nútoyoq, compa-re nella íiessa-sede metrica, anche se in casi di-versi, in A.P V 175,8 (Mer.); VII 147,4 (Ancu.): (tgéov núta1oq; IX 769,4 eXl 352,16 (Acnru.). Non sappiamo quale dei due Diotimo, uno compreso nellaCorona di Meleagro, uno in quella. di Filippo, sia I'autore dell'epimfio per I'ignotoCrinagora, che appare comunque in un contesto non meleagreo (v. Gow - Pnce,HEll, pp.270-273: lo ritengono un Pezzo epigrafico).
altri poeti al servizio degli imperarori romani, come Leonida3o,uno,degli epigrammistf encàmiastici piir intimi aat" .orr.claudrana e neroniana, e pancrate, autoie di un poema in esa_metri esalrante Anrinoo, il giovane favorito di ,Àdriano (GLpr281tr. II caso del diletranté Dioscoro di Afroditooiii, à a.rpiùr geniale Nonno dj.panopori, dovrebbero t.rrtarrii i"àurr.
"una ce.a cautela nell'assegnare ogni manifestaziorr. l.tt.i"riaoriginale esclusivament.
"JAr.rr"idri"; i morivi per quarihca-
re 'alessandrino' il componimenro sono
"lui, ir" .íi i'.ìrt'i.rr.
lo pervade e che interpreta forse i sentimenti d.gii nr.rr*ari-ni schieradsi a favore
-di Antonio e ansiosi di fa; aiÀ.rrti."r.
a{ .1u9vo Baor},eóg romano il pericolo rappresenrato per lui111 "]l',t" 11s"" espo nen re dell J casata r"l.'d ;i;;;
^à."l"rr"rr.uon abrre sincretismo, I'anonimo autore accosta i simboii apol_linei.della mitologia augusrea
"d .È;.;;i ali; ;rr*"'.-lt"-
na' gra assunrr nel campionario dei tu1toi encomiastici toleíraici(come il richiamo aJl'uberms nilodca), inserendo .ori .or-rr"-turalezza Ottaviano nella sequerrr" -Íl..r"ri;; ì"ì;;;r;Jrr" aidominatori dell'Egitto; p.. q,r.rro ,."a.r.i
"a .r.i"a.ri-.fr.
r aurore sra uno degli epigrammisd greci attivi a Roma (Aool_t:lli:, An tipatro i.r,ioi i..r., c ri fi "g;r"' ài'n t,i.":l,
tT,,,.e staro suggerito da \ùídliams: consideiar. t.
"o*"oii-;iff.;."ze nelle modalità del culto imperiale tr" I,Ori..rt. ^.
ì" ^pir"
occidentale dell'impero, un talè componimento sarebbe itarosenza dubbio fuori.luog.". dú-;.;;'lìl prtnnpr, sul paladno,benché all'ombra ai q"!il'Ap"lr"
-iA;;;"q da esso esartato.
30 V ad es. A.p t ,"r-l"f:1,j.qdo d1 compleanno di Cesare; W 328: iluNilou invia il III libro di epigrammi in ómaggio all rmperatore, amraverso la Gre-cia; lX 349: preshiera o.'. li.""lut. di ó;.rTîÀ îis, lx 355: regali.per Agrippi_na e Poppea. suieonida. *: lp-.:rg ,.;;li; i" .-u." p.ou.n,. nze estztana u.p w321,2: Nettraín Mo.oa:,.IX iii,<, O-r.iJii"r.ti_. oo,Oonótog)-, v. Crcsozuust922, pp. 365-371. Carilio.de;; Nr.rrà*,igrrà'_di Nt..r,or.'".ià..-.à.ìi,ipt_gramma per Augusto a File (BrnNaNo 1969b-ri""l<z,tl-tS, comm. p. g5, e l,a_crosrrco n" 143), potrebbe essere il^nipote a.rf,J.r*"j.in. fu;-iilrJi"""íi!.,aiAugusto (Dro LI-16: suer. Aug. 89;
'p,-". ;;;iij:'i po.ti cortigiani dei secoli ve VI d.C. provensono in"....p1rlofiú alf_'r.* iii'panopoli (v.-Cavgnoru 19g2,pp 217 2zr) Se"oggi la qr.1i1^11,i"-f*,ilil...lri.". nelt,età diAugusto è te-s'monrara sopratrurro daeri epigrammisti greci_(o .l'u.n' rn greco: v. \ùZ*'nvs1978' pp' r24-rig)' dob6iamo.supporre, àon wsrre r99i, pp. 204-205, un,ana-loga fioritura latina, di ."i. r'.pigràÀ-"'fu;;i;;;:;-rastico di Domizio Marscrper Az.ia,(v.^nota 168) è solo ún-esempio.
] l t Bowe 1990, pp. 8t-83.,
'.' Un solo scrirrore'alessandrino è noto come dilo storico il;;;;. b;or D82. issidente rispetto ad Augusto:
SILVIA BARBANTANIuN EPIGRAMMA ENCoMIAsrtco .ALEssANDRrNo" pER AUGUSTO 269268
Epigramma come encornio ed ércEpaot;, encomiastica. Possibile
ieslinaziore ePigrafca di SH 982'
se I'evento ispiratore del componimento ̂ è esplicitamente cele-
Èrato (la vittória aziaca),la destinazione finale dell'epigramma,
oi"*oìr" esreso (14 w.) e con movenze da inno cledco nellal .
sezlone lnctplrafla e conclusiva, non è invece immediatamen-
te perspicua'. Prima di sviluppare alcune supposizioni,in pro-
posito già sopra anricipare, iJrà bene inquadrare quest'unic.um
àrrg,rtró nelia tradizióne dell'encomio epigrammatico.in lin-
g.,i gr.." a noi nota, nelle sue linee principali, per circa un
millennio.Lelogio dei Boorl,eîg ellenistici non si manifesta soltan-
to nelle fJt-. più esplicitè d.ll'.rr.o-io in versi dattilici e del
Doema storico33 direitamente indirizzati al protagonista delle
î*pr.r. celebrate, ma assume sPesso le forme ridotte e il tono
oii dirrresso dell'epigramma' mitigando I'intento adulatorio
ton urr" profusione d"i preziosismi slilistici e di allusioni lette-
rarie. La predicazione della lode di un individuo, solitamente
per meriti bellici, in brevi componimenti metrici, perlopiù dat-
iili.i, "pp"rriene
già in epoca àrcaica alle epigrafi epirombali o
"n"t.-àii.h eJ4, ; accompagna I'evoluzione letteraria dell'epi-
gramma, che dal IV-III secolo si presta a diventare una sorta
éi encomio o epinicio in miniatura' semPre più spesso svin-
colato dal supporto epigrafico35, e, venute meno le remore cul-
turali e religiàie d.l p.iiodo arcaico e classico, s:mPle. più spes-
so destinaó a .elebr"r. le imprese e le doti di "dèi ed eroi'
contemporanei: già lo spartano Pausania, vincitore a Platea sui
Persiani, a't.'t "
i.ttt"to, invano, di utilizzare un breve epi-
33 Il merito della riscoperta di questo asperto misconosciuto della poesia en-
comiastica ellenistica si deve'a K. Ziegler, neli'opuscolo del 1966, -ripubblicato in
rod*iorr. italiana a Bari nel 1988 (tepos ellenistico. IJn capitolo dimenticato delk
ooesia sreca).' I't Gli epitafi di guerrieri, in cui il motivo della lode prevale. sugli akri topoi
funerari, porróno esserè considerati dal punto di vista retorico veri e propri enco-
mi; v. SrÈcuen 1981, pp. 46-47; sui primi esempi di encomio elegiaco nel VI-V
sec. a.C. v. CarrEnox 1995, pp. 289-290.35 In tal caso il
'passantè' invitato a soffermarsi sull'epitafio è il lenore del-
I'antologia (Hr-iNren l9\2, p. li6). Laffìnamento retorico dègli epigrammi-epitafi,
dou.rto in origine all'esigenza di 'catturare' I'attenzione del passante, diviene nell'e-
pirafio fitrizio"una formidi compiacimento letterario, o un èspediente per far emer-
lere I'eoisramma in una raccolta (WnrsH 1991). Sulla connotazione incomiastica
iegli .fifr"mmi funerari in età bizantina v. G,qLll CaroezuNI 1992, p. 116.
gramma anatemarico come veicolo della propria gloria36, masolo alla fine del v secolo il suo concittadino Lir"rr?to riusciràad omenere in vita onori semidivini.
Mentre.l'aggettivazione dei primi epigrammi è ancorascarna e limitata, a partire dal vI ìecolo a.i. più spazio è la-sciaro alla lode delle npú(etg, in proporzione j|estàsione delcomponimento; è presenre il motivo del paragone mitico, chetroverà ampio sviluppo narrarivo soprattutto nei paneeirici inprosa d'età imperiale3T. Dat IV secolo a.c. fanno i" loío .o--parsa epigrammi,di dimensioni maggiori e daila sffurrura sin-tattica più. complessa, menrre breviélegie (epigrammi da r0-12 a qualche decina di versi) sono composre con una cerra fre-quenza, accanro a p_eni di dimensioni ridotte, nel primo pe_riodo ellenistico (III-II a.c.) e in quello tardoimpe'riale. Allosviluppo di categorie professionali ú raudanl; (i membri del-le confrarernite di tecniti, i rappresentanti della gerarchia dipalazzo, dell'amministrazione e^àel'esercito, gli
"r%,i Ji-*ri.
specialità38) consegue la formazio ne di topoi àncomiastici spe-cifici. Anche. I'epi.tafio diviene più ampió ed elaboraro, comeotmostrano r prohssr componimenri funerari alessandrini3e adestinazione epigrafica a partire dal III secolo a.C., veri e pro-
'":4P W 197; Tnuc. | 132; ptu. De Hex mal. 42,13, 873c.37 V. Srpcsen 1981, pp..20, 4-1. ps.Drorvys. A" Rh. (ópiruùl), ZeO Uru-uBn-RaosnvacHrR "..o-,rnJ l,epiafio all,encomio p;, É p;;:;; f;í iiii ;/r,(natpíòog, yévoug, <púoeog, .iygyîq npú(eo4).'
"- r .er la sua evoluzrone.v..SrecHrn 1991, pp.4g ss. Lantico encomio epi_grafico dell'atlera, svincolandosi dall'occasione-*"iJ*",i." . ".l"ir-,La"
.., "."ì",-
tttr rrrpr-g prll lemerario,.finirà per assumere le funzioni ai "ri.piri.i"
r, -i"ir-tura. A.P IX 588 (Ar-c. Mess.), sìila vitroria.al pancrazio di Clitàmaco Ji f.-UL, ef ^b"::._^.,1..:1..lp]"i.ir
sorro l'apparenza di un commenro, rivolto a uno (eîvogdr pas!1ggio, per una statua dell'atièìa virtorioso.
^L: 1'S^ugti epigrammi di venti versi e oltre v. Carurcnori 1993, p. 13. Sui lun-gnr eprratr alessandrini v. fr.asen, pA I, pp. 612-617; II, pp. g66-g69; ,pi.."r,oquello in distici dell'uffìciale Tolomeo . d'i'ruo ngrì., i" kài,", iÉrK*íììàs,
l-lff tr,r, =*rrr,* rr4e, rr a.c ?), cfr.-pEii--iir tc,i,"t è-igàiiBi,íi"1,r eplra'o crr un uttlcrale composro da tale Erode e scoperro in una necropoli úifryJliî 'pgli: Magna (BenL.rarìo. D.!9u
"" 5,pp. l3_t8, F*rr^, pAt, p;.6tr_u^ro/; reprtatlo dl un mercenario.d.i Apamea di nome Diazermis (BTRNAND tr6gal" !0'pp. 75-79 = PEer< t-l53), dallarìecropoli di Abou-Billou. r.*."rti.,^íra-lo,del ioldato Filonide f ut
"ó.1, f r.u"uitrl;;;.1; N;";; dr**;'óà#""uo/. rn quesre plccole orLTioni funebri in versi sono elencate esaurientemenre le im-prese e le vlcende del defunto, spesso anche di membri deila sua famiglia. uno deimigliori esempi di poema funebL esamerrico_ d'.p*; iú;jl: ;;H'il;;;;.nimento di Marceilò di side per negilh, Àojri. aí pàa. h,,i.. tuo*v,*';;ír-MoerLsrtooRrp 1928; Bovrs' 1990,"pp. 67_8r.-
270 SIL\4A BARBANTANì UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO .ALESSANDRINO. PER AUGUSTO 27I
L
pri encomi in distici del defunto, commissionati da clienti fa-
èoltosi a poeti di talento non eccelso.Gli épierammi in onore di dinasti ellenistici del III-II se-
colo a.C. toio *d"ti in qran parte perduti (tra i superstiti non
inclusi nell'Anthologia Glaeca,ri rono gli epinici per gli.Attali-
di SF1 121, ESERT 59); possiamo ancora leggere quellt com-
oosti da professionisti gr;itanti nell'orbita -della
corte e del
ivl.rr.o (Cilimaco, Posiàippo, Edilo) per i primi Tolomei, che
si distinguono generalmetti. p.t la levità e I'ironia con cui è
rrarraro i"l t.-""dell'elogio. Loriginalità e I'equilibrio della poe-
tica 'callimachea' \r.tte;to -.ttó nei secoli iuccessivi, lascian-
do il posto a toni d.iisa*ente piìr squillanti e all'uso abbon-
dante di luoghi comuni retorici. Aparte poche eccezioni,.non
abbiamo pr'rriroppo molti termini di confronto dalla provincia
egiziana. Tha eli'epigrammi encomiastici per sovrani viventi dal
I"a.C. al VI i.C.'tii.."tto ANrIp. Tnsss. A.P nil 75, tronfro
encomio in distici àel re tracio Cotys, épyov &oròomól"tov (v'
4; cfr. Ov. Pont. 2,9) e due componimenti in esametri, co-
struiti sui secolari topoi della teologia monarchica, A'P XIV
148, oracolo che p"r"gott" GiulianJa Zeus vincitore del fq-
ytn3tn... gó).ovi". i), papvúpevog ltepo6v nol.ra.g ruìreiyeu pcrKpú (u. 4), e Cvn. A.P YI 9 (definito dal lemmaèyiiílptóv), in cui I'imperatore Teodosio II è presentato comela sumrna delle virtù déi mieliori eroi omericia0. Un breve en-comio di Anastasio I, trioÀfatore sugli Isauri, è inserito nelpoemetto ecfrastico di Cristodoro (A.P II 403-406), nel pun-io in cui si esalta il suo (antenato) Pompeo. Il Ciclo di Ag1-zia ha conservato numerosi epigrammi ìncomiastici per gliimperatori del M secolo, tra cui A.P X\n 62-63 (anonimi, indisiici), per le ofFerte di doni a Giustiniano Mr1òoItóvog(62,1)3l'Mq8o<póvoc, (63,4)at; A.P. IV 4 (3b), la 'prefazione'
ao Il poeta paragona I'imperatîre a diversi eroi, dei. quali però,no.n.possiede
i diFetti: manca il^paràgon. .on la divinità, consuero nell'encomio ellenistico e ro-
mano. Cfr. VIr;nvaa 1968, pp. 64, 115; Cnvenou 1982' pp. 228-230.arlaggeitivo, che ricorda una delle paginepiìr.gloriose della storia greca, è
rioreso in tmbito encomiastico già nel III a.C. (Katsel- 30'6: p1òogovcov"'
nirtéprov) ed è utilizzato nell'epigiammistica tardoantica ancora.a proposito delle
Guerre Persiane del V a.C.: in A.2l4,VI 118,1 (Pnuu Stl.) si esaltano le pqòo<pó-
vooq... 1eípag di Cinegiro, in A.P X\il 233,7 (TErs.r' Scnol') Maratona è detta
O pnOoiiOvoq-(come in-pru. De glor. Ath. 7 Milziade), Temistocle nepoortóvoq.
Anche nell'encomio elegiaco che iirroduce tl Cido di..Agazia i nemici_oriengli (w.
58-76) sono rappresenàti come Giganri ormai debellati. Per A.P. ;g.II 46,2 v. ol-
ue, p. 179.
della raccolta di Agazia, comprendente un elogio in esametridelle vittorie di Gfustiniano; Acnrs. A.p ylf 72, in distici,destinato ad accompagnare una srarua di Giustino, e, dellostesso autore' rx 641 (celebrazione in distici del ponte sul San-gario eretto dopo la vittoria giustinianea)a2.
Nonosranre abbia vissutò una breve ma intensa evoluzio_ne nel primo periodo ellenistico (dalle Einzelelegiez callimacheeai poemi encomiastici per vittorie militari SHg69,9jg), al difuori dell'ambito epigrammatico I'uso del distico elegíaco incomponimenti encomiastici in greco in età imperiale 5 rarissi-mo: lo si trova nel tardo GDRK )OO( recto-(kudatio di unprofessore di Berito), forse in una sezione proemiale (Vilja-maa), accanto al giambo e all'esam.tro; pro.Ài in distici sonofrequenti invece nella poesia latina
"o"rrà, in Claudiano e Si_
donio.Il motivo encomiasrico, migrando dall'epitafio all'epi_
gramma letterario, entra spesso in iimbiosi .or, ,rrro deeli eser_cizi di virtuosismo prediletti dai poeti ellenistici, l'ér$'pcotg.Sono questi componimenti, di dlmensioni ridotte . di to'oleggero e apparenremenre disimpegnaro, ad avere la meglio,sulla lunga disranza, sugli encomì s"olenni e sui magniloqíen-ti.poemi.epico-storici: a volte inscritti su epigrafi érpori. ,,,edifici celebri in tutto il Mediterr"tt.o, ,p.rio"utilizzati comeesercizio di lettura scolastico (sH 978-97g), quasi sempre co-piati da privati (GLP 104: epigrammi di poiidippo tiascrittidal rúto1oE memfita Tolomeò,-nel 160 d.C.) o àà.olti in an-tologie.prima della scomparsa del suppono marmoreo, gli epi-grammi ecfrastici seppero carturare lbitenzione dei lemelti ài-lemanti e suscitare la curiosità an-tiquaria e archeologica deglieruditi, guadagnandosi una possibilità di soprawiveiza allor-ché, con la scomparg-a dei regali dedicatari, i componimenti oc-casionali segnari dalla più tronfia adulazione
".i."rorro di in-
teressare il pubblico dei lettori. se I'encomio esalra e pubbli-cizza spesso le res gestae milirari, l'ér<ppaorq celebra Ie ,op.."di pace',.Ie maniFstazioni architettoniche e artistiche .rp..r-sione ddla îpogú regale o nobiliare. La minuziosa descrizionedi-oggetti, luoghi, ei-uoto, opere d'arte e d'architettura è unadelle caratteristiche ricorrenti in particolare nella poesia ales-
a2 GarLr CerorzuNr 1992, pp. ll8-9; Vrqavaa 196g, pp.60-62.
\-
SILVTA BARBANTANI UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO ..ALESSANDRINO' PER AUGUSTO 273
spesso ben poco spazio, nel già esiguo componimento, è la-
,ài"ro alla dèscrizioi", . il poelmetto"si risolve nell'encomio di-retto al personaggio raffigurato e alle sue virtù47. Come acca-de nell'epigramÀà su Crinago ra A.P VII 227 , in quelli su atle-
ti vittoriàsi (ad esempio gli-inediti epigrammi epinici di Posi-dippo, tra cui quello per la statua equestre di un vincitore aNèmea, della quale evidenzia il realismoas; quelli per le statuedegli aurighi dell'ippodromo di Costantinopoli, A'P. $fI ?35-lW) o in quelli pèr governatori bizantini, si giustifica il ri-tratto con particolari benemerenze del soggetto, che vengonoelencate ed esaltate.
È possibile che anche in "Sl1 982 I'insistenza sull'eventoazíaco è sulle sue
'miracolose' conseguenze sia motivata dal-l'occasione per cui è stata eretta una statua (di Onaviano o delsuo divino patrono Apollo, possibilmente con le sue sembian-ze) sulla cui base esso doveva o poteva essere inscritto, owerouna commemorazione dell'aduentus di Omaviano in Egitto.Probabilmente per la stessa circostanza fu concepito il ritrattodel vincitore con acconciatura egtzianaae, che lo presenta comeun erede dei Tolomei e dei Faraoni, nonostante alcuni dei pri-mi atti pubblici di Ottaviano nella provincia abbiano segnala-to il suo personale distacco dalle tradizioni teologiche e dina-stiche egrzie e lagidi50. La connessione tra performance poeticae dedica di opere d'arte figurativa in occasione di solenni fe-ste di benvenuto diverrà un luogo comune per i retori impe-riali. Sia nel l,óyog rpooqcovî1îtKóg sia in quello
la coppia imperiale); XW 33: ci si rivolge al cubiculario imperiale Callinico lo-dandone le virtir; filI 37 identifica la statua di Pietro e descrive i simboli deila ca-rica prefettizia; LroNr. XVI 32 celebra un dipinto del prefetto Gabriele, rivolgen-dosi al soggetto; Io. BanB. XVI 38, encomio iperbolico per la statua di Sinesio,giurista e prode in guerra; Mtcu.Gnavu. XVI 316 (ritratto di Agazia); XVI 35 (daAfrodisia, sul governatore Palmato); CIG lI 2592, epigramma di Gortina per unastatua di Leonzio, prefetto del pretorio d'Illiria nel 412-413 (v. Ronrnr 1948, pp.14-15 ss.). Non per tutti gli epigrammi sopra menzionati è dimostrato I'uso epi-gralrco.
a7 V LauReNs 1989, p. 42: la maggior parte degli epigrammi epidittici cele-bra, non descrive.
48 Riporrato in traduzione da BnsrnNrrut - G*rdzzr 1993, p. 38.ae Gzuvu 1981, pp. 20-21, rav. XII; Srnocrcn 1980, tav. eO Oe-Zg ^.C.);
HerNeN 1995, tav. XI. Il colosso, alla cui erezione non presiedette diretramenre Ot-taviano, sorgeva presso Karnak. Sull'iconografia _egizia di Ottaviano v. anche Hu-Nnr.r 1995 tàw. IX (porta di Kalabscha) e XII (rilievi del tempio di Iside a File);DuNaro 1983, pp. 49-53;'ÍHouvsoN - KorNpN 1984, pp. 132 ss.
t0 V. Gn-eùren 1995: Ottaviano 'nuovo Cambise'.
272
sandrinaa3: se in qualunque.Poe:ma.ellenistico di una certa
estensione ro,'o p"""ti brani^ecfrastici' è soPrattutto ai 'breve
giro dell'ep1g*-i1^ iit" ti pttfttisce affìdare la descrizione
compiuta dt un eotficio' di ún q""+.to o di una statua' o al-
;;i'l;;*ssione àti tt"ti^tnii di ammirazione e stuPore
che questi oggettl 'ì"ttJt"ti sus:l.ta.no nello spettatore' Tut-
tavia, con l'eccez#e.lffi;tit"=aa lunso epigramma di Ar-
chimelo (SH 20D-;;"iil;;"t di Ieronelsoló i'l V-VI secolo
si arriverìr al poemetto ecfrastico ":.t9 .e ptoptio:-9tl*i::t:
in esametri, ,t' opt" d'arte ed edifici conservati o restal'rratl
, o t to i I p at ro n ato ;i' -{ t;i::;'"""':*inX,1 Jffi:î,ffi: 11cura dei-monumenti si assocta' esPllclta
te, a quello per la pacificaziont aimata dell'impero' che rende
rirriÈru f" ào,ituo artisticaas'^
Non sempre f'l'Ji"'it"t ePigrammatica delle effìgi pitto-
riche o statuarie dti;;;;;-'i;-t'd;: monumenti da essi eretti o
restaurati, frequente in ePoca tardoimperiale . (pareccl^1,^t]l
.ì.*ii".f ^òìti
ii nguiaio6 sfocia in un esercizio ectrasttco:
a3 G' Zanket la considera uno degli elementi del cosiddetto 'realismo' ales-
sandrino (i987, p' g:' óig'l-tti su mo-numenti toft-tial' Sull'ér-9-puo4';fle1i-
"j5il###i;.'*nf :p+;," *{";ff [:{:ff:f r:i:l*"::;f i:
f ambi,op.,q"r:i:--y:*i5'ittm{#inqd;à*?xli,T:":îiFÍ:i\ ^,{trt;f"';tr;î;del tempio ciziceno a'1" a'tuni^ Àpollonide'' moglie'di At-
;í"ri,;;,í;"'di *li,o gìi Lpij*--i descrittivi.traval;.,."H LjlrgT:1il"t',,1i.^,j-lixfi":x1ruffi::;1f,}ffii';.îilq;qr;ìiluu^*ìlei?,"4o FGEr,pp. 26-;ò: sij"?q'';;;:
"-80; n'n
'V zor"; Mgfc'Hr9N: FGrHi'
sr lrr n' 57r,: Kònm...p eoe' "rraoaà;ry z*iifl'""f'î;lÍX,'.',if:fii:r[1'#X:
í***'*::;":1#l';ili'.j:;"'ft-:.1,i'1,i.':;ffi il;;;d.ir"i:::':"**hf ,+;,ÎiT.T:":''rff :'J"Jf ;:1:,f Ja,Tfi '"xi'J,'.',:HT"ffi 1.nJ'À'::ili:rT;ill.'P;i:il.il Jir'l''pi"i''"ii'd;ìì;;";" :'P'"i]J-.'*TT.l:ilf
"J.i:::ì:;'fl1;;;Àil; Poseidone' esso fu co"c'pito forsc pt
i"'íitr^*'',ii,ff*l;JÍl;i%r-cz 'utt'r*'ppaorq di s, s^'ff {P'qur' Srr-')' Suopere giustinra n r r. ,;'';\k'éir"tncitti' coi (P;"1 srr-')' 820 (s'n'1)"sull'ér-
îî3:if,:bBT^,T:$;lf ar^*n**l'*.1'li,;[ffi l'Í;'j3'1li;
::*,s.li*:iie''r,gtrut,;l;u":;l' ,rr'rutrffitr;r;J-","ff ifl#:'ffin::f; .,I;# ;:'fl"r;,Í ;;; ;^o;;; ; r ; mo des'co'lr'r.buto al suo valore) e <f '"rrÌ"irni"ltioto'" ro-"1o-ì1;;;"; vicina a quella del-
ènrBcrt(prov, entrambi destinati secondo il manuale di Me-nandro Retore all'accoglienza di governatori5l, ma i cui topoisono applicabili anche all'&núvtqo'tg di imperatori52, si sotto-linea la coesistenza dell'elogio poetico e della celebrazione ico-nografica dei potenti: p€îo( ptKpòv &vcrOqoopev eiróvag,perù prrpòv notqtaì roì l.oyonotoì rcÈ p'4topeq qÍooo-or. tùq cperùq raì òraòéoouotv eig Tévn núvtrrrvcrvOpóno:v (MeN. Ru. Tí'att.II 381); si inviano eiróvag del-I'imperatore a Delfi, Olimpia, Atene e se ne riempiono le città(rr 4r7).
Se nel caso dell'encomio epinicio (lirico o epigrammati-co) I'occasione dell'elogio è una recente vittoria, atletica o mi-litare, l'érgpo(otq può essere sollecitata dallo stesso laudandus,o da altri committenti a lui vicini, in corrispondenza dell'inaugurazione dell'edificio o del monumento: pur essendo l'e-logio concepito per una particolare solennità, la sua consistenzaepigrafica lo rende più durevole degli antichi componimentiencomiastici, di fruizione prevalentemente aurale (almeno finoal III a.C.), garantendo così anche il ricordo dell'opera d'arte
5t Tian. II 415-418, pp. 164-171 Russr.rr--\MrsoN. Il retore inoltre consi-gliava, nel caso di un ì,óyog npoorptovqtrróg, di subordinare cautameote la figu-ra del dignitario (governatore. comandante) a quella dell'imperatore: subito dopo ilnpooípr,ov I'oratore condenserà in poche battute l'encomio del sovrano, "poichéquesto accresce le lodi del governatore', proseguendo con l'elogio rivolto aì perso-naggio interessato. E quanro accade già nell'epigramma di Catilio (Katml 978; Btn-N,qNp 1969b n" 142), a File: il componimento esordisce con una magniloquenteesaltazione di Cesare Augusto nZeus LiberatoreD, per poi elogiare, in termini piìrconsoni ad un mortale (w. 7-8): raì péycrv èr peyúî,olv Touppúvtov, óvòpcròírcrtov,/ AiyÓntou nóoaq géprcrtov ó1epóvcx (= praefectus Aegypt).
'2 MacConvacx 1972; PenNor 1993, p. 95. Laduenns, cerimonia dalle for-ti connotazioni religiose (v. I'elegia IG ll-UI'3 3606 per il ritorno di Erode Atti-co), oltre che in relazione dl'imperatore, nell'Oriente tardo antico e bizantino si ri-propone in occasione di ritornì dall'esilio (Atanasio, Giovanni Crisostomo), del-i'.nì."t" di reliquie in citta, o all'arrivo di statue di imperatori o dignitari di corte(GDRKI l, p. 128: panegirico esametrico di Dioscoro per una statua di GiustinoII, mai venuto in Egitto). Nel periodo ellenistico sono note scene di anúvtrlorgma non i poemi di accoglienza (Attalo I: LIv. )OO(I 14, 12 e Pows. ^rl 25-26;Attalo I I I : 'OGIS332; To-lomeo l l l FGrHist I I I n'160; i f igl i di Corys,37 d.C.:Syll.3 798,22,.ove si preannuncia I'istituzione di una anúvtqotg). Laccoglienza adun personaggio, privato o pubblico, non solo segue sempre determinati schemi ce-rimoniali (presenza della popolazione in massa fuori dalle mura della città; parte-cipazione di sacerdoti), ma viene anche descritta seguendo costanti topoi lerterari(negli epiloghi dei l"ó1ot rtr"1ttroi e degli èntBtrt{ptcx: MeN. Rn. Tian. II 381,6ss., p. 100; Tian. ll 427,10 ss., p. 188 Russell-'WIt-soN; v. GaulHrpn 1985, pp.50-51). Aduenru.r inFormale si veril-ìcò in occasione del ritorno di Alcibiade (Nip.Alc. 6,l; Pw. A|c. 32,3) e di Cicerone (Pis. rl ss.). Cfr. Ptu. Cat. Mi. 13: una so-lenne anóvtqotq viene allestita per un potente liberto ad Antiochia.
uN EPIGMMMA ENcoMrAsrrco dLEssANDRrNo" pER AUGUSTo 27 j
nello spettatore e accentuandone il valore di monument tm, unconcerro parricolamente insistente in SH 9g2,1_Z,tZ. -Non
siesclude che alcuni .pú;;;1" ."ì.-i"rrico-descrittivi venisse-ro recitati dall'autorè it.rso d.urante r" l.tiÀ."i"';;;;;"."-zione o la consacrazione del -;;;;;., ;;;il;;"ri.,r,. r"coronavano (cfr. srer. silu. r J)st; la possibilità Ji l;;' irrfonrnAnce recitativa rende più suggesriva^l'i"uo."rìorr. ì""ií" ,il"divinità locale che snes.., .^;:";: ;-:::::v'r.'rrrrLiimendanatematicìil'.0""ì'".9fi ll;t'*"ffi:1'fi i"rJ,"fl3..?l,ip.fg .4i un _epigramma),. A uolt. i.prgramma sresso invita ilpubblico a freqùenrare il monumentó ire ;;i;b;;,;;;ip""essere esposto, sopra_tturto se questo è un tempio (Karuer Bl0,per il tempio di^Afrodite
" Si""L.r",^pos,oóp. ùi"ÉÉ'p.,
9y9ll9 di Afrodite Zeftritid,e; À.fll\89; Manc. Sro. lGX,VL389).Naturalmenre non turti gli eoirrrastiÉitu;;;;';;i't,#;il;f.ili.'f i:1ft'"'*T*:'.:ff ;retorici, altri furono _forse -còncepiti,
ma non scelti, p.i.rr.r.inscritti: la sorte di SH 9gz reri'" d^or" or..rr".. La porrara pubbliciraria di un .L-po'i_.nto di quesrotipo. viene dilatatà,.nel tempo .
".tto ,p"rio, dall,inserzione delmedesimo in antorogi., in^ p"rti.or"ré q,r.'. di destinazionescolastica. Il fatto .hà l.pigrlÀÀ" i"lìiir.r. rorr.li;#;^"r_cora inrorno al|' d.c.'nil circoro à.grì lilpi.g"ri"i"io".ri"ricome noro esempio d^i cerebrazione del"pri".ip."porrJru.' a,supporre che il rèsto^lsse^e'i'."fi;, i. èrarro^fois.
"ncÀe gliepigrammi SH 97g-97g GÌp'tOr, .ànr.rr.rrti uno un,elabo_rata descrizione di,una fonre, l,ri;';" celebrazione del tem_pio di omero, urilizzati *;.;;;.i]i'di l.rrura nel III a.C.,€, rrero sicuramenre; 9.ugl-fo di posidipp. ,"t ,._pìà J Lri_noe-Afrodite Zefiriride iCtp 104);;ó;to privatamente da unTolomeo a Memfi i" ;rt;il.rf" í""i ergpúoerg o cele_brazioni di monumenti patroiin"ti-a"i-f-"giai.
53 V Hn-norc 1983,^pp. 12.5_136. Situ. I l (érgpaotq della statua equesrredr lJomiziano' cfr' I p'a"f ^rg ss.) e III r ri""o
"jl..cle, per ra ricosrruzione delsuo tempio;,cfr. 3 praef l0 s..) .ono .r-ò;;;; à;r;cerimonia d'ln.ulur"rÉre; è possibile che-anche ,i.].-tlt-il Poeta ha.assistito alla
vocasseroil-.;?;;;l;;s",i.;i;";;;;il;.:.dXli.:Ì'f :TTf:ff :f i:':;::",i:
*:h. piir cpigramríi.]1.,_rj_rta ,,.r."-,Íoì,r_.nto, forse opera di un me_qesrmo aurore o risurrato di un .concorso poerico in con.omitlaìt"I". rir",i_"*zione (Ronenr 1948, oo.8l-82). a;Rú''tìì-ip*ir* che 'eregia IV 6 di?ro_perzio' tematicamenre'molto. vicina al'epigr"ÀÀ"tiono,rr.re, sia l,èrgpaorq di undipinto raftìgurante la vitroria aziaca ,ir,l"'- ".ì-f.ipro dr Apollo palatino.
SIL\'IA BARBANTANI
276 SILVIA BARBANTANI
lÌApollo Aziaco a cui il.Poeta si rivolge in apertura del-
I'epigraóma è, con verosimiglianza, materiili,, to ln forma di
stitu"a (v. 2: pvfrps; tutte le apposizioni ai w' 2, 14 sono neu-
tre o femminilii'comm.morant. I'entrata di Ottaviano vinci-
t.r.-i" Égitto, della quale non rimangono però trecce archeo-
logiche. 5i può ttppbtt. che I'epigram-1 P:t Augusto non
63.À à.rri""^to .r.lùrìuarnenre a còmparire inciso sotto la scul-
;;;;, ;" fosse declamato in occasione di qualche solennità
connessa col monumento e il suo dedicatario: I'apostrofe ini-
)irJ, , il saluto finale al dio gli conferiscono un andamento
,r"*"-.tr. innodico, comune ù altri componimenti dello. stes-
so genere, anche se mai così pronunciato (cfr' con la chtusa
de[%pieramma ecfrastico-encomiastico Sf/ 979, o con I'epi-
nr"--f di Catilio Kelssl 975 = BenNeNn 1969b, n" I42, in-
Eiro ,,, un pilone del tempio di Iside a File nel 7 a'C')' ed è
possibile .t. it poemetro -foss.
p.nr"to in origine per la reci-
iariorr. davanti "l
,,torro signoré dell'Egitto in una cerimonia
di benvenuto, o, in sua asJenza, al cospetto dei suoi raPPre-
sen tanti, per €sse re. Po i co n se gnato all' i m pera::it ii, T'^t_9,','^tl;
ne pregiata. II confronto con ll cttato ePlgramma dl LatlIIo '
-oi,o ".rtrb.rarrte dai punto di vista rerorico eppure utilizzato
epigraficamente, suggerisce che anche SH 982 possa essere^sta-
tò èomposto per la dedica del monumento (nel caso spectftco,
urra ,tai,r"); tuttavia, a differenza di quello esplicitamenle 1na-remarico iel tempio di File, che si apre col dativo del dedica-
tario, si pro.l"m" Tp&lrpcr inciso ;u-pietra (w' 5-6) e dichia-
ra il nome dell'autore e il luogo della dedica, in questo man-
cano indizi onomastici . g.og.àfi.i, né il fittizio 'inno ad-Apol-
lo Azio' si propone dichiaratimenre come un'iscrizione. E con-
sueto che gli àpigt"-mi anatematici, sia quell.i.reali sia quelli
letterari ,"à.olti p-rincipalmente nel Vl libro dell'Anthologia Pa-
latina (v. anche'fuor-ioNIn. A.P IX 791, per un tempio di
Afrodite in Asia Minore dedicato dal proconsole c. vibio Po-
5a Kcríoopr novtopéòovtr rcrì dneipcov rpcxréovtr, I zuv\ rep Èr Zavoq
rrcrîpoq, 'EÀ.eúepirp, / òeonótcxt Eùpónaq te r<xì.
'Aoiòoq, tíotpql c",no,.oo,ql'eÀiaéoq, òg otodgp Zeìrg crvétetl,e péyrxq,/ icrpQ èv nétpq to Katíl'toq
cryvòv é0nre/ Yp&frp', òn' 'Al.e(úv6pou òe0po poì,òv nól"rog,/ rai pé1ov
èr peyú?tcov Tooppúvtov, óvòpa òiratov,/ AiyÓnto núoaq rpéptcttov
cryepóva,/ otúÀq Èveotúl,aroev, ív'eiq tóòe vúoo éòe0Àov/ ndq, o poi'òv
ùuvfi tòv 1Oovoq, òl,poEótuv'/ tcrì òè <Dil,at groveOvtt rctf,òv népcq, Ai1ón-
toroi èppi rcrì Ai0tónr,rv y&q 6ptov veútotq,.
UN EPIGMMMA ENCOMIASTICO .,AIESSANDRINO, PER AUGUSTO 277
s.tulo),_si aprano.col vocativo, seguito però generalmente daldativo della-divinità a cui è d;diil; Iigg.ril; I,;;iilìr, .dalla descrizione del medesimo; i" .rri vi è di sorito una di-chiarazione esplicita di intenti ".il"
dl""rione (nome e quari-'ca qel donatore, motivo del dono e invito ad accettare, I,oÈferta), tu*i elemenri.mancanri
".ti'.pigramma lorrdi..r., .h.preferisce insisrere sul rapporto simbitt"i.o tra Apoilo .lì'rrro-narca, ,,Zeus Liberatorer. Lomissione dei consriiri-ifi) ,pi_ff!:l non depone però necess"ri"-..rt.-" rà""ì.'à.rírrili,,"di SH 982 come isirizione,
" -*o-.t. 1or, .;-;ù;;;r.
ill iTlt-: poera alessandrino il diri;;; Ji"ì,gr"j?ril r" ,."r_
locazrone deil'ipotetica srarua ar di fuori del|airbito templarepotrebbe inoltre aver influito suila À"ggio.. lùil --i.ri-tiva dell'epigrammista.
Encomio come inno alk diuinità' del laudandus.
Lespediente di celebrare a*raverso l'esartazione di una divinitàun porenre che da questa.si dichiara.prorerro,,in.ri.na"-q"in_di su di lui una sacralità . ur,orrrilorenza sovrannaturali, èben collaudato dalla tradirione .rr.-o"rii"r,i.a eilenistica, ed èpref.eriqo dai poeti-di.corte.più r;ffì;;ti rirp.tto Ji. i""ìr.-s,tazioni più plareali. di aduràzione (diretta id.ntifi."rior,ì'.ot
:io/, rapqreserrare.dal-noto peana a Demetrio poliorcete. Ti"agrl esempr pru noti.spiccano l,fnno ad Apotto (soprattutto w.26-27), I tino a Delo'e y Inno'r- t;;t-lt cailimaco, a cui si de-ve ag.giungere con verosimiglianza l,fnno a pan di Arato, che,con il.preresro di celebrare"una diviniin t.g"r" J."rì" ii""-stico,. inneggiava i1 realtà al B""r,irúa-d" ;;;;r;; j;;"_
no, ricordandone la vitroria sui Galati." t_irì_".nì";;. "CA
oii_ma dell'era dei Diadochi e degli gpg""i l,Inno ,Ai WrA ,í^_posto da fuistotele (definito i".h. ?;;;" " e"p., .ó:-ò;"L. V 4 e 6; ArH. XV 696ab; D,". í;brm. W t9) finiva percelebrare il defunto amico . -...rr"r. j.i ni.r.i u._i"t,
55 su ce'. Der. v. tra gli altri B'.rc lgg' e M^reun rgg4. su',interpreta-
ij;illfifi ';#r,;,f ffi ;:#m;nÍLlti*:',r"íp;;:il;'Fii;'i.1974, anche r. noìli *ìì""ai .o"ai"ia.é L i.r;'ià".'ji,""l
Ltsrmachia_èBAxrc^zzrpoemaditu",o.F.ì;;;..d1;.in;;;;;;;*;\:'éiff ;iiî;^:ír?nf-ùl
278 SILVIA BARBANTANI UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO .Aì-ESSANDRINO" PER AUGUSTO 279
lil
I
IiitLli rI
illili,ilrillllili
ffii
Atarneo; dalla testimonianza di Ateneo pare il poema sia sta-to pretesto ad Atene per un'accusa di empietà ad_ Arjstotele,
per aver reso onor€ "d
,.tt mortale .o-. "
,r.t dio56.-È possi-
bile che già un eroe della seconda Guerra Persiana (Pausania?
Leonida?)57 fosse paragonato ad Achille, esaltato con un inno
da Simonide nelltlegia sulla battaglia di Platea. Lartificio re-
torico di rendere più dignitoso e meno adulatorio l'encomio'travestendolo' da inno ad una divinità protettrice del kudan-
dus venne assimilato anche dai versificatori di provincia d'e-
poca imperiale, tanto che lo si riscontra addirittura nel caso di
un privaio, nel III secolo d.C.: si tratta dell'encomio a Teone,
benèfattore della nó),rg (P.O"y. VII 1015; GLP 130), che si
apre con una celebrazione di Hermes58, estesa ai nove versi ini-
,î^Ii; l^ stessa mano ha vergato, sul papiro su cui il componi-
mento è scritto, due diverie intestazioni: la prima è 'Eppo0
Èyróptov, nel quale in seguito è stato cancellato il nome del-
la divinità per sóstituirvi un più appropriato eig tòv tiplov-
tc. che risulta essere il titolo definitivo.Laccostamento del sovrano alla divinità è comunque so-
lo a un passo dalla sovrapposizione delle due figure. Anche se
l'uso ufficiale dell'aggettivo 0eîoq per designare .og-getti, istitu-
zioni e persone chè-circondano il sovrano si diffirse nell'eti-
chetta di corte e nel linguaggio burocratico solo in età impe-
riale e bizantina5e, già nèlla poesia cortigiana del primo elleni-
smo il paorî,eóq ólemaico può essere definito direttamente0eóg, come il Filadelfo nell'Inno a Delo di Callimaco' Rispet-
to J culto dinastico, e poi imperiale, diretto dall'autorità cen-
trale, la poesia encomiastica ellenistica può concedersi quindi,paradossalmente, una nappqoía adulatoria pari a quella dei
àecreti emanati dalle nól,etg in onore prima dei re macedoni,
poi degli imperatori romani60: anche se il titolo è conferito uf-
t6 V. SnNroNr 1993.57 Per Leonida propende Pavpsr 1995, per P.ausania la maggior parte degli
altri commentatori. Pér úna bibliografi" recente sull'elegia simonidea v. il numeromonosrafico di Arethusa 29,2 (1996).*58
V. RosERrs 1953, p.274.se V. ad es. KtessLtNG 1969, p. 123.60 Nei culti dinastici ellenistièi, come a Roma' I'apoteosi del sovrano è san-
cita solo dopo la morte. Questo non vale ol'viamente pèr i culti non greci' in cui
i[ monarca àssurqe automaticamente a]lo status divino e può essere venerato. come
oóvvcoq degli Jai. Sul carattere locale, non centralizzaio, del culto impertale tn
Egitto v. DuneNo 1983.
ficialmente nel culto greco-macedone solo a monarchi defun-d, OeoE è designazioné onoraria attribuita nei culti civici a re'benefamori'
ancora in vita, ad esempio al seleucide Antioco IIper iniziativa della cittadinanza milésia. In età augustea, Oeógè usato in tutto I'oriente ellenizzato per tradurre"approssima-tivamente il titolo dl.uus, anticipando così rispetto iil'uro ,o-mano e occidenrale I'apoteosi uffìciale dell'imperarore, posru_ma; Augusto è chiamato regolarmente <ó> eeói già in vita neidocumenti emessi da membri del clero egiziant"(Sg V g070;Plond. II 192,46; PMich. inv. 4343,6)61
Rispecchiando la ritolarura consueta di Augusro nei siu_ram.enti .greco- egiziani, al termine dell'epigr"--I alessandfi noquello che nel primo verso era detto séniplicemente Kaîocrpè promosso al.rango di ZeìlE Kpoviòr1E-XeBaoróq (v. 13j,scavalcando nella gerarchia olimpica lo sresso Apolro, fittiziodedicatario dell'inno, e quindi aÀche il suo lontano predeces-sore al trono faraonico, Tolomeo Filadelfo (in Cnrl.
^Del. l7t
Apollo, non ancora nato, considera profeticamente la lotracontro i Galati62 uno f,uvoq cie0l,og ion il Filadelfo, già de-f in i to Oeog ú_ l , l ,oE a lv . 16 í ; in pnop. M,37-54 Apo i lo , g iàadulto e combattivo, esorra ottaviano al combatti-Énro . "gli
dichiara la sua protezione).
. In q.uesra testimonianza greca di elogio imperiale, che cre-do una delle prime, figuranolutti gli elJmenti^tipici dei futu-ri encomi. poetici latini (lode delle impr.s. dell'imperarore, pa-ragone e identificazione con divinità,-descrizione dell' adueitusche porta prosperità), ma la titolatura divina attribuita ad Au-gusto, a parte appunro Eepcro.ró6 che fornisce un terrninus po-st quem per il componimenro, non è ufficiale (nemmeno i'e-piclesi nZeus 'fl"eu0éptoqr,
ricorrente in formule epigrafichee di giuramento), così come sarebbe erroneo consiàeLre un
6r V. DuNaNo 1983, p. 49.; 'S(/HrrrnonNn
1992, pp. 42g-430.62 Da Pnop. II ll risulta che le porre del tempio'ài Apoilo pa.latino raffigu-ravano su uno dei batrenti la strage dei Gajati a Delfi, imprèsa comoiuta dai ire-ci con I'aiuro del dio, e che Tolomeo II si amribuì il meiito dl
"".L *-oi.t"ro,
con la repressione della rivolta galarica del 278. Gli impii n.mi.i .o..irnJndor,,agli c,oepeîg, ai 0eoîorv èX0poí ostili al faraone (v. KorNru 1959, pp. ll0 ss.;.1968; 1970; 1983, pp. 174 ss. e 1993, pp.8l-83). Nella t."dirion. .'óiana i ri-belli al_sovrano sono croepeîq affìliari a TifoneiSeth (poxy. )o{ll 233í,10: oraco-Io del vasaio, ed. Kor,Nr:N 1970 e 1968). sulla frequenza-dell'immaeine della Gi-gantomachia in relazione ad Augusto nella poesia latina, eredità dJiln l.tt.."tu..cortigiana ellenistica v. \fiano 1933, pp.205-2ll e Hnnorp 19g6, pp. g5 ss.
280 SILVTA BARBANTANI uN EPTGRAMMA ENCoMLASTtco "ATESSANDRTNo' PER AUGUSTo 281
oCombattente sul mare, signore, che Azio proteggi,/ delle ge-sta di Cesare monumenro-e di fauste fatiche testimonianza,/tu, dalla bocca dell'Eternità celebrato - per te infatti di Ares/i colpi <egli> acquietò e lo strepito di scudi,/ quando, rronca-ti i tormenti della Pace bel viso,/ alla terra del Nilo vennegioioso6a,/ del fardello del Buon Governo e della Prosperitàdall'ampia úcchezzal carico, come Zeus Liberatore65;/ con ma-ni generose di doni accolse il Nilo il sovrano,/ e la sposa conauree braccia lavatal dalla pioggia66 pecrfica e serena di ZeusLiberatore,/ perfino il nome della guerra si spense del tutto./Salve, beato Leucadio, che unico e bello presiedi/ alle impre-se vittoriose di Zeus Cronide Augusto>.
Lelegia si apre con un invo cazione innica ad Apollo6T nsignoreche combatte sul mareD, con i suoi attributi di protettore deltempio di Azio, ampliato e restauraro da Augusto dopo la vit-toria navale del 31 (Srn. IV 192,b,2; Dro LI 1,2 ss.; Sur,r.Aug. 18,2; presso il santuario di Apollo a Nicopoli, di frontealla penisola di Azio, si tenevano i giochi Aziacr68, a comme-morazione dell'evento), e di restimone e cusrode del ricordodella vittoria, e si chiude con il saluto indirizzato alla divinità,ancora in stile innodico (26aîpe; cfr. ad esempio Tsnoc. Id.XVII 135; Cau-. Iou. 9l; Del. 325): così Callimaco aveva in-
6a Lunica alrra occorrenza dell'aggettivo yqOoÀéoq è in GDRK II n' IXII76 (ricerta di Andromaco a Nerone).
65 Plce FGE, p. 485 interpreta úÍe come causale: uinasmuch as he is ourZeus EleutheriosD, menrre in GLP 113 preferiva la traduzione qui proposta.
66."OpBpov è accusativo interno di l,ooopÉvq (Page); i[ parricipio è nellastessa sede metrica in A.P IX 615,2 (ANoN.); XI 58,4 (MacEo.); KI 116,2 (ANoN.).È possibile però che si debba sotrintendere un altro èòé(aco (cosl traduce Koe-nen): mentre il Nilo uricevette, il sovrano, la usp654o, in corrispondenza con I'ar-rivo del nuovo re-Zeus Liberarore, nriceverreu una prodigiosa e bèneaugurante piog-gia, simbolo della benevolenza divina nei confronri del nuovo territorio conqu.isra-to e della cessazione di tutti i conflitti. "Aòqpq, propriamente ,,senza conteie, (lr.LeoN. l.? WI 440,7, cfr. 1i. XWI 42) forma endiadi con cr,ntól"epog, aggettivopresente già in Il. II 201, IX 35, 4l; cfr. A.P IX 323,5 (ANrll.).
67 Si noti però che il rituale ctvcl, epireto divino fin d.agli Inni omerici, rife-rito ad_Apollo al v. l, è il termine con cui si designa Augusto al v. 9.
68 Sui due santuari elalocalizzazione dei giochi, v. GacÉ 1936, pp.5l ss.(cita I'epigramma in questione e p. 57, ma lo ritiene rroppo vago per idèntificareil monumento a cui si riferisce, ad Azio o a Nicopoli); Gunvar 1995, pp. 65-55.
I.ff"'H :m;:m:.'àr ;x.":il:"f,Ti#I'. i',:1a: soro con Augus'ro di-
semDlice riflesso della titolatura ufficiale gli epiteti e le espres-
sionì .ncomiastiche presenri nei componimenti alessandrini
per i Tolomei. Il culto di Augusto come divinità, da solo o con
îa de" Roma, nell'Oriente el-lenizzato non venne organizzato e
diretto sistematicamente dall'alto, e I'associazione in vita del-
I'imperatore alle divinità fu un prodorro dell'iniziativa indivi-
dual'e . di singole istituzioni o-città. Il vocabolario dell'epi-
qramma augusteo, come quello degli encomi ellenistici, va
Eonsiderato i,rrrq,r. ninoffizielle Titulaturn63, ispirato Prevalen-temente al linguaggio epico e innico.
Il testo.
Il testo dell'epigramma qui Proposto, verificato sul P.Lond' II
256, si discotà solo minimarnente da quello di Parsons e
Lloyd-Jones. Ho Preferito dare rilievo con la maiuscola all'e-
pitéto di Zeus ai w. 8 e 11 e ai nomi delle personificazioni'
"Arnov aplqréncov, tiva v]crtpú1e' Kaíoapoq épYaY'pvîps roì" eòlt]plfarv pcrpcopír1 rcapútrov,
Aióvoq gttlépggtv BeBoqpéve - ooi yùp "Apqoq
dl"úlTlpaltct rcrì ocrrÉrov èotópeoev núrcr1ov,5 Eip{vr1g pó1Oooq eòóntòog évOc rl.aòeÓocrq,
yîv èttì verl.Ótrv vioe<to> 1q0ul.éo6'Eòvoptíîllq <póptotot raì EùOeviqq pu0onl'oótoo'
pprt0ólpevog pó(qv Zebq &r,' 'El.et0éptoq,
òropogópor6 òè 1épeootv èòélato Neî}.oq óvurtct,10 rcrì ò&pap f1 lpugforq n{1eor lotopévq,
udtlól.epov raì óòrptv 'El.eu0éproo
{r$5 ópppov'àtperèq èopéoOn ò'oóvopu raì 491.épou-,
1crîpe, púrcp Aeur&,tc, Aròg (pqvi6ao EeBcroto0,y16aíolv épyorv Èv npr:túveopa ral.óv.
1 ap[grénoiq, aptgrnó].et Veil 2 pcrptupirl<v> Weil 4 dveúltaltcrBiicheler 5 pó2g0ooq' ntopOooq Veil; póo1oog Alfonsi 6 vrl'rotrvpap.; vioeo Veil 10 2gpóoeov, n(1etq Veil 11 el.euOeptov pap'rEiet0epíou Kenyon; ót Fp..o \Weil 12 cttperèq' veireoq, \7eil; rcri'
ndv Búcheler 13 rpovetòuo pap', eadem manu e peyaÀoro correc-tum.
6r OpEI-r 1960, p.46.
li-
282 SILVIA BARBANTANI UN EPIGRAMMA ENCOMTASTICO ..AIESSANDRINO" PER AUGUSTO 283
castonato l'encomio al Filadelfo nell'Inno a Delo, riverberandosul monarca la gloria della divinità sua protettrice. Augusto se-gue quindi, come Tolomeo II6e, la consuetudine del rapportoprivilegiato sovrano-Apollo, che si manifesta soprattutto nelladistruzione dei barbari nemici del dio e agenti del Caos: nel-I'epigramma, ai Celti come nuovi Giganti ostili ad Apollo e aZeus si sono sostituiti i tumulti della guerra civile e, qui nonricordati esplicitamente, come invece in Aen. VIII, i teriomor-fi dèi orientali protettori di Cleopatra e Antonio. Il dio è in-vocato, oltre che come alleato in battaglia, come custode del-la memoriaTo, in quanto immortale guardiano del luogo(cxpl<pténrrlv) in cui si sono svolti gli straordinari eventi chehanno condotto nCesareo alla uterra del Nilor. Il tema dellamemoria del successo militare, qui amplificata col richiamo adAion, I'Eternità, è presente anche in Properzio III 11 (cfr. w.6l: monumenta; 63: testatun 72: memor, e soprattutto 69: Leu-cadius uersas acies rnemorabit Apollo) e IV 6 (I7: Actia luleaepelagus monumenta carinae, 67: Actius binc naxit Phoebus mo-numenta), con riferimento però non a una semplice effige deldio, ma al tempio di Apollo Palatino e aJla decanea offera aItempio di Azio. tElegia IV 6, come I'epigramma del papirolondinese, celebra la divinità in funzione di Ottaviano: I'inter-vento del dio nella naumachia è introdotto al centro del com-ponimento come s,ittov dell'edificio consacrato da AugustovincitoreTr, a ricordo del suo successo, il tempio di Apollo Pa-latino. Non è escluso che il tema della memoria fosse sottoli-neato dall'epigrammista in quanto la statua che forse lo ispiròsi trovava presso lo stadio dove si svolgevano i giochi quin-
6e Cfr. GosuNc 1992.70 Mvflpa: in questa sede metrica, generalmente in esametri, è frequenre, ma
con il significato di utombar, <monumenro sepolcraleu, ad es. in A.P Wl 45,1;165,3; 208,1; 478,3; 594,1; N 4,6; 7,7; solo in Y7 140,2 indica un monumenroper una vittoria corale. \Weil preferisce considerare l' "Artrov iniziale come agget-iivo di pvffpcr. Maptopiq, piir .^.o rispetto a poptúptov, è nella stessa sede"ire-trica in A.P | 87,2; VI lB,2 (Iur. Arcwr.); 147,4 (Cnu.); fr4 279,6; c[r.nputóveopcr v. 14.
7l GuRv,qr 1995, pp.256-257,277-278, tende a sminuire il ruolo di Apol-lo in questa elegia di Properzio, in polemica con Catms 1984, che interpreta IV6 come un canonico inno alla divinira, secondo le orescrizioni ooi canonizzate daMenandro Rerore, e destinato alla recitazione nel tempio di Apollo Palatino, difronte ad Augusto e il suo entourage.
quennali fondati da Ottaviano nelle Nicopoli d'Epiro e pressoAlessandria, a commemorazione della vjtioria. La pr.oJ.up"-zione di erernare nei posteri il ricordo della benefirèn ^ ausu-stea, attraverso un prowedimento più duraturo di una selm_plice opera d'a*e o ài giochi periodìci, è anche il movente deldecreto del rorvóv asiatico óCtS 45g (v. oltre, p. lg3).
Si rievoca come úascorso (víoecto)), ma nàn da molto,{ato 1l rono speranzoso e la vivacità del quadro, I'aduentus diOttaviano, pacificarore vitrorioso, yfrv èn[ ver],6Trv: I'esDres_sione potrebbe richiamarne una analoga celata nelle lacune dit4_2.69 (v, 2: Tcxîlqv 6r' ètg Nleil.oo, integr. TrRzncur1957), papiro del III secolo a.C. conren.rrt. qtràllo che sem_b^ra un carme fipoogovnîrKog per uno sffarego vincitore diritorno nella nrerra del Nilor, o Lr,
"nnuncio d"ei suoi più re-
centi successiT2. Lanastrofe della congiunzione rrova pràeden-ti in CallimacoT3 e in Il. ]VJrI73, mi se ne hanno esempi an_che in componimenti grecoegizi di valore non eccelso,
^.o*.
in BrnNaNo 1969b n' 158 It (da File, età augustea), vv. l-2:Nfroov .€(g):. / ...&g(úp€vor, v. 5: ycxîuv éq flperépr1v ol,'Inyo al Nilo ripubblicato dalla CnrsroRl 1995 (pi, ll1',
". S,
€n€íTso orlv enì. yoîav.Non si nasconde la difficoltà dell'impresa cosmica com-
piuta da Augusto (épycr, rópcrror, pó10òt, góprot, Bpreó_Bt-yoq), owero la cessazione delle guerre civili e il ripristinodella normalità, anzi della prosperió, ma si sottoline" il lo.ocompimento in linea con il destino e il favore degli dèi (Aion,v. 3; eùto1éov, v. 2). IJaccenno a Kcrpúrta'v (v."))t< è spessoPt:t.Lr._ in epigrammi encomiastici per personaggi eminentinel _V-VI secolo (mancano purtroppo le tapp. intéimedie, do-po il I secolo), insieme ad-altre espressioni^simili come pó1-Oot, nóvot75, a designare generalménte le opere virtuose in pa-ce e in guerra che hanno meriraro al kudandus il monumàn-
_ 72 Mi riprometto di esporre in altra sede un esame dertagliaro del frammen-
to, che con SH 958 è srato oggetto della mia ricerca di dotto.?to.73 Fr. 43,15 Pprrprpn; Del. 195, Cer. 123; SH 254,4;cfr. [-qpp t965, pp. 45-47.7a fl gen. plur. torna in gy:*-di pencamerro in A.pW r r,< tiirri.tiiO,z(Macpo.); 65,|2 (Ptur. Stt.); _73,4-(\1eceo.); 95,6 (ANrr'H*.); 28i,8'GE;Li;UI
321,2 (ANorv.); ' \4Il 153,4;tX7,6 (lut. Por.);675,4;W 31,4 didl; òou"*I 254,2 e Íl 324,4.
7t RospRr 1948, p. 2l noce 3.
284 SILVIA BARBANTAN]UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO "ATESSANDRINO"
PER AUGUSTO 285
ferita dalla magsior parte dei commentatori, come anche dachi scrive, poicÉZ, olire ad evitare problemi grammaticali e fi-lologici, créa un'armoniosa composizione ad anello (epiclesi adApollo - aduentus del princep.r pacificatore - saluto ad Apol-lo), sottolineata anche dalla rispondenza di épyotv al primo(Kuíoopog... épyov) e all'ultimo verso (vtrcírov épyrrlv), lenimprese, vittoriose del comandante che, già secondo i princì-pi della regalità ellenistica, ne giustificano il potere e ne ga-rantiscono il rango imperiale. Malgrado l'affermazione di \ilZeil
(1895, p. 180: (comment expliquer le pronom ooi au vers 3?Ce n'est pas pour Apollon qu'Octave remporta la victoirer)7e,la poesia postaziaca e la leggenda politica alimentata da Au-gusto e dal lealismo dei sudditi, specialmente orientali, cerca-rono di dimostrare proprio come la vittoria fosse dovuta allaprotezione di Apolló, che già Ottaviano aveva cominciato adassociare alla sua persona, seppure in sordina, prima del trionfodefinitivo sul rivale
'dionisiaco'Antonio. Ioí andrà quindi in-teso (per te <o Apollo>)) o nin tuo onoreD; il soggetto sarà Ot-taviano. che mette fine all'infuriare di Ares ristabilendo la Pa-ce, tema ricorrente nella poesia, anche epigrammistica (PHrl-.A.P lX 285, W 236), augustea.
Augusto come Zeus Liberatore: I'esito romano-egiziano della tra-dizione ellenistica dei Buoùeîg <saluatori>.
I nove versi che costituiscono il nucleo dell'elegia sono dun-que dedicati all'encomio di Augusto, mentre la chiusa, comeI'invocazione iniziale, è innodica; tuttavia, la figura di Apollo,che nelI'incipit era esaltata con una sequenza di espressioni al-tisonanti, negli ultimi due versi, pur rimanendo il soggettogrammaticale, è decisamente sminuita dalla Presenza di nZeòqKpovi8'4g EeBao'tógn, direttamente accostato nello stesso v.13, ua I'altro, al semplice epiteto apollineo pórap Aeur0to.Malgrado I'ossequio alle formule innodiche, la divinità che ri-salta in questo componimento è Augusto, che ha dissipato le
porlpéve ad Augusto.(v. S( add.' p. 863: *peBolpÉve enim de homine, non dedeo dici exDecraveriso) e sull'integrazione crp[gtnó]"et.
-" Garrr 1952, p. 151 accerta I'ipotesi di \Weil per quanro riguarda I'identi-
ficazione di ooi con Àrrg,rrto, uè per te che <Apollo>-calmò la r.-"p.rr"...u.
to onorifico: v. TAM II 187,11-12 (Sidima; per Tàziano, pre-fetto d'Egitto e consolare); SEG II 377 (Apollonia d'Epiro; perVittorino, un governatore giustinianeo); A.P IX 658,3 (Paur-.Sn., per Domnino); A.P n/7 32,4 (LeoNT., su un ritratto diGabriele prefetto di Bisanzio); 37,2 (LroNr., per il prefettoPietro: i simboli del suo porere sono púpîùpeg fióvov);43,3(anonimo, per Damocari, governatore che aiutò Smirne dopoil terremoto del 551); 46,2 (elogio anonimo di Niceta[6,353,2 e 4 (per la statua dell'auriga Porfirio), 367,6 (per la sta-tua dell'auriga Costantino); gli epigrammi di Efeso per il pro-console Messalino e per EutropioTT. Limmorralirà degli épyodi un cittadino benefattore, a cui è stata dedicata una srarua,è esaltata in Katepl 909a,3 (aetpvrlo'rorg ènì ép1org) nonmeno sonoramente delle imprese imperiali.
Linterpunzione e il destinatario dei vocarivi non sono deltutto perspicui: BeBoqpéve sembra riferirsi ad Apollo, comeXcrîpe, mentre il soggetto di vío'e<ro> sarebbe Augusto (\íeil,Parsons, Lloyd-Jones, Koenen). Se invece BeBoqpéve e víoeosono indirizzati entrambi ad Ottaviano, si dovrebbe integrareapf<ptÉnorg, considerare "Arttov un aggettivo, e accusativopcxpropíq<v>, apporre un punro dopo Ko(púTCIv e riferireèotópeoev (stessa sede metrica per Èorópeo'cxv in Pnrr. A.PIX247,2) ad Apollo (\X/eil)78. La prima soluzione è quella pre-
76 È un encomio al vincitore dei Persiani, che richiama la tradizione dei Gre-ci-del periodo classico (cfr. nota 41): Nrr{to òopito}"pov óva(, otporóq, úoteo,
QîFoq/ otfioav ònèp peyól,ov Mr1òogóvov rapút<ov. Nicèta, collabóratore diEraclio prima e dopo la sua salita al potere, pamecipo alle sue lotte contro i Per-siani nel 622-630.
77 Per Messalino: MrrrNrn 1960, pp. 276,283-284; RosERr 1961, nn" 53G-537; per Eutropio: J. & L. RosrRr 1942, n" l5l, p. 356.
t8 Interprero il vocativo peBoqpéve come riGriro al dio, come Koenen inTnovrson - KoEt'tEu 1984, p. 126 nota 34. Veil integra ap[qrÉfiolq e corregoetrrapn-rpíq .in .paptupíqv, ,orr.n.rro poi da G,rcÉ : gl?, i.-i-e,- iiii.'". .f,. 1iF-poqpéve alluda agli oracoli diffirsi all'epoca della vittoria e che virsilio Fa risalireai tempi di Enea: (car c esr pour roi, héios annoncé par les voix de lÈternité. ouA-pollon calma la rempére d'fuès...' (con vocarivo rifèrito ad Auzusto). BeBonrl.évepuò anche significare, oltre che nannunciarou (nel senso di "próisto,;, n.ll.brrrouin seguito alfevento -compiuto (Keydell, cfr. Koenen: nyou iApollo>'whose nameis on Aioni- lipsn): cfr. altri passi che indicano individui o fatrì eià awenuti e di-ven^uti poi famosi: Aclnar. A.P Wl l3B,l: "Erctop 'Oplpeilotrí
oeì Bepo4pévepipl,orq; con A.P IX 20,3, su un cavallo vittorioso Neuén desonuévoc; con KV4,3 (iscrizione funebre a Nicea): & tov evì. (ooîc BeBoaubuou idbo,púnrcr,v; conGDRKI n" )OO(V 57: peploqpévto1v 'El,l"ú6r yainc. A'p"rr. quèsti esempi poe-rici, iI participio è usato perlopiùr da tardi prosatori (L-ib"nio, Sinlsio, Giorgio Mo-naco). Arrousl 1950, p. 74 concorda con \Weil sull'attribuzione del vocativo pe-
286 UN EPIGMMMA ENCOMTASTICO .ALESSANDRINO' PER AUGUSTO 287
li
I
incertezze e i travagli delle guerre civili. Che questo elementosia determinante nell'accettazione del nuovo sovrano è eviden-te dall'enfatico e insistente richiamo alla pace, attraverso la ne-gazione del suo contrario (vv. 3-4; pó10ouq... rcl.oòeÓoaq v.5; ix-nróXepov, ó-òqptv v. 11; èo'Féo0q ò'oÓvopcr ruìnol,Époo v. 1280). Era questo, come si nota già nell'inno iti-fallico di Ermocle a Demetrio Poliorcete (CA, p. 174, v. 2L:eipúvnv noíqoov), il miracolo generalmente richiesto -ai po-tenti in condizioni storiche pariicolarmente travagliatesr: nelperiodo ellenistico, la protezione accordata da un Btxo-tl,eÓgalle nól"etg, con I'impègno ad arginare le scorrerie dei barba-ri (soprattutto Galati) e degli indigeni, o gli attacchi di po-tenze
-rivali82, faceva scattarè regolarmente il meccanismo dei
culti locali, con I'attribuzione al benefattore di epiteti qualiEcoc{p (conferito dai Rodii a Tolomeo I; attribuito ad Antio-co I e ad Attalo I; Antigono Gonata è celebrato come ocoîúpcon ioo0óotg npaîg in-unepigrafe di Ramnunte scoperta nel1992$), non necessariamente legati a una titolatura ufficiale o
80 Per I'inversione di rctí v. KnosLL 1934, p. 423 e cfr. Od. IY 710 At.Rrroo. III 679, 1092; un'esgressione simile è,presenìe nell'anonimo A.P XII 39,1'2 (èopéofi Níravòpoq,, ctnéntato nGv crno 1potflq,/ tiv0oq, rcxi 2gcrpíttr:vl,otnòv ét'ouò'óvopa). Oóvopo compare nella stessa scde negli epitafi, ad es. Kat-stt 614,6; 297a,6, p. 524: rorvòv életv è0él.ov oìjvopa rcaì 9avarov. laf-fermazione di un principio positivo attraverso la negazione del suo contrario è unprocedimento ur"io
"n.h. iel brano degli Oracula"Sibyllina nor.o come uOracolo
àeila Aéonotvcr', lll 378-380 (v. nota 18); nell'ent merazione dei benefici attesidalla nuova era, la profezia è molto simile a SH 982, che però constata un muta-mento gla awenuto.
tlBovsnsocr 1965, p. 139 cita I'epigramma alessandrino su Augusto cometestimonianza della npolitical obsession oF the ager, il ritorno alla normalità.
s2 V. HasrcFrr-1970, pp. 83-85, 9l-99, loz-tol, 156-159 e 1973, pp. 85-88 per il culro personale, inìèlazione alla protezione dal nemico o a particolari be-.r"ó"r".rr" ,retsò le città. Sulle virtir del dinasta ellenistico testimoniate dai docu-menti epigrafico-papiracei, tra cui I'ameggiamento benevolo e salvifico v. ScHUoART1937. pp. 13-15.
83 HastcFlt 1996, pp. 132-133 e 1970, pp. 65-73 ritiene che anche I'epi-erafe di Ios (1G Xll Suppl. 168) celebrante un Antisono come &otúp sia relativai Go.r.t" e non al Monofr"l-o. Il decreto di Ilio óG1S 219,36-38'il1'inizio delregno di Antioco, reca già la dicitura eòep1étr1v rcrì o<rltfrpot; per JoNrs 1993,p. 92 I'epiteto uSalvatore, si riFerisce ad uno scontro con i Galati già nel 278, pri-ma della'battaglia degli elefanti'. Il culto della Lega Ionica per Antioco I è atte-stato da OGIS"222 (i6819)i egli è orotÍp anche à Teo (26àll) e Bargilia.(Syll.3426); a Seleucia in Pieria (OGIS 245,11-12) pare venereto con Apollo ootqp: an-che in De hps. in sal.9 Luciano gli attribuisie lo stesso appellativo. Sull'epite-to v.ancl:.e ASA4S-$, qqz,St ss. (Aniioco III porta la pace e^là libertà a laso); oGlS56 (decreto di Canopo perTolomeo IID;1GXil 5,'557; Sytt.3 760 -(Cesare osalva-
tore'dell'umanid'). èil^in eta classica si ebbero alcuni prec-edenti, cfr. Tnuc' V 1l(Anfipoli dedica un culto eroico a Brasida come orrlt{i).
al culto dinastico. Tha i Romani filelleni, già T: Quinzio Fla-
minino aveva ceduro alla tentazione ellenisiica di sfilare ua ali
di folla a lui plaudente come Ecotùp Kcrì 'Eî'EÙOéptoq' nel
ile, aopo i" irro.l"-azione della 'libertà' dei Greci.aigigchii"Ài.i irtu. >oo(tV 50,9: seruutorern kberatoremq.ue)aP' C-y;
nelio Lentulo fu proclamato oorúp ad Acraifa nel l7l-l67on'
."À. C..itio Meiello Macedonico a Tessalonica nel 14816 (in-
tesr. in IGX}I134, Syll.3 680), Cecilio Metello Cretico a
PJlirrenia ne 6917 (LCrit.Il 252, n" 14), e Cornelio Lentu-
lo a Cirene (Syll.3 750)- - ó"ti i prÉcedenti, non ci si stupisce della profusione di
"pp.tt"ri"i silvifici attribuiti al vincitore di Azio, non solo nel-
Itoinr"-* a esiziano, ma in documenti epigrafici in tutto l'O-
r i " ' " r? . f i . " i .o?5. In un ' iscr iz ione d i Mir in i , IGRMlT3 (9
*ó.i, 'i esalta il dio Augusto ùnèp eipfvqg c,90crglÎq- -lP:-Aususta\: nel decreto di i4itilene 1G XII 2 58 (= IGR IV 39=
'òCtS'+56; ta il27 e l'11 a.C.) si decantano la rcpoOupicr
. ttó"Zprtor di Augusto; in OGIS 458 si stabilisce un calen-
dario di onori da ,.ider. al benefattore, diffuso in diverse cittàr
dell'fuia Minore, per iniziativa del proconsole P' Fabio Massi-
Ào86: Augusto è àefinito nelfampolloso Preambolo' che pure
non lo .hlama Oeóg, come colui <che ha dato un nuovo ?sP9t-;; ;;.o, ,"It"ído h vita del mondo e dei singoli' Il vin-
citore di Azio è salutato in varie iscrizioni, in oriente e in oc-
cidente, come colui che ha restituito la pace (Per. ter-ra e PermarertT: la chiusura del tempio di Giano (gennaio 29.a'C')
sancl simbolicamente I'impreia'cosmica' di-Augusto: Apollo
stesso, in Pnop. IV 6,37, riconosce Ottaviano come rnundt ser-
ahtor, oweîo x<otf1p.ijú;"gitt. dèi monarca salvatore, così popolare in futa
Minore, venne ProPosta anche in Egitto' Durintè le ultime fa-
sa Fr.yr.L 1955, p. 419 n" L.8t Delle iscrizioni gr..o-""i",ith" che celebrano Ottaviano-Aug-usto come dio'
,r. ,rn.l.r,.o in Tanon ítti' tP' 270-283 e in T'cEcen 1960' p' 187 nota.3'-188
;;.l.;ffi:;p*. "1.*-i" zéir-ltt 3 ed. minor3237;vz 424,425;604; 1288;
XII SnPPL 4l''"'""{dí fr"rrr^.rrti delle redazioni greca e latina dell'editto sono raccolti e com-
mentati da Ldrn 1967 '"*"*;; f;;r"f. del Foro Romano in GecÉ 1936, pp. 80,91; GIBM-IV 894' So-
,ro *.t,. i"'-le dell'iscrizione del monumento a cielo aperto eretto a Nicopoli po-
co dopo la vittorra azraca (Munnav-Persas 1989, p. f Zd). Sulla formula u. Movr-
ài*ì51saz' Gaucen 1984' pp' 277-282'
I
288 SILVTA BARBANTANI UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO "ALESSANDRINO' PER AUGUSTO 289
si della guerra civile, in Orienre si erano diffusi oracoli di ca-rattere messianico, non solo nella cultura giudaica, ma anchetra i Greci fautori di Antonio e Cleopatra, nella sressa Ales-sandria: è probabile che anche Ottaviano abbia proweduto adiffondere testi, o almeno voci, che dessero espressione alle at-tese dei suoi sosreniroriss, anche se dopo la vittoria egli feceprudentemente bruciare parecchi libri di profezie. per*far di-mendcare al trionfatore il sostegno offerto dagli Alessandriniai suoi nemici, I'epigramma per Augusto pr.r.ttra il nuovo do-minatore con gli stessi tratti di sovrano universale e salvificoche avrebbero dovuto caratterizzare nell'oracolistica la sfortu-nata coppia erede del Iegno tolemaico. In linea con questa vi-sione teocratica, lo stile del componimenro, come qúeilo del-la poesia encomiastica ed epica egiziana successiva, è ridon-dante di immagini (piu*osto gtottès." quella del vincitore chegiunge appesantitose dalla soma del Buon Governo e della pro-sperità), meraforee0 e iterazioni (la duplice menzione di Zeus
.^ ^ tt
Y GncÉ 1936, pp. 78-80. Per Tanr.r 1932 il frammento del III libro de_gh .Uracuta S;ibyllilg (w. 350 ss.; cfr. fll 75_92) d.etto nOracolo della Aéorcorvctu,è,rrterrto^forse a- ̂c-leopatra (scettico Genacr 1983, pp. 72-79: d'accoido invece lawvrcr 1994' p. I03), come firtura pacificatrice e dominarrice del mondo, oorratri-ce di'opóvotcr tra orienr.e e occidente; I'oracolo prefigura unetà dell'oro'cararre-rizzata non ranto dalla fertilità naturde,.quanro dal_lascof,parsa dei mali (òuovo1r,",neví', etc.), che è anche il risultato dell'a'vento di Auguiro secondo sH 9gz.'8e Si noti I'insistenza sul concetro in góptoroti ppt(ópevoE ptgnu. Naf"quotidianità egiziana, I'immagine richiama queria dei baiLlli larich"l ai l.r.dì
'.n.
percorrevano il.Nilo fino ad.A-lessan_dria. Bpi0opev- è frequente all'inizio d'esame-tro nei poeti dattilici (F-siodo, Apollonio Rodio, Teocriro, No.rno, euinto Smir-neo), si tlova in iylipit di verso ià Karaer_ l028,l8 (Andro IV *..t1,ìr,a.-BóiàO_peva ^oopapoig èl"tvótponoE [ev n],orúpot9l; A.p XIV 3,1l.
"
" Xtopévvupr^(v. 4): l,.appianareo, forse con richiamo al mare burrascoso,non solo quello metaforico della guerra (i dveópoltcr di Ares, nella parte aJv."-to tempesroso' secondo una lezione che non condivido) ma anche if mare d'Azio,tormenrato dal maltempo per.alcuni giorni prima della barraglia. xl"uòcúrrr (v. 5),letteralmenre (p.orarer: con^la lezion-e.ntóp0ou.6 (accolra da póvrr-r r933: npruningoff rhe sprays of fair-eyed Peaceo), \ùveil intende proporre I'immagine del rarno d'olttvo,,srmbolo dl pace. Alfonsi inrerpreta il verbo con significato èausativo, ufar ger-mogharer, e pone come oggeno póo1oo6, ugermogliu,-a questa poetica metafoia èpreferibile però pó1Oooq del papiro, che, seppur nieno ra-ffìnato, richiama i termi-nl dl fatrca,e,storzo dei primi due versi e sottolinea I'angoscia provocata fino a quelmomenro d,all.e guerre civili, che ancora pervade I'epigrairma; iconfronti ,opr" pro-posn con alrn eplgrammi encomiastici d'età imperiale inoltre sosrensono la lézio-ne del papiro. I a più antica arrestazione di rltaòeúal è in Esopo. Si iori |uso del-l'astratto nputúveupa (v._ 14) per nputúvrq (per gli edirori àer sff nel senso di(o povo€ îTlv vtKnv òtotrrloaq>)t nputúveupcr si trova piùr oltre solo inTHropuvt-. Srrraoc. I1zir. IV 4,8, menire nputúvetov e nptrúvrg compariranno fre-quentemente come merafore negli encomi in prosa (cfr. PEnNor 1993, p. 419).
Liberatore). Notevole è il ricorso frequente alle personi0rcazio'
ni, in armonia con il gusto letterario dell'epoca' ma anche tn
sintonia con I'epica diéascalica esiodea e le.più antiche.elegre
civili della storià eflenicael. Nell'arte figurativa coeva sPiccano
f. O.rr""incazioni degli stessi concettilsaltati in SH 958, ad
.r.,i"pio nei rilievi deiYAra Pacis,la simbologia della.TazzaFar-
nese ìn particolare è stata accostata all'epigramma in.questto-
ne da TuoupsoN e KopNgN 1984, che interpretano il manu-
fatto come un allegoria dell'awento di Gallo, Prefetto d"E'gtt-
;;, i" qualità di iittolemo-Horos, similmentè al ritrano di
Augusto portatore di fecondità in SH 982'
Le Personificazioni: un quadro dell' 'EtA dell'Oro"
Aióv, I'Eternitàr, sPesso Personificata nell'iconogrlfia "1"]t-
smatica tardoimperi"l., q.ti assume il ruolo della Fama dalle
-olt. bocchee2 É gararrtisce Per semPre la funzione di memen-
to della vittoria assunra da Apollo, iotto forma di statue o di
teÀpfi ed ex-uoto a lui dedicati. Aiòv fl]'outóvto$' secondo
I'oracolo di Ammone aftesraro dù Romanzo di Alessandro, è le
ai"i"i,l che presiede al luogo dove Alessandro fondò la sua ca-
pitale eeiziana (Ps.Cer-LISr;. Vita Al.Magn' I30,7;.33;2): no-
;;;;";:-ii ;."ori"o di Altutdi di ricostiuire una 'teologia' di
Aion risalente al periodo tolemaico, tuttavia, non esistono con-
f*À. .fi."istiché di un culto di Aion sostenuto già dai prlmi
iagidi ad Alessandúf3, e cerramenre I'accenno di Sf/ 982 è
trópo fugace per suffragare le ipotesi dello studioso tedesco'
A pàrtire -d"lla-fondarione
dell'impero, Aion è presentato co-
eÌ Cfr. Sor. [r. 4 Vrsr, con la personificazione di Eùvopia' Ar:ovolticr e
nirn. Suir"ppo.. ai n""o-i" .." ft itre virtù civiche' v' Kplr- 1916' pp' 39-44'- ' iz >.d1ioo,u pO
"g... *.ne un_plurrle poetico, cfr. TslocN.240; SIuv'
A.p\,11203,2; M.qr.c. A;.; . t IX 87,6;Ar. Rgbo. IV 1607 (Page)' Aion.è ban-
ditore dell" fama fr.rtura in BewaNo 7969a n" 57,1-2: Aítiv KÎ1pot91 tnv 91-
ilú;ó-""ì 9*ea.l",ià" l.ìlì-p.ii.t., epitafio di Serapous). sull'iconografia
di Aion v. LE Guv 1981'e3 Non tutti i manoscritti dello Ps.Ca.llistene concordano sul quarto ver-so del-
I'or".olo, qi-"p".aen"'Aiòv ;Iì'ootóvroq 'òtòq ùvúoocov; v' ArpÓrot 1977 e
ìó7S, .].fr;*,o .n.rgi."*.r,te da Z'Nrz t-9SS; .fi. ID..19921 soPrattutto pp. 29-
33. Ii culto misterico di Aion ad Eleusi è attestato già nel I a'U' da una dedrca Prr-
íí*.'a" ""ri.
di un Romano W.i ttzl)- Sulle Feste di Aion ad Alessandria nel
periodo imperiale, v. MERxlLg,qcu 1963' pp' 47-50'
i;
290 SILVIA BARBANTANI UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO "ALESSANDRINO' PER AUGUS]O 29I
volríng fiorÉ.prl,, un elefante da guerra ha compreso eip{vr1q..'
26úprv e ha gettato gli strumenti di fues.Il tema esiodico della corretta amministrazione della giu-
stizia e del buon governo, oltre che diventare canonico nel-I'encomio in prosa, è consueto negli epigrammi d'età imperia-le e tardoimperiale in onore di giudici e magistrati, in cui iconcetti astratti inerenti alla gestione del potere e all'ammini-strazione della giustizia sono regolarmente personificad: ac-canto ad Eunomia troviamo spesso la personificazione diDikeeT. Eunomia è una presenza consueta nell'encomio esa-metrico tardoantico: in GDRK I n" )O(VIII 33, l,óyoq èm-put{prog di Massimo, il laudandu.i, ovcí0eoq (v. 32), è pre-sentato come gcxívorv eùvopíqE lepòv gúog, mentre nel-l'Encomio di Callinico, di Dioscoro di Afroditopoli (GDRKXLII I 5,37) ù"per{ ed eùvopicr sono le doti del duca.
La connessione tra Eunomia e la Pace o 'libertà.', intesa
come liberazione dalla guerra (questo il significato dell'epitetoeî,euOéptog atribuito a Zeus in .911982) torna anch'essa nel-I'epigrammistica piir tarda: un epigramma di Efeso dell'iniziodel V secolo celebra Nonno proconsole d'Asia, che le due so-relle esiodee (Theog. 90Z1tt Eùvopirl òè roì Eipúvîì r€Ocr-
e7 A.PVll 697,10 (CHzusroD. per Giovanni di Epidamno); IX 686 (su unblocco ora inserito in una Dona di Teisalonica, si riferivi a una statua dell'impera-tore Basilio, che come únaploq rese quesra cirtà 1ópog, Eùvopír1q,, v. 4); I.Cret. In" 13 B, p. 256 (eòòtrín); CIG II 2592,3 (Dike personificata; per Leonzio); IGV7l 94-95 (per Plutarco, di cui si esaltano eòvopicr e òírn); SEG IV (1929) 467(tre carmi per Festo, procuratore d'fuia che preservò il tempio di Apotlo dai Cotinel 263 d.C.; nell'Ep. I 6 egli è oóv0povog di Dike); A.P IX 445,6 (il firnziona-rio e Dike oóv0povot). V Rosanr 1948, pp. 16-27,35 ss.; JoNrs 1997; su SEGlV 467, che nomina anche la 26pto{v ipi1vt1v, ai w. 15-16, v. RosERr 1948, pp.74-75. Eunomia è decantata anche in Karnrr- 855,8 (Atalante di Locri, ca.229 a.C.)e 1052,4 (in onore di un cittadino di Stratonicea in Caria, IV sec.); Kallal- 1071(= Couctl III p. 317 n' 159), per una fonte di Nauparro, esalta il governatoreAndreas (integr. Ronenr 1948, pp. 84-87) come Eòvo[píq]g i0rvtúp; A.P IX692,2, per i[ prefetto Vviano di Costantinopoli (su unopera architettonica igno-ta); XVI 72,5 (Acl;r:r..), per una statua dell'imperatore Giustino, ererta per com-memorare la sua eòvopíc quando era console; Y/7 34,2 (Turooonrr.)
-per il ri-
tratto di Filippo prefeno di Smirne, offerto da Filadelfia come (etv{ro;-XVl 21(ANoN.), epitafio del patriarca Nicola; XVI 22,1, distico anatemarico per una sre-le e{lvopír1q rotì oco<ppooóyng crvóOnpcr, con ritratto del governarore-Nicola, cheincarnava quelle virtù. Per eùvopic in clausola v. Coucxy 1 120,6 (cft Ptu. Arat.14; èrì rfl
'Apútoo eiróvt 1cxl"xfr) e 909a,2 (per una statua di un cittadino il-lustre, Plutarco; Megara, IV sec.).
es RosEnr 1948, pp. 97-98. La maiuscola atuibuita a Eunomia e Eirene èmia. Il brano di Esiodo è ripreso da PlNo. O, XIII 6 ss.; BRccun. XII 186 ss.;Bpncr<, PZG IIl, p.734 adcsp.140; h.Orph.43; I.Perg.324,13 ss. (inno a Zeus: al
me collaboratore della grand ezz Íomana e g1-1-n-te della sua
eterna durata: ad esempio nella quarta sffofe dell'Inno a Roma
iA iq, di datazione conttoversa ma probabilmente attribui-
UiL Af"'prima età imperiale, Melinno'si dichiara certa che ò
FGt;ó aióv che tufto muta manterrà intatto il potere di
il;"t;iui invece esso comPare non come custode del futu-
; t-p;tt bensì come entità P.rofetica.th: gii dalla notte dei
tempi aveva previsto I'awento 'messianico' del PrlncePs ttl' 1'
anticipazioni^della sroria romana nell'elisio virgiliano, culml-
nanti con Aen'Yl791 ss.: hic air hic est, tibi quem promini
sae\ius audis,/ Augustus Caesar, diui genus, aured c7ndet/saecu'
la,.'..), qui er"lt"to"tr"mite Apollo, suo protettore ad Azio (sog-
*.,r. ,Íi peBorlpéve, v. not; 78): I'accento non è posto quin-
At ;;-lt *ii"ppi firturi del regno di Augusto, ma sul.fatto che
l" ,ui' vittorià, simboleggiata dall'Apollo Aziaco, sia.il compt-
À.rrro a lungo atteso "dLtt
disegÀo cosmico' Agche questo
.1.*..r,o poiebbe indicare una datazione alta del componi-
mento.----- ntt" Pace si allude come a una fanciulla dal bel volto, Ii-
berata dai tormend dall'eroe 6('}rúp, come la Protagonista di
una saga mitologica: eòónròtx è aggettivo già. omerico conno-
t"rr,. T" bellezla verginale, generalmente in clausola con
"fup,fu (cfr. Od'. VI 1"13, l4ù9 h.Cer' 333; cfr' anche A'PV
2g7"1-3). Le conseguenze della liberazione di Eirene sono Pre-sentate il' v. 7: EuÀomia ed Euthenia'----
f f,""omia che si accompagna alla Prosperità. è, con la Pa-
ce, una delle personificazionipìi evocative nella letteratura el-
lenica. Lassociazione di Eunomia ed Eirene grazie al trionfo di
Aueusto sui suoi nemici è il tema di due epigrammi dt FtltP--
;"?iTessalonica: in A.P Vi 236,5-6, sui ioitri delle navi di
hntonio dedicate agli dèi, dopo Azioe5, I'eùvopicr di Augusto
ha ins.etrto "nche""lle
armi^di Antonio a produrre fr!-tti di
p".., oíti" un alveare; in A.P lX 285,5-6, per Augustoe6 eù-
ea Per la datazione ai primi anni del principato v. Ga'ucrn 1984 (considera
il rnoti,no-Je[t,..r,i,1 a.t poi.r. ,o-"to e iiuoi grecedenti); Zur'rz 1992' pp' 54-
55 lo accosta cronologicamente al Carrnert !!!c:'!are orazrano'e5 Sul sito a.f -on"-ì"to to"'"'o di Nicopoli d'Epiro,v' GrcÉ l9f' pp'
54-55 e Munnay-Prrsas ilSS. À"t,.i furono dedicaci però anche a Roma (Dto LI
79'2)' e6 Sull,identificazione del Kaîocrp in questione t: 9o.v - Pace, GP II,.p.
332; Crcnop.ru s 1922, ii. iii-àqe.-l:ipig'a'i'm" è probabilmente posteriore afa
morte di Augusto.
)c't) SILVIA BARBANTANI UN EPIGMMMA ENCOMTASTICO .ALESSANDRINO" PER AUGUSTO 293
l,tîcr/ Ofrrov anetpeoírov nroì.írov oogòv r1vto1fra (r.u. 3-4); in un'iscrizione per una srarua del governatore Acolio (sar-di, III-IV d.C.)nu, la Bouì,r1 dichiara d"i avergli ererro una sÉ-tua Eùvopíqg púp.ropcr Trrororútr1v (v. 4\, poiché, tra I'al-tro, egli ha reso la loro città un 'El.eu0epíqg
ìépevog (". 6).
Augusto, sourano nilotico, apporîatore di prosperità.
Il comp.ito di mantenere I'ordine cosmico e quindi anche lapace^e I'abbondanza nel proprio regno è una dille prerogativedel faraone ereditate anche
-dai nuovi siqnori dell Eeitti: se-
condo I'Inno ad Iside di Medinet Madi "(BeRNnNo i969a n"
175 Ifi:' I a.C.), w. 13-15, il sovrano dominatore dell'Asia edell'Europa, amaro.dalla dea egizia, come il buon paotl,eóEesiodeo è garante di. pace e pósperità: eip{vq(v) re cÍyolv,rapnoì BpíOouorv en'uùtQl / nuvtoiolv aya06v, rcpnóvte .gépovteg cÍp[to]t[ov]. Il topos sopîavvive in erà imperialee si diffonde anche al di fuori-dell'Egitto, in relazione'"n.h.agli intermediari del monarca: un'iscr'ízione di Efesor'' onorail governatore Isidoro, dal nome e dalla patria nilotici (ocxpíqgano yoír1q i rcrì Neiî,ou yovoeutoi, vv. I,2), non con ilconsueto richiamo a Dike, ma ricordando la prosperità cheprodusse_per. i -suoi concittadini con I'appror.uigionamenro an-nonario (v. 4: iivuoe rapnoróroo lrlfr{tepof ópnvtov ó}._Bov), come se avesse acquisito egli stesso, ii*il-.rrt. all,im_peratore, i poteri del fiume egiziano.
. Origine e simbolo della rerra egiziana, il Nilo fecondo,che già aveva saluraro I'arrivo del viÀcitore Sosibio (ceu. fr.384 PpplprpR)tot e che negli encomi dei secoli ,u...riirri ,itor-nerà, secondo un topos otmai canonizzato, a ricevere dienitari{i ::rr.. e generali, qui si presenra
"d u"..ogli.r., tJÀeE.i.",""
9) il trionfarore, rendendo I'crnóvttlorg,rr, ".rr..rro .po."l. pr"_
v. 15 Eunomia, Eustasia, Eirene). Sul rapporto Eunomia-Eirene v. Ke* 1916, pp.J,/ ss.
en RoscRr 1948, pp. 35-36.RosEnr 12f8,^ó. 43.(quesro è uno dei pochi epigrammi per governatori
ln cul non sl trartr lt rema della giustizia).r0rLe piene_del Nilo sono"presenti anche altrove nella poesia tolemaica delIII a.C.: Tseoc. Id. K{lI 78-80;^Drosc. A.p WI 76; tX 56É leffetri della pienxnella 1ópcr); Ar. Rlroo. CA Fr. I e 2,3, (ò6pa rl"ooóíou Neíltou).
senziato dagli dèi. Ottaviano entrò infami ad Alessandria all'e-poca della piena, il primo agostoloz. La sposa, irrorata dallenbraccia, (v. l0), o letteralmente dai ucubiti, di cui cresce I'ac-qua durante la piena nilotica, è I'Egittoto3 (\Weil), o, perKenyon, Eù0qvia (ipotesi meno convincente, nonostanteEuthenia sia così raffigurata su monete imperiali, visto chequesta compare già d v. 7): in occasione dell'arrivo di ZeusLiberator., essa riceverebbe la pioggiatoa fecondante come unanuova Danae, da cui forse I'epiteto naurei, riferito a ocubitiu,
se non allude genericamente alle messi o alla ricchezza del pae-se. Il termine ópppoq,
"l .t'. 1 1, è utilizzato spesso anche nei
papiri documentari per designare I'acqua della piena (ad esem-pió v.Cair.Zen. 59i83,13; P.Tebt. 72 rv 7l1tos. La metafora
iponsale è da sempre riproposta in Egitto in riferimento al-I effetto fecondanté del Nilo: la fase della piena è spesso de-
scritta come un matrimonio (Avlrr.r. orb.terr.34O: Aegyptum fu-sus fluctu premit arua marito), e già. nella religione egiziana era
r02 V. TnorurpsoN - Kor,Nr.N 19${, p. 129.r03 BoNNEau 1964, p. 272 ("La terre baignée de la vallée'); Prc GLP, p'
471 interoretò le uauree braccia, e le umani che-distribuiscono doniu come le pie-,r. .he uabbra.ciano, la terra; piir tardi lo studioso cambiò idea (FGE p. 485),identificandole con i sette braccì del Nilo (ndoubt if golden is anyrhing but bom-!a51u), interprerazione meno convincente in questo coÀresto di personificazioni. PernîXói i" riferimento ai ucubiti, cfr. I'espresìione, di diverso sigli!9a-to--11si5r-riletr.[.or,ru,,o, ntg2geot òe2gvopévq, nella itessa sede metrica, in A.P Y 232,6. Ktu-oett 1934, pp. tiio-<zl
"c.ort" ii pezzo su Azio all'inno per la piena d.el Nilo,PSI
VII 845 GLP 147, GDRKI n')OOilX; Vrr-Javaa 1968, p. 131 lo giudica.uq qra-no d'epitalamio con similitudine nilotica): vopgíe pll òíOuve, teòv.6' é{ /óvOecr' rupg{tlóevtt gepéotcr{ovl úpqene'vópqqv,/ ùpetéprov [ò'ù]4óvq1ono?"uppgQ[íolv] ópevairov e ad dtri brani encomiastici che.rip-ropongono lo stes-
so rrprr.'Lbro i simbolo di divinità e ricchezzai a proposito deil'naureacor':ente del
Niloí cfr. CtLt-. Del.263; I'Inno al Nilo d'età imperiale, in Czuuonr 1995,.w' 7'8: raì 260òv yr.rpvcooeîoa tel,eootyóvrov <'ùpèv>crírov/ v6tov ùvanlóoaocrpéver Xpùooppóbv óòap. Per 2gpoooppóqg riferito d Nilo cfr. CzusroRE 1995.o--. i. 8: BB'nNaNo 1969a n" t15 ll tZ: inno a Iside; Arn. V 203c; Gnrc. N'qz'Ox 21,87 MrcNB, PG)OO(V, p. 1116; Pnocop. Gl.z' Ep.8I,2: lpoo@ péovtatòv Neîllov. Page mette invece^in relazione il colore
"u.ó.on i cereali dorati fat-
ti sounrare dall'úione Fecondatrice del fiume.' ro4 Sdfidentificazione upioggia-piena del fiumeo come principio fecondatorev. Kryoell 1934, p.424; TnovpsoN - KoeueN 1984' p. 128' La pioggia che pro-vocava le piene erà formata, nella mitologia egiziana, dalle lacrimè di Iside (Pnus.
X 32,18).V. Me,nxrlsacrt 1963' pp. l2 ss'; Bgyx.rnu 1971, p. 54; 1964, pp. 255'Ai ó5-il4i 130 note t e.2 9 PP. 316.-319, sull'identificazione del Nilo cón Zeus-pioggia, della piena come ópppoq e sulla pioggia come origine delle piene nella tra-dizione egiziana e.greca- .ro:fl.5p1s5siòne Atoq ópppov è nella stessa sede metrica in ANrtp. A.PV7I398,1 .
294 SILVI.A BARBANTANI UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO .AIESSANDRINO" PER AUGUSTO 295
nata di spigherrO, o ne reca un mannello nella destra' Essa fe-
ce [a suJ.ó-p"rt" dapprima su monet-e di Augusto' con co-
rona di spighe e con spighe in mano. ln una moneta cretese
è esplicitam"ente chiamàtiE{r0r1víu leBcrot{l11. In una scul-
t.tt" d"l 160-180 d.C., ora al Museo Greco-Romano di Ales-
sandriall2, Euthenia è ritratta come una donna sdraiata sul
fianco, col nodo isiaco sul seno che la assimila alla dea egizia'
na, attorniata dai putti simbolizzanti, come nelle statue del dio
Nilo, i cubiti di ciescita del livello del fiume in piena. La Pro-
sperità è presente in un conte_sto epitalamico egiziano,. come
d""ltt" paite è nuziale la metafora usata al-v. 10 dell'epigram-
-", ..1 carme per le nozze del conte Callinico, di Dioscoro
di Afroditopoli-(GDRK I n' 21,9), e si può suPPorre che la
sr.r" pr.r.rrrà fosse un topos nei poemi di questo tipo. Il ter-
minè neutheniar, utTlizzato Per la prima volta, a quanto è no-
to finora, da Aristotele, compare di solito nella forma con rl
(è frequente soprattuto negli autori dal I d'C. in poi, pagani
e cristiani), -e.ttre piir rara è la forma Presente nell'epigram-
ma, per motivi meirici, con e: la si trova forse in un epi-
gr"--" di Tèeteto (HE 3351; Dtoc. !' IV 25), dove però è
Fr'.rtto di congettura (Cobet) al posto di eò0upi11, e^in Cou-
cNyVI 259,ó = KAIBEL 1036,1, (Nicomedia); al di fuori del-
l'ambito epigrammatico la forma eòOevío compare-raramen-te, ad .r.mpìo in Aplsr. Rh. 1360b,15, H.A.602a,15 e DIoc'
L. I83,7. Sp.rro, dal II a'C. in poi, tende ad assimilarsi alla
forma eù0évetcr.Il benessere che nella teologia della regalità ellenistica il
monarca è tenuto ad elargire al suo paese è collegato stretta-
mente alla sfera dionisiaca-della fecondità piuttosto che a quel-
la 'apollinea: da qui I'interpretazione spesso 1lbjgua. di.que-
ste manifestazioni di abbondanza marèriale. Malgrado I'assi-
milazione ad Apollo, ben evidenziata anche d{le.pigrammista
e in linea .ott ìl pantheln di corte dei primi Tolomei, .Otta-viano nell'ex dominio tolemaico dovette adattare la propria im-
magine alle aspettative e alle tradizioni locali dei sudditi, co-
rro PooLE tav. )OilI 28, 108; WI 796.rrr Per la raffigurazione di Euthenia con spighe su monete alessandrine di
Augusto, v. MIrue 1933 n' 23; BMC tav. )O(II 28; per I'esempio cretese v. Svo-
noNos 1890, P. 121, tav' XI l-2'Ìr2 No inv. 24124; cîr. K,q,nrr- 1993, p. 84, fig. 5.
considerata simbolo dell'unione di Iside e Osirider06. Il Nilo,che..qui accoglie l'ú,vc,rtcx vincitore (v. 9), è definito egli stes-so óva( in Hroyr-. apud Aru. yJ 497d (HE I.{).
La Prosperità è iperbolicamente un <pozzo di ricchezzar,come i Medi Bo0oKîécrvor di Sll 959,13107. E{l0qvía sem-bra nascere come divinità solo in epoca romana, corrispon-dendo all'Annona (Bonneau)108, ad Abundantia/ Ubertas (poo-le), owero, nel caso specifico dell'Egitto, al risultato dell'i-nondazione del fiume. Essa è associata aI Nilo come consorrenella simbologia monetaria alessandrina d'età imperiale (poo-LErOe tav. )CflI 485: è accanro alla personificazione dei Cubitidella piena nilotica), a volte assimilata ad Iside; è spesso coro-
106 PLu. De Is.363d e 366a; Hnroo. Aeth. lX 9; Hrv. Disc. g,5. V BoN-urau,1964., pp'71'272. sul le feste del la piena del Ni lo, in relazione al culto di(Jsr.de,_vd. l'rnrerpretazione del mosaico di palestrina di Mrvsoov 1995.^, _,*^'.11, raro aggetrivo 9a0.rtéc,vog, ispirato forse a nol,urtÉ'vog di prxo.t:rL x !(r ('proposro da Carl. Ap. 35), ritorna in componimenri d,eooca tarda:I 'AUL. SrL. A.PX74,l (attr ibuto ai fy.n. l , Kamer- 1069,i (per una òófoq di "r ic_chi abitanti,, anonima iscrizione siriata) e NoNu. Dioz. xri rze (la corrÉnte Jel-I'auriFero Pattolo). I composti con pcrOr- sono molto lrequenti *ià
";if;;i;"-".caica (pcr0uòivqg, pa0ó(rovoq,, Bo€órol,noq. pcr0ó}"eqoi, Bcreól,qtoq, ilaeúp-pooq., poOuppeiq6, Ba0óonog, Bc0óotepvog. Ba0óo1ótvog, Baeóépi(. Ba-uDxc'rîr€). La rrcchezza sorto forma di oro e ornamenti è caratterisrica dei popo-li orientali, v. Ancu. l9,l VesC; AescH. perr. l, no?"u2gpóoo" àrp"r,aó-'<:,f!|llOuoor .xúpòeq. (cfr. w., 3, 53); ps.Srraor.r. FGE WI z, fpl:"o,ióp.uMt1òolq I'iscrizione dedicaroria degli scudi macedoni consacrati d" pii.o
" bàao-
na^dopo la vittoria su Antigono donata, ANoN. FGf CXLII l: 'Aoíòa
t;î""noló1pooov. Ba0orl.oórol compare già in Bnccnvr_. III g2, in Ascu. Supp.554e fr. 45lg(a),3 T\GF, in CzuN. A.? nh qo,Z e spesso i" Non"o, O;r
"l;í[t r. t^
Pace, qui come già in Esiodo compagna di Eunomia, è dema 0créórcqpnoc ii IGIII l7{i
,(KArBEL.7lz, t;,.paetrn}.outoi in Eun. cre,pi. pr.-4;1tt;;;;A*: à;r,g.fr. I I I Kassgr-Ausrrl. Per altri riferimenti letterarialla pace portatrice di ricchez-za v HaRDen 1985, pp. 105-106.
^-^r08 II preferto àell'annona ad Alessandria è demo ueutheniarcau. TanN 192g,p. 252 presenta il titolo come esistenre già sotto i rolomei, ma di ciò non vi è con-lerma; rl termine, coi suoi derivati, è invece attestato in età romana, generalmenrecon q,. molto raramenre con e (in PSI M 705: eò0evrap26éol, III dk.; 1G XIV1072,4-:_eò9evícrg éncrp1og, Roma, II d.C.; IG )OV StZ,i3: eù0eveíoc érao_Xoq,, tll 4.9. = praeJectus annonae)t v. POry. X l2j2 uerso ii lg, XII l4l2,l-2,XVIJ 2108,3-4; Sa X tozsg,2; pkoln 5j,3i pstraft t53,r2; BG,U It 556 ií n.Y..O*T*. 1917, pp. 339-343; BenNecr* líe;. e,t.rr""aii",.pu.,,o Ji ..nn"."r"deue.'cchezze granarie anche al tempo del sitologo Acusilao, i d.finit" nell'epita-tro dr lJrazelmrs (BERNAND 1969a n. 10,7) Aitónto[o] r],ervr1v oraluprliopatóporv.
-.It^S_ql.!",rapp-resen_razione di Eò0qvicr su monere imperiali, v. poor-c 1892,pp. DO(VIII-DOOflI; rVnsrn l9t9; BoNNenu 1964, pp. \lO-lSt; CsnrsrrnNseN1988, pp . 140, 143, 154, 162, l7 r , r78 , r87 , 194,200,2o4,207 ss . ,2 r5 ,220,2 2 2 , 2 2 4 , 2 2 7 , 2 4 2 s s .
296
me poi i suoi successorill3, anche se solo con Caligola in Egit-to I'imperatore verrà ufficialmente identificato con Dionisorra(Pn. Leg. ad Gai. IL e l2).Il corrispondente egizio di Apol-lo è infatti Horos, divinità associata alla piena e quindi allafertilità. Antonio, preparandosi a divenire come compagno diCleopatra il nuovo sovrano dell'Egitto, aveva favorito in ognimodo, anche platealmente, la sua identificazione con Dioniso,il dio della prosperità conquistatore dell'fuia; la propagandaoccidentale ebbe buon gioco a presentarlo come un deprava-to, traditore dei costumi romani, visto che già da una partedella tradizione filosofica e storiografica Breca I'ostentazionedella ricchezza e del lusso (tpog{) era generalmente messa inrelazione con la corruzione morale del singolo e con la deca-denza dello Stato (Pnnarc. FGrHist n" 81 F 40 = ArH. XII536de)rt:. Lesibizione della tpug{ aveva assunto invece unnuovo significato nella politica interna dell'Egitto tolemaicol16:anche I'aspetto corpulento ostenmto dei primi Tolomei nei ri-tratti monetari non è necessariamente o soltanto sintomo diuna tara ereditaria o di una vita sregolata, quanro I'incarna-zione del benessere e dell'abbondanza che il sovrano presumedi garantire al suo regnolrT. Il pcorî"eóq-faraone, secondo I'e-sempio di Alessandro, si presenta spesso nelle vesti sfarzose diDioniso, dio capostipite della stirpe lagide118, come proclama
rr3 V Csnpaux-Tor.romau 1957, pp.82,83; Huzan 1988 e 1995, sopratrur-to_ pp. 3l14-3124; Hrruew 1995; G,crrr 1952, p. 155. Sugli elementi conJervativie le novità dell'amministrazione romana in Egitró sotto Omiviano, v. PrcaNror- 1953e Atr,tpLo:'n 1990, che media la posizione più diffirsa sulla conrinuità con quella diGenacl 198J, più propenso a sorrolineare-la rorrura con la tradizione toleÀaica.
I'a Dionìso "on
C del rurro assenre nell'iconografia uffìciale augustea a Ro-ma (v. Kelluu 1990, pp. 282-283), anche se vi gioca-un ruolo cerraménte minore.
rr5 PÉoecH 1989, pp. 467-468, fa risalire I-a descrizione plutarchea della dio-nisiaca corte di Tolomeo IV a Filarco (Cleom. 33,1-2; 34,2; 36,7). Le IIepì tovétî,onútola iotopicrt_di Tolomeo di Megalopoli (FGrHist II B n" t6l),'diplo-matico di rolomeo rv e V si occupavano anéhe àegfi aspeai piir licenziosi della cor-te, ma Jacoby dubita che siano la Fonte principale aei passi ótitolemaici di polibio.
116 V. ToNoruRu 1948a; Kvnrer-Erj tgZi, p. 164; HuNeN l9g3 e 197g, pp.188-192; Glcaxre-L.qNz,rne_ 1994, pp. t04-107; ll_rspn 1993, pp.70-71.1r7 V FLrtscnen 1996; cfr. pèro il ritratro dello straripani. M"g" in Agatar-chide, apud Arn. XII 550bc (cfr. Cunvorx 1956, pp.33-i4).
rr8 Si nota un aumento dell'interesse per il culto dionisiaco sotro i TolomeiII I e IV uNuovo Dionisou (NrxsoN 1957, pi. I 1-12; DuNnr.ro 1983; WEBER 1993,PP. 165, 343-346). Lidentificazione di Dioniso conquistatore dell'fuia con Osiri-de awenne già nel periodo faraonico, secondo VenNrÉn-e 1990, che pure insiste sulcarattere ellenico dél Dioniso tolemaico, derivante dal modello di Alessandro (cfr.
JraNuarn-e 1972, pp.351 ss., 446-9, 525).
UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO "AIESSANDRINO" PER AUGUSTO 297
l'iscrizione adulitana )GIS 54. Lidentificazione tra il dio e il
sovrano tolemaico cominciò già con il soter per culminlre con
Tolomeo IV (l'assimilazione tra Alessandro e Dioniso fu so-
stenuta da Ermippo, storico contemPoraneo al Filopatoreile),
che patrocinò tiasi dionisiaci a corte ì tra i privatil2o,. per cul-
minare con Tolomeo VIII, detto Tryphon, che suscitò invo-
lontariamente il disgusto degli austeri inviati di Roma, suoi
ospiti a corte. Si di6nde su Éronete e oinochoai cultualil2l, co-
mà strumento della propaganda lagide, e s,a,rà poi ereditata. da
quella augustea e imperialè, I'immagine della cornucopia, sim-
bolo di piosperità e fecondità. Nell'epigramTl Per Augusto si
cerca di'mediare il cara*ere 'tryphaico' e quello apollineo sot-
tolineando l'aspetto combattivo e vittorioso de| princeps, Prg-tetto da Apollo nella naumachia presso Azio, ma senza di-
menricare fli .ffetti di questa vittoiia sulla fioritura del regno
egiziano. Ù" t,rorr" 'Età, dell'Oro' Porrata.da Augusto con la
pàce è una promessa di abbondanza, e l'-Egitto ne divenne ben
pr.rto il simbolo nell'arte imperiale:- la Tazza Farnese Prese.ntaà.."nro a Saturno con corn;copia la Personificazione dell'E-
gitto, o Euthenia, come una dèlle próvincie più ricche del-
I' imperol22.Come i faraoni e i re tolemaici, anche Augusto e i suot
successori vennero identificati in Egitto con il dio benefattore
responsabile della soprawivenza dèl p.aese, quindi, in primo
luoeo, del buon andimento del ciclo della piena, come dimo-
,tr""l'.pigramma dedicato a Iside nell'isola di Filet23, KNIEI-
9U3-4 i= BrnNaND 1969b, n' 158 I): raì Neil'oo pa0ìl
rre V. Crnraux-ToNonnu 1957, pp. 157-16l; KyruelEIs 1975, pp.7,43 ss.i20 V Nocr 1924; ToNomau tg46, 1948a, 1948b,1950a' 1950b; lfruoe
1988.r21 v Tsovpsor.r 1973. Ars. XI 4gTbcricorda che per volontà del Filadello
le effìei di fusinoe porrafono il corno di Amaltea simbolo di ó),Foq, che assegne-,LU.?*fì-na.ifi ii i"t.rl,o delle piene del Nilo (BoNgru 1964, p.323); in.alcunibrorrr.ti alessandrini il re è raffigurato nelle vesti di Alessandro (con la pelle d e-
lefante) e come dio della ferrilitai nell'atto di gettare un pugno di sementi (Laun-
scuEn l99l; Monr,No 1994, pp.322-323). La cornucopia comPare su monete ales-
sandrine di Augusto (v. ad ei.-GerarN 1974 nn' l, 13, 15' 24).ttt V. Poiuut 1992, clte ritiene la Tezza creare per Augusto tra il 30-10 a'C'
Lascia sostanzialmente invariato il senso delle personìficazioni I'interpretazione di
TuoupsoN - Kor.lspN 1984 (data: 30-26 a.C.).r23 Il tempio di Augusto nBenefattore e Salvatore, a File è datato al 13-12
a.C. Sulle iscrizi,oni attestànti atd di adorazione a File v. Fr'sructÈnp 1970, basato
sulla raccolta di BrnNaNo 1969b.
SILVIA BARBANTANI
SILVIA BARBANTANI
X€Opcr, òg Alyorctov nol"óol,B[ov / crièv étoq oó(erKcxíoapoq eùtu1íarg (cfr. DroscoRo, Encornio di Callinico,GDRKI n" 5,25-26: èr oéOev flyrlreipcxq enéEpope neí.pa-tcr yofrlq / Neíl,oo apoupoBúm1g). Viceversa, la corruzionedei governanti può essere dimostrata dalla propaganda awersaapportando fa prova di una piena poco abbóndanie: prima del-I'evento celebrato da questo epigramma, sotro Cleopatra e An-tonio, il fiume avrebbe soflerto di un periodo di ìiccità (cfr.StN. nat. IYa 2, 16 e, secondo una supposizione di Parsons eLloyd-Jones, PRop. III 11,51: timidi...Mlirrn; VEnc. Aen.yIII713). ll.legame tra il sovrano e il Nilo (e il dio che lo rap-presenta) risale alla cultura egizianatzs: nelle credenze locali, lamancata_piena del fiume non dipendeva però da un difettomorale del faraone, bensì da inadempienzè di rito alle qualitoccava al sovrano-sacerdote rimediarè. Nel passaggio alla ci-viltà ellenistica, il pcro'tl,eóg si trovò ad essere respoisabile conle sue azioni del benessere del paese, in primo luàgo della pie-na del Nilo: alcuni epiteti dei Tolomei, quali o,rotfp oeòepyétqq, olrre che rispecchiare le doti richieste al re àaila_teologia.monarchica ellenistica, appanengono già al culto delNilo e del dio che lo proteggel26; I'int.rpr.t^rlon morale delfenomeno naturale fu ereditata anche dal Romanir2T.
Lassimilazione del Nilo (e del sovrano) con Zeust28, grà.diffusa nella cultura ellenica fin dal VI-V secolo a.C. (prNo.Pyth.IY 56: Neil.oro... Kpoviòcx, cfr. Schol. adpmo. pvth.Iy99; nel poema ciclico Danaide il fiume è esso ,t.rro íio ,o-vrano: eùppeíoo notopoO, Neíl,oto &vurrog, F 1, 2 Da-
t24 Contra, Koenen in THoupsor.r-KorxrNr 19g4, p. 729 nota 4i.r25 v BoNNEeu 1964, pp. 305-314. per una panoràmica dei motli esizi con-fluiri,.spesso arrraverso tramiii ellenisrici, nella pó.ri" .o.ra
"J e"lrri.,T**.-
sÉNrr- W,cr-oApr rt | 9 65.126 V MrRrprsacu 196^3^, pp. _23 ss.; BorqNrau 1964, p.240. TnoupsoN _
KoENeu 1984' pp. 120 ss., r30 sì. uEuergete, è attribuito anéhe ad au*urìo,-ài,..a orotí1p,3{ _es, in tGRt 9ot (Fanasoria)i1GVn r836 (il;i;i;rGRiVli; rp.._qfri?L1.GRIlI_4_2-6.(Termesso)rj-rlh trasposizione A )ri"'rip, a.[fì-.pi,.,ì a.i *eltenrsf lc_r v. IAEGER 1960, pp. 186 ss.
. . t27 PLIN. N.H. V 58; Luc_qN. .\.III 9?6- 9.s. (morte di pompeo). Dovettero ge_
stire in modo plopagandisrico le piene det Nilo Vespasiano ., :;; -.;; a;;;",Ad.ano, entrambi in visita in Egitto (MEnxrloacn
'1963, p.25; Bor.rNeAu 1964,
p p . 3 1 l - 3 1 3 ) .t28 Nella stele di Rosetra Tolomeo Epifane è uimmaqine vivente di Zeusu;
Hory.. carm. III 4 presenta il principe "o-.
2.,r, nella Gigaitomachia, assistiro daApollo (cfr. Cnu.'Iou. 165-188).
UN EPIGMMMA ENCOMLASTICO ,,ALESSANDRINO' PER AUGUSTO 299
vIES, p. l4l; v. il fr. giambico di Parmenone di Bisanzio Sf/604 A, pp. 288-289: Ailóntte Ze$ Neî}.(e)), permise dicreare un vincolo ancora piùr stretto tra il governante e il fiu-me. Lo Zeus dell'epigramma (responsabile della pioggia, v. 11)pare I'ipostasi greca del dio egizio che con le sue precipitazio-ni si riteneva provocasse la crescita del livello delle acque (Am-mone)r2e; a loro volta le piene nilotiche svolgono la stessa fun-zione della pioggia di Zeus (Eup.. Hel. 2-3): in un tardo en-comio a Giovanni, duca della Tebaide (GDRKI3,3, p. l3l),Dioscoro paragona il kudandus ad "A{plpova Neil,ou e gliattribuisce un favorevole influsso sulla piena nilotica (w. 42-43; cfr. P.Cair. Masp. II 67L3t uerso B, per il praesss Vittore:o Tcrp oòE oot{p ver}.o(yoyòg négcrvtar).
Il noto mosaico di Palestrina, secondo il suggerimentodella Bonneau, che lo accosta a questo epigramma per il temadella prosperità nilotica, potrebbe rappresentare la beneaugu-rante piena in occasione dell'arrivo di Ottaviano vincitore inEgitto: uQui sait si I'empereur, qui par d'autres cótés cherchaà lmiter I'attitude d'Aleiandre f l'égard de l'Égypte, n'auraitpas souhaité que non loin de Rome, un mosaique évoquàt laèonquéte rornaine de l'Égypte tandis que le mosarque d'A-lexandre [a Pompei, I a.C.] illustraît la victoire guerrière deI'Occident contre l'Orient?r130. Che si debba accogliere o me-no questa aÉhscinante interpretazione del controverso sogget-to del mosaico, manifestazioni uffìciali di onore nei confrontidel fiume padre dell'Egitto non mancarono sotto il regno diAugusto. It Nilo stesso avrebbe facilitato la sottomissione delterritorio egiziano da parte di Cornelio Gallo, che il 15 apri-le del 29 ;.C., dopo la sanguinosa repressione di una rivoltanel sud del paese, fece erigeie una stele trilingue (OGIS 654),sul modello di quelle regali tolemaiche, come segno di ringra-
r2e Le due divinita citate dall'eoisramma e ritenute responsabili della piena
nilotica, Zeus (Ammone) e Apollo (Hà;t Furono identificate ìn Sarapis, il cui cul-
ro fu oromosso dalla dinastiitolemaica (v. Koenen in TuovpsoN - KoerqeN 1984,pp . 127 ss . ) .
rr0 BoNNr.Ru 1964, pp. 89-94 (94); questa la traduzione dell'epigramma pro-posta ddla studiosa, ibidem:
"ll mit un terme aux souffrances de la blonde paix et
vint rejoindre la terre du Nil..., avec les abondantes richesses de la Prosperité... leNil a óouhaité la bienvenue à son Seisneur avec des bras chargés de présents... etle nom méme de la glrerre s'est éteiní.o. In uno degli studi p'íù recenti sull'argo-mento, il mosaico di Palestrina è datato al 120-ll0;.C. (MEyBoou 1995, p. l9).
uN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO ,,ALESSANDRINO" PER AUGUSTO 301300 SILVIA BARBANTANI
ziamento agli dèi e al Nilo che lo aveva favorito, forse, limi-tando la crescita del livello delle acque ed evitando così ogniimpaccio ai movimenti delle rruppe romaner3r. Il culto del Ni-lo continuò ad essere praticatol32, e i poeti romani ereditaro-no metafore e movenze espressive dei- loro predecessori ales-sandrini ed egizi: il Nilo è definito ancora niadre, in Tibullo(I 7,23); tuttavia, come simbolo del paese slonfirto, il fiumedovette sfilare, incarenaro i serre bracti, nel trionfo di Augu-sto nel 29 (Prop. II 1,3I-32: ...Nilum, cum attractus in Urbim/sept::n captiuis debilis ibat aquis), come già al tempo di Cesa-re (Fron. II 13, 88: in ferculis Niluò.
In questo.epigramma Augusto è dapprima paragonaro aZeus (v.8: Zeùg rÌt'
'El,eo0éproq), come è nella .ónsrretu-
dine della poesia encomiastica greca e ladna (cfr. CnrN. A.p IX224,5-6; HoR. carm.III 5,1-4: Caelo tonantem credidimus Io-uem/ regnare: praesens diuus habebitur Augustus...; MaNn_. I916;Ov. niit.V t,45 rt.)|,,, così come in opére d'arre figurativa (laGemma Augustea)r3a; poi è direttamente identifiàro con lasomma divinità, addirittura con la sostituzione di peyól"oto99" il_più solenne patronimico Kpoviòao al v. 13 (ArogKpovíòao XeBoorog): in quanto figlio adottivo del diviniz-zato Giulio Cesare (diui filius), Augusto verrà dichiararo neidocumenti in greco ndio figlio di un dior. Nella climax enfa-tica della chiusa anche al generico Kaîoocp del primo verso sisostitujsce il più altisonante leBaotog (Augustu), I'appellari-vo ufficialmente attribuito ad Ottaviano n l 27 a.C. óér deli-bera del Senaro romano. Anche I'aggettivo vrraîoE riierito al-l:. r!. imprese (". t+1è perlopiùr attiibuto divino, gàneralmentedi Zeus (Dro XLV 17,2,5; XLWI 40,2,4; LX 31,L,4: tempiodi lupiter uictor); esso compare già, in un conresro epiniiio,
r3r V BoNNEAU 1964, p..80;.B.gnNnrlo^1969b, n" 12g; GnrNran 1995, pp.3184-3187. Gallo utilizzò i màduli delle stele faraoniche e tolemaiche .oniro ii
',r.-
mico s-traniero per enunciare una vittoria sugli stessi egiziani. Sul possibile ritrarrodi Gallo comeTi'itrolemo o dio-della piena Àilotica, olire che sulla'simbologia del-la stele, v. TnovpsoN-Kopr,rabr 1984.
rr2 V. BoNluau 1995.r33 V. furwaro 1912, pp.274-275; tVnno 1933; T,q-ecnn 1960, p. tBS.
. t'.n L. simbologia monèiaìe postaziaca richiama spesso Zeus @MÒ628).Tut-
tavia nella polirica re-ligiosa di Augusto Zeus ricoprì uri ruolo -".Àin"l" rispetro adApollo e ad altre divinità. V. FEARS 1981, pp. 56-66; Z,lNrcn 19i8, pp. 230-237(convinto invece dell'importanza iconografica e simbolica di Giove néll'atte augu-stea); FrsHwcr 1992.
in Cau. fr. 384,39 PprrrrER (riferito all'ègÓpvtov di Archi-loco).
Per ben due volte (w. 8, 10) Zeus è definito 'El,eu0é-
pto6, particolare .che suggerisce I'origine alessandrina o co-munque greco-egizia dell'autore dell'epigramma:. in Egitto lanormale formula di giuramento in età augustea, almeno dal,27in poir35, sancisce I'identificazione dell'imperatore con Zeìlq'El,eo0éptog;
la stessa formula è comune nei documenti am-ministrativi e nelle iscrizioni dedicatoriei36, a partire almenodil, 12 a.C. il poeta ha quindi aftinto alla fraseologia buro-cratica e cultuale familiare ai sudditi della sua provincia (v.
CIG III 4715, Denderah), che diverrà comune anche nella ti-tolatura non ufficiale utilizzata dalle città greche d'fuia (/GXII
2 156, Mitilene). Il significato dell'epiteto in questo contestonon è del rutto chiaro.
'El"eu0éptog è originariamente attri-buito a Zeus in concomitanza con azioni di guerra risolte in
successo, con la caccitta del nemico barbaro, come le GuerrePersiane (Prv. Ar ist .2l ; Ps.SrvoN. FGE){ ' / 4, pp. 2l l -2l3:
dedica di un altare di Zeus Liberatore a Platea)r37. Escluderei
rr In BGU II 543 (eennaio 27 e.C.) manca ancora il titolo cultuale: esso
venne attribuito co.rt.mporinealnenre ad Augustus, secondo lVilcken (BruveNrnt
1913, p. 329 nota 6; \ù7nno 1933, p. 214);lon essendo però, a quanto si sappia,
un titoio uffìciale imposto da Roma, ma invalso nella consue.tudine giuridica e,sa-
...dot"l. egiziana, è'possibile che vi fossero oscillazioni nell'uso abbastanza fre-
q"*ai,.tJt" documlntazione papiracea è troppo scarsa^per,farci .conoscere: I'o-
missione dell'appellativo nel 27 non è dunque probante. ctr. le emtsslonr moneta-
rie asiadche d.i )S a.C. su cui Ortaviano si proélamò LIBERTATIS P(opuli) R(orna-
ni) WNDEX (v. MaNNsnrncen 1973).136 In Egitto Augusto è spesso veneraro come Zeus Liberatore in documentt
eoierafici in er;co' l" pii-" atteltazione è in SB Ill 7257 (12 a'C'' Denderah); ClG
tít?iil, {rn"èp atrto'rpótopog Kcríoapoq,,0eo0 tio0,.aròq. lf'eoQrylgt-}e-p""roo = òCtS e>') (iedici
"él tempio'di Isis a, Denderah, I d'C') = IGRI 1163;
'sntSaS = iCnl i t ìz ( i tot" di Soànopaion, dedica di statua' 3 d'C' ' cfr ' sBV
SÀ95, 24 a.C.: Socnopaion, dedica pri,raìa! SB | 360 = IGRI 1322 (l d'C'); SB
i'ieZa, = IGRI t2ò6 (Karnak); SB VIII 9671 (Karnak). In Catilio, BsnNeNo
1969b, n" 142,12: Krllíospt rovtopé6ovc rcrì oneipov rpatéovet/ ,?gYi tQ
C"-Zl"Oq trotpòq "EÀeudepíq (cfi. trodp Zeòq,...' pé14q, v' 4l Psot'^lY 6' 37t
novcopéòovt. v. li Pnop. fV 6, f i; cfr. Gnrrr 1952' P. 156; TaeTn 196O' Pr.2O2);cfr. Mitilene, IGXII 2, 156 (èl'eoOéproq, orotfp, eòep1Étqq; tuEvai-o l2]?'pt
à91 attribuis.e la formula ad Adriano); Cys (CousrN-DEscHAMPs. 1887' p'.306' n"
i,Ol po le formuie di giuramento in nome di Augusto Zeus Eleutherios il PaPiridocumentari v. P.Osl. ll 26,38-39 (514 a.C., Ossirinco); PRein. II 99'3 (Ossirin-
chite); CPR I 224,2; P.Amst. I 28,1-2 (cfr. RoNcuI 1974, pp. 395-396; pry-c9Nt1976, pp.213-215; Gpnecr 1983, pp. 153-154)t in POxy. [ l -253,16-18 (cfr.240
integr.-r. 4) Iberio è detto .figlio d-i Zeus Liberatore Auguston.- t37 V. JEsseN 1905b, coll. 2348-2349; É,rrEr.rxp-PrÉnq,nr 1975, pp. 63 ss.;
Scnacurun 1994, pp. 125-143. Eccessivo il giudizio di Koenen (THolrpsoN-Kor-
302 SILVIA BARBANTANIuN EPIGMMMA ENCOMIASTICO "ALESSANDRINO'
PER AUGUSTO 303
che si debba individuare un riferimento puntuale alla 'libera-zione' dalla dinastia tolemaica, come puie è sraro autorevol-mente suggeritor38, anche perché I'epitèto verrà attribuito piìrtardi, e in diverse parti dell'impero,'anche ad artri imperatori. tolj.gpre con riferimento specifico ad azioni belliche (Ne_roner3e, Domiziano, Adriano, Antonino pio)ra': è possibile che,senza esplicite allusioni all'estinzione dei Laeidi tper eli AIes-sandrini il 'barbaro'
da cui liberarsi sarebbe rí"ro .àrorrí"i il ro-ry-ang Antonio, o comunque il governo di Roma), esso alludaalla fine di ogni conflimo e allàwenro del saecuio* or.rro*,cons.tatazlone e speranza espresse accoratamente dall'epigrarn_ma londinese. La connessione del titolo 'Eî,eu0éprog
àn lacessazione delle guerre civili e il ritorno dell'Eunomii è con-fermaro da alcuni confronti con episodi precedenti e successi-vi al trionfo di ottaviano: l'immàgine àell'Ereutheria," Ào-nete alessandrine è proposra solo di Galba e otone nel tenra-tivo di propagandare la fine delle guerre interne del 6g e il ri-torno della legalitàtar; nell'epigrafuma di Catilio, sugseriscerERNAND 196b, pp. 80-81 (v. 2: Zuvi te èr Zavòq i"arpog'Eî,eu0epírp)rat,
i'àttributo di R"g"r,o p"u.bb. .rr.È gliriin:caro come un eredità del padre Glllio cisare, assimilatJa Zeus
NeN 1984, p. .128), per cui la vittoria di Augusto sui Tolomei sarebbe interpreraranF'l eplgrammrsra come avente lo stesso significato culturale della virtoria dÉi Gre_ci sui Barbari a Platea.r38 V Rrewero 1912, pr 2g7; Blur,arNrnar t9.13, p.330;.!íano 1933, pp.213-218; Genncr, 1983, p. t j4 e DuN,qNo 19g3, p. 49 nòta 17: non.on.oid-o.on
r oue stucrosr ner credere che Eleatheios, nei documenti come nell'epigramma, siaun epireto usaro addirittu.ra.dalla .propaganda uffìcialeo (il;;l;;?';;;';"r.Auey.rrg come.liberatore dall'oppresiiori.?i Aoronio-. crà"p"i*lfiri;;;,"-no di Zeus Liberatore v. Cpnraw-ToNpnieu 1951, ;p.'i;í-à;àr-;"';;;;i;;".egiziana in eeroelifici dell'epiteto augusreo <Zeus> a iiu"i"o ;;iF;; pd.- arMende (GnÉr.rreí tgael.
r3e Nerone sarà chiamato nfilellenoo e nZeus Liberatoreo nel 67 d.C. (Stilt.3!t.a)* luando proclamerà, ripetendo reatralmente it g."railfrÀL-i"J'È'fiir."ader Greci (non piir dai barbar^i^persiani o Macedoni,La dal... gou...,à i."-""11.r4o RlEvnLD 1912, pp.2gg-292.
Hr. Gnexrcn 1986, p.,8,8._V Mrr_Nr 1933, Galba nno 307, 3ll, 323, 3Zg,343;.Otho..nn" 359, 360,'365; poorr 1892, Gatbi n" t9t; Othí,; jO7,é"n.,ut9!!,^Galb4 nn" 220, 232, 234; Otho nn" 247, i<A. tria. a à** ,Èi."e.fptf"nel PO>ry.,|I 1380,80 (invocazioni a hide, primi'del II d.C.), -.rir. nóri^ii"SzSPrete'sce I ln-tegrazlone él"eo0é[p]av, con riferimento al nome della dea madre mi-croasrauca (cfr. Jxsrx 1905a).
, ^':: {yg"rto, in qualità di salvatore, vi è definito ctorpcp únúoag/ 'E},}.óòog
(vv.^3-4); il paragone implicito con I'astro che sorge è al v. 4: otorùp-Zeì16 avélT€tÀ9,4t?T91.<sr levg grande come Zeus Salvatoreo; è possibile che usi levòu, nsor_seu richiami I'immagine del pianera inrirolato a Zeus (bernand).
già in vita (Dro XLIV 6,4): egli fu infatd chiamato Liberatoréopo la vittoria sui Pompeia-ni a Munda (Dro XLIII 44:'Eieo0eprotúv); la funzione di 'salvatore' dello Stato romanodai nemici interni ed esterni è attribuita a Giove ricorrente-mente verso la fine del I secolo (Crc. Catil.I 5,11; 13,33: sta-tor III 9,22; 12,29; Phil. XIII 3,7; XIV 3,8).
I-laspetto paterno e Protettore di Zeus, salvatore e libera-tore dai pericoli che incómbono su regni e città, fu attribuitaa Ottaviano, olffe che in Egitto, nelle zone orientali dell'im-pero, in Grecia e fuia Minore (v. IG II-III 3 ed. minor 3237 'ix z, 424-425; 604; 1288; XII Suppl. 41: 0eo0 oi.og oeo-qxepaotòq eòep1ét'4g rcrì ocot{p k-aì rtíotqq). E-gli è esal-tato, probabilmente ancora in vita, come Zeus Patroos eooîúó ad Alicarnasso (GIBM M94,6 ss.), p,ortatore di..pa-ce in terra e in mare, di eòvopíc, òpóvotcr alle città dell'A-siala3. A differenza di quanto accade in Occidente, in cui ilculto imperiale è piùr cóntrollato dallo Stato, tali epiteti sonoleeati esciusivamente ai culti locali, in Asia come in Egitto, e
nJn farrno parte di un programma diretto d-al governo di Ro-ma, che puie trovò .ot r.ttlttt. lasciare che la venerazione e il
l.ii.-o dei sudditi si esprimessero in questo modo esuberan-te. I_lartribuzione di queiti epiteti cultuali da parte delle rcó-l,etq asiatiche era già ìna pràssi diffusa non solo in onore deipaorl,etg, -" *.É. di citìadini privati: diplomatici e. funzio-nari benemeriti sono chiamati (oroîúp') e (Kîíorng' della pa-
tria, o addirittura nZeìlq 'El.etoéptog, (Teofane di Mitilene'in IGYJI2163 b = SyllS 753)t44. È stata avaîz r^ dalla Gat-
d I'ipotesi che 'Eî.eogéptoq in Egitto riecheggi l'attributo già
roleÀaico di l<od1pra5: la tiiolaturà tolemaica sarebbe stata uti-
ra3 Sul decrero di Alicarnasso, quello di Mitilene e sui culti civici amribuiti
ad Aususto nelle citta "siati.he
t. Éuò*tnn 1935 (ritiene il decreto di Alicarnasso
;;&;;i,r*,."'iaiÀ"g"rro); Tar,cen 1960, pp. 188 ss.; l'irrn 1967., PP' 58-
B;ffi; tgll' ip- >q-16 (il d...eto di Alicarnaió potrebbe riferirsi ad Augusto
ancora vlvente,rr+ 3o*t*toa* 1965, pp. l2O'121. Su Teofane, la cui divinizzazione è pro-
ente Dostuma (dooo i1'44 a.C.), v. RosrRr 1969, pp. 48-52; Pzucr 1984'b"bil^."*lo'ì"i" ldll fr'qii.C)y v. RosrRr 1969, pp' 48-52; Patcr 1984'pp. 48-50; Mtn-rl_ 19.84; Gom 1987, pp. 94 ss.pp. 48-50; Mtr.qn 1984; Gorc 1987, pp. 94 ss.r. rú bircutibile I'opinione della Gi'irr 1952, pp. 156-157, per cui gli Egizia-Ia) Discutrbrle l'oprntone della GATTI l.))2, pp. L>o-I)/, Per cul gI DBrr!
ni avrebbero acceftato,ing,r.to come nliberatot , dilia guerra ma non come ocotfp----r-: :-.,^"^'.,{.1 -""..:'..h. i Tt l^--: ^',ìr6^c. "'-".. Mr""doni invasori del-oerché invasore del paese: anche i Tolomei ocotflpeq eiano Macedoni invasori
lEgi.ro. Per-l'epitetó.v- Benxeno 1969a, n' 106, pp:4.0q-Í0q: dedica, da part969a, n" ro6,'pó. 406-408: dedica, da parte dia Zeùq Erot{p'(U d.C.); si conosce una dedicasf;i"". f"*igli", di una statua a Zeìlq E<ot{p'(jl d.C.); si conosce una dedica
li. ..".to dio in correlazionc con t"t" dt" Sirii: oGlS 733 Gta di Tolomeo v)'Aio t,.tto dio ií correlazione con una iea Siria: )GIS 733 (età di Tolomeo V)'
304 SILVIA BARBANTANI UN EPIGMMMA ENCOMIASTICO 'ALESSANDRINO' PER AUGUSTO
lizzata con parsimonia, e solo accanto ai nuovi titoli imperia-li (Kcrîoap, EeBao'tó6), p.t evitare equivoci nelle pratiche delculto locale, che conservavano ancora il ricordo degli 'dèi'
La-gidita6. Tirttavia, poiché ortrîúp è utilizzato in associazione a,o separatamente da, èl,euOéptoq in tutto il Mediterraneo,Egitto compreso, e non in sostituzione dell'altro attributo cul-turale, credo che qui èî,euOéprog possa essere inteso come iltradizionale epiteto di Zeus vittorioso. Che poi nell'epigram-ma vi sia anche un'eco del cesariano Liberator, come suggeri-sce Bernand a proposito del testo di Catilio (dove comuiqueè esplicitata al v. 2 la discendenza da Cesare u1,s:us,,, a diffe-renza di quanto accade in .!l/ 982), è possibile, ma non cre-do che vi fosse la necessità di far ricorso a principi politici ro-mani per esprimere il lealismo dei Greci d'Egitto; I'idea di unmonarca che 'libera
lo Stato dalla minaccià nemica e dalleguerre.civili, lungi dall'opporre i princìpi della dinastia lagidea quelli del princeps occasionalmente osiile ad una su" rappr.-sentante, accomunava già la civiltà ellenistica, in particolarequella, egizia e tolemaica, a quella romana tardorepubblicana.
Lepiteto èî,euOéproq si rrova arresraro una volta anche inrelazione al dio augusreo per eccellenza, Apollo, proprio inconnessione con I'epiclesi XeBcrotóE: il culto di Apollo'El.eo0Éprog
xeBootóq (OGIS 457) ad Alabanda, in earia,potrebbe celare quello dello stesso Augusto e derivare diretta-mente dal culto imperiale egiziano (Gatti), ma si tratta sol-tanto di un'ipotesi indimostrabiletaT.
cfr. OGIS 734 (172 a.C., El Koussieh, Medio Egirto). Una definizione di AntiocoI come Apollo l<ot{p si ha in OGIS 245,12 géleucia in pieria, fine III - inizi IIa.c.). Sul significato religioso dell'epiteto ooc{p v. HeenrNs 1948. sull'affinirà delc.ulto augusteo di Apollo con quello seleucidico v. La Rocca 1994, con le riservedi ORrH 1997.
146 Orro 1910, ricorda il culto a File dell'crùtorpútorp Kaîocrp lepaotòqEorttlp raì EòepyÉcqq 03-12 a.C; OGIS6jT = BEwaNo'1969b nò l4d), e unanalogo cu-lto a Tolemaide: con la definizione di n0eòg orotr1p,, si indicherebbetout-c,art il nuovo sovrano,_l'imperarore romano, il cui èulto in Egitto fu una na-turale continuazione di quello lagide. Br-uvENrner 1913, pp. 322-liq, è meno pro-penso a sosrenere la continuita tra il culto tolemaico e quèllo aususreo: se il clltodei,sovrani promosso dalla corte tolemaica ebbe fine con'l'estinziJne della dinastia,le forme locali e sponranee di venerazione dei Tolomei non scomDaryero: non sipuò essere dunque'così sicuri, quando si legge una dedica x un uOeóg o."1p" 1.o-me a Tolemaide) in età ,om"nà, di trorrarsl"di fronte a un culto d.i Cesari'e ,ro.,a una soprarwivenza di tradizioni tolemaiche. Sul mantenimenro delle vestigia mare-ria.li e onomastiche dei Tolomei da parte di Augusto è d'accordo Fnsrn Pl I, p. 31.
ra7 V a proposito furv.qlo 1912, p. 297 nota 2.
Malgrado I'esaltazione della vittoria navale e.. l'epitetovaopú26òg attribuito ad Apollo al v' 1, manca nell'epigram-ma, già sovraccarico di similitudini e identificazioni divine,l'assoéiazion e del princeps con Poseidone, che egli stesso volleonorare dopo il successo di Azio (ad esso, oltre che a Marte -
v. Sunt. Aug. 18,2;96,2 - era dedicato il podio rostrato di Ni-copoli d'Epiro). Ad Alessandria la Prerogativa del dominio sulmire e della protezione dei naviganti fu ben Presto attribuitaad Ottaviano, che nel tempio iniziato per Antonio (Dto LI15,5; Srn. XVII 1,9; Suda 11329 Aor-tn, s.v. f1píepyov) fuonorato come come Etnporúplog (Pn. Leg. ad Gai' 22)t48, as-sumendo la funzione di patrono dei viaggi marittimi un tem-po affìdata alle regine tolemaiche (soprattutto Arsinoe II), e avolte ad Apollo (Fr-u. II 32,2: a Tiezene); Catilio, nell'esordiodi K,qrsel 978, attribuisce ad Augusto l'omerico ?tovropé6rov,sovrapponendo I'imperatore a Poseidone, secondo il principiogià el'lènistico che attribuisce al monarca il ruolo di pacifica-Iore . dominatore terra rnarique, formula riecheggiata in Pnop.rv 6,39.
honografia detlApollo aagusteo. ResponsabilitA del princeps nel'I'e la b-orazio ne de lla prop ria irnmagin e'diu ina'.
Lenfasi dimostrata dall'anonimo epigrammista nell'esaltare ladivinità del princeps rivela la PÍontezza dei sudditi_ greco-egi-ziani ad assimilare i precoci sègni di propaganda elaborati daOttaviano dopo la vittoria aziaca (l'affìnità con Apollo), e adadattare al nuovo sovrano il sistema politico-cultuale propriodella tradizione locale e grecomacedone (l'identificazione conZeus-Nilo). Dato che il passaggio grammaticale dal soggettodell'invocazione iniziale a quello dei versi centrali è, secondolo stile innodico, piuttosto repentino, verrebbe il sospetto chelo pvfrpa di cui Ji parla sia una statua di Apollo 9on i linea-menti di Augusto; meno verisimile, nonostante l'identificazio-ne del princeps con Zeus
'El,etl0éptog nell'epigramma, è che
la statua raffigurasse un Augusto -Zeus, come il colosso di Ce-sarea.
'48 Cfr. faneddoto riportato da Supr. Aug. 98. V. BluvrNrHat- 1913, pp.
318-319; GncÉ 1916, pp . 82 , 88-91 .
UN EPIGRAMMA ENCOMI,ASTICO dIESSANDzuNO' PER AUGUSTO 307306 SILVIA BARBANTANI
È possibile che già durante il suo soggiorno ad Alessan-
dria nef 30-29 Ottaviano abbia commissionato, o se non altroapprovato, una statua di Apollo con le sue fattezze' accomPa-gnata da un'iscrizione metrica inneggiante al suo aduentus, periicordare (v. 2: pvfrpa) anche in sua assenza agli Aiessandrinila vittoria sulla regina tolemaica ottenuta col favore divino? AdAlessandria I'assimilazione evidente deI princep.r con la divinitàavrebbe sicuramente suscitato più consenso che a Roma, dovepure sembra vi fosse un eiróv di questo tipo: a una statua diApollo-Augusto situata nella biblioteca del tempio di ApolloPalatino accennano infatti PssuooncR. scltol. ad Hop.. epist. I3,17: Caesar in bibliotheca statuam sibi posuerat habitu dc sta-tu Apollinis, e SeRv. adYrpc. ecl.IY l0: Augustum, cui simu-lacrum factum est curn Apollinis cunctis imaginibulae. Non èchiaro se la statua del dio con le sembianze di Augusto citatadagli scoli esistesse già al momento dell'inaugurazione del tem-pio, o se sia stata eretta piir tardi, addirittura sotto un altroimperatore. Le due fonti risalgono ad un periodo in cui il cul-to imperiale era già una realtà indiscutibile, e possono averfrainteso l'aspetto e il significato dell'effìge augustear50; tuttavia,se mai un luogo sacro di Roma poteva racchiudere un'imma-gine simile, questo era proprio il complesso templare paladno.
Il tempio di Apollo Palatino, iniziato nel 36 dopo la vit-toria su Sesto Pompeo, fu consacrato al dio aziaco nel settem-bre del 28 a.C. (Dro XLIX 15; Susr. Aug. 29). Eretto su unterreno acquistato da Ottaviano accanro alla propria residenza,il cempio divenne una sorta di 'cappella
privata della famig.liadi Augusto, oltre che simbolo della protezione offerta dal dio
rae Tencrn 1960, p. 100 e nota 70a è scettico sull'identificazione dell'effieecitata da Senv. a/Venc.'ecl. lY 10, con già la definizione di Augusnm, .on q,-,."1-la del tempio iniziato già inrorno al 36; àccetra invece la notizia"a proposito àellastatua delli Biblioteca, fa intendersi come divinirà con trarri simili a que'lli de| prin-cets, non viceversa.' r50 GuRVAt 1995, p. 290, ritiene che l'identificazione della srarua come unnOttaviano con le [attezze di Apollo, sia un'interDretazione dei commentatori oitrtardi, e ritiene casuale la somigìianza tra le fatteize del dio e quelle del prinàps.cledo 9!9 invece nel complesso programma iconografico august.'o illustrató, tra glialtri, dalla Simon e da Zanker,'talé somiglianza
"no., Fosse"lasciara al caso. Allve-
stremo opposto, la T,rnon 1931, p. 154 suppone che lo stesso Ottaviano abbia pa-trocinato [a statua, dopo che la iredenza iúll" sua origine apollinea ebbe trovàtocredito soprattutto preiso i molti grecoasiatici residenti"a Roma (non sembra peròche i sudàiti greci siano mai stati"iI principale obietrivo della politica religioà diAugusto, e proprio a Roma!).
allo Stato romano. All'interno, tra |e altre, si trovava la statua
cultuale di Apollo citaredo, scolPita da Skopas' N"lF lTgia-mo dell'effige di Apollo con liricui accenna Pnop' II 31,5-6:sembra che,-a differenza della statua di culto, questa si trovas-
se nel Dortico del Tempio Palatinor5r. Pr-rN. 'ò/'^FL )OCilV 7,
4i collàca un Apollo fuscanicurn colossale, probabilmenl. I'A-poilo T.-.nit. da siracusa (surr. Tib. 74), nella bibliothe.ca'templi
Augusti, quindi nel tempio ererro da Livia e Tiberio do-
oo i" ,rroire del' prince\s, in suo onore' sul Palatino (Dto LVI
?6,3, Ptt*. l/.É1- XII í4t Suu.. Cal. 22), e non nel tempio di
Apollo sito sullo stesso coller5z.^ Lassociazione di Ottaviano con Apollo, benché fosse per
cerri versi ereditaria, fu sicuramente incentivata dalla progres-
siva assimilazione di Antonio a Dionisort3, dopo la sua scelta
di campo a favore dell'oriente e il ripudio della Pace di Brin-
disi; è però ancora oggerro di discussione se essa sia stata.pia-
nificata da Ottaviano"hn dall'inizio della sua carriera politica(Gagé, Lambrechts, Bertrand-Ecanvilr5a) o se sia stata il frutto
di un abile adattamento alle circostanze, comunque non pre-
cedente ad Azioi55. Tioppa importanza si è attribuita all'awe-
r5r IAs-r 1953; Jucxrn 1982, pp. 93-94; Gtct 1955, pp. 535-536 lo-para-
eona all'Apollo di Brvaxis. Secondo ùiv*o*rH 1994, pp' 56-5il anche Pnop' .lI 3 i '
\4 ;;';;;;);i'fiírt" iiri nii puhhrio, ipso/ nanioreus tacita carmen hiare ly'
,i'"lrrrL!r'JÍ"a.t li """
,"trteu'r"rione di'ottaviano con le sembianze di Apol-
io'.'i,"r.Jo. Il testo però è corroito e non è suffìcientemente chiaro Per sostenere
i.t.in,.rpr.,azione: i posiodi Phoebo si potrebbe leggere Phoebus (è [a lezione dei
codicí deteriores, forse ésatta; v. Gunvat 1995, p' 729 nota99)'---- ut V. JonoaN-HUrsm 1907, p.8O nota.-98.per altre fonti; c[r. Ls BouNtrc-
G.úLer oE S,tr.rrEnne t95i, p. tg+i, V. Torelli, ià Sren'rsv 1993, s'v' Bibliotheca
temoiì Diui Ausutti.' r:r y4qfr5ppncrn 1973; Cocnossr 1978, pp. 145-146.r5a L-orvnnrcurs tsSzÉ, ii. ei-zo r.ddì"'ià. schematicamen*^i {yt BtTll
in cui otraviano avrebbe cercato scientemente unassimilazione adApollo: ttno,ar
Zl a.C. e deJ 12 a.C. in poi (dopo I'assunzione del .pontificato); l| .l5ggenda oet
divino conceoimento di Azia risalirebbe al momento dell'adoztone dl (Jttavlano oa
""r..-ai ò.rI* (Dro XLV 1,2). Non è possibile in realtà tracciare un diagramma
èosì netto, anche perché è ignoto quali iniziative lPolltnee' slano Pattlte dlretta-
;;;;-A Ott"r,iino priÀ""alt" lua vittoria definitiva. Lo stesso Lambrechts
l'li1l^l ritiene che Ot't"uirno "bbi"
,c.lto Apollo come suo protettore perché dio
à.rdato.e, come Romolo, non in contrasto con il dionisiaco Anronto. V. L5ERTMND-
Ecar.rvrr 1994.-"- iis Gunvrl 1995, pp. 90 ss.; PoLr-rNr 1990, p. 334 nota \,-pp:?!5:356
(nes-
suna assimilazione divinà'prima di Azio). Tayr-on 1931, pp. 233-234. giustamente
,"irifi".r ..-e le rradizio'ni sulla divinità di Augusto-naóquero.solo in-parte dagli
intenti propagandistici del principe, menrre in parte furono ispirate dd lealrsmo o
dall'adulazibnè dei sudditr.
308
nimento ricordato da Sunr. Aug. 70, un fatto privato del 40-38, forse pubblicinato negativamente dalla fazione antoniana(la partecipazione di Ottaviano, nelle vesti di Apoll.o, ad unacena ln cul r commensali rappresentavano ciascuno la parte diuno dei dodici dèi); è ben diffìcile che questa sia da intendersicome una mossa propagandistica di Ottaviano, anche perché,verificatasi durante una caresda, l'azione fu aspramente criti-cata da popolo.
Nelle ultime fasi della guerra civile, da quando cioè si puòdocumentare un uso strumentale e programmatico dell' assi-milazione con la divinità, I'associazione Apollo-Ottaviano è at-testata con frequenza soprattutto nell'area orientale dell'impe-ro, raggiungendo Alessandria probabilmente già prima dell'ar-rivo di Ottaviano in Egitto (30). Nell'ottobre del 31, poco do-po Azio, egli si recò ad Atene, che aveva un tempo accolto en-tusiasticamente le manifestazioni dionisiache di Antonio: urii-scrizione ateniese (1G II-[I ed. rninor 3262 + IG III I ed. rni-nor 4725)t56, forse concepita per una statua del principe, cele-bra il vincitore come nNuovo Apolloo, mentre un decreto (1GII-III ed. minor I,2 l07I) fa coincidere le feste per il dies na-talis di Ottaviano con quelle per la nascita del dio; nello stes-so periodo (la scritta KADAP garantisce una data anteriore al27), su un oóppol,ov di piombo coniato ad Atene, molto pro-babilmente in occasione delle distribuzioni di grano frte dalvincitore, compare il profilo apollineo, con corona d'alloror57,simbolo che Augusto introdusse stabilmente nell'iconografiadel potere imperiale. La monetazione postaziaca fino aI ZT (do-po la sanzione uffìciale del suo potere monarchico Augustosarà piìr cauto nel presentarsi come divinità) esibirà spesso unprofilo di Ottaviano molto simile a quello di un giovane Apol-lo, coronato d'alloro (RIC' 271, 272; BMC 633-636Ysa, con-
156 Prppas-DBivousou 1979. La studiosa (p. 128) ritiene che la base regges-se una statua di Apollo-Augusto (come quella della Biblioteca del Palatino), erettain un ginnasio (l'epigrafe è una dedica di un agonoteta dei giochi efebici). Il tito-lo oNuovo Apollo,, in parte integrato nell'iscrizione ateniese (Néov 'Alnól,l,rovc),
fu acribuito anche a Nerone in Attica (IG lI 2 3278) e a Tito in Tessaglia (SEG23, 1968, p. 450\.
rt7 Éorp 1992. Sulla simbologia dell'alloro augusteo, in poesia e nelle arti fi-gurative, v. SluoN 1957, pp. 38 ss.- r58 Sulla monetazione di Ottaviano in questo periodo v. LIeclr 1941, pp. 92'94 (ritratti'apollinei'di Ottaviano, fig. 3); SIvoN 1957, tav. l1'1-2; Tercpn 1960'pp. 104-106; ZaNrsx 1973; MaNNsptncen 1973; Cocnossr 1978 (simbologia sola-
fermando indirettamente la possibilità di una raffigurazione a
rutro rondo di un Apollo con i litteamenti di ottaviano posta
netla biblioteca del tempio di Apollo Palatino'La definizione di Apollo come Actius tuttavia comPare Per
la prima volta parecchi inni dopo la vittoria navale, sul rove-
,"ii Ji ""
d.rrlio coniato a Róma nel 16 a.C. (primo anno
il;; lar*lu*, anno dei ludi quinquennali.:.dti,giochi
azíaci; intorno a questa data anche Piopeizio pubblica ti,lv It
;;-A.11. ;"; J+i;i;1-in cui esalta i" vittoria del 3I) dal
;il;; Àor,.rrÉ Ríristius Vetus (NC' 365' 366)t60' Il dio
vi è rappresentato con lungo chitone, su una curiosa piat-
taforma àrr,"," da quelli cheìembrano rostri e ancore' con una
lira nella sinistra . ,r.r"-p",tta nella destra' intento a-sacrifica-
re su un altare. L" i;;;J" AI'}OLLINI ACTIO lo identifìca
.o., il patrono di Augusto' ma non garantisce che I'immagine
;;"1;pi"Ell; d;;" cultuale di-Skopas venerata nel tem-
"[ ai epóflo p*1",1""i;i, né di quella .,ri f" allusione Pnop. II
li,;Z'. fr; ;;;; (;*; e d'n"'ii) .con raffigurazione di
..no"[" Aziou, molto simili al denario di Vetus' sono conrete
;il;"""- ".fli-r 2 a'C'z in esse manca la piattafort?' .'
il di; in piedi di profilo verso-^destra' tiene la lrra nella srnr-
;;^;';ilri;;;dl"'J.rtr" (Rrc? r7o, 17r a-b' r7e'r80' 1e0;:ú ìíi;'ilz'li, rg3 "-u)"1'
È sllto ProPosto' in modo piùo É.rro esplicitor63, di identificare I'ipotetica starua raltrgurata
re, 20-l4a.C.); ArseRr 1981 su BMC 633 .= klcz 271; BMC 637; 638 = yC'
272; odie Mtinzpr:igungTti'nt"p"g|t "tg,$er VergÍittlichung des Prinzeps ernge-
setzt wurdeno); Pot-t-tNI 1990, pp' 546-ttl (l^ somiilienza' susserisce' non rmPone'
l'identificazione con il aó' f"fti*. 1984, pp, 44-43; GuxvÈ\995:PP'47-65' tav'
l-5. Sulla tipologia dei riuatti augustei.dacui derivano i conii v' HautvaNlt 198I'
pp. 535 ss., soprattutto ;:frj;.'f*i: ;il i-:È:f".ot Apollo-Augusto sul Pdatino
Dossa essere stata moctetto dei ritratti mo-netari.di Onavàno..con-sembianze apolli-
nee). Le Rocc,c 1994 #t':;ia'ii;'J9rr' gtf it'"mo iJ"li""ato e'apollineo'del
sovrano nella monetazi#Èi ú;ii.tq "ri"ii.i, in particolare seleucidi (dinastta
.lt. tiil*t.t" discendente da Apollo)'rie V. FEDELI 1965, p. 171.
UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO 'ATESSANDRINO" PER AUGUSTO 309
"'yu"é-* i'là2,7"í. t.t-l' Gunvar 1995, tau,' 6'.*t;fi t,'#i,'ilì,.'?"0-*î'*:1';i;'.*llo:t."(cmn.re44-,-ses;11t9*;;;15à;' ool zor tt.i inJi"iduà nei 'rostrr" i.foruli contentnt ],,t1:ltda Surripnrexo 1984' pp' 203 ss') individua,net
-rostil. r,foratt,"tl""l'''iì'ltt'i]
liliifi"ii.*f.ri,i ú" ót'ti"i""" nel'Tempio Palatino, nelle 'ancore' piante dt attoro'
- GrcÉ Ie55. oo. l+:->+6'iuàL;it'8i' -pp.
86-87' Krrrutut 1985' P' tz'f s11-liliiri"ii.*riri,i i" ó,ii"i""" nel Tempio palatin-o, nelle'ancore' pranre dr atroro'
ì:"il;;'ittí pf ;+;'s+àirffii-i?:8t' nn' àe bi,-ry::Yy l'^Y: F;]1'il'i1.'."èiii-ib::' pp' 545-546; Jucxrn.1982, pp' 86-87' KTLLUM lvu)' p' r'lr s.rr
bra dare per scontato .n..,"'.1"*"*ai-é[.i*i"tqs.';" 1; qll'll:+'":,lT*P'{:]:b;"1;; p.i t.ótìo. che. le siatua di Skopas-reggess-e la patera' come lrrPoilo'qcr-
i"b*. ai Sorrento: t"..bd;.;;;",o ii,.i"" deTfofftn" àel dio a Zeus' dopo l'uc-
cisione di Pitone'
* +:tr^à?rlid,'i;,1 Í;, î'iil*#?i;;?i.%r,rucr<an ,e82, pp. e6-r00
SILVTA BARBANTANI
3 r0
sul denario di Antistio con un monumento eremo all'aperto adActia Nicopoli, sul luogo collinoso dell'accampamenro di Or-taviano, ex-uoto descritto con norevoli varianti da più testimo-ni (Srn. YII 7,6; Svw. Aug. 18,2; Dro 5t, IJ): La piir re-cente ricostruzione del sito, proposra da Murray e Petsasl6a inseguito ad un approfondita campagna di scavi, non sosrieneperò questa ipotesi: pare infatti che il luogo fosse occuparo so-lo da un imponente podio ornaro dai giganteschi rosìri dellaflotta nemica, e sovrastato da vna stoa; iÀruna fonte menzio-na una statua di Apollo, rantomeno su singolare base rosrata eornata di ancore come quella che appare sui denarii del 16 a.C.
IJimmagine coniata da Antistió rimane ancora non iden-tificata. Non si tratta della riproduzione fedele di un monu-mento, forse, ma di un'interpretazione della divinità che in-tervenne ad Azio, a cui allude I'epitetor65; più verosimilmente
4CnO potrebbe alludere, t. ro., alle statue palatine, ad unaltro monumenro che celebrava la stessa divìnità, come adesempio_la statua-di Ottaviano uNuovo Apollou ad Atene (v.nota 156) o uneffige alessandrina, come q.rìil" per cui può es-sere staro composro l'epigramma SH 992. Il dià nAzio, com_parirà ancora su monere alessandrine neroniane der 6616gd.C.,_ anche se quesre rappresenrano un busto della divinità enon la figura intera dell?\pollo ciraredo, come le monere au_gustee delle zecche occidentalit..; è noto che Nerone, come se-dicente, a*isra, predilesse il simbolo augusreo di Apolro Aziodall'emblema musicale, accettando i*pli".it"-.nte lîidentifi ca-zione del dio col suo predecerror. qu"rrdo, secondo Supr. À/r_ro 12,8, risultato vilciggrg- all'agone quinquennale a Roma, eglidepose la cera ai piedi di unJstat,.t" di hugusror6T.
Lassociazione di Augusro con Apolro, cie sia srara o me-no escogitata in Occidente prima del a t, in Egitto non fu can_
',:.: Plz, pp. -16-21,,9r; ricosrruzione del podio a p. 88.
...^^ ,."1 (i-qcÉ 1955, p. 545 suggeriva nune imitaìion appioximative d,une des sta_tues du culreD' cuRVAr r995, pp. 2g.5-2g6 crede che la patera del sacrificio sia sem-plicemente un'allusione d
"oà. d.l -"".r".io, ,,,C;ilri,rr,.
V Poola 1892, tav.-III 144 (p. !liv:.o.,ìa.rr,.), yocr 1924, pp. 33,
1?:_:.: r93?:!: r33, nn",2,70,27r,' '287, roo_jo:; GuaeN 1e74, nn" re4, re6;LHRrsrr.ANsEN 1988, pp. 54_15, 60, 72.167 Secondo Cièr tSil, pp. 575-.576, scetrico a proposito dell'esisrenza diuna starua di Augusto-Apollo come quella segnalat" d"gli ,.àli, I'unico csempio diAugusto-Apollo ciraredo sarebbe questo omafgio tribuàtogli da Nerone.
TIN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO 'ALESSANDRINO' PER AUGUSTO 31I
tara solo dagli epigrammisti, ma fu discussa anche dall'autore
di urielaborlt" ópit" teologica. Secondo una uadizione atte-
stata per la prima volta indirettamente da rlno degli.Epigram-
rnata Bobieisia (n" 39, di Domizio Marso)r68, la madre di Ot-
taviano, Azia, proclamò di aver concepito suo figlio- da un ser-
pente, ipostasi^di Apollo (Sunr. Aug. 94,4: sogno di Azia;, D,to
XLV 1,2-3: unione col serpente durante un'incubaztone')' La
versione scritta di questa leggenda si deve, secondo Suetonio'
ad fuclepiade di Mende, g.éco-.giziano, che probabilmente si
ispirò, i-.to in parte, ll. tt"iirioni sulla nascita di Ales-
sàdrot6e. Tirttavia, poiché una leggenda di questo tipo era.già
familiare al pubb[cà romano a proposito di Scipione Africa-
no (Lrv. )OOt{ 19), certo Ottaviano non avrà aspettato.l'ope-
ra dello scrittore egiziano, che non si può definire una lettura
pofot"r., per far "lr.ol"r.
voci sulla propria origine divina' È
.o-p..rrùile comunque che quesre dicerie abbiano attecchi-
,o ,"pid"r.rente in Oriènte e siano state accolte anche dai dot-
168 Ii distico 39, forse posteriore al trionfo di Ottaviano, esalta Azia come
oossibile À"J.. ai ""-air;
i'óieramma 40 è un distico funerario che presenta le
i."..i i.tt" matrona, -ot," .tèl?3 a.C. V' Bnmcnzzr 1964'r6t Di fuclepiad. .;;;i ;;",.. qt'"ti n'alla (FGrHist n" 677: lo si identifi-
., ..,.' l'""uàr.-;;i;; aì ,*tosi" citatà da Suda t1 450 AoLen' s'v' 'Hpaiorog)'
;;;,;-h; ;ri3""ìl'i'i--"gì."-'on. J.gli studiosi. KteNas'r 1969 ritiene che il
;"à;;;; il;;; q.,.tto 3.tt'i".ubazione siano entrambi opera di Asclepiade,
Dresenre a Romi dopo r\zio; è possibile invece che egli abbia.solo dato forma e cltr-'firsione
lemeraria a úna tradizione gia wiluppatasi in seno dla famtglta e al ctrcolo
ài ó,r"ui"r,o (SrvoN 1957, pp. li-13; GÙirvnr- 1.995.,.pP; 100-101; anche G-tcÉ
1955, pp. 570-571è propenso ad una datazione aÌtadella leggenda):,se;olo:-:*-
sio Dione Ia stessa nri" a,-fÈ*e f" *iiri" a.U'"nione divina. Iliogno di Azia.e quel-
io di Ottavio si ispirano invece piìr scopertarnente a tradizioni ràligiose egiziane. (la
dea Nut oartoriscà il sole, che si identifica col faraone), reinterpretate slncretrstlca-
-..rt. .oìì da renderle Familiari anche ad un pubblico- gj:co--P.mano t$n1t1roE11986, pp. 369-37). Grandet ritiene i Theologumena scrittì^in Egtmo tra,rl JU e rl
)l"i|é.i , i'l;;í "J-t8
;.C., .o-. ,tru-E,to di giustificazione ideologica alla
conouista romanai -" oo.rorro't.ssanta libri (se il teito è da identificarsi con .gli;"tiì,;;;A Jt;i;;J;Àil. III 83c) di elaborazioni teologiche e.ra-cconlj
liti-ci,'che presuppottgotto un vasto uso di fonti, essere stati,comPgttl, I--t:lt^3ttotempo? i{rrnÈN 1995, pp. 3174-3176 sosriene cautarnente I rPotesl dr.L'randet' ma
è sclttico sul valore pròpagandistico dei Theologoumena presso gli Egrzant;, IAECER
igeo, pp. 211-212;"pb;?;;h; ii *gno di Àzia pott" ttt"tJi'pirato dla rradi-
zione ràmana (Scipionè), mentre l'accoppiamento col serpente, ch€ llProPone la vl-
cenda di Olimpiade, sarebbe un elemento alessandrino.proPtto qt.AscttP,taoe;-l so-
eni di Azia e Òttavio potrebbero anche essere opera di Giulio Marato (cfr' SuET'"iis.-9ail.Il Vaso Poidand, secondo la SrvoN'1957, raffrgurerebbe Ia ierogamia'ii1i,ii'r'dp"llo.
Sullo sfr,ritamento propagandistico della-paternità apollinea da
parte di Augusto v. Klewen 1988.
SILVTA BARBANTANI
312 SILVTA BARBANTANI UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO "ALESSANDRINO' PER AUGUSTO 3I3
ti (già i dinasti seleucidi avevano sancito ufficialmente la lorodiscendenza apollinea) r7o.
Il passo su Augusto, che facesse o no parte dei Theolo-goumen*, composti probabilmente parecchi anni dopo Azio,propone un'elaborazione sincretica delle leggende solari legatealla famiglia di Ottaviano, di quelle su Alessandro e dei cultiegizi. E possibile che Asclepiade abbia conosciuro Ottavianogià a MendelTr o ad Alessandria nel 30-29, e si sia reso conrodelle esigenze politico-religiose del futuro sovrano; in ogni ca-so, la dichiarazione di unorigine divina era necessaúa aJ. prin-ceps, come al re macedone, una volta raggiunto l'Egitto, terradi tradizioni teocratiche: per Ottaviano la presa di Alessandriarappresentò una tappa della sua identificazione con Alessan-dro, come conquistatore e
'pacificatore' del mondor72. Dopo
aver perdonato pubblicamente gli Alessandrini nel ginnasio, ar-ringandoli in greco (cfr. Pr-u. Ant. 80,2; Dro LI 16,4; Supr.Aug. 89,1), è al corpo del fondatore della città, e non ai ca-daveri dei Tolomei, che il vincitore di Cleopatra volle rendereomaggio, toccandolo quasi per impossessarsi del suo carisma(Sutr. Aug. 1,8,1); I'immagine di Alessandro comparve anchesu uno dei suoi sigill i (Pr-rN. N.H.37,10; Sun. Aag. 50).
Ottaviano rimase ad Alessandria dall'agosro fino all'au-tunno a'vanzato del 30, prowedendo ad opere di ristruttura-zione, oltre che al rastrellamento di tesori; fece probabilmenreun giro nella 1ópcr (Suer. Aug. 93); a circa rrenra stadi dallacittà, nel luogo dove aveva sconfitro da ultimo Antonio, fondòNicopoli, sede di giochi quinquennali (Dro LI l8,l), come piùtardi altre città dell'Orienre greco (Neocesarea, Ierapoli, Bosira;gli agoni sono commemoraii da emissioni monetàrie con le-gend3 AFT4)tt'. È possibile che a Nicopoli si sia sviluppatoil culto del fondatoretz4, e che quindi vi i'ossero collocate^sta-
t70 V. OGIS 212,13-t5; cfr. Musrr t966, pp. 106, 130; GtrNrnrn 1971, pp.69 ss.; Ln Rocca 1994.
r7r GRENIEn 1986 ipotizza, poiché un profeta di Mende vanta in una stele diaver chiesco personalmenìe un fivore ad Augusto, che esli definisce in eeizianouZeus, ed erede dell'ultimo lagide, che nell'oriobre-no.,r.-6.. del 30 ottaviino srapassato per Mende sulla via cÉe lo conduceva a Pelusio e alla Siria.
r72 V Krcwasr 1969; Gunvar 1995, pp. 70 ss.r73 V Gunvrr 1995, pp.78, S0.r7a Dro LI 18,1 afferma che Nicopoli presso Alessandria fu fondata dapola
Nicopoli d'Epiro. Poiché Ottaviano lasciò l'Épiro poco dopo la vitroria aziaca, èowio che eglì avrà soltanto pianificato il sinecismo di Actià Nicopoli, operazione
tue come quella a cui sembra riferirsi l'epigramma {eJ nanlrclondinese. iJipotedca effige di Apollo-Onaviano farebbe parte
delle manifesiazioni tocall di culio del paotl.eóq, gil verifica-
toi ,r"gti Stati ellenistici in occasione delle vittorie dei dinasti
gt "od"..aoni,
piuttosto che dei .programmi propagandistici
f,ello stesso prinieps, quali invece g[ agoni commemorativi' Se
"o" e possiiile di-ortr.t , per mancanza di attestazioni ar'
cheoloe'iche o letterarie, I'esisènza di questo particolare qyal,-
1r,o, è "..rto .h. la capitale egiziana e i suoi dintorni furono
;;; ti.Àpiti di ritràtti del"nuovo monarcalT5' per uno dei
(uali S11982 potrebbe essere stato comPosto'
Apollo oAzio> e APollo oLeucadio''
La presenza dell'epiteto apollineo oleucadio, nella chiusa del
.;J;;;[;r,ro .h. si era^aperto sonorarnente con il nome di
4'il;it-pone I'inrers."*bi"bilità delle due denominazioni
ben doàumentata nella poesia latina; in particolare.si impone
tl;;ft;;.." gri epitàti usati da Pnop. ill 11,69 (Leucadiuù'rll-e,ei Qq,cuíù"6, entrambi in apertura di verso, derivati
d"ì ,"rriu"ri vicini di Leucade e di Azio, esistenti da molto pri-
ma delle guerre civili. È possibile che I'epigrammista,greÎ9,"o"
fosse a .o-ror..rrr" delle differenze cultuali tra I'Apollo di leu-
;;A . quello aziaco: non sembra comunque che queste fosse-
ro moltà importanti ai fini encomiastici;.giustame",",,,Ko:ÎtÎ
ha osservato-che in questo caso il topos innodico dell-eptclest
J aio con elenco deile varie sedi di culto è utilizzato come
oframing devicerlTT. , ,r,^ tt , .t , ,-- La"prima citazione latina esplicita.dell'Apoll?. !:1"t'"
ambito Doetico compare piuttostoìardi, in Aen- VIII 704' nel-
ful(ó";i; della bàttagfi" di Azio raffigurata sullo,scudo di^Eil pt;úbil. fottr. díispirazione per Pior'' IY 6;Hou' epod'
lunga e complessa; il suo soggiorno prolungato in Eeitto eli avrà permesso invece
àì'r[,ri." -églio ii ,org... l!if" iiì..p.tt alftsand'ini(u. lùunnav-Pers^s 1989' pp'
t26-127i Gunvnr 1995, p. 73).rzr 5ui ,11."111 augústei irovati in Egitto v..Jucrrn 198.1, pp' 669-679',.176 Su pRop. rv 6,.l"eio,."lli*".f,.o,del-vincitore di llzio, v. tra gli dtri
SweE.r tg72 (cpr. i w. 15-68 ion Aen.Ylll 675-713)t su Pnor. III 1-5-, Forse^ispira-
i:^d'H;;. t;;' III, NpnrBnc'r 1971; su Pnop. III 11, Gunver 1995'pp'206 ss'177 In TuotnlpsoN-KorNtN 1984, p. 127 nota 34.
3 1 4 SILVTA BARBANTANì UN EPIGRAMMA ENCOMI-As'TICO 'ALESSANDRINO' PER AUGUSTO 3I5
9 ignora il ruolo del dio, menrre Pnop. III 11 fa riferimenroal solo Leucadio. Associa i due epiteti Ov. epist.N 165-166:Phoebus ab excebo, quantum patet, aspicit aequor/ Actiacum po-puli Leucadiarnque uocant benché la casa di-Augusto fosse or-mai protetta all'ombra del tempio di Apollo Aziico, Ovidio ri-corda ancora in nist. III I,4I-42I'intèrvento del dio di Leu-cade: n_urn quia perpetuos merait domus ista tiumphos?/ an quiaLeucadio semper amatd deo est?. Gli attriburi spetifici, ma an-ch'essi spesso confusi, dei due culti sono l'arco (Leucade) e lacetra (Azio)r78. Questa divenne il caratteristico emblema del-I'Apollo aziaco del Palatino (il Citaredo di Skopas), e compa-re in numerose opere d'arte figurativa augusrea: nel bassorilie-vo romano di Budapest una processione avanza verso un Apol-lo con cetra, seduro su una roccialTe; il dio citaredo è preien-te anche nell'altare della gens Augusta a Cartagine
Non è stata ancora trovata una soluzione soddisfacente alfatto che i due artributi cultuali del dio siano usari in poesiacon indiffetenza, se non con una netta preferenza per nf,eu."-dior, benché l'immagine del citaredo legata al cultà aziaco siacomprensibilmente prediletta dagli artisti, protetti dal dio eli-conio (in Pnon IV 6,69-70, il dio che duianre la naumachiaha teso il suo aÍco a favore di Omaviano, dopo la vittoria de-Pgne 1t^ armi e_ riprende la cetra; cfr. Eleg. in^Maecen. I 5I-52:Actiu|8o ipse.lyyry plectro percussit ebuino/ postquam uictricesconticuere tubae). Forse non esiste nessuna spiegazione cultua-
_ '^u V. GacÉ 1936, pp.46-50. FnaN* I976 identifica I'iconosrafia dell'Aoollo
Leucadio arciere su monere.imperiali_posraugustee. su monete deísandrine di Ne--1,..,il
iy:,,g_di Apollo arciere.è definito "Àp9llo Azion, ed e pr.rro.f,J i"airii.-gurDlle call emrse dr <ADorlo lJz_lgD,_se non per la diversa legenda (MILNE 1933, nn"1to, zzt, 287:300iob e p. 133;'Fons*'.irn ila9,-Nr-,";;; ii8; lit,-íZó, ;r._do che il ntridenteu visro dà p_o_9|e,.y. nota 166, sia'ciò che ro," Jut" i"ro."j. p..la Gnrrr^I952' pp. 149-150, virgilio (Aen. yril 704-70j: arcum intendebat.../ de-luper) e liroperzio (rv 6,39-40) associano l'arma anche all'Apollo aziaco: è possibi-le,però che..ny3T9t,O.ntino alla posizione sopraelevata dei santuario di ieucade(cfi. ov. epist\ 165: ab excebo),'da cui I'arcière divino avrebbe Doturo sovrasra-re la flotra nemica meglio che dalla collina di Azio; la stessa ambieiità si ritrova inAen. lU 274-276, dovó i Tioiani,^diremi al tuog" ou.
"*;rrl;'H";;;; ;;À"":i,",
vedono il santuario leucadio del formidarus naítis... Apolh (cfr. c^"J I liZ, "".
+e -47); súl'apparizione.ap:lline.a id A"i", che.ha are ';Ji; ;;; 1""g" ìí'aiii['". atenrca (rawrvata nel 278 da.ll'invasione galatica) e romana, v. Gncdt955, pp. 499-5r6 .
r7e Tav. I I in GncÉ 1936 e 1955, p. 5O9.Luso assoluto di Actius nell'elegia a Mecenate è unico, forse ispirato ar-
I'analogo uso di Delius (ScuooNnowu l\g}, p. lZ4).
le, archeologica o geografica' e la.migliore spieqazione resta
quella puramente letteíaria, suggerita.da Gurvalftl: il dio di
leucade era già "";";;;;ti
ti"ttttdi! ner le sue evocazioni
poedche e leggendarit-ti*it*'.f1 94 GsNrrr-l; la leggenda di^S"ffo
diffora e distort-a i"tltt dalla Commedia) e per gli epi-
sodi di sacrificio ;;;^;-;"i"iaio (Srav. DnN. iz vnnc. sri.
VIII 59, inyvxc. Àr".-ly z}i; srn. X2,9; ov. fast'..Y,630)
che avevano luogo ;;; f" t1'nt leucadia' rntt'itt il dio di
Azio assuns. i-po"t""'" ttf" aJpt la battaglia' qiil'1:!io-
viano fece ,.r,",'r,""*fit-pi" tiauto in 'or"itt"-' aggiungendo
un trofeo di dieci n"t'i anioniane sconfitte' e fonAando sulla
il;i[]r."1ll,''i:ff* j:;?"Ì::gil;"lil,:"i.ffi:;il?::J,T[iìtTo,i'o"'" nemica Presso ';:;' ; l'"ì'o' amribu-to cultuale leucadio, Possono aver suggerito un coinvolgimen-
;; ;il.1tpAf. Ii*i*o'. I letterlii al servizio di Augusto
a quanto p"r. ,to"-'ittt"t'o doveroso pubblicizzare in modo
ossessivo e rirt.matii"l "tl"a" l'ePiteto
"'azio> "'aziaco"'
il cla-
moroso successo ai"ó"""i""o; si à.ve osservare' come fanno i
;il"r"ele"r;-rt,rdio'i della poesia augustears2' che le opere in
versi conte-por""* + tíiii;it di "Aueusto non danno l'im-
pressione di essere pi"íifit"it tornt -ti"*ente -Propagandisti-in.li'rJ, a.r,.,,o, [ti Ji; :o,::l i::*[,T::il1"i',:ì"X, XT-to il regno di Augusto sono escluslvam
toria aziaca'o'.
Influssi reciproci d'ella poesia encomiastica ayy?st:a.greca e latina':d";';;f
iírt^t i;'nprimere la stessa ideologia?
Per concludere vorrei aggiungere qualche osservazione su alcu-
ne interpretazioni datt-1" p"""to dell'epigramma londinese'
Rilevando Ie numerose co"Jonanze rt^ le'eÉeie di Properzio e
il componirn.,t'-"tiiiÀi*iitt alessandrino'"Alfonsi notava a
r8r 1995, pp.206-207.r82 \fHIrE illl,.pp'.ye-205, Gunvar 1?'rí;rrr* 1985, p. 37. Gti attribu-'D Sugli epiteti del dio in età augustea'.v' l
ti relativi alla vittoria J't";t;t;;; "rfil"to
di epotto {^d es' naialis' Pnop' IV l'3;
oicton Psop.IV 6,69; ;*;;;;;"; o,. -'t' t aí;--tniidot *g;tto' Hox' carm' I
1i.Zì """
sono piir frequenti di altri'
3r6
proposito di quest'ultimo che nci troviamo... di fronte... all'u-nlca versrone encomiastica e parastoriografica della battaglia diAzio come attestata da Virgilio, Properzio e Orazio (carrn. I37), affrne alla tradizione liviana comprendente Cassio Dioner;come i passi citati di Properzio, il componimenro alessandri-no sarebbe anch'esso (traccia... di ununica rappresentazioneufficialerl8a. In un secondo articolors5, lo studioso prese chia-ramente le distanze da quanti ipotizzano un legame rroppostretto fra la tradizione ellenistica e il poeta elegiaco latino:nAssai piir owio appare pensare che l'aurore dell'epigramma siappropri, con motivi persondi (lo Zeùg
'Eì.er0éprog ben do-
cumentato ed illustrato dalla Gatti per l'Egitto) egizi, di unatradizione ormai ufficialmenre consacrara, ranro più data lacronologian. Lawertenza è rivolta in primo luogo alla citata C.Gatti, che diede all'epigramma la priorità sui poeti romani:mentre costoro, seguendo le prescrizioni augustee, darebberomaggiore risalto al dio di Azio, I'epigramma utilizza solo I'e-piteto Aeur&tcx; l'iniziale "Artrov sarebbe generico, alluden-do non al santuario ma allo ospecchio di mare in cui si è svol-ta la battagliaurs6; il maggior rili.rro attribuito al dio Leucadiocome sostegno di Augusto deriverebbe a Properzio dalla tradi-zione ellenistica, probabilmente da una fonte comune ancheall'epigramma: nell'elegia IV 6 vi sarebbe (un riecheggiare dimotivi>r87 dell'epigramma SF1 982 e di quello di Catilio, fat-ta eccezione, ed è comprensibile in ambito latino, dell'idend-ficazione troppo esplicita del sovrano con Zeus o Apollo. Lastudiosa addirittura sostiene che oProperzio era così volto ver-
.r8a ArpoNsi 1950, pp. 75-76. Che le 'ltime fasi della guerra civile in realtànon siano state interpretare univocamente dagli stessi poeti làtini può essere pro-vato dal Carmen de i,etto actiaco, di datazione"assai .o.rì.orr.rr*, ma' probabilmàntecomposro non molro dopo gli eventi descritti (Zoccxrxr 1987; CoinrNuv 1993,pp.334-340).
.r85 ALpoNsr 1954 (cirazione da p. 552): un breve intervento per puntua.liz-zare alcuni aspetti del culto apollineo ìn epoca augusrea, con particolare arrenzio-ne alla tradizione platonico-pÎragorica (l'iómagine*di Apollo Leucadio con I'arcocompar^e n_ei rilievi^dell'absidà de"lla Basilica piàgorica diPorta Maggiore).
186 Garll 1952, p. 151. Il confronto propirto dalla Gatti .olPnrl. A.PW251 non_pare convincente a Pece, FGE, p.^ 484: nell'epigramma di Filippo si rn-voca Apollo Leucadio, il forznidans nautis... Apolb diYlpC. Aen. III 275,-ion Azia-co, affìnché proregBa la navigazione aerso il plorto di Azio; Crcuop.rus 1922, p. 350lo ritiene una prova del soggiorno ad Azio di Filippo, forse per partecipare agli ago-ni in onore di Augusto.
r87 GArrr 1952, p. 152.
UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO 'ATESSANDRINO" PER AUGUSTO 3I7
so i modelli della poesia alessandrina che non solo atteggiava
secondo i canoni di questa' verllnte ln modo particolare sul
;;;;.-ti.o, .l.git-t*e'la III 1l' ma traevJvolentieri ali-
ffi;;;;ì;ilr;d; n.lti ia'aidi Ausustonrs8' Al conffario
\flilliamsr8e, ,il.l "tJo un? coincidenza ii tematiche tra I'epi-
;;;;; che egli '#; i;tPiegabilmente' in base alle upoliti-
:J;; ;;"..ro ít .,,o totttt'ut"e' databile dopo il 17 a'C' (co-
me si è notato' irr,.A'i it'níco terminus bos; auernè dato dal-
I,uso di Ee''otoq)1.'f" i"r,*"i,rr* l",i'tt" céeva (il Carmen
Saecularedi Orazioi Pton iV 6; I'accoglienza..del \ilo ad ry-
gusto sarebbe una "tactfi'rl adaptation> di quella a Cleopatra tn
VEnc. Aen. wrl 7i:ilt, *""'tl passo vúgiliano non ti^1l
;;;".;;"o alla fertilitàr, dominante nell'epigramma)' consr-
dera l' epigr"--i,t"" àiitìa"1tit dai modelli ^ro=mani'
seguendo
la linea irr,.rpr.,"'i't'I^tai-nrr""tii d"t1 la cautela' e goffaggine
con cui il poeta o;;1l tloiiat"tifica progressivamente Au-
;;; 25"i'ti'atv-rebbe it'ppo*t che nthe"Poet was closely
enough in touch *tt^ft ?tJi"i à' \"it to know Augustus' ex-
pressed aversion ,o- dtifit"'iín - it' fact' the Pottf may well
have been written i''' ilo*t about 17 B':C.'' when the Poet al-
ready knew th. pot-' oi Éo'""t'.Propertius' and Virgilo' Non
,i.Ípir..p.raf erq""1'i::',vi^1f"":;;Tt"nl'"1Ì::"fffi :| "' :'^ l: 1: ::" i ̂ *,'.::o"ftriÎ,1tffiffi " I i nea, il p.unto d i vis tate' come pure Io sfcssu w:" ' ' : : ' . : """"^^----^i l^ ^l :^^^^,^,,o
greco-egiziano, tot il rischio di incorrere nella disapprovazto-
ne del principe per un esaltazione troPpo esplicita délla sua di-
vinità. o di non incontrare comunque int"ti dell'ambiente cor-
tigiano latino: è molto piir economito D"t"t"" che I'autore del-
I'epigramm" rr"r.,i'à in.Egino.fosse un Greco del posto (me-
no probabitrn."tt '''io
i"i"t""ti Romani filelleni di cui tratta
\íil-liams), . .f" ''JiJtji'ttp;i"dJo
la 'ensibilità greco-egi-
zia dei suoi comp"trioti nei confronti del Bcrotl'eóq romano'
Se nulla vieta di tpt"t"tt
che I'epigramma sia stato comPosto
intorno al 17 a'C-', i presunti riferimenti alla poesia latina au-
t"#; o;.ii """i'"o" diptt'dono necessariamente da una
diretta conoscenza dei testi, quanto dall'uniformità del clima
SILVIA BARBANTANI
r88 GArTr 1952, p. 154.tse 1978, p. 125.
3 1 8 SILVI,A BARBANThNI UN EPIGRAMMA ENCOMTASTICO "ALESSANDRINO' PER AUGUSTO 3I9
politico e culturale, che accomunava I'oriente greco e l'occi-dente latino nella rrarrazione di ueuali tematicÉ.
Benché concordi con la Gatti"nell,innalzarc la cronologiadell'epigramma verso 11 27 a.c., piutrosto che abbassarla conAlfonsi verso la data del papiro it t d.C.), non mi sento dicondividere alcune posizioni della studiosa. In primo ruogo, èormai.improponibile la tesi dell"ufficialità' della poesia ig"-stea, sia nelle sue manifestazioni greche che in qu.ll. romane,secondo modelli derivati dai sistemi totalitari móderni: in nes-suno degli autori citati, benché accomunati dar consenso rora-le. o parziale nei confronti del governo augusreo, è possibile in-dividuare rracce di un uniforrÀ. progr"mira di-po'litica cultu-rale', ranro che anche gli epiteti à.1lio pror.,r-. di Augusroe il. modo di rappresentarlo ,ono all'iniegna della varie"tàre'.Inoltre non credo che Properzio avesse 6irog.ro di derivarespunti.dalla p.g.:i1 elegiaca.alessandrina del suo"tempo (cita in_fatti i 'maestri'
del !r.l.mo ellenismo ormai assunti nàl pn rlrro,letterario, Filita e callimaco), per di piir rappres.nr"rà da epi-grammisti anonimi o da abili-versifièarori càrtigiani, q,r"rràoprim,a di.lui i più autorevoli Orazio e Virgilio, {rruit"rrii 'r,i.i-no aJ princep.s e ai suoi collaboratori, avevino .irrt"to Ie vitro_rie di ottaviano. Gli 'ideali'
su cui Augusto fece leva per ac-cattivarsi se non il consenso entusiastico- almeno I'accet'taziorr.degli intellettuali così come delle masse sono comuni al mon-do romano ed orientale (il ritorno della pace ranro agognara,la. stabilità politica, Ja prosperità e.onomìca), benchJ'.r"pr.*idrversamente nelle due aree del Mediterraneo. In orienìe, latradizione del culto civico dei benefattori privati e dei dinastirent';va, più sponranee', nei decreti epigrahci come ir, f".ri",quelle che nell'occidente romano r"r.bt ro sembrate forme diempietà o manifestazioni adulatorie di cattivo gusro. È fors.p.irì semplice ?ensare :f. l. fonti ispiratrici dell%pigr"rn-ir,,alessand.no fossero, più. che componimenti poetici"romani oespressioni derivate da documenti e proclamì uffìciali, forÀ.più dirette e improwisate di propaganda' o manifer,"rio.rì di
::oîsenso,,ordi,: figurative, soite imLediatamente dopo la ,rit_
to'a navale nelle zone il cui possesso doveva ancora essere con-
reo Sui_rapporti riail princeps e i ,suoi'poeti v. Gzunpru l9g4;Wurce l99J;
NrvueN t967, pp. 36-60.
fermato il, princeps romano.' .e qui assimilate all'ideolog.ia e al-
iì:;;;;r;d tr"iirior"le ieila'monarchia locale; se I'aurore
dell'epi'eramma non è un professionista ma un dilettante ap-
;;;.il "l ..ro dirigentÉ o alla burocrazia locale, come si è
;;;;;;";" all'inizio, leímmagini e i toni da usare nel.poemetto
;il;;;;;. ttati indirett"-titt suggeriti' oltre che dalla tradi-
|iorr. .rr.o-iastica ellenistica, dai contatti con i rapPrese.ntan-
,i d.ll'"--inistrazione e dell'esercito romano' alcuni di essi'
;";; il ;;i*o pr.f.,,o d'Egitto Cornelio Gallo e lo stesso Au-
;';;,;5;i;i-;i;; ""ività "poetica amatoriale ma tutt'altro che
iisprezzabile'er.
APPENDICE
Poiché si è supposto che I'epigramma sia stato scritto (anche
se non necessartam.r,,. .otpoio) nello stesso ambiente da cui
derivano i documenti che fo'rn"tto il topoq' vi9n9 riportato
il ti; ;;;;;;e"ione dei documenti P'Lond' rr 256 a' d
ed e, riveduro ,..orrJo-I. to"t'ioti pubblicate nei volumi del-
l; i;t;;tirwngsliste.i.,,."ti in bibliografia' le ultime pubblica-
,ìorri ,.,11'irgorrr.rr.o e un controilo àutoptico del papiro'
a) Ricevuta di un ropepv{tqs .irúo11.òJl':"i1p' "0A.urí"o ri.f"g" aaÉ aue'I-isirn"chidi' per l7l8 V2
"t:"b^t,.disrano, che egll si impegna a portare a desttnaztone ad Ales-
3ffi;;;J'b;;;i'; [r) . piiotoeo-' probabilmente i naucleri
al servizio a.i q.r"ii-e'ií pilota [Wic*rN l9l2)' Anno 15
d.c.1e2
l g l su l l ' a t t i v i t àpoe t i ca i ng recode ì ^Roman i v i c i n i a l l ' impe ra to re ,apa r t i r e
dall'età auquste", u. Vtllrruuts 1978' pp' 122 ss'. .,re2 liubblicata "".hll'
\í';-íí lllz "" 443' pp' 521'523 kîr' P'orv' II
276:77 d.C.; P.oxv. rv zó4,'ró'd d-ò't nHiU'n I 9s: 25ì a'C')' V' VrrcrcN 1901'
oo. 145-146 (c[r. P.Petrie ii rii; ià, ír ".c''
scu iti soz' qz d'c'; Poxv' I 63:
íriirií.c.j ' n.*ó*t.* róoZl p. àl' p*ooxs 1e10, p' 70; S+rNeoe\ r?]5'pp'
t2t-l23;TsovpsoN triòí pp. 5iz)iri' u""*rn t938' pp' I lo-l I lr \(ru-rqce
rei8, pp. 42 ss.; BonNeJ'rll i i l i.îlzi.ls-tct S*rvari2 1948' pp' 181189;
í;r*fi 1950; Denrs rgisiîpi\';Z-r:7' po*t"It 1968' p' 102 no-ta a P,!v'
ffiiii zozrj,r (testi paralleli riemaici e romani); Swoener 1969-70;.Lavs.l983'117-l l9i srnxs ryi i ,
- ; ; . ' i t i ,r . I l
' t ' " 'potto f luviale.del le derrate
líou"iúptoul, piir tardi liturgicà, è in origine perlopiir unimpresa dt prtvatt' a cut
320 SILVTA BARBANTANI
1. . . . . lavSlql ropepv(tqg oxcrgrlq òr1pooíaq
t(&ptop6rv).l,no frs n{alpaonpos îprs òra u'ilÎnil]n9'-IÉrto6 'Arívroq
[revróp]r.ag 'Aplou l.eyr6vog òeuépug riroorfrE oruípcq
[6ett]fpugte5'Arouor].&<p orro],óyrp 6qpotolírpAoorpaliò(olv)te6
lF tQ rucrlpa Aooríoo {úlprou crneî,eu0époo r6plronXepaoto0
[Kaiocrp]og 1aíprv.'Optol,loydr èvpepl.îot0lcr nopúoolJ afir foÎ) Kc[
[ra tlto],lepai6a ["Opp]ou ro0 'Apotvoít[oo] vopo0 èv'EpoBfirg'e7
[eig Arov]óooù'e8 rcrì <Drf,o],óyou ].óyop àno t6vT€vnpcxî(l)v
[toO a (étoug)] Ttpepíou Kcioapog Xepaoto0arol,oóOrrlg 16
1 0 t . . . . . . . . l o r a n o o t ó l , r p t e e n u p o O r i p ó t o uttltttPh
UN EPIGRAMMA ENCOMTA5 ICO -ALESSANDzuNO" PER AUGUSTO 3ZI
[gro0] rSg0a]'o0 q6tól]'oo arpi0ou rerlolorlrlveupévoupe
ftpqr òr'1po]oirp r.<avrep]'otqo'lo tQ trvevrlveypévrp ùr.{' èl
ilr!ò "úo
t,tl.4E"Nópà{€. nPótou !tprcro0201 gprcrFtcul
ittl,t"íe e*""óqtt"je ò!ra. ortò fiptoov (Yivetat) &'-
>é taptapaq) tQVtn (rcrì {iptoov)l
15 ltÌq xuil rcrtoodíloo eiq ;a')'eEúvòpeav rcxì napuflóoo
tq)l
[AtovÓo]ql raì Or]'o]'ó1oo iir 0q202 óv ou^trt^19o016o0î[vat] lg
t ' . . . . lVotry[" ' ' ] ' ' ' tpg[v]QY òî"yp4203 ra] oi te^e1"oolr èlvra1.62oo
t I 'Epp'oT. I . . ttrcòq 1é1Po<Pa {rnèP aòto0.Etù to PÌ1
è a€fidata in seguito a una gara d'appalro (si conoscono solo due navi pubbliche cr-tate prima di Ùiocleziano, {,r.sr" dì Rfond. lI 256 a - I'unica nota a Bbnr.rnn 1939,p. 39 e ScHwanrz 1948, p. 183 - e quella del documento edito da GuÉnauo 1950).Nelle ricevura piìr tarde, ad es. Plond. II 301 (regno di Antonino Pio) compare ilgiuramento pei la tó1r1 dell'imperatore, qui ancoia assenre.
r"r 'W'rLcKEN 1912: ayol lqg).rea Il gen. è integrazione di \ù7rr-cx.eu 1912. Cfr. PCair.Zen.V 59849b,9-10
=_4-5: orcrgeîla r óyovto ltpvGq I À(; POxy. lXll97,9-tl (211 d.C.); POxy.){/lI2125,3-4 (220-221d.C.); POxy. >oCflll 2670,r-2 (127 d..C.).
te5 Sesto Atinio è un legionario-della legione )Cfll Deiotariana (riroorlg =rcti eirootfrg), come quasi iurri gli èninl"oór a noi noti nel I secolo, incariCatidella soweglianza del caiico di granb fino ad Alessandria; la mansione divenne poi
!i1qrgi91 e-afiìdat"-a civili. V. Scnwnnrz 1948, pp. lB4 ss.r GuÉneun f950, fp.108-109 (traduce òra èrcínl,ooo come alant poui conuoyeur, subrécargue, tto.t éortvalore di mezzo); Denrs 1958, pp. 156-157.
-
'e6 Poiché in256e si nomina uno orporqyòg tfrq pepiòoq, i villaggi di Li-simachide si trovano nell'fusinoire, divisa in tre sezioni. KrNyoN 1898a, p. 97 sup-poneva che la pepig in questione fosse l'Eraclide,.perché Polemone e Temistos era-no raggrup-pate jnsieme sorro un solo srrarego e lo scriba avrebbe usato il plurale,usezioniu. Sulla localizzazione delle Lisimachidi v. nora 218.
Ie7 II luogo, se di un toponimo si tratta, non è sraro identificato: si suppo-ne fosse nei préssi di Ptolemaìs Hormou (v. \lmsnr-v 1904, p. 60; PTebt. Iil p.376;|n CnropzuNI 1973, p. 130 è collocato erronemenre vicino a Lisimachide).
IeB fintegrazione è dcll'editor princeps. Per'WrrcrceN 1912 il nome è troppolungo per la laiuna; egli lascia quindi qui e a r. 16 il nome del primo.r".,.i.ronon inregrato. MrrrErs l9l0: [eig Atov]uo<í>ou.
ree Si tratra della ricevuta (qui ó cnóotoÀoq; cfr. Dig. 49,6,1: lineras dimis-sgrias siue apostolos) consegnata ai capitani in partenza da Alessandria (dal II sec.d.C. dal prócuratore di Naaspoleos): èrrata è quindi I'inregrazione di MtrrEts 1910:crrol"oóOrrlq tó [nupaòeòofrévol por òró olou ùnooté],,<p, anche se un partici-
lei8év]cxt crùtòv TPúP]tcr<Îo(>20 ("Etooq) P T$ePíot KoiocrPog
XeF[a]ot[o]O 'A0ìrP &
pio potrebbe essere integrato nella lacuna' Imbarcato.il carico previsto' il capitano
iil^rèi"u" una ricevuta, ttni.'i;1" q"i 'ipo't"t"' "ì
sitolosi-(\6lcrc.r l9l2' p'
521; HonrvErN 1e38, p. iìì']ed;À.-rl5i' pp' z+-D ' Úilcken'lcq'::::'.:n'
alla r. l0 si debba integrare ii 'nome del procuiitore' ed eventualmente tl suo tlto-
i.ii;,i"oii,"Elf :,'l:**.'*,*mU:Í::;,iTi'fij:,Ju:l"l;,:'fil}:,l,"Ìilii'\::$"Îi"l:'il:""1iit"il;;tù':'l;,-*::il;*'?;I"'Ul'i i tà del erano r icevuto (v' P'Oxy' IV 708' comm''ùltLcx-eN 19i2 n'432;Swnr-
i l i i i l i : ió; * É.si ; I . ' i " ' . l4 ie, I t d.c.) . -^11 o t t2 --xrcr) ,ot(ù -200 Da scartar. f"'i.rioL ii Vii.*t -1912 n' 443' Iu)"trerÌ"ortp
'
naknÀúcqr. Equivale "tt;;;;ilrQ
(tf'' fl t; GneNpsrr 1916' p' 132: comm'
" nO*. XII 1447,4-5, 'itt't"'t" di versàmento di grano' 44 d"C')' Àa a-rayrel--
) 'arîn, ' f ined *i th a g' i ' i ' ( ; i l "R*'"1'88' pp' l .za-ín: comm' a P'ory' LV
3804,141-2),ad indicare i"'n]"adil ittr" -i'lt-i"tt uffiti"lt' Lo strumento di
misurazione viene portato anch'esso da Alessandria'2or KrNyoN rsss"' ;;r,ìi,h. ifi;41$ q'"*n in the tusinoite nomeD;
pnrrsrcxr. 1 9 I 0, pp. zo-z r ì".'ii,i.". iàpi.i",. Jau "siri"' s.rsnt tt tgzs, pP;. l z l-
123eTHor . . lpsor ' r1930"" " " "g t " t f ' " / ; tuL?r incepîs i t ra t tad ig ranodtqua l r tasr -riaca ma seminato t',nt'ìi"É;itto-1ptt ríto"osox oerò Deótepog' ttporo'q' non
indicherebbero 'di prima' o ài';"tJ;à; "tlt""
tttt ài Drimou o udi secondo rac-
coltou); St;pesrerJu-vonl io)?' ";;'
;q Zl in p's.'l' 'inv'
25279'16 (Bnasuean
1995, ît" 2621, Eracleop.#, ì;/it6 "c')'-pt'a'
nuooc étt'"tpoq è definito' iòl-
otov, probabilrn.r,,., toltìrJuce I'editorà' "dtll"'^igliore qualità'' ll problema
ài q"'i" ffÎili.':'tir:;:Ji,l1'Ji'0""" editore' crr' GtcNac re76' pp"r'e7'1e8'
zo: 1(nyon l.gg.u" t1x r.. t6-i7 qllttag; "rrdr.bbt ""tt"ta
per'ùíilcken I'in-
tesrazione di Mlrrrrs r s r'ó, P" jir
^iqtJ1tró ltl"oO"tp itf,. vttttrs t 91 2' p'-260
I'T,Ji.'rirttt *r.r l9l2 pì"'p5..'tti;èóbjqit<opétvlov òî1pc; :i.ll"tt" o:t-:*-
Iri.".îi cereali trasportiti, '.ont.n.rìo in.rn u*o^o in un sacco sigillato e accom-
f"fif ,l['lJ;t'i'fr!:"; der ropepvftqs' v' GuÉnauo re50'
205 Non è verisimiie a questo punto del documento la citazione di tòv too
320 RBANTANI
t. . . . . lavSlCl roBepvftrlg orógr1q òr1pooícrq
r(cprcxg6v).l,nn îq nlalpúonpos îpq òrù #l;nír]o$'-Xértog 'Atíwog
[revtóp]rag 'ABíou
].eyr6vo6 òeurépuq riroorfrg onípcq[òeut]fpagtes'Arororî.úrp orto]"óyrp òqpo[o]írrr
Auorpcrlíò(alv)te6[F tQ no]pcr Aooríou tSúlpror ansî,er0époo rfplîon
XeBaoto0[Koíocrp]o6 1aíprv.'Optoî.loy6 èvpep[frote]ur napó
ooo ènì toO ra[tò llto],lepaíòa ["'Opp]ou toO 'Aporvoít[ou]
vopo0 èv'EBopfirgteT
[ei.g Arov]óooùre8 rcrì <Dr[o],óyou ]"óyop crruo tév -
UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO 'ALESSANDRINO' PER ATJGUSTO 3ZI
lcrro0] rSq0oc]'o0 cl6[ó]]'oo crrpi0ou rer[o]or[t]vetpévoupL
[tprp òr1po]oirp 6ov6ep]'ott!'lo tQ uvevnveYp'Éve ùT't'èl
ip'oò "f"O -er,.teoluOpbaq. rpótou ruptcroO2or ùptóFtcrq'l
i16.i,i"Íe etttoriqitdig ò-ércr. òrtò fiptoov (yívetat) &'-
:,é tcrptapaq) tQVtn (xcrl úFtoov)l
15 ttÌq rcrìl ratao{r1loo eiq 'A}'e(úvòpecrv rol 'td'pct'Ò[o-oo
Î4)l
lAtovóo]ql rcrì éú"o]'ó1ou i\r 0q'202 óv ou-ytó^oogtòo0î[vcrt] lg
t . . . . . lVotrt t [ . ' ' ' ] ' ' ' tpglvlgY òî1p4203 *o. i - oòe^t l ,oolt è]vro]"6204
lto0 cx (étouq)l Trpepíouyevqpútolv
Kaíoapog Xepaoro0
[ ] ' E P P ' 0 T ' " ' l " o r o q
leiòÉvlat cr{rtòv YPúPPactu>20 ("Eroùq) P T$ePiou KaíoaPoq'
XeFlolotlol0 'A0ìrP G'
^yéypcr<po ùnèP ot{rtoO6toc tò Pi
arcol,oó0roq t610 t . . . . . . . . l ooanoo tó l , r p reenopoOnpó tou
t>lr{plr
è affìdara in.seguito a una gara d'appalto (si conoscono soro due navi pubbliche ci-tare prma dr L)roclezíano, quesra di Plond. lr 256 a - I'unica nota a BónNrn 1939,p. 39 e. scuwtnrz, ts+p, p., I83 -_e qu.ell_l del documento edito da Gurnruo rg50).:ì:,_t.jl:1_r:
p1ù ,:ld.: ad,es. Plond. II 301 (regno di Antonino pio) compare ilgluramento per la îùXn dell rmperatore, qui ancora aò-'senre.Iei \ftLcrceN 1912: o1<o(^ing.
, . "n Il gen. è integrazione di\Wrr_crsN 1912. Cfr. pCaìr.Zen.V 59g49b,9_10= +-):_or(crgrUcr r dyovîcrl lpugS lÀ(; pOry. IX t197,9-1I (2lt d.C.); p.Oxy.)(Vl[21.25,3-4 (220-22r d.C.); pOxy. )oc(IIí 2670,r_2'(127 l.Cj.-rt5 Sesro Atinio è un legionariodella^regione )o<rr o.i.o.i"l (rirootflq =raì eiroorflg), cgTe quasi _iutti gli enínl,oér a noi noti nel I secoio, incaricatiî:.t,1i:-.glt#za
del carico d.i grano fino ad Alessandria; la mansione divenne poiIrturgrca e attrdara a civili. V ScnwnRrz 194g, pp. lg4 ss.; GuÉneuo 1950, pp.108-109 (traduce òro ènínlooo ,o^r_ o1,-*t poài ,orooyrri ,;i;;;;;g";';;" ,"valore.di mezzo)i Dnrus 1958, pp. 156-1'57. '
Poiché in 256e si nomina uno orpcrrtìyòg tîq gepíòoq, i villasei di Li_simachide si rrovano nell'Arsinoite, divisa in ,r. ,frÉni.''rcu*-ió^-iàóa",'p:"9i,"p-poneva che la pepíq in questione fosse |Eraclide, perché pot.Ào".;'i.Àìr;;r;."-no raggrup^pate insieme sorro un. so_ro srrarego e lò scriba avrebbe usato ii pl;ol.,nsezioni,. Sulla localizzazione delle LisimachTdi v. nota 218.
" "' Il.luogo,. se di un toponimo si tratra, non è stato identificato: si supur.r_
l:.:::.j:.'^l::::l.dl_t:*t.-ais Hormou (v. rVessery 1904. p. 60; pTebr. ri, p.J/o; lnr-ArDEruNl .1973' p. 130 è collocaro erronemente vicino a Lisimachidej.
,..-^^ _^-t,'lÌ.grazione è. dell'editor princeps. per \frlcrcni l9l2 il nome è troppo
::ry_f] la la.cuna; egli^lascia quindi qui e. a r. 16 il nome del primo .,"u.l..onon lnregraro. MrrrErs l9l0: [eig Arov]uo<í>ou.'" ùr rrarra della ricevuta (qui ó anóoroÀ.og; c[r. Dig.49,6,1: lineras dimis-sTrys,siye apostolos) cgn_sggnara_ ai^capitani in partenza da ?..lessandria ral fi-r".
o'\-.^oar procur:arore dr Neaspoleos): errata è quindi l'integrazione di MlrrErs 1910:cxxol"oú0<rlg, tò [napaòeòopóvq por òrcr o]ou ùnooté],q1, anche se rn p"i,i.,_
pio potrebbe essere integrato nella lacuna' Imbarcato.il carico previsto' il capitano
rilasciava una rtcevuta' ..t*^ì"Jftì"i riportata' ai sitologi iwrr-cxrN l9l2' 'p'
521; Hosr-wcrw 1938, p. i ì ì , 'eÀJ- r i5l , pp' 24-25)' Úi lcken suggerisce che
alla r. 10 si debba in,.g'"tt^il''i-t Ja pt*iatote "d eventualmente il suo tito-
t tiàd"gitì"p*ùo, li'.",i"t è però attèstata nei documenti solo in età piìr tar-
da), o nome e titolo ai ""Irr"tzui;;;;;rPgltsabile
di queste operazioni' Il
il;;;;;:iNì^rpol.o, ''t'l'"""""it' iL tompito di verificare h qualità e ia quan-
iità del srano ricevuto (t P&:^IY 'Zit}. ó- \7ncrcu 19li n" 432; Sunot-
*i* iseí-zo, su P.Berl. inv. 1419, I I d'C') '200 Da scarrar" t"'i."iorr. ài \ítt *rr ,1912 n" 443, Xo,)^eú"orrÙ =
raî,rnl'úitp. f-q"ì"d. ,,on-" "à1*éi"l'qr
(cfr' B'L.l; Gnr'Nrelr,1916' p 132: comm'
i nOtn. KI 1447'4-5, ricevuta di versamento di grano' 44 d'C')' ma a rcr"yrel-
ì"arîn, frtted with a gr;i'(;il -R*
itÀ8 ' pp' "1.28-129: comm' a Poxv' IV
3SO4,l4l-Z), ad indicare ['-.a'i,l della mis,rrazione ufficiale. Lo strumento di
Lirui"riorr. viene portato anch'esso da Alessandria'20r Kg11y9N l8ss",.;.;iiln. syti"" ki1{ glown in the Arsinoite nomeD;
pnrrsrcxr 1910, pp. ZO-Zr'ìiri,i.".ìipóri"," a*"Siri": S*rNrsrt-1925, pp' 121'
123 e TsonnsoN 1g30 ';;;;; I'eàitor princep.c si tratta di qrano di qualità si-
riaca ma seminaro "r*^ì
ì;^H;i,.-1p., fítononsosr però òeótépoq'. npótoq non
indicherebbero "di prima" o "aÌ-ttt"ìat scelta' ma^'di primou o udi secondo rac-
coltou); St;pssrrtlN-'woru i,,ilPt ;q Zl- t" Rs.'t' 'inv'
25279'16 (Bnasupal'
1995, n'2621, Eracleop"f i , . ' i : l ik." 'C') ' però' nupòc òeÓtepoq' è definito' i iò1-
otov, probabil-.n,., to*t-""Jutt l'tdito'à' 'della migliore qualità'' Il problema
ài o,t.i,. definizioni è ancora aperto'' 202 Equivale "
qÎg, ù;J;tdti"p'i,''o editore' c[r' crcNac 1976' pp' 197-198'
203 Kènyon l.gg.u" * ,. 16-i7 qulttaq; "ndr.bb.
scartata per Vilcken I'in-
tesrazione di Mrrr'rs l9ló:;: ,,l ^ieft'.p,+';rr"otrvc,r
(cfr. Mrrr'rs 1912, p. 260
no-ra 1). Wtrcrss 1912 propone ùdeo<PplqTrco>pelvjov 6îyf'"' :1,:11:: j:i:,"*
"i.r.ai cereali trasportàri,^.ontent'ìo in u" t'"to^o in un sacco sigillato e accom-
;;;;'J;td dichiJrazione del roBepv(tr1q, v' GuÉnauo 1950'204 wlLcKEN 1901.205 Non è verisimile a questo punto del documento la citazione di tòv too
SILVIA BARBANI-ANI UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO 'ALESSANDRINO' PER AUGUSTO 323
...pilota della nave pubblica che trasporta [(artabe) ...], ilcui emblema è un ibis, per tramite del sorvegliante SestoAtinio, [della centuria] di fuio, legione )C(II, coorte [II],ad Acusilao, sitologo pubblico delle [due] Lisimachidi, rap-presentante di Lucio Mario liberto... di Augusto [Cesare],salute. Confermo che sono state imbarcate da parte tua alporto di Tolemaide nel nomo Arsinoite in Ebore (?), perconto di [Dioniso] e Filologo, dal raccolto [dell'(anno) l]di Tiberio Cesare Augusto, secondo 1a.... lettera di accom-pagnamento, di grano siriano di prima scelta puro, nonadulterato, non mescolato, setacciato, secondo la misurapubblica calcolata con la grata, portata da [me] da Ales-sandria, artabe di Siriano di prima scelta millesettecento di-ciotto e mezzo, (totale) (Siriano) di prima scelta (artabe)
Ll7l8V2, che] porterò ad Alessandria e consegnerò a [Dio-niso] e Filologo o a coloro a cui si ordinerà di consegnar-1e... campione, e non ho nulla da rimproverarti ... Erm...... scrissi per lui che non [sa] scrivere. (Anno) 2 di TiberioCesare Augusto, Athyr l.
e), d) Disposizioni date al sitologo Acusilao per la conse-gna di sementi ai òqpóo'tot yecopyoi206. Le sementi sono da-te in prestito e devono essere usate esclusivamente per la se-mina di terre pubbliche, secondo la dichiarazione giurata chesi richiede ai contadini.
e) p, il documento sullo stesso foglio del quale è statoscrifto I'epigramma, con l'ordine delle autorità imperiali. An-no 11 d.C.2o7
'Eppo0 lerptopóv (PSI Yll 792,14; cfr. KarÉN 1932, pp. 103-104 noa 2 e n" 4
comm. a rectoYl l-14 e uerso V 24), I'ufficio del procurator ad Mercurium Alexan-driae (CILX3847; voN PnsveRsrEIN 1903, pp. 14-17; HottLvttN 1938, pp. 111-ll2), noto a partire dal II secolo, Si dovrebbe invece integrare un nome di perso-na; MtrtEIs 1910 proponeva ['Aop(t.1].rog)l
'Epp[eîvog vcro]trróq (l'ultima paro-la non è accetrata da \Wncrru 1912).
206 Per le integrazioni cfr. \flt-cxsN 1901, 1906, e 1912, pp. 407-408, n"344, e i volumi della BL citati in bibliografia. Cfr. POxy. LYII 3907-3909, concatalogo di documenti dello stesso tipo (-finora tredici) e analisi diplomatica (Er-Macnnagr-Tuotras 1990); PVindob.Thndem 9; cfr. POxy. )OO0 2588-2591;POxy. XLIX 3486 (41142? d.C.). Normalmente in questo tipo di documenti ilmittente è lo stratego; meno frequentemente i capi di associazioni di contadini (nelpapiro di Vienna e nel documento / qui trascritto). Coloro che ricevevano semen-ii eig òcrveíc, come in questo clso, erano tenuti ad emettere ricel'uta (VIEnecr 1895).
207 Il documento eè edito da KEuvoN 1898a, pp. 96-97;Wnc.<rx 1912, n'344. Cfr. P.Ory. MI 1024, 129 d.C. (HuNr 1910,-pp. 153-15f) e PBerl. inv.11559, 167-168 d.C. (Poernxr 1969, pp.93-99; Tovsttt 1977, pp. I-15' n" 26).
écr0otoq, flBíorou Kaioapoq'ArouotÀ'úlrrl]t 6t-
;ol,àia itotpalíòov òóo 1crlipletv' Métpqoov a{ò
"é" yi"tlpato[v] toO tpl (étouq) Kcioapoq òlpooiotg
Teú)pToîq eiq iiv yeropyoOor poorl,trrflv] rcrì tepcv
rai' ètÉipluu Tîn'b' ttùpoO &xo}'otóOlrog toîg .ùnòOtot6q6'otptcrtlnyoO tclflg pepiòoq trotìl'Aorl"rlntúòoupafot]].troO YPcr,PP[atéroq]
èrugotcrl,pévotq KcLì ènqgqpayt[opé]votg-.$ilpcrot' ou-
vEncr,Kol,ooeoóvt<ov ,[oo fottglpx]oo ra[ì"] 'ro0 Kolro-
yplopp]crréroq îîq Kótplîg KCrl tdrv ó]'[l'tov]
teligr.lo]péveY'on, eiq ${vetcr ttfrlg eiq ro llicl] (éroq)
tKoliSSpAg Kcrrcronopdq l"apò.v ficl'p'crÒr6)v Îùv
"f"fe+r"ói.i"v Xttlpstypis<piav aepì ro0 Íúvrcx' tù' nepì
tfiv [róPt1v]
è$Sqn l.ryvcr[out] Kctl Kcrrcroln]Eîplcrt tl6t 6égvtr
lLìóó n"bO ""i toîs appó(ou..o1 raì- ["""ì 1Éveet"o
ral' pqEepícrv &poopav è&ocxt ép[1pov]
iì tÍBoox.ov ì évppo1ovz" ncr9"Y" ttlîq rctg' 0v On4s-
;'r;é;itpó.b" ài'dúel'tr"av pÌ1 oî{crlpsisnq Tî9 ot""t
{rqópta rcrl rcrO{rovtcr èr toO iòiloo]
rcri rú òe2r2 onépputa rc0apa rtcril rqrcp[""] npeva
{r1r6q213 Kcrroenosoecrr eiq lùv ytîv roì pql8qvì pq0
t.t..Ocr-fft.trft t..qlgopq"o òe .t'l ò<petl"{patq u[ I
2oB Per I'editor Pinceps, come per'Wtlcrlx l9l2' p' 408 I'naltrau è la rpo-
oóòou o iòt<ottrl 1i, ,.it.tto privato su cui si pagava una tassa'
z'n \rrLcxlN rrue .*r"à". !i" 1'11isq-i".:;"UliI:"if:,Y jyi::ìi#it11oupévcov flJíncrtN. 1901): nel l9l2 introduce ouesta' accorra qa Jrn'rLL
1925, pp. 123-124. s' t'"io'atiftt'itt"'i locali da cui promana tl-l:-::IiÎt"
irrriaiÍi )jZi. >unr"o*àioueot'u"tov si riferisce a pétprloov (le autortta toca-
i;";;;rii";; le operazioni)' Cfr' P'Berl' inv- 11559a22 ss'2r0 così integra I'editor princeps, rata. rc'tpov-ottéplpoot' *t:t-y).luou
propone ìàiq" IFt gEg;i 'iti '..uottot'6€1
oPDure crvcrnctul-tcrttrotq' o
loptúolpcrot, .or, .o.,,-J"to'tli" diffe'e"t' t'" tti'Lt-inata a cereali e Brach'
lznd- eoropon ,t.orrtrorrtl .o., nftUt' 66,56 ss'; nel 1912 offre.l'integrazio,nt,q"t
accolta ianèhe ,", p., ."ur'."1.1;;;;;;ó;r,tata), ,uggerita anche da Bell (Bt I)'
2rr sulle co.dizioni ìdi;;;;-tt-t";i v' SorNeíÉr- 1925' pp' 25-29'212 Errore Per t€'2r3 Lintegrazione di Kenyon era è{vtl<xÓottoq' ma cfr' ad es' POxy' \4I
1024,32-35.2r4 T davanti a el.eopcr non è verisimile (Bell, BI I); cfr' P'Oxy' VII 1031'21-
324 SILVIA BARBANTANI
pnòè cròcò.[v] eíg ro l6rov &,nevéyrcx,o0crt cxro].oóOcogroîg ùnò coO flyepóvog nepì aùt16v èreoraî,pévorll&ncrvta ?t51q...6e ey..v[
toî .aòroO pa (éroug) K+iOOOog èrreOOíotg re rsì.ra0{rooor afv]onó],oycr îcrvîog'taol,oytoojtrónop[o0])[o]prg[rco]O npótgr; aptcpaq ò[r]arooíog tóyòolfrov_ta rpeî6 [rcrì"]
nopo0 Xupígr2 cpttúpagl òrarooí[cr]g (yívetcn) (nu_po0). Xupíoo d (ùprúpar) ony, 6v roì l.úpe tlvrcrOfror-roov STSXTúIy [òroo{v]
UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO 'ALESSANDRINO' PER AUGUSTO 325
di cui prendi la conveniente ricevuta [in duplice copia]'
(Anno)-4l di Cesare, LthYr 23'
/) Questo è I'ultimo documento a destra del tópog'. in
,.hrín.-àr, luefio sopra trascritto'. Il. documento arsinoitico
i,Vi"a"U. Tarràe- 9, àel 10 d.C', indirizzato dai rappresen-
ianti dei contadini ad un sitologo di nome Acusilao' e molto
simile a questo e probabilmenté, secondo i suoi editori' ap-
Darteneva allo stesso archivio di Acusilao da cui provengono i'fogli
del ropog ooTKol,l.iotpoq londinese'
Ilverpéprog @epiorrrvoq, iyoÓpeVloqlr(ai) Iltol,epuîoq, tonúp1r1g rcrl'Apc9p[iòopog]rcopoYpoppcrteìrg rai'Ioitov ypoptpat(eòq)lyeropy6lv oi ò tdlv ano Ktlv6lv rdól'eroq'12t8
5 ;Aroootl.úot òrlpooirp ottol'óyrp tQ rclplctl
Ilptorou Kaioapog lcripetv' Métpqoov to[îq]
tùlmoyeypappévotg òqpooíotg yeoploî[g eig]-òórt1o óréppcrtcr tffq elg tò pu é[tog]
ratoonop&q, taq relprlpanopévcq nlpîvl
10 Korcr Xpnpottopoòq 'Aorl"ertúò[ou pa]
lohl,rro'O"lpappcrtÉog, rcÈ Oíaroq otBg{tq1oOl
lraìl2re éctóctot llpioro[u] Kcioapog fiopouIloPiotll
[òe]ptépot àptúpoq 1a( (rcì fiptoov; raì eiq
tùao).(qPrYtv) (oPtúFsg) Ptl(Tivetcrt) (nupo0) lo.p F t"p""pctg) o( (roì 'iiptoov) "0
15 [6lv] to rat'tívòPa 'bnórttat
ir.grr. l" lista dei contadini in ordine alfabetico con nome'
patrontmico, simbolo di grano' di artaba e numero)'
2 lss iconosceunaCinopo l icap i ta lede lnomo.Cinopo l i tene l l 'Ep tanomide;
Kenyon la identifica -, ,iiaii" li,ià'àÀ"ni-" nell'fusinoite. Questa, come le Li-
il;"ítd; .ì.-."ri"."o J;;"fir. rra la sezione Polemone e la Temistos e comPa-
re ora sotto l'una ora t"; l;dt;;;;Ài"",iottt in epoche diverse; i-villaggi si ro-
;;;;;". " """ re,ptptc;'i;; di 1Égupat'(cfr' PtlaJig III 43; vtrcrru
l9l2 n" 387; BoNlmau ógó, pp.50-51), oggi,forse identificabile' ma senza dcu-
;;';r;;.;,; ;,h; h'g.-ivÉ.i*il ú'*'Jiltsa and Shidmoho (D' RarHsoNs'
e-mail del dicembre'szl.'V.-í"ìil \i/*iitisoa, p' 97 e PTebt' II' p' 386; cat--
pep.rxr 1978, PP- 166-167'"-'"""2tí Mrè*N 1g0l propone rcrì.al posro di,òtù, rirenendo inverosimile che
uno stratego agisca attraverso uno schlavo lmPerlale'"""
';;6;d,. (sz uf1àprap"qf o e dÈ r. sesuente (aptóFcrg) ro<t>( (rcì
ijptoov).
10
[ ( "Etorg)] pcr KaíoapoE 'A0ìrp rl.
Fausto <uicarius> di prisco, schiavo di Cesare, ad Acusilao,sjtgfgSo delle due Lisimachidi, salute. Misura dai prodottidell'(anno). [40] di Cesare ai pubblici contadini, p.ì l" ,.._ra che coltivano, la regia e la iacra e I'alrra, <una quantità>di grano secondo i campioni spediti e sigillati da Oiax, stra_tego della sezione, e da fuclepiade, regiò segretario, con su_pervisione.del toparco e del segretarió del villaggio e deglialtri [soliti], in presrito per la semina dell'(anii) t4tl liCesare, prendendo da essi la conveniente dichiarazio;. gru_rata di irrigare tutti i terreni intorno al [villaggio] e dis.-minarli al momenro opporruno col grano . {lí.àntU ... .di non lasciare n.rr,rrrJ
".,rr" tr"r.,,i"t" o .r-o' irrigata o
rroppo irrigata... rasse e convenienti <prodotri> dal póprio,e che le sementi pure e [setacciate]... in modo.ori.r,à r"_ranno seminate nella terra e a nessuno né ....,......... pro_dotti e che non se lo accaparreranno second.o gli ordini delprefetto in materia, tt.rtto q,.r".rto .orr" l. tasse e i<prodotti> convenienti dello stesso (anno) 4l di Cesare,senza alcuna deduzione, di grano siriano di prima scelra, ar_tabe duecentoorrantarré [e] di grano siriano artabe duecen-to, (totale) (di grano) siriano di prima scelta (artabe) 4g3zt7,
22 =_Mrcrev 1912 n" 343, note r. 22; per ò<peLl,t'1pcr,1c cfr. pBerl. inv. 11559,25-26; P.Oxy. VII 1024,30 ss.Si sottinrende forse onÉpprcxtcÍ,, come anche ad avùnól,oyq,: in ouesre ._ghe do'eva esserci la clausola delia resriiuzio". J;iÈ;;;';;'; ;#;.'216 Le rerre év ùnol.óTrp apparrengono ah ."i.e;ri" ai i".ri. íài'..-.r".-
mente coltivabili (HoHr-wprr.r t93'g, pp. àt-+Z;. U.rp.."r.i".. aja..";;r;;;"-babi lment_e eq uivale semplicemen re ji" .l".,ro í",,r#;;.;;; i;d";;;.
"" t''" La sressa somma compare in pVindob. Tandem 9 rr. 7 e 22.
l
iiì
il,1il
ilì
uN EpTcn,tMMA ENcoMtASTICo "ALESSANDRINO' PER AUGUSTo 327
326
Pneferos figlio di Temisone, capo <dei contadini>2zr, e To-lomeo, toparca, e Artemidoro, segretario del villaggio, eIsione, segretario dei contadini, tutti e quattro di Cinopo-li, ad Acusilao sitologo pubblico, rappresentante2zz di Pri-sco, schiavo di Cesare, salute. Misura ai sottoscritti pub-blici contadini, in prestito, sementi per la semina dell'an-no 41, stabilite da noi secondo le disposizioni di fuclepia-de, regio segretario, e di Oiax, stratego223 [e] di Fausto <1.,i-carius> di Prisco, schiavo di Cesare, 697 y2 artabe di gra-no siriano di seconda scelta e in [aggiunta22a 110 (artabe)],(totale) (artabe) (di grano) (siriano) di seconda scelta 807Yz, segue la lista dei loro nominativi.....
Ho condotto ie ricerche sul Plond. ll 256 in Inghilterra grazie a una borsa di per-fezionamento dell'Università Cattolica di Milano, tra il giugno e il dicembre 1997.Sono riconoscente a E. Bowie per I'ospitalità presso il Corpus Christi College,Oxford, e per aver discusso con me le varie €asi del lavoro; grazie anche a R. Hun-ter (Pembroke College, Cambridge) e, per la consulenza nella sezione documenta-ria, a D. Obbink, A.K. Bowman (Christ Church College, Oxford), D. Rathbone(Kingt College, London), M. Sharp e D. Colomo; preziosa mi è stata la disponi-
ljtlî,l.t Pro[ P.J. Parsons. La responsabilita di tutto quanto è scritto resta soltan-
22r SI;RrsreryN-lVonl 1976, pp. 43-44 escludono le integrazioni iepéotv(Kenyon) e rópr1g @.L \ p. 250): in PVindob. Thndem 9 un personaggio che n-copre la stessa caflca e crrato tout-court come îlToolttvog.
222 St;r,estegN-\lonp 1976, p.44: comm. a PVndob.Tandem 9, r. 11, in-terpretano ó nopa Aouríor rtl,. come Stelluertreter uon, anche se quesro non si-gnifica che Acusilao fosse aI servizio del liberto imperiale.
223 Asclepiade segretario regio compare anche in PVndob.Thndem 9, rr. 18-19 (v. B,q.srr,qNlNI-Wurtesomn 1987, p. 126), dove lo srrarego invece è un certoQóaî,oq. Accanto ad essi è presente, come qui, uno schiavo di uno schiavo impe-ride, Sifilo di Cresimo, qualificato come forologo. Lo stratego Valerio Varo è no-to come stratego della sezione Temistos dell'Arsinoite in BGU lll 757 (12 d.C.):il segretario Asclepiade si mova invece in PMert. I 9 (12 d.C.). In effetti, notanoanche Sijpesteijn e Worp (1976, pp. 45-48), è possibile che gli sconosciuti villaggidi Lisimachide non appartenessero alla sezione Eraclide (v. nota 218) e che Acusi-lao fosse sitologo nella Temistos (CaroEruNI 1924, p. 64 lo annovera tra questi).Non sappiamo però di quale pepiq fosse stratego Oiax (catalogato come strategodella Temistos in BasrnnrNr-\WHITEHoRNE 1987, o.39, della Polemone in Bnsrtl-NINI 1972), né se dawero fuclepiade è la stessa pìrsona in tutti i papiri citati.
224 laggiunta è contata separatamente perché serve all'Ènrpepropóq (coltiva-zione obbligàtoria di terreni al di fuori dal territorio del villaggio) per altre terre dicondizione diversa da quella elencata (cfr. SI.Jnrsrrryr.r - \7onp 1976, p.49: comm.a P.Vndob.Tandem 9, r. 20; Tsot'.rpsoN 1930, p. 206; PorrHxe 1969, pp. 93-99,Tovsrtt 1977, n" 26: comm. a P.Berl. inv. 11559 I16-17).
BIBLIOGRAFTA
La bibliografia sugli argomenti trattati-è sterminata e si è accresciuta
vertiginosamente negli li;;i-;ttt"ni' Si elencano qui solo i testi cita-
ti nell'articolo.
R. ArseRr 1981: Das Bild' des Augustus aufdy ftiihen Reichspràgungen'
Studien "u' wf i)'g-;7' tìt"""Prinzips' Spever am Rhein
^ *$;?l Redeunt saturnia Regna I4; Frorn theAion Plutonios of the
Ptolemies "
th' ;;;;L'* F"'gift'u m. o'f the Roman Ernperors' in
Greece and' 'n' ú'i*' t'l'a;"'ío"on in'Ancient Hisnry and Prehi-
story. studies p";;;;';'ti- i"s'ho'h"rney on the occasion of bis Ei'
ghiieth Birthda1";';;"Kn' KrNzu-dt'lin - New York' pp' 1-30
1e7e: Redeu". é;';;;; R' g"? wI:, !rus'fer-Tîipt'(1m1f im pto'
lemijisc h-rónti" h;;' il;;il'í'wt' Chiro n -9'
Pp' 5 53 -606
t *ilìil sull,epigramma drt pccLw d.el Museo Britunnico, Aegyptus
30, PP.72-76ié'síi s"ltae'llo augusteo' Aevum 28' pp' 552-555
t' *"rrrot sitologia in Roman ngyPt:!!^!'pp' 289-307 (orain Esays
and Papers, Athens 1994' pp' 5>->vt --) +t"" pnlo of Sirclor'
1956: upon si;;ì;s;;'t'' ài*on Eg4pt and the Role of Sitologi in
its Fin anc i a I Ai*f"'i ú''o'i' vri"' 3o^p"pyrussamml' Ost' Natio-
nalbibl. \íi'" ;;";;' tt zz (Essavl 1ee4' pp 5:''57 ' ^ "1970: A Re,ei;; í;'1;:'lto'tog"E'do"'d oid np'n into Account
by a Prahtor si;íí"'íttiioî a'o'' Aesvptus 50' pp' 74-87
M' Ava.lo'mr 1990: L'Egixo nugusteo na 'o'itl'i continuitA' JJP 20' pp'
n.o. K2i*roN-P'J' PensoNs-R'G'M' Nrsger 1979: Elegiaa by Gallus*" -fr;;
a"'r Ib'rîm'JRS 69' pP'125'/,5:5C. BnlcoNr 1976t Do'u"enti'gzeci e latini d'Egixo di eta augustea'-' -
LgYPttts 56' PP' 208-286
A. Baruce'zzt1964: Su due epigrammi d'i Dornizio Marso' L L'epigramma di Azia
mad're d'i a'g'i'ti' Athenaeum 42' pp'261-265
1974: (Jn fali"' i''Utnno a PaÀ di Arato' RhM I 17 ' pp' 271-
c. s.Îr16*"t" t 1972: Gli strateghi d'ell.Arsinoite in epoca roTnana' P^py'
rologica Bruxellensia l1' Bruxelles
G. B.qsruNttl t-C' Gitnzt 1993: Il poeta rinoaato' Ca' de Sass 121' pp'
34-39
liiltil1lrinii;jrillllllji lLll
'llirl;liiill
328 SILVIA BARBANTANI UN EPIGRAMMA ENCOMIAS'|ICO 'AIESSANDzuNO' PER AUGUSTO 329
G. BasrtanrNr-J. lWHrrEHonNr 1987: Strangi and Royal Stibes of Ro-man Egypt. Chronological List and Index (Papyrologica Florentinal5), Firenze
Berichtigungsliste der griechischen Papyrushunden aus Agypten (BL)I 1922, hrsg. F. PRltstGKE, Berlin - LeipzigII 1929, hrsg. F. Btle.rtL, HeidelbergM964, hrsg. M. DnvrD, B.A. var'r GRoNrNcrN, E. Kressr-rNc,LeidenV 1969, hrsg. E. BosrnNxtL, M. Daun, B.A. vnN GRoNrNcpN,LeidenVII 1986, hrsg. E. BosrxnNru-, \M Cunyssr, P\M PEsrveN, H.-A. Ruppnrcnr, LeidenIX 1995, hrsg. P.\W. PesrueN, H.-A. RuppnecHr, F.A.J. HocrN-ourc, Leiden - New York- Kciln
É. BrnNnNo1969a: Inscriptions métiques de I'Egypu gréco-romaine. Rechercltessur la poésie épigrammatique dzs Grecs en Egypte, ParisI969b: Les instiptions grecques et latines d.e Phike II. Haut et BasEmpire, Paris
E. BEnNscKEn 1965: RE suppl.X, s.u. Eú9r1vtapyau rr. 189-190, Stutt-gart
E. BenrnaNo-EcnNvrr- 1994: Présages et propagande idéologique: à proposd'une liste concernant Octaaien Auguste, MEFRA 106.2, pp. 487-53r
P BtNc 1988: The Well Read Muse. Present and Past in Callimachus andtbe Hellenistic Poets, (Hypomnemara 90), Góttingen
J. BrNceN 1969: Le PStrasb. 191 et Ia sitologie, CE 44, pp. 345-346F. Brunrrvnrer l9l3 Der iigltptische Kaiserhult, APF 5, pp.317-345E. BónNen 1939: Der Staatliche Korntransport im griechiesch-riimisclten
Agltptrn, Diss. HamburgD. BoruNreu
1964: La nue du Nil, diuinité égltptienne A ilauers mille ans d'hi-stoire (332 au.- 641 ap. J.-C.), Parisl97l: Les rttes de k crue du Nil. Problèmes de lieux, de dates etd'organisation, REgypt 23, pp. 49-651993: Le régime administratif de I'eau du Nil dans I'Fg,lte grecque,romaine et byzantine, Leiden -New York- Kóln1995: La diuinité du Nil sous Ie principat en Ég1tpte, in ANRW Il18.5, Berlin -New York, pp. 3195-3215
G. Bourvpnr7970: Esclaues et afranchis sous le Haut-empire Romain. R6le poli-tique et adminisnatif Napoli1974: Domestique etfonctionnaire sous le Haut-Empire Romain. Lacondition de l'afranchi et de l'esclaue du prince, Paris
G.'\?. Bo'wnnsocr 1965: Augustus and the Greeh WorM Oxford' rist'
\festport, Connecticut 1981E.L. Bovri 1990: Greek Poetry in Antonine Age, in Antonine Literature,
ed. D.A. Russell, Oxford, PP. 53-90A.K Bowl,mN
1996: Egypt, in Cambridge Ancient HislW*, edd' A'K' BowvaN'
E. Cnavpl-rN, A.\7. Llt'trotr, pp. 676-7O2A.K Bowr,am-D. RarnsoNz 1992: cities and Adminisnation in Roman
Egypt, JRS 82, PP. 105-127W. M.Enesnser. 1995: Agyptische tJrhunden aus den Staatlichen Museen
zu Berlin, GriechiscÈ'urhunden, XVI Band: The Archiue of Athe-
nodoros (and' Assorted Documents of the Augustan Period)' -BerlinC. BnuuN l99}: Sorne Comments on the Status of Imperial Freedmen- -
(ittt Case of Ti.Ctaudius Aug' lib'Clasicuù' ZPE 82' pp' 271-285lW.H. Bucrr-en 1935: Auguste, Zius Panoos, RPh 9, pp' 177-188
R.L.V. CecNAT l91l-27: Insoiptiones Graecae ad res Romanas Peftinen-/er, Paris, rist' Roma 1964 (IGPO
H.A. CnnN 1944: Zu einem Miinzbild' des Augustus' MH 1' pp' 203'
208F. CrunNs
1984: Propertius and the Banle of Actiunt, in Poetry^and. Politics in
the Age oTArguurr, edd. A. \7oónvaN, D' '$(/ssr' Cambridge' pp'
r29-1681989: Vergit's Augustan Epic, Cambridge
A. Cru-orruNi1924:@HZAYPOI.Ricercheditopografaedistor iadelhpubbl i 'ca amministrazione nell'Egixo greco-roman4 Milano
1973: Dizionario dei ooúi gtlg'afti e topografci dell Egitto greco-
rornAno, a c' di S. Da-n:s, II,1, Milano1978: Dizionario dei nomi geografici e topografici dell Egitto greco'
romano' a c. di S. Denrs, III,1, MilanoA. Cevsnolr
1982: The Empress and the Poet: Paganism and Politics at the Court
of Theodasius 11, YCIS 27 ' Pl' 217--2891993: The Crrrh A,'thohgT from Meltager to Planudes' Oxford
1995: Callimachus and Èt C'ititt' Princeton New JerseyA. 6{ A. CevrnoN 1966t The Cycte of Agath;at' IHS 86' pp' 6-25
L. Crnrnw-J. ToNoRrau 1957: -rJn
'in'u"'nt du Christianisme' Le cul-
rc des souuerains dans la ciuilisation gréco-romaina Paris
F. CHavoux 1956: Le roi Magas, RH 80, pp' 18-34 .E. K. CHTsTnNSEN 1988: Thi Roman Coins of Alexandria' Aarhus l-)en-
markC. Crcrqoruu s 1922: Riimische Stud.ien: historisches, epigraphische' lite'
rargeschichtliches aus uier Jahrhunderten Roms, Leipzig
330 SILVIA BARBANTANI
'W'. Cr"qnvssr, 1983: Literary Papyri in Docamentary oArcbiuesr, in Egypt
and the Hellenistic World, Proceedings of the International Collo-quium Leuuen 24-26 Ma1, 1982, (Studia Hellenistica2T), edd. F..VaN'l DRCrc, P.VeN DesseL,'W VeN GucHr, Lovanii, pp.43-61
C. Cocnosst 1978:. Lapollinísmo augusteo e un denario con il Sole ra-diato di L. Aquilio Floro, CISA 5, pp. 138-l5B
E. Coucxv 1927 Epigrammatum Anthologia Paktina cum Planudeis etAppendice noua Epigramrnatum ueterum ex libris et marmoribus duc-torum, vol. III, Parisiis
E. Counî'IBv 1993: Fragmentary Latin Poets, OxfordG. CousrN-G. Descrnups 1887: ErnpkcenTents et ruines de la uille de
Cys en Carie, BCH 11, pp. 305-3ltR. CrustoRE 1995: A Hymn to the Nile, ZPE 106, pp. 97-106'W'.
CnÒNenr1901: Litterarische Tèxte mit Ausschluf der chrístlichen, APF l, pp.104-t201925: De critici arte in papyris exercenda, in Raccoba di snitti inonore di G. Lumbroso, (Pubblicazioni di Aegyptus, Serie Scientifi-ca 7), Milano, pp. 439-534
S. Danrs 1958: Osseruazioni su alcuni papiri di carattere militare, A.gyp-tus 38, pp.149-158
M. Da.,rrs 1988: Epicorum Graecorum Fragmenta, Gòttingen'W. DnrpNertcsR.
1903-5: Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, Lipsiae @GfS)l9l5-24: Sylloge Insniptionum Graecarum nunc tertium edita,Leipzig (SylP)
F. DuruaNn 1983: Culte royal et cuhe impérial en Égtpte. Continuités etruptures, in Das Rdmisch-byzantinische Agypten. Ahten des interna-tionalen Symposions 26-30 Sept. 1978 in Trier,hrsg. G. Gnrutr, H.Hr,INeN, E.
'S(/'rNtsR, Mainz am Rhein, pp. 47-56
J. Enenr 1972: Griechische Epigramme auf Sieger an Qtmnischen undHippischen Agonen, ASA\í 63,2, Berlin
\W. Ecrc - J. Hrwzucns 1993: Sklauen und Freigekssene in der Gesell-schart der riimischen I(aiserzeit, Darmstadt
'W'. Ecr 1994: M. Lucretius lulianus, Procurator Augustorum. Zur Funk-
tion und sozialen Wertschdtzung uon Prouinzialproburatoren, ZPE100, pp. 559-576
H. Er-MecnRABI - J.D. Tnoues 1990: comm. a P.Oxy. Ll'4J 3907-3909
R. ÉrrrNNE. - M. PIÉnenr 1975: Un décrer du Koinon des Hellènes àPktées en l'honneur de Glaucon, fik d'Etéoclès, dAthènes, BCH 99,pp. 5r-75
J. R. Faans l98l: The Cuh of Jupiter and Roman Imperial ldzology,ANRWII I7.1, Berlin - New York, pp. 3-L4l
LTN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO "AIESSANDRINO' PER AUGUSTO 331
P. Fror,ri 1965: Properzio, Elzgie libro M Batr
J.-L. Frnnnnv 1988; Phileilenisrne et Impérialisrne: tspects idéologiques dela conquète romaine du rnonde hellénistique, Patis
A. FnsruciÈnr 197ù Les proscynèmes dc Philae, REG 83, pp. 175-197M. Fsyer 1955: InsriPtions inédites dAchraipha,BCHT9, pp.417-422D. FIsnwrci< 1992: On the Temple of Diuus Augustus, Phoenix 46, Pp.
232-255R. Frstscsrn 1996: Hellenistic Royal lconography on Coins, in Aspects of
Hellenistic Kingship, edd. P Btloe, T. ENcseRc-PrnERsEN, L. HAN-NESTAD, J. ZNtrr, Afuhus, pp.28-40
G. FónscHlren 1989: Die Miinzen der Riirnischen l{aiser in Alexandrien,Frankfurt am Main
P.R. FneNxs 1976: Apollo Leucadius und Octauianus?, Chiron 6, pp.r59-163
P. M. Fnessn 1972 Ptolemaic Alexandria, Oxford (P,4)
J. Ge.cÉ1936 Actiaca MEFR 53, pP'38-1001955: Apollon Romain. Essai sur le culte dApollon et le-déuehppe'rnent di <ritus graectts> a Rome d.es origines a Auguste, BEFAR 182'Paris
I. Garu Cat-nr,ruNt1987: Lbpigramma tard\antico: tadizione e innouazione, Yichiana16,pp. 103-1341991i Retorica e realtA negli epigrammi di Agazia Scolnstico, AAPn.s . 41 , pp . l l3 -1271995: Ui- epigrammista di età giustinianea: Giouanni Barbucallo, in
La Poesia Biùrtina, Atti della terza Giornata di studi bizantini sot-to il panocinio della '4ssociazione haliana di Studi Bizantini (Ma'
ceratà tI-12 maggio 1993),ITALOE^^HNIKA, Quaderni 8, a
c. di U. Cp.rscuoio e R' MatseNo, Napoli, pp.79-lI2
J.-D. Gnucrn 1984: Der Rom-Hymnos dzr Meliino (Anth' Lyr' II2 6
209f) und d.ie Vorstellung uon drr oEwigheit' Rorns, Chiron 14' pp'
267-299P. GnurHrr,n 1985: Les cités grecques et leur bienfaiteurs (BCH Suppl.
12), ParisC. G,trr 1952: Un e?igramlna sulla battaglia di Azio, PP 22-27' pp'
r49-r57A. Gr,mEn 1974: Katalog Alexandrinischer Kaisermiinzen der Sammlung
d.es Instituts fiir A"ltertumshunde der (Jniuersitàt zu Kiiln I, Abh'
Rhein.-Westf. Ak. \Wiss, Papyrologica Coloniensia V, Opladen
G. Genncr 1983 Genesi delk prouincia romnnA d'Egitto, Bologna.
V. Glcasrn-LaNzena 1994: oDa Zeus i rer. Poesia e Potere nellAlessan'dria dei Tblernei, in , spetti e problemi dell'Ellenismo. Atti del Con'uegno di Studi Pisa 6-7 nouembre 1992, a c. di B. VlncILIo, Pisa,
P P . 9 l - 1 1 8
1 1 / SILVIA BARBANTANI LINI EPIGRAMMA ENCOMIASTICO "ALESSANDRINO, PER AUGUSTO 333
F.T. GtcNrc 1976: A Grammar of the Greeh papyri of the Roman andByzantine Periods I, Phonologl, Milano
B.K. Golo 1987: Literary Patronage in Greece and Rome, Chapel Hill- London
S. Got-pHrr-l 1994: The Naiue and Knowing Eye: Ecphrasis and the Cul-ture of Viewing in the Hellenístic World, ín Ari and Text in AncientGreeh Cubure, edd. S. GoLoHrLL, R. OseoRNr', Cambridge, pp.r97-223
A. GosuNc 1992: Political Apollo: from Callimachus tu the Augustans,Mnemosyne 45, pp. 501-512
A.S.F. Gow - D.L. Pece1965: The Greeh Anthology. Hellenistic Epigrams, Cambridge (liÈ)1968: The Greek Anthology. The Garland of philip, CambridgeGN
P GneNner 1986:, Les songes d'Az;a et d'Octaaius. Note sur les rapportsdAuguste et de l'Ég1tpte, RHR 203, pp. 365-379
B.P GneNpslr 1916: comm. a POxy. XII 1447J.-C. GruNrm
1986: L1 Prophète et lAutokratoa REgypt 37, pp. gt-891995 L'Ernpeleur et le Pbaraon, in ANRIV II 18.5, Berlin - NewYork, pp. 318l-3194
J. Grurrn l9B4: Augustus and the Poets: oCaesar qui cogere posset,, inCaesar Augustus. Seuen Aspects, edd. F. MrLla'n., E. Srcar, Oxford,pp . 189 -218
G. Grurr.rr'.r l98l: orient und ohzident in der l{unst Alexandriens, in
^ ^Alexandrien, Aegtptiaca TTeuerensia I, Mainz am Rhein, pp. 13-25O. GuÉnauo 1950: Un aase aJtant contenu un échantillon de bú @EIf -
MA),IJP 4, pp. r07,rr5\7. G{-rrvrHsn 1971: Das orahel uon Didyma in hellenistischer Zeit. Ei.R. A. Gunvar 1995: Actium and Augustus. The politics and Emotions of
Ciuil Var, Ann fubor MichiganC. HasrcHr
1970: Gottmenschentum und Griechischen Stiidte, Zetemara 14,Mi.inchen1973: Die augusteische Zeit und das erste Jahrhundert nach ChristiGeburt, in Le culte des souuerains dans I'Ernpire Romain, in Enne-tiens Fondation Hardt 19, Genève, pp. 4t-997996: Diuine Honours for King Antigonus Gonatas in Athens, SCIl 5 , p p . l 3 l - 1 3 4
H. Ha-enrNs 1948:Zaníp et orrrtqpíu (Srudia Hellenistica l5), Lo-vanii, pp. 57-68
A.E. HaNsoN 1989: Village fficials at Phikdelphia: a Model of Roma-nísation in the Julio-Ckudian Period, in Egitto e storia antica dal-lEllenismo all'eta araba. Bilancio di un confonto. Atti del colhquio
internazionale, Bohgna 31 agosto-2 settembre 1987, a c. di L' Cnr-
scuolo e G. Gnnect, Bologna, pp. 429-440A. Hamsn 1985 Euripidu Kresphontes and Archelaos, LeidenA. Hanon 1983t Statlus and the Silvae.' Poets, Patons and Epideixis in
the Graeco-Roman Voild, LiverPoolP.R. HenorE 1986: Virgil's Aeneid. Cosmos and lmpetium, OxfordU. HnusrraeNN 1981: Zur Tlpologie und Ideologie des Augastus Portriits,
in ANRIV[ 12.2, Berlin - New York, pp. 515-598H. HpTNEN
1978: Aspects et Probhmes de la monarchie ptolémai:que, Ktema 3,pp. r77-r991983, O;t fryphè d.es Ptolernaios WII. Euergetes II. Beobachtungenzum Ptolemiiiichen Henscherideal und zu einer riimischen Gesand'schaf in Agyptrn (140/39 VChr.), in Abhistorische Studien H.Bengtson zum 70. Geburtstag, hrsg' H. HslNEN, lViesbaden, pp.l 16 -1301995: Vorsnfen und Anfiinge des Herrscherkultes im riimischen Àg1tp-
ten, in ANRW II 18.5, Berlin - New York, pp. 3144-3180E. Hurscu 196l-4: Die griechischen Dichterfagmente der riimischen l{ai'
serzeit, Góttingen (GDRóóS.J. Hevwonrs 1994: Some allusions to Callimachus in Latin poetrl,MD
33, pp. 5 l -79G. HrnscHiu-o-F.H. Mansrnrl 1863-1916: The Collection of Ancient
Greeh Inscriptions in the British Museum IV Oxford (GIBM
M.C. Hoee 1992: Augustus, Apollo and Athens, MH 49' pp. 223-232
N. HonrvetN 1938: ie blé d'Églpte, Ér.de Pap. 4' pp. 33-119A.S. HuNr' 1910: comm. a P.Oxy. Vll1024R. Huwren 1992: Callimachus and Heraclitus, MD 29, ll3-123
E.G. Huzen1988: Augustus, Heir of the Ptolemies, in ANRV II 10.1, Berlin -
New York, pp. 343-3821995: Empìrir W'orship in Julio-Claudian Egypt, in ANRIYII I8'5'
Berlin - New York, pp. 3092-3143K. JeNoen l9l3: oratorum et Rhetorum Graecorum Fragmenta nuPer re-
perta, BonnH. JanNverru 1972: Dioniso, religione e cultura in Grecia, Torino, 1" ed'
Paris l95lO. JessrN
1905a: RE V s.v. Eleutheria, rr. 2344-2345, Stuttgart1905b: REV s.v. Eleutherios, t.2348-2351, Stuttgart
C.P. JoNes1993: The Decree of llion in Honor of a King Antiocbus, GRBS 34,pP.73'921997: Epigrams fron Hierapolis and Aphrodisias, Hermes 125, pP.203-2r4
334 SILVTA BARBANTANI UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO "ALESSANDzuNO" PER AUGUSTO 335
H. JomeN - C. HúmpN 1907: Topographie der Stadt Rom im AherthumI 3, Berlin
H. Jucrrnl98l: Riimische Henscherbildnisse aus Aglpten, in ANRW II 12.2,Berlin-New York, pp. 667-6871982: Apollo Paktinus und Apollo Actius auf augusteischen Mùn-zen, MH 39, pp.82-100
L. KnHn- 1996: Culx in Hellenistic Alexandri; in Alexandria andAlexandrinism. Papers Deliaered at a Symposium Organized by theJ.Paul Getty Museum and the Geny Center for the History of Artand Humanities, and Held at tbe Museum April 22-25 lig3,- Ma-libu California, pp. 75-84
G. Katsel 1878: Epigrarnmata Graeca ex lapidibus conlecta, Berolini, ri-st. Hildesheim 1965
T. Knr-Ér.r 1932: Berliner Leihgabe Griechischer papyri I, UppsalaB. Kur 1916: Eípfivr1. Eine philologisch-antiquarische Untersuchung Be-
richt ùber die Verhandl. Kón. Sàchs.Ges,\Wiss. zuLeipzig, pÈit-ti-st. Klasse, 68, 4
B. A. Knluv1985: Scubural Programs and Propaganda in Augusta.n Rome: theTemple of Apollo on the Palatine, in The Age ofAugustus. Interdi-sciplinary Conference Held at Brown (Jniuirsitl, Aplil 30-May 2,1982, ed. R.
'WrNxrs, Louvain la Neuve, pp. 169-l7G
1990 Tbe City Adorned: Programmatic Display at the Aedes Con-cordiae Augusra€, in Between Republic ani E*pire. Interpretationsof Augustus and His Principate, edd. K.A. Reerll,us, M. Tonrn,Berkeley - Los Angeles - Oxford, pp. 276-307
G. KnvyoN1895: Une épigramme sur la bataille dActium, RPh 19, pp. 177-1791898a: Greeh Papyri in tlte British Museum II, London
]898b, Fragments d'exercices de rhétorique conseraés sur un papJtrus,in Méknges H. Weil" Paris, pp. 2$-Z4B
R. KEmell1934: Zwei Stùche Griechisch- tigyptischer Poesie, Hermes G9, pp.420-4251936: IIATPIA EPMOYIO^EQ>, Hermes t7, pp. 465-467
D. KiBNnsr 1969: August und Alexander, Gymnasium 76, pp. 432-45GE. KtenrtNc 1969: Wiirterbuclt der griechischen Papyrushunien, Suppl. I,
AmsterdamF.S. Kt-trNen 1988: The Arch in Honor of C.Octauius and the Fathers of
Augustus, Historia 37, pp. 347-35iL. KoeNrN
1959: @eoîotv è10pó6. Ein einheimischer Gegenhiinig in Agypten(132/1a), CE 34, pp. 103-119
1968: Die Prophezeiungen des .Tiipfers,, ZPE ?, pP' .178-209. -1970: The Priphecies oia Ponert a- Prophecy of \Vnld Renew1lle-
colnes an Apocalypse, in Proceedings of the XIhh. International con-
gnu of Pap)trology, Ann Arbor lulichigan 12-17 August 1968, ed'
D.H. SavÚel (American Studies in Papyrology 7), Toronto - Am-
sterdam, pp. 249-2541983 : D ie adaptation Aegtptis ch er Kiinigsideo logie am Pto lemiierh of,
in Egypt and the Hellenistic VorA. Proceedings of the International
Colloquium Leauen 24-26 May 1982, (Studia Hellenistica 27)'
edd. E. VeN't Decr, P. VaN DesstL,'W. Ven Gucul, Lovanii, pp.
r43-r901993: The Ptolemaic King as a Religious Figure, in lrnages and Ideo'
logies: Self Defnition in the Hellenistic World, edd. A. BuLLocH,
E.S. GnuEN, A.A. LoNc, A. Srrwenr, Berkeley - Los Angeles, pp'
25-1r5E. KonNr,uaNN 1907: "Avo[ rcrtvòq,
'A6pravó9, Klio 7, pp' 278-288
A. KnANzr-r,tN 1952: PVind. inu. 25824 a/, b/ U.Amh. 65, 4 Kapitel:
Die Sitologie gegen Ende des ersten Jahrhunderts, JJP 6' pp. 215-223
H. Kvrusrers 1975: Bild'nisse dzr Ptolemàer, Berlin
U. Lern 1967: Le iscrizioni relatiue all'intoduzione nel 9 a.C. del nuo-
uo calendario delk prouincia dAsia, SCO 16' PP. 5-98
P Leunnrcsrs1953a: Augustus en Apollo, Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschie-
denis 15, pp.85-124I953b: Li potìtique oapollinienne, dAug.r.ste et le cu6e imperial, La
Nouvelle Clio 5, pp. 65-82E. t qlp 1965: De Callimachi Cyrenaei tropis et fguro Diss' Bonn -E. Ln noccn 1994: Theoi epiph:aneis. Linguaggio fguratiao e culto dina'
stico da Antioco M aà Augusto, in iúalit und Kuhu' im Rom der
Kaiserzeit, hrsg. K. RosrN, Bonn, pp' 9-63
H. Lesr 1953: Thelabula hebana and Propertius 11,31, JRS 43' Pp'27'29
H.P. Leuescurn 1991: Ptolernàische Reiterbilder, MDAI(A) 106' pp'
223-258P. l-q.unrNs 1989: LAbeillc dans lAmbre. Célébration de l'épigramme de
I'époque alexandrine à k fin d.e la Renaissance, París
H. Le ÈoNNtrc - H. Gnurr óe SnNrrnnr 1953: Pline lAncien' Histoi'
re Naarel liure WIV ParisM. Le Gr-ry l98l: Aionin Lexicon lconographicam Mythologiae Classi-
cae, Z;úrich - Mùnchen, pp. 399-4llN. Ltvts
196l: Leitourgia Studies, in Proceedings of the IX International Con-
gress of Papyrology, Oslo lgth-22nd August 1958, ed.. L. AvuNn-seN, Hertford, pp. 233-245
336 SILVIA BARBANTANI
1963: Leitourgia Papyri. Documents on Compulsory Public Seruicein Egpt under Roman Rule, Philadelphia1969: On the Starting Date of Liturgies in Roman Egypt, TAPA100, pp. 255-2601983 Life in Aegypt under Roman Rule, Oxîord19972 The Compulsory Public Seruices of Ronnan Egypt, Firenze, 7'ed. 1982
J. Lrrcr-r l94l: Die Miinzpràgung Octauians nach dem Siege uon Ahtiumund die augusteische Ifunst, JDAI 56,pp.91-ll9
S. MecCoruaacrc 1972: Change and Continuity in Late Antiquity: theCeremoryt of Aduentus, Historia 21, pp.72l-752
F. Mella.runou 1992 Beschreibung uon Kunsnuerken in der hellenistischenDichtung. Ein Beitag zur hellenistischen Poetih, Leipzíg
D. MaNNspencan 1973: Apollon gegen Dionysol Numismatische Beiniigezu Octauians Rolle ak Vindex Libertatis, Gymnasium 80, pp. 381-405
H. Mesorl 1974: Greek Tèrms for Roman Institutions, TorontoH. Marrwcrv 1923: Coins of the Roman Empire in the British Museum
I, London, rist. 1965 GMAR. Mnnxr.Lsncs 1963: Isisfeste in griechisch-riimisclten Zeit, Daten und
Riten, Beitn z. Kl. Phil. 5, Meiseheim am GlanPG.P Mryeoorra 1995: The Nile mosaic af Palestrina. Early euidence of
Egyptian Religion in haly, Leiden-New York-KólnF. Mnr,q,n 1984: State and Subject: the Impact of Monarchy, in Caesar
Augustus Seuen Aspects, edd. F. MrLLen, E. Sccal, Oxford, pp.37-bU
J.F. MIrnn 1982: Callimacbus and tbe Augustan Aetiological Eleg1, tnANRV/11.30.1, Berlin -New York, pp. 371-417
H.J .M .MnNE1927: Catalogue of the Literary Papyri in the British Museum,Lon-don1933: Catalogue of Alexandrian Coins, Uniuersity of Oxford, Ash-molean Museum, Oxford - London
F. Mtrrxen 1960: Beibkx XXII: Vorlàufger Bericht iiber die Ausgrabun-gen in Ephesos,IóAl 44, pp. 243-314
\W.H. MINrun 1984: Hymn to Delos, Mnemosyne Suppl. 83, LeidenL. Mrrrr,rs
l9l0: Das Receptum Nautarum in den Papyrushundea, Bericht.iiber die Verhandl. K. Sàchs.Gesell.\7iss. zu Leipzig 62, pp. 270-278l9l2: Grundziige und Cltrestomathie der Papyrushunde ll. Band:
Juristischer Teil I. Helfte: Grundziige, Leipzig -Berlin
K. Mórt-r,n 1985: Giitterattribute in ihrer Anruendung auf Augustus. Ei-ne Studie iiber die indirehte Erht;des ersten Princeps in der Díchtungseiner Zeit Idstein
UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO "ALESSANDzuNO, PER AUGUSTO
A. MovtcrmNo 1942: Tèrra mariqur. JRS 32, pp. 53'64O. MoNrpvtccnr
337
1973: La Papirologia, Milano1988: L'amministrazione dell'Egixo sotto i Giulio-Claudii' ANRV/II 10.1, Berlin - New York, pp. 447-47 -
P. MorENo 1994: La scuhura ellenistica, Roma\f. M. Mun-nev - PM. PrrsRs 1989: Octauiani Campsite Memorial for
the Actian .Var,
PhtladelphiaD. Musrt 1966: Lo Stato dci Seleu.cidi. Dinastia Popoli CittA da Seleu'
co I ad Antioco 1/1, SCO 15, pp. 6l-197M.P. NIrssoN 1957: The Dionysiac My*eries of the Hellenistic and Ro'
man Age, LundW'.R. NErsrncur
1970: The ironic priest: Propertius' oRoman Elegiesr, III. I-5: Imi-tations of Horace and Wrgtl, AlPh 91, pp. 385-407l97l: Propertius 3.11, TAPhA 102, pp' 4ll-443
J.K. NeweN 1967, Augutt t and the New Poerry, Bruxelles - BerchemA.D. Nocr 1924: The Historical Importance of Cub-Associations, CR 38,
pp. 105-109F. ÓnriL l9l7: Die Liturrie. Studien zur Ptolemriischen und Kaiserlichen
Wrw ahung Àgptu"l LeipzigC.H. Olor',unir 1923: The Greeh Literary Texts from Graeco-Rotnan
Egtpt, Univ. of 'Wisconsin
t. Operr-t960: Zum Kaiserhub in der griechischen Dichtung, RhM 103'
pp. 43-56Vr. Oniu 1997: Hellenistische Monarchie und riimiscber Prinzipat, KJio
79,2, pp. 354-36rW'. Orro 1910: Augustus Soter, Hermes 45, pp' 448-460R.A. Pecr 1965: The Greeb and Latin Literary Texts fom Greco-Roman
Egypt, Ann Arbor Michigan,2" ed. (Pacr2)
D.L. Pace1942: Greeh Literary Papyri l, Poetry, London (GZD
l98l: Further Greeh Episrams, Cambridge (FGE)
F.-H. Parneulr MAssA 1981'-2:. il problema degt; -Stylop;nabia' del tem-
pio di Apottónis a Cizico. Aliune consideraziona AILPeT 19 n's' 5'
pp. 149-219P.J. PnnsoNs - H. Llovo-JoNrs 1983: Supplementum Hellenisticum, Be'
rolini - Novi Eboraci (.SF4PJ. PansoNs 1968: comm. a POry. )OC(III 2670i.O. Po*tt 1995: Elegia di Simonide agli Spartiati per Platea, ZPE
r07, pp. r-26F. Pnurus [i14, Protopographie der Beamten des
'Apotvoír't16 Notloq ;n
der Zeit uon Augustus bis Diohletian, Borna-LeipzigP PÉoEcn 1989: Trois historiens méconnus (Theopompe, Duris, Phylar-
que), Paris
338
W Prsr 1955: Griechische Wrs-Inschrifien l, BerlinD. Prppns-DElMousou 1979: A Statue-Base for Augustus, IG II2
3262+IG II2 4725, AJPh 100, pp.125-132L. PenNor
1986: Les topoi de l'éloge chez Ménandros Ie Rhéteur, REG 99, pp.33-531993: La rhétorique de I'éloge dans Ie monde gréco-romain, Paris
G.C. Prcexr 1957: Les trophées romaines. Connibution à I'histoire de lzreligion et de I art triomphal dr Rome, Paris
A. PtcnNtor 1953: Le Statut Augustéen de l'Egypte et sa destruction, MHl0,pp. 193-202
G. PoETFIKE 1969: Epimerismos: Betraclttungen zur Ztaangspacht in Agp-ten wiihrend der Prinzipatszeit (Papyrologica Bruxellensia 8),Bruxelles
J. Polr-rNr1990 Man or God: Diuine Assimilation and Imitation in the LateRepublic and Ear$ Principate, in Between Republic and Empire. In-terpretations of Augustus and His Principate, edd. K.A. Reerlaus,M. ToHpn, Berkeley - Los Angeles - Oxford, pp. 334-3631992: La Tazza Farnese: Augusto Imperdtore oRedeunt Saturnia Re-gna!,, AJA 96, pp. 283-300
R.S. Poore 1892: Catalogue of the Coins of Alexandria and tlte Nomos,London, rist. Bologna 1964
J.U. Povru- 1933: Neu Chapters in the History of Greeb Literature IIl,Oxford
J.U. Powrrr - E.A. Bensrp. 1929: New Chapters in the History of GreehLiterature II, Oxford
F. Pnusrcrrl9l0: Girowesen in griechischen Aglpten, Stra8burgl9\5: Sammelbuch Griechische (Jrhunden aus Agyptez I, Sua8burg
A. VoN PRrvrnstelN 1903: Die Buchf)hrung einer àgtptischen Legion-sabteilung Klio 3, pp. l-46
S. R. F. Pmcr 1984: Rituak and Power. The Roman Imperial Cub inAsia Minor, Cambridge
E. Pucrn 1998: GIi inuentari librari di PVindob. Gr. 39966, ZPE 123,pp.78-86
D. RnrngoNa 1991: Economic Rationalism and Rural Societv in Third-Century A.D. The Hieroninus Archiue and the Appianui estate,Cambridge
j.R. REA1975: comm. a P.Oxy. XIIII 30891978: comm. a P.Oxy. Y\LVI 32731988: comm. a P.Oxy. LV 3804
R. Rr,nzrxsretN 1908: Zu Horaz, Neue Jahrb. fúr das Klass. Altert. 11,pp. 365'367
UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO "ALESSANDRINO" PER AUGUSTO 339
P RrsvALo l9l2: De Imperatore Romanorum cum certis dis et compara'tione et aequatione,-Diss. Philol. Halenses )O( 3, Halis Saxonum
J. & L. RossRr 1942: Bulletin épigraphique, REG 55, PP. 321-365L. Ronerr
1928: Isis Eleuthert RHR 98, pp. 56-591948: Hellenica IY. Recueil d'épigraphie, d.e nurnismatique et d an-tiquités grecques, Paris (Épigramme d'Egina, pp. 3-34; Épigrarnmesrelatiaes a des gouuerneurs, pp. 35-ll4)196l: Bulletin épigraphique, REG 74, pp. 219-2211969: Théopltane de Mlttilène à Constantinople, CR-[J, pp. 42-64
C.H. RosnRrs 1953: Literature and Society in the Papyri, MD 10, pp.264-279
G. Ror.rcHr1974: Lexicon Theonymon Rerumque sarnrum et diainarum adAegltptum pertinentium quae in Papyris Ostracis Titulis Graecis La-tinisque in Aegtpto reperth kudantur II, Milano1977: Lexicon Theonymon Rerumque sArnrum et diuinarum adAeglptum pertinentium quae in Papyris Ostracis Titulis Graecis La-tinisque in Aeglpto repertis laudantur V Milano
M. RosrovzEv1906: Kornerhebung und ffansport im griechisch-riimischen Agypten,APF 3, pp.20r-224l9l0: Studien zur Geschichte des Riimischen Kolonates, Leipzig -
BerlinH.-A. Ruppnrcrr 1994r Kleine Einfihrung in die Papyruskunde, Darm-
sradtD.A. Russr,ll - N.G. WtrsoN l98l: Menandrr Rhetor, OxfordA. SaNroNI 1993: L'Inno di Aristotele per Ermia di Atarneo, in La com-
ponente autobiografica nella poesia greca e latina fa reaha e artif-cio letterario. Atti del Conuegno Pisa 16-17 maggio 1991, a c. diG. AnnrcHrrrr e F. MoNreNApJ, Pisa, pp. 179-195
A. ScnncHrsx 1994 Cults of Boiotia 3. Pomia tu Zeus, BICS Suppl.38,3, London
M. ScHNenrr 1925: Die Landuirtschart im hellenistischen Agypten, M,únchen
H. ScsooNsovEN 1980: Elegiae in Maecenaten, Groningen\7. ScHueeRr
l9l3: Alexandrinische Urhunden aus der Zeit des Augusrus, APF 5,pp. 37-r311937: Das hellenistische Ki)nigsideal nach Inschrirten und Papyri,APF 12, pp. l - l3 l
J. ScHwenrz 1948: Le Nil et le raaitaillement de Rome, BIFAO 47,pp.179-200
E. SIturoN 1957 Die Portlanduase, Mainz
SILVIA BARBANTANI
340 SILVIA BARBANTANI
C.J. SIrrarsoN 1993: Horace Carm. I 2 30-44, Apollo Paktinus and Al-lusions to Shrines in Octaaianls Rome, Athenaeum 2, pp. 632-642
B. Srnrs l99l: Food for Rome, The Legal Smtcture of the Tiansportationand Processing of Supplies for the imperíal distributions in Rome,Amsterdam
PJ. StlrrsreryN - K.A. \Xr'onp 1974: Literary and Semi-Linrary Papyri
fom the Vienna Papyrus Colhaion, CE 49, pp. 309-331P.J. Srlr,esreIyN - K.A.1Voru 1976: FiinfunddreitligViener Papyri (PVin-
dob.Tandem), (Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius an-tiquum et papyrologica pertinentia 6), Zuthpen Holland
M. Sonot 1982: Timagene di Alessandria: uno storico ellenocentrico e f-hbarbaro, ANRIY/il 30.1, Berlin - New York, pp. 775-797
A. Srrcnrn l98l: Inschrirthche Grabgedichte auf Krieger und Athleten:eine Studie zu Giechischen Vertpradihationen, Innsbruck
J.A. Srneus 1978: Notes sur quelques papyus concernnnt lbsclauage dansI'Egypte Romaine, ZPE 32, pp.|Si-Zel
E.M. Srrrr.rav 1993 (cur.): Lexicon Tbpographicum Ubis Romae I, Ro-ma
V.M. Srnocrn 1980: Augustus als Pltarao, in Eihones. Studien zum Grie-chischen und Ri;mischen Bildnis. H. Jucher zum 60. Geburtstaggeutidmet, hrsg. R.A. Srucrcy, I. Jucrun, T. Gsr-zER. (AK Beiheftl2) , Bern, pp.177-180
C.H.V. SurHrm-e.No - R.A.G. CensoN 1984: Roman Imperial CoinageI, London, 2^ ed. (MC2)
J.N. SvonoNos 1890: Numismatique de la Crète anciennr I, MacónE. Svrrr 1972: Propertius and Political Panegyric, Arethusa 5, pp. 169-
175A. Svtnrrurc 1969-70: The Responsibility of Corn-Thasport to Alexandria:
olÍohóyoq èníil"oot, \etyparorcarayayeóE (PBerol. inu. I4I 9and 7441), EOS 58, pp. 63-66
F. T,q-Ecsn 1960: Charisma. Studien zur Geschichte des antihen Herr-scherbuben II, Stuttgarr'u?.'W. T.qnN1928: Ptolemy II,IEA 14, pp. 246-2601932: Alexander Helios and the Golden Age, JRS 22, pp. 135-160
L. R. Tnvr-on 1931: Tbe Diuinity of the Roman Emperor, MiddletownConnect.
N. TBnzncsl 1957: Un nuouo fammento di Callimaco?, in Sndi in ono-re di A. Calderini e R. Paribeni,II, Milano, pp. 127-135
D.B. TnorrapsoN 1973: Ptolemaic Oinochoai and Pornaits in Fai'ence.Aspect of the Ruler-Cula Oxford
D.B. TnovrpsoN - L. KoeNtN 1984: Gallus as Ti,iptolemus on the ThzzaFarnese, BASP 21, pp. l l l-156
H.A. TuorrarsoN 1930: Syrian Wheat in Hellenistic Egypt, APF 9, pp.207-2t3
UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO .ALESSANDRINO' PER AUGUSTO 34I
K. Tsuxrll 19242 Sitologen Papyri aus dem Berliner Museum, UppsaraA. ToustN 1977: Berlinl, tt;lr[abt griechischer Papltri, II, Uppsala
J.L. ToNonr,a,u1946: Les thiases dionysiaques royaux dz h cour ptolémai'que, CE2 l , p p . l 4 9 - l 7 l1948a: Un thiase dionltsiaque a Péluse sous Ptolémée V Philopator,BSRAA 37, pp.3-lI1948b: Rois Lagides comparés ou identifiés a des diuinités, CE 23,pp. 127-1461950a: La dynastie ptolémaiQue et la religion dionysiaque, CE 25,pp. 283-3161950b: Thtouage, liene et qrnoétisme, Aegyptus 30, pp. 57-66
I. TnnNcsÉr.nr-\?'elonprer 1965: Eléments égyptiens dans k poésie latinede I'àge d'or, AUB(class) 6, pp. 3-13
E.G. TunNen1987: Greeh Manuscripts of the Ancient \JhrA, Second Edition Re'uised, ed. P.J. PansoNs, BICS Suppl. 46, London1994: 'Recto' e 'uerso'. Anatomia del rotolo di papiro, Firenze (1" ed.ín Actes du We Congrès International de Papyrologie, Bruxelles '
Louaain 29 aoù.t - 3 septembre 1977, I, edd. J' BtttclN, G. Na-cHTERGAEL, Bnrxelles 1978)
Y. VEnNIÈne 1990: L'expédition mythique d'Osiris-Dionlsot en '4sie et ses
Prolongements poútiques in Mythe et Politique. Actes du colloque de-Liège 14-16 septembre 1989, edd. F. JouaN, A, MorrE, Paris, pp.
279-285P Vnnrcr 1895: Quitnngen aus dem Dorfe Karanis ùber Lieferung uon
Saathorn, Hermes 30, pp. 107-123T. Vlqevee 1968: Sndies in Greeh Encomiastic Poetry of the Early B7-
zantine Period, (Commentationes Humanarum Litterarum, Socre-
tas Scientiarum Fennica 42,4), HelsinkiI. Vocr 1924: Die Alexandrinischen Mùnzen, I, StuttgartS.L. \ùíerr.tcr 1938: Tizxation in Egyptfom Augustus to Diocletían,Prin'
cetonG.B. VnxH l99l: Callimachean Passages: the Rhetoric of Epitaph in Epi-
gram, luethusa 24, pp. 77-105M.M]\ínnn 1933 The '*sociation of Augastus with Jupiter, SMSR 9'
pp.203-224O. \fnsan 1909: RE VI s.v. Euthenia rt' 1498-1500, Stuttgart
PR.C. 'SlsAVEx
1972: Familia Caesaris. A Social Study of the Emperor's
Freedmen and Slaues, CambridgeG. WEsen 1993: Dichnng und Hi)fische Gaellschafi. Die Rezeption uon
Zeitgeschichte am Haf dc, eriten drei Ptolemàrr (Hermes Einzel-
schriften 62), StuttgartH. \?'etr 1895: Rernarques sur l'épigramrne grecque découuertu par
M.Kenyon, RPh 19, pp. 180-l8l
14 ) SILVIA BARBANTAN] i UN EPIGRAMMA ENCOMIASTICO .AIESSANDRINO' PER AUGUSTO 343
K.'W'nsssry 1904: Tbpographie des Faij,îtm (Arsinoites nomus) in Griechi-sclter Zeit, Denk. Kais. Ak. \(/'iss., Phil.-hist. Kl. 50, \Wien
P $7uIrs 1993: Promised Wrse: Poets in the Society of Augustan Rorne,Cambridge Mass. -London
J. WHreHonNr 1992: Augustus as 'Theos'
in Contemporary Papyri, inProceedings of the XIXth [nternational Congress of Papyrology, Cairo2-9 Sept. 1989,lI, ed. A.H.S. Er- -Moser"unv, Cairo, pp. 421-424
U. voN \7tr",*aovrz-Moru-rNoonrr 1928: Marcellus aon Side, SPA\7,
PP. 3-30U. \ftrcrr,N
l90l: Papyrus-Urhunden, APF 1, pp.122-1771906: Neue Nachntige zu PLond.II, APF 3, pp. 236-2461912: Grundziige und Chrestomathie der Papyrushundel. Band: Hi-snrischer Teil il. H?ilfte: Chrestomathie, Leipzig -Berlinl9l3: Papyrus-Urhunden, APF 5, pp. 198-300
G. \Tnrreus 1978: Change dnd Declíne. Roman Literature in the EarlyEmpire, Berkeley - Los Angeles - London
H. \lnroe 1988l. Die tanzenden Musihanten uon Mahdia in der alexan-drinische Giitter- und Henscherhuh, MDAJ(R) 95, pp. 97-ll4
M. Vvrr 1994 Augustan Cleopatras: Female Power and Poetic Autho-rity, in Roman Poetry and Propaganda in the Age of Augustus,Oxford (I ed. London 1992), pp. 98-140
H.C. Yourre1952: Critical Notes on Greeh Papyri, TAPA 83, pp. 100-119l97O: Callimachus in the Titx Rolls, in Proceedings of the XIhh In-ternational Congress of Papyrology, Ann Arbor Michigan 12-17 Au-gast 1968, ed. D.H. Saruunr-, Toronto-Amsrerdam, pp. 545-551
G. ZeNxen1987r Realism in Alexandrian Poetry: a Literature and its Audien-ce, London - Sydney - \folfeboro
P ZeNrcnn1973: Studien zu den Augustus-Pornrits, I: Der Actium-Typw, Gór-tingen1988: The Power of the Images in the Age of Auga*us, Ann ArborMichigan
G. Zrccnwl 1987: Il Carmen de bello acriaco. Snriografia e lotta ?o-litica in eta augustea (Historia Einzelschriften 5l), Stuttgart
H. G. ZvNrz1988: Aion Plutonios (Eine Griindungslegende uon Alexandria),Hermes 116, pp. 291-3031992: AIAN in der Literatur der Kaiserzeil [W'iener StudienBeiheft l7), \7ien
l . :r-



















































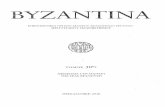



![Microsoft Word - \256]\255}\277o\275\327\244\345final](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334cc342532592417003b0e/microsoft-word-256255277o275327244345final.jpg)













