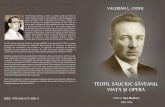"The Mill and the Cross" di Lech Majewski. Il film come opera teorica
Transcript of "The Mill and the Cross" di Lech Majewski. Il film come opera teorica
Semiotica delle soggettivitàISBN 978-88-548-xxxx-x
DOI 10.4399/97888548xxxxx21
pag. 381–393 (settembre 2013)
The Mill and the Cross di Lech Majewski
Il film come opera teorica
Fʀ�ɴ����� Z����ɴɪ
�ɴɢʟɪ�ʜ �ɪ�ʟ�:The Mill and the Cross by Lech Majewski. The Film as Theoreti-cal Object
�ʙ��ʀ���: In ����, the Flemish painter Pieter Bruegel the Elder completesThe Road to Calvary, a painting that represents and actualizes the storyof the Passion of Christ and is composed of a large number of figures.In ����, the Polish director Lech Majewski realizes The Mill and theCross, a film that aims to reconstruct the production context and processof Bruegel’s painting through a set of tableaux vivants. The artist —the main character of the film — leads the viewer inside the paintingand invites him to observe its compositional aspects and recognize, inthe drama of Christ, the anachronistic transfiguration of events thatshook Flanders in the sixteenth century. Analyzing Majewski’s filmhelps to problematize one of the crucial questions that characterizedfilm and visual studies during the twentieth century: the relationshipbetween films and paintings. Working on the edge of the “frame” —between Majewski’s and Bruegel’s pictures — this article reflects uponthe status of the artist as a humanist able to contribute — through visualstorytelling — to organizing the cultural references of his community.
��ʀ�ʟ� �ʜɪ���: Film Analysis; Cinema and Painting; The Frame of Repre-sentation and Its Figures; Theoretical Object; History and Anachronism.
�. Il soggetto tra i dettagli
Nel ���� il pittore fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio realizza Lasalita al Calvario, un dipinto capace di rappresentare e attualizzare ilracconto della Passione di Cristo, disponendo sulla tela un numeroimpressionante di figure in processione: dal corpo di Cristo schiacciatodal peso della croce a Simone di Cirene che interviene ad aiutarlo,dalla figura instabile di Maria in primo piano al luogo del supplizio
���
��� Francesco Zucconi
che si riconosce in profondità di campo, fino alla struttura imponentedel mulino che si staglia verticalmente. Una lunga schiera di soldatia cavallo taglia invece sul piano orizzontale l’intera composizione. Ilcolore e la foggia del loro abito non lascia spazio a dubbi: si tratta deimercenari assoldati dal re di Spagna per reprimere l’affermazione dellaRiforma protestante. Prendendo a pretesto il racconto evangelico e lesue figure, il pittore mette dunque in scena il dramma che sconvolge ilsuo popolo, quando Filippo II decide di intraprende una difesa armatadell’ortodossia cattolica�.
Figura �. La salita al Calvario, Pieter Bruegel, ����, cm ��� x ���, Kunsthistorisches,Vienna.
Nel ����, ispirandosi al saggio–bestseller del critico d’arte MichaelGibson dedicato a La salita al Calvario�, il regista polacco Lech Ma-jewski ha messo in scena The Mill and the Cross (trad. it. I colori dellaPassione), un film che mira a ricostruire il contesto storico ed il pro-
�. Per un’analisi dettagliata delle figure presenti nell’opera, cfr. Gibson (����).�. Cfr. Ibidem.
The Mill and the Cross di Lech Majewski ���
cesso ideativo dell’opera di Bruegel attraverso una serie di tableauxvivants�.
Traendo spunto dalle ricerche storico–artistiche che hanno indivi-duato un autoritratto del maestro fiammingo in un personaggio postosull’estremo margine destro dell’opera�, Majewski fa del pittore ilpersonaggio guida del film: è Bruegel a condurre lo sguardo dellospettatore cinematografico all’interno del dipinto, invitandolo a riflet-tere sulla sua composizione, fino a riconoscere nel dramma di Cristola proiezione anacronistica degli eventi traumatici che sconvolsero leFiandre a partire dalla metà del XVI secolo e che si protrassero nellaGuerra degli ottant’anni (����-����).
Figura �. La salita al Calvario di Pieter Bruegel, dettaglio del presunto autoritratto| Il pittore sulla scena nel film The Mill and The Cross di Lech Majewskj.
Lavorando ai margini della “cornice” — tra l’opera cinematogra-fica e quella pittorica — il film di Majewski dischiude dunque unospazio di riflessione sullo statuto dell’artista–umanista in quanto sog-getto del discorso visivo, capace di partecipare, attraverso il racconto,all’organizzazione delle coordinate di senso della sua comunità. È inquesto modo — mettendo in luce i saperi dello sguardo, valorizzandoil rapporto intermediale e interdiscorsivo tra cinema e pittura — cheil regista polacco ripensa e supera il luogo comune storiografico che
�. Da Pokój Saren (trad. eng. The Roe’s Room, ����) a Ogród rozkoszy ziemskich (trad.eng. The Garden of Earthly Delights, ����), la filmografia di Majewski si caratterizza perl’interesse nei confronti dell’iconografia artistica occidentale, mentre la tecnica del tableauvivant è impiegata in Szklane usta (trad. eng. Glass Lips ����) per animare e attualizzare laDeposizione dalla Croce (����) del maestro fiammingo Rogier van der Weyden.
�. Per una prima formulazione di tale ipotesi interpretativa, cfr. Auner (����).
��� Francesco Zucconi
per molti anni ha portato a considerare il maestro fiammingo comeun pittore “popolare”.
Piuttosto, Bruegel è un artista capace di mettere al servizio dellasua comunità le elevate competenze pittoriche, narrative e scientifichedelle quali dispone�.
�. La macchina del cinema e la macchina della pittura
Più di una volta, durante il film, il pittore mostra i disegni preparatoridell’opera alla quale sta lavorando: un progetto a cui tutti avrebberopreso parte, come a un rito. I protagonisti del quadro sono infatti iconcittadini del pittore, esautorati dai diritti civili e religiosi, continua-mente sottoposti ad angherie e soprusi da parte dei militari assoldati daFilippo II. Come nell’opera pittorica, il ruolo dei carnefici, che nell’i-conografia cristiana è assunto dai centurioni romani, viene attribuitoai mercenari in abito rosso.
Le linee geometriche tracciate dalla mano del pittore sui disegnipreparatori manifestano da subito l’organizzazione sintattica dei cor-pi nello spazio e i rapporti semantici tra le figure all’interno dellarappresentazione. In particolare, la relazione tra le braccia della croce— al centro della composizione —, e le braccia del mulino poste alvertice dell’immagine — sopra una rocca — prefigura agli occhi dellospettatore quanto le sequenze successive del film non faranno chemagnificare, ma esprime anche la concezione razionalista e antidog-matica che caratterizza la produzione artistica e la visione del mondodi Bruegel.
�. Per un approfondimento sulla figura di Pieter Bruegel all’interno dei circoli eruditied umanistici del suo tempo, come per una ricognizione bibliografica sul tema, cfr. Cala-brese (����) pp. ��-��. Calabrese è ritornato più volte sul tema, indagando le forme di ma-nifestazione del sapere umanistico nelle opere stesse del maestro fiammingo. Si ricorda laconferenza al Musée du Louvre “Pieter Brueghel l’ancien et ses «collections de savoirs»” (��novembre ����), l’intervento “Rhétorique de la liste: l’énumeration comme objet théoriquedans certains images de Pieter Bruegel l’Ancien” al convegno “Retorica del visibile” dell’As-sociazione Internazionale di Semiotica Visiva (�� aprile ����), e “Paradigmas y sintagmasdel saber en algunos cuadros de Pieter Brueghel El Viejo” del �� novembre ����, coordinatoda Jorge Lozano presso il Circulo de bellas artes de Madrid, del quale è possibile ascoltarela registrazione all’indirizzo: www.circulobellasartes.com/mediateca.php?id=����.
The Mill and the Cross di Lech Majewski ���
Figura �. L’artista al lavoro: il disegno preparatorio, The Mill and the Cross,fotogramma.
Se la presenza del pittore sulla scena, così come la ridistribuzionedei ruoli dell’iconografia cristiana all’interno del suo racconto, sonoesplicitate fin dall’inizio, è soltanto con la sequenza centrale del filmche la doppia cattura tra lo sguardo cinematografico e lo sguardo pittoricoviene tematizzata in modo esplicito.
La sequenza si apre con il dialogo tra il collezionista NicholasJonghelinck ed il pittore. Il primo chiede se è possibile, attraverso lecompetenze artistiche, “arrestare il tempo della storia” e cercare dicomprendere gli eventi traumatici che caratterizzano l’Europa durantequegli anni. La risposta di Bruegel è molto teatrale ed assume una fortevalenza teorica: con un gesto della mano il pittore entra in contattocon il mugnaio, che a sua volta interrompe il movimento rotatorio delmulino e, di conseguenza, quello dei soggetti che prendono parte allaprocessione.
��� Francesco Zucconi
Figura �. Fermare il mulino per arrestare il tempo della storia, The Mill and theCross, fotogramma.
Il punto di vista si abbassa. Un lungo carrello laterale — che siprotrae fino ad inquadrare Bruegel e Jonghelinck di spalle mentreosservano il tableau vivant — passa in rassegna i dettagli della com-posizione pittorica, mentre la voce dell’artista descrive il sistema deiruoli e degli sguardi che organizzano l’opera.
Arrestando il movimento rotatorio del mulino, arrestando il pro-cesso produttivo che alimenta l’intera comunità, si arresta anche l’il-lusione sulla quale si fonda il meccanismo (ed il naturalismo) dellariproduzione cinematografica. La domanda del collezionista di ar-restare il tempo della storia, trova dunque, all’interno del film, unarisposta al livello enunciazionale: il racconto storico (nella sua articola-zione spaziale, temporale e attoriale) può essere “arrestato”, analizzatoe compreso soltanto se ricondotto alle condizioni di discorso che loorganizzano�.
�. Si riprende la bipartizione proposta da Èmile Benveniste tra “enunciazione storica”— che non prende mai “in prestito l’apparecchiatura formale del discorso” operando unapiena oggettivazione dell’enunciato — e “discorso”, dove si articolano relazioni interperso-nali, spaziali e temporali in relazione all’atto dell’enunciazione. Cfr. Benveniste (����) pp.���-���. Per uno studio approfondito sulle forme del discorso storico, cfr. Lozano (����). Perla riformulazione dei rapporti tra storia e discorso nell’ambito della teoria dell’immagine edella semiotica visiva, cfr. Marin (����, ���� e ����) e Calabrese (����).
The Mill and the Cross di Lech Majewski ���
Figura �. Lo sguardo cinematografico dettaglia lo spazio e il tempo pittorico, TheMill and the Cross, fotogramma.
Pur trovando una manifestazione figurativa nel pittore presentesulla scena, è dunque a partire da questa sequenza e fino alla fine delracconto che il discorso filmico, fatto di inquadrature e montaggio, sicostituisce in quanto “soggetto” dettagliante, tanto sul piano spazialequanto su quello temporale: la visione della macchina del cinema sisovrappone alla sintassi che organizza la macchina della pittura, espli-citando in un’operazione analitica il racconto del quadro oggetto; latecnica del tableau vivant, ripensata nei termini di “dettaglio tempora-le”, costituisce invece la strategia adottata per esplicitare il dinamismopassionale comunque implicato nella resa figurativa delle immaginistatiche�.
Il grandissimo interesse manifestato da Bruegel nei confronti del-l’evoluzione scientifica e tecnologica del suo tempo, la cura nellariproduzione dei meccanismi di funzionamento delle macchine all’in-terno delle sue opere e l’introduzione della struttura meccanica del
�. Per una teoria generale del dettaglio, capace di evidenziarne le implicazioni sulpiano spaziale e temporale, cfr. Calabrese (����) pp. ��-��. Per un approfondimento dellalogica di funzionamento del dettaglio spaziale in ambito pittorico, cfr. anche Arasse (����).Sulla possibilità del cinema di rivelare la “plasticità” della rappresentazione per mezzo delralenti, cfr. Païni, (����) p. ��.
��� Francesco Zucconi
mulino all’interno della Salita al Calvario, in una posizione carica diimplicazioni metafisiche, vengono dunque riletti, all’interno del filmdi Majewski, in quanto occorrenze figurative di un’ampia riflessioneteorica riguardante la meccanica della visione�.
�. Il film come opera teorica
Che cosa significa dunque tornare ancora a confrontarsi con un temacome il rapporto tra cinema e pittura, dopo che, per decenni, tanto lateoria del cinema quanto la teoria delle immagini vi si sono dedica-te, correndo talvolta il rischio di esaurirsi nella ricerca degli specificilinguistici e mediali? Come emerge dalla visione di The Mill and theCross, un film interamente incentrato su di un’unica opera e sul con-testo storico e politico nel quale si colloca, il rapporto tra le arti nonpuò esaurirsi nel semplice riconoscimento delle fonti iconografiche,ma deve trasformarsi in un’occasione di studio, condotta attraverso imezzi del discorso che assume una funzione metalinguistica, dei testidi cultura prodotti in un determinato periodo�.
Quella del regista polacco è dunque un’opera teorica, mirata allamessa in risalto delle strategie dello sguardo pittorico��. Si tratta di unfilm programmaticamente riflessivo, nel quale i mezzi espressivi sonotalmente finalizzati alla scansione analitica della Salita al Calvario daassegnare ad alcune sequenze i tratti della parodia.
�. Sulla funzione assunta dalle macchine in Bruegel, cfr. nuovamente Calabrese (����)pp. ��-��.
�. Come testo di riferimento fondamentale sui rapporti tra il cinema e le altre arti,cfr. Costa (����). Sulla necessità di indagare il rapporto tra cinema e pittura così comeespresso all’interno delle singole opere che lo attualizzano, cfr. tra gli altri Calabrese (����)e Bernardi (����). Per un ripensamento del problema generale dell’intertestualità in chiave“archeologica”, anziché filologica (come ricerca delle fonti) o tematica (come ricerca dipermanenze “lessicali”) e di sfruttarne l’efficacia all’interno della teoria della cultura, cfr.Casetti (����).
��. Com’è noto, attorno al concetto di “oggetto teorico” arte si incontrano e si rendonoconfrontabili le prospettive di ricerca di studiosi come Louis Marin, Daniel Arasse, HubertDamisch, Jean–Claude Bonne, Omar Calabrese, Paolo Fabbri, Giovanni Careri. Per unaformulazione sintetica, cfr. Damisch et al. (����), Marin (����) pp. ��-��, e Calabrese (����)pp. VII-X. Parallelamente, sembra possibile rinvenire, in forme più o meno esplicite, nellateoria del cinema l’elaborazione di un concetto affine per descrivere il portato teoricopresente in alcuni film. Cfr. almeno, Deleuze (����) p. ���, Aumont (����) pp. �-��, DeVincenti (����) pp. ��-��, Casetti (����) pp. ���-���, Zunzunegui (����), pp. �-��.
The Mill and the Cross di Lech Majewski ���
Ultimo esempio di quel rapporto tra cinema e pittura che tanto hasegnato i dibattiti nei decenni passati, The Mill and the Cross riesce dun-que a valorizzare — attraverso una teatralizzazione della riflessivitàartistica — le potenzialità “analitiche” della settima arte nei confrontidei testi di cultura ereditati dal passato. È il montaggio cinematogra-fico, grazie al quale lo spettatore contemporaneo ha familiarizzatol’operazione sintattica propedeutica a ogni messa in forma del sen-so, a prestarsi alla messa in evidenza delle strategie di composizionepresenti nel discorso visivo pre–cinematografico o più genericamentenon cinematografico. È il personaggio cinematografico Bruegel, dota-to di competenza estetica, ad assumere un ruolo metadiscorsivo neiconfronti del lavoro di disposizione dei dettagli operato sulla tela dalpittore Bruegel. Ma, come avviene in buona parte della produzionecinematografica e artistica contemporanea, inserire un soggetto dota-to di competenza estetica in quanto punto di vista guida del racconto,significa anche invitare lo spettatore a riflettere sulla funzione assuntadella creatività all’interno della società. The Mill and the Cross mostrail processo che porta alla costruzione del capolavoro realizzato daBruegel nel ���� e allo stesso tempo opera una decostruzione analiticadel suo carattere monumentale.
Come mi ha fatto notare con grande generosità Daniele Salerno,l’operazione di Majewski sembra trarre ispirazione dal dipinto pano-ramico, conservato a Breslavia, che celebra la Battaglia di Raclawiceattraverso la quale la Polonia tentò, nel ����, di liberarsi dall’influenzadell’Impero Russo. Al livello tematico, infatti, tanto l’opera di Brue-gel — almeno nell’interpretazione offerta da Gibson e Majewski —quanto il dipinto panoramico mirano a rappresentare il trauma di unpopolo sotto l’occupazione o l’influenza straniera. Allo stesso modo,dal punto di vista strutturale, l’eterogeneità di campo tra gli osservato-ri che si muovono lungo il corridoio circolare e la superficie pittoricadel Panorama di Raclawice (Fig.�) richiama, in tutta evidenza, l’incom-mensurabilità spaziale e temporale tra i corpi di Bruegel e Jonghelincke quelli del quadro animato digitalmente nella sequenza del film sopraanalizzata (Fig. �).
��� Francesco Zucconi
Figura �. Gli osservatori del monumento panoramico, fotografia realizzata pressoil Panorama di Raclawice, Breslavia (© Governo di Polonia, Ufficio per il turismo).
Se gli spettatori del Panorama di Raclawice e di qualsiasi altro monu-mento visivo hanno semplicemente la facoltà di osservare quanto di-sposto dalla cornice dell’opera, le figure di Bruegel e Jonghelinck all’in-terno del film di Majewski sono a tutti gli effetti due meta–osservatori:osservano e allo stesso tempo descrivono le forme che organizzanola visione dell’opera–monumento. Il gioco di cornici del film diventadunque un espediente per riflettere sulla capacità del sapere artistico,e degli attori che di volta in volta lo mettono in atto, di rappresentaree riflettere criticamente sui racconti che inquadrano il senso di unacomunità, di ripensare, rimettere in atto, i sistemi narrativi, le confi-gurazioni passionali e le assiologie della tradizione iconografica nellachiamata del presente.
In questo senso, il film non si limita ad analizzare La salita al Calvariodi Bruegel, ma mostra anche come il pittore, il regista ed in generalechiunque si esprima attraverso un lavoro creativo sia in possesso delpotente strumento dell’anacronismo, ovvero della facoltà di montare,accostare e far convivere, come in un innesto, immagini e raccontiappartenenti ad epoche e contesti storici e culturali ben diversi��. Che
��. Come riferimento ormai classico sul tema dell’anacronismo in ambito
The Mill and the Cross di Lech Majewski ���
cosa significa, infatti, attualizzare l’iconografia cristiana, restituire vitae passione ai suoi personaggi, riassegnare i ruoli della vittima e deicarnefici in nome degli eventi che sconvolgono il presente?
Figura �. Dalla macchina della pittura alla macchina del museo, The Mill and theCross, fotogramma.
Come forse suggerisce la sequenza finale del film, girata dentro ilKunsthistorisches Museum di Vienna, dove La salita al Calvario è postaal lato della Grande Torre di Babele, ogni epoca riordina, espone einterpreta quanto ereditato dal passato a proprio modo��.
È forse, allora, anche per questo motivo che continuare a studiareil funzionamento della “macchina della pittura”, la “macchina dellamusica”, la “macchina del cinema” e così via. . . significa continuarea riflettere e ad interessarsi — prendere parte consapevolmente —al movimento della “macchina della cultura”. Quella macchina dallaquale nessuno è escluso e tantomeno può scappare.
storico–artistico, cfr. G. Didi–Huberman (����).��. Sul museo come forma di organizzazione del sapere, cfr. Zunzunegui (����) e
Damisch (����).
��� Francesco Zucconi
Riferimenti bibliografici
Aʀ���� D. (����) Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Flam-marion, Paris (trad. it. Il dettaglio. La pittura vista da vicino, Milano, ilSaggiatore ����).
A���ɴ� J. (����) À quoi pensent les films, Séguier, Paris (trad. it. A cosa pensa-no i film, Pisa, Ets ����).
A�ɴ�ʀ A. (����) Pieter Bruegel: Umrisse eines Lebensbildes, “Jahrbuch der Kun-sthistorischen in Wien”, ��, pp. ��-���.
B�ʀɴ�ʀ�ɪ S. (����) Kubrick e il cinema come arte del visibile, Il Castoro, Mila-no.
C�ʟ�ʙʀ��� O. (����) La macchina della pittura. Pratiche teoriche della rappre-sentazione figurativa fra Rinascimento e Barocco, Laterza, Roma–Bari.
——— (����) L’età neobarocca, Laterza, Roma–Bari.
——— (����) Kubrick pittore, “Cinema & Cinema”, ���, pp. ���-���.
——— (����) Come si legge un’opera d’arte, Mondadori, Milano.
C�����ɪ F. (����) L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità, Bom-piani, Milano.
——— (����) “Intertestualità e lavoro sul film: possibilità per la ricerca”,in G. Carluccio e F. Villa, (a cura di) L’intertestualità. Lezioni, lemmi,frammenti di analisi, Kaplan, Torino, pp. ��-��.
C���� A. (����) Il cinema e le arti visive, Einaudi, Torino.
D��ɪ��ʜ H., H�ʟʟɪ�ʀ D., Kʀ���� R., F����ʀ H. (����) A conversation withHubert Damisch”, “October”, ��. pp. �-��.
——— (����) L’amour m’expose, Klincksieck, Paris.
D�ʟ���� G. (����) Cinema �. L’image–temps, Minuit, Paris (trad. it. Cinema �.L’immagine–tempo, Ubulibri, Milano ���).
D� Vɪɴ��ɴ�ɪ G. (����) Il concetto di modernità nel cinema, Pratiche, Parma.
Dɪ�ɪ–H�ʙ�ʀ��ɴ G. (����) Histoire de l’art et anachronisme des images, Mi-nuit, Paris (trad. it. Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, Bolla-ti–Boringhieri, Torino ����).
Gɪʙ��ɴ M. (����) The Mill and the Cross — Peter Bruegel’s “Way to Calvary”,Acatos, New York.
L���ɴ� J. (����) Il discorso storico, Sellerio, Palermo.
The Mill and the Cross di Lech Majewski ���
B�ɴ��ɴɪ��� E. (����) Problèmes de linguistique génèrale, Gallimard, Paris (trad.it Problemi di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano ����).
M�ʀɪɴ L. (����) Détruire la peinture, Galilée, Paris.
——— (����) Opacité de la peinture. Essais sur la représentation au Quattrocen-to, Usher, Paris (trad. it. Opacità della pittura. Saggi sulla rappresentazionenel Quattrocento, La Casa Usher, Firenze ����).
——— (����) De la représentation, Gallimard, Paris (trad. it. Della rappresen-tazione, a cura di Lucia Corrain, Meltemi, Roma ����).
P��ɴɪ D. (����) Le temps exposé. Le cinéma de la salle au musée, Cahiers ducinema, Paris.
Z�ɴ��ɴ�ɢ�ɪ S. (����) Metamorfosis de la Mirada: Museo y Semiótica, Cate-dra, Madrid (trad. it. Metamorfosi dello sguardo. Museo e semiotica, NuovaCultura, Roma ����).
——— (����) La mirada plural, Catedra, Madrid.


















![[Schaum - Murray R.Spiegel] Mecanica Teorica](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6316b839c5ccb9e1fb03d12d/schaum-murray-rspiegel-mecanica-teorica.jpg)