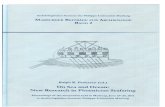Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana...
Transcript of Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana...
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Romacxiv - n.s. xxiii
BCom CXIV.indb 1 04/03/15 12:12
pubblicato a cura di
ROMA CAPITALEASSESSORATO ALLA CULTURA, CREATIVITÀ E PROMOZIONE ARTISTICA
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI
Sovrintendente Claudio Parisi Presicce
Comitato scientificoEugenio La Rocca coordinatore - Hans-Ulrich Cain, Francesco De Angelis, Michel Gras, Gian Luca Gregori, Chris Hallett, Lothar Haselberger, Tonio Hölscher, Pilar León, Ricardo Mar, Marc Mayer, Luisa Musso, Domenico Palombi, Clementina Panella, Claudio Parisi Presicce, Joaquin Ruiz de Arbulo, Thomas Schäfer, Rolf Schneider, Stefano Tortorella, Desiderio Vaquerizo, Alessandro Viscogliosi, Andrew Wallace-Hadrill, Paul Zanker.
Comitato di redazioneClaudio Parisi Presicce coordinatore - Maddalena Cima, Maria Gabriella Cimino, Susanna Le Pera, Paola Rossi, Emilia Talamo. Francesca Ceci, Isabella Damiani, segreteria e revisione.
Il periodico adotta un sistema di peer-review
BCom CXIV.indb 2 04/03/15 12:12
Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale
di Roma
CXIV
2013
«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER
BCom CXIV.indb 3 04/03/15 12:12
COPYRIGHT © 2014 by «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER - ROMAVia Cassiodoro, 19
Curatore redazionale Daniele F. Maras con Alice Landi
Periodico: Autorizzazione Tribunale di Roma n. 523 del 24-10-1988
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. - N.S. 1(1987/88)- . - Roma : «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 1989- . - v. ; 29 cm.- Annuale
ISSN 0392-7636
ISBN 978-88-8265-739-0
CDD 20. 930.1’05
BCom CXIV.indb 4 04/03/15 12:12
Sommario
mura aureliane
Le Mura Aureliane su via Casilina (Mun. i) di Alberta Ceccherelli, Valeria Bartoloni 187
Mura Aureliane presso Porta Clausa: un tratto altomedievale ritrovato (Mun. i)
di Maria Gabriella D’Ippolito 203
via salaria
Il sepolcreto salario (Mun. i ex ii) di Carlo Buzzetti 207
via nomentana
L’attività della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma nell’ambito di Villa Torlonia (Mun. ii ex iii)
di Simona Morretta 209
Via Nomentana, Villa Torlonia (Mun. ii ex iii)
di Simona Morretta, Luca Bressanello, Nikitas Diamadis 209
Sculture antiche da uno scavo all’esterno del Teatro di Villa Torlonia (Mun. ii ex iii)
di Simona Morretta 215
Casino nobile di Villa Torlonia. La lettura del-le vicende costruttive di un ambiente pluri-stratificato: dal colombario romano al bun-ker antigas (Mun. ii ex iii)
di Carla Galanti 219
via salaria/via nomentana
Località Casal della Donna. Nucleo sepolcrale di epoca romana (Mun. iii ex iv)
di Pietro Barbina 227
La Lupa Capitolina: indagini termografiche per lo studio delle tecniche di formatura e delle finiture del bronzo dopo la fusione
di Augusto Giuffredi, Fulvio Mercuri, Claudio Parisi Presicce, Carlo Stefano Salerno, Stefano Paoloni, Noemi Orazi 9
L’Ipogeo degli Ottavi di Magdy Tawfik 25
Il Divorum, l’aedes Divorum in Palatio e il Caesareum degli Arvali. Tetrastyla, epula e culto dinastico in età flavia
di Francesco Marcattili 47
Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana a deambulatorio sulla via Ardeatina
di Annarena Ambrogi 63
L’insediamento altomedievale di Veio - Piazza d’Armi. Un’ipotesi di identificazione di Michele Damiani 83
Alcune considerazioni su un ripostiglio di xiv secolo conservato nel Medagliere Capitolino di Mariele Valci 93
MUNIFICENTIA SS . D . N . BENEDICTI . PP . XIV Le provvidenze di Papa Lambertini per il Museo Capitolino (1740-1758)
di Francesco Paolo Arata 105
The Warren Chalice in the Imagination of its Creator and as a Reflection of his Time di Maria Teresa Marabini Moevs 157
Relazioni su scavi, trovamenti, restauri in Roma e Suburbio 2009-2012 (seconda parte):
BCom CXIV.indb 5 04/03/15 12:12
6 Sommario
Via di Tor San Giovanni, 35. Area sepolcrale (Mun. iii ex iv)
di Marzia Di Mento 230
Tenuta Radicicoli Del Bene, via della Bufalot-ta, n. 1297. Edificio (mausoleo) con mosaico (Mun. iii ex iv)
di Melissa Marani 233
I pavimenti in opus sectile in ambito funera-rio: il caso del sepolcro di via Capo Sottile (Mun. iii ex iv)
di Melissa Marani 237
Due tracciati stradali nella Tenuta Radicicoli Del Bene (Mun. iii ex iv)
di Chiara Peguiron 243
Via della Bufalotta - via Villa di Faonte. Edi-ficio funzionale alla captazione idrica (Vigne Nuove) (Mun. iii ex iv)
di Gerardo Fratianni 246
Via della Bufalotta - via Villa di Faonte. Edifi-cio funzionale alla captazione idrica: analisi dei materiali (Mun. iii ex iv)
di Andrea Di Napoli 248
Captazione idrica in località Torricella (Mun. iii ex iv)
di Francesco di Gennaro, Simone Santucci, Massimo Pesci 252
Via delle Vigne Nuove, km 1,400 (angolo via Giovanni Conti). Sepolcreto di epoca impe-riale con edificio funerario (Mun. iii ex iv)
di Mauro De Filippis 258
L’abitato del Bronzo Antico e Medio di Radici-coli Maffei. 2. Lo scavo nell’area del Bronzo Medio 3 a sud del Raccordo Anulare e i nuovi materiali appenninici (Mun. iii ex iv)
di Francesco di Gennaro, Barbara Barbaro 263
Via delle Vigne Nuove e via di Settebagni. Due località di interesse paletnologico nella Tenu-ta Radicicoli Del Bene (Mun. iii ex iv)
di Francesco di Gennaro, Barbara Barbaro 275
via nomentana
Via Senigallia: impianto termale (Mun. iv ex v) di Marzia Di Mento 281
via prenestina/via casilina
Il Mausoleo e la Basilica Circiforme della cd. Villa dei Gordiani sulla via Prenestina: tec-nica e strategia di rilievo (Mun. v ex vi)
di Alessandro Blanco, Daniele Nepi, Alessandro Vella 285
via prenestina/via casilina/via latina
L’attività della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (Mun. v ex vi)
di Anna Buccellato, Anne De Loof, Carlo Tor-ri, Lisa Traversi 294
Via Prenestina: il complesso monumentale in località “Casale delle Cappellette” (Mun. v ex vi)
di Stefano Musco, Maria Cioccolini, Federica Zabotti 304
Vicolo di Torre del Fiscale, 9: edificio funera-rio (Mun. vii ex ix)
di Marzia Di Mento 328
via appia
Villa di Massenzio. Relazione preliminare dello scavo effettuato presso il tratto nord-occiden-tale dell’ambulacro di collegamento tra l’Aula Palatina e il Pulvinare (Mun. viii ex xi)
di Alessandro Delfino, Michela Rossi 333
Sant’Urbano alla Caffarella: un edificio di epo-ca massenziana (Mun. viii ex xi)
di Alessandro Blanco 346
via ostiense
Recenti ritrovamenti nel territorio ostiense (Mun. x ex xiii)
di Simona Pannuzi 366
Le indagini archeologiche in Ostia Antica paese: il colombario di piazza Gregoriopoli (Mun. x ex xiii)
di Simona Pannuzi, Walter Pantano, Marco Tantucci 376
Indagini di scavo preventive nel parcheggio della Stazione di Ostia Antica della Ferrovia Roma-Lido (Mun. x ex xiii)
di Simona Pannuzi, Andrea Carbonara, Do-nato Colli 381
Indagini di scavo preventive per cantiere Acea - Illuminazione pubblica nel Parco dei Ra-vennati-via Gesualdo (Mun. x ex xiii)
di Simona Pannuzi, Savino Sbarra, Paola Catalano, Loredana Carboni 384
Le indagini preventive per il cantiere Acea lungo la via Ostiense (km 22,300) (Mun. x ex xiii)
di Marco Tantucci 393
Le indagini archeologiche preventive presso via di Castelfusano (Mun. x ex xiii)
di Simona Pannuzi, Alice Ceazzi, Walter Pantano 394
BCom CXIV.indb 6 04/03/15 12:12
Sommario 7
Loc. Ostia Antica. Indagini archeologiche in via Pericle Ducati (Mun. x ex xiii)
di Simona Pannuzi, Claudia Di Tomassi, Fa-biana Fiano, Fabrizio Felici, Marina Marcel-li, Federica Zavaroni 400
La necropoli imperiale di Castel Malnome (Ponte Galeria): risultati preliminari. Il sepol-creto dei saccarii salarii? (Mun. xi ex xv)
di Laura Cianfriglia, Alessio De Cristofaro, Marzia Di Mento 414
via portuense
Località Monteverde (Mun. xii ex xvi) di Daniela Rossi 423
Via Fratelli Bandiera. Area funeraria e battuti pavimentali (Mun. xii ex xvi)
di Marzia Di Mento, Domenica Augelli, Cesa-re Baglieri 424
Viale delle Mura Portuensi. Scarichi di fornace per ceramica di età moderna (Mun. xii ex xvi)
di Marina Marcelli, Massimiliano Munzi, Gianluca Schingo 431
via cassia
Novità archeologiche dal sito di Campetti a Veio (RM) (Mun. xv ex xx)
di Ugo Fusco, Loredana Lattanzi 436
via cassia/via trionfale
La Giustiniana - Via G. Iannicelli. Necropoli romana (Mun. xv ex xx)
di Alessandra Cerrito, Walter Pantano 450
MISCELLANEA ARCHEOLOGICA
Miscellanea Archeologica di Carlo Buzzetti 469
BCom CXIV.indb 7 04/03/15 12:12
Sulla via Ardeatina, a circa 600 metri dal bivio del «Quo Vadis?», una serie di campagne di sca-vo condotte dell’università degli Studi di Roma, Tor Vergata, in collaborazione con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, a partire da-gli anni ’90 del secolo scorso, hanno messo in luce i resti di una basilica paleocristiana a deambula-torio, da identificarsi con la chiesa fatta erigere in età costantiniana da papa Marco1. Durante la campagna di scavo del 2009, nelle fondazioni è stata rinvenuta una testa femminile riutilizzata come materiale da costruzione nel conglomerato cementizio del muro perimetrale Est (USM 39: muro a destra di chi entrava nelle chiesa)2. Il pez-zo si trovava inserito sulla cresta della fondazione con il viso rivolto verso l’esterno (fig. 1), in cor-rispondenza del piano da cui doveva partire l’e-levato del muro, che nel breve tratto al di sopra
Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni
della basilica paleocristiana a deambulatorio sulla via Ardeatina
1. Roma, Via Ardeatina, scavo della basilica a deambulatorio. Par-ticolare del rinvenimento della testa-ritratto. Foto Vincenzo Fioc-chi Nicolai.
1 La basilica paleocristina circiforme, già individuata nel 1991, è stata oggetto di una serie di campagne di scavo negli anni 1993-1996, 2007-2012, eseguite da archeologi specializzandi nel Ponti-ficio Istituto di Archeologia Cristiana, da studenti dell’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, e da dottorandi e dottori di ricer-ca dell’Università degli Studi di Roma, Sapienza, sotto la direzione di Vincenzo Fiocchi Nicolai, al quale sono particolarmente grata per avermi affidato lo studio di questo reperto e per aver seguito la ricerca con fattiva collaborazione e preziosi consigli. Ringrazio, inoltre, Daria Mastrorilli e Alessandro Vella per le utili informazio-ni sullo scavo e in particolare sulle fasi del rinvenimento dell’opera in esame. Per la bibliografia relativa alla scoperta e agli scavi della basilica paleocristiana a deambulatorio rinvenuta sulla via Ardeati-na si rimanda a Fiocchi Nicolai 1995-1996, pp. 69-233, e ai suoi più recenti contributi: Fiocchi Nicolai 2002, pp. 1175-1201 con bibl. prec. a nota 1; Fiocchi Nicolai 2006, pp. 25-28; Fiocchi Ni-colai 2013, pp. 60-66; Fiocchi Nicolai–Mastrorilli–Vella cds.
2 Il reimpiego di marmi lavorati è tipico delle fondazioni di edi-fici tardoantichi: Lugli 1957, pp. 402-404, 440-441.
BCom CXIV.indb 63 04/03/15 12:12
64 Annarena Ambrogi
rigonfia. L’ampia arcata delle sopracciglia è resa plasticamente con un lieve aggetto, che diventa più sporgente all’esterno; non vi sono indicati i peli. Il naso è molto breve ed affilato (lungh. cm 4,5), dal profilo diritto, senza gobbe; le cavità del-le narici sono oblunghe. La bocca è piccola e ben delineata: ha le labbra chiuse, separate da un sol-co inciso, con lievi fossette agli angoli; il labbro superiore, sinuoso, è più sottile dell’inferiore, che risulta carnoso e appena aggettante. La canaletta sopralabiale è indicata da un incavo a goccia poco profondo. Le rughe d’espressione labio-nasa-li sono rese plasticamente con un rigonfiamento sottolineato da un avvallamento. Gli orecchi sono piccoli: di quello destro, rotto, rimangono gli in-cassi forati dal trapano del condotto auricolare e l’attacco del padiglione. L’orecchio sinistro, in-tegro, si caratterizza per un padiglione ridotto, molto distaccato dal cranio, e con un lungo lobo carnoso, aderente al collo. Al di sopra del capo si conserva una piccola porzione di una parete liscia di fondo (alta cm 1,5 e spessa cm 6), che testimo-nia l’appartenenza del frammento ad un rilievo.
Per realizzare il ritratto è stato utilizzato essen-zialmente lo scalpello, con cui sono stati segna-lati i particolari fisionomici e dell’acconciatura, separando con solchi più o meno profondi le sin-gole ciocche, mentre con il trapano sono stati resi esclusivamente gli incavi più profondi, quali le narici e le cavità dei padiglioni auricolari. Que-ste ultime appaiono diverse: la cavità destra, più piccola, è resa con due fori di trapano, mentre la sinistra, più ampia, presenta tre fori. La carun-cola non è forata, né è indicata con una linea in-cisa la ghiandola lacrimale.
Alla sobria compostezza di questo viso d’im-pianto classicheggiante si contrappone la ricca e variata articolazione delle masse capillari (fig. 7). La complessa acconciatura presenta frontalmente un ‘diadema’ composto di tre elementi con scri-minatura centrale. I primi due, partendo dal bas-so, sono a fasce sovrapposte e si prolungano fino agli orecchi, mentre il terzo, più breve, ma più alto, si limita all’alzata frontale, formando una crestina a lunetta. Il primo elemento si compone di una sottile treccia di ciocche ritorte; la seconda fascia, più alta, presenta ciocche semilunate di-sposte a raggiera, in due serie contrapposte, che si incontrano nella mandorla mediana, in forma di cuspide acuminata; la separazione delle cioc-che è ottenuta con ampi solchi a virgola incisi con lo scalpello. Il terzo elemento presenta due setto-ri speculari, simmetrici alla scriminatura centra-
della testa era ad un livello inferiore rispetto al piano di calpestio3.
Il ritratto (figg. 2-6) è realizzato in marmo lu-nense4 e misura in altezza cm 26, in larghezza cm 21, in profondità cm 14. L’altezza della testa dal mento alla sommità dell’acconciatura è di cm 21.
Il frammento è rotto tutt’intorno ed il retro appare completamente scheggiato. Resti di mal-ta si conservano sia sul volto che sull’acconciatu-ra. Una grossa scheggiatura è presente nei pri-mi due elementi del ‘diadema’. Alcune rotture, che interessano il mento, il collo, gli orecchi e il naso, sono antiche: la presenza della malta sopra di esse attesta che erano già presenti al momento del riutilizzo e che probabilmente furono causa-te proprio dai colpi che ridussero l’opera in pez-zi per poterla inserire nel conglomerato cemen-tizio. Una grossa lacuna in corrispondenza della mandibola destra, per la supeficie regolarizzata e per il taglio netto del contorno, potrebbe rife-rirsi ad un incasso eseguito in antico per l’inse-rimento di un tassello; l’interno conserva trac-ce di scialbatura di calce, presenti anche sul bul-bo dell’occhio sinistro. Sul sopracciglio sinistro, sulla palpebra inferiore corrispondente e vicino al naso si notano resti di colore rosso (minio?): queste tracce rivelano che la scultura in origine era stata scialbata con calce diluita per unifor-mare la superficie e poi completata con il colore5.
La testa femminile si caratterizza per una fisio-nimia individualizzata ed una complessa accon-ciatura con ‘diadema’ multiplo e turbante di trec-ce. Essa rappresenta una donna di giovane età, come rivelano la tensione e la levigatezza dell’e-pidermide, solcata da rughe di espressione ap-pena accennate. Il volto appare piuttosto largo e squadrato con zigomi alti e ampie guance, pie-ne e sode. La fronte, relativamente alta, è liscia e senza rughe; la superficie risulta morbidamen-te modulata dal lieve rigonfiamento della bozza centrale, al di sotto della scriminatura, e dai tenui avvallamenti laterali nella zona temporale. Gli occhi piccoli e allungati, di forma amigdaloide, hanno il bulbo liscio, privo delle indicazioni in-terne di iride e pupilla, e sono contornati da pal-pebre carnose; il plastico rigonfiamento della pal-pebra inferiore è segnato in basso da un natura-listico arco incavato. La palpebra superiore, nella parte mobile è a fascia liscia, molto spessa e con il bordo a spigolo acuto, orlata da un solco inci-so che continua nell’angolo esterno, parallelo ad un’altra incisione inferiore, più breve, mentre nel settore sub-sopraccigliare la palpebra è appena
3 Sulle fondazioni della basilica: Fiocchi Nicolai 1995-1996, pp. 75-77.
4 Il riconoscimento del tipo di marmo si deve a Matthias Bruno, che ringrazio per la sua consueta disponibilità.
5 Sono grata per queste utili osservazioni a Barbara Mazzei della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, che ha eseguito una preliminare pulizia della testa; ringrazio la dottoressa Mazzei per la sua cortese disponibilità.
BCom CXIV.indb 64 04/03/15 12:12
Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana a deambulatorio sulla via Ardeatina 65
2-6. Roma. Testa-ritratto femminile. Foto Vincenzo Fiocchi Nicolai.
2
3 4
5 6
BCom CXIV.indb 65 04/03/15 12:12
66 Annarena Ambrogi
sopracciglio. L’orecchio sinistro, meglio conserva-to, appare più alto e con il padiglione molto aper-to, a ventola. Anche la parte sinistra della bocca è meno aggettante, più schiacciata. La parte destra del volto è resa con maggiore plasticità ed organi-co naturalismo. La guancia destra è più ampia e piena; la mandorla dell’occhio non è allungata e sollevata all’insù come nel sinistro, ma si sviluppa organicamente su un unico piano orizzontale. L’o-recchio destro, purtroppo privo del padiglione, in origine doveva essere scolpito con maggiore accu-ratezza, come rivela l’incavo più ampio, forato in modo più articolato. Tutta la parte destra della te-sta presenta una maggiore consistenza plastica ed, inoltre, risulta più attentamente eseguita. La metà sinistra dell’acconciatura, seppur accurata nei par-ticolari, appare più sfuggente e schiacciata verso il fondo, con le singole trecce del turbante meno pla-stiche, ‘a stuoia’ piatta; come si è detto anche il ter-zo elemento del ‘diadema’ è ridotto e sommario. Questa lavorazione asimmetrica rivela che la par-te destra del volto doveva essere in primo piano, mentre la sinistra appariva di scorcio: ciò fa sup-porre che la testa fosse girata verso la sua sinistra, come è confermato anche dall’impostazione obli-qua del fondo, che taglia diagonalmente la nuca.
Il volgersi del capo presuppone la presenza di un’altra figura, posta nella parte destra del-
le; quello destro è formato da cinque trecce, quel-lo sinistro da quattro, per cui la porzione sinistra risulta più bassa e schiacciata, oltre ad essere resa più sommariamente. Il turbante, di forma ampia ed espansa, ben calzato sul capo, avvolge l’intera circonferenza cranica ed è direttamente collega-to al ‘diadema’. Il turbante, appena inclinato, è composto di una corona di sei trecce sovrappo-ste, del tipo tubolare con solchi incisi profonda-mente da una serie ininterrotta di Y affiancate; la treccia inferiore spunta per un breve tratto ai lati dell’elemento a crestina. Le due trecce superiori appaiono più brevi e l’ultima è incassata dietro la penultima. Sulla sommità della testa la superficie è sommariamente scolpita con una banda piatta, centrale, rilevata, ai cui lati si dispongono cioc-che larghe e piatte, appena sgrossate, pettinate verso il basso con rozzi solchi paralleli. Gli orec-chi sono completamente scoperti; dalle tempie si staccano due riccioli, quello a destra ad uncino, mentre il ricciolo sinistro è ridotto ad un accenno appena visibile di forma lenticolare.
Si notano evidenti asimmetrie nelle due metà della testa. La parte sinistra del viso è più sfug-gente e schiacciata: la guancia è breve e ribassata, lo zigomo è alto ed anche l’occhio è appena sol-levato e più allungato, con l’angolo esterno che si alza leggermente in sù, come anche l’estremità del
7. Disegno Arch. Mario Chighine.
BCom CXIV.indb 66 04/03/15 12:12
Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana a deambulatorio sulla via Ardeatina 67
la tradizione delle immagines maiorum, da cui di-pende anche la sistemazione rigidamente paratat-tica delle figure nei rilievi cosiddetti a cassetta12. Questi ultimi dipendono direttamente dai rilievi funerari a figura intera, di cui costituiscono una forma abbreviata di risparmio13: i busti possono variare nell’ampiezza, limitandosi a volte alle sole spalle o arrivando fino ai fianchi14, e nel numero: due o più personaggi allineati in serie, uno accan-to all’altro, di prospetto, come veri e propri grup-pi di famiglia15. Sulle spesse cornici a fascia liscia, che inquadrano il campo figurato, sono incise le iscrizioni sepolcrali. Il tipo ‘a cassetta’ si carat-terizza per la rigida frontalità16 e l’isocefalia, per l’aggetto ridotto e la mediocre qualità dei ritratti.
I rilievi a figura intera, meno diffusi di quelli ‘a cassetta’, sono più strettamente legati all’ambito urbano e si caratterizzano per una superiore qua-lità artistica17. Essi consistono in una lastra lunga e stretta, in genere priva di incorniciature late-rali18, ma spesso fornita di una superficie di ap-poggio per permetterne l’inserimento nella mu-ratura dell’edificio sepolcrale19. Sul fondo neutro campeggiano le figure di prospetto, affiancate, ma senza contatti fisici, e delineate nettamente con un aggetto molto alto, per cui le teste-ritrat-to risultano quasi a tutto tondo e i corpi raggiun-gono una monumentalità statuaria, essendo di dimensioni al vero o leggermente superiori. In genere si tratta di una coppia di coniugi20, a volte accompagnata dai figli21, rappresentati tra i ge-nitori o al loro fianco. Più rari sono i rilievi con due uomini togati22, con due togati e una donna al centro23, con due donne24: in tali casi, però, sia
la lastra: probabilmente il marito, secondo la ti-pologia più consueta dei rilievi funerari con gli sposi, che nel girare la testa l’uno verso l’altra o nell’atteggiamento delle mani strette nella dex-trarum iunctio manifestano il vincolo nuziale. La maggior parte di questi rilievi presenta la don-na alla sinistra e l’uomo a destra di chi guarda6, proprio come doveva essere in origine nel rilie-vo in esame; ma la posizione delle componenti della coppia poteva anche essere invertita, come è testimoniato in alcuni rilievi tardo-repubblica-ni, quali quello da via Statilia e quello da Porta Maggiore, entrambi nel Palazzo dei Conservato-ri, di cui poi tratteremo.
La produzione dei rilievi funerari inizia a Roma nella tarda età repubblicana, diffondendosi velo-cemente nei centri della penisola e delle province occidentali per tutta la prima e media età impe-riale; essi venivano posti all’esterno delle tombe, in genere inseriti nelle facciate7. La maggior par-te degli esemplari esaminati da Kockel sono in marmo lunense8, come il nostro frammento; rari quelli in travertino, calcare e tufo. Sono testimo-niate due tipologie9: la lastra di forma rettangola-re, a sviluppo longitudinale, con i defunti a figura intera, e il rilievo quadrangolare, a sviluppo tra-sversale, che limita la raffigurazione al solo busto. Entrambe le tipologie costituiscono un’eviden-te riduzione economica10, carica di valenza sim-bolica, delle statue funerarie a tutto tondo, che venivano dedicate all’interno dei sepolcri o nelle domus aristocratiche11 a ricordo dei membri de-funti della famiglia, considerati exempla virtutis. La forma del busto trae spunto direttamente dal-
6 Es. Goette 1990, n. 64, tav. 20, 2; nn. 110-111, tav. 23, 3-4; n. 35, tav. 36,1.
7 Sulla sistemazione dei rilievi sepolcrali nella struttura architet-tonica: Frenz 1977, pp. 89 n. 1, 91 n. 3, 94 n. 10, 97-98.
8 Kockel 1993, pp. 57-58. Partendo dalla considerazione che le cave di Luni furono aperte per la prima volta sotto Cesare e che il marmo lunense fu adottato a Roma come materiale da co-struzione non prima del 50 a.C. e per la produzione statuaria dal 30-20 a.C., si può supporre che tale materiale non sia stato disponibile per la più modesta scultura funeraria prima del 20 a.C. Cfr. Kleiner 1977, pp. 71-75; Kleiner–Kleiner 1975, pp. 257-259.
9 Sulle forme dei rilievi funerari: Frenz 1977, pp. 10-33 (il grup-po j è quello dei rilievi a figure intere); Kleiner 1977, pp. 47-66 (la Kleiner suddivide il gruppo dei rilievi funerari in 11 formati, di cui quello A è dei rilievi a figura intera, quello B dei rilievi con ritratti tagliati al busto); Frenz 1985; Kockel 1993, p. 10.
10 Kockel 1993, p. 11.11 Testimonianze si hanno nelle gallerie statuarie giulio-clau-
die e nelle edicole funerarie di Pompei: Zanker 1975, p. 308, fig. 15.
12 Le spesse cornici sui quattro i lati conferiscono al rilievo l’a-spetto di una cassetta da cui si affacciano le teste (Kastengrabsteine e ‘Fensterguckern’): Kockel 1993, pp. 10, 12; Zanker 1975, p. 279.
13 Zanker 1975, pp. 280-281, 307; Kleiner 1977, pp. 52, 78-81; Kockel 1993, p. 11.
14 Zanker 1975, p. 281, fig. 9.15 Zanker 1975, pp. 294-297, fig. 31; da ultimo sui vincoli fami-
liari evidenziati sui monumenti scultorei: Kleiner 2000, pp. 43-60. 16 Zanker 1975, pp. 286-287.
17 Secondo la Kleiner (Kleiner 1977, pp. 47-49, 51,nn. 1, 8, 11-13, 37, 64-66) dei complessivi 92 esemplari, i 9 rilievi del gruppo A, a figura intera, i più ambiziosi, costituiscono il 9.78% del totale.
18 Sulla struttura dei rilievi ‘a cassetta’: Kleiner 1977, pp. 78-80; Kockel 1993, p. 10. Incorniciature e strutture architettoniche presentano, invece, le stele funerarie achitettoniche con figure in-tere dei defunti, tipologia assai più rara di quella con busti, ampia-mente diffusa in Italia Settentrionale : Pflug 1989, pp. 39-47, Kat. Nn. 30, 45, 56, 179, 190-191, 222, 259-261. Il rilievo funerario di età adrianea di Galatea e del marito, conservato in Vaticano, da Villa Borghese, presenta effettivamente un listello tutt’intorno, su cui corre in alto l’iscrizione: Goette 1990, p. 134, n. 64, tav. 20, 2.
19 Frenz 1977, pp. 105-106.20 Raramente accompagnati dai figli, rappresentati con propor-
zioni naturalistiche (Zanker 1975, pp. 280, nota 53, 287, figg. 13-14; Kockel 1993, pp. 110-111, D 6, tav. 24 a-b; pp. 152-153, I 8, tav. 66 b-d; p. 206, 212-213, N 18, tav. 126 d; p. 221, O 27, tav. 128 c), a volte il ritratto del bambino è in forma di busto, collocato tra i genitori: rilievo a palazzo Valentini, Roma, da Ostia, di età tardo-antonina, già citato supra a nota 5.
21 Testimonianze di rilievi a figura intera in cui un bambino o una bambina accompagna la coppia sono raccolte in: Kockel 1993, pp. 110-111, cat. D 6, tav. 24 a-b (frammento con donna e bambino del 30 a.C.); pp. 152-153, cat. I 8, tav. 66 b. d (coppia con bambina, frammentario, di poco antecedente all’Ara Pacis);
22 Kockel 1993, pp. 95-96, cat. B 2, tavv. 10 b, 11 a-b: 50/30 a.C.23 Kleiner 1977, p. 217, n. 37, fig. 37 (30-13 a.C.); Kockel 1993,
p. 152, cat. I 7, tav. 66 a. c. (rilievo coevo all’Ara Pacis).24 Kleiner 1977, p. 199, n. 8, fig. 8 a-c; Kockel 1993, p. 222, cat.
O 29, tav. 132 a. c.: media età augustea.
BCom CXIV.indb 67 04/03/15 12:12
68 Annarena Ambrogi
lità formale sono elementi che permettono di escludere l’appartenenza della testa in esame alla tipologia ‘a cassetta’, attribuendola piuttosto ad un rilievo a figura intera, in cui la coppia di sposi presentava i corpi di prospetto, paratattici, e le teste girate l’una verso l’altra. Allo stesso modo, in base all’altorilievo, alle dimensioni (alt. men-to-sommità della testa cm 23 e cm 25) e al vol-gersi del capo verso sinistra, due teste femminili conservate nei magazzini del Museo Nazionale Romano32, datate una negli anni ’50 del i secolo a.C., la seconda negli anni ’30, sono state attri-buite ciascuna ad un rilievo a figura intera con almeno due personaggi. Nella seconda testa la torsione comporta la perfetta rifinitura dell’ac-conciatura sul solo lato destro, quello più visibi-le, mentre la parte sinistra è lasciata in abbozzo e l’orecchio corrispondente è più sporgente, pro-prio come avviene nel nostro esemplare.
Il rilievo, cui apparteneva la testa della basilica circiforme, doveva apparire in origine simile ad alcuni noti esemplari, già citati, quali il cosiddet-to rilievo di Eurysaces e di Atistia33 (fig. 8), che si data secondo alcuni nella media età augustea, secondo altri poco prima della metà del i secolo a.C. Esso presenta una coppia a figura intera e a rilievo molto alto; i corpi in posa statuaria sono affiancati, ma non interagiscono, mentre entram-be le teste si girano l’una verso l’altra, creando un legame d’intesa, pur senza incrocio di sguar-di. Questo doveva essere lo schema compositivo, seppur con le posizioni invertite, adottato origi-nariamente nel rilievo pertinente alla nostra te-sta. Simile lo schema riprodotto nella lastra in calcare rinvenuta a via Statilia34 (fig. 9), datata intorno al 50 a.C., dove l’uomo a sinistra, togato, e la donna a destra nel tipo della Pudicitia, sono rappresentati ad alto rilievo, rigidamente fronta-li, ma senza il caratteristico volgersi delle teste. Un altro rilievo fornisce un’idea di come dove-va apparire la nostra opera integra: la lastra, rin-venuta a Pianabella (Ostia) e conservata a Roma nel Palazzo Valentini35 (fig. 10), con la coppia dei
i corpi che le teste sono rigidamente frontali. Ciò conferma che nel caso in esame il rilievo doveva essere composto da una coppia di sposi, visto che la donna non ha il capo di prospetto, ma volto di lato. Rari sono i rilievi a figura intera con quattro o più figure25 oppure con un solo personaggio26.
L’appartenenza dei defunti alla classe dei li-berti e dei loro discendenti27, come è testimonia-to dalle iscrizioni incise sulle cornici dei rilievi ‘a cassetta’, rivela che la creazione e la diffusione di questi manufatti sepolcrali coincide sostanzial-mente con l’affermazione della classe libertina, che costituiva lo strato medio urbano impegnato nella piccola impresa e che proprio negli ultimi decenni del i secolo a.C. cominciò ad assumere un ruolo chiave nella società romana, giovando-si della stima e dell’apprezzamento di Augusto. L’importanza dei liberti si mantenne inalterata fino a tutta l’età traianeo-adrianea, quando co-minciò l’ascesa dei funzionari di rango equestre. Secondo Zanker28, la predilezione dei liberti per i rilievi sepolcrali con figure di dimensioni na-turali o al di sopra del vero, anche se tagliate al busto, dipendeva dal fatto che in essi veniva dato grande risalto al volto, su cui si doveva concen-trare l’attenzione dello spettatore, mentre ap-parivano poco rappresentative le stele funerarie tardo-ellenistiche, nelle quali le figure, seppure intere, risultavano di dimensioni troppo ridot-te29. Nella produzione del ii secolo d.C., i rilie-vi funerari mantengono pressocché inalterate le caratteristiche tipologiche e compositive30, ade-guandosi alle mode del tempo nel taglio del bu-sto in vita, nell’accentuazione del movimento, nell’introduzione di elementi utilizzati nel pe-riodo medio-imperiale per l’elevazione e la deifi-cazione dei defunti, come il calice di foglie (Blät-terkelch) al di sotto del busto o l’assimilazione a Venere nel tipo iconografico, e nel collegamento con elementi tratti dalla decorazione dei sarco-fagi.
Posizione di tre quarti della testa, rilievo in forte aggetto, quasi a tutto tondo31, e buona qua-
25 Frenz 1985, pp. 106-107, n. 48, tav. 23.26 Ricordiamo come esempio un rilievo da via Casilina, datato tra
l’età tardo-repubblicana e quella augustea, con una donna anziana nello schema della Pudicitia: Ambrogi 1984, pp. 337-338, n. x.45; Frenz 1985, p. 97, n. 32, tav. 15, 1; Kockel 1993, p. 223, cat. O 31, tav. 133 a (Kockel esclude che il rilievo, ritagliato tutt’intorno alla figura, potesse includere un altro personaggio) e un rilievo al mu-seo di Ostia di età tiberiana con un togato: Calza 1964, pp. 39-40, n. 48, tavv. xxix-xxx.
27 Sulla committenza libertina di questa classe di rilievi sepolcra-li, si rimanda in particolare a: Zanker 1975, pp. 281-284; Kleiner 1977, pp. 22-46.
28 Zanker 1975, p. 310.29 Le stele tardo-ellenistiche erano note a Roma e in Italia grazie
all’importazione e all’imitazione; esse, a differenza dei rilievi se-polcrali di cui stiamo trattando, costituivano dei monumenti a sé stanti, non inseriti in una struttura architettonica: Zanker 1975, pp. 309-310, note 145-146.
30 Kockel 1993, pp. 206-213.31 Kockel (Kockel 1993, p. 10, nota 77) sottolinea che dal marca-
to altorilievo di alcune teste frammentarie (per esempio i nn. Cat. A 12, E 9, N 17) si può desumere la pertinenza del frammento ad un rilievo a figura intera.
32 Kockel 1993, pp. 92-93, cat. A12, tav. 9 a-b con bibl. prec.33 Non è certa la pertinenza al sepolcro del fornaio Eurisace,
presso Porta Maggiore, né dell’iscrizione, né del rilievo funerario: Kleiner 1977, pp. 202-203, n. 12, fig. 12 a-b (13 a.C.-5 d.C.); Ko-ckel 1993, pp. 88-91, cat. A 8, tav. 7 a-d (poco prima della metà del i secolo a.C.), con bibl. prec.
34 Kleiner 1977, pp. 201-202, n. 11, fig. 11 (palombino, 75-50 a.C.); Kockel 1993, pp. 94-95, cat. B 1, tavv. 10 a, 12 a, 14 a-b con bibl. prec.
35 Calza 1978, pp. 29-30, n. 32, tavv. 24-26; Kleiner 1981, pp. 522-527, n. 3, tavv. xxi, 4- xxii, 5; Frenz 1985, p. 97, n. 32, tav. 15, 1; Goette 1990, p. 136, n. 110, tav. 23, 3; Kockel 1993, p. 212, cat. N 17, tav. 126 c con bibl. prec.
BCom CXIV.indb 68 04/03/15 12:12
Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana a deambulatorio sulla via Ardeatina 69
questa classe rimane sempre un po’ di spazio li-bero al di sopra delle teste, mentre nella maggior parte dei rilievi funerari ‘a cassetta’ la sommità arriva a toccare direttamente il soffitto della cor-nice superiore37.
Nel tentativo di definire l’iconografia e l’iden-tità della donna raffigurata nel nostro frammento possiamo solo affermare con certezza che non era capite velato e che doveva essere piuttosto gio-vane, vista la tensione dell’epidermide, l’assenza di rughe profonde e la freschezza dell’incarnato; nulla possiamo dire, invece, dell’abbigliamento e della tipologia statuaria a causa dell’esiguità del pezzo. In genere nei rilievi funerari, sia a fi-gura intera che a busti, gli uomini indossano la toga, status-symbol che connota i liberti come cittadini romani. Le donne sono vestite di tuni-ca e mantello (palla)38 e riproducono i tipi sta-tuari greci della plastica a tutto tondo: i più dif-fusi sono quello della piccola Ercolanese39 e una variante del tipo della Pudicitia, denominata ‘Braccio Nuovo’40, presente sia nei rilievi a figu-ra intera, che nei rilievi a busti, a Roma e nel
coniugi a figura intera e il busto del figlio, data-bile in età tardo-antonina. Le figure degli adulti sono rappresentate a grandezza naturale36 e qua-si a tutto tondo: la donna, nel tipo dell’Afrodite del Fréjus, si trova a sinistra e gira il capo verso l’uomo, ponendogli la mano sinistra sulla spalla destra.
Anche le dimensioni della testa in esame, leg-germente al di sopra del vero, concordano con quelle dei rilievi a figura intera: quello cd. di Eu-risace misura in altezza ben 207 centimetri e le sole teste raggiungono i 26 centimetri (mento-sommità del capo); il rilievo di via Statilia è alto cm 179 e le teste misurano cm 24/25. L’altez-za della nostra testa non supera i 21 centimetri: apparteneva, quindi, ad un rilievo di dimensio-ni notevoli, al di sopra del vero, ma leggermente inferiori rispetto a quelle degli esemplari sopra-citati.
Il fatto che nel pezzo in esame la porzione della parete di fondo sopravanzi il capo (di 1, 5 centi-metri) è un altro argomento a favore della per-tinenza ad una stele a figura intera, dato che in
8. Roma, Musei Capitolini, rilievo funerario cd. di Eurysaces (da Kockel 1993, tav. 7, a).
10. Roma, Palazzo Valentini, rilievo funerario da Ostia (da Kockel 1993, tav. 126, c).
9. Roma, Musei Capitolini, rilievo funerario da via Statilia (da Kockel 1993, tav. 10, a).
36 L’altezza totale della lastra è di cm 170.37 Si citano a titolo esemplificativo alcuni rilievi a cassetta con
sommità delle teste che toccano direttamente il bordo: Kleiner 2000, figg. 3.8, 3.9 a p. 55 (pp. 43-60); Fittschen 1996, p. 42, figg. 1-2; S.H. Cormack, in Kleiner–Matheson 1996, pp. 199-201, nn. 149, 150, 151.
38 Frenz 1977, pp. 60-66, 66-67.
39 Kockel 1993, p. 29.40 Sui rilievi funerari in cui è attestato questo tipo statuario: Ko-
ckel 1993, pp. 25-26. Sul tipo Braccio Nuovo, creato nella seconda metà del ii secolo a.C. in ambito microasiatico, diffusosi in suolo italico nella metà del i secolo a.C.: Linfert 1976, pp. 151-152, note 597-601 con lista delle repliche; Fittschen–Zanker 1983, pp. 41-42, n. 47.
BCom CXIV.indb 69 04/03/15 12:12
70 Annarena Ambrogi
tratto di grande qualità sia stato necessariamente commissionato da un cliente dell’alta società; lo rivelano le iscrizioni pertinenti a ritratti di eleva-to livello qualitativo, che appartengono a mem-bri della classe media.
Neanche la pettinatura può fornire più puntua-li informazioni sull’identità e sullo status sociale e civile della donna, in quanto il tipo di accon-ciatura adottato nelle immagini scultoree sepol-crali era essenzialmente vincolato ai dettami del-la moda diffusa dalle immagini imperiali e solo in modo generico alludeva allo status economico, culturale e sociale della persona ritratta46. Tutta-via, le donne private raffigurate con pettinature molto complicate e raffinate, che necessitavano dell’aiuto di una ornatrix e di capelli posticci47 e che seguivano attentamente la moda delle prin-cipesse imperiali, dovevano appartenere ai ceti più elevati o quantomeno a famiglie con notevo-li risorse finanziarie48; prerogativa quest’ultima non soltanto della classe aristocratica49, ma an-che dei ricchi liberti50.
Solo occasionalmente l’acconciatura serviva ad indicare una precisa funzione sociale, civile o religiosa rivestita dalla donna ritratta, come nel caso delle Vestali, il cui ufficio sacro era segnala-to dalla presenza nei capelli delle infulae51, o nei casi delle matres familias e delle flamini, distinte dal tutulus52, acconciatura formata da un’ampia fascia avvolta sul sommo del capo, con i capel-li raccolti sulla nuca in un cono di trecce. Con un’elaborata e particolare pettinatura si accon-ciavano le nubentes in occasione della celebrazio-ne delle nozze, ornandosi con i seni crines53. Ma a nessuna di queste circostanze sembra alludere l’acconciatura della testa in questione, che sep-pur complessa rientra in un tipo assai comune tra le donne di età traianea e adrianea, apparte-nenti sia alla corte imperiale, sia alla cittadinanza privata di ogni rango. Peraltro, gli studiosi non sono concordi sul valore di indizio cronologico e di strumento di conoscenza dello status socia-
resto dell’Italia41; quest’ultimo tipo diventa più raro alla fine del i secolo a.C., a favore di altre va-rianti42 che si diffondono a partire dalla tarda età repubblicana e proto-augustea. È, inoltre, docu-mentata una tipologia più semplice, imitante le figure maschili togate, adottata negli esemplari di minore qualità in tutto l’arco temporale della produzione43. Questi differenti tipi iconografici sembrano essere usati casualmente, senza regole basate sull’età o sullo stato civile della defunta44: la scelta forse dipendeva più dal repertorio dello scultore, che dalla posizione sociale del commit-tente. Soltanto la rappresentazione della don-na palliata e capite velato, a volte con l’aggiunta della stola, appare distintiva del ruolo di donna sposata e dello status di matrona, in genere col-legata alle varianti e derivazioni della Pudicitia e prediletta nella tarda età repubblicana. Questi dati inducono ad escludere che il personaggio in esame potesse essere una matrona di nobili na-tali.
A causa dell’esiguità del frammento, limitato alla sola testa, è difficile stabilire il ruolo sociale della defunta e il ceto di appartenenza; possiamo solo ipotizzare che potesse appartenere alla clas-se libertina o fosse una discendente di un liberto o una sua sposa, essendo i rilievi funerari, come si è detto, prerogativa quasi esclusiva della classe libertina.
Non fornisce un indizio dirimente nemmeno la qualità formale dell’opera. È probabile che la de-funta scolpita nel nostro rilievo appartenesse ad una famiglia benestante urbana, sufficientemen-te abbiente per poter affidare la memoria della congiunta scomparsa ad un monumento alquan-to costoso, quale doveva essere un rilievo a figu-ra intera, di buona fattura. Il fatto che la testa si caratterizzi per una qualità formale abbastan-za alta, non fornisce, tuttavia, indicazioni pun-tuali sulla classe sociale della donna raffigurata, poiché, come è stato sottolineato da Fittschen45, non si può automaticamente affermare che un ri-
41 In ambito urbano, rilievi a figura intera: Kockel 1993, cat. B1, I 7, O 31, tavv. 10 a, 66 a, 133 a; rilievi ‘a cassetta’: Kockel 1993, cat. A10, E 77, F 1, K 2, tavv. 6 c, 28 d, 31 a, 81 a; cat. F 4, H 13, K 3, tavv. 34 d, 56 a, 82 a. Rilievi funerari con il tipo ‘Braccio Nuovo’ nel resto dell’Italia: 11 esemplari sono catalogati da Frenz 1985, p. 107, n. 49, tav. 22; pp. 109-110, n. 55, tav. 24, 2; pp. 113-114, n. 62, tav. 28, 1; p. 118, n. 72, tav. 32, 3; pp. 152, n. 137, tav. 58, 3; p. 154, n. 142, tav. 58, 4; Pflug 1989, p. 239, n. 209, tav. 31, 3; pp. 245-246, n. 226, tav. 29, 3; p. 248, n. 231, tav. 33, 2.3; pp. 248-249, n. 232, tav. 34, 1.2; cfr. Kockel 1993, p. 26, nota 226.
42 Varianti del tipo ‘Braccio Nuovo’ diffuse nei rilievi sepolcrali: tipo ‘KLM-Via Flaminia 160’, tipo ‘Bologna-Verona’ e tipo ‘Eu-machia’ o tipo ‘Fundilia’: Kockel 1993, pp. 26-27, note 227-229; Cesa 2011.
43 Kockel 1993, pp. 28-29.44 Kockel 1993, p. 29.45 Fittschen 1996, p. 48.46 Concetto ribadito recentemente in: Bartmann 2001; Miche-
li-Santucci 2011, in part. p. xii: «i capelli… contribuiscono a dare identità alle donne di epoca romana».
47 Sull’utilizzo di toupet e capelli posticci per queste complicate acconciature: Fittschen 1993, pp. 203, nota 6, 208, nota 31.
48 Fittschen 1993, pp. 207-208, note 31-32.49 Come nel caso del ritratto di Milreu, studiato da Fittschen:
Fittschen 1993.50 È del tutto verosimile che acconciature complesse venisse-
ro adottate anche dai membri dello strato più basso della società, come dimostrano alcuni rilievi funerari di artigiani del ii secolo d.C.: Fittschen 1993, p. 208, nota 32.
51 Sull’ornatus delle Vestali: Frapiccini 2011, pp. 35-36 con bibl. prec. Fittschen (Fittschen–Zanker 1983, p. 66 al n. 86) ha sugge-rito la possibilità di una Angleichung delle acconciature a ‘turbante’ e ‘diademi’ alle complesse pettinature rituali con nastri delle Vestali.
52 Frapiccini 2011, p. 33.53 Le nubendae condividevano la pettinatura con le Vestali; en-
trambe avevano i capelli tagliati stretti nei seni crines: Frapiccini 2011, p. 35. Su queste acconciature peculiari, citate dalle fonti let-terarie, e sulla loro interpretazione: Sensi 1980-1981, pp. 53-92; Fayer 1986, pp. 1-24 con bibl. prec.; Betori–Cetorelli Schivo 2004, pp. 69-77.
BCom CXIV.indb 70 04/03/15 12:12
Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana a deambulatorio sulla via Ardeatina 71
mente ridimensionata dalle osservazioni avanza-te da Kockel a proposito proprio dei rilievi fu-nerari63: per lo studioso tedesco le pettinature non possono essere usate come unico strumen-to di datazione, né come indicatori assoluti dello status sociale64. Bisogna, inoltre, tener conto del fatto che non tutte le donne seguivano pedisse-quamente i dettami delle immagini ufficiali del-le imperatrici e delle principesse della corte: so-prattutto le più mature preferivano farsi rappre-sentare con pettinature ormai passate di moda65. Capita così che nei rilievi ‘a cassetta’ del i e ii secolo d.C.66 con affollati gruppi di famiglia sia possibile vedere una vera e propria carrellata di pettinature differenti, dalle mode tardo-flavie a quelle adrianee, fino alle più recenti proto-anto-nine67. Queste gallerie di acconciature, però, più che attestare l’adozione contemporanea di mode di periodi diversi, servivano ad illustrare la se-quenza generazionale dei membri di una stes-sa famiglia68. Ciò è confermato dall’uso di mez-zi stilistici differenti, alcuni intenzionalmente retrospettivi, come la mancanza di indicazioni oculari nelle coppie più anziane, altri innovati-vi, come l’aggiunta di iride e pupilla nei ritratti tardo-adrianei e antonini. Questo ‘conservatori-smo’ delle acconciature femminili deve, perciò, mettere in guardia dal fondare le proposte cro-nologiche sull’unico dato fornito dalla pettina-tura, specialmente nei casi in cui il frammento conservatosi sia troppo esiguo e con una singola figura, proprio come nel caso del ritratto della basilica circiforme.
Si deve tener conto, infine, anche della possibi-lità che oltre ai modelli imperiali, le donne roma-ne seguissero altri suggerimenti, come propone Fittschen in un suo articolo del 199669. Egli, par-tendo dall’osservazione che nessuna delle accon-ciature note dai ritratti femminili del ii secolo è rappresentata nelle effigi ufficiali delle impera-trici e che anche lo stile ‘a turbante’, così diffuso nella ritrattistica privata del periodo adrianeo, è sostanzialmente assente in quella imperiale con-temporanea, giunge ad ipotizzare che il modello
le da attribuire alle pettinature femminili, su cui purtroppo la documentazione antica, letteraria ed archeologica offre rare informazioni. Già We-gner54 nel 1938 si era mostrato perplesso sulla va-lidità probante dell’unico indizio fornito dall’ac-conciatura, avendo riscontrato notevoli ritardi tra la creazione del prototipo e la sua imitazione nella ritrattistica privata. Secondo Fittschen55, invece, la freiwillige Bildnisangleichung doveva seguire strettamente i cambiamenti della moda ufficiale, poiché soltanto l’imitazione tempesti-va poteva soddisfare la costosa Selbstdarstellung. I casi di palesi incongruenze cronologiche56 tra pettinatura, indicazioni oculari e taglio del busto si spiegano supponendo che l’esecuzione del ri-tratto sia avvenuta molti anni dopo la morte della persona rappresentata57; in genere, però, secon-do Fittschen58, l’imitazione avveniva non molto tempo dopo la creazione del prototipo imperiale.
Sulla semantica delle acconciature si è soffer-mata recentemente la Alexandridis59, eviden-ziando che le pettinature femminili, così come i lineamenti fisionomici e gli ornamenti, dipen-dono sostanzialmente da precise esigenze rap-presentative, intese a suggerire le risorse econo-miche a disposizione della persona ritratta per assolvere al costoso processo produttivo della rappresentazione iconica60. Peraltro, l’adozione di una particolare foggia di capelli non si limi-ta ad essere soltanto un fenomeno di moda imi-tativa dell’immagine imperiale, ma costituisce, secondo la Alexandridis61, una forma di testi-monianza della leale condivisione degli inten-ti morali, politici e culturali del potere centrale, sebbene risulti difficile distinguere tra Zeitgesicht inconsapevole e Angleichung consapevole62; con-cetto già formulato dalla Bonanno, che ricono-sce nel processo di assimiliazione da parte del-la ritrattistica privata della fisionomia e dell’ac-conciatura delle donne della famiglia di Traiano un’esplicita identificazione con le qualità morali che i membri della gens Ulpia incarnavano.
L’attribuzione di precise valenze semantiche alle acconciature femminili è stata sostanzial-
54 Wegner 1938, cc. 316-325.55 Fittschen 1984, pp. 129-132, note 7-11 (lo ‘Zeitgesicht’ è so-
prattutto il risultato della ricezione del ritratto imperiale da parte dei cittadini. L’elemento più imitato dai privati è sicuramente l’ac-conciatura, ma anche i particolari della fisionomia imperiale ven-gono adottati), 134-138.
56 Fittschen 1984, p. 132, nota 11: si può ricordare il caso di un ritratto femminile ai Musei Capitolini con pettinatura flavio-traia-nea, ma con indicazioni oculari successive al 130 d.C. e su un busto, non sicuramente pertinente, dal taglio adrianeo-protoantonino, le cui incongruenze cronologiche si possono spiegare supponendo che l’esecuzione del ritratto sia avvenuta molti anni dopo la morte della rappresentata: K. Fittschen in Fittschen-Zanker 1983, pp. 78-79, n. 103 con note 3-4.
57 Fittschen-Zanker 1983, pp. 78-79, n. 103, tav. 130.58 Fittschen 1984, p. 129. 59 Alexandridis 2004, pp. 65-67.
60 La stessa opinione aveva già manifestato: D’Ambra 2000, pp. 104-105. Nello studio recentissimo della Micheli si ribadisce che «l’acconciatura trasmette immediatamente informazioni su età, sta-to e ruolo della donna»: Micheli 2011, in part. pp. 49-50.
61 Alexandridis 2004, pp. 66-67.62 Bonanno 1988-1989, p. 301.63 Kockel 1993, pp. 35-49, 52.64 Secondo Kockel lo stato sociale è meglio suggerito dalla palla
o dalla vitta, attributi delle donne adulte di rango patrizio. Sulle vittae crinales, prerogativa delle donne nate libere, simboli di pu-rezza e modestia, poi messe anche dalle liberte: Frapiccini 2011, pp. 31-33.
65 Wegner 1938, p. 325; Kockel 1993, pp. 35-49, 58.66 Per esempio: Kockel 1993, cat. M 2, N 9, tavv. 111 c, 123 b.67 Kockel 1993, pp. 206, 209-210, cat. N 9, tavv. 123 b. c; 124 d.68 Kockel 1993, pp. 209-210. Cfr. Kleiner 2000.69 Fittschen 1996, pp. 44-46.
BCom CXIV.indb 71 04/03/15 12:12
72 Annarena Ambrogi
torea, soprattutto riguardo ai ritratti raffigurati sui più modesti rilievi funerari. A tal proposito interessanti sono le osservazioni di Kockel74, il quale sostiene che, pur basandosi le caratteristi-che anatomiche sull’osservazione diretta del rap-presentato e pur essendo la varietà iconografica testimoniata assai ricca, gli scalpellini dovevano utilizzare alcuni caratteri-base (cifre o sigle) re-lativi alla forma della testa, al sistema delle rughe e all’acconciatura: l’addizione analitica di queste componenti standardizzate conduceva alla for-mulazione della singola ‘individualità’. ‘Ricono-scere’ il personaggio per mezzo delle caratteri-stiche esteriori ‘realisticamente’ riprodotte non riguardava tanto l’individuo in sè, ma piuttosto la sua appartenenza ad una struttura sociale, in particolare alla famiglia: è per questo che, come scrisse Schweitzer, i ritratti romani ci appaiono come Lebensdokumente, des Einzelnen, der Fami-lie, des Geschlechts, des Staates75. Come nei rilievi tardo-repubblicani, anche in quelli del ii secolo d.C. ciò che risulta decisivo è la rappresentazio-ne delle affinità, dello status e del legame fami-liare nella sequenza generazionale76. Tra queste formulazioni di caratteri-base e l’individuali-tà vera e propria si inserisce e/o si sovrappone lo Zeitgesicht, che si sviluppa orientandosi verso l’immagine tipica della nobiltà e il modello pro-posto dalle effigi della famiglia imperiale77.
Dopo queste osservazioni generali sul valore semantico fornito dall’acconciatura e dai caratte-ri fisionomici di un ritratto, ritorniamo all’opera in esame, consapevoli che in un frammento così limitato l’analisi tipologica, iconografica e stili-stica può condurre a risultati più che verosimi-li, ma non definitivi. Nella testa rinvenuta nella basilica circiforme di via Ardeatina la comples-sa articolazione del ‘diadema’ e dell’ampio tur-bante, che avvolge completamente il capo come una corona di capelli, richiama essenzialmente le pettinature delle dame della famiglia Ulpia78, in particolare ripropone abbastanza fedelmen-te l’acconciatura di Marciana79 (fig. 11), sorella
per le classi inferiori non fosse fornito soltanto dalle immagini delle imperatrici, ma anche dai ritratti delle donne delle famiglie aristocratiche più influenti. Proprio per il ii secolo è, infatti, at-testato un numero notevole di ritratti femminili (venticinque)70, che Fittschen ha riunito in grup-pi di repliche derivanti da tipi ritrattistici comu-ni, non corrispondenti ai modelli imperiali coevi e pertinenti probabilmente a donne dell’ordine senatorio ed equestre, che influenzarono forte-mente lo sviluppo e la diffusione delle pettinatu-re di moda in tutto l’impero. Concetto ribadito recentemente in un articolo del 201271, in cui lo studioso, pur ammettendo l’esistenza di model-li o Musterbücher strettamente dipendenti dall’i-conografia imperiale, riconosce l’esistenza nella ritrattistica privata di pettinature anomale, deri-vanti da creazioni individuali e da forme ibride: questo fenomeno di Nicht-Angleichung ha come conseguenza che la datazione basata sulle sole acconciature abbia un valore solo approssimati-vo, essendo necessario l’ausilio di criteri stilistici e tecnici, come è già stato sostenuto da Kockel72. Per quest’ultimo, infatti, la varietà delle pettina-ture in voga in uno stesso periodo è tale da non poter essere afferrata metodicamente con una seriazione tipologica ordinata in una sequenza temporale, poiché allo strumento tipologico è necessario affiancarne altri, come lo Zeitgesicht, lo stile e il contesto, per giungere ad un risulta-to affidabile. Nel caso in esame, comunque, l’ac-conciatura può assumere una maggiore validità indiziaria, visto che, come sostiene lo stesso Ko-ckel, nei ritratti di giovani donne è più probabile la contemporaneità tra la tipologia adottata nel monumento sepolcrale e la sua creazione nell’i-conografia imperiale, sebbene vada considerato un certo lasso di tempo, tra i dieci e i venti anni, intercorrente tra la creazione del tipo e l’esecu-zione del rilievo73.
Un’altra questione è stata ampiamente dibat-tuta dagli studiosi di ritrattistica romana: quel-la dell’effettivo ‘realismo’ dell’immagine scul-
70 Fittschen 1996, pp. 46-49, figg. 6, 10, 13, 15, 17-18, 19, 21.71 Fittschen 2012, in part. pp. 106, 110-111.72 Kockel 1993, pp. 48-49, 58.73 Kockel 1993, pp. 49, 58.74 Kockel 1993, pp. 62-76; in particolare sull’effettivo ‘realismo’
dell’immagine p. 76, note 604-605.75 Schweitzer 1948, p. 137.76 Kockel 1993, p. 206.77 Secondo Zanker il fenomeno dello Zeitgesicht, che si diffonde
nell’ambito della ritrattistica privata maschile a partire dall’età nero-niana e flavia, raggiungendo il suo apice proprio in età traianea grazie alla grande popolarità dell’imperatore e del contenuto etico insito nel suo ritratto, consiste nell’assimilazione dei tipi iconografici ufficiali imperiali nell’ambito della ritrattistica privata, sia per quanto riguar-da l’acconciatura, che per la fisionomia: Zanker 1982, pp. 307-312, in particolare per l’età traianea p. 310. Cfr. Giuliani 1986, pp. 223-225.
78 Sull’evoluzione delle acconciature di età traianea e adrianea, da ultimo: Micheli 2011, pp. 70-74 con bibl. prec.
79 Wegner 1956, pp. 77-79, 121-122, tavv. 35-36; Kent–Over-beck–Stylow 1973, tav. 70, n. 274 (aureo 114/117 d.C.); un’at-tenta revisione con elenco dei ritratti attribuibili (Firenze, Log-gia dei Lanzi; New York, Metropolitan Museum, n. inv. 20.200; Ostia, museo n. inv. 20; già S. M. Capua Vetere, Antiquarium) e di quelli non riferibili a Marciana è in Bonanno 1988-1989, in par-ticolare sui ritratti di Marciana, pp. 261-277, 301, nn. A 1-4, figg. 1-16 (cfr. anche Fittschen 1993, pp. 204-205, nota 13; Brilliant 1993, p. 309). Sull’acconciatura traianeo-adrianea con ‘turbante’ o Flechtennest si veda anche: Mannsperger 1988, pp. 61-71, figg. 63-71. L’esplosione della moda dell’acconciatura ‘a turbante’ nella ritrattistica privata avviene tra l’età tardo-traianea e l’età adrianea, continuando fino alla piena età antonina, ma con una diversa tipo-logia di turbanti più stretti, in forma di torre rastremata, posti sulla sommità della testa, e con frange lisce o ondulate, che sostituiscono il ‘diadema’. È difficile, per il gran numero di testimonianze e di variabili attestate, poter tracciare una linea evolutiva e stabilire una classificazione della pettinatura ‘a turbante’ ai fini di una periodiz-
BCom CXIV.indb 72 04/03/15 12:12
Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana a deambulatorio sulla via Ardeatina 73
particolare, fu proprio con Marciana85, Augusta dal 105 al 112 d.C., che diventò di moda l’artico-lazione a tre livelli del ‘diadema’, diff ondendosi tra le immagini delle altre componenti femminili della famiglia imperiale e poi anche tra i ritratti privati di età traianeo-adrianea86, che riproduce-vano il modello standard variandolo, in partico-lare nella composizione e nel numero delle fasce del ‘diadema’, ridotte o aumentate fi no a quattro.
L’acconciatura ‘a turbante’ di Sabina è testi-moniata, come si è detto, in un solo tipo statua-rio: quello ‘Vaison’. Il ritrovamento in Gallia è da porsi in collegamento con il viaggio di Adriano nel sud del paese compiuto nel 121-122 d.C. 87.
di Traiano, e della fi glia Matidia80 (fi g. 12), poi adottata anche da Matidia minor81 e dalla sorel-lastra Vibia Sabina nei suoi ritratti del primo tipo, come mostrano le effi gi monetali82 (fi g. 13) e le otto repliche del tipo statuario detto di Vaison, dalla località di provenienza della statua eponi-ma83 (fi g. 14). Gli elementi distintivi della cosid-detta acconciature a turbante sono l’alta corona di trecce calzata intorno al capo come un berret-to e la costruzione a più livelli del ‘diadema’, di cui il primo, formato da una fascia di fi tte cioc-chette arcuate a mezzaluna, serviva a fi ssare l’ar-tifi ciosa struttura, terminando davanti agli orec-chi con un ricciolo a cavatappi o a chiocciola84. In
11. Aureo di Marciana (114-117 d.C.) (da Kent–Overbeck–Stylow 1973, tav. 70, n. 274).
13. Sesterzio di Vibia Sabina (134-136 d.C.) (da Kent–Overbeck–Stylow 1973, tav. 73, n. 288).
12. Aureo di Matidia (114-117 d.C.) (da Kent–Overbeck–Stylow 1973, tav. 70, n. 275).
zazione cronologica. La Buccino (Buccino 2011, p. 375) evidenzia il gran numero di variabili nello schema compositivo del turbante: posizione (sopra o intorno alla testa, verticale o inclinato), forma (cilindrica, espansa, incurvata, tubolare, sporgente oltre la nuca, etc.), sviluppo in altezza, a seconda del numero e dello spessore delle trecce, e tipo di chiusura sul retro. Su questa serie di ritrat-ti di private con pettinatura ‘a turbante’, si veda anche E. Rosso, in Balty–Cazes–Rosso 2012, pp. 179- 180. Secondo la Buccino (Buccino 2011, p. 375), in età tardo-traianea e adrianea compaiono i primi esempi, caratterizzati da un tipo di turbante che parte di-rettamente dalla fronte, senza frangia e ‘diademi’ (esempio la statua di Ostia, collegio degli Augustali: 5.17), svasato e calzato intorno alla testa (tipo Matidia minor); questo tipo di turbante potrebbe essere prioritario cronologicamente rispetto a quello posizionato sopra la calotta.
80 Sui ritratti scultorei attribuiti a Matidia, la cui iconografi a non è stata ancora del tutto chiarita: Wegner 1956, pp. 80-83, 123-5, tavv. 37-40, in particolare per i ritratti di Matidia con l’acconciatu-ra a ‘turbante’ e alto ‘diadema’: Wegner 1956, tavv. 37 (palazzo dei Conservatori), 39 (Parigi, Louvre 1196); Kent–Overbeck–Stylow 1973, tav. 70, n. 275 (aureo 114/117 d.C.); Fittschen–Zanker 1983, pp. 9-10, n. 8, tav. 10; Vermeule 1989, pp. 71-74, tavv. 31-38.
81 A Matidia minor recentemente è stato attribuito un notevole numero di repliche, tra cui ricordiamo il ritratto rinvenuto nelle vi-cinanze di Villa Adriana e la statua bicroma del teatro di Sessa Au-runca: Ruggi D’Aragona–Pensabene, 2002, pp. 325-326, n. 23; Reggiani 2007, pp. 122-125 con bibl. prec.
82 Sulle prime effi gi monetali di Vibia Sabina, con acconciatu-ra ‘a turbante’ e triplice ‘diadema’ frontale, simile alle pettinature di Matidia e Marciana: Wegner 1938, c. 303, fi g. 1, d-e; fi g. 3, d; Strack 1933, pp. 23-25, in part. p. 23, tav. vii, n. 359, tav. xvii, nn. 856-857; cfr. Kent–Overbeck–Stylow 1973, tav. 73, n. 288 (se-sterzio del 134/136 d.C.).
83 Del cd. tipo Vaison sono note 8 repliche a tutto tondo: la sta-tua eponima di Vaison-la-Romaine, il busto di palazzo Medici Riccardi a Firenze, le teste a Siviglia, da Italica, e a Copenhagen, da Ostia, a Malmö, da Roma, a Zurigo, probabilmente dall’Egit-to, un busto da Tivoli in collezione privata americana e un busto documentato nell’archivio fotografi co Bardini (Buccino 2007, p. 149, note 9-16 con bibl. di riferimento). Su tale tipologia si riman-da alla seguente bibliografi a: Wegner 1956, pp. 84-87, 126-127, 130-131, tavv. 41 b, 42; A.C., pp. 136-138, 145-147, 151-153, 223-224, nn. 3-4, 17, 22, fi gg. 16-20, 52-53, 61, 63, 65; Fittschen–Zanker 1983, p. 10-12, nota 5 (elenco di 5 repliche), nota 11; Fittschen 1996, p. 42, nota 14 (sulla replica americana nella col-lezione Dubroff ); Söldner 2010, pp. 224-225; Buccino 2011, p. 400-401 con bibl. prec.
84 Come nei ritratti di Marciana: Buccino 2011, p. 372, cat. 4.23 (Marciana), 6.12 (Matidia), 6.15 (Vibia Sabina).
85 Si confrontino i quattro ritratti sicuramente attribuibili a Marciana (Firenze, Loggia dei Lanzi; New York, Metropolitan Musem; Ostia, Museo, inv. n. 20; già S. Maria Capua Vetere, Antiquarium), che presentano tutti questa fascia di ciocche se-milunate intorno alla fronte, i riccioli davanti agli orecchi e un ampia ciambella di trecce sull’occipite: Bonanno 1988-1989, fi gg. 1-16.
86 Fittschen 1993, pp. 204-205, tav. 20 a-b; Buccino 2000, p. 143, note 571-572. Sui ritratti di private assimilate alla ritrattistica uffi ciale di Marciana: Bonanno 1988-1989, pp. 277-301 con elen-co delle opere a pp. 302-308. Sull’articolazione delle acconciature traianee, le cui complesse strutture fanno ipotizzare l’utilizzo di toupet: Fittschen 1993, pp. 203-205. Un accurato riesame delle acconciature femminili del ii secolo, in particolare del tipo ‘a tur-bante’, è stato recentemente svolto da: Buccino 2011, pp. 374-375 con bibl. prec.
87 Wegner 1938, c. 303-304, fi gg. 14-15.
BCom CXIV.indb 73 04/03/15 12:12
74 Annarena Ambrogi
o, più verosimilmente, con l’ascesa al trono di Adriano nel 117 d.C.89. Il 128 d.C., comunque, costituisce un terminus ante quem per la creazione del tipo ‘Vaison’, giacché nelle monete compare il nome di Adriano senza il titolo di pater patriae, che l’imperatore assunse proprio in quell’anno90. L’acconciatura somigliante a quella dei ritratti di Marciana e Matidia e delle private di età traianea e protoadrianea91 induce a preferire una crono-logia alta di questo tipo, che rimase in uso fi no alla morte di Sabina, nel 136 d.C., come rivela la coesistenza di repliche senza indicazioni interne oculari e di altre con i bulbi incisi. Ricordiamo che la datazione dei tipi ritrattistici di Vibia Sabi-na è ancora discussa e che alcuni studiosi dubita-no di poterli ordinare in una precisa successione cronologica92, giacché tipi diversi convivono con-temporaneamente, come testimoniano le emis-sioni monetali, sia urbane che provinciali, nelle quali vengono adottate nello stesso periodo tutte e quattro le versioni iconografi che93. NeIl’accon-ciatura ‘a turbante’ adottata da Sabina, i primi due elementi del ‘diadema’ si compongono di fa-sce sovrapposte, la seconda molto più alta della prima, rese con fi ni ondulazioni radiali, mentre il terzo elemento è di forma semilunata. Nei ritrat-ti scultorei ampie ciocche pettinate obliquamen-te occupano lo spazio tra il ‘diadema’ e il grande turbante a corona di trecce sovrapposte.
La corrispondenza nella composizione del ‘diadema’ e del turbante della testa della basi-lica circiforme con l’iconografi a imperiale risul-ta abbastanza evidente per la struttura generale e per le singole componenti, sebbene siano sta-te adottate alcune soluzioni originali. La fascia con corte ciocche a mezzaluna e i riccioli davanti agli orecchi sono stati variati nella testa in esame, spostando la prima nel secondo settore del ‘dia-dema’ e semplifi cando i riccioli in un ridotto un-cino davanti all’orecchio destro e in un tondello piatto davanti al sinistro; simile quest’ultimo a quelli presenti nei ritratti di Marciana, ma privo delle consuete spirali incise94. La terza fascia del diadema concorda nella forma a crestina, ridotta in larghezza, con quella presente nel primo tipo ritrattistico di Sabina, in cui forse è rappresenta-to un vero e proprio ‘diadema’ in materiale pre-zioso o una retina ornata di perle, come sembra-
La ricercata acconciatura è ancora vicina a quelle di Marciana e della fi glia Matidia, anche i line-amenti del volto, giovane e severo, resi con so-brio realismo, corrispondono a quelli delle don-ne della gens Ulpia: la forma della fronte conves-sa, il particolare taglio allungato degli occhi, le palpebre carnose e le morbide borse sub-oculari, l’incavo della caruncola ben evidenziato e molto lungo, le guance piene e lisce con pieghe labio-nasali appenna accennate, la bocca piccola e chiu-sa, segnata da fossette angolari, con il labbro in-feriore più carnoso ed ampio, e il mento potente. È certo che il tipo ‘Vaison’ vada collocato all’ini-zio della serie dei quattro tipi ritrattistici di Sa-bina, riconosciuti nelle monete e nelle immagini scultoree uffi ciali. È, invece, in dubbio se sia da mettere in relazione con l’elevazione ad Augusta di Sabina (data incerta tra il 119 e il 128 d.C.)88
14. Statua di Vibia Sabina, da Vaison-La-Romaine (da Balty–Ca-zes–Rosso 2012, fi g. 105).
88 Fittschen–Zanker 1983, p. 11, note 10-11: il primo tipo sa-rebbe stato creato nel 128 o forse prima; Salzmann 1989, p. 364; Schröder 1993, p. 200, n. 53: propendono per una datazione nel 121-122 d.C.
89 Sulla procedura di produzione dei ritratti imperiali e sul ‘ri-tratto-tipo’, modello uffi ciale commissionato dall’amministrazione imperiale e adottato da scultori e incisori per le copie dirette e indi-rette, e sulla datazione del primo tipo di ritratto uffi ciale di Sabina: Fittschen 1996, p. 42, nota 14, fi g. 5.
90 Söldner 2010, p. 224.
91 Cfr. Fittschen–Zanker 1983, n. 69, tavv. 86-87; Bol, Villa Albani, I, 1989, n. 117, tavv. 204-205; Chamay–Maier 1989, n. 17, tav. 31; Picozzi 1990, pp. 269-270, n. 147; Fejfer–Southworth, I, 1, 1991, pp. 31-32, n. 2, tavv. 3-4; Fittschen 1993, pp. 203-205, tavv. 18 b, 19 b; Kockel 1993, n. N 2, tav. 122 c; Schröder 1993, pp. 178-180, n. 45.
92 Salzmann 1989, p. 363; Söldner 2010, p. 224.93 Fittschen–Zanker 1983, p. 11, note 16-17; Salzmann 1989,
p. 364.94 Sul ricciolo a tondello con incisioni spiraliformi, si veda: Bo-
nanno 1988-1989, fi g. 7-12.
BCom CXIV.indb 74 04/03/15 12:12
Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana a deambulatorio sulla via Ardeatina 75
nel ritratto in esame ritroviamo questa singolare combinazione di austerità del viso e artificiosi-tà dei capelli101. Le pupille e le iridi non segnate confermano che la testa è stata realizzata prima del 130 d.C., quando nell’iconografia ufficiale di Adriano fu introdotta la novità dell’indicazione di iride e pupilla102; anche se questo criterio non è infallibile, suggerisce, comunque, una cronolo-gia antecedente alla tarda età adrianea.
Importanti indizi per precisare meglio il perio-do di realizzazione della testa in esame sono for-niti dal confronto diretto con il ritratto della già citata statua dal collegio degli Augustali di Ostia (fig. 15), raffigurata come Venere Genitrice se-
no suggerire i globetti in rilievo presenti nelle ef-figi monetali. I cambianti registrati rispetto alle tipologie ufficiali rivelano che il grado di adesio-ne ai modelli imperiali della testa della basilica circiforme di via Ardeatina non è totale, rispec-chiando quanto già evidenziato sulla tendenza comune alla ritrattistica privata di non rispettare totalmente i modelli imperiali95, prevalendo sul-la generale volontà di imitazione il desiderio di personalizzare con elaborazioni, modifiche e ag-giunte ogni singolo ritratto96.
Nella testa rinvenuta nella basilica circiforme di via Ardeatina il richiamo ai modelli ufficiali di età traianea e proto-adrianea si ravvisa anche nell’impianto generale del volto e nel disegno dei particolari fisionomici, obbedienti in sostanza alla Bildnisangleichung del severo ethos traianeo, che aveva determinato la diffusione di ritrat-ti femminili dai caratteri duri e austeri e dall’e-spressione fredda ed energica, culminante nelle labbra serrate97. Esempi particolarmente signifi-cativi di questo Zeitgesicht si hanno nella statua ostiense della sede degli Augustales, di cui si dirà in seguito, in una statua di Sabina da Cartagine, ascritta per il tipo di acconciatura e per il model-lato netto e vigoroso al 121-122 d.C.98, e in una testa coeva, conservata nei magazzini di Ostia99. Queste opere condividono nel trattamento pla-stico del viso, largo e angoloso, il realismo ‘obiet-tivo’100, privo di compiacimenti virtuosistici e di dettagli minuziosi, della ritrattistica aristocrati-ca e imperiale traianea e proto-adrianea, che im-pronta sostanzialmente anche la testa in esame.
Questo stretto collegamento con la ritrattistica ufficiale dei primi decenni del ii secolo induce a proporre per il ritratto della Circiforme una cro-nologia tra la prima e la media età adrianea. Il viso piuttosto massiccio, dall’impianto solido e squadrato, e i tratti fortemente individualizzati, che richiamano, pur in una versione più ‘popola-re’, il sobrio realismo e la robustezza plastica del primo tipo ritrattistico di Sabina, permettono di fissare la datazione tra il 120 e il 130 d.C. Come nei ritratti di Plotina, Marciana, Matidia e nel primo tipo di Vibia Sabina, nei quali alla compli-cata e artificiosa acconciatura si combina un vol-to realistico dall’espressione severa, così anche
15. Ostia, Museo, statua dal collegio degli Augustali (da Adembri–Nicolai 2007, fig. a p. 130).
95 Fittschen 1993, p. 206.96 Un gruppo piuttosto unitario di ritratti ‘a turbante’, caratte-
rizzati da variazioni nel numero delle trecce della corona e nella posizione sulla testa, che lascia visibili i capelli frontali, scrimi-nati nel mezzo e pettinati indietro, è stato riunito da Fittschen intorno a due ritratti dei Musei Capitolini, uno dell’inizio, l’altro della tarda età adrianea: Fittschen–Zanker 1983, pp. 61-63, nn. 83-84, tavv. 104-106; cfr. anche Buccino 2011, pp. 374-375; E. Rosso, in Balty–Cazes–Rosso 2012, pp. 179-180, nota 11. Sulla varietà e ricchezza delle acconciature femminili, da ultimo: Buc-cino 2011, pp. 361-383, in part. per le donne del ii secolo d.C. pp. 363, 372-376.
97 Bonanno 1988-1989, pp. 296-297; Buccino 2000, pp. 142-143, nota 568.
98 Kersauson 1996, ii, p. 134-137, n. 55, figg. a pp. 134, 137.99 Calza 1964, p. 64, n. 96, tav. lvii.100 Questo trattamento fisionomico improntato al realismo, se-
condo Fittschen, si ritrova in ritratti di private appartenenti al ceto medio: Fittschen–Zanker 1983, p. 63, al n. 84 b, d, k, Beil. 17 a, c-d.
101 L. Buccino, in La Rocca–Parisi Presicce–Lo Monaco 2011, p. 402, n. 6.16.
102 Cfr. Wegner 1956, pp. 10, 21-22, 62; Daltrop 1958, p. 70, nota 121; Balty–Cazes–Rosso 2012, p. 183.
BCom CXIV.indb 75 04/03/15 12:12
76 Annarena Ambrogi
ti mandibole squadrate. Analogo è anche il na-turalistico trattamento dell’incarnato con mor-bidi trapassi di piano intorno alla bocca e nella zona degli occhi. Simili le labbra, con lo stesso modellato carnoso e arcuato dell’inferiore, breve e sinuoso del superiore, e gli archi sopraccigliari, piuttosto bassi e privi di incisioni, sebbene nella testa ostiense la linea sia più diritta. Affini nelle due opere sono anche gli occhi, di forma allunga-ta, contornati dalla palpebra superiore molto ar-cuata, a breve fascetta corposa nettamente deli-neata, e dalla palpebra inferiore più diritta e con un leggero rigonfiamento, segnato in basso da un arco lievemente incavato. In entrambe le teste il globo oculare non presenta indicazioni interne incise. Questa sostanziale vicinanza tra la testa ostiense e quella in esame conferma la cronologia di quest’ultima agli anni 20 del ii secolo.
Allo stesso periodo conduce anche il confron-to con un ritratto femminile conservato a Kas-sel110 (fig. 16); la testa erroneamente attribuita a Matidia maior, appartiene piuttosto, per l’ac-conciatura ‘a turbante’ raffinata e ben rifinita, ad una donna di alto rango della prima età adria-nea, la cui resa fisionomica e stilistica appare in-fluenzata dalle immagini ufficiali di Matidia e da quelle di Sabina del tipo ‘Vaison’. La cronolo-gia in età protoadrianea è confermata dai bulbi oculari lisci con i particolari interni originaria-mente dipinti. Nonostante la diversa formula-zione dell’acconciatura ‘a turbante’, le anologie tra l’opera di Kassel e il ritratto rinvenuto nella circiforme appaiono evidenti, nella configurazio-ne del volto dai tratti giovanili, caratterizzato da mandibole squadrate, incarnato morbido e fre-sco, fronte spaziosa. Simile la modellazione dei grandi occhi a mandorla, privi di indicazioni in-terne, e delle sopracciglia appena arcuate, senza incisioni; le palpebre sono plasticamente modu-late. Anche la testa di Kassel presenta una co-struzione leggermente asimmetrica per la torsio-ne della testa, con l’occhio sinistro più grande e posto poco più in alto del destro. Similissimo è il disegno della bocca, breve, con la fossetta so-pralabiale. In entrambe le opere il modellato del
condo il tipo statuario dell’Afrodite del Fréjus, sulla cui identificazione si è sviluppata un’accesa discussione tra gli studiosi. Per prima la Calza103 ha proposto di riconoscervi un’immagine privata di Vibia Sabina giovane, creata tra il 100 e il 117 d.C., anteriormente alle nozze con Adriano; ipo-tesi spesso ribadita, anche di recente104. Le imma-gini sicuramente attribuibili a Sabina giovane105 mostrano, però, notevoli divergenze dal ritrat-to di Ostia, che si caratterizza per il viso largo e tondeggiante con guance molto ampie e il profilo più corto ed ossuto, per le sopracciglia marcate e orizzontali, poste appena sopra agli occhi, che appaiono diversi da quelli dell’imperatrice, per il naso con la gobba e le labbra più piccole e arretra-te. Queste notevoli differenze fisionomiche hanno indotto Wegner per primo, seguito da numerosi studiosi106, a negare l’identificazione con Sabina e a riconoscere nella statua ostiense una cittadi-na privata di età adrianea, raffigurata nei panni di Venere, secondo un processo di teomorfismo, particolarmente diffuso a Roma tra l’età claudio-neroniana e quella adrianea, e attestato fino agli inizi del iii secolo107. Anche il tipo di acconciatu-ra ‘a turbante’ della statua ostiense non trova ri-scontri diretti nell’iconografia di Sabina, nemme-no nelle effigi monetali, mentre è assia frequente nei ritratti privati108. Più convincente appare, per-ciò, l’identificazione in una donna privata di età adrianea, come risulta confermato dalla recente ipotesi che questa statua provenga da uno dei se-polcri privati ostiensi e che sia stata trasferita nel collegio degli Augustali in età tardoantica per es-sere calcinata109. Il confronto diretto tra la testa ostiense e quella della basilica circiforme non ri-guarda le acconciature, che presentano un’affinità generica limitata al turbante di trecce sovrappo-ste, disegnate in una simile trama ‘a stuoia’, ma si diversificano nella zona frontale, che nella statua ostiense presenta un’articolazione a trecce sotti-li sovrapposte, formanti una sorta di cuffia. La sostanziale somiglianza appare, invece, evidente nella struttura generale del volto, che in entram-be le opere, si caratterizza per una forma simile, piena e tondeggiante, definita in basso da possen-
103 Museo di Ostia, n. inv. 24; Calza 1964, pp. 77-78, n. 124, tav. lxxii, con bibl. prec.
104 Carandini 1969, pp. 134-136, n. 1, figg. 10-12; Wrede 1981, p. 306, nota 36; Mikocki 1995, p. 199, n. 336, tav. 31; Germoni 2007, pp. 130-131.
105 Ad esempio, il busto di Vaison: L. Buccino, in La Rocca–Pa-risi Presicce–Lo Monaco 2011, pp. 400-401, n. 6.15.
106 Per primo Wegner ha riconosciuto nella statua ostiense una privata di età adrianea, non trovando alcuna somiglianza fisionomi-ca con le immagini di Sabina (Wegner 1956, p. 127); tesi ribadita da: Sydow 1969, p. 152, nota 36; Helbig4, iv, 1972, pp. 61-62, n. 3061 (H. v. Heintze); K. Fittschen, in Fittschen–Zanker 1983, p. 63, n. 84 c; Wegner–Unger 1984, p. 150; D’Ambra 2000, p. 107 fig. 6.3; Fittschen 2000, pp. 512-514; Laird 2000, pp. 55-57, figg. 7-8. La discussione è stata recentemente ripresa a favore dell’attri-
buzione della statua ostiense ad una privata da: A. Lo Monaco, in La Rocca–Parisi Presicce–Lo Monaco 2011, p. 351, n. 5.17; E. Rosso, in Balty–Cazes–Rosso 2012, pp. 177-178, che considerano l’opera un esempio significativo dello Zeitgesicht adrianeo, replica-to in una rappresentazione sub specie deae.
107 Wrede 1981, pp. 67-175; sulla rappresentazione in formam deorum e sul processo di assimilazione delle private alle dee, più re-centemente: Matheson 1996, pp. 182-193; Lo Monaco 2011, pp. 335-349, con bibl. prec.
108 Un elenco di 12 ritratti di donne private con questa acconcia-tura è stato redatto da Fittschen, in Fittschen–zanker 1983, pp. 62-63, n. 84, tavv. 105-106.
109 Laird 2000, pp. 54-57, 64.110 Antikensammlung, alt. cm 30: Buccino 2011, p. 395, n. 6.11,
con bibl. prec.
BCom CXIV.indb 76 04/03/15 12:12
Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana a deambulatorio sulla via Ardeatina 77
volto appare caratterizzato dalla combinazione di ampie superfi ci morbidamente sfumate (zona della bocca, profi lo delle guance) con dettagli e contorni resi in maniera precisa e nitida (labbra, palpebre, sopracciglia), secondo il linguaggio formale della ritrattistica della prima età adria-nea111, che unisce al realismo obiettivo dell’anali-si fi sionomica il morbido plasticismo del model-lato; in ciò la severa asciuttezza traianea risulta ormai superata a favore di un classicismo natu-ralistico ed elegante.
Un altro confronto è fornito da un ritratto di Sabina su busto non pertinente, conservato nel Palazzo Medici Riccardi di Firenze112 (fi g. 17). Le analogie anche in questo caso si limitano al volto, essendo il turbante di dimensioni minori, calzato in obliquo e arretrato sull’occipite. Il ri-tratto Medici Riccardi, in base al modello adot-tato del tipo ‘Vaison’ e agli occhi dal globo liscio, è un’opera della prima età adrianea, databile in-torno al 121 d.C., realizzata da un’offi cina urba-na, come testimonia l’ottima fattura, la politezza della superfi cie marmorea e il delicatissimo mo-dellato del volto.
Un busto femminile con acconciatura ‘a tur-bante’ datato nel 100-125 d.C., conservato a Lei-den113 (fi g. 18), presenta un’acconciatura simile a quella della testa in esame, con il doppio ‘dia-
16. Kassel, Antikensammlung, ritratto femminile (da La Rocca–Parisi Presicce–Lo Monaco 2011, fi g. a p. 395).
17. Firenze, Palazzo Medici Riccardi, ritratto di Vibia Sabina (da La Rocca–Parisi Presicce–Lo Monaco 2011, fi g. a p. 401).
18. Leiden, Museo, ritratto femminile (da Bastet–Brunsting 1982, tav. 146, n. 500).
111 Söldner 2010, p. 225.112 Alt. testa con il collo cm 31: Buccino 2000, pp. 145-151, n.
49, tavv. 47-48; Buccino 2007, pp. 146-153 con bibl. prec.; Bucci-no 2011, pp. 400-401, n. 6.15.
113 Bastet–Brunsting 1982, pp. 260-261, n. 500, tavv. 146-147.
BCom CXIV.indb 77 04/03/15 12:12
78 Annarena Ambrogi
globo oculare suggerisce una datazione anterio-re al 130 d.C.
Un altro ritratto di donna di età matura della collezione fi orentina Medici Riccardi116 (fi g. 20), datato intorno al 130 d.C., off re ulteriori spunti di analisi sulle peculiarità iconografi che e stilisti-che caratterizzanti lo Zeitgesicht di questo perio-do. Le analogie di questo ritratto con la testa in esame sono evidenti nel ‘diadema’ doppio a cioc-che arcuate, semilunate, convergenti al centro, nella struttura squadrata del volto e nell’obiet-tiva segnalazione dei dettagli fi sionomici e dei segni dell’età, evidentemente più avanzata nella donna fi orentina. Il turbante è, invece, di forma e posizione diverse, ridotto in una piccola ciam-bella e posto in obliquo sul culmine del capo; gli occhi con indicazioni interne rivelano una data-zione leggermente più bassa rispetto all’opera in esame.
Al momento di passaggio dalla Turbanfrisur alla Turmfrisur si ascrive una testa femminile conservata a Villa Albani, datata negli anni 20 del ii secolo d.C.117 (fi g. 21): la ricordiamo non per l’acconciatura, che presenta una crocchia diversa, a torre, ma per le analogie formali nel trattamento del volto, che si avvicina a quello
dema’ a ciocchette piatte, semilunate, e il con-tiguo turbante di trecce; analoga è anche la resa semplifi cata e appiattita dei capelli sulla sommi-tà del capo, pettinati in una larga treccia piatta. Le indicazioni all’interno degli occhi e l’incar-nato più coloristicamente modulato rivelano una lieve posteriorità della testa di Leiden.
Di elevata qualità formale, certo superiore a quella dell’opera in esame, è un busto-ritratto di privata da Chiragan, conservato a Toulouse114 (fi g. 19): quest’opera, probabilmente urbana, si avvicina alla nostra per l’analogo turbante, per la resa della zona oculare e per la levigata ten-sione delle guance. Si diff erenzia, però, oltre che per il fi ne virtuosismo con cui sono resi i par-ticolari dell’elegante acconciatura e del volto, per la relativa semplicità della pettinatura, pri-va del ‘diadema’, sostituito da fasce lisce di ca-pelli, scriminati al centro della fronte, che tro-va confronto con una serie di ritratti anonimi115, databili tra l’epoca adrianea e l’età protoantoni-na. L’evidente vicinanza di questo ritratto fran-cese con quelli più antichi di Sabina permette di riconoscervi un esempio di altissima qualità formale dello Zeitgesischt dell’epoca. Il dettaglio tecnico dell’assenza di indicazioni interne nel
19. Toulouse, Musée Saint-Raymond des Antiques, ritratto fem-minile da Chiragan (da Balty–Cazes–Rosso 2012, fi g. 102).
20. Firenze, Palazzo Medici Riccardi, ritratto femminile (da Buc-cino 2000, tav. 45).
114 E. Rosso, in Balty–Cazes–Rosso 2012, pp. 172-183, n. 9, fi gg. 101-104, 107, 111-112.
115 Su questo gruppo di ritratti ‘a turbante’ privi di ‘diadema’: E. Rosso, in Balty–Cazes–Rosso 2012, pp. 179-180, note 10-18.
116 Buccino 2000, pp. 141-145, n. 48, tavv. 45-46.117 R. Amedick, in Villa Albani, 1994, iv, pp. 396-397, n. 515,
tavv. 226-227.
BCom CXIV.indb 78 04/03/15 12:12
Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana a deambulatorio sulla via Ardeatina 79
Abbreviazioni bibliografiche
Adembri–Nicolai 2007 B. Adembri, R.M. Nicolai (a cura di), Vibia Sabina. Da Augusta a Diva, Mila-no 2007.
Alexandridis 2004 A. Alexandridis, Die Frauen des römi-schen Kaiserhauses. Eine Untersuchungen ihrer bildlichen Darstellung von Livia bis Iulia Domna, Mainz am Rhein 2004.
Ambrogi 1984 A. Ambrogi, in A. Giuliano (a cura di), Museo Nazionale Romano, i.7, Roma 1984, pp. 337-338, n. x.45.
Balty–Cazes–Rosso J.-Ch. Balty, D. Cazes, E. Rosso, 2012 Sculptures antiques de Chiragan. I. Les
portraits romains, i.2. Les siècle des Anto-nins, Toulouse 2012.
Bartman 2001 E. Bartman, Hair and the Artifi ce of Roman Female Adornment, in AJA, 105, 2001, pp. 1-25.
Bastet–Brunsting 1982 F.L. Bastet, H. Brunsting, Corpus Si-gnorum Classicorum. Musei Antiquarii Lugduno-Batavi, Leiden 1982.
Betori– A. Betori, G. Cetorelli Schivo, In Cetorelli Schivo 2004 modum diadematis. L’acconciatura fem-
minile a Roma come indicatore di status, in Reggiani 2004, pp. 69-77.
Bonanno 1988-1989 M. Bonanno Aravantinos, Un ritratto femminile inedito già nell’Antiquarium di S. Maria Capua Vetere. I ritratti di Mar-ciana: una revisione, in RendPontAc, 61, 1988-1989, pp. 261-308.
Brilliant 1993 R. Brilliant, Hairiness. A Matter of Style and Substance in Roman Portraits, in R.T. Scott, A.R. Scott (edd.), Eius virtutis studiosi: Classical and Postclas-sical Studies in Memory of Frank Edward Brown (1908-1988), Washington 1993, pp. 303-312.
Buccino 2000 L. Buccino, in V. Saladino (a cura di), Le antichità di Palazzo Medici Riccardi, ii. Le sculture, Firenze 2000.
Buccino 2007 L. Buccino, Busto di Sabina, in Adem-bri–Nicolai 2007, pp. 146-153.
Buccino 2011 L. Buccino, Morbidi capelli e acconcia-ture sempre diverse, in La Rocca–Pari-si Presicce–Lo Monaco 2011, pp. 361-383.
Calza 1964 R. Calza, Scavi di Ostia, v. I ritratti. 1. Ritratti greci e romani fi no al 160 circa d.C., Roma 1964.
Calza 1978 R. Calza, Scavi di Ostia, ix.2. I ritratti. Ritratti romani dal 160 circa alla metà del iii secolo d.C., Roma 1978.
Cesa 2011 M. Cesa, Le artigiane del capello, in Mi-cheli–Santucci 2011, pp. 41-48.
Chamay–Maier 1989 J. Chamay, J.-L.Maier, Art romain.Sculptures en pierre du Musée de Genève, ii, Mainz 1989.
Daltrop 1958 G. Daltrop, Die stadtrömischen männ-lichen Privatnildnisse trajanischer una hadrianischer Zeit, Münster 1958.
D’Ambra 2000 E. D’Ambra, Nudity and adornment in female portrait sculpture of the second cen-tury AD, in Kleiner–Matheson 2000, ii, pp. 101-114.
De Nuccio–Ungaro M. De Nuccio, L. Ungaro (a cura di), I 2002 marmi colorati della Roma imperiale, Ve-
nezia 2002.Fayer 1986 C. Fayer, L’ornatus della sposa romana,
in StRom, 34, 1986, pp. 1-24.Fejfer–Southworth J. Fejfer, E. Southworth, The Ince 1991 Blundell Collection of Classical Sculp-
ture, i. The Portrats, 1, London 1991.Fiocchi Nicolai V. Fiocchi Nicolai, La basilica circifor- 1995-1996 me della via Ardeatina (con appendice
di M.P. Del Moro, D. Nuzzo, L. Spera), in RendPontAc, 68, 1995-1996, pp. 69-233.
della testa della basilica circiforme per il dise-gno delle labbra, per le pieghe labio-nasali ap-pena infossate, per la resa degli occhi dal bulbo liscio e con la palpebra superiore carnosa, netta-mente delineata, e l’inferiore rigonfi a. L’assenza del trapano nei capelli e nel viso e il modella-to naturalistico confermano la contemporaneità delle due opere.
I dati forniti dall’analisi tipologica, icono-grafi ca e stilistica e dai confronti considerati tracciano un quadro coerente che permette di riconoscere nella testa rinvenuta nel muro di fondazione della basilica circiforme sulla via Ardeatina un ritratto in origine pertinente ad un rilievo funerario a fi gura intera, composto verosimilmente da una coppia di sposi, che do-veva essere esposto presso un monumento fu-nerario, forse inserito nella facciata, eretto lun-go la via Ardeatina o la vicina Appia, probabil-mente non lontano dal luogo di riutilizzo. La testa fu realizzata in età adrianea, approssima-tivamente tra il 120 e il 130 d.C., ad opera di un artigiano di discrete capacità, attento agli im-pulsi stilistici e iconografi ci maturati nell’am-bito della produzione scultorea di carattere uf-fi ciale e in grado di riproporre gli insegnamenti plastico-naturalistici della tradizione classica, di cui è imbevuto, in un linguaggio formale mi-surato ed obiettivo.
Annarena Ambrogi
21. Roma, Villa Albani, ritratto femminile (da Villa Alba-ni, iv, tav. 226).
BCom CXIV.indb 79 04/03/15 12:12
80 Annarena Ambrogi
Kleiner 2000 D.E.E. Kleiner, Family Ties. Mothers and Sons in Elite and Non-Elite Roman Art, in Kleiner–Matheson 2000, pp. 43-60.
Kleiner–Kleiner 1975 D.E.E. Kleiner, F. Kleiner, A heroic funerary relief on the via Appia, in AA, 1975, pp. 250-265.
Kleiner–Matheson D.E.E. Kleiner, S.B. Matheson (eds.), 1996 I Claudia. Women in Ancient Rome, i,
Austin 1996.Kleiner–Matheson D.E.E. Kleiner, S.B. Matheson (eds.), 2000 I Claudia. Women in Roman Art and So-
ciety, ii, Austin 2000.Kockel 1993 V. Kockel, Porträtreliefs stadtrömischer
Grabbauten. Ein Beitrag zur Geschichte und zum Verständnis des spätrepublika-nisch-frühkaiserzeitlichen Privatporträts, Mainz am Rhein 1993.
Laird 2000 M.L. Laird, Reconsidering the So-called “Sede degli Augustali” at Ostia, in Me-mAmAc, 45, 2000, pp. 41-84.
La Rocca– E. La Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Parisi Presicce– Monaco (a cura di), Ritratti. Le tante Lo Monaco 2011 facce del potere, Roma 2011.Linfert 1976 A. Linfert, Kunstzentren hellenistischer
Zeit. Studien an weiblichen Gewandfigu-ren, Wiesbaden 1976.
Lo Monaco 2011 A. Lo monaco, Algide e belle come dee, in La Rocca–Parisi Presicce–Lo Mo-naco 2011, pp. 335-349.
Lugli 1957 G. Lugli, La tecnica edilizia romana, con particolare riguardo a Roma e Lazio, Roma 1957.
Mannsberger 1988 M. Mannsperger, Frisurenkunst und Kunstfrisur. Die Haarmode der römischen Kaiserinnen von Livia bis Sabina, Bonn 1988.
Matheson 1996 B. Matheson, The Divine Claudia: Women as Godesses in Roman Art, in Kleiner–Matheson 1996, pp. 182-193.
Micheli 2011 M.E. Micheli, Comae Formatae, in Micheli–Santucci 2011, pp. 49-78.
Micheli–Santucci 2011 M.E. Micheli, A. Santucci, Comae. Identità femminili nelle acconciature di età romana, Pisa 2011.
Mikokci 1995 T. Mikocki, Sub specie deae. Les impé-ratrices et princesses romaines assimilées à des déesses. Etude iconologique, Roma 1995 (RdA, Suppl., 14).
Pflug 1989 H. Pflug, Römische Porträtstelen in Obe-ritalien. Untersuchungen zur Chronologie, Typologie und Ikonographie, Mainz am Rhein 1989.
Picozzi 1990 M.G. Picozzi, in F. Carinci, H. Keut-ner, L. Musso, M.G. Picozzi, Catalogo della Galleria Colonna in Roma. Le scul-ture, Busto Arsizio 1990, pp. 269-270, n. 147.
Reggiani 2004 A.M. Reggiani (a cura di), Adriano. Le memorie al femminile, Milano 2004.
Reggiani 2007 A.M. Reggiani, Ritratto di Matidia minore, in Adembri–Nicolai 2007, pp. 122-125.
Ruggi D’Aragona– M.G. Ruggi D’Aragona, P. Pensabene, Pensabene 2002 Statua di Matidia/Aura, in De Nuccio–
Ungaro 2002, pp. 325-326, n. 23.Salzmann 1989 D. Salzmann, Sabina in Palmyra, in H.-
U. Cain, H. Gabelmann, D. Salzmann, Festschrift für Nikolaus Himmelmann, Mainz am Rhein 1989, pp. 361-368.
Schröder 1993 S.F. Schröder, Katalog der antiken Skulpturen des museo del Prado in Ma-drid, 1. Die Porträts, Mainz am Rhein 1993.
Schweitzer 1948 B. Schweitzer, Die Bildniskunst der rö-mischen Republik, Leipzig-Weimar 1948.
Sensi 1980-1981 L. Sensi, Ornatus e status sociale delle donne romane, in AnnPerugia, 18, 1980-1981, pp. 53-92.
Fiocchi Nicolai 2002 V. Fiocchi Nicolai, Basilica Marci, co-emiterium Marci, basilica coemiterii Balbinae, in F. Guidobaldi, A. Guiglia Guidobaldi (a cura di), Ecclesia Ur-bis. Atti del Congresso Internazionale di Studi sulle chiese di Roma (iv-x secolo).Roma, 4-10 settembre 2000, Città del Va-ticano 2002, pp. 1175-1201.
Fiocchi Nicolai 2006 V. Fiocchi Nicolai, in LTURS, iv, Roma 2006, pp. 25-28, s.v. Marci basili-ca, ecclesia, coemeterium.
Fiocchi Nicolai 2013 V. Fiocchi Nicolai, Corredi aurei da una tomba della basilica di Papa Marco sulla via Ardeatina, in M. Barbera (a cura di), Costantino 313 d.C., Cat. della mostra (Roma, 11 aprile - 15 settembre 2013), Milano 2013, pp. 60-66.
Fiocchi Nicolai– V. Fiocchi Nicolai, D. Mastrorilli, Mastrorilli–Vella cds. A. Vella, Le campagne di scavo 2007-
2012 nella basilica paleocristiana a deam-bulatorio della via Ardeatina, in Atti del xvi Congresso internazionale di Archeo-logia Cristiana (Roma, 22-29 settembre 2013), in stampa.
Fittschen 1984 K. Fittschen, Über Sarkophage mit Porträts verschiedener Personen, in B. An-dreae (Hrsg.), Symposium über die anti-ken Sarkophage (Pisa, 5.-12. September 1982), Marburg/Lahn 1984 (Marburger Winckelmann-Programm), pp. 129-161.
Fittschen 1993 K. Fittschen, Bildnis einer Frau trajani-scher Zeit aus Milreu, in MM, 34, 1993, pp. 202-209.
Fittschen 1996 K. Fittschen, Courtly Portraits of Women in the Era of the Adoptive Im-perors (98-180) and their Reception in Roman Society, in Kleiner–Matheson 1996, pp. 42-52.
Fittschen 2000 K. Fittschen, Nicht Sabina, in AA, 2000, 4, pp. 507-514.
Fittschen 2012 K. Fittschen, Über die Haartrachten von Kaiserinnen und Bürgerinnen in der mittleren Kaiserzeit, in Études et travaux, xxv, 2012, pp. 103-118.
Fittschen–Zanker 1983 K. Fittschen, P. Zanker, Katalog der römischen Pörtrats in den Capitolinischen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen det Stadt Rom, iii, Mainz am Rhein 1983.
Frapiccini 2011 N. Frapiccini, La retorica dell’ornato, in Micheli–Santucci 2011, pp. 13-40.
Frenz 1977 H.G. Frenz, Untersuchungen zu den frü-hen römischen Grabreliefs, Frankfurt am Main 1977.
Frenz 1985 H.G. Frenz, Römische Grabreliefs in Mittel- und Süditalien, Roma 1985.
Germoni 2007 P. Germoni, Statua ritratto di Vibia sa-bina come Venere Genitrice, in Adembri–Nicolai 2007, pp. 130-131.
Giuliani 1986 L. Giuliani, Bildnis und Botschaft. Her-meneutische Untersuchungen zur Bildnis-kunst der römischen Republik, Frankfurt am Main 1986.
Goette 1990 H.R. Goette, Studien zu römischen To-gadarstellungen, Mainz am Rhein 1990.
Kent–Overbeck– J.P.C. Kent, B. Overbeck, A.U. Stylow, Stylow 1973 Die römische Münze, München 1973.Kersauson 1996 K. de Kersauson, Musée du Louvre. Ca-
talogue des portraits romains. De l’année de la guerre civile (68-69 après J.-C.) à la fin de l’Empire, ii, Paris 1996.
Kleiner 1977 D.E.E. Kleiner, Roman Group Por-traiture. The funerary Reliefs of the Late Republic and Early Empire, New York-London 1977.
Kleiner 1981 D.E.E. Kleiner, Second-century Myth-ological Portraiture: Mars and Venus, in Latomus, 40, 1981, pp. 512-544.
BCom CXIV.indb 80 04/03/15 12:12
Testa-ritratto femminile di età adrianea proveniente dalle fondazioni della basilica paleocristiana a deambulatorio sulla via Ardeatina 81
Villa Albani 1996 P.C. Bol (Hrsg.), Forschungen zur Villa Albani. Katalog der antiken Bildwerke, iv, Berlin 1994.
Wegner 1938 M. Wegner, Datierung römischer Haar-trachten, in AA, 1938, cc. 276-327.
Wegner 1956 M. Wegner, Das römische Herrscherbild, ii.3. Hadrian, plotina, Marciana, Mati-dia, Sabina, Berlin 1956.
Wegner–Unger 1984 M. Wegner, R. Unger, Verzeichnis der Bildnisse von Hadrian und Sabina, in Boreas, 7, 1984, pp. 105-156.
Wrede 1981 H. Wrede, Consecratio in formam deorum: Vergöttlichte Privatpersonen in der römischen kaiserzeit, Mainz am Rhein 1981.
Zanker 1975 P. Zanker, Grabreliefs römischer Freige-lassener, in JdI, 90, 1975, pp. 267-315.
Zanker 1982 P. Zanker, Herrscherbild und Zeitge-sicht, in WissZBerl, xxxi, 1982, pp. 307-312.
Söldner 2010 M. Söldner, Die Bildhauerkunst wäh-rend der Regierungszeit des Hadrian (117-138 n. Chr.), in P.C. Bol (Hrsg.), Die Geschichte der antiken Bildhauer-kunst, iv. Plastik der römischen Kaiserzeit bis zum Tode kaiser Hadrians, Mainz am Rhein 2010, pp. 215-275.
Strack 1933 P.L. Strack, Untersuchungen zur römi-schen Reichsprägung des zweiten Jahrhun-derts, ii. Die Reichsprägung zur Zeit des Hadrian, Stuttgart 1933.
Sydow 1969 W. v. Sydow, Zur Kunstgeschichte des spätantiken Porträts im 4. Jahrhundert n. Chr., Bonn 1969.
Vermeule 1989 C. Vermeule, Matidia the Elder, a pivot-al woman of the height of Roman Imperial Power. An Imperial Portrait in the Style of Asia Minor from yhe Area around Rome, in N. Basgelen, M. Lugal (edd.), Festschrift für Jale Inan, Istanbul 1989, pp. 71-74.
Abstract
During the excavation campaign of 2009 on the via Ardeatina a female head was found, reused as building material in the foundation of the early Christian basilica ‘a deambulatorio’. It represents a young woman with a personalized appearance and a complex hairstyle, formed by a ‘crown’ and a turban of multiple hair-braids, which is reminiscent of the official models of the Trajanic and early-Hadrianic periods.
The results of the typological, iconographic and stylistic analysis provide a coherent framework that allows us to recognize in the head a portrait originally pertaining to a whole-length funerary relief, probably relating to a married couple. The relief was originally part of a funerary monument (perhaps inserted into its facade), erected along the via Ardeatina or the neighbouring via Appia.
BCom CXIV.indb 81 04/03/15 12:12
L’altura di Veio-Piazza d’Armi è oggetto di in-dagini archeologiche da quasi un secolo: iniziate con gli scavi Gabrici (1913) e con quelli di Ste-fani (1917 e 1919), proseguite con le prime ricer-che dell’Università di Roma «La Sapienza» (Be-gni, Colonna, Schichilone, Torelli, 1968/1970) e con quelle della Soprintendenza Archeologica dell’Etruria Meridionale in collaborazione con il CNR (1988), dal 1996 procedono senza soluzio-ne di continuità nell’ambito del «Progetto Veio» condotte da Gilda Bartoloni e dalla sua équipe del Dipartimento di Etruscologia e Archeologia Italica dell’Università di Roma «La Sapienza»1 (fig. 1).
Queste ultime indagini hanno evidenziato sul piccolo pianoro fasi di continuità insediativa dal ix al v sec. a.C.2, ma anche la presenza di una fase di frequentazione medievale, associata a piani di vita e fosse di scarico e di spoliazione degli edifici più antichi3.
Alla luce di questi rinvenimenti, in questa sede ci si propone di rileggere in via preliminare tut-ti i risultati delle indagini che hanno interessa-to questo sito4, per individuare nella documen-tazione altre tracce di un’occupazione medievale e, parallelamente, effettuare un’analisi storico-
topografica per determinare il processo attraver-so il quale un eventuale insediamento tardo sul pianoro di Veio-Piazza d’Armi si possa inserire nel quadro delle dinamiche dell’incastellamen-to dell’agro veientano nei secoli centrali del Me-dioevo5.
Com’è noto Enrico Stefani condusse una pri-ma campagna di scavi a Piazza d’Armi nel 19176: nei pressi della porta di accesso alla cittadella mise in evidenza un utilizzo più recente, rispetto a quello arcaico, delle mura difensive connesso a un notevole rinvenimento di resti scheletrici che definì “un’area cimiteriale completamente deva-stata”7; durante la stessa campagna rinvenne, nei pressi della grande cisterna centrale dell’insedia-mento, “i resti di un edificio a pianta rettangolare (m 13,62 × 10,00) realizzato in blocchi squadrati di tufo, parte dei quali, affiorando alla superficie, erano assai danneggiati dall’aratro”8.
Stefani dichiarò anche che questo edificio (fig. 2) fosse “quasi perfettamente orientato”, ossia impostato sui punti cardinali, e le recenti ricer-che effettuate nell’Area i sembrano dimostrare che non ci sia rapporto tra questo edificio e l’im-pianto urbanistico antico9: l’edificio infatti risul-
L’insediamento altomedievale di Veio – Piazza d’Armi Un’ipotesi di identificazione
1 M. Milletti, F. Pitzalis, in van Kampen 2012, pp. 57-59. Per la pianta generale degli scavi cfr. Bartoloni 2004, fig. 8.
2 Bartoloni 2009, pp. 7-14.3 V. Acconcia, in Bartoloni‒Acconcia 2012, p. 12, periodi viii
e ix.4 Il testo, salvo lievi modifiche, è stato consegnato nel maggio
2012. Ringrazio Iefke van Kampen, Direttore del Museo dell’Agro
Veientano (Formello, RM), anche per il supporto sulla bibliografia per il periodo etrusco.
5 Damiani 2012, pp. 161-164.6 Stefani 1922, pp. 390-397.7 Stefani 1922, p. 397.8 Stefani 1922, pp 391-399; figg. 13E e 19.9 Bartoloni 2011, pp. 118, 129-130, fig. 1.6.
BCom CXIV.indb 83 04/03/15 12:12