La “mentalità giuridica” di Pio X nelle carte del suo Archivio particolare
Su un particolare tipo di colonna decorata di età paleocristiana
-
Upload
independentresearcher -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Su un particolare tipo di colonna decorata di età paleocristiana
Nel fondamentale volume del 1992 sulla scultura di VI secolo del complesso di S. Clemente a Roma, Federico Guidobaldi1 si era occupato di una particolare tipologia di colonna decorata, quella dei raffinati fusti avvolti da delicati tralci di edera reimpiegati nella tomba quattrocentesca del Cardinal Venerio († 1479)2. Tali colonnine, coronate da capitelli bizo-nali di manifattura bizantina, erano state fino ad allora variamente ritenu-te coeve al monumento funerario oppure – in relazione ai capitelli – rea-lizzate da artefici di epoca bizantina o altomedievale3, mentre si deve pro-prio a Federico Guidobaldi se esse sono state ricondotte nel giusto conte-sto cronologico di riferimento, l’ultimo quarto del I secolo d.C. e più pre-cisamente l’età domizianea4.
Esse appartengono ad un genere di colonna che ebbe grande diffu-sione nell’antichità, come sembrano attestare numerosi esemplari integri o frammentari5, o anche riprodotti in pittura6, seppure in molteplici varian-ti che comprendono differenti specie vegetali, la presenza o meno di putti o animali e la diversa articolazione e decorazione degli elementi struttura-li canonici, quali basi, collarini ed eventualmente capitelli. Il reimpiego di questo tipo di manufatti antichi in un monumento quattrocentesco, come
ROBERTA FLAMINIO
SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA DI ETÀ PALEOCRISTIANA
1 A lui va tutta la mia affettuosa gratitudine per avermi sempre spronata e ben indi-rizzata nelle mie ricerche, ricordando gli anni trascorsi come allieva del Pontificio Isti-tuto di Archeologia Cristiana sotto la sua guida, che sono stati per me una indispensabi-le formazione.
2 F. GUIDOBALDI, I capitelli e le colonnine riutilizzati nel monumento funebre del Car-dinal Venerio, in F. GUIDOBALDI, C. BARSANTI, A. GUIGLIA GUIDOBALDI, San Clemente. La scultura del VI secolo (San Clemente Miscellany IV,2), Roma 1992, pp. 13-66.
3 GUIDOBALDI (op. cit. nota 2), p. 28.4 GUIDOBALDI (op. cit. nota 2), pp. 13-17.5 GUIDOBALDI (op. cit. nota 2), pp. 21-28.6 GUIDOBALDI (op. cit. nota 2), p. 25 e nota 27.
574 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 575
quello del Cardinal Venerio, testimonia la fortuna che le colonne avvolte da tralci7 ebbero anche in epoca successiva, a giudicare sia dagli esempla-ri antichi, riutilizzati per le loro peculiarità tipologiche al fine di conferi-re particolare enfasi a contesti monumentali8, sia dalle repliche successi-ve, in realtà ben più sporadiche9, che ricorrono, talora, in edifici religiosi, spesso associate ad un simbolismo cristologico.
Ad una più elaborata tipologia di colonna decorata appartengono inol-tre le ben note colonne vitinee di S. Pietro in Vaticano, superstiti di una
7 Per le varie tipologie di colonne avvolte da tralci, anche definite columnae coelatae, e le principali varianti, si rimanda al recente contributo di B. NOBILONI, Le colonne viti-nee della Basilica di San Pietro a Roma, in XeniaAnt 6 (1997), pp. 811-142, che, pur es-sendo dedicato in particolare alle colonne vitinee tortili di S. Pietro, offre un vasto reper-torio di confronti e costituisce quindi una sintesi dettagliata e completa delle varie tipolo-gie di colonne decorate dell’antichità.
8 Si ricordano qui, tra gli altri, il pilastro con semicolonne addossate rivestite da tralci, datato ad età severiana, che è stato trovato reimpiegato nella residenza imperiale del Bu-coleon a Costantinopoli (C. BARSANTI, Note archeologiche su Bisanzio Romana, in F. DE’ MAFFEI, C. BARSANTI, A. GUIGLIA GUIDOBALDI (ed.), Costantinopoli e l’arte delle provin-ce orientali (Milion. Studi e ricerche d’arte bizantina 2), Roma 1990, pp. 11-50, in par-tic. pp. 40-43, tavv. XVIII-XIX, figg. 39-41, con ulteriori confronti ed ipotesi sulla pro-venienza; C. MANGO, Ancient Spolia in the Great Palace of Constantinople, in C. MOSS, K. KIEFER (ed.), Byzantine East, Latin West. Art-Historical Studies in Honour of K. Weitz-mann, Princeton 1995, pp. 645-649, in partic. p. 648, fig. 15; NOBILONI (art. cit. nota 7), pp. 107-108 e nota 111; C. BARSANTI, Le chiese del Grande Palazzo di Costantinopoli, in A. C. QUINTAVALLE (ed.), Medioevo: la Chiesa e il Palazzo, Atti del Convegno interna-zionale di studi, Parma 20-24 settembre 2005 (I convegni di Parma 8), Parma 2007, pp. 87-100, in partic. p. 88 e nota 40), oppure, sempre nella capitale bizantina, il caso, men-zionato dalle fonti, delle sei colonne con il fusto decorato da tralci vitinei che l’impera-tore bizantino Basilio I (867-886) avrebbe posto a decoro del Kainourgion, una delle co-struzioni da costui erette nel complesso del Grande Palazzo (BARSANTI, Note archeologi-che, p. 43, nota 120; NOBILONI, ibid., p. 82 e nota 11).
9 GUIDOBALDI (op. cit. nota 2), p. 25 e nota 36; tra queste i due rocchi di colonna (V-VI secolo) con tralcio di vite abitato, che include anche una scena di Battesimo, del Mu-seo Archeologico di Istanbul (G. MENDEL, Musées Impériaux Ottomans. Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines, II, Constantinople 1914, nn. 658 (901) e 659 (902), pp. 435-442; N. FIRATLI, La sculpture byzantine figurée au Musée Archéologique d’Istanbul, catalogue revu et présenté par C. Metzger, A. Pralong et J.-P. Sodini, Paris 1990, nn. 190-191, pp. 102-103, tav. 61); o ancora l’insieme di colonne con tralci viti-nei – 7 esemplari tra integri e frammentari – che rimane della nutrita serie di colonnine, di datazione dibattuta (IV-V secolo), in cui si articolava il presbiterio della distrutta chie-sa della Daurade a Tolosa, oggi disperse in musei e collezioni private (M. DURLIAT, M. DEROO, M. SCELLÈS, Recueil général des Monuments sculptés en France pendant le Haut Moyen Âge (IVe- Xe siècles). IV, Haute-Garonne, Paris 1987, n. 7, pp. 28-29, tav. III.7a-IV.7b, n. 127, p. 95, tav. LXII.127a-b; J. CAILLE, Sainte-Marie «La Daurade» à Toulou-se. Du sanctuaire paléochrétien au grand prieuré clunisien médiéval, Paris 2006, pp. 66-69, 72-80, e soprattutto pp. 299-315).
574 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 575
serie più ampia di esemplari10, le quali, assegnate al II e agli inizi del III secolo11, fin dal loro primo riutilizzo nella basilica Vaticana sono state ri-conosciute – come si deduce dalla evidenza loro conferita nella tradizione testuale che le riguarda12, anteriore alle leggende legate al simbolismo re-ligioso ad esse in seguito associato13 – quali opere pregiate atte a dare lu-stro al santuario dell’Apostolo; e questo intento si scorge anche attraverso i reimpieghi successivi, segnatamente quelli dell’intervento berniniano14.
In parte comparabili con i sostegni pertinenti alla pergula vaticana so-no le sei splendide colonne oggi in opera nel presbiterio di S. Prassede, che appartengono alla tipologia, alquanto più sporadica, delle “colonne di acanto”, cosiddette per la caratteristica scansione del fusto in più settori verticali mediante corone vegetali, solitamente composte appunto da foglie di acanto e derivate dalla famosa colonna acantinea di Delfi, di dimensioni
10 J. B. WARD PERKINS, The shrine of St. Peter and its twelve spiral columns, in JRS 42 (1952), pp. 21-33; A. ARBEITER, Alt-St.-Peter in Geschichte und Wissenschaft, Berlin 1988, pp. 166-181; NOBILONI (art. cit. nota 7), con bibliografia precedente.
11 WARD PERKINS (art. cit. nota 10), pp. 30-31; NOBILONI (art. cit. nota 7), p. 114. La lunga storia critica riguardante le colonne vitinee di S. Pietro, iniziata sullo scorcio dell’800, è sintetizzata nella nota 2 di NOBILONI, ibid.. A tal riguardo si ricorda che anche F. MAZ-ZANTI, La scultura ornamentale romana nei bassi tempi, in Archivio storico dell’arte s. II, 2 (1896), pp. 33-57; 161-187, in partic. p. 15, si soffermò sulle colonne di S. Pietro, at-tribuendo loro, però, la datazione allora in parte condivisa, al IV secolo.
12 Una prima serie di colonne sarebbe stata posta in opera ad ornamento della tom-ba dell’Apostolo già all’epoca di Costantino, come riferisce il Liber Pontificalis nella vi-ta di papa Silvestro (L.P., I, p. 176, fonte della prima metà del VI secolo), ove si speci-fica che le columnas vitineas sarebbero state donate dallo stesso Costantino, che de Gre-cias perduxit. Una seconda serie di sei colonne fu in seguito donata dall’esarca ravenna-te Eutichio all’epoca di papa Gregorio III (731-741): L.P., I, p. 417. È ormai quasi una-nimamente condivisa la provenienza orientale o più specificatamente greca o microasiati-ca delle colonne petrine (WARD PERKINS (art. cit. nota 10), p. 27; NOBILONI (art. cit. nota 7), p. 103, nota 95 con bibliografia), peraltro suggerita anche dalle indicazioni delle fonti summenzionate, l’una più esplicitamente, l’altra indirettamente, se si rilevano gli evidenti legami dell’esarcato con la capitale bizantina.
13 WARD PERKINS (art. cit. nota 10), p. 24, con bibliografia.14 Certamente il riutilizzo che interessò undici colonne vitinee nell’ambito della mede-
sima basilica vaticana (WARD PERKINS (art. cit. nota 10), p. 24; NOBILONI (art. cit. nota 7), pp. 82-91) è stato dettato da ragioni legate al contenuto ideologico e al ruolo che intanto tali colonne avevano assunto nella storia del santuario, come sottolinea la Nobiloni (ibid., p. 89), ma la ripresa quasi pedissequa di un tale modello nel baldacchino del Bernini non può certo prescindere dallo straordinario valore formale delle colonne petrine. Va aggiun-to che tale reimpiego naturalmente comportò modifiche e rimaneggiamenti, fenomeno che si è potuto evincere anche a proposito delle colonnine di S. Clemente: riguardo a queste, infatti, merito del Guidobaldi è stato inoltre aver posto in evidenza gli interventi di rilavo-razione ascrivibili al VI secolo, presumibilmente dovuti innanzitutto alle necessità di ria-dattare e regolarizzare i due fusti (GUIDOBALDI (op. cit. nota 2), pp. 28-31).
576 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 577
ben più imponenti e fungente probabilmente da sostegno isolato15. Proprio tali elementi di scansione costituiscono infatti una componente comune al-le colonne vitinee, dalle quali però le “colonne di acanto” si distinguono innanzitutto perché non presentano il fusto tortile, ed inoltre per l’uso più parco di elementi esornativi e per la differente combinazione tra ornati ve-getali e stilemi direttamente discendenti dal lessico architettonico degli or-dini classici. Il livello qualitativo decisamente elevato identifica indubbia-mente le colonne di S. Prassede, e gli splendidi capitelli ad esse sovrappo-sti, come manufatti antichi. Riutilizzate con la plausibile intenzione di re-plicare la pergula di S. Pietro, le sei colonne oggi in opera nel presbiterio di S. Prassede sono state apprezzate, al pari di quelle vaticane, per la loro raffinata fattura e riutilizzate, questa volta in un contesto riferibile alla Ro-ma carolingia di Pasquale I (817-824), quali componenti della recinzione liturgica di IX secolo, come ha ben dimostrato l’Emerick riprendendo una felice intuizione di Krautheimer16. Esse rimasero poi in situ nei successivi rifacimenti del presbiterio17, inglobate nei muri dei coretti realizzati nelle
15 GUIDOBALDI (op. cit. nota 2), p. 26; NOBILONI (art. cit. nota 7), pp. 111-112. Sulla colonna di Delfi si veda Th. HOMOLLE, Monuments figurés de Delphes. La colonne d’acan-the, in BCH 32 (1908), pp. 205-235; G. W. ELDERKIN, The Akanthos Column at Delphi, in Hesperia 10 (1941), pp. 373-380.
16 R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum Christianarum Romae, III, Città del Vaticano 1971, pp. 235-262, in partic. pp. 253, 260, fig. 218 e nota 5 a p. 260 con citazione di os-servazioni a lui precedenti; J. J. EMERICK, The Tempietto del Clitunno near Spoleto, Univ. Park P. A. 1988, in partic. pp. 415-416; ID., Focusing on the Celebrant: the Column Di-splay inside Santa Prassede, in Arredi di culto e disposizioni liturgiche a Roma da Co-stantino a Sisto IV, Atti del Colloquio internazionale, Istituto Olandese a Roma, 3-4 di-cembre 1999, in MededRom 59 (2000), pp. 129-159 (ove si propone, a p. 139, una ge-nerica datazione tra il I e il III secolo d.C.); da ultima C. GOODSON, Revival and Reality: the Carolingian Renaissance in Rome and the basilica of S. Prassede, in ActaAArtHist n. s. 6, 20 (2006), pp. 163-190, in partic. pp. 174-175. Più di recente è tornata brevemente sull’argomento A. BALLARDINI, Scultura per l’arredo liturgico nella Roma di Pasquale I: tra modelli paleocristiani e Flechtwerk, in A. C. QUINTAVALLE (ed.), Medioevo: arte e sto-ria, Atti del Convegno internazionale di studi, Parma 18-22 settembre 2007 (I convegni di Parma 10), Parma 2008, pp. 225-246, in partic. pp. 228-229. Gli studiosi si sono fino-ra soffermati principalmente sul reimpiego di tali colonne, di cui manca a tutt’oggi uno studio specifico che ne definisca un puntuale inquadramento cronologico.
17 Anche delle colonne di S. Prassede si può dunque constatare una continuità d’uso che riflette un unanime riconoscimento della loro valenza estetica e della loro peculiari-tà tipologica, come già rilevato a proposito degli altri casi summenzionati di reimpiego, benché ciascuno riguardante modalità dettate da circostanze differenti e contesti cronolo-gicamente distanti, che, purtuttavia, almeno nel caso di S. Pietro e di S. Prassede origina-no sicuramente in un arco di tempo che interessa il periodo paleocristiano ed altomedie-vale. L’apprezzamento per questo tipo di colonne, di certo in molti casi dovuto all’asso-ciazione con quelle della recinzione della Basilica Vaticana, si può dire sia perdurato at-
576 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 577
due ali del transetto all’epoca del Cardinal Pallavicini (1489-1503) – allora probabilmente celate alla vista – e riscoperte, con comprensibile sorpresa e ammirazione18, nel 1729, durante i restauri degli anni 1728-1734 promossi dal Cardinale Ludovico Pico della Mirandola (1728-31).
Una trentina d’anni dopo la loro riscoperta le colonne di S. Prassede colpirono anche l’immaginario di Giovan Battista Piranesi, il quale, come ha ben rilevato il Guidobaldi19, sembra avesse un particolare interesse per le colonne di insolita fattura, riprodotte in gran numero nella sua opera Della Magnificenza ed architettura de’Romani. Qui, tra le altre, è raffigurata sia una delle colonne in opera in S. Prassede, posta accanto ad uno degli esemplari vitinei di S. Pietro20, sia una colonna apparentemente pertinente al medesimo tipo di quelle della basilica carolingia, individuata dal Pirane-si sempre a Roma, In frontae januae domus Mastrotiae in area S. Hyero-nimi de Charitate, come si specifica nella didascalia alla tavola21 (fig. 1).
Fino ad oggi ritenuta dispersa, questa colonna è invece tuttora esi-stente, in opera, insieme ad un’analoga compagna, proprio dove si trova-va all’epoca del Piranesi22: entrambe infatti inquadrano il portale di Palaz-
traverso tutto il medioevo, come attestano le note copie delle colonne vitinee petrine con-servate nella chiesa romana della SS. Trinità dei Monti e nella chiesa di S. Carlo a Ca-ve di Palestrina (queste ultime provenienti dalla chiesa di S. Lorenzo nella stessa cittadi-na), ascritte al contesto artistico romano della seconda metà dell’XI secolo (WARD PERKINS, (art. cit. nota 10), pp. 31-33; sull’argomento si veda da ultimo P. C. CLAUSSEN, Scultura e splendori del marmo a Roma nell’età della riforma ecclesiastica nell’XI e XII secolo, in A. CALZONA (ed.), Matilde e il tesoro dei Canossa, tra castelli, monasteri e città, Catalo-go della mostra, Reggio Emilia - Canossa, 31 agosto 2008 - 11 gennaio 2009, pp. 202-215, in partic. pp. 213-215, e le schede di S. RICCIONI, ibid., nn. 25-26, pp. 429-431, con bibliografia e storia critica).
18 C.-G. CODA, Duemilatrecento corpi di martiri. La relazione di Benigno Aloisi (1729) e il ritrovamento delle reliquie nella Basilica di Santa Prassede in Roma (Miscellanea del-la Società Romana di Storia Patria 46), Roma 2004, pp. 69-70, e soprattutto p. 71; le co-lonne furono rimesse in opera nel novembre 1731 (ibid., p. 77).
19 GUIDOBALDI (op. cit. nota 2), p. 26, nota 31.20 G. B. PIRANESI, Della Magnificenza ed architettura de’Romani, Roma 1761 (rist. Pa-
rigi 1836), risp. tav. VI, fig. IV, con didascalia Columna in aede Divae Praxedis (GUI-DOBALDI, op. cit. nota 2, p. 25), e tav. VI, fig. V: Columna in cella SS. Crucifixi in Ba-silica Vaticana (cfr. NOBILONI, art. cit. nota 7, p. 85 e nota 33). Si noti come in entram-bi i casi il Piranesi non specifichi che si tratta di singoli esemplari estrapolati da una se-rie più numerosa, come certo doveva essere evidente anche allora sia nella Basilica Va-ticana che a S. Prassede.
21 PIRANESI (op. cit. nota 20), tav. XI; GUIDOBALDI (op. cit. nota 2), pp. 25-26, fig. 28b; NOBILONI (art. cit. nota 7), nota 152.
22 Anche qui, come nei due casi precedentemente citati, il Piranesi non specifica se si trattava di una o più colonne.
578 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 579
Fig. 1 – Colonna In frontae januae domus Mastrotiae… (da G. B. PIRANESI, Della Ma-gnificenza ed architettura de’ Romani, Roma
1761).
578 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 579
zo Mastrozzi Graziosi (come indicato nella didascalia all’incisione), situa-to nella piazza di S. Caterina della Rota, che si apre proprio accanto al-la chiesa di S. Girolamo della Carità23 (fig. 2). Le due colonne, di marmo proconnesio, scanalate e scandite in tre segmenti da altrettanti calici foliati, uno dei quali emergente dalla base, si conservano ancora integre e in buo-ne condizioni, se si eccettua un lieve dilavamento dovuto alla lunga espo-sizione all’esterno24. Esse si aggiungono alla esigua serie degli esemplari noti di “colonne di acanto”, testimoniate a Roma da un fusto frammenta-rio reimpiegato nel chiostro dell’Abbazia delle tre Fontane, anch’esso do-cumentato dal Piranesi e reso noto dal Guidobaldi25, e, al di fuori di Ro-ma, da alcune colonne tutte di ambito greco: la monumentale, già citata, colonna di Delfi, due esemplari frammentari a Corinto26, oltre ai quali si ricordano anche due frammenti visti nel complesso del Megalo Monastiri ad Atene e un altro frammento sull’Acropoli, individuati tra il Museo e il muro sud, questi ultimi però testimoniati unicamente da disegni27.
23 Fondato alla fine del ’600, il Palazzo, al n. civico 91, la cui facciata inquadra a de-stra la chiesetta che fa da sfondo all’omonima piazza, si estende anche su via di Monser-rato; esso occupa una parte dell’area dove almeno fin dal tardo medioevo sorgeva la co-siddetta Corte Savella, il carcere che l’omonima famiglia baronale romana gestiva per con-to della Chiesa, trasferito nel 1657 nella nuova sede di Via Giulia (F. LOMBARDI, Roma. Palazzi, palazzetti, case. Progetto per un inventario 1200-1870, Roma 1991, p. 334, cfr. anche p. 229; C. RENDINA, I palazzi di Roma, 2. Il Seicento. Il Settecento, Roma 1993, p. 330). Che il Piranesi abbia menzionato come luogo di riferimento, invece che la più vici-na S. Caterina della Rota, la chiesa di S. Girolamo della Carità si spiega forse con il fat-to che quest’ultima era stata rinnovata nel terzo quarto del Seicento, assumendo così un ruolo di maggiore visibilità per l’epoca. Negli stessi anni inoltre la piazza costituisce il soggetto di un’incisione del Vasi (G. VASI, Delle magnificenze di Roma antica e moder-na. Libro sesto, Roma 1756, tav. CXI: Palazzo Mastrozzi è indicato con il n. 3), ove pu-re si scorgono, sullo sfondo, le due colonne, che dunque, ancor più stranamente, sono fi-nora passate inosservate.
24 La colonna di sinistra appare inoltre integrata al sommoscapo, apparentemente ri-lavorato anche in quella di destra; quest’ultima presenta invece alcune fratture che attra-versano il fusto e misura 2,97 m. Esse sono state restaurate nel 2004, informazione che devo all’attuale proprietario, ing. Riccardo Marcelli Graziosi, che ringrazio per la corte-se disponibilità accordatami. L’individuazione del marmo dipende per il momento solo da un’osservazione autoptica, ma le caratteristiche riscontrate (grana e venature) indirizzano verso questa identificazione.
25 G. B. PIRANESI, Trofei di Ottaviano Augusto innalzati per la vittoria ad Actium e conquista dell’Egitto, con vari altri ornamenti antichi disegnati ed incisi, Roma 1953, tav. X; GUIDOBALDI (op. cit. nota 2), p. 26, figg. 28c., 382.
26 R. L. STILLWELL, Excavations at Corinth, 1934-35, in AJA 40 (1936), pp. 21-45, in partic. pp. 24-25, fig. 3, fig. 207.
27 HOMOLLE (art. cit. nota 15), pp. 233-234, figg. 18-19: i primi furono visti e disegnati dal Donaldson nel 1826, la segnalazione dell’altro si deve a R. Phene Spiers, noto archi-
580 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 581
Fig. 2 – Roma, Palazzo Mastrozzi Graziosi, portale (foto Autore).
580 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 581
Nonostante l’innegabile analogia strutturale, ravvisabile già nell’inci-sione settecentesca, tuttavia ad un’osservazione diretta, le due colonne di Palazzo Mastrozzi si differenziano alquanto, per le loro caratteristiche for-mali, rispetto alla serie di S. Prassede e all’insieme, in realtà piuttosto ete-rogeneo, degli altri esemplari di colonne con calici foliati28. Mi riferisco in particolare sia alle evidenti irregolarità nella resa delle scanalature e dei dettagli del decoro vegetale, sia alla peculiare morfologia dei calici folia-ti29 (fig. 3). Questi inoltre non presentano la canonica corona di acanto, ma invece un filare di foglie di palma espanse ed unite alla base, dal profi-lo lievemente ondulato e percorse da venature dalla insolita conformazio-ne della costolatura mediana, scarsamente rilevata e fiancheggiata da mor-bidi e profondi solchi che si incurvano aprendosi verso il bordo30; tra di
tetto londinese (1828-1916). L’argomento fu ripreso da J. BOSQUET, Delphes et les Aglau-rides d’Athènes, in BCH 88 (1964), pp. 655-675, in partic. p. 667, il quale sottolinea l’ori-gine attica della “colonna d’acanto” e rileva come dei frammenti in questione solo quel-lo sull’Acropoli fosse ancora visibile all’inizio degli anni ’60 del Novecento. Il Megalo Monastiri si potrebbe identificare con la Megale Panagia, chiesa eretta, tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, sulle rovine della basilica di VII secolo costruita nel perisitilio della Biblioteca di Adriano (N. H. J. WESTLAKE, On Some Ancient Paintings in Churches of Athens, in Archeologia, s. 2, 51 (1888), 1, 173-188, in partic. pp. 173, 181-183; CH. H. WELLER, Athens and its Monuments, New York 1924, p. 148 e fig. 83; J. TRAVLOS, Athè-nes au fil du temps. Atlas historique d’urbanisme et d’architecture, Boulogne 1972, XIII e XVIIIb): la sua distruzione in un vasto incendio che devastò l’area dell’agorà nel 1884 spiega forse perché di tali frammenti già all’inizio del XX secolo si era persa traccia.
28 I confronti citati sembrano infatti tutti di epoca classica, ma ben poco si può dire per i frammenti ateniesi, data la scarna documentazione.
29 In realtà si notano evidenti difformità di esecuzione anche tra calici della medesi-ma colonna, poiché le costolature delle foglie assumono in alcuni casi un rilievo più ri-gido e squadrato.
30 Foglie analoghe, ma di diversa fattura, compongono anche le corone alla base della summenzionata colonna di Delfi e l’unico cespo superstite del frammento visto nel XIX secolo sull’Acropoli di Atene (HOMOLLE, art. cit. nota 15, p. 234, fig. 19). Se si considera la complessa tradizione letteraria riguardante la “colonna d’acanto”, discussa dall’Elderkin (art. cit. nota 15), non si può escludere tuttavia che tale alternativa all’acanto sia invece da identificare con la foglia di Silphium, un genere di pianta erbacea originaria della Ci-renaica appartenente alla famiglia delle Asteraceae, molto nota e ricercata nel mondo an-tico per le numerose proprietà officinali nonché gastronomiche, della quale esisteva un esemplare presso il santuario di Apollo a Delfi, lì inviato dal popolo libico: infatti le fo-glie del Silphium, frequentemente raffigurato nella numismatica e nella pittura vascolare ed oggi presumibilmente identificabile con una delle varietà della Ferula communis, pre-sentano forma lanceolata dal profilo continuo e ondulato o frastagliato ed hanno la par-ticolarità di avvolgere il fusto della pianta ad intervalli regolari, unite a coppie lungo la larga base. Sull’argomento si veda comunque NOBILONI (art. cit. nota 7), pp. 97, 111, e soprattutto note 73, 134.
582 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 583
Fig. 3 – Roma, Palazzo Ma-strozzi Graziosi, particolare della colonna a destra del por-
tale (foto Autore).
esse, negli intervalli, emergono foglie d’acqua dalla superficie lievemente increspata e con costolatura mediana lievemente accennata. La morbidezza del rilievo, quasi sfumato nella resa delle foglie in secondo piano e delle fasce dalle quali originano le corone di foglie, dal profilo appena bomba-to, quasi non rifinite (ma forse frutto di un’esecuzione un po’ frettolosa, riscontrabile anche nei particolari dell’ornato vegetale), potrebbero suggeri-re una cronologia di età tardo antica, forse non anteriore al IV secolo, co-me dimostrano le affinità delle corone di foglie sovrapposte con quelle di alcuni capitelli ostiensi31; la morfologia delle foglie trova infine un plausi-
31 In particolare P. PENSABENE, Scavi di Ostia, VII. I capitelli, Roma 1973, n. 768, p. 180, tav. LXXI, n. 690, p. 167, tav. LXV, entrambi dalla Collezione del Piccolo Merca-
582 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 583
bile confronto con quelle dei singolari capitelli in porfido rosso del rivesti-mento marmoreo dell’emiciclo absidale di S. Agnese f.l.m. a Roma32.
Tale ipotesi, che suggerirebbe quindi il protrarsi in epoca più tarda della realizzazione di colonne di particolare struttura, che ricompongono in modo insolito e fantasioso stilemi e ornati di gusto classico, ci porta ver-so l’oggetto principale di questo contributo, una tipologia di colonna, tor-tile nella parte superiore e baccellata in quella inferiore (figg. 4-9), di cui solo di recente sono stati circoscritti l’ambito cronologico di riferimento e l’area di provenienza: il bacino orientale del Mediterraneo del VI secolo.
Tale argomento fu oggetto, ormai una trentina di anni fa, di un arti-colo del Rusconi riguardante quattro colonne di questo tipo reimpiegate nel paramento esterno della cattedrale romanica di Acerenza33, per le qua-li lo studioso proponeva una datazione tra la fine dell’VIII e il IX secolo, estesa anche alla nutrita serie di esemplari analoghi esaminati, in ciò con-dizionato tuttavia dalla presenza di quattro colonne del medesimo tipo in opera nel noto ciborio di S. Eleucadio nella basilica ravennate di S. Apol-linare in Classe, assegnato, grazie ad un’iscrizione, all’81034. Egli rilevò inoltre una notevole omogeneità tra le numerose colonne citate, sia nella fattura, sia nelle dimensioni, solitamente piuttosto contenute (di rado su-periori ai 3 m), per le quali ipotizzava una comune funzione come com-ponenti di portichetti o di arredi liturgici – dunque cibori o pergulae – in edifici di culto altomedievali.
Tuttavia, più di recente, alla luce di altri esempi individuati in area bizantina, è apparsa difficilmente sostenibile una datazione troppo avanza-ta verso i secoli dell’alto medioevo35, se si considera la relazione, in alcu-
to, di provenienza ignota, datati tra III e IV secolo; per la tipologia della foglia si cfr. ibid. n. 645, p. 157, tav. LXI.
32 H. BRANDENBURG, Le prime chiese di Roma, IV-VII secolo. L’inizio dell’architettu-ra ecclesiastica occidentale, Milano 2004, pp. 246-247, figg. 154a-154b, qui definiti di “età imperiale”; per una più dettagliata analisi del rivestimento parietale si cfr. A. GUIGLIA GUIDOBALDI, P. PENSABENE, Il recupero dell’antico in età carolingia: la decorazione scul-torea absidale delle chiese di Roma, in RendPontAc 78 (2005-2006), pp. 3-74, in partic. pp. 42-46. Colgo qui l’occasione per ringraziare il Prof. Patrizio Pensabene per i suoi sug-gerimenti e per la proficua conversazione sulla plausibile cronologia tardoantica di questa coppia di enigmatiche colonne.
33 A. RUSCONI, Il ciborio longobardo della Cattedrale di Acerenza, in Atti del II Congres-so Nazionale di Archeologia Cristiana, Matera, 25-31 maggio 1969, Roma 1971, pp. 423-436; le colonne sono ricomposte in più frammenti e dunque certamente di reimpiego.
34 Cfr. infra. Già E. MAUCERI, Colonne tortili così dette del tempio di Salomone, in, L’Arte 1 (1898), pp. 377-384, in partic. p. 383, aveva rilevato la peculiare struttura di queste colonne.
35 G. BERTELLI, Sul reimpiego di elementi architettonici bizantini a Bari, in VeteraChr 24 (1987), pp. 375-397, in partic. 395-396; EAD., Le Diocesi della Puglia centro-setten-
584 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 585
Fig. 5 – Rodi, Sultan Mustafa Camii, co-lonna reimpiegata nello şadirvan (da J. L. BENSON, Spirally Fluted Columns in
Greece, in Hesperia 28, 1959).
Fig. 4 – Atene, colonna frammentaria rinvenuta presso l’Odeion di Erode Attico (da J. L. BENSON, Spirally Fluted Columns in Greece, in Hesperia 28, 1959).
584 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 585
Fig. 6 – Betlemme, chie-sa della Natività, partico-lare della Grotta (la co-lonna si intravede sulla
destra).
Fig. 7 – Roma, S. Bibiana, prima colonna del colonnato destro a partire dal presbite-
rio (foto Autore).
586 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 587
Fig. 9 – Tuscania, S. Pietro, cripta (foto Autore).
Fig. 8 – Colonna In vinea PP. Soc. Jesu, … in Aventino (da G. B. PIRA-NESI, Della Magnificenza ed archi-
tettura de’ Romani, Roma 1761).
586 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 587
ni casi riscontrabile, con fasi costruttive o contesti di V-VI secolo, e l’im-piego quasi regolare del marmo bianco venato, presumibilmente proconne-sio, e se, inoltre, si pongono in relazione questi due indizi con un prospet-to dei siti ove sono state rinvenute queste colonne. Appare evidente infatti come la diffusione di tali manufatti abbia riguardato prevalentemente loca-lità del Mediterraneo orientale e, più ad ovest, aree comunque interessate dall’esportazione di marmi di provenienza bizantina, quali l’arco costiero adriatico dall’Istria alla Puglia, alcuni siti dell’Italia meridionale contigui alle rotte marittime e in contatto con l’Oriente, ed infine Roma, ove ho potuto recentemente individuare un gruppo consistente di tali colonne36 e che può essere stata tramite per la distribuzione di alcuni di questi mate-riali in località circostanti. L’omogeneità del tipo di decorazione, delle pro-porzioni e del materiale utilizzato hanno inoltre suggerito l’ipotesi di una vera e propria produzione in serie37; a tal riguardo si rileva inoltre che i vari esemplari si presentano anche dal punto di vista strutturale piuttosto uniformi: le uniche, lievi varianti consistono nelle dimensioni e nel rilie-vo delle spire e delle baccellature, nelle proporzioni tra la parte baccella-ta e quella spiraliforme o infine, come si dirà, nella conformazione della zona di raccordo tra queste due parti, solitamente costituita da una fascia liscia e in molti casi lievemente bombata. Infine, l’ipotesi di una crono-logia più alta sarebbe d’altra parte comprovata anche nel caso del ciborio di S. Eleucadio, già identificato da una parte della critica come un assem-blaggio di pezzi di spoglio più antichi38.
In realtà la provenienza greco-orientale di questo tipo di colonna, che peraltro troverebbe ulteriore conferma dalla precedente tradizione di pro-duzione ed esportazione di “colonne decorate”, constatata per gli esemplari
trionale. Aecae, Bari, Bovino, Canosa, Egnathia, Herdonia, Lucera, Siponto, Trani, Vie-ste (Corpus della scultura altomedievale 15), Spoleto 2002, pp. 307-308; C. BARSANTI, Ra-venna: gli arredi architettonici e liturgici negli edifici di età teodoriciana, in C. BARSAN-TI, A. PARIBENI, S. PEDONE (ed.), Rex Theodoricus. Il Medaglione d’oro di Morro d’Alba, Roma 2008, pp. 185-202, in partic. p. 198.
36 L’occasione per questa piccola indagine sulle colonne tortili e baccellate è scaturita durante la redazione delle schede del Corpus della scultura altomedievale riguardante la III regione ecclesiastica di Roma (Esquilino, cfr. infra), curata da chi scrive e da C. Bar-santi, A. Guiglia Guidobaldi, in corso di pubblicazione.
37 RUSCONI (art. cit. nota 33), pp. 429-430, che ipotizza una manifattura orientale; BAR-SANTI (art. cit. nota 35), p. 198.
38 CH. ROHAULT DE FLEURY, La Messe. Études archéologiques sur ses monuments, III, Paris 1883, pp. 77-81; C. BARSANTI, A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Gli elementi della recinzione liturgica ed altri frammenti minori nell’ambito della produzione scultorea protobizantina, in F. GUIDOBALDI, C. BARSANTI, A. GUIGLIA GUIDOBALDI (op. cit. nota 2), Roma 1992, pp. 67-270, in partic. p. 72 e nota 14.
588 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 589
antichi di columnae coelatae, vitinee e “a corone di acanto”, era stata già suggerita dal Benson in un contributo ormai datato, scarsamente – o per nulla – considerato nella successiva storia critica. Qui lo studioso, esami-nando le colonne spiraliformi della Grecia, ne enuclea una variante, costi-tuita appunto dalle colonne tortili e baccellate in questione, definite “com-posite spirally fluted columns”, sulla base di un esiguo gruppo di esem-plari che sembra non siano stati in seguito più ricordati e che costui, a ra-gione, pionieristicamente si direbbe, riferisce al V-VI secolo39. Si tratta di due segmenti di colonna individuati sull’Acropoli di Atene, il primo for-se in due frammenti, che lo studioso assegnò alla metà del V secolo d. C. e ipotizzò potessero provenire dalle basiliche impiantate in epoca protobi-zantina nell’Asklepieion o nell’Olimpieion40; a questi si aggiunge una co-lonna frammentaria, simile alle prime due e dal Benson associata ad es-se, situata presso l’Odeion di Erode Attico41, edificio pure situato sul pen-dio meridionale dell’Acropoli, non lontano dai due santuari summenzio-nati. Quest’ultimo e il primo degli altri due esemplari presentavano infat-ti la fascia divisoria tra la parte spiraliforme e quella baccellata decorata con un motivo a chevrons inciso (fig. 4). Un’altra colonna, resecata alla sommità e parzialmente lacunosa anche alla base, sosteneva invece, insie-me ad altre sette colonne di spoglio, il baldacchino dello şadirvan (fon-tana per le abluzioni) della Moschea di Sultan Mustafa a Rodi42 (fig. 5). Tutte queste colonne, a giudicare dalla descrizione che il Benson riporta circa il tipo di marmo, sembra fossero di proconnesio. Le peculiarità for-mali della resa plastica, priva di contrasto tra il morbido aggetto delle spi-re superiori e il lieve chiaroscuro delle baccellature inferiori, il cui profi-lo quasi grafico dalle estremità stondate e la cui superficie interna lieve-mente convessa appaiono infatti ben distanti dal profondo solco delle sca-nalature degli ordini classici, indusse lo studioso a proporre una datazio-ne di tali colonne nell’ambito del periodo protobizantino – con una prefe-
39 J. L. BENSON, Spirally Fluted Columns in Greece, in Hesperia 28 (1959), pp. 253-272, in partic. pp. 255-259, tav. 45.
40 BENSON (art. cit. nota 39), pp. 255-256, 263, tav. 45b.-d.; se pertinenti al medesi-mo fusto i due frammenti misurerebbero ca. 1,61 m, dimensione corrispondente a ca. 3/5 della colonna integra (che doveva quindi misurare ca. 2,70 m); l’altra, di cui si conserva-va solo la parte inferiore baccellata e un breve tratto di quella superiore a spirale, misu-rava invece 1,08 m e presentava un foro ricavato nella parte con baccellature. Per le ipo-tesi sulla pertinenza si veda ibid., p. 255, nota 10.
41 BENSON (art. cit. nota 39), pp. 255-256, 264-265, tav. 45a.; la colonna si compone-va di due frammenti combacianti, per una altezza totale di m 2,245.
42 BENSON (art. cit. nota 39), pp. 255, 257-258, 269, tav. 45e.-f.; altezza: 1,455. Al-l’estremità superiore della parte baccellata un foro ampio qualche centimetro conservava tracce di una grappa in ferro.
588 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 589
renza verso il VI secolo – comprovata inoltre dalla loro pertinenza a con-testi che ebbero fasi di vita postclassiche, nonché dalla frequente presenza di fori e tracce di grappe di ancoraggio, correlati all’utilizzo di tali colon-ne in recinti analoghi a quelli delle chiese paleocristiane.
Gran parte degli altri esemplari attualmente superstiti sono costituiti da colonne intere o frammentarie, per lo più erratiche, oppure riutilizza-te quali materiali di spoglio, rinvenute solo raramente in contesti origina-ri. Ciò spiega infatti la difficoltà di inquadramento cronologico di chi fi-nora si è imbattuto in questo tipo di manufatti.
Ancora in area greco-insulare si ricordano una colonna in opera nel portico dell’esonartece del Katholikon medievale di S. Giovanni a Pat-mos43, che potrebbe provenire dai materiali della precedente chiesa paleo-cristiana; due, frammentarie, venute alla luce durante gli scavi della basi-lica B di Nea Anchialos44; un frammento, infine, in marmo pentelico, da-gli scavi di Corinto45.
In ambito micrasiatico alcune colonne del tipo in esame sono state rinvenute in più riprese negli scavi dalla chiesa di S. Giovanni ad Efeso e riassemblate a formare il ciborio dell’altare46; un altro esemplare, fram-
43 A. K. ORLANDOS, H arcitektonikh kai ai buzantinai toicograjiai tej Monhj tou Qeologou Patmou (L’architecture et les fresques Byzantines du Monastère de St. Jean à Patmos), En Athenais 1970, p. 17 e figg. 2, 3 e 8; l’altezza di questa colonna, mancante della estremità inferiore, corrisponde a 2,05 m.; A. D. KOMINIS, Oi qhsauroi thj Monhj Patmou, Athens 1988, p. 28, figg. 11-12. Anche Orlandos osserva come co-lonnine di questo tipo furono per lo più utilizzate come sostegni per cibori (si vedano a tal proposito le ricostruzioni, solo indicative, in ID., H xulostegoV palaiocristianikh basilikh thj mesogeiakej lekanhj, Athenai 1954, II, pp. 473-476, figg. 434, 437).
44 G. A. SOTIRIOU, Ai cristianikai Qhbai thj Qhssaliaj, in AE 1929, pp. 1-158, in partic. p. 119, figg. 165-166 (uno dei due frammenti, più esteso, è collocato a terra nel-l’area dell’altare, nella prima foto; l’altro, consistente della sola estremità inferiore, si vede riverso sullo sfondo del bema nella seconda foto); lo studioso ricostruisce però con colon-nine di questo tipo il ciborio della basilica A, tav. V, con riferimento a p. 123.
45 R. L. SCRANTON, Corinth XVI: Corinth, Results of Excavations conducted by the Ame-rican School of Classical Studies at Athens, vol. XVI, Medieval Architecture in the Cen-tral Area of Corinth, Princeton 1957, n. 43, p. 108, tav. 24: il frammento misura 1 m di altezza. È segnalato anche dal Benson (art cit. a nota 39, p. 265).
46 H. HÖRMANN, Die Johanneskirche (Forschungen in Ephesos 4.3), Wien 1951, pp. 135, 138-139, 140, 144, figg. 29.2 (colonna integra in marmo bianco venato di grigio, h 2,08 m; non si conosce l’area esatta del rinvenimento, probabilmente l’atrio della chiesa, ma lo studioso ritiene possa essere stata destinata a sostenere il ciborio del bema), 31.4, 32.3; A. THIEL, Die Johanneskirche in Ephesos (Spätantike - frühes Christentum - Byzans. Kunst im ersten Jahrtausend - B: Studien und Perspektiven, Bd. 16), Wiesbaden 2005, pp. 63-64, 65, tav. 26 fig. 79, tav. 29 fig. 87 (altre colonne, ora rimesse in piedi nell’area del-l’altare, furono rinvenute durante gli scavi condotti dai Turchi a partire dal 1960).
590 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 591
mentario, si trova a Akhisar in Bitinia47. In quest’ultimo caso non vi è al-cuna fascia divisoria tra la parte baccellata e quella spiraliforme, ma dal piano di fondo rialzato prendono forma baccellature e spire. Infine, sem-pre nell’area del Mediterraneo orientale, un frammento di colonna del tipo in esame fu rinvenuta negli scavi della Chiesa dell’Annunciazione a Na-zaret48, un’altra fu reimpiegata nella Basilica della Natività a Betlemme49 (fig. 6); infine, un’altra colonnina di questo tipo, frammentaria, fu riutiliz-zata nella cripta di XII secolo della chiesa copta di S. Sergio al Cairo50, di origini più antiche.
Altrettanto vario è il panorama che si prospetta in Occidente, dove lun-go l’arco adriatico una colonnina, mancante della sommità, si trova oggi al Museo Archeologico di Pola in Istria, ma proviene forse dalla cattedra-le o dal battistero della città51, e, proseguendo verso sud, è possibile indi-viduare due gruppi più consistenti a Ravenna52 e in Puglia.
A Ravenna, quattro colonne sono riutilizzate nel noto ciborio di S. Eleucadio in S. Apollinare in Classe53, di cui si è detto, e tre si trovano in
47 Y. ÖTÜKEN, Forschungen im nordwestlichen Kleinasien: antike und byzantinische Denkmäler in der Provinz Bursa, Tübingen 1996, pp. 118-119, tav. 17.3; anche per que-sto pezzo, molto esiguo (altezza massima: 32 cm) è stata ipotizzata l’originaria funzione di colonnina di ciborio. In questo caso non vi è alcuna fascia divisoria tra la parte baccellata e quella spiraliforme, ma dal piano di fondo rialzato prendono forma baccellature e spire.
48 B. BAGATTI, Gli scavi di Nazareth. I. Dalle origini al secolo XII, Gerusalemme 1967, pp. 108-109, figg. 63.7, 64.6; a giudicare dalle proporzioni – il frammento è alto 1,95 m – la colonna doveva presentare un’altezza di almeno 2,70/2,80 m.
49 B. BAGATTI, Gli antichi edifici sacri di Betlemme, Gerusalemme 1952, p. 131, figg. 19-20: per l’a. la colonnina, “di chiara impronta bizantina”, collocata senza base a sorreg-gere il baldacchino sopra l’“altare del Presepio”, sembrerebbe un rattoppo posteriore per mascherare l’interruzione del paramento marmoreo; doveva essere comunque già in ope-ra nel 1519, epoca in cui fu raffigurata in un disegno della Grotta, di Jan van Scorel, ora a Utrecht.
50 P. CELLINI, L’opera di Arnolfo all’Aracoeli, in BdA s. IV, 47 (1962), pp. 180-195, in partic. nota 9, fig. 29, ove si data la colonnina al IV secolo.
51 RUSCONI (art. cit. nota 33), p. 425, fig. 6.52 Va esclusa, con tutta probabilità, dalla serie di esempi riportati dal Rusconi una
colonnina spiraliforme frammentaria che suddivide le arcate della bifora meridionale del campanile (1063) dell’Abbazia di Pomposa e che M. SALMI, L’abbazia di Pomposa, Ro-ma 1936, nota 21 a p. 224, fig. 224 (19672: nota 21 a p. 119, fig. 240), assegna alla no-stra tipologia e data al VI secolo, pur non escludendo che essa possa essere più tarda: si cfr. R. FARIOLI CAMPANATI, Il patrimonio artistico tardoantico di Ferrara e del Ferrare-se, in Storia di Ferrara, III, L’età antica (II), IV a.C. - VI d.C., Ferrara 1989, pp. 566-597, p. 595, fig. 15.
53 R. KAUTZSCH, Die langobardische Schmuckkunst in Oberitalien, in Römische Jahr-buch für Kunstgeschichte 5 (1941), pp. 1-48, in partic. p. 43, fig. 43; P. ANGIOLINI MAR-TINELLI, “Corpus” della scultura paleocristiana bizantina ed altomedievale di Ravenna, I,
590 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 591
opera nel portico quattrocentesco di S. Spirito54, cattedrale ariana di fon-dazione teodoriciana (fine V - inizi VI secolo).
Meno circoscritto ma più numeroso appare l’insieme pugliese, di re-cente analizzato dalla Bertelli che propone una cronologia comune al VI secolo: vi appartengono una colonnina in opera in una bifora della testata meridionale del transetto e un’altra nella cripta di S. Nicola a Bari55; due, che fungono da sostegno del baldacchino dell’altare di S. Pietro nel san-tuario di Monte Sant’Angelo56; una, erratica e frammentaria, oggi custodi-ta nell’atrio della Stazione ferroviaria di Barletta, ma proveniente forse da una delle basiliche paleocristiane della vicina Canne57; una nella cripta di S. Nicola Pellegrino a Trani58.
Anche a Roma, come si è detto, si concentra un gran numero di esem-plari, alcuni già noti da tempo ma in parte oggi non più reperibili, altri in-dividuati solo di recente.
Tre colonne di questo tipo si trovavano in opera nel distrutto convento di S. Maria in Aracoeli e di queste una, frammentaria, era stata riutilizza-
Altari, amboni, cibori, cornici, plutei con figure di animali e con intrecci, transenne e frammenti vari, Roma 1968, n. 34, pp. 36-37; M. LAVERS, I cibori d’altare delle chiese di Classe e Ravenna, in FelRav s. IV, 2, 102 (1971), pp. 131-215, in partic. n. 19, pp. 200-211; C. RIZZARDI, Il ciborio di Sant’Eleucadio in Sant’Apollinare in Classe nella cul-tura artistica carolingia, in Ocnus 1 (1993), pp. 161-167. Tre delle quattro colonne mi-surano m 2,23 di altezza e la quarta, alta m 2,33, presenta anche un diametro lievemente maggiore (LAVERS, ibid., pp. 200-201).
54 M. MAZZOTTI, La «Anastasis Gothorum» di Ravenna ed il suo battistero, in FelRav s. III, 24, 75 (1957), pp. 25-26, in partic. p. 38 e nota 62; LAVERS (art. cit. nota 53), pp. 194-196, n. 17; P. NOVARA, Sì vagamente dalla natura fregiate. Per una analisi archeolo-gica degli antichi fusti di colonna esistenti in Ravenna, Ravenna 2002, p. 18, tav. IX,2; BARSANTI (art. cit. nota 35), pp. 197-198, fig. 59d. L’altezza, uguale in tutti e tre gli esem-plari, corrisponde a m 2,55; sul fusto, a m 1,77 dalla base, piccoli incavi cruciformi ospita-vano probabilmente croci metalliche a bracci uguali, mentre lungo i fianchi, fino ad un’al-tezza di m 0,88, si notano dei solchi, probabili incassi per transenne (LAVERS (art. cit. no-ta 53), pp. 194-195). Il Mazzotti ipotizza che esse facessero parte dell’originario ciborio della chiesa e che sarebbero state reimpiegate nel portico all’epoca dei restauri condotti negli anni 1543-44 dall’allora abate commendatario Corrado Grassi.
55 BERTELLI (art cit. nota 35), rispettivamente pp. 395-396, 380-382; EAD. (op. cit. no-ta 35), rispettivamente n. 42, p. 114, tav. XV, e n. 125, p. 152, tav. XL (quest’ultima al-ta m 1,65); per l’esemplare della cripta si veda inoltre G. BERTELLI in F. ABBATE (ed.), Arte in Puglia dal Medioevo al Settecento. Il Medioevo, catalogo della mostra, Foggia, Museo Civico - Bari, Basilica di San Nicola - Bari, Museo Diocesano- Bari, Pinacoteca Provinciale - Trani, Sezione Ebraica - Lecce, Museo Provinciale, 18 febbraio - 30 apri-le 2010, Roma 2010, n. I.5, p. 48.
56 BERTELLI (op. cit. nota 35), nn. 362-363, pp. 307-308, tav. CXVII: altezza: 1,53 e 1,29 m.
57 BERTELLI (op. cit. nota 35), n. 203, pp. 202-203, tav. LXVII: altezza 1,29 m.
592 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 593
ta nel chiostro quattrocentesco, demolito nel 188559; delle tre colonne, che furono descritte dal Cattaneo60, due sono attualmente disperse e solo una fu in seguito inglobata nel cosiddetto “caminetto del Sacconi”, un curioso pastiche di marmi provenienti dalle demolizioni, situato nei sotterranei del memoriale a Vittorio Emanuele II e, pare, fungente da studiolo dell’archi-tetto61. La colonna reimpiegata nel “caminetto” sembra potersi identificare con quella visibile nel loggiato dell’ordine superiore del chiostro quattro-centesco, ritratto in alcune fotografie eseguite intorno al 1870, dunque so-lo di qualche anno anteriori alle demolizioni62.
Ben quattro colonne integre, due di dimensioni maggiori e due di al-tezza inferiore, si trovano in opera nella chiesa di S. Bibiana, di fondazio-
58 BERTELLI (op. cit. nota 35), n. 467, p. 376, tav. CXLIX: altezza 2,23 m.59 Il chiostro, realizzato tra il 1420 e il 1480, era il più recente dei due dell’antico com-
plesso dell’Aracoeli (l’altro, il c. d. chiostro “benedettino”, risaliva invece al IX secolo), e fu il primo ad essere distrutto, in occasione della costruzione del Vittoriano (sul com-plesso dell’Aracoeli si veda da ultima M. BRANCIA DI APRICENA, Il complesso dell’Aracoeli sul Colle Capitolino (IX-XIX secolo), Roma 2000, con bibliografia, in particolare pp. 30 e 98-111 sul secondo chiostro; si cfr. inoltre il breve contributo di M. PIZZO, Il Vittoriano e la demolizione del convento dell’Aracoeli, in M. G. BARBERINI (ed.), Tracce di pietra. La collezione dei marmi di Palazzo Venezia, Roma 2008, pp. 55-59).
60 R. CATTANEO, L’architettura in Italia dal secolo VI al Mille circa, Venezia 1888, p. 163, dove si dice che “…Tre interessanti fusti di colonna, di non uguali misure, e che do-vettero far parte di ciborî, apparvero nelle recenti demolizioni dell’antico convento d’Ara-coeli. Sono per un terzo striate verticalmente da larghe scanalature riempite da bastoni, e per due terzi striate a spira da scanalature doriche. Che questi eleganti fusti sieno da as-segnarsi allo stile italo-bizantino, ci verrà confermato da altri ciborî di Ravenna, autenti-camente del IX secolo, che ne sono ugualmente forniti”. Stranamente solo un ventennio più tardi G. A. SARTORIO, Dei chiostri benedettini distrutti sul Campidoglio, in Capitolium 6 (1928), pp. 453-457, sostiene di aver cercato invano “... qualche colonna della galle-ria superiore ... striata in modo così caratteristico che gli studiosi potrebbero individuarla chissà dove sarà andata a finire”.
61 P. ACCIARESI, Giuseppe Sacconi e l’opera sua massima. Cronaca dei lavori del Mo-numento a Vittorio Emanuele II, Roma 1911, fig. 68 a p. 67; CELLINI (art. cit. nota 50), p. 188, fig. 16, nota 9 a pp. 194-195; RUSCONI (art. cit. nota 33), p. 425; M. CARTA, L. RUSSO, S. Maria in Aracoeli (Le chiese di Roma illustrate, n. s. - 22), Roma 1988, pp. 223-224; BRANCIA DI APRICENA (op. cit. nota 59), p. 35, fig. 10, nota 38 a p. 56, dove si ipotizza che la colonna tortile e baccellata reimpiegata facesse già parte del ciborio della chiesa altomedievale; PIZZO (art. cit. nota 59), p. 59.
62 CELLINI (art. cit. nota 50), fig. 19; CARTA, RUSSO (op. cit. nota 61), fig. 59; BRAN-CIA DI APRICENA (art. cit. nota 59), figg. 3, 22; L. RUSSO, Santa Maria in Aracoeli, Roma 2007, fig. 155. Varie sono le datazioni proposte: per CELLINI (art. cit. nota 50), nota 9, la colonna, come quella di S. Sergio al Cairo, cit. supra, andrebbe assegnata al IV secolo; CARTA, RUSSO (art. cit. nota 61), p. 40, la datano all’VIII-IX secolo e BRANCIA DI APRICE-NA (art. cit. nota 59), p. 35, al IX secolo, in rapporto con la fondazione della chiesa.
592 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 593
ne paleocristiana ma oggi giunta nella veste probabilmente ascrivibile ad un restauro di papa Onorio III (1216-1227), rispettivamente la prima cop-pia al termine dei colonnati che dividono le tre navate, all’estremità anti-stante il presbiterio (fig. 7), l’altra coppia posta ad inquadrare la pala d’al-tare della Cappella della Madonna e di S. Flaviano, fondata nel 170263. Un frammento analogo, di dimensioni minori, si trova reimpiegato in un trat-to delle Mura Aureliane posto a sud dei Castra Praetoria, tra questi e la Porta Tiburtina, dunque poco lontano da S. Bibiana64.
Tra gli altri esemplari dispersi si ricorda infine una colonna tortile e baccellata, integra, che fu vista dal Piranesi intorno alla metà del XVIII secolo nella Vigna dei Gesuiti, sita nella vicinanze di S. Prisca, tra questa e S. Sabina, sull’Aventino65 (fig. 8).
Non distante da Roma, inoltre, un’altra colonna, resecata nella parte inferiore, si trova reimpiegata nella cripta romanica di S. Pietro a Tusca-nia66 (fig. 9).
Oltre a questi nuclei più cospicui si possono ricordare, sempre in terri-torio italiano, numerosi esemplari isolati, già in gran parte raccolti dal Ru-sconi: innanzitutto le quattro colonne, già menzionate, murate nel paramento esterno della Cattedrale di Acerenza67, nell’absidiola orientale del transetto nord e in quella vicina del deambulatorio absidale; una, evidentemente ri-lavorata nella parte a spire, che si trova murata sull’angolo della cappelli-na di S. Anna pertinente a S. Pietro a Corte in via Adalberga a Salerno68;
63 MAZZANTI (art. cit. nota 11), in partic. p. 28; R. E. MALMSTROM, The Colonnades of High Medieval Churches at Rome, in Gesta 14/2 (1975), pp. 37-45, in partic. pp. 40-41 e nota 34; S. VASCO ROCCA, Santa Bibiana (Le chiese di Roma Illustrate, N.S. - 14), Ro-ma 1983, pp. 55, 81, fig. 29; V. TIBERIA, Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Ago-stino Ciampelli in Santa Bibiana a Roma. I restauri, Todi 2000, fig. 186 a p. 204; P. C. CLAUSSEN, Die Kirchen der Stadt Rom im Mittelalter 1050-1300, A-F (Corpus Cosmatorum II,1), Stuttgart 2002, pp. 183-185, fig. 127; C. BARSANTI, R. FLAMINIO, A. GUIGLIA GUIDO-BALDI, La Diocesi di Roma. La III regione ecclesiastica (Corpus della scultura altomedie-vale, VII, 7), Spoleto, in corso di pubblicazione: le due colonne maggiori misurano in al-tezza ca. 2,80 m, le due minori ca. 2,28 m.
64 BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA GUIDOBALDI (op. cit. nota 63).65 G. B. PIRANESI (op. cit. nota 20), tav. XVI,c: In vinea PP. Soc. Jesu, e regione tem-
pli Divae Priscae in Aventino.66 RUSCONI (art. cit. nota 33), p. 425, fig. 7. La colonna, la prima da est della secon-
da fila da sinistra, è alta m 1,86 ma la parte baccellata è mutila, per cui si potrebbe le-gittimamente ipotizzare un’altezza originaria di almeno 2 m.
67 RUSCONI (art. cit. nota 33), pp. 423-424, figg. 1-3; le colonne superano di poco i 2 m.68 RUSCONI (art. cit. nota 33), pp. 430-431, fig. 11bis; C. TAFURI, L’Istituzione di San
Pietro a Corte in Età Moderna, in San Pietro a Corte. Recupero di una memoria nella città di Salerno, Napoli 2000, pp. 63-74, p. 69, fig. 2 (per la situazione successiva ai re-centi restauri). Rusconi ipotizza che essa facesse parte di un eventuale ciborio (VIII seco-
594 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 595
un’altra, infine, al Museo di Palazzo Bellomo a Siracusa, proveniente dal-la cattedrale della città69.
Sempre in Campania, di problematica collocazione è la colonna, molto simile a quelle finora descritte, venuta alla luce in uno scavo in via Dome-nico Morelli a Cimitile: la colonna, per cui è stata proposta un’attribuzio-ne ad età flavia, è stata rinvenuta nel portico di una villa che sarebbe ca-duta in disuso già prima del 506 d.C. ma che fu interessata anche da una fase di rioccupazione del sito successiva a tale data70.
Ed ancora in Campania occorre rimanere, andando indietro nel tem-po, per rintracciare eventuali altri esemplari antichi che possano aver fat-to da modello per il tipo di colonne in esame. L’origine di questa tipo-logia di colonna decorata sembra infatti risalire ad epoca romana71, come attestano gli esemplari in laterizio rivestito di stucco, e ornati con baccel-lature incise nel terzo inferiore e a spirale nei due terzi superiori, perti-nenti al “peristilio superiore” della Villa S. Marco a Stabiae72, datata an-teriormente al 79 d.C.
lo) della chiesa palatina salernitana (RUSCONI, art. cit. nota 33, nota 16); la Tafuri identi-fica invece la colonnina come classica.
69 G. AGNELLO, L’architettura bizantina in Sicilia, Firenze 1952, p. 48, fig. 32, tav. XIV; ID., Le arti figurative della Sicilia bizantina, Palermo 1962, pp. 21-22, fig. 3: la co-lonnina, sovrastata da un capitello ionico tardoantico che sembra esserle pertinente, fu ri-mossa dalla cattedrale, ove mostrava una collocazione non di uso primario, durante i re-stauri del 1929: le sue ridotte dimensioni (nel testo non riportate) hanno fatto ipotizzare una originaria funzione come sostegno di portichetto o, più probabilmente, di una pergu-la di recinzione presbiteriale.
70 C. EBANISTA, Dinamiche insediative nel territorio di Cimitile tra tarda antichità e Medioevo, in H. BRANDENBURG, L. PANI ERMINI (ed.), Cimitile e Paolino di Nola. La tom-ba di S. Felice e il centro di pellegrinaggio. Trent’anni di ricerche, Atti della giornata te-matica dei Seminari di Archeologia Cristiana, École Française de Rome - 9 marzo 2000, Città del Vaticano 2003, pp. 43-86, in partic. pp. 60-61, fig. 3 con bibliografia; diversa-mente T. LEHMANN, Paulinus Nolanus und die Basilica Nova in Cimitile/Nola, Wiesbaden 2004, pp. 132-133, tav. 167, figg. 240-241, attribuisce con argomenti convincenti la co-lonna (h 1,90, totale ca. 3,20 m) ad epoca tardoantica.
71 A tal proposito il Cattaneo faceva notare che presso i Greci “della decadenza” si preferiva lasciare lisci i fusti di colonna, per goderne appieno la politezza e il colore dei marmi, mentre i Romani adottarono ampiamente la pratica di scanalare le colonne, soprat-tutto di marmo bianco, per creare effetti di chiaroscuro, fenomeno che si sarebbe verifi-cato con maggiore frequenza in epoca tardoantica (CATTANEO, op. cit. nota 60), pp. 163-164; giudizio poi ripreso da MAZZANTI (op. cit. nota 11), p. 19).
72 BENSON (art. cit. nota 39), p. 255; RUSCONI (art. cit. nota 33), p. 426, fig. 11; A. FERRARA, La Villa San Marco a Stabiae, in D. CAMARDO, A. FERRARA (ed.), Stabiae dai Borbone alle ultime scoperte, Castellammare di Stabia 2001, pp. 99-104, in partic. pp. 99, 101, 104, figg. 90-93 a p. 141, figg. 95-99 a p. 142: le colonne furono tra i primi ritrova-menti degli scavi della villa, iniziati alla fine del 1950, ed esistevano ancora all’epoca del
594 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 595
Un caso finora privo di altri riscontri è costituito, invece, da un mau-soleo a Souma Djassa in Algeria, datato al IV secolo d.C., che mostra nel prospetto aperto della parte superiore una coppia di colonnine del tipo in esame73. Una trascrizione iconografica del tema della colonnina tortile e baccellata si rileva, nello stesso periodo, sia nella decorazione dei rilievi funerari dell’Egitto copto74, ricavati in pietra locale e datati tra il V e il VII secolo, sia, come ha già rilevato il Rusconi75, nel decoro di un grup-po di avori tardoantichi (V-VI secolo) con figurazione ad edicola che rac-chiude eminenti personaggi o personificazioni76. Tra questi, il dittico con Roma e Costantinopoli al Kunsthistorisches Museum di Vienna77 e quel-lo con la Musa e il Poeta del Tesoro del Duomo di Monza, ove, però, la
Rusconi, ma oggi purtroppo non sono più indagabili, poiché al peristilio superiore, ogget-to fin dalla metà del 1951 di lavori di consolidamento e restauro, fu sovrapposta una tra-beazione di cemento e muratura, che causò il crollo di una colonna, già nell’ottobre del 1960, e la distruzione dell’intero colonnato in occasione del sisma del novembre 1980.
73 RUSCONI (art. cit. nota 33), pp. 427-428, figg. 13-15: a tal proposito si è pensato an-che ad un’origine copta della tipologia di colonnine qui esaminate, ipotesi da scartare se si tiene conto del fatto che le colonne sono tutte ricavate in marmo greco, compreso l’esem-plare di S. Sergio al Cairo (RUSCONI (art. cit. nota 33), p. 426 e nota 7).
74 S. GSELL, Monuments antiques de l’Algérie, Paris 1901, II, p. 94, fig. 109; V. CHAPOT, La Colonne torse et le décor en hélice dans l’art antique, Paris 1907, p. 133, fig. 164; RUSCONI (art. cit. nota 33), p. 427, fig. 12.
75 RUSCONI (art. cit. nota 33), pp. 427-428, figg. 16-18. Nonostante i confronti con gli avori tardoantichi, da lui stesso chiamati in causa, il RUSCONI (art. cit. nota 33), p. 428, preferisce, però, pensare ad una ripresa della colonna scanalata e baccellata nell’arredo ar-chitettonico dello scorcio dell’VIII secolo.
76 RUSCONI (art. cit. nota 33), pp. 427-428. Ancora si discute sulla provenienza di mol-ti di questi preziosi manufatti, in genere variamente ascritti alle officine di Alessandria, Costantinopoli, Milano o Ravenna.
77 W. F. VOLBACH, Elfenbeinarbeiten der spätantike und des frühen Mittelalters, Mainz 19763, pp. 43-44, n. 38, tav. 21: datato al V secolo; S.R. ZWIRN in K. WEITZMANN (ed.), Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century, Ca-talogue of the exhibition, New York, Metropolitan Museum of Art, November 1977 - Fe-bruary 1978, New York 1979, n. 153, pp. 173-175: fine V -inizi VI secolo. Si vedano inoltre le colonnine che inquadrano i santi Acacio e Teodoro nel dittico più tardo del Mu-seo Civico di Cremona, forse copia di un esemplare più antico (VOLBACH, ibid., pp. 143-144, n. 252: X-XII secolo), quelle sul dittico, piuttosto rozzo, con i quattro Evangelisti al Fitzwilliam Museum di Cambridge (VOLBACH, ibid., p. 100, n. 152, tav. 79; N. PATTER-SON-ŠEVĆENKO in Age of Spirituality, ibid., n. 486, pp. 540-542: VI secolo; D. BUCKTON (ed.), Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections, Lon-don 1994, n. 63, pp. 72-73: VI secolo; qui solo una colonna delle sei sembra presentare una redazione a spire e baccellature), e infine la colonnina più visibile sulla placca con S. Pietro e S. Marco del Victoria and Albert Museum di Londra (VOLBACH, ibid., p.141, n. 243, tav 111: XI secolo; N. PATTERSON-ŠEVĆENKO in Age of Spirituality, ibid., n. 490, p. 546: fine del VII secolo).
596 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 597
colonnina in questione funge da reggi-leggio78, a riprova che la diffusio-ne di tale partito decorativo in differenti media artistici si spiega piuttosto con il ricorso ad un medesimo repertorio iconografico che non con il ri-ferimento a modelli monumentali.
Anche nei secoli seguenti il tema della colonna tortile e baccellata tro-va attestazioni nel campo della pittura o della miniatura: per esempio, nel-la colonna che funge da quinta alla scena di uno degli affreschi frammen-tari del portico di S. Giovanni a Porta Latina a Roma (terzo quarto del-l’XI secolo)79, caratterizzata da proporzioni alquanto allungate, coerenti con quelle delle vicine figure che riflettono lo stile dell’epoca; una singolare alternanza di parti baccellate e spire contraddistingue invece le colonnine raffigurate sia in una pagina miniata del Codice delle Omelie di Gregorio Nazianzeno (Paris, Bibliothèque Nationale, ms. gr. 510), sia in un’altra del Salterio di Parigi (Bibliothèque Nationale, ms. gr. 139, fol. 5v), lussuosi manoscritti costantinopolitani, ascrivibili rispettivamente allo scorcio del IX (880-883) e al X secolo, che si ispirano a modelli più antichi80.
Infine, una variante della tipologia di colonna qui presa in esame, che comprende una parte inferiore baccellata ed un insolito decoro di eleganti girali con mezze palmette e foglie trilobate che avvolge la parte superio-re del fusto, è testimoniata da sei colonne reimpiegate come sostegni nel-la cripta romanica della cattedrale di Otranto. La cronologia quanto me-no paleocristiana di tali esemplari, che non hanno finora ricevuto l’atten-zione che meritano e ai quali è stata finora attribuita una datazione sia al VI che al IX secolo81, si deduce dalla resa formale del tralcio e dalla pre-
78 Nel pannello con la Musa (VOLBACH (op. cit. nota 77), pp. 57-58, n. 68, tav. 39: inizi del VI secolo; C. COMPOSTELLA, in Milano capitale dell’impero romano 286-402 d.C., ca-talogo della mostra, Milano - Palazzo Reale, 24 gennaio - 22 aprile 1990, Milano 1990, n. 5b.1d, pp. 341-342: tardo V secolo).
79 F. DOS SANTOS, in S. ROMANO (ed.), La pittura medievale a Roma 313-1431. Cor-pus, IV. Riforma e tradizione. 1050-1198, Viterbo 2006, n. 13, pp. 104-105. Tale crono-logia è d’altra parte coincidente con la ripresa, a Roma, del tema della colonna vitinea nella redazione scultorea (cfr. nota 17).
80 Per il primo si veda M.-O. GERMAIN, in J. DURAND (ed.), Byzance. L’art byzantin dans les collections publiques françaises, catalogo della mostra, Paris 1992-1993, Paris 1992, cat. 258, pp. 346-348 (la scena in questione raffigura i tre padri cappadoci, Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e Gregorio Nazianzeno inquadrati da arcate su colonne); per l’altro M.-O. GERMAIN, ibid., cat. 261, pp. 350-351; I. KALAVREZOU, in H. C. EVANS, W. D. WIXOM (ed.), The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261, catalogo della mostra, New York 1997, cat. 163, pp. 240-242 (la miniatura ri-trae la danza di una figlia di Israele per la vittoria di David; le due colonne in questione sostengono un portichetto sullo sfondo).
81 E. BERTAUX, L’art médiévale dans l’Italie méridionale, I, Paris 1903, p. 75, fig. 14 (V. KIENERK, in A. PRANDI (ed.), Aggiornamento, IV, Rome 1978, p. 254); J. RASPI SERRA,
596 ROBERTA FLAMINIO SU UN PARTICOLARE TIPO DI COLONNA DECORATA 597
senza di una treccia a due capi formata da un nastro monosolcato che di-stingue i due tipi di decoro. Per la loro peculiarità strutturale e per l’esi-guità dei confronti rintracciabili esse richiederebbero un’approfondita di-samina, su cui non vi è lo spazio qui per soffermarsi. L’individuazione di quest’ultima singolare variante compositiva apre infatti ulteriori spunti di ricerca sulla fortuna e la varietà delle colonne decorate in epoca paleocri-stiana ed altomedievale.
Una lontana eco di tale gusto, che propone in maniera più estrosa una sorta di abbinamento tra diverse tipologie, si coglie ancora, in secoli più avanzati nel Medioevo, nelle colonnine che scandiscono la parata di per-sonaggi ritratti sulla ben nota margella di pozzo, di datazione dibattuta, nella chiesa di S. Bartolomeo all’Isola Tiberina a Roma82. Nella fattispe-cie, una di esse ripropone la struttura della “colonna d’acanto” con i due segmenti di fusto interessati rispettivamente da spire e da un’ornamenta-zione fitomorfa.
Sculture tardoantiche, paleocristiane ed altomedievali di Otranto, in BdA s. 5, n. 3-4 (1972), pp. 138-143, in partic. p. 139, fig. 9; BELLI D’ELIA, Otranto, Cattedrale, in Alle sorgenti del Romanico. Puglia XI secolo, Bari 1975 (19872), pp. 161, 164, 170-171; P. VERGARA, Elementi architettonici tardoantichi e medioevali nella cripta della Cattedrale di Otranto, in RIASA s. III, 4 (1981), pp. 71-103, in particolare pp. 99-100, fig. 39.
82 A tal riguardo la critica si è recentemente orientata verso una datazione agli ini-zi (F. GANDOLFO, I puteali di S. Bartolomeo all’isola e di Grottaferrata, in S. ROMANO, J. ENCKELL JULLIARD (ed.) Roma e la Riforma gregoriana. Tradizioni e innovazioni artistiche (XI-XII secolo), Actes du colloque, Lausanne 10/11 décembre, Roma 2004, pp. 165-184, in partic. pp. 165-169, con bibliografia precedente) o nella seconda metà del XII seco-lo (P. C. CLAUSSEN, Der Marmorbrunnen von S. Bartolomeo all’Isola in Rom, oder: im-mer wenn der Tiber kam, in Georges-Bloch-Jahrbuch der Kunstgeschichtlichen Seminars der Üniversität Zürich 1 (1994), pp. 70-92; ID. (op. cit. nota 63), pp. 152-163), mentre la tradizionale attribuzione agli anni intorno al 1000 è stata riproposta da R. TOLLO, An-cora sul puteale della chiesa di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, in ArchStorRom 123 (2000), pp. 85-104.































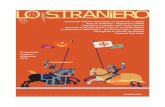



!['Generale e particolare' ['General and Particular'], in Chora V, 14 (2007): 27-36](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633eeee69fa33b2a320f90f5/generale-e-particolare-general-and-particular-in-chora-v-14-2007-27-36.jpg)










