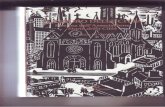Il nuovo quartiere aragonese sul porto nel primo Trecento a Cagliari
Cearmica Grezza proveniente dalla città di Cagliari: attestazione di Pantellerian Ware
Transcript of Cearmica Grezza proveniente dalla città di Cagliari: attestazione di Pantellerian Ware
This title published by
ArchaeopressPublishers of British Archaeological Reports Gordon House 276 Banbury Road Oxford OX2 7ED [email protected] www.archaeopress.com
BAR S1662 (I)
LRCW 2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean : Archaeology and archaeometry
© the individual authors 2007
ISBN 978 1 4073 0098 6 (complete set of 2 volumes) ISBN 978 1 4073 0100 6 (this volume) ISBN 978 1 4073 0101 3 (volume II)
Printed in England by Chalvington Digital
Cover illustration: Eastern Mediterranean Cooking pot from Marseille, La Bourse excavations (1980). [After Coeur-Mezzoud, F., La vaisselle du sondage 10, in Fouilles à Marseille, Les mobiliers (Ier-VIIe s. ap. J.-C.) (eds. M. Bonifay, M.-B. Carre and Y. Rigoir), Etudes Massaliètes 5, 160, fig. 130, Paris]
All BAR titles are available from:
Hadrian Books Ltd 122 Banbury Road OxfordOX2 7BP [email protected]
The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment is available free from Hadrian Books or may be downloaded from www.archaeopress.com
CERAMICA GREZZA PROVENIENTE DALLA CITTÀ DI CAGLIARI (SARDEGNA-ITALIA):
ATTESTAZIONE DI PANTELLERIAN WARE
STEFANO CARA1, SILVIA SANGIORGI2
1Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del C.N.R., Piazza d'Armi 1, 09123 Cagliari, Italia ([email protected])
2Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico-artistiche dell’Università di Cagliari, Piazza Arsenale 1, 09124 Cagliari, Italia ([email protected])
The present work shows the results of the investigation conducted on the coarse ware from two important archaeological sites in the city of Cagliari (Sardinia, Italy), respectively the S. Eulalia Church underground and Vico
III Lanusei. The excavations, carried out during the 90s, discovered a great quantity of coarse ware shards regarding
coarse ceramic pastes. The study of these materials was particularly interesting and suggested to advance further investigations on a particular group of fire ware artefacts which belong to the Pantellerian Ware, according to a first
formal macroscopical analysis. This work reports the results of an archaeological and archaeometrical investigation
on these artefacts, carried out to verify the reliability of this first attribution, comparing there characteristics with the other productions discovered in Pantelleria and in northern Sardinia (particularly in Porto Torres area). In this we
verified if the finds from Cagliari area were related to the Pantellerian Ware production, giving further information on
the shapes exported in southern Sardinia.
KEYWORDS: SARDINIA, COOKING WARE, COARSE WARE, PANTELLERIAN WARE.
1. INTRODUZIONE
Lo scavo archeologico cagliaritano effettuato al di sotto della chiesa di S. Eulalia e condotto dalla Soprintendenza per i Beni archeologici in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari ha restituito – al pari di numerose altre indagini svolte in Sardegna - centinaia di migliaia di frammenti riferibili a diverse ed eterogenee produzioni di ceramiche da fuoco, di cui si è dato conto in differenti lavori: è stato infatti indagato un contesto pluristratificato relativo ad un quartiere dell’antica città, obliterato da accumuli, alti fino a 7 metri, contenenti oltre un milione di frammenti ceramici, a cui si aggiunge un consistente numero di reperti appartenenti ad altre classi di materiali, circoscritti prevalentemente in un arco cronologico dal IV al VII secolo d.C. (Martorelli e Mureddu 2002a; Martorelli e Mureddu 2002b; Martorelli et al. 2003; Sangiorgi e Cisci 2003; Pinna 2003; Pinna 2005; Sangiorgi 2005; Sangiorgi c.s.).
Poiché l’analisi macroscopica e morfologica di una parte dei manufatti da fuoco suggeriva l’appartenenza alla Pantellerian Ware, sono stati sottoposti ad analisi archeometriche 25 campioni rappresentativi dell’insieme di materiali (Tabella I).
La ricerca è stata allargata inoltre a 4 tegami, provenienti da un altro scavo urbano condotto dalla Soprintendenza per i Beni archeologici nel centro di Cagliari, situato in Vico III Lanusei (Tabella I), i cui materiali hanno
costituito oggetto di uno studio, condotto da una equipe coordinata da R. Martorelli e oggetto di una recente pubblicazione. Anche nel caso di quest’altro ritrovamento, le similitudini formali con la ceramica pantesca hanno fatto supporre si trattasse di tali importazioni (Mezzanotte 2006).
La Sardegna era comunque già inserita nella carta distributiva della produzione pantesca con Tharros (Peacock 1982, 93; Fulford, Peacock 1984, 9-10, 157) e successivamente con Porto Torres (si rimanda a C.A.T.H.M.A., 40. F. Villedieu propose inizialmente, nell’impossibilità di effettuare analisi archeometriche, un’origine locale per queste e per le altre ceramiche modellate a mano o a tornio lento provenienti dallo scavo turritano: 1984, 155-156, 247).
È comunque opportuno ricordare come la diffusione in Sardegna di ceramiche grezze che sembrano presenti, seppure sporadicamente, fin dal I sec. a.C. e l’incompletezza che ancora connota la loro caratterizzazione, inducano ad una certa prudenza nell’ascrivere i ritrovamenti alla produzione pantesca o ad altri gruppi noti (cfr. inoltre le considerazioni in Santoro Bianchi 2002, 997-998 e Santoro Bianchi 2003, 67).
2. I REPERTI
I reperti provenienti dallo scavo di S. Eulalia, che da un’analisi macroscopica degli impasti e dei trattamenti
LRCW 2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry
329
superficiali sembrano da ricondurre alla nota produzione siciliana, sono relativi a teglie, tegami e coperchi; mancano invece, allo stato attuale delle ricerche, frammenti pertinenti alle pentole e olle che completano l’articolazione morfologica di queste ceramiche massicciamente presenti nel Mediterraneo e definita in recenti lavori dei quali si riprende la terminologia e la suddivisione (Guiducci 2003, 61-65 che differisce in alcuni punti da Santoro, Guiducci 2001). La produzione di Pantelleria, notoriamente piuttosto diffusa, sembra coprire un arco cronologico assai ampio che parte dal II-I a.C., con un picco tra la metà del IV e la metà del V, arrivando fino al VI inoltrato (il riferimento è soprattutto a: Fulford, Peacock 1984, 157-159; C.A.T.H.M.A. 1991, 40; Reynolds 1995, 102-105; Cau Ontiveros 2003, 114; Santoro Bianchi 2003, 66-70; Santoro Bianchi 2005, 328). I contesti di rinvenimento del sito in esame sono riferibili, grazie all’associazione con altri materiali, al V-VI sec. d.C.
Per quasi tutti i frammenti di S. Eulalia campionati è possibile risalire alla forma: tra i 25 campioni, 9 sono relativi a teglie, 6 a tegami, 7 a coperchi, mentre non è chiaro a quale forma appartengano un frammento di fondo ed uno di parete (C. 8, 25). Infine il campione 16, pertinente ad un tegame, è stato sottoposto ad analisi per verificare l’appartenenza alla produzione di Pantelleria, sebbene all’esame macroscopico presenti caratteristiche relative anche alla produzione 1.2 di Cartagine (Fulford, Peacock 1984, 159-161).
I campioni 17-20, come sopra accennato, provengono invece dallo scavo di Vico III Lanusei: si tratta di tegami, considerabili materiali residui rispetto alla cronologia di provenienza.
I 9 frammenti di teglie campionati rientrano nei due tipi principali riscontrati per questa forma, che risulta quella maggiormente caratteristica della Pantellerian Ware;recano visibili tracce di lisciatura all’interno, di steccatura all’esterno e marcati segni di utilizzo: i campioni 1, 3, 4, 12, 21 (Fig. 1, n° 1-2; Fig. 2, n° 1) sono riconducibili a teglie dall’orlo esoverso e piatto realizzato mediante ripiegamento all’esterno e scanalatura per l’alloggiamento del coperchio (per il tipo di teglia si rimanda a Guiducci 2003, 61-65: teglia M1). Il diametro, verificabile in quattro casi su cinque, è superiore ai 23 cm. I campioni 2, 11, 22, 23 (Fig. 1, n° 3; Fig. 2, n° 2) hanno orlo ugualmente esoverso, ingrossato per rovesciamento e privo di scanalatura per l’alloggiamento del coperchio (Fulford, Peacock 1984, 157, fig. 55: forma Fulford 1; Guiducci 2003, 61-65: teglia M2). Il diametro, verificabile in due casi su quattro, è superiore ai 28 cm.
I 6 frammenti di tegami campionati hanno orlo indistinto e pareti curve; sono steccati all’esterno e lisciati all’interno e presentano tutti tracce di utilizzo. I campioni 15 e 24 (Fig. 1, n° 4) sono di dimensioni minori (diametri 20 e 23 cm) e pareti curve (Guiducci 2003, 64: tegame
G1); i campioni 13, 14 (Fig. 1, n° 5; Fig. 2, n° 3-4), dal diametro maggiore (superiore a 30 cm), hanno le pareti leggermente introflesse che risultano superiormente aperte (Guiducci 2003, 64: tegame G2). Per i frammenti 9, 10, data l’esiguità della porzione conservata, non è determinabile l’orientamento. In due casi (C. 13 e 14; Fig. 1, n° 5; Fig. 2, n° 3-4) sono conservate le prese ad orecchia collocate al di sotto dell’orlo che caratterizzavano, in coppia, i tegami.
I 4 tegami da Vico III Lanusei hanno caratteristiche formali simili a quelli provenienti da S. Eulalia, ma sono lisciati internamente ed esternamente in tre casi (C. 17, 19 e 20) e con steccature realizzate in modo disordinato e poco accurato, tanto da creare escrescenze di pasta nel quarto manufatto (C. 18). I campioni 19, 20 hanno pareti ricurve, orlo indistinto e arrotondato e presa al di sotto dell’orlo. Il campione 17 è simile ai precedenti, ma ha le pareti maggiormente aperte, mentre il frammento 18 ha orlo e presa squadrati e pareti dritte.
I frammenti di coperchi sottoposti ad analisi, tutti relativi alla porzione dell’orlo tranne un caso, sono 7: i campioni 6, 7 e 29 presentano orlo indistinto (Guiducci 2003, 64: coperchio L1), i numeri 5, 27, 28 (Fig. 1, n° 7; Fig. 3, n° 2) orlo ingrossato per rovesciamento (Guiducci 2003, 64: coperchio L2), mentre il campione 26 è una presa a disco che caratterizza la forma (Fig. 3, n° 1). Per le porzioni di orlo i diametri esterni, ricostruibili in tre casi su sei, sono di 20, 36 e 38 cm, confermando l’estrema variabilità dimensionale che caratterizza questa forma finalizzata all’utilizzo su recipienti dalle misure differenti.
3. ANALISI ARCHEOMETRICA
La campionatura dei reperti per l’analisi archeometrica è stata eseguita su 29 frammenti ceramici che sono stati successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio per la definizione della composizione della matrice, della natura della frazione sabbioso-siltosa e per la definizione dei caratteri granulometrici e morfometrici (Fig. 3, n° 3-4).
La composizione mineralogica è stata determinata con tecnica di diffrazione di raggi X (XRD) utilizzando un’apparecchiatura Rigaku Geigerflex D-max con radiazione Cu K . Per la definizione delle caratteristiche dello scheletro sabbioso-siltoso contenuto nei corpi ceramici è stata eseguita l’analisi mineralogico-petrografica in sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore.
Al microscopio ottico in luce trasmessa tutti i frammenti analizzati mostrano un aspetto “terroso” di colore bruno e ricco di degrassante. Quest’ultimo è costituito in prevalenza da frammenti grossolani (fino a millimetrici) di cristalli di feldspato alcalino (anortoclasio) e di roccia vulcanica. I primi si distinguono per l’aspetto tabulare e la geminazione albite-periclino. Hanno dimensioni
S. Cara, S. Sangiorgi
330
comprese perlopiù fra 0,3 mm e 1 mm, anche se si riscontrano elementi che raggiungono i 3mm (Fig. 4, n° 1-2). I frammenti litici di origine vulcanica hanno una struttura porfirica, con fenocristalli di feldspato alcalino immersi in una pasta di fondo costituita anch’essa da microliti di feldspato, pirosseno, aenigmatite e minerali opachi. All’interno del corpo ceramico si trovano disseminati nella pasta di fondo frammenti di cristalli di quarzo, con dimensioni solitamente al di sotto di 0,5 mm, e più raramente più minuti frammenti di pirosseno e aenigmatite (Fig. 4, n° 2-4).
La frazione siltoso-sabbiosa contenuta nei corpi ceramici è stata stimata in media pari al 40% in volume, valore abbastanza comune negli impasti di ceramica grezza da fuoco (Fig. 4, n° 1). I reperti analizzati mostrano un annerimento diffuso delle superfici esterne conseguente alla loro destinazione d’uso (ceramica da fuoco). A seguito dell’elevata porosità di questi manufatti la fuliggine è penetrata anche all’interno delle pareti, interessando talvolta quasi l’intera sezione del corpo ceramico.
Allo scopo di determinare la natura delle eventuali fasi mineralogiche non rilevabili al microscopio petrografico (frazioni argillose residue) e di individuare le eventuali fasi mineralogiche di neoformazione è stata eseguita su tutti i campioni l’analisi mineralogica XRD. L’indagine diffrattometrica ha confermato l’associazione mineralogica definita con quella petrografica e non ha rivelato la presenza di frazioni argillose residue né di minerali di neoformazione conseguenti al processo di cottura (Fig. 5; Tabella I).
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La campionatura e le relative analisi effettuate erano finalizzate alla verifica della presenza di Pantellerian
Ware nei due siti cagliaritani che hanno restituito numerosi frammenti di ceramica da fuoco. Le caratteristiche macroscopiche dei materiali di S. Eulalia, molto simili a quelle dei materiali siciliani, orientavano con maggiore sicurezza verso tale attribuzione, ad eccezione del C. 16 (Tabella I) che presentava similitudini anche con la produzione ritenuta delle Eolie/sarda (steccatura all’interno, spessore dell’orlo di dimensioni minore). Sono stati inseriti nella campionatura anche i frammenti da Vico III Lanusei, anche se un’analisi preliminare evidenziava alcune dissonanze, non strettamente morfologiche, ma relative al trattamento superficiale e agli impasti rispetto al vasellame da S. Eulalia.
L’analisi archeometrica condotta sulla campionatura dei corpi ceramici ha messo in evidenza una paragenesi mineralogica costituita da anortoclasio, clinopirosseno, aenigmatite ai quali si associano quarzo (Fig. 5, Tabella I) e una frazione relativamente consistente di frammenti litici riconducibili a rocce vulcaniche alcaline (Fig. 4).
Questi elementi costituiscono la tipica associazione ritrovata nelle ceramiche da fuoco della tipologia nota come Pantellerian Ware, così come descritta da vari autori e ben definita da recenti studi tipologici e tecnologici condotti sui materiali archeologici e sulle materie prime ritrovate nell’isola di Pantelleria (Alaimo, Montana 2003, 52; Montana, Iliopoulos e Giarrusso 2005; Montana, Iliopoulos e Tantillo 2005). L’assenza di minerali argillosi nei corpi ceramici indagati fa supporre che la temperatura di cottura dei manufatti sia compresa fra i 700 e gli 800 °C (in accordo con Montana, Iliopoulos e Giarrusso 2005).
Fra i materiali indagati rientrano in questa tipologia solo quelli provenienti dallo scavo archeologico di S. Eulalia, mentre quelli dello scavo di Vico III Lanusei non risultano compatibili con le caratteristiche composizionali di questa tipologia. I manufatti di Vico III Lanusei, benchè numericamente non rappresentativi, mostrano infatti un’associazione mineralogica data da quarzo, plagioclasio, K-feldspato, muscovite e contengono inclusi siltoso-sabbiosi di origine metamorfica, composizione che si discosta nettamente da quella della Pantellerian
Ware.
Lo studio, in sintesi, ha portato ad una nuova attestazione della produzione pantesca in Sardegna, dando conto delle forme esportate nell’area meridionale. Il ritrovamento a Cagliari induce a nuove verifiche e ricerche. Tale presenza non è numericamente ancora quantificabile, ma comunque invita a rivedere alcune considerazioni relative all’esigua presenza di importazioni da Pantelleria in Sardegna (ad esempio Peacock 1997, 100).
Sebbene lo scavo di S. Eulalia sia concluso da anni, la consistente mole di materiali recuperata e i connessi problemi logistici relativi alla sua conservazione non consentono di analizzare il ritrovamento nel suo complesso, ma solo a piccoli e frammentari lotti. Da una prima stima assolutamente approssimativa, il vasellame di Pantelleria nel sito cagliaritano sembra coprire almeno il 10% del totale della ceramica da fuoco, comprensiva della ceramica realizzata a tornio veloce, costituita essenzialmente dall’Africana da cucina, oltre alle diverse produzioni a tornio lento o a mano.
Al momento attuale non sono stati riscontrati frammenti della medesima produzione relativi ad olle (forse di cronologia anteriore rispetto alle altre forme: Guiducci 2003, 64) e pentole, anche se è opportuno ricordare che l’analisi è stata estesa ad una parte dei materiali, che comunque supera il migliaio di frammenti.
Nota degli autori:
La stesura del paragrafo 2 di questo lavoro, che risulta concepito unitariamente, è di Silvia Sangiorgi; a Stefano Cara, oltre alle analisi di laboratorio, si deve il paragrafo 3. I paragrafi 1 e 4 vanno considerati lavoro comune di entrambi gli autori.
Ceramica grezza proveniente dalla città di Cagliari (Sardegna - Italia): attestazione di Pantellerian Ware
331
BIBLIOGRAFIA
Alaimo, R., e Montana, G., 2003, Scienza e archeologia: le analisi archeometriche, in Pantellerian Ware:
Archeologia subacquea e ceramiche da fuoco a Pantelleria (eds. S. Santoro Bianchi, G. Guiducci, e S. Tusa), 52-55, Palermo.
C.A.T.H.M.A., 1991, Importations de céramiques communes méditerranéennes dans le midi de la
Gaule (Ve-VIIe s.), in A cerâmica medieval no
Mediterrâneo Ocidental (Lisboa 1987), 27-47, Mértola.
Cau Ontiveros, M. A., 2003, Cerámica tardorromana de cocina de las Islas Baleares, Estudio arqueométrico,BAR Int. Ser. 1182, Oxford.
Fulford, M. G., e Peacock, D. P. S., 1984, Excavations at Carthage: The British Mission I.2, The Avenue du
President Habib Bourguiba, Salammbo, The pottery and other ceramic objects from the site, Sheffield.
Guiducci, G., 2003, Le forme della Pantellerian Ware, in Pantellerian Ware: Archeologia subacquea e
ceramiche da fuoco a Pantelleria (eds. S. Santoro Bianchi, G. Guiducci, e S. Tusa), 61-65, Palermo.
Martorelli, R., e Mureddu, D. (eds.), 2002a, Scavi sotto la chiesa di S. Eulalia a Cagliari, Notizie preliminari, Archeologia Medievale XXIX, 283-340.
Martorelli, R., e Mureddu, D. (eds.), 2002b, Cagliari, Le
radici di Marina, Dallo scavo archeologico di
S. Eulalia un progetto di ricerca, formazione e valorizzazione, Atti del Seminario (Cagliari, 27 marzo 2000), Cagliari.
Martorelli, R., Mureddu, D., Pinna, F., e Sanna, A. L., 2003, Nuovi dati sulla topografia di Cagliari in epoca tardoantica ed altomedievale dagli scavi nelle chiese di S. Eulalia e del S. Sepolcro, Rivista di Archeologia Cristiana LXXIX, 365-408.
Mezzanotte, L. M., 2006, Pantellerian Ware, in Archeologia urbana a Cagliari. Scavi in Vico III
Lanusei (1996-1997) (eds. R. Martorelli e D. Mureddu), 192-196, Cagliari.
Montana, G., Iliopoulos, I., e Giarrusso, R., 2005, Pantellerian Ware: new data on petrography, chemistry and technological properties, in LRCW I, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and
Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and
Archaeometry (eds. J. Mª Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigós e M. A. Cau Ontiveros), BAR Int. Ser. 1340, 425-435, Oxford.
Montana, G., Iliopoulos, I., e Tantillo, M., 2005, Establishing a "recipe" for Pantellerian Ware: raw materials field survey, analysis and experimental reproduction, in LRCW I, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean,
Archaeology and Archaeometry (eds. J. Mª Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigós e M. A. Cau Ontiveros), BAR Int. Ser. 1340, 437-450, Oxford 2005.
Peacock, D. P. S., 1982, Carthage and Cossyra: a ceramic conundrum, in Actes du Colloque sur la céramique
antique (Carthage 1980), Cedac Dossier 1, 91-98, Cartagine.
Peacock, D. P. S., 1997, La ceramica romana tra
archeologia ed etnografia (traduzione a cura di G. Pucci), Bari.
Pinna, F., 2003, Il corredo funerario nella Sardegna post-medievale: la cripta della chiesa di S. Eulalia a Cagliari, in Fonti archeologiche e iconografiche per la storia e la cultura degli insediamenti
nell’altomedioevo (ed. S. Lusuardi Siena), Atti delle giornate di studio (Milano-Vercelli 2002), Contributi di Archeologia 3, 313-325, Milano.
Pinna, F., 2005, Una produzione di ceramica comune nei siti tardo-antichi e altomedievale della Sardegna: note sui materiali decorati a linee polite dallo scavo di S. Eulalia a Cagliari, in LRCW I, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the
Mediterranean, Archaeology and Archaeometry (eds. J. Mª Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigós e M. A. Cau Ontiveros), BAR Int. Ser. 1340, 267-284, Oxford.
Reynolds, P. 1995, Trade in the Western Mediterranean, AD 400-700: The ceramic evidence, British Archaeological Report. Int. Ser. 604, Oxford.
Sangiorgi, S. 2005, Le ceramiche da fuoco in Sardegna: osservazioni preliminari a partire dai materiali rinvenuti nello scavo di S. Eulalia a Cagliari, in LRCW I, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology
and Archaeometry (eds. J. Mª Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigós e M. A. Cau Ontiveros), BAR Int. Ser. 1340, 255-266, Oxford.
Sangiorgi, S., c.s., Le ceramiche da fuoco in Sardegna: status quaestionis di una ricerca in corso, in Atti del
Seminario (Vercelli, giugno 2004) (ed. G. Cantino Wataghin), c.s.
Sangiorgi, S., e Cisci, S., 2003, Scavi archeologici nella chiesa di S. Eulalia a Cagliari, I Beni Culturali -
Tutela e valorizzazione XI-2, 7-11. Santoro Bianchi, S., 2002, Pantellerian Ware: aspetti
della diffusione di un ceramica da fuoco nel Mediterraneo occidentale, in L’Africa Romana, XIV, Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale:
geografia storica ed economia (eds. M. Khanoussi, P. Ruggeri, C. Vismara), 991-1004, Sassari.
Santoro Bianchi, S., 2003, Cronologia e distribuzione della Pantellerian Ware, in Pantellerian Ware:
Archeologia subacquea e ceramiche da fuoco a Pantelleria (eds. S. Santoro Bianchi, G. Guiducci, e S. Tusa), 66-70, Palermo.
Santoro Bianchi, S., 2005, The informative potential of archaeometric and archaeological Cooking Ware studies: the case of Pantellerian Ware, in LRCW I, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and
Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and
Archaeometry (eds. J. Mª Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigós e M. A. Cau Ontiveros), BAR Int. Ser. 1340, 327-339, Oxford.
S. Cara, S. Sangiorgi
332
Santoro, S., Guiducci, G., 2001, Pantellerian Ware a Pantelleria: il problema morfologico, in ReiCretariae Romanae Fautorum Acta 37, 171-175, Abingdon.
Villedieu, F. 1984, Turris Libisonis. Fouille d’un site
romain tardif à Porto Torres, Sardaigne, BAR Int. Ser. 224, Oxford.
Campioni da S. Eulalia C. forma quarzo anortoclasio pirosseno aenigmatite clasti 1 teglia M1 * *** ** ** vulcanite 2 teglia M2 * *** ** * vulcanite 3 teglia M1 Fig. 1,1 * *** ** ** vulcanite 4 teglia M1 * *** ** * vulcanite 5 coperchio * *** ** ** vulcanite 6 coperchio * *** ** * vulcanite 7 coperchio * *** ** * vulcanite 8 non id./fondo * *** ** * vulcanite 9 tegame * *** ** * vulcanite
10 tegame * *** ** * vulcanite 11 teglia M2 Fig. 1,3 * *** ** * vulcanite 12 teglia M1 Fig. 1,2 * *** ** ** vulcanite 13 tegame G2 Fig. 1,5 * *** ** * vulcanite 14 tegame G2 * *** ** * vulcanite 15 tegame G1 Fig. 1,4 * *** ** * vulcanite 21 teglia M1 * *** ** * vulcanite 22 teglia M2 * *** ** * vulcanite 23 teglia M2 * *** ** * vulcanite 24 tegame G1 * *** ** * vulcanite 25 non id./parete * *** ** * vulcanite 26 coperchio Fig. 1,6 * *** ** * vulcanite 27 coperchio L2 Fig. 1,7 * *** ** * vulcanite 28 coperchio L2 * *** ** * vulcanite 29 coperchio L1 * *** ** * vulcanite
C. forma quarzo plagioclasio k-feld biotite clasti 16 tegame *** * ** ** metamorfici
Campioni da Vico III Lanusei C. forma quarzo plagioclasio k-feld muscovite clasti 17 tegame *** ** ** ** metamorfici18 tegame *** ** ** ** metamorfici19 tegame *** ** ** ** metamorfici20 tegame *** ** ** ** metamorfici
Tabella I. Risultati dell’analisi mineralogico-petrografica. Stima semiquantitativa: *** molto abbondante; ** abbondante; * poco abbondante.
Ceramica grezza proveniente dalla città di Cagliari (Sardegna - Italia): attestazione di Pantellerian Ware
333
Ceramica grezza proveniente dalla città di Cagliari (Sardegna - Italia): attestazione di Pantellerian Ware
335
Ceramica grezza proveniente dalla città di Cagliari (Sardegna - Italia): attestazione di Pantellerian Ware
337