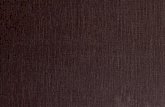Storia di un'industria di Stato. La siderurgia italiana: 1945-1980
Transcript of Storia di un'industria di Stato. La siderurgia italiana: 1945-1980
Introduzione
Partendo dalla situazione post-bellica italiana nel campo
industriale, più specificatamente nel settore siderurgico, il
saggio si pone il compito di analizzare, attraverso le diverse
politiche economico-industriali e le vicissitudini accumulatesi
nel corso del tempo, come questo settore industriale sia diventato
uno dei perni dell’economia di Stato che è direttamente produttore
di acciaio e, di come la società detentrice della gestione della
produzione, la Finsider, riesca a portare l’Italia in una
situazione quasi alla pari con il mercato siderurgico mondiale,
fino a sprofondare negli anni ’70, in una spirale disastrosa che
ha portato sino alla messa in vendita delle partecipazioni
statali.
I temi che si vogliono approfondire riguardano il dibattito sul
rilancio del ciclo integrale e il passaggio ad una nuova
impostazione tecnico-scientifica del lavoro. Queste tematiche
saranno descritte attraverso un’ analisi degli sforzi del governo
e dei suoi tecnocrati di svincolarsi dalle oscillazioni del
mercato cercando di ridurre le importazioni di scarti e di semi-
lavorati e di concentrare la maggior parte della filiera
produttiva in pochi centri siderurgici scelti in modo strategico.
Si vogliono inoltre affrontare le tematiche attorno allo scontro
tra le posizioni pre-fordiste della famiglia Falk e quelle
fordiste del gruppo Finsider impersonate da Oscar Sinigallia. Idee
che andranno, nel 1952, a formare le basi del famoso “Piano
Sinigallia”. Si passerà poi ad esaminare il Piano Finsider,
focalizzando l’attenzione sul progetto di Cornigliano, passando
1
prima però dall’analisi del ruolo svolto dagli Stati Uniti
nell’indirizzare le politiche siderurgiche italiane secondo uno
schema “americano”, attraverso un approfondimento prima sui metodi
di erogazione dei fondi Erp in Italia, poi sull’introduzione,
prima solo nel centro di Cornigliano, poi a tutti i centri Ilva-
Italsider, delle politiche di Job Analysis e Job Evalutation.
Il saggio vuole poi esaminare la situazione siderurgica europea
del dopoguerra, soprattutto il quadro franco-tedesco, dal quale
scaturirà il Piano Schuman che darà vita alla CECA; si cercherà
quindi di tratteggiare innanzi tutto le fasi che portarono alla
nascita dei primi trattati di cooperazione continentale e in
seguito alla CECA, per poi delineare la situazione italiana
all’interno dello scacchiere europeo e le circostanze che l’hanno
portata all’ingresso nella Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio, nonostante il suo ruolo ancora marginale nella
siderurgia continentale.
L’analisi continua tornando a focalizzarsi sulle le vicissitudini
della siderurgia in Italia, con particolare attenzione al
Mezzogiorno, che diviene il nuovo centro ove si vuole far
sviluppare l’industria dell’acciaio, dato che era diventato ormai
palese che, per soddisfare i consumi futuri, le capacità
produttive realizzate col Piano Sinigallia non sarebbero bastate.
Si analizzeranno quindi i temi dello Schema Vannoni per il
rilancio economico del Mezzogiorno assieme ai punti del nuovo
piano siderurgico ideato da Marchesi e i suoi punti in comune e le
sue divergenze con il Piano Sinigallia; si approfondirà in seguito
il dibattito che vedrà protagonisti molti industriali e politici
2
italiani riguardo al luogo e alle modalità di apertura e
produzione del IV centro siderurgico del paese.
Infine il saggio si pone il compito di capire la nascita degli
errori dell’ultimo periodo di gestione della produzione
siderurgica di Stato che ha portato fino alla scorporazione
dell’Iri e alla vendita ai privati delle partecipazioni statali.
Errori individuati per lo più nell’abbandono delle linee guida di
Sinigallia e Marchesi e nell’appropriazione di un nuovo modello
sia gestionale che produttivo degli impianti di marca giapponese e
non più americana, modello che non è riuscito a mettere radici nel
tessuto industriale italiano che ripose, dagli anni ’70 in poi
quasi tutte le sue speranze nel solo stabilimento tarantino.
3
1. Ricostruire gli impianti
1.1 Ricostruzione dell’industria siderurgica italiana nel
dopoguerra
La fine della seconda guerra mondiale, contro gli alleati, per il
Regno d’Italia avvenne l’8 settembre del 1943, ma la guerra nel
paese continuò per altri due anni. Il primo Maggio 1945, con la
resa delle truppe tedesche in Italia, la campagna d’Italia poté
definirsi conclusa. Il conflitto trasformerà l’Europa in un
continente esausto che da quel momento non sarebbe più stato il
centro economico, politico e culturale del mondo. L’Europa dovette
cedere il suo scettro alle due nuove superpotenze mondiali, gli
Usa e l’Urss. Così nel Luglio 1944 si tenne la conferenza di
Bretton Woods preposta a stabilire il nuovo modello di
regolamentazione degli scambi internazionali. L’accordo previde il
superamento del vecchio sistema definito gold standard per il nuovo
gold exchange standard che stabiliva la convertibilità del dollaro in
oro e l’assunzione dello stesso dollaro ad unità di scambio e di
riserva; vennero inoltre istituiti il Fondo Monetario
Internazionale per vigilare sugli scambi e la Banca Mondiale per
aiutare lo sviluppo dopo la guerra. <<A tale quadro di
regolazione, che sanciva la piena supremazia americana sugli
scambi internazionali, si opponeva un Europa in cui sia i4
vincitori che i vinti si presentavano esauriti dal punto di vista
economico e in profonda crisi istituzionale, dovendo, gli uni e
gli altri, provvedere a una radicale trasformazione della propria
struttura di regolazione economica. Gli sconfitti dovevano
abbandonare il protezionismo e la soverchiante presenza dello
Stato in economia […]. I vincitori-[…]- dovevano fare i conti con
la fine del colonialismo che aveva rappresentato la proiezione
globale della loro economia e della loro potenza politica.1>>
Il conflitto comportò naturalmente anche in Italia un grande vuoto
politico dovuto alla caduta delle istituzioni che avevano
governato per circa vent’anni. I danni invece non intaccavano
molto un apparato produttivo che si presentava in condizioni non
del tutto disastrose, nonostante la caduta del PIL dal 1938 al
1945 si assestasse attorno ai 45 miliardi. Il settore che
manifestava la situazione peggiore fu senz’altro quello agricolo
che vide buona parte del patrimonio arboreo e zootecnico andare
perduto e il ridursi, di circa il 50%, della produzione
cerealicola in confronto alla produzione prebellica2. Le attività
industriali erano invece quasi del tutto paralizzate, con una
produzione ridottasi nel 1945 a meno di un quarto del volume di
produzione del 1938-39. Non tutti i comparti naturalmente subirono
la stessa quantità di danni. Il settore industriale secondo il
rapporto CIR (Compagnie Industriali Riunite) ha riportato stime di danni
pari a circa 450 miliardi, con il settore siderurgico in testa che
registrò una diminuzione del 34% nella produzione dell’acciaio e
1 Bianchi P, La rincorsa frenata. L’industria italiana dall’unità nazionale all’unificazione europea, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 802 Amatori F., Colli A., Impresa e Industria in Italia. Dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editori, 1999, p. 193
5
del 67% di ghisa3. A subire i danni maggiori furono soprattutto i
centri a ciclo integrale dell’Ilva sul Tirreno, oltre all’impianto
di Cornigliano che venne privato dai tedeschi, durante la
ritirata, degli impianti migliori. L’industria siderurgica
italiana aveva toccato il suo picco produttivo nel 1938.
1.2 Dibattito sul rilancio del ciclo integrale e i primi
accordi transoceanici
Nonostante questo un forte dibattito critico impegnava i massimi
dirigenti della siderurgia sia di Stato che privata, anche prima
che la guerra, come visto, ne riducesse drasticamente le capacità
produttive. Il giudizio pressoché negativo fornito da Sinigallia
sulla siderurgia già negli anni Venti, sembrava ampliamente
condiviso, sia per i prezzi troppo elevati sia per la cattiva
qualità dei prodotti. A sostegno di questa valutazione si
aggiunsero nel dopoguerra anche i maggiori esponenti
dell’industria meccanica per la quale la siderurgia è situata a
monte del sistema produttivo, lamentandosi proprio della scarsa
qualità dei prodotti. Solo gli imprenditori siderurgici privati
difendevano la siderurgia per com’era, sottolineando l’alta
percentuale di acciai non comuni prodotti in Italia e negando che
la protezione doganale potesse avere conseguenze significative per
l’industria meccanica.
Queste posizioni antitetiche non facilitarono di certo la ripresa,
ma ci mostrano come le idee di Sinigallia, posto a capo della
3 Bianchi P., La rincorsa frenata. L’industria italiana dall’unità nazionale all’unificazione europea, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 55
6
Finsider nel 1945, fossero di derivazione fordista e roosveltiana.
Egli puntava cioè sulle grandi dimensioni degli stabilimenti e
sulla produzione di ampi lotti standardizzati per ottenere bassi
costi4 e riteneva che l’impresa pubblica si dovesse sostituire a
un’industria ormai incapace di impegnarsi in investimenti per lo
sviluppo dei settori di base. Quando la Finsider al termine del
conflitto inizia le operazioni di riassestamento e
riammodernamento della siderurgia di Stato individua le cause
dell’inferiorità italiana <<nell’esuberanza delle attrezzature
unita a un’inadeguata potenzialità delle singole entità
produttive, nell’eccessivo frazionamento delle fabbriche e
mancanza di specializzazione, nella cattiva organizzazione
dell’ambito commerciale […] nella prevalenza data in Italia al
processo di fabbricazione del rottame, anzi che dal minerale >>5.
Si volle seguire l’esempio dell’Armco (American Rolling Mill Corporation)
che per la Finsider divenne un vero e proprio modello d’azienda
offrendo ai suoi manager la possibilità di aggiornamento sia
tecnologico che metodologico. Racconta Osti <<Il fatto di aver
concluso quegli accordi con la Armco fu per noi molto importante.
Il primo accordo che facemmo fu di prenderli come consulenti per
il piano Marshall e questo, indubbiamente, fu decisivo per fa si
che ottenessimo i prestiti>> e continua ancora <<Con l’Armco
vennero stipulati accordi di consulenza un po’ con tutte le
società della Finsider, ma all’inizio il rapporto più stretto fu
senza dubbio con la Cornigliano. Io [Osti] andavo a Middeltown,
4 Balconi M, La siderurgia italiana. (1935-1990). Tra controllo pubblico e incentivi del mercato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 815 Amatori F, La storia d’impresa come professione, Venezia, Marsilio Editore, 2008, p. 199
7
Ohio, due volte all’anno. Conoscevo tutti i dirigenti>>6. Venne
abbandonato così il “modello tedesco” per quello “americano”; il
motivo principale, oltre all’organizzazione aziendale di tipo
verticistico e la produzione organizzata in conglomerati, fu il
fatto che proprio il controllo dei conglomerati era detenuto dalle
banche miste producendo così una rete di mercato governata da
pochi cartelli, lasciando pochissimo spazio all’azione
concorrenziale che i dirigenti Finsider volevano svolgere nei
confronti dei produttori privati. Il ciclo integrale era quindi
necessario sia per ottenere economie di scala sulle quali agire
sia per ottenere i bassi costi che avrebbero costituito il punto
di forza della siderurgia italiana.
L’industria privata era “capeggiata” dalla famiglia Falk,
portatrice però di idee pre-fordiste e convinta che l’industria
meccanica nazionale non si sarebbe potuta sviluppare come
consumatrice di prodotti di massa e che non ci fosse quindi spazio
per una siderurgia a ciclo integrale. La proposta era di tipo
misto, comprendeva cioè sia la ricostruzione che il
riammodernamento di determinati impianti e si chiedeva però
contemporaneamente un mantenimento delle barriere doganali per
proteggere i prodotti italiani, si prevedevano produzioni di
150.00-300.000 tonnellate annue. <<Basterebbero otto o dieci di
questi stabilimenti disseminati nelle zone più opportune dal punto
di vista energia, trasporto e mercato, per soddisfare i bisogni
italiani>>7 o ancora << L’industria siderurgica italiana dovrebbe
essere un’industria complementare, indispensabile per i bisogni6 Osti G. L., in Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p 57 Falk G., in Balconi M., La siderurgia italiana (1945-1990). Tra controllo pubblico e incentivi del mercato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 85
8
più minuti della Nazione, lasciando che i grandi acquisti della
produzione di massa, come rotaie ecc., possano venire dall’estero.
Se l’Italia fosse un paese a mire imperialistiche, come prima,
capirei la necessità di una grande siderurgia >>8 affermava
Giovanni Falk interrogato nel corso dell’inchiesta del Ministero
per la Costituente. L’industria siderurgica privata chiedeva anche
un ammodernamento e una ristrutturazione degli impianti esistenti
e il mantenimento delle barriere doganali per salvaguardare i
livelli di occupazione; sarebbe stato compito poi dell’Istituto
della temporanea importazione aggirare i dazi per non svantaggiare
i prodotti italiani. Al contrario, i dirigenti Finsider ritenevano
indispensabile il rilancio del ciclo integrale per ottenere quelle
economie di scala sulle quali operare e i bassi costi dei
lavorati. L’importazione delle materie prime inoltre non sembrava
essere un problema, perché avendo dovuto importare tutto il
materiale, l’Italia sarebbe stata in condizione di scegliere i
minerali e il carbone di qualità migliore. Questa preoccupazione
da parte della Finsider era già forte prima del conflitto perché
ci si accorse che con l’introduzione dei nuovi altiforni Martin,
in sostituzione dei vecchi Thomas, non sarebbe stato più
economicamente vantaggioso l’uso del rottame.9 Quindi la strategia
Finsider si basava sul minore costo dei materiali e i più alti
ricavi ottenibili dai sottoprodotti (che in Italia avrebbero avuto
un costo più elevato rispetto alla media europea, poiché si
trattava di prodotti importati) che avrebbero dovuto compensare il
costo elevato delle materie prime importate.
8 Falk G., in Amatori F., Colli A., Impresa e industria in Italia. Dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editore, 1999, p.2009 Amatori F, La storia d’impresa come professione, Venezia, Marsilio Editore, 2008, p. 145
9
1.3 Gli accordi tra Finsider e Fiat e procedura
d’erogazione dei fondi Erp
L’obbiettivo della ristrutturazione del sistema siderurgico non
puntava al rilancio sul mercato internazionale solo dei prodotti
della siderurgia ma anche dell’industria meccanica. In questo modo
anch’essa venne posta nella condizione di beneficiare
dell’ammodernamento degli impianti, dandole la possibilità di
entrare a far parte di un sistema produttivo di massa, impossibile
da sviluppare su un mercato ristretto come quello italiano10. Lo
stesso Sinigallia sostenne che la caduta del concorrente tedesco e
il basso costo della manodopera aprivano grandi prospettive per
l’industria italiana, in particolare il settore meccanico che
aveva per Sinigallia possibilità di esportazione sconfinate.
<<Occorre però che le industrie italiane sappiano riorganizzarsi
razionalmente, in modo da ridurre i loro costi di fabbricazione a
quelli che sono indispensabili per concorrere sul mercato
internazionale. È necessario inoltre potenziare e ammodernare
l’industria siderurgica, quale base essenziale, indispensabile per
l’industria meccanica, mettendola in grado di produrre acciai e
laminati agli stessi costi degli altri più importanti paesi
industriali.11>>
10 Balconi M., La siderurgia italiana (1945-1990). Tra controllo pubblico e incentivi del mercato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 9511 Catronovo V., L’Industria italiana dall’800 a oggi, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1980, p. 270
10
Fu la Fiat il settore meccanico più attivo, che con Valletta capì
subito che si doveva adeguare ai modelli e al mercato americano,
l’unico che offriva tecnologia, mezzi finanziari, possibilità di
accordi a lungo termine. In questo periodo infatti vennero riprese
una serie di iniziative e di accordi in merito alla produzione in
serie. Inoltre tra le due guerre le capacità della Fiat si erano
allargate in modo notevole e avevano posto l’azienda di fronte
alla necessità di incrementare il rifornimento di lamiere. Tutti
questi fattori diedero vita agli accordi siglati nel 1948 tra Fiat
e Finsider. L’accordo più importante impegnava la Fiat ad
acquistare una quota di laminati prodotti nello stabilimento di
Cornigliano, pari al 50% delle prime 200.000 tonnellate di
produzione; la Finsider dal canto suo si impegnava a fornire alla
Fiat i coils a prezzi di produzione. Con questi accordi la Fiat
diede l’opportunità di raggiungere e mantenere il livello minimo
critico di efficienza e ne ricavava in cambio una fornitura a
prezzi più bassi di quelli di mercato.12 Questi accordi vennero
siglati anche nell’ottica di poterli sfruttare come accreditamento
nei confronti dell’Eca ( Economic Cooperation Administration ), per
ottenere i fondi dell’Erp (European Recovering Program) o più
comunemente conosciuto come Piano Marshall, utili alla
ricostruzione di Cornigliano, progetto principale nell’idea di
ammodernamento della siderurgia italiana dei dirigenti Finsider.
Il comitato esecutivo del piano Marshall era formato da uomini
d’affari come il presidente della “General Eletric” Philip Reed,
il finanziere Bernard Baruch, il presidente della “Studebaker
Motocar” Paul G. Hoffman, che spingevano verso un’esportazione
12 Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 34
11
duratura del modello americano in Europa che consisteva in:
forniture di macchinari e materie prime e in concessione di
prestiti a tassi ridotti per l’acquisto di impianti che avrebbero
avuto come conseguenza un integrazione dei mercati, una produzione
di massa, la standardizzazione, un organizzazione scientifica del
lavoro ed alti salari. Amatori e Colli sottolineano come però ci
fosse bisogno da parte americana di una “rieducazione industriale”
dell’Europa. Infatti fu data molta importanza al grand tour in Usa
sia da parte degli imprenditori che dei tecnici e degli operai.
L’Erp si divideva su tre livelli decisionali: a Washington vi era
l’ECA deputata a prendere le decisioni finali. Le domande
nazionali invece dovevano essere presentate all’OECE
(Organizzazione economica di cooperazione europea ) a Parigi13. Il Piano si
fondava sui criteri di “self help” e di “mutual aid”; <<l’obbiettivo
era stimolare attraverso il Piano Marshall la cooperazione
economica tra gli europei occidentali, premessa fondamentale per
la creazione di un sistema economico euro-americano basato sul “free
trade”.14>>L’Italia redasse così il suo <<Programma di investimenti
nel settore industriale per il periodo 1948-52>>, inserito nel
<<Memoriale italiano per il programma a lunga scadenza>> che il
governo italiano presentò all’OECE per ottenere i fondi ERP. Il
programma prevedeva un investimento del 20% dei fondi disponibili
nel solo settore metallurgico; furono stanziati 252 milioni di
dollari su un totale di 980 milioni, di cui 199 per il solo
settore siderurgico; fondi che avrebbero portato ad un aumento
13 Amatori F., Colli A., Impresa e Industria in Italia. Dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio Editore, 1999, p 22214 Varsori A., Le origini dell’Europa comunitaria nel contesto internazionale, in AA.VV, (a cura di), La comunità europea del carbone e dell’acciaio(1952-2002), Padova, Cedam, 2004, p. 47
12
occupazionale solo dell’1% tra il 1952-53 rispetto al periodo
anteguerra15.
A livello internazionale questo stanziamento provocò grosse
polemiche. Sia l’Eca che l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) si
chiedevano se fosse giustificata una cifra tale dato che non
portava alcun contributo all’aumento effettivo dell’occupazione e
l’appoggio americano risultava indispensabile per l’attuazione del
piano. Particolarmente refrattari furono anche i delegati
francesi, che si spinsero sino alla richiesta di negare al
rappresentante italiano il diritto di entrare a far parte a pieno
titolo del Comitato Acciaio. Anche all’interno del paese vi erano
voci contrarie, soprattutto diverse fazioni all’interno dei
sindacati e dei partiti di sinistra che contestavano gli eccessivi
costi sociali del piano e il <<processo di concentrazione
monopolistica voluto dalla Finsider>> che si prefigurava anche
grazie alla spartizione dei fondi Erp proprio tra la Finsider, i
Falk e la Fiat, quest’ultima ritenuta unica beneficiaria del piano
che le dava il vantaggio di non doversi rifornire dal mercato di
prodotti siderurgici. Anche gli industriali privati, capeggiati
ancora dalla famiglia Falk, erano reticenti verso il progetto
proposto dalla Finsider, non si credeva infatti che la produzione
siderurgica italiana potesse superare 2 milioni e mezzo di
tonnellate annue e si credeva che una tale spartizione dei fondi
avrebbe portato ad una fuoriuscita dal mercato internazionale dei
prodotti dell’industria privata. A livello nazionale comunque,
secondo Valerio Castronovo, le reticenze mostrate dall’industria
privata risultarono vane perché <<l’industria pubblica svolse
15 Dati ECA in, Balconi M., La siderurgia italiana (1945-1990). Tra controllo pubblico e incentivi del mercato, Bologna, Il Mulino, 1991, p 88
13
un’opera determinante di sostegno e di integrazione allo sviluppo
dell’industria privata. Alleviata dai rischi e dai pesanti impegni
tecnici e finanziai di lungo periodo, connessi alla realizzazione
di infrastrutture e di economie esterne essenziali per
l’incremento della produttività generale del sistema economico, e
avvantaggiata, nello stesso tempo, dalle condizioni favorevoli
assicurate dagli investimenti della mano pubblica nei settori di
base e nei beni capitali, l’industria privata poté ingranare una
marcia più alta che in passato e orientare con maggior sicurezza i
suoi programmi, sia in termini strutturali che in termini di
redditività.16>>
Grazie alla titolarità dell’ordine Fiat, la Finsider ebbe un’arma
in più da far valere nei confronti dell’Eca. Era comunque
difficile, ricorda Ranieri ricostruendo l’intervista ad Osti, che
le richieste di un paese venissero bocciate a Parigi, perché le
decisioni erano prese in modo unanime e ciò avrebbe dato vita ad
un effetto domino che non avrebbe risparmiato nessuno. Nonostante
questo vi erano molte riserve nei confronti del piano italiano.
Oltre alle riserve europee bisognava far fronte a quelle oltre
oceano; a Washington vi era infatti il livello superiore della
rappresentanza dell’Eca. Fu qui che la Finsider cercò di fare più
pressioni data l’immagine negativa dell’ente in USA, in quanto si
trattava di un ente statale. Nel Gennaio del 1949 la commissione
dell’Eca a Roma boccia il progetto di Sinigallia.
Il gruppo dirigenziale Finsider riuscì comunque a superare
l’empasse grazie alla “carta Armco-Artur McKee” molto influente in
16 Castronovo V, L’Industria italiana dall’Ottocento a oggi, Milano, Arnolodo Mondadoro Editore S.p.A., 1980, p 291
14
America, soprattutto all’Eca. Gian Lupo Osti ricorda infatti che
<< gli accordi fatti da noi con l’Armco furono molto importanti
per superare le resistenze americane ai nostri progetti, in quanto
loro avevano un notevole peso, specie nell’Amministrazione
repubblicana. Le [Ranieri] faccio l’esempio di George Verity, che
era allora un giovane dirigente – aveva la mia [Osti] stessa età –
di cui divenni amico personale e che poi, in anni molto recenti, è
stato ministro del commercio nell’Amministrazione Regan.[…]. Sia
nell’Eca che nello State Department, l’Armco riusciva a dire la
sua ed era ascoltata. A parte i petrolieri, l’Armco era una delle
poche grandi aziende Usa che avesse sempre avuto una sua presenza
sui mercati internazionali.17>> La corporazione americana così
produsse due rapporti nel 1949 che avvallarono a pieno il piano
Finsider. L’altra arma fu naturalmente l’accordo siglato con la
Fiat che avrebbe dovuto assicurare il finanziamento minimo
richiesto. L’idea di un’espansione verso i consumi di massa fu
l’argomento più convincente per gli USA. Infatti il Country Study
dell’Eca aveva criticato proprio la mancanza di una politica
economica espansiva e i funzionari che avevano steso il rapporto
furono gli stessi che esaminarono i progetti Fiat nel 1949, dando
il via alla concessione dei crediti all’azienda, che portò di
conseguenza all’approvazione in toto del piano Finsider.18
Secondo Franco Amatori e Andrea Colli i governi italiani, le forze
politiche che li sostenevano e anche i manager pubblici non erano
in grado, e non erano neanche nella posizione, di contrastare la
forte influenza americana che diventò sempre più pressante dalla
17 Ranieri R, L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p 14418 Ibidem, p.38
15
fine del secondo conflitto mondiale. Perché gli Stati Uniti
diventarono per l’Italia l’unico “alleato forte” di cui il paese
non poté, col tempo, più fare a meno. <<Al termine del secondo
conflitto mondiale gli Stati Uniti detenevano una posizione di
assoluta supremazia economica potendo vantare una produzione
industriale più che doppia rispetto all’Europa, mentre il valore
commerciale delle esportazioni risultava quintuplicato in
confronto all’anno precedente l’entrata nel conflitto. Era
tuttavia viva nel Governo e in vasti settori della classe
dirigente americana la consapevolezza del fatto che senza una
vigorosa ripresa dell’economia europea sarebbe stata molto
probabile la ricaduta in una devastante crisi da
sovrapproduzione.19>>
Fu per questo che l’Eca nel fornire le direttive all’Italia per la
pianificazione postbellica spinse per l’attuazione di due
possibili strade da intraprendere: una che passava attraverso la
pianificazione dell’organizzazione del “fondo lire”, allo scopo di
rafforzare la riserva valutaria e tenere sotto controllo
l’inflazione; l’altra strada invece prevedeva l’attuazione di una
manovra keynesiana di sostegno alla domanda attraverso un
impegnativo programma di investimenti pubblici. E fu intrapresa,
come visto, la strada che passava attraverso la manovra
keynesiana. Anche la Finsider dovette passare attraverso questo
passaggio obbligato che però le permise col tempo di attuare la
maggior parte dei punti cardine presenti nelle idee di Sinigallia
dando così vita <<al modello fondato sulle grandi dimensioni,
sulla fluidità del ciclo produttivo, sul completo monitoraggio
19 Amatori F. Colli A., Impresa e Industria in Italia. Dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 1999,p. 221
16
della fabbrica. Per concretizzarne le potenzialità non bastava
disporre di costosissimi macchinari, occorreva apprendere nuove
tecniche organizzative e metodi di controllo […].20>> e fu proprio
così che si fece almeno alla Finsider e alla Fiat perché in linea
generale Amatori e Colli notano come <<la fragilità della
situazione economica e la disomogeneità delle forze politiche che
guidano il paese nel dopoguerra fanno sì che in Italia non venga
realizzata un’ampia strategia di piano, neanche su sollecitazione
dell’ “alleato forte”. Il massimo che il Governo riesce ad attuare
è una politica deflattiva che rafforza il sistema economico in
vista di una ripresa della competizione internazionale e che crea
le condizioni per una stabilità sociale maggiore rispetto
all’accidentato percorso postbellico. Tuttavia le imprese
interessate a cogliere le opportunità dell’americanizzazione
seppero perseguire un loro disegno anche all’esterno del Paese
quale appare dai contatti di Valletta negli Stati Uniti e
soprattutto dall’azione della Finsider che nell’intricata vicenda
ora descritta mostra le capacità di muoversi come una potente
lobby. E l’appoggio di De Gasperi a Sinigallia in frangenti
decisivi rivela che il Governo pur non disponendo di un’organica
visione industriale seppe riconoscere i reali interessi della
nazione.21>>
TAB. 1. Programma di investimenti nel settore industriale nel periodo 1948-195222
Investiment Aumento Produzione Capitale
20 Ibidem, p. 22721 Ibidem, p. 22722 Balconi M., La siderurgia italiana (1945-1990). Tra controllo pubblico e incentivi del mercato, Bologna, Il Mulino, 1991
17
i
1948-52(1)
dell’occupa
zione nel
1952-53
rispetto al
periodo
prebellico(2)
ipotizzata
al 1952-53
(1938=100)
investito
per addetto
nel 1939(3)
Industrie
manifatturiere
e minerarie:
Meccanica 233 125 150 1880
Metallurgic
a
252(4) 1 130 4750
Tessile 226 47 125 1690
Alimentare 38 22 108 1860
Chimica 67 28 140 6750(5)
Estrattiva 37 20 125 3410
Materiali
da
costruzione
20 40 153 2040
Varie 109 75 120-30 4590
Totale 982 358 - 2230 (1)Dati in milioni di dollari 1948; (2) Migliaia di unità; (3) In dollari 1948; (4) Di cui 199 per la sola siderurgia;(5)Compresa
la raffinazione del petrolio
Fonte: ECA [1949].
18
TAB. 2. Occupazioni del gruppo Finsider in siderurgia ( 000 unità ) e andamento della produttività (
t/addetto ) 1945-4723
1945 1954 1955 1956 1957
Occupanti 45,2 42,4 43,9 46,1 48,5
Produttività(1) 22,9(2) 47,8 62,1 63,7 71,6 (1)Rapporto tra la produzione di acciaio e gli occupanti in siderurgia; (2)Valore corretto per l’anno 1945, nel quale la
produzione fu bassissima a causa dei danni bellici, considerando al numeratore il valore della produzione del 1938,
massimo prebellico
Fonte: Finsider, Relazione annuale, Anni vari.
23 Ibidem, p 9719
TAB. 3. Domande presti ERP approvate dall’IMI-ERP (al 30 giugno 1949, $/000)24
Settori N. Domande Importo % Totale
Siderurgico 12 41089 26,27%
Meccanico 42 28284 18,08%
Petrolifero 5 20000 12,79%
Elettrico 4 17400 11,12%
Chimico 8 10660 6,82%
Tessile 37 10394,8 6,65%
Aeronautico 2 9000 5,75%
Elettromeccanic
o
25 5372 3,43%
Minerario 10 3444 2,2%
Carta 8 3034 1,94%
Telecomunicazio
ni
8 2045 1,31%
Editoriale 27 1739,5 1,11%
Gomma 3 1320 0,84%
Calce e Cemento 2 890 0,57%
Ceramica e
Vetro
5 675 0,43%
Metalmeccanico 1 650 0,42%
24 Amatori F. Colli A., Impresa e Industria in Italia. Dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 1999,p. 229
20
Varie 5 307 0,2%
Alimentare 1 90 0,06%
Pelli-Cuoio 1 12 0,01%
Navale - - -
Totale 206 156406,3 100,00%Fonte:CIR-ERP, Relazione
2. Piano Sinigallia e nuovi modelli industriali
2.1 Il Piano Sinigallia e la ricostruzione di Cornigliano
Grazie ai fondi erogati si poté dare il via al <<Piano di
Ricostruzione e di Razionalizzazione degli stabilimenti
siderurgici della Finsider>> o più comunemente <<Piano
Sinigallia>>. L’idea alla base del piano era rifornire l’Italia di
prodotti e semilavorati necessari a costi competitivi sul mercato
internazionale, prodotti in pochi centri strategici situati per li
più sulle coste del paese; non si pensò mai, come ricorda anche
Osti, a un piano per l’esportazione <<D’altra parte sarebbe stato
ridicolo pensare di affermarci sul campo delle esportazioni con
21
prodotti che restano, in molti casi, dei semilavorati. […] d’altra
parte bisogna anche dire che gli americani, nelle discussioni del
piano Marshall, non avrebbero accettato un’impostazione che
prevedesse larghe esportazioni.>>25
Punto focale del piano fu il rifacimento di Cornigliano
smantellato dai tedeschi durante la ritirata, che sarebbe stato
riorganizzato e gestito da una società autonoma, la Cornigliano
Spa, dove si sarebbe dovuta accentrare la produzione dei prodotti
piatti con una grossa acciaieria d’altoforno basata sulla carica
liquida, oltre all’aumento di specializzazione dei centri a ciclo
integrale di Piombino, dove si prevedeva di accentrare le
lavorazioni dei prodotti lunghi e Bagnoli prevalentemente per
l’industria edilizia. Gli stabilimenti secondari, ricorda Osti,
vennero però solamente aggiornati: << Siac e Terni sostanzialmente
restarono inalterate senza una reale revisione strategica né di
compiti loro assegnati, né delle loro linee di produzione.
Piombino mantenne le sue specializzazioni che erano,
sostanzialmente, travi e rotaie. >>26. L’innovazione più importante
fu quella di un treno semicontinuo per coils a Cornigliano.
Sinigallia cercò soprattutto di abbassare i costi delle materie
prime per l’industria meccanica, dato che il settore si apprestava
a raggiungere un ruolo di traino dell’economia italiana.
L’impianto di Cornigliano entrò in funzione nel 1953 e già nel
1960 produceva il 17% della produzione nazionale di acciaio, il
50% di laminati piani a caldo e il 41% dei laminati piani a
freddo. L’utile netto superò sia nel 1959 che nel 1960 i tre
25 Osti G. L. ,in Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, 11826 Ibidem, p. 120
22
miliardi e mezzo di lire27. Sul finire degli anni ’50 diventa
l’impianto a ciclo integrale con la maggior capacità produttiva di
ghisa e acciaio grazie al nuovo procedimento Martin, ma il settore
più caratterizzante è quello della laminazione: << delle 29.000
tonnellate mensili di nastro a freddo mediamente prodotte, 18.000
circa sono destinate a essere lamierino utilizzato nell’industria
automobilistica, degli elettrodomestici , dei mobili metallici,
ecc., e 6000 latta. […] >>28
TAB. 4. Capacità produttiva della ghisa, dell’acciaio e dei laminati negli stabilimenti di Cornigliano,
Bagnoli, Piombino. Anno 195929
ALTIFORNI A COKE
N. unità Capacità produttiva
giornaliera in
tonnellate
Cornigliano 2 1600
Bagnoli 4(1) 2400
Piombino 3(2) 2400
(1)Il quarto altoforno capacità produttiva giornaliera di 1200 t non è ancora
in funzione; (2) Il terzo altoforno della capacità produttiva giornaliera
di 900 t non è ancora in funzione
FORNI MARTIN
N. unità Capacità per colata in
tonnellate (ciascuno)
27 Dati in, Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 199328 Amatori F, La storia d’impresa come professione, Venezia, Marsilio Editore, 2008,p. 16329 Ibidem, p 159
23
Cornigliano 6 250
Bagnoli 4 73
Piombino 2 180
Piombino 3 160
CONVERTITORI (THOMAS)
N. unità Capacità per colata in
tonnellate (ciascuno)
Cornigliano - -
Bagnoli 4 26,5
Piombino - -
LAMINATOI A CALDO
Bloomin
g
Sbozzato
ri
Vergell
a
Profila
ti
Lamiere Nastro
strett
o
Nastro
largo
Corniglia
no
1 - - - 1 - 1
Bagnoli 1 1 1 4 - 1 -
Piombino 1 - - 3 - - -
LAMINATOI A FREDDO A LAMIERINI
N. unità
Cornigliano 2
Bagnoli -
24
Piombino -Fonte: Repertorio Assider, Milano, 1959
A Cornigliano vi erano sia alcuni tra i migliori manager, arrivati
grazie al << Piano Autartico >>, che portò qui tra i migliori
manager privati, sia le migliori maestranze d’Italia grazie alla
creazione a Genova, nel 1936, da parte sia della SIAC (Società delle
acciaierie di Cornigliano) che dell’Ansaldo, della scuola per apprendisti
più grande della penisola. Anche il Piano di Oscar Sinigallia
aveva simili fondamenta, poiché il punto centrale del programma
era proprio la <<specializzazione degli impianti, che avrebbe
permesso l’accesso ad economie di scala, a cui doveva
corrispondere un analogo processo di specializzazione delle
mansioni operaie, chiave per accrescere la produttività e, quindi,
i salari.30>> Cornigliano verrà costruita secondo il modello delle
grandi imprese americane; non poteva in effetti non essere così
dato che i fondi erogati dall’Erp erano stati ottenuti proprio
grazie alle pressioni effettuate dall’Armco, società in stretta
collaborazione con la Finsider e la Fiat, alla sede centrale
dell’Eca a Washington solo pochi anni prima. Il modello era quello
delle “large corporation” con una << U Form>>. Il management centrale
aveva cioè il compito sia di controllare sia di agire servendosi
di quadri intermedi ben strutturati; le operazioni aziendali, in
linea con le idee di Sinigallia, sfruttavano le economie di scala
con una stretta integrazione fra produzione e distribuzione.
TAB. 5. Produzioni del gruppo Finsider-1953-57 (000 t)31
30 Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 33
25
Minerali di
ferro
Ghisa Acciaio Laminati a
caldo
1953 600 832 1566 1120
1954 658 940 2029 1500
1955 1081 1257 2725 2135
1956 1326 1504 2936 2348
1957 1282 1699 3473 2791Fonte: IRI, Relazione annuale, anni vari
TAB. 6. Quote produttive del gruppo Finsider sul totale nazionale32
Ghisa Acciaio Laminati a
caldo
1938 77 44 38
1952 66 44 43
1957 82 51 55Fonte: IRI, Assider
2.2 Americanizzazione del sistema industriale
Con l’esperienza di Cornigliano si darà il via ad un’ innovazione
nei confronti dell’organizzazione del lavoro; attraverso l’
allineamento con le politiche di stampo americano, muterà verso il
modello oltre oceanico anche il modo di concepire l’
31 Balconi M., La siderurgia italiana (1945-1990). Tra controllo pubblico e incentivi del mercato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 9632 Ibidem, p 97
26
organizzazione lavorativa secondo il modello descritto da Taylor;
un modello che si poneva in modo completamente opposto da quello
attuato fino ad allora in Italia e che si basava su tre punti: a)
capacità del dirigente di raccogliere tutte le nozioni, possedute
fino ad allora da una classe operaia di tipo specializzato e di
classificarle per poterle esplicitare in semplici regole; b)
concentrare tutto il lavoro intellettuale nell’ufficio di
programmazione e progettazione; c) programmare in anticipo la
giornata dell’operaio nell’azienda in modo che esso sapesse “sia
cosa vada fatto sia come si debba fare”. Questo tipo di
organizzazione del lavoro è definita “organizzazione scientifica
del lavoro”, proprio perché la classe dirigenziale, ove è fatta
concentrare tutta la gestione dell’azienda, dalla programmazione
alla lavorazione sino alla distribuzione, organizza in modo
“scientifico” la giornata dell’azienda senza escludere il minimo
particolare. Questo perché nel nuovo stabilimento di Cornigliano
l’obbiettivo era l’aumento sia della qualità che della quantità
dei prodotti con conseguente aumento della velocità del ciclo
produttivo, che fa sì che la << variabile organizzativa divenga
per la nuova dirigenza una variabile di tipo critico33.>>
Franco Amatori nota però, seguendo uno studio effettuato nel 1953
dalla sociologa industriale Joan Woodward nel South Essex
sull’assetto organizzativo di 203 aziende, che << il successo
economico di un’impresa non dipende tanto dall’attenersi ai
dettami dello scientific management, quanto piuttosto dall’adeguare
l’organizzazione all’area tecnologica a cui l’azienda appartiene
33 Amatori F., La storia d’impresa come professione, Venezia, Marsilio Editori, 2008, p. 124
27
>>34. Dalla ricerca della Woodward emergono tre grandi
raggruppamenti dei sistemi produttivi; secondo Amatori l’industria
siderurgica a ciclo integrale è collocabile nel raggruppamento che
include le aziende con una <<produzione di processo in cui sono
considerate le produzioni intermittenti di prodotti chimici e la
produzione a ciclo continuo35>> al quale corrisponde un modello di
organizzazione non di tipo scientifico bensì un’organizzazione per
unità operative. Questo perché << il processo di fabbricazione
dell’acciaio, […], arriva al prodotto finito, […], dopo essere
passato attraverso la fabbricazione nell’altoforno della ghisa e
l’affinazione di quest’ultima mediante la riduzione della
percentuale di carbonio e rimozione delle impurità in
convertitori, o in forni Martin-Siemens, o in forni elettrici. Il
ciclo produttivo presenta quindi una serie di trasformazioni poste
in sequenza rigida con la tendenza a ridurre al minimo le
discontinuità e la necessità di coordinamento tra le unità
operative risulta essere di primaria importanza>> in quanto << […]
la fermata non programmata di un solo settore può interrompere il
ciclo provocando perdite di produzione degli impianti che sono per
la loro complessità estremamente sensibili alle irregolarità di
marcia.36>> Ma questa strada non verrà mai intrapresa, anzi per
Amatori << l’esperienza di Cornigliano nel secondo dopoguerra
costituisce forse l’esempio più rilevante in Italia di stretta
collaborazione teorico pratica con il mondo industriale americano
per il quale, nonostante tutti i tentativi di revisione, il
34 Ibidem, p 12635 Ibidem, p 12736 Ibidem, p 128
28
paradigma tayloriano resta il punto di riferimento
fondamentale.37>>
Sarà proprio a causa di questa stretta collaborazione con gli Usa
che per il management di Cornigliano il documento della Booz
Allen-Hamilton diverrà la linea guida per tutti gli anni ’50. Nel
documento sono riassunti tutti i principi essenziali dello scientific
management: definire chiaramente gli obbiettivi dell’azienda;
stabilire i canali di autorità; determinare l’ampiezza del
controllo di modo che quanto maggiore è la complessità delle
operazioni o il grado di interdipendenza, tanto minore deve essere
il numero dei dipendenti che fanno capo a un superiore; realizzare
un tipo di decentramento per cui il potere di decidere e di agire
entro i limiti dei piani, delle linee di condotta e delle
direttive approvate, compatibilmente con il principio dell’unità
di direzione, sia il più vicino possibile al punto dove sorge la
necessità di decisione e d’azione; strutturare l’organizzazione
per funzioni produttive precisando tuttavia per iscritto la
posizione di ogni membro nell’organizzazione; affiancare uno staff
di specialisti alla << linea >> di esecutori, tenendo sempre
presente però il principio della responsabilità personale e non
collettiva e il fatto che lo staff << raccomanda >> e la linea <<
comanda >>; ricercare il principio della perpetuazione
dell’organizzazione così che gli inferiori siano in grado di
esercitare immediatamente il ruolo dei superiori.38
37 Ibidem, p 13338 Booz Allen Hamilton, Schema di lavoro per una revisione organizzativa dell’azienda in, Amatori F, La storia d’impresa come professione, Venezia, Marsilio Editore, 2008, 153
29
2.3 Job Analysis e Job Evaluation a Cornigliano
Si introdusse sempre negli anni ‘50, prima alla Cornigliano per
poi estenderlo a tutte le industrie Italsider dopo la fusione
degli anni ’60 con la Cornigliano Spa, l’ applicazione di un nuovo
sistema atto ad analizzare e descrivere il contenuto dei lavori e
a determinare il valore relativo in una corrispondente scala di
valutazione. Questo sistema verrà studiato negli Usa da un equipe
di tecnici Finsider mandata nel 1952 all’Armo Steel Company e
porta il nome di Job Analysis e Job Evaluation. Franco Cai ricorda
però come negli Usa il 13 gennaio 1947 si era pervenuti a un
accordo nazionale: <<scopo fondamentale dell’accordo sulla Job
Evaluation fu quello di eliminare le ingiuste diversità di
retribuzione (wage rate inequities) cercando di applicare il principio,
fortemente sostenuto dalle organizzazioni sindacali, della stessa
paga per lavoratori simili (equal pay for similar work) non solo
all’interno di uno stabilimento, ma anche per tutta l’industria
siderurgica nazionale. In realtà l’accordo fu più conosciuto come
inequities agreement che non come nuovo contratto basato sulla Job
Evaluation.39>>
Il sistema che venne scelto aveva il nome di Basic Steel, ma venne
utilizzata la variante prodotta dall’Armco Steel Company. Il Basic
Steel era un sistema analitico di punteggio che si basava su
fattori di valutazione e ponderazione prestabilita, suddivisi in
gradi d’intensità a progressione non lineare; la variante
dell’Armco prevedeva ventiquattro classi anziché trenta e
39 Cai F., L’esperienza italiana nella Job Evaluation. Il caso Italsider, in AA.VV. (a cura di), Ascesa e Crisi del riformismo in fabbrica, Bari, De Donato Editore, 1976
30
un’ampiezza non costante degli intervalli di classe. Questo
sistema sarà così esteso a tutto il personale operaio tra il 1953-
54, portando alla sostituzione delle <<paghe di posto>> degli
operai e delle <<paghe di qualifica>> del personale dei servizi;
nel 1955-56 verrà esteso anche agli impiegati e alle categorie
speciali e sarà applicato in maniera unilaterale dalla Cornigliano
Spa40.
Secondo Franco Cai i motivi che portarono all’introduzione di un
sistema di analisi e valutazione del lavoro (AVL) furono
principalmente quattro: a) il personale dello stabilimento
proveniva sostanzialmente dalla scuola o dal mercato del lavoro
del primo impiego, da altre industrie siderurgiche del gruppo
Finsider, da altri settori industriali, dal settore terziario e
dall’artigianato; ciò avrebbe comportato una differenziazione
troppo elevata delle retribuzioni che sarebbe divenuta in poco
tempo incomprensibile, inoltre, nacque l’esigenza di analizzare il
fenomeno e di introdurre criteri per creare un assetto retributivo
più equo ed ordinato; b) nella siderurgia operante esistevano due
criteri d’inquadramento e retribuzione del personale: le <<paghe
di posto>> e le <<paghe di qualifica>> e questa divisione
comportava problemi di confrontabilità ed equità: c) la struttura
retributiva degli altri stabilimenti siderurgici aveva un assetto
particolare: paga di base inferiore al 50% della retribuzione; il
complemento al 100% era costituito dal cottimo e da indennità
particolari; d) avendo la direzione della società investito così
tanti capitali per realizzare l’impianto ultra moderno di
Cornigliano, non ci si poteva non accorgere che c’era il bisogno
40 Amatori F., La storia d’impresa come professione, Venezia, Marsilio Editore, 2008, p. 140
31
di impostare il problema dei rapporti di lavoro su basi più
solide41.
Le reazioni del personale furono inizialmente positive perché il
sistema retributivo risultava essere più favorevole di quello
delle altre industrie peninsulari. I primi problemi sorsero per
mancanza d’informazioni e conoscenze del nuovo sistema, così << si
cercò di ovviare al problema diffondendo una serie di fascicoli
esplicativi, addestrando alcuni membri delle Commissioni interne
all’uso del Manuale di valutazione ed accettando una serie di
discussioni tra esperti AVL ed operai assistiti dai loro capi
operativi. 42>>; sempre Cai nota come << un equilibrio abbastanza
soddisfacente si raggiunse solo quando […] ci si rese conto in
pratica che la Job Evaluation poteva consentire una promozionalità
(passaggi definiti a lavori di classe superiori) per lo meno pari
a quella ottenibile con l’inquadramento tradizionale.43>>
Gian Lupo Osti che nel Gennaio del 1955 divenne Segretario
generale della Cornigliano Spa. ricorda che <<lo stabilimento di
Oscar Sinigallia nacque sulla falsa riga degli stabilimenti Armco
e quindi anche per gli organici copiammo gli schemi americani. Per
ogni posto di lavoro c’era una descrizione molto precisa di tutte
le mansioni affidate. Ogni mansione veniva quindi valutata sulla
base di regole precise. La valutazione portava ad un punteggio ed
è in base al punteggio che veniva stabilita la paga (paga di
posto). Tenuto conto degli accordi sindacali in essere, ogni posto
veniva poi inquadrato nelle classi o categorie sindacali
41 Cai F., L’esperienza italiana nella Job Evaluation. Il caso Italsider, in AA.VV. (a cura di), Ascesa e Crisi del riformismo in fabbrica, Bari, De Donato Editore, 1976, p. 3042 Ibidem, p 3443 Ibidem, p 34
32
confacenti.44>> Ricostruendo l’intervista ad Osti si può forse
fornire un’analisi da un punto di vista interno alla Cornigliano
riguardante i giudizi nei confronti dell’introduzione di questo
modello made in Usa. Il Segretario generale della Cornigliano
giudica almeno inizialmente in modo abbastanza positivo l’evento,
motivo di tale valutazione fu principalmente l’abolizione delle
paghe <<che non trovavano riscontro in quel che l’operaio faceva
realmente>> il mutamento delle paghe per quei lavori nei quali era
mutuata, rispetto al passato, la responsabilità e l’impegno fisico
e nervoso e in ultimo l’abolizione di quei posti di lavoro <<che
addirittura non avevano più ragion d’essere ma che, in un modo o
nell’altro, i sindacati erano riusciti a mantenere.45>> Con
l’introduzione del sistema Armco di Job Evaluation e Job Analysis
invece tutto venne studiato da zero prendendo spunto da come si
svolgeva negli Usa. <<In definitiva Cornigliano poté partire con
organici ben studiati e calibrati, con posti di lavoro definiti e
descritti in modo preciso e con paghe che avevano riscontro nelle
mansioni svolte da ciascuno.46>> Con l’estensione del sistema a
tutti gli impiegati Osti riscontra gli stessi problemi emersi
dall’analisi di Franco Cai, questo perché per gli impiegati, al
contrario che per gli operai per i quali basta una descrizione
delle attività manuali, <<bisogna fare riferimento invece, per
fare un esempio, a studi e a relazioni>> che risultano più
difficili da descrivere e valutare <<a parte il fatto che uno
studio, una relazione, possono essere fatti meglio o peggio e non
possono essere valutati come avviene per la produzione, in base a
44 Osti G. L., in Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 17245 Ibidem, p. 17346 Ibidem, p. 173
33
criteri assolutamente oggettivi: tanto di prima, tanto di seconda
scelta e tanto di scarto. In definitiva l’analisi e la valutazione
del lavoro si rivelò abbastanza presto soggetta agli stessi
fattori personali dei sistemi tradizionali: il giudizio e la
valutazione del capo restavano basilari.47>>
TAB. 7. Esempio di valutazione del lavoro a Cornigliano48
Fattore Motivazione Grad
o
Valor
e
Requisiti
professiona
li
Requisiti
intellettuali
richiesti per
l’esecuzione
del lavoro
Sorvegliare il
funzionamento di impianti
complicati (forno Martin
basico da 200÷220 t)al fine
di produrre vari tipi di
acciai di specificate
caratt. chimico-fisiche.
Programmare nei dettagli lo
svolg. di lavori complicati
C 1.0
Tempo
occorrente per
l’acquisire
l’addestr. e
l’esperienza
necessaria
Da 31 a 36 mesi G 2.4
Capacità
intell.
Programmare e dirigere le
operaz. del forno in modo
da creare le adatte
E 2.8
47 Ibidem, p. 18048Cai F., L’esperienza italiana nella Job Evaluation. Il caso Italsider, in AA.VV. (a cura di), Ascesa e Crisi del riformismo in fabbrica, Bari, De Donato Editore, 1976, p.51-52
34
condizioni chimico-fisiche
per le aggiunte, la
formazione della scoria e
l’affinazione della colata
Abilità manuale Manovrare macchina (Blow-
Knox Gunchrome) per il
lancio di materiali
refrattari, usare la lancia
dell’ossigeno, manovrare
pale, cucchiaio per
provini, barre di ferro,
ecc…
B 0.5
Responsabil
ità
Responsabilità
per i materiali
Accurata attenz. e continui
controlli richiesti per
mantenere la giusta
condotta del forno.
Mancanza di attenz. e
controllo può portare alla
declassicaz. delle colate.
Costo stimato 1.125.000.
D 5.3
Respons. per
utensili,
attrezzature e
macchinari
Elevata attenzione e cura
richiesta per evitare danni
alla volta, alle pareti e
alla suola del forno
E
Max
3.0
Respons. per il
lavoro
Responsabile della
continuità delle operazioni
e del grado di
utilizzazione della
produttività di un forno
F 4.0
35
Martin da 200÷220 t
Respons. per la
sicurezza
altrui
Elevata attenz. richiesta
per evitare infortuni ad
altre persone perché
responsab. di un impianto
che produce metallo fuso
con pericolo di esposiz. a
spruzzi di metallo,
fiammate
D 1.2
Sforzi Sforzo mentale
e visivo
Considerev.
sforzo mentale e visivo
richiesto per dirigere la
carica, condurre e
osservare le fusioni,
esaminare i provini,
effettuare le aggiunte per
ottenere una buona finitura
della colata
D 1.5
Sforzo fisico Moderato sforzo fisico per
spalare materiali
refrattari, adoperare barre
di ferro e lancia
dell’ossigeno
C 0.8
Condizioni
di lavoro
Ambiente di
lavoro
Esposizione ad elevate
temperature per
considerevoli intervalli di
tempo, e leggere esalazioni
di gas e fumi nocivi; e
D 1.2
36
forti luci abbaglianti
Rischi Lavorare dove il rischio di
infortunio è elevato
D 1.2
Note: 225t x 5000 L.= 1.125.000 L. 5 al kg di declassamento medio
3. Gli accordi agli albori della comunità europea
3.1 Fondazione della Ceca
Nel 1941 due antifascisti, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, al
confino sull’isola di Ventotène scrissero un documento avente come
titolo <<Per un Europa libera ed unita. Progetto d’un manifesto>>.
Si tratta del primo documento che spiega le necessità di un’Europa
unita in modo federalista, con una moneta unica, un esercito unico
ed una politica estera unica. Questo manifesto è considerato
adesso il testo fondante l’Unione Europea. Da questo scritto nel
dopoguerra presero spunto diverse correnti che si definirono
“europeiste” e si iniziò a pensare quindi di attuare politiche
comuni in tutti il continente come non era mai avvenuto prima.
Grazie a queste spinte verso un’Europa più unita venne creato il 5
maggio 1949 il “Consiglio d’Europa” al quale aderirono l’Italia,37
la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, l’Olanda, la Danimarca,
il Belgio, il Lussemburgo, la Norvegia, la Svezia, l’Islanda, la
Grecia, la Turchia e l’Irlanda. Fu sull’onda della creazione di
questo Consiglio d’Europa che nel maggio 1950 il Ministro degli
Affari Esteri francesi, Robert Schuman, assieme a Jean Monnet,
lanciò l’idea che portò alla creazione della CECA (Comunità Europea
del Carbone e dell’Acciaio): mettere la produzione totale di carbone e
acciaio, sia della Francia che della Germania Federale, sotto il
controllo di un Autorità comune.
<<La proposta di Schuman aveva innanzitutto il significato
politico di portare Francia e Germania sulla via della
riconciliazione, rompendo con le politiche di
deindustrializzazione dell’economia tedesca e restituendo l’unità
naturale al triangolo industriale che comprendeva la Ruhr, la
Lorena, la Saar, una parte del Nord della Francia, il Lussemburgo,
la maggior parte del Belgio e del Sud dell’Olanda, […], inoltre in
una prospettiva neofunzionalista l’integrazione delle economie
sarebbe debordata in campo politico, portando alla creazione di
una potenza europea unitaria.49>> Nell’Aprile del 1951, poco più
di un anno dopo la proposta di Schuman, si firmò a Parigi il
Trattato istitutivo della CECA, che portava l’abolizione delle
barriere doganali tra i paesi partecipanti, stabiliva
l’armonizzazione dei dazi verso i paesi terzi e vigilava
sull’approvvigionamento regolare del mercato comune; i paesi
firmatari furono la Francia, la Germania Occidentale, l’Italia, il
Lussemburgo, il Belgio e l’Olanda.
49 Balconi M., La siderurgia di Stato (1945-1990) Tra controllo pubblico e incentivi dello Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 98
38
La dichiarazione del 9 maggio 1950 sembra poter essere l’atto
fondante dell’unità europea, ma naturalmente al momento della sua
pubblicazione suscitò molto scalpore. Gerard Boussuat nel suo
saggio “Il piano Schuman del 9 maggio 1950: luogo simbolico della ritrovata fiducia
europea” traccia le linee guida che dalla dichiarazione del 9 maggio
portarono all’attuazione di politiche volte all’unificazione
continentale, ma il punto focale del saggio è << dimostrare, a
dispetto di una certa mitologia semplificatrice, che questo atto
fondante è tale più a livello simbolico che istituzionale50.>>
Dall’esplicazione del piano Schuman si iniziò a credere che
l’unità europea fosse ormai prossima e che tale processo di
unificazione sarebbe avvenuto tramite il metodo funzionalista
proprio del piano. <<Numerosi progetti furono elaborati dopo il 9
maggio: l’Europa verde, l’Europa bianca (prodotti farmaceutici),
l’Europa dei trasporti, poi l’Europa della difesa, la CED, e in
seguito l’Euratom, perfino l’Europa della moneta.51>> Monnet
credeva che partendo dall’unificazione del mercato del carbone e
dell’acciaio si sarebbe potuti arrivare all’unita economico
politica. Tra i diversi progetti sopra elencati pochi furono però
portati a termine. Ad esempio l’idea dell’Europa verde (o il Pool
verde) venne subito accantonata dall’OECE, stessa sorte per la CED
(Comunità europea di difesa) il quale progetto venne abbandonato
definitivamente nel 1954. Monnet non desistette, insistendo sul
modello funzionalista e propose così nel 1955 il rilancio europeo
basato sulla creazione di una “Comunità europea per il nucleare”
(Euratom) e una “Comunità europea dei trasporti”. Solo l’Euratom
50 Bossuat G., Il piano Schuman del 9 maggio 1950: luogo simbolico della ritrovata fiducia degli europei, in AA.VV (a cura di), La comunità europea del carbone e dell’acciaio(1952-2002) Gli esiti del trattato in Europa e in Italia, Padova, Cedam, 2004, p. 351 Ibidem, p. 4
39
riuscì però a prendere vita ma non nella forma auspicata da Monnet
che desiderava << una comunità europea dell’energia atomica volta
alla produzione di materiale fissile a scopi pacifici.52>>
Nonostante tutte le riserve arrivate a posteriori, sia nei
confronti del Piano Schuman (analizzato da Boussat solo come
“simbolo” e non come effettivo momento cruciale nei confronti
della strada che avrebbe portato all’unificazione europea), sia
nei confronti delle idee di unificazione di Monnet, lo stesso
Piano Schuman rappresenta comunque una pietra fondante per la
futura Unione Europea anche per lo stesso Boussat. Il piano
infatti ha per l’autore due facce: << una faccia idealista e una
faccia realista.53>> Realista perché è letto come una risposta alla
delicata situazione continentale data dal <<contrasto franco-
tedesco, così carico di conseguenze per l’Europa per oltre un
secolo, e la minaccia nucleare derivante dalla guerra fredda.54>>
Lo stesso Schuman propose alla Germania Occidentale la pace in
vista della costruzione di un Europa unita << sans distinction ,
qu’ils soient de l’Est ou de l’Ouest, et touts les territoires,
notamment l’Afrique (…)>> Secondo Boussat dunque storicamente
parlando il testo della Dichiarazione inventa una nuova forma
d’unità europea. <<La diplomazia francese vide nell’integrazione
europea la soluzione della questione tedesca e decise di
trasformare uno degli elementi di conflitto tra Francia e Germania
in un fattore di collaborazione.55>>
52 Ibidem, p. 953 Ibidem, p.1054 Ibidem, p. 1055 Gualdesi M. N., L’Italia, la Ceca e la costruzione comunitaria: aspetti storico istituzionali, in AA.VV. (a cura di), La comunità europea del carbone e dell’acciaio(1952-2002), , Padova, Cedam, 2004, p. 70
40
3.2 L’Italia e la Ceca
Il Piano Schuman ebbe tra i paesi firmatari anche l’Italia,
nonostante i livelli di produzione fossero nettamente inferiori
nei confronti degli altri paesi contraenti. Nel 1950 la produzione
di acciaio grezzo aveva raggiunto i livelli pre-bellici con una
produzione di 2,3 milioni di tonnellate mentre la ghisa si
assestava attorno al milione di tonnellate. Solo Germania e
Francia producevano rispettivamente ghisa 14 e 8,5 volte in più56.
Malgrado la strada fatta verso l’integrazione europea attraverso
l’adesione al Consiglio d’Europa, alla NATO (North Atlantic Treaty
Organization), al Piano Marshall e all’OECE, l’Italia era
considerata, all’interno delle trattative per la CECA, come un
partner di secondo piano, con una limitata capacità di incisione.
Gian Lupo Osti ricorda che <<ci vedevano essenzialmente come dei
parvenus che volevano sedersi al tavolo comune. Non ci prendevano
assolutamente sul serio>> e ancora in risposta alla domanda di
Ranieri: <<Neppure i Francesi?>> risponde <<All’inizio direi di
no. Anzi i francesi ci trattavano peggio degli altri. Le vecchie
imprese siderurgiche europee, bhe, bisogna averle conosciute: non
si trattava di aziende, erano delle Istituzioni. Malgrado le
distruzione belliche molte avevano ancora sedi splendide, un po’
polverose forse, se viste con occhi moderni, ma certamente
imponenti e sussiegose. Non era solo il fatto che noi eravamo dei
concorrenti potenziali (ho l’impressione che all’inizio questa
fosse l’ultima delle loro preoccupazioni). Ma ci consideravano
56 Ranieri R., L’espansione siderurgica italiana nel primo quindicennio del trattato CECA(1952-1967), in AA.VV. (a cura di), La comunità europea del carbone e dell’acciaio(1952-2002), , Padova, Cedam, 2004, p. 156
41
come persone che volevano impegnarsi in un’impresa assolutamente
al di sopra delle proprie forze.57>>
Anche se, secondo Marinella Neri Gualdesi <<la strategia di
integrazione settoriale, proposta dalla Francia con la
dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, apriva uno spazio nuovo,
sia all’aspirazione dell’Italia di uscire da una posizione di
marginalità, che ai progetti italiani di unificazione europea.58>>
Al di la di queste aspirazioni future, l’iter per entrare a far
parte della Comunità europea del carbone e dell’acciaio non fu
facile per l’Italia. Il 12 maggio 1950 un documento del Ministero
degli Esteri italiano metteva in luce la posizione del paese nei
confronti del Piano Schuman. Nel documento si esplicitò la
necessità per un paese privo di materie prime e produttore di
acciaio in maniera limitata, come l’Italia, di aderire al piano
ritenendo che <<l’organizzazione che sarebbe stata creata avrebbe
facilitato l’approvazione dell’unione doganale italo-francese, si
spingeva ad indicare che ciò avrebbe messo i due paesi nella
situazione di dirigere l’organizzazione stessa, quasi l’ambizione
di un asse italo-francese. Ambizioni che saranno presto frustrate
dall’asse franco-tedesco.59 >> Del resto il Piano era stato creato
specificatamente da parte francese per avere una garanzia di
controllo sull’espansione economica della Repubblica Federale
Tedesca, << la domanda che si posero Monnet e Robert Schuman era
duplice: in che modo ricostruire la siderurgia tedesca e come
57 Osti G. L. in , Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 15458 Gualdesi M. N., L’Italia, la Ceca e la costruzione comunitaria: aspetti storico istituzionali, in AA.VV. (a cura di), La comunità europea del carbone e dell’acciaio(1952-2002), , Padova, Cedam, 2004, p. 6759 Ibidem, p. 73
42
utilizzare “sovranazionalmente” la Ruhr, pur affidandola a uno
Stato sovrano.60>>
L’ingresso italiano non era per nulla stato preso in
considerazione durante la stesura preliminare del Piano Schuman,
tanto che l’Italia fu ammessa solo dopo al tavolo dei negoziati.
Nonostante tutte le reticenze sia interne che esterne al paese
l’ambasciatore italiano a Parigi Pietro Quaroni consigliò di
essere presenti a giugno all’inizio dei negoziati, sottolineando
comunque che << partecipare non significa firmare; non è ancora
detto che si arrivi veramente al piano ambizioso proposto dai
francesi e in fondo, in ultima analisi, resta come garanzia la
ratifica del Parlamento che potrebbe rifiutare.61>> L’Italia sia
per motivi politici che economici non poteva rimanere fuori da
questi negoziati che l’avrebbero portata all’esclusione dal
contesto europeo. I delegati italiani comunque non mancarono di
sottolineare un punto fermo per l’adesione italiana ai trattati,
quello dell’interesse nazionale <<l’abbandono di sovranità a
favore di un organo superiore avrebbe potuto rivestire forme non
ancora identificabili, ma era un fatto che sarebbe avvenuto.62>>
Dai negoziati l’Italia riuscì ad ottenere: la richiesta di parità
nella rappresentanza parlamentare con i due paesi maggiori, la
presenza di almeno un italiano membro dell’Alta Autorità,
l’importante concessione di un periodo di sei anni prima di
abolire integralmente i dazi sull’acciaio nei confronti della60 Ibidem, p. 7061 Telespresso n.07474, il MAE a destinatari vari in, Gualdesi M. N., L’Italia, la Ceca e la costruzione comunitaria: aspetti storico istituzionali, in AA.VV. (a cura di), La comunità europea del carbone e dell’acciaio(1952-2002), , Padova, Cedam, 2004, p. 7462 Gualdesi M. N., L’Italia, la Ceca e la costruzione comunitaria: aspetti storico istituzionali, in AA.VV. (a cura di), La comunità europea del carbone e dell’acciaio(1952-2002), , Padova, Cedam, 2004, p. 74
43
Comunità e l’inserimento nel Trattato del “Principio della libera
circolazione dei lavoratori”, anche se limitato ai lavoratori del
settore carbosiderurgico. << L’introduzione del principio della
libertà di circolazione stava particolarmente a cuore al governo
italiano, che vedeva nella possibilità di trovare occupazione
fuori dai confini nazionali un’importante compensazione per quei
lavoratori che, a seguito della ristrutturazione delle imprese del
settore carbosiderurgico, avrebbero perso il loro posto di
lavoro.63>> Il trattato recitava che << il periodo di transizione
comincia dalla data di costruzione del mercato comune e finisce
allo spirare del periodo di cinque anni a decorrere dalla
istituzione del mercato comune per il carbone. All’Italia veniva
concessa la possibilità di mantenere, su autorizzazione della Alta
Autorità, dazi di dogana sui prodotti siderurgici provenienti
dagli altri stati membri, purché fossero progressivamente ridotti
durante i cinque anni del periodo transitorio, e soppressi alla
fine del periodo stesso.64>> I delegati italiani riuscirono ad
ottenere anche una clausola speciale per il paese: sottrarre ai
normali poteri di giudizio dell’Alta Autorità gli investimenti già
in corso dal 1º Marzo 1951, dando così la possibilità al piano
Finsider di procedere sulla sua strada.
Alla fine dei negoziati il mondo industriale italiano si divise.
Osti nell’intervista effettuata da Ruggiero Ranieri ricorda che
<<Sinigallia era favorevole a una liberalizzazione dei mercati,
anche se spingeva per una certa gradualità soprattutto in vista
dei problemi agli altri gruppi, nonché della Terni, dell’Ilva ecc.
Nei primi anni, fra il 1949 e il 1950, ci furono alcune riunioni
63 Ibidem, p.7864 Ibidem, p 78
44
al ministero del Commercio Estero nelle quali soprattutto l’Ilva
insisteva che non bisognava aumentare il contingente di
importazione. Io [Osti] rifiutai di associarmi a quelle pressioni:
non vedevo, infatti, perché l’industria italiana dovesse pagare
l’acciaio più caro per far piacere all’Ilva. Lo dissi a Sinigallia
il quale mi diede pienamente ragione. Sostanzialmente egli era
favorevole a una piena liberalizzazione anche se è possibile che
le sue posizioni ufficiali fossero diverse, in quanto era
costretto a tener conto del fatto che una gran parte
dell’industria siderurgica era molto spaventata, abituata, com’era
stata, prima, nell’anteguerra, alla protezione dei consorzi, poi,
più recentemente, a quella dei contingenti di importazione. Molti
insomma temevano che eliminare la protezione volesse dire un
crollo del mercato.65>>
La Finsider comunque non era stata accontentata su tutto, in
quanto uno dei punti su cui insistette di più fu quello degli
approvvigionamenti di minerali di ferro dal Nord Africa, ma
l’articolo 79 del trattato limitava l’applicazione di esso ai
territori europei degli stati contraenti, escludendo i territori
francesi d’oltremare, si arrivò comunque ad una soluzione di
ripiego: Francia e Italia firmarono una “convezione bilaterale”
per la fornitura all’Italia di un quantitativo ragguardevole di
minerali di ferro algerino per un quinquennio, << secondo
l’accordo italo-francese di Santa Margherita, nel primo anno dopo
la ratifica del Piano Schuman era prevista una fornitura di
450.000 tonnellate fino a giungere a 850.000 nel quinto anno.
L’accordo era rinnovabile e nell’ambito del quinquennio potevano
65 Osti G. L. in , Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 151
45
essere assegante all’Italia altre 400.000 tonnellate di minerale
africano da Conakry (Guinea).66>>
TAB. 8. Dazi approvati nel Luglio 1957 verso i paesi terzi (%)67
Italia Francia Germania RF Benelux
Ghisa:
Specolare 7 4 3 3
Altre 5 4
Acciaio
comune:
Lingotti 7 4 3 3
Semilavorat
i
8 5 4 4
Coils 9 6 5 5
Larghi
piatti,
lamiere
9 6 5 5
Barre,
profilati
non forati
9 6 5 5
Vergella 10 7 6 6
Lamierini 10 7 6 6
66 Ranieri R., L’espansione siderurgica italiana nel primo quindicennio del trattato CECA(1952-1967), in AA.VV. (a cura di), La comunità europea del carbone e dell’acciaio(1952-2002), , Padova, Cedam, 2004, p. 16567 Balconi M., La siderurgia di Stato (1945-1990) Tra controllo pubblico e incentivi dello Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 99
46
Lamiere
zincate
10 7 6 6
Lamiere
stagnate
10 9 8 8
Lingotti
fini al
carbonio
7 4 3 3
Lingotti
acc. legato
5/6 3 3 3
Coils acc.
Legato
8/9 6 6 6
Fonte:Assider, Regime daziario italiano per i prodotti siderurgici al 1º Luglio 1963, mimeo
3.3 Effetti del Piano Sinigallia e rimessa in discussione
dei suoi principi
I sei anni di transizione concessi all’Italia, che vanno dal 1953
al 1958, coincidono con il primo momento di assestamento e di
crescita della siderurgia italiana e in generale di tutto il
sistema economico italiano. La produzione di acciaio grezzo
raddoppiò nel quinquennio 1952-1957 avvicinandosi ad una
produzione annua di 7 milioni di tonnellate68. Grazie ad uno
sviluppo delle produzioni più veloce del consumo e alla forte
domanda estera, nel 1956 l’Italia passa alla posizione di
esportatore netto di prodotti siderurgici. Forte spinta la diede
l’assestamento dei finanziamenti del Piano Sinigallia che
portarono all’entrata in produzione degli altiforni di Piombino e
Cornigliano e al superamento, nel 1957, da parte dello68 Ranieri R., L’espansione siderurgica italiana nel primo quindicennio del trattato CECA(1952-1967), in AA.VV. (a cura di), La comunità europea del carbone e dell’acciaio(1952-2002), , Padova, Cedam, 2004, p. 170
47
stabilimento di Cornigliano del milione di tonnellate di acciaio.
Ancora molto alto era invece il consumo di rottame e il livello di
dipendenza dalle importazioni nonostante fosse stato quasi del
tutto abbandonato, nel resto dell’Europa, il forno elettrico.
Margherita Balconi nota infatti come parte della storiografia
esprime un commento positivo su questo periodo di sviluppo della
siderurgia italiana, imputando alla rifondazione della siderurgia
italiana voluta col piano Sinigallia gran parte del merito di aver
chiuso gli impianti più obsoleti, di aver fatto aumentare il
livello di produttività e di aver fatto avvicinare i prezzi dei
prodotti italiani a quelli della Ceca. <<L’impresa pubblica aveva
conquistato un ruolo egemone, lanciata alla rincorsa delle
economie di scala e della massima efficienza produttiva. La
ristrutturazione – una delle più vaste e profonde mai operata
nell’industria italiana – aveva comportato notevoli costi sociali
in una prima fase, allorché gli investimenti si accompagnavano ad
una diminuzione dell’occupazione; ma, una volta compiuto il
risanamento, l’ulteriore espansione dell’offerta di prodotti
siderurgici poté contribuire positivamente alla formazione di
nuovi posti di lavoro.69>> Trae conclusioni molto simili alla
Balconi anche Fabrizio Barca: <<la vicenda della siderurgia
pubblica del primo quindicennio postbellico qui riassunta non è
certo l’inevitabile risultato dell’operare di “forze naturali”. In
poche altre situazioni l’Italia conosce un gruppo di dirigenti
accumunati da un chiaro progetto strategico che oltrepassa la mera
vita di un’impresa o di un gruppo, per quanto rilevante, e
coinvolge in via duratura l’intero percorso di sviluppo di più
69 Balconi M., La siderurgia di Stato (1945-1990) Tra controllo pubblico e incentivi dello Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 104
48
decenni. Si tratta di un caso di genuina “politica industriale”,
in parte dovuto alla natura speciale del legame tra gli uomini
dell’impresa pubblica del periodo.70>> L’autore cita anche
Rugafiori che afferma nel suo libro che <<la “corte” di uomini di
nostro interesse si forma non per tranquilla cooptazione secondo
il tradizionale sviluppo di carriera dei singoli nelle società
operative e finanziarie, ma attraverso un’evoluzione fondata sul
dinamico e tenace dislocarsi a difesa di un progetto che non
giustifica, ma modifica, e in modo radicale, l’esistente. È in
sostanza una “scalata” a sostegno dell’innovazione e non della
routine quotidiana.71>>
Vi era però un netto divario tra l’industria pubblica,
specialmente quella di marca Cornigliano, e l’industria privata
ancora costretta a rifornirsi di rottame. La proposta del mondo
industriale privato fu quelle delle importazioni che sarebbero
state naturalmente avvantaggiate dall’abbattimento dei dazi
doganali nel 1958; questa prospettiva che avrebbe portato ad una
massiccia penetrazione straniera sul mercato italiano fu vista dai
continuatori di Oscar Sinigallia come una sfida ad aumentare le
capacità produttive. Tale questione venne posta nello “Schema di
sviluppo dell’occupazione e del reddito” presentato nel 1954 dal
Ministro del Bilancio Ezio Vanoni coadiuvato da un gruppo di
tecnici coordinati da Pasquale Saraceno. Il documento aveva come
obbiettivo l’incremento del reddito nazionale ad un saggio annuo
del 5% al fine di creare nel decennio 1955-64 quattro milioni di
posti di lavoro da offrire a due milioni di disoccupati ed alle70 Barca F., Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra a oggi, Roma, Donzelli Editore, 1997, p 20571 Rugafiori P., in F., Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra a oggi, Roma, Donzelli Editore, 1997, p 206
49
nuove leve che si sarebbero col tempo presentate sul mercato del
lavoro72. Il reddito avrebbe dovuto essere più intenso nel
Mezzogiorno, risultato che doveva essere ottenuto destinandogli
poco meno del 50% degli investimenti previsti per raggiungere la
<<riduzione degli scarti esistenti in termini sia di reddito, che
di occupazione, che di produttività, che di attrezzatura
ambientale e sociale.73>>
I settori nei quali doveva essere incentrato l’investimento erano
quelli dell’agricoltura, dei servizi, delle opere pubbliche e
dell’edilizia. Nell’industria invece gli investimenti potevano
derivare anche dall’iniziativa privata, in mancanza di essa si
sarebbe fatto avanti lo Stato <<per soddisfare le esigenze di
sviluppo nei campi nei quali la [sua] presenza fosse
determinante.74>> Si sosteneva la tesi che la Ceca non avrebbe reso
<<convenienti nuovi rilevanti investimenti nella siderurgia
italiana, al di fuori di quelli ancora necessari al raggiungimento
delle più economiche dimensioni degli impianti esistenti.75>> Se vi
fosse stato un forte incremento della domanda nel secondo
quinquennio (1959-64) si sarebbe ricorsi alle importazioni. <<In
tal modo venivano rimesse in discussione le principali tesi di
Sinigallia: l’idea del “servizio” offerto dalla disponibilità di
prodotti siderurgici competitivi all’industria meccanica, data
l’inesistenza di svantaggi assoluti di costo “naturali” rispetto
ai migliori concorrenti internazionali, e la fiducia in un
72 Ibidem, p. 10773 Ibidem, p. 10774 Ibidem, p. 10875 Ibidem, p. 108
50
allentamento del vincolo estero attraverso gli effetti diretti e
indiretti dello sviluppo del settore.76>>
TAB.10. Consumo apparente nazionale di acciaio grezzo e flussi di commercio con l’estero di prodotti
siderurgici-1951-5877 (Milioni di t)
Consumo Import Export Saldo
1951 3,5 0,6 0,2 -0,4
1952 3,9 0,6 0,2 -0,4
1953 4,1 0,8 0,2 -0,6
1954 4,8 0,9 0,3 -0,6
1955 5,5 0,7 0,5 -0,2
1956 5,8 0,7 0,9 0,2
1957 6,3 1,0 1,1 0,1
1958 6,3 1,0 1,1 0,1Fonte:Assider
76 Ibidem, p. 10877 Balconi M., La siderurgia di Stato (1945-1990) Tra controllo pubblico e incentivi dello Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 103
51
4. La nuova sfida della siderurgia a partecipazione
statale
4.1 Divergenze sul rilancio siderurgico nel Meridione
Si iniziò a parlare dell’ubicazione del IV centro siderurgico già
nel 1955; si pensò inizialmente di localizzarlo nel Meridione e
naturalmente, riprendendo le idee di Sinigallia, in una posizione
limitrofa alla costa. La spinta per posizionarlo nel Mezzogiorno
fu ancora più pressante sull’Iri che nel 1957 si vide vincolata da
una legge che la “costringeva” ad investire nel Meridione. Andando
ad analizzare però gli aumenti di domanda previsti fino al 1961-62
essi non prevedevano alcuna espansione ma, solo un ammodernamento
degli altiforni da 1,6 a 2,9 milioni di tonnellate annue e delle
acciaierie da 3,2 a 4,6 milioni di tonnellate. Inizia così una
controversia tra governo, presieduto allora da Amintore Fanfani, e
l’Iri. Il governo, spinto dagli ambienti più riformisti, fece
molta pressione per il rilancio industriale nel Mezzogiorno con la
convinzione che <<ai fini dello sviluppo economico nazionale il
rischio fosse da corrersi e che, gestendo prudentemente la
crescita degli impianti, si potevano sfruttare le opportunità già
esistenti in attesa che il mercato del Sud prendesse forma e
52
consistenza.78>> Molto forti erano le resistenze sia all’Iri che
alla Finsider preoccupati dalla <<impreparazione ambientale ad
accogliere una grande industria del tipo siderurgico […] la
scarsità di manodopera adatta e di personale direttivo preparato,
la diffusa tendenza a considerare una grande industria come un
ente sociale di sussistenza, le difficoltà di controllo e di
gestione data dalla posizione periferica staccata dai centri delle
associazioni, della cultura, della istruzione tecnica ecc.79>>.
Questa disputa si risolverà solo nel 1959 con l’insediamento del
governo Segni che prese immediatamente la decisione di dare il via
ai lavori per un nuovo centro siderurgico in Puglia. Gian Lupo
Osti ricorda come l’idea del centro siderurgico non venne dagli
ambienti dell’Iri <<Non ricordo con esattezza quando si cominciò a
parlare di Taranto […]. Mi sembra tuttavia che la questione si
pose con forza nel 1957 e a farsene portavoce per primo fosse
Pastore, che allora era ministro per il Mezzogiorno, poi seguito
da Fanfani che riprese l’idea, impegnando il governo. L’idea
quindi, per quanto posso ricordare, non venne dall’Iri […]. La
prima reazione di Manuelli alla proposta di Taranto fu
violentemente negativa e in questo egli fu influenzato dagli
industriali privati e dai tecnici dell’Ilva, e in particolare da
Giannini che era diventato allora Amministratore delegato
dell’Ilva.80>>
78 Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 8079 Documento direzione studi Finsider, in Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 8080 Ibidem, p. 288
53
Una prima risposta al dibattito in corso tra Stato ed Iri arrivò
dalla Fiat. I dirigenti Fiat avevano previsto un aumento del
consumo di coils così elevato che le forniture preferenziali di
Cornigliano sarebbero presto state insufficienti. La Fiat così,
non volendo ricorrere ad importazioni massicce, decise di
costruire un nuovo centro a ciclo integrale specializzato nella
laminazione di prodotti piatti <<implicitamente riaffermando la
giustezza, nella fase storica di allora, delle tesi di
Sinigallia.81>> La località scelta fu quella di Vado Ligure, e il
progetto prevedeva la costruzione di sei altiforni da otto metri
di diametro, di tre convertitori LD, di un laminatoio continuo a
caldo per coils e di laminatoi a freddo. L’azienda torinese diede
subito il via ai lavori, che però vennero bloccati nel 1957 a
causa del nuova destinazione di quei terreni e abbandonò
definitivamente il progetto quando nel 1957 fu annunciata la
costruzione di un IV centro siderurgico. Come compensazione la
Fiat ottenne il rinnovo degli accordi del 1952 con la Finsider con
quantitativi aggiornati alle richieste presenti. Osti ha comunque
dei dubbi sul progetto di costruzione di Vado Ligure: <<Alcuni di
noi pensavano che Vado fosse una mossa della Fiat per ampliare gli
accordi di collaborazione in essere con Cornigliano, in condizioni
di vantaggio. In effetti alla Fiat occorreva aumentare i suoi
approvvigionamenti di lamierino e peraltro doveva affrontare anche
degli onerosi programmi di investimento nel suo settore chiave,
quello automobilistico.82>>
81 Balconi M., La siderurgia di Stato (1945-1990) Tra controllo pubblico e incentivi dello Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 10982 Osti G.L. in, Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 227
54
4.2 Il nuovo centro siderurgico e l’espansione quasi
senza fine del gruppo Finsider
I primi sostenitori dell’apertura di un IV centro provenivano da
diversi settori governativi e in particolare dall’Iri. A favore di
Taranto si mosse, come ricorda Osti, soprattutto Pastore, di
provenienza cislina, e Colombo appartenente ai dorotei.
Naturalmente non tutti gli ambienti, sia politici che industriali,
erano favorevoli all’apertura del nuovo centro. Margherita Balconi
dimostra come i maggiori organi di stampa economici come “Il
Sole”, il “24 ore” o il “Mondo Economico”, molto legati al mondo
industriale privato, espressero opinioni alquanto negative
sostenendo le prime tesi dell’Iri basate sull’inutilità
dell’aprire un nuovo centro siderurgico al Sud credendo che la
strada migliore da intraprendere fosse invece il rimodernamento
degli impianti. <<Si affermava inoltre che per soddisfare i
bisogni del Mezzogiorno erano sufficienti gli impianti di Bagnoli,
mentre si contestavano gli “effetti indotti”, se questi non
potevano “neppure essere previsti come ipotesi di lavoro”.83>>
Forti resistenze in realtà arrivavano anche dall’Iri e dalla
stessa Finsider. Ruggiero Ranieri nel ricostruire l’intervista a
Gian Lupo Osti racconta che la dirigenza Finsider e il gruppo
dirigente dell’Ilva non volevano scontarsi col settore privato e
proponevano la vecchia logica di cartello, e tali resistenze si
rivelarono così radicate che l’Iri si rifiutò per tutto il 1959 di
avvallare il programma di Taranto. <<L’ostruzionismo Iri e
Finsider, tuttavia, fu seriamente indebolito dalla posizione del83 Ibidem, p 114
55
gruppo di Cornigliano.>> In quanto <<l’investimento di Taranto
venne visto come parte di una più generale ristrutturazione della
siderurgia pubblica, che il gruppo di Cornigliano si candidava a
guidare. E in una prima fase si trattò di una candidatura
vincente.84>>
Uno dei documenti che spinse il nuovo governo Segni ad avvallare
il progetto per Taranto fu redatto sotto il governo Fanfani nel
1958 e fu il nuovo “Rapporto del Presidente del Comitato per lo
Sviluppo dell’Occupazione e del Reddito” rivolto al Presidente del
Consiglio dei Ministri e firmato da Pasquale Saraceno. Il rapporto
era impostato sulle stesse linee guida dettate da Oscar
Sinigallia, che comportavano il rilancio della siderurgia a ciclo
integrale con stabilimenti ubicati sulle coste e auspicava una
progressiva riduzione dell’utilizzo del rottame. Il nuovo
stabilimento doveva specializzarsi nella produzione di
semilavorati che sarebbero stati rivenduti poi al Nord. Per chi
era preoccupato dell’aumento dei prezzi a causa dei lunghi
trasporti che comportava un ubicazione ed una specializzazione del
genere, Saraceno controbatteva argomentando che le politiche di
sviluppo nel Mezzogiorno avrebbero spostato col tempo proprio al
Meridione il baricentro dei consumi. Inoltre l’ubicazione sul Mar
Ionio era utile nei confronti delle esportazione verso i paesi
afro-asiatici ed il mercato interno che gravitava sulla costa
adriatica. <<In ultima analisi, infine, a fronte di maggiori costi
di trasporto e di eventuali maggiori costi inerenti ad un impianto
esercito in una regione non industrializzata stavano le
agevolazioni alle nuove iniziative industriali localizzate nel
84 Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 77
56
Mezzogiorno.85>> Un’altra argomentazione a favore dell’ubicazione a
Taranto era fornita dal fatto che ben presto la carenza di lamiere
sarebbe stata pressante sui cantieri dell’Adriatico, dello Ionio e
del Tirreno <<e l’impianto da istallare doveva comunque essere sul
mare e preferibilmente nelle vicinanze di un cantiere navale (a
Taranto c’era l’Arsenale della Marina Militare).86>>
Per confutare ulteriori dubbi nel 1959 fu nominato un C.T.C.
(Comitato Tecnico Consultivo) presso l’Iri. Presidente della Commissione
fu nominato il professor Caglioti, parte della commissione era
composta dal professor Saraceno, da Marchesi, dall’allora
Direttore Generale dell’Iri Dr. Leopoldo Medugno e dal presidente
dell’Assider Dandolo Francesco Rebua. Scopo della commissione fu
quello di stilare una raffronto tra le previsioni della domanda e
delle capacità produttive ottenibili in base a programmi già noti.
Il calcolo dei consumi inerente al periodo 1960-68 fu effettuato
basandosi sulle seguenti ipotesi: -per il triennio 1960-62,
adottando un coefficiente di elasticità pari all’ 1,6% e per il
reddito un’alternativa tra una vigorosa ripresa, tale da dar luogo
ad un aumento del reddito al saggio annuo del 5%, ed uno sviluppo
del reddito nella misura del 3,5% annuo, pari a quello avuto negli
Stati Uniti negli ultimi dieci anni e che si congetturava potesse
valere anche per l’Europa Occidentale; -per il periodo successivo
adottando un tasso di incremento del reddito nella misura del 3,5%
annuo ed un coefficiente di elasticità, in un caso dell’1,6% e
nell’altro dell’1,4%87. Lo scostamento tra l’ammontare dei consumi
85 Balconi M., La siderurgia di Stato (1945-1990) Tra controllo pubblico e incentivi dello Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 11586 Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 7987 Ibidem, p. 116
57
di acciaio previsti in base ai criteri elencati e a quelli che poi
si realizzarono effettivamente è riportato in tabella:
TAB. 11. Previsioni sui consumi di acciaio del C.T.C. IRI del 1959 e consumi effettivi88
Ipotesi
massima (A)
Ipotesi
minima (B)
Consumi
effettivi
(C)
Scostamento
tra C e A
1960 6,7 6,5 9,2 +37%
1965 9,2 8,4 11,5 +25%
1968 10,9 9,7 17,4 +60%
Il C.T.C concludeva il rapporto affermando che <<se la costruzione
di un nuovo impianto venisse subito avviata, non soltanto
quest’ultimo non potrebbe essere economicamente gestito, ma anche
quelli esistenti entrerebbero in crisi per l’impossibilità di
utilizzare appieno le innovazioni tecniche che si stanno
introducendo.89>> Subito dopo la pubblicazione delle conclusioni
assunte dal Comitato Tecnico Consultivo dell’Iri nel 1959, il
Comitato dei Ministri per le Partecipazioni Statali deliberò la
costruzione del quarto centro siderurgico italiano a Taranto. Nel
1961 si dava anche il via alla creazione dell’Italsider tramite la
fusione tra la Cornigliano Spa e l’Ilva che Osti ricorda come <<in
sostanza, consisteva in un processo di “corniglianizzazione”
88 Balconi M., La siderurgia di Stato (1945-1990) Tra controllo pubblico e incentivi dello Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 11689 Relazione del C.T.C in, Balconi M., La siderurgia di Stato (1945-1990) Tra controllo pubblico e incentivi dello Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 117
58
dell’Ilva.90>> Il modello di conduzione aziendale dell’Italsider
rimase infatti fino alla metà degli anni ’50 molto simile a quello
del gruppo di Cornigliano; constava infatti di un modello basato
sulle grandi imprese siderurgiche americane come la stessa Armco e
USS (United States Steel Corporation), con le quali, come in precedenza,
erano stati stipulati rapporti di consulenza e contratti di
partecipazione societaria. Dalla seconda metà degli anni ’60
invece il modello degli Stati Uniti venne via via abbandonato per
lasciare spazio al nuovo modello nipponico, in particolare quello
della Nippon Steel Corporation. La nascita dell’Italsider trovò
naturalmente delle resistenze sulla sua strada, una delle più
importanti fu quella dell’Iri che grazie al sistema in atto era
riuscita ad appropriarsi di molti poteri che appartenevano alle
finanziarie e che invece si vedeva ora costretta a cedere il
privilegio di intrattenere direttamente i rapporti col Ministero
delle Partecipazioni Statali. L’Iri si sentì come esautorata
dall’Italsider <<perché temeva la nascita di un grosso gruppo
operativo, con accentramento di poteri, che di fatto non poteva
che tagliarla fuori, per esempio, nelle trattative con le autorità
locali, e per molti altri aspetti.91>>
Dai saggi di Margherita Balconi e Ruggiero Ranieri emerge
un’immagine dell’operazione che ha portato alla costruzione del
centro siderurgico in Puglia <<guidata soprattutto da criteri
politici>> nonostante l’avvallo della Cornigliano ormai sicura,
secondo Marchesi, del superamento della soglia massima di
produzione. La stessa domanda è posta proprio da Ranieri ad Osti
90 Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 7791 Ibidem, p.213
59
che afferma: <<Non c’è dubbio che la localizzazione del IV centro
siderurgico a Taranto sia stata conseguente a una scelta politica.
Personalmente sono certo che, facendo riferimento solo al bilancio
aziendale, la localizzazione migliore sarebbe stata Piombino.
Credo che anche Marghera avrebbe avuto qualche chance, mentre,
sempre ripeto in una logica strettamente aziendale, Taranto non
avrebbe meritato neppure di essere presa in esame. Ciò a
prescindere dai contributi e dalle agevolazioni statali per gli
insediamenti nel Mezzogiorno (e non tenendo conto degli obblighi
di legge che impegnavano le Partecipazioni statali in tal
senso).92>> Prendendo però atto degli obblighi di legge anche
secondo Osti la scelta di ubicare il IV centro siderurgico a
Taranto sembra giustificata <<A Taranto, infatti, l’esistenza dei
Cantieri Tosi e dell’arsenale della Marina aveva già portato ad
una mentalità più “moderna” rispetto ad altre città costiere
meridionali.93>>
I costi finali per la costruzione del IV centro siderurgico, che
vide durante la costruzione due fasi di espansione della capacità
produttiva, ammontarono a circa a 600 miliardi di lire. Già
nell’Ottobre del 1961 si poté inaugurare la prima unità, un
tubificio per la produzione di tubi saldati di grosso diametro. La
prima fase si concluse nel 1964 e il centro si trovò dotato di una
banchina per l’attracco di navi pesanti, di due scaricatori di
banchina, di una linea di convogliatori a nastro e di un tronco
ferroviario per il trasporto delle materie prime e dei prodotti.
Direttore dello stabilimento fu nominato l’ing. Cesare De
Franceschini; come responsabili delle singole sezioni e dei
92 Ibidem, p. 19793 Ibidem, p. 197
60
servizi vennero scelti dei giovani dirigenti con specifiche
specializzazioni; invece per i responsabili dei nuovi impianti
furono previsti appositi training negli Stati Uniti, <<venne fatto
un accordo con la Jones & Laughlin per addestrare il nostro
personale di acciaieria nel loro stabilimento, dove avevano
istallati dei grandi convertitori LD simili a quelli progettati
per Taranto. Infine, per completare il quadro di quegli accordi,
varie decine di dirigenti, per lo più sotto i 45 anni, vennero
inviati presso l’Armco e la USS per un corso di circa 20 giorni,
se ben ricordo, sui sistemi direzionali.94>> Lo stesso progetto di
costruzione dello stabilimento tarantino prendeva le mosse da uno
stabilimento americano sul mare, quello di Fairless a Philadelphia
per poi seguire però negli anni il modello giapponese della Nippon
Steel Coprporation. Vennero applicate anche a Taranto ad esempio
le politiche di Job Analysis e Job Evaluation, considerate ancora
pietre miliari nell’attribuzione della paga per gli addetti alla
produzione: <<Direi che i risultati furono largamente positivi. La
Job Analysis e la Job Evaluation vennero estese rapidamente a
tutti gli stabilimenti ex-Ilva e, naturalmente, anche a Taranto.
Sarà che io mi sento molto coinvolto personalmente in materia, ma
io non ho ancora trovato chi mi sappia proporre un sistema
migliore per determinare le paghe di un addetto alla
produzione.95>>
La seconda fase di espansione coincide sia con l’approvazione
della legge 685 del 1967, che avvallava il “Primo Programma
Economico Nazionale”, con il quale lo Stato italiano continua ad
attribuire alle industrie di base il ruolo di settori a forte
94 Ibidem, p. 21095 Ibidem, p. 211
61
rilevanza strategica, sia con il processo di snaturamento in atto
nell’Italsider, facilitato dall’allontanamento di Marchesi a causa
di una malattia, al quale seguì una presa di potere da parte di
Capanna. Venne così formato un nuovo Comitato Tecnico Consultivo
sia per far fronte alle rosee prospettive di crescita, sia per
impedire una nuova incursione nel mercato italiano da parte della
siderurgia francese, che stava progettando la costruzione di un
nuovo centro siderurgico specializzato nei prodotti piani e
concepito per il mercato mediterraneo. Nella relazione del C.T.C.
<<si affermava che i consumi italiani di acciaio avrebbero
raggiunto 25,5 milioni di tonnellate nel 1975 e 30,5 milioni nel
1960. Si stabiliva quindi, […], di: a) avviare subito
l’ampliamento del centro di Taranto, fino a raggiungere una
capacità produttiva di 10,3 milioni di tonnellate di laminati a
caldo (con l’assunzione di 7.400 nuovi addetti), nonché dei
reparti di laminazione e di finitura del centro di Cornigliano; b)
iniziare nel 1971 la costruzione, in un’altra area del Mezzogiorno
ancora non precisata, di un nuovo impianto di laminazione a freddo
da 1 milione di t/anno, […]. Esso avrebbe dovuto essere integrato
in tempi successivi in un nuovo centro a ciclo integrale della
capacità produttiva di acciaio e laminati piani di 4,5 milioni di
t/anno, da completare entro il 1977.96>> In linea generale il
programma proposto dal Comitato fu approvato nel novembre 1970 dal
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Con
l’approvazione del Piano i progetti Italsider crollarono
soprattutto quello riguardante Piombino, <<Tutti gli ampliamenti
vennero invece accentrati a Taranto, con il risultato, a mio
96 Balconi M., La siderurgia di Stato (1945-1990) Tra controllo pubblico e incentivi dello Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p.230
62
giudizio, di rovinare anche lo stabilimento di Taranto. Infatti la
produzione non aveva ancora raggiunto i quattro milioni di
tonnellate di acciaio annue, che già si iniziavano i lavori per
portarla a sette, e poi a dodici e così via in una perenne
escalation. Peraltro queste cifre iperboliche non furono mai
raggiunte, mentre l’operazione ebbe il risultato di mantenere lo
stabilimento in uno stato di perenne confusione, per cui sia dal
punto di vista della manutenzione, della organizzazione e della
produttività le prestazioni furono compromesse.97>>
Gian Lupo Osti è molto critico nell’analizzare queste previsioni,
che si rivelarono poi realmente esagerate, di incremento della
domanda di acciaio, commenta infatti affermando che <<A mio [Osti]
avviso, e cerco di esprimere non solo quello che penso oggi, con
il senno di poi, ma anche di riandare a quello che pensavo allora,
queste aspettative di incrementi della domanda di acciaio non
erano una cosa molto seria. È poco serio, infatti, parlare di
aumentare la produzione di tanti milioni di tonnellate per fronte
a una domanda crescente; per essere più seri bisognerebbe scendere
molto più nel dettaglio di quali segmenti di domanda si tratti:
lamierino? tondino per cemento? e così via. Quelle proiezioni
invece, altro non furono che la conseguenza di quello che andavano
dicendo la Finsider e l’Iri, per motivi essenzialmente politici.
Gli anni a cui si riferisce lei [Ranieri], infatti, erano gli anni
del massimo potere di Emilio Colombo, che sembrava un politico
molto lanciato, anche su scala europea. L’obbiettivo principale
era quello di adoperarsi per continui incrementi e il fatto che
fosse stato abbandonato ogni serio proposito di ingrandire
97 Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 214
63
Piombino, significava spostare tutto il peso dell’espansione su
Taranto.98>>
4.3 Il crollo della Finsider
Il mutamento più grande della gestione Finsider si ebbe quindi con
la decisione di raddoppiare il centro siderurgico tarantino <<con
la conseguente “tarantizzazione” dell’Italsider99>>, un po’ com’era
stato fatto con la Cornigliano con la differenza che il centro
siderurgico tarantino non era sfruttabile al 100% data la sua
enorme mole e l’inesperienza della classe operaia e dirigenziale
nel gestire un centro siderurgico sul quale sarebbe ricaduto tutto
il peso dell’espansione siderurgica italiana per gli anni a
venire. Tuttavia fino al 1976 le capacità complessive di
produzione di ghisa del gruppo Finsider aumentano, oscillando tra
il 52% e il 53%, come aumentano anche le capacità di laminazione a
caldo del 61% e delle laminazioni dei prodotti piani dell’87%. Ma
dal 1976 l’espansione interna inizia la sua fase di stasi non
facendo registrare per tutto il decennio successivo alcun impegno
della gestione nell’integrazione verticale. Nel 1980 l’Italsider
risulta essere comunque ai primi posti in Europa per il suo
livello di avanzamento tecnologico ma, questa modernità non è
sfruttabile al massimo del suo potenziale a causa della gestione
maldestra e del forte periodo di stagnazione che fece seguito al
raddoppio di Taranto, in netto contrasto con le previsioni
dell’ultimo C.T.C., che tra il 1976 e il 1979 non permise il
98 Osti G.L., in Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p.25299 Ibidem, p. 253
64
superamento del 70% delle capacità del centro siderurgico
pugliese. La produttività, a partire dal 1968 non registra, per
circa 13 anni, alcun progresso, arrivando solo nel 1980 a toccare
il livello produttivo raggiunto nel 1968.
Le rosee aspettative del nuovo gruppo dirigenziale della Finsider,
che nel 1975 nominò presidente Alberto Capanna (già Direttore
Generale dell’azienda nel 1969, poi amministratore delegato tra il
1970 e il 1975), iniziano a scivolare in un vortice di decadimento
quasi senza fine, provocato, nella maggior parte dei casi, dalla
mancanza di una linea strategica lungimirante. Uno degli errori
più macroscopici imputato alla gestione di Alberto Capanna fu
l’allontanamento dai modelli industriali americani, che erano
stati il perno della ricostruzione e dell’avvio del ciclo
integrale nelle idee di Sinigallia e dei suoi continuatori
Marchesi e Manuelli, per approdare ad un nuovo modello, quello
giapponese, caratterizzato da un gigantismo tecnologico molto
apprezzato dal nuovo Presidente che però tese a sottovalutare la
ricaduta sociale e culturale che avrebbe provocato una gestione
degli impianti secondo questo nuovo modello nipponico. Ma il
modello nipponico, definito keiretsu, non era nuovo al paese, infatti
già dal finire della seconda guerra mondiale esso si pone come
modello d’impresa concorrente al modello conglomerale americano.
Le differenze tra i due modelli sorgono nella differente gestione
che nel caso americano prevede un quartier generale che sulla base
di alcuni rapporti finanziari deve determinare la politica del
gruppo e la distribuzione delle risorse tra le varie imprese; il
modello keiretsu invece è di tipo orizzontale e l’autonomia lasciata
all’azienda è quasi totale, in quanto hanno libertà di decisione
65
sui mercati, sugli investimenti ecc., con questo tipo di
organizzazione non nasce il bisogno di avere un quartier generale
fisso che prenda autonomamente le sue decisioni, infatti esso si
riunisce periodicamente giusto per uno scambio d’informazioni tra
i massimi dirigenti; il ruolo centrale in questo modello è svolto
dalla banca keiretsu che garantisce la solidità degli assetti
azionari assicurando la stabilità dei managers. Secondo Amatori e
Colli <<la scelta della conglomerata di separare il vertice dai
dirigenti operanti nelle aziende costituisce uno dei punti deboli
dell’economia americana, mentre il keiretsu rappresenta una pietra
angolare del successo giapponese. La lezione che si può trarre è
che un gran gruppo fortemente diversificato deve essere il più
possibile acefalo e lasciare il più ampio spazio all’autonomia del
management delle imprese che controlla. Per evitare serie fratture
fra azienda e quartier generale quest’ultimo deve essere quanto
mai leggero mentre decisa è la sua posizione di garante del
management.100>> Ma in Italia il modello nipponico non venne
assimilato del tutto, perché con la presenza del Ministero delle
Partecipazioni Statali, che dettava le linee guida di investimento
nei diversi settori, venne meno la presenza di un’organizzazione
acefala come quella nipponica, e si impediva così ad ogni singolo
settore di usufruire della libertà di movimento generale propria
del modello giapponese. Secondo Ranieri questa situazione nasce
proprio dalla cattiva gestione della Finsider da parte di Capanna
che <<esautorò progressivamente l’Italsider attraverso una
sovrapproduzione di funzioni che, di fatto, vanificano lo sforzo
di accentramento che era stato compiuto. Si poneva, così, un
100 Amatori F. Colli A., Impresa e industria in Italia. Dall’unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 1999, p. 285
66
modello di conglomerato, creando una struttura di vertice che
interferiva in vario modo nella vita delle società operative,
soprattutto attraverso l’appropriazione e riallocazione delle
risorse finanziarie, senza peraltro l’ambizione di dirigere dal
centro lo sforzo produttivo. Ne conseguiva il ritorno a una
confusione di responsabilità e di competenze, a cui l’esperimento
Italsider aveva tentato di porre fine.101>> Un’analisi un po’
differente fu quella di Saraceno riportata da Colli e Amatori:
<<Saraceno affermava che il sistema delle imprese pubbliche non
andava visto in senso gerarchico-unidirezionale dal vertice
politico alla base tecnico-manageriale, ma come un’arena di
confronto fra obbiettivi politici ed esigenze del management. Questa
posizione intellettuale è certamente di grande interesse, tuttavia
non resiste al confronto con la realtà.102>> E furono proprio i
dirigenti della Finsider che non avevano mai appoggiato del tutto
le idee di Sinigallia, e che proprio ora iniziano la scalata
all’interno della classe dirigenziale dell’azienda, che fanno
proprio questo modello di Partecipazione Statale con la
costruzione a Taranto del nuovo centro siderurgico.
Un altro errore imputabile a questa gestione e che emerge
dall’intervista a Osti fu il fatto che si iniziò a puntare più
sulla quantità di acciaio prodotto invece di riporre l’attenzione
sui prodotti finiti che, essendo più difficili da produrre, sono
quindi meno esposti alla concorrenza dell’acciaio semilavorato e
che si lasciò la produzione degli acciai speciali o in mano alle
piccole acciaierie private o in mano alla concorrenza straniera,101 Ranieri R., L’industria di Stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider, Il Mulino,Bologna, 1993, p. 82102 Amatori F. Colli A., Impresa e industria in Italia. Dall’unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 1999, p. 288
67
impersonata principalmente dalla Francia che proprio in quel
periodo edificò nei pressi di Marsiglia un nuovo centro
siderurgico a ciclo integrale per lanciarsi proprio sul mercato
mediterraneo. A conclusioni molto simili a Osti arrivano anche
Amatori e Colli <<I manager Finsider comprendevano lucidamente che
non era tanto importante la semplice espansione quantitativa
quanto la necessità di indirizzare i propri sforzi verso prodotti
specializzati ad alto valore aggiunto meno soggetti alla
competizione di nuovi paesi emergenti in campo siderurgico come il
Giappone in grado di ottenere irraggiungibili economie di scala.
Ma espansione quantitativa significava più occupazione e quindi
maggior consenso. Su questo terreno ha inizio un’alleanza fra il
potere politico e una parte del gruppo dirigente della Finsider
che non aveva mai accettato le idee di Oscar Sinigallia. Lo
stabilimento di Taranto, […], cresce enormemente negli anni ’70
per produrre acciaio a basso prezzo, senza alcuna strategia di
mercato. Per la Finsider è l’inizio della fine.103>>
Non fu solo naturalmente colpa di Capanna e del nuovo management
Finsider se l’azienda vide ridursi drasticamente i suoi bilanci di
anno in anno a partire dal ’75; uno dei motivi principali del
rallentamento, o meglio della regressione della siderurgia di
Stato è individuato da Margherita Balconi nel metodo di gestione
delle decisioni d’investimento e dei livelli occupazionali perché
<<le decisioni prese diventavano poi impegni vincolanti una volta
entrati a far parte dei piani del gruppo, che, invece di
configurarsi come strumenti flessibili e modificabili, in molti
casi si traducevano in veri e propri obblighi a sbagliare: della
103 Ibidem, p. 28868
loro attuazione infatti si doveva rendere conto al parlamento, ai
partiti e ai sindacati, ma non dei risultati economici a cui
conducevano.104>>
Conclusioni
Riepilogando possiamo affermare che il rilancio siderurgico
italiano, almeno nella sua prima fase di espansione ha dato i suoi
frutti. Il Piano di ricostruzione industriale ideato da
Sinigallia, che pone il complesso industriale formato da industria
siderurgica e meccanica, come punto focale del rilancio economico
italiano arriva ben presto a compimento; ne sono prova i livelli
produttivi che raggiunge Cornigliano, il nuovo centro a ciclo
integrale sul quale tanto aveva insistito Sinigallia, che già nel
1960 produceva il 17% della produzione nazionale di acciaio, il
50% di laminati piani a caldo e il 41% dei laminati piani a
freddo, con un superamento dell’utile netto sia nel 1959 che nel
1960 di tre miliardi e mezzo di lire.
Naturalmente questo rilancio industriale ed economico non sarebbe
mai potuto avvenire senza un alleato forte che era nella posizione
di investire capitali in Italia e Sinigallia e il suo management
ne erano a conoscenza. L’industria siderurgica italiana, dal
vertice alla base, venne messa in stretta collaborazione sin da
subito con le aziende americane. Lo ricorda benissimo Gian Lupo
Osti che si recava in America molto spesso e lo conferma
l’adozione da parte della Finsider del vademecum dello scientific
104 Balconi M., La siderurgia di Stato (1945-1990) Tra controllo pubblico e incentivi dello Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 251
69
management prodotto dalla Booz Allen-Hamilton o ancora i molti
accordi che la Finsider strinse con l’Armco e con la US Steel.
Questo perché Sinigallia era consapevole di aver bisogno di un
aiuto interno molto forte, come fu l’Armco, per riuscire ad
ottenere i fondi Erp e finanziare il suo progetto di rilancio
industriale della siderurgia. Non tutta la storiografia è però
concorde con questo modello di sviluppo di stile americano, in
quanto non tiene molto conto della reale situazione italiana che è
naturalmente molto differente dalla situazione americana. Infatti
Amatori è molto critico verso il modello di taylorismo importato
in Italia dagli USA perché non avvenne nessun adeguamento
nell’organizzazione delle aree tecnologiche in relazione
all’azienda, anzi per Amatori << l’esperienza di Cornigliano nel
secondo dopoguerra costituisce forse l’esempio più rilevante in
Italia di stretta collaborazione teorico pratica con il mondo
industriale americano per il quale, nonostante tutti i tentativi
di revisione, il paradigma tayloriano resta il punto di
riferimento fondamentale. >>
Non ci sono solo voci contrarie all’introduzione di alcuni modelli
di gestione americani in Italia. Molto apprezzato da Gian Lupo
Osti è infatti il sistema di Job Analysis e Job Evaluation atto a
ad analizzare e descrivere il contenuto dei lavori e a determinare
il valore relativo in una corrispondente scala di valutazione.
Motivo di tale valutazione fu principalmente l’abolizione delle
paghe <<che non trovavano riscontro in quel che l’operaio faceva
realmente>>, il mutamento delle paghe per quei lavori nei quali
era mutuata, rispetto al passato, la responsabilità e l’impegno
fisico e nervoso e in ultimo l’abolizione di quei posti di lavoro
70
<<che addirittura non avevano più ragion d’essere ma che, in un
modo o nell’altro, i sindacati erano riusciti a mantenere. >>
Indiscutibilmente però le idee di Sinigallia e l’apporto di
modelli gestionali americani portò l’industria siderurgica
italiana ad un livello molto più avanzato rispetto al periodo
prebellico, tanto che con l’introduzione della Proposta Schuman
nacquero anche ambizioni di unità doganale con la Francia e <<si
spingeva ad indicare che ciò avrebbe messo i due paesi nella
situazione di dirigere l’organizzazione stessa, quasi l’ambizione
di un asse italo-francese>>. Ambizioni che però vennero presto
smorzate perché lo scopo del Piano Schuman, come si evince dal
testo, era un altro e l’Italia non era che un attore di secondo
piano nel progetto della CECA; tanto che inizialmente vi furono
anche alcuni dubbi interni al paese sulla partecipazione ai
negoziati, dubbi che però vennero subito smorzati dalla paura che
provocava il rischio di restare fuori da questi accordi, che
avrebbero portato la posizione dell’Italia ,da quella di attore di
secondo piano, ad una posizione di marginalità assoluta in campo
internazionale.
I sei anni di transizione concessi all’Italia coincidono con il
primo momento di assestamento e di crescita della siderurgia
italiana e in generale di tutto il sistema economico italiano.
Grazie ad uno sviluppo delle produzioni più veloce del consumo e
alla forte domanda estera, nel 1956 l’Italia passa alla posizione
di esportatore netto di prodotti siderurgici. Parte della
storiografia esprime un commento positivo su questo periodo di
sviluppo della siderurgia italiana, imputando ad essa gran parte
del merito di aver chiuso gli impianti più obsoleti, di aver fatto71
aumentare il livello di produttività e di aver fatto avvicinare i
prezzi dei prodotti italiani a quelli della Ceca. Le imprese
pubbliche divennero senza dubbio le protagoniste di maggior spicco
del miracolo economico italiano, industria siderurgica in testa.
<<La formula ideata da Alberto Beneduce negli anni trenta che
prevedeva la proprietà statale per aziende operanti come le altre
sul mercato, sembrava “l’apriti sesamo” per un Paese impegnato
nella rincorsa di quelli di prima fila, che non disponesse però di
risorse finanziarie e manageriali private sufficienti per le
necessità dell’industria e in particolare per i settori ad alta
intensità di capitale: essa ci veniva invidiata e copiata.
Sull’onda dei successi ottenuti in campo petrolchimico,
siderurgico, automobilistico, lo Stato Imprenditore era avviato
alla sua massima espansione.105>>
Sull’onda del successo e in base alle previsioni del C.T.C. si
decise di aumentare i livelli produttivi del settore siderurgico.
Si pensò così alla costruzione di un nuovo centro siderurgico a
ciclo integrale. La nuova ubicazione doveva essere al Meridione, e
a tal proposito le spinte erano tante, soprattutto a causa delle
nuove leggi e che spingevano per una localizzazione al Sud. Come
emerge dal testo, l’Iri e la Finsider non furono molto d’accordo
inizialmente con le idee provenienti dall’ala riformista del
governo Fanfani, ma alla fine, grazie soprattutto all’appoggio di
Marchesi, ormai a capo della Finsider, si decise per la
costruzione del IV Centro Siderurgico italiano a Taranto.
105 Amatori F., Colli A., Impresa e Industria in Italia. Dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 1999, p. 281
72
I segnali di futuro sviluppo erano indiscutibilmente buoni, ma
forse l’entusiasmo fu troppo e il prezzo da pagare fu alto.
Certamente ricorda Osti da un punto di vista prettamente aziendale
probabilmente l’investimento più gusto si sarebbe dovuto fare a
Piombino, ma come visto le spinte contrarie furono molte. Taranto
però non disponeva di una cultura operaia di lungo corso, come fu
per Cornigliano e il progetto di Corniglianizzazione di Taranto
finì ben presto. Spinti infatti dalle rosee previsioni l’impianto
venne raddoppiato per ben tre volte, senza riuscire mai a
raggiungere la massima efficienza e i livelli previsti.
Non è certamente imputabile ad un ristretto gruppo di persone,
come neanche ad un ristretto numero di eventi la caduta dei
progetti italiani di espansione siderurgica dopo gli anni del
miracolo, di certo però i cambi di gestione della Finsider non
trovarono più quel gruppo di dirigenti accumunati, come ricorda
Barca, <<da un chiaro progetto strategico che oltrepassa la mera
vita di un’impresa o di un gruppo, per quanto rilevante, e
coinvolge in via duratura l’intero percorso di sviluppo di più
decenni.>>
73
Bibliografia
- Amatori F., La storia d’impresa come professione, Venezia, Marsilio
Editore, 2008
-Amatori F., Colli A., Impresa e Industria in Italia. Dall’Unità a oggi, Venezia,
Marsilio Editori, 1999
-Balconi M., La siderurgia di Stato (1945-1990) Tra controllo pubblico e incentivi dello
Stato, Bologna, Il Mulino, 1991
- Barca F., Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra a oggi, Roma, Donzelli
Editore, 1997
-Bianchi P., La rincorsa frenata. L’industria italiana dall’unità nazionale
all’unificazione europea, Bologna, Il Mulino, 2002
-Castronovo V., L’Industria italiana dall’Ottocento a oggi, Milano, Arnolodo
Mondadori Editore S.p.A
-Castronovo V, Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri, Torino,
Einaudi, 1995
- Giugni G.,Ascesa e Crisi del riformismo in fabbrica, Bari, De Donato Editore,
1976
74