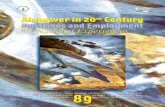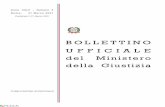sommario - Esercito Italiano - Ministero della Difesa
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of sommario - Esercito Italiano - Ministero della Difesa
S O M M A R I O
pag. 139
pag. 132
Myanmar o Birmania: dialogo più che sanzionidi Giovanni Bucciol pag. 16
La guerranel pensiero filosoficodi Sara Greggi pag. 100
Somalia 1995:Operazione «Ibis 3»di Leonardo Prizzi pag. 116
Il Legal Advisor «tattico»nelle operazioni militariterrestri all’esterodi Enrico Dubolino pag. 26
United States SergeantsMajor Academydi Raimondo Spasiano pag. 38
Afghanistan: Operazione Salamdi Fernando Termentini pag. 58
Gli Allievi Marescialli di oggidi Riccardo Venturinie Luca Giovangiacomo pag. 32
La robotica sempre più nel futuro di Pietro Batacchi pag. 48
SPECIALE EODGli ordigni esplosivi:l’Arma del genio al passo con i tempi
pag. 56
La lotta agli ordigni esplosivi improvvisati:Counter-IEDdi Giuseppe Fernando Musillo e Domenico Spoliti pag. 68
Presente e futurodell’Arma del genio a cura di Marco Ciampini pag. 94
Il nuovo centro dieccellenza nazionaleper il C-IEDdi Roberto Arcioni pag. 88
Operazione Salam 2 di Pierluigi Scaratti pag. 66
Le «Military Search»di Renato Scudicio pag. 74
3/2010maggio-giugno
PERIODICO DELL’ESERCITO DAL 1856
RUBRICHE
2
La collaborazione è aperta a tutti. Ampia libertà di trattazio-ne è lasciata ai collaboratori, anche qualora non se ne condi-vidano le opinioni.Gli scritti inviati, inediti ed esenti da vincoli editoriali, espri-mono le opinioni personali dell’Autore, che ne assume diret-tamente la responsabilità e garantisce il rispetto della nor-mativa vigente sul copyright rispetto a testo e immagini. «Ri-vista Militare», al momento dell’elargizione del compenso, neacquisisce automaticamente la proprietà e ne può disporresecondo quanto stabilito dalle leggi sull’editoria.Il materiale fornito, pubblicato o meno, non viene comunquerestituito.Gli elaborati, di grandezza non superiore a 10 cartelle in for-mato Word, devono essere resi disponibili su supporto carta-ceo e informatico (dischetti da 1,44 Mb, CD rom o e-mail),corredati da una breve sintesi (di massimo 10 righe) e da im-magini attinenti al tema trattato. In tal senso, sono preferibi-li fotografie a stampa convenzionale o immagini elettronichee fotografie digitali in formato non inferiore ai 300 dpi e20X30 cm di dimensione. Non sono idonee le fotografie informato Word o Powerpoint. Di quest’ultimo programma ècomunque possibile avvalersi per eventuali tabelle o illustra-zioni contenenti parti di testo.«Rivista Militare» si riserva la facoltà di cedere quanto pub-blicato, anche in forma parziale, ad altre pubblicazioni e pe-riodici associati all’E.M.P.A. (European Military Press Associa-tion) o a terzi previa concessione di specifica autorizzazione.Ogni collaboratore deve inviare, oltre a un breve curriculum,il proprio codice fiscale, un recapito telefonico e l’eventualeindirizzo e-mail.Tutti i dati personali forniti sono trattati secondo le vigentinorme sulla tutela della privacy.
norme di collaborazione
in copertinaIl nostro indirizzo e-mailè il seguente:
«Rivista Militare» ha lo scopo di estendere e aggiornare la preparazionetecnica e professionale del personale dell’Esercito e di far conoscere, allapubblica opinione, i temi della difesa e della sicurezza. A tal fine,costituisce organo di diffusione del pensiero militare e palestra di studio edi dibattito. «Rivista Militare» è quindi un giornale che si prefigge diinformare, comunicare e fare cultura.
EditoreMinistero della Difesa
Direttore ResponsabileMarco Ciampini
Capi RedattoriLuigino Cerbo, Giuseppe Fernando Musillo
RedazioneDomenico Spoliti, Roberto Zeppilli, Stefano Massaro, Claudio Angelini,Lorenzo Nacca , Annarita Laurenzi, Marcello Ciriminna, Lia Nardella
GraficaAntonio Dosa, Ubaldo Russo
Segreteria e diffusioneResponsabile: Riccardo De SantisAddetti: Franco De Santis, Carlo Livoli, Gabriele Giommetti, Giosuè Parolisi, Stefano Rubino, Sergio Gabriele De Rosa
La traduzione dei testi della rubrica “Sommario varie lingue” è curata da Nicola Petrucci, Livia Pettinau, Carla Tavares e Christel Galatzer
Direzione e RedazioneVia di S. Marco, 8 00186 RomaTel. 06 47357373 Fax 06 47358139
AmministrazioneUfficio Amministrazione dello Stato Maggiore dell’Esercito, Via Napoli, 42 Roma
Fotolito e StampaStilgrafica srlVia Ignazio Pettinengo, 31/33 - 00159 RomaTel. 0643588200 • e-mail: [email protected]
SpedizioneIn abbonamento postale 70% RomaTassa pagata - Taxe perçue
Condizioni di cessione per il 2010Un fascicolo Euro 2,10Un fascicolo arretrato Euro 4,20 Abbonamento: Italia Euro 11,40, estero Euro 15,50. L’importo deve essere ver-sato su c/c postale 22521009 intestato a Centro Pubblicistica dell’Esercito -Ufficio Amministrazione - Via XX Settembre 123/A - Roma. I residenti all’esteropossono versare l’importo tramite bonifico internazionale intestato a SME -Centro Pubblicistica codice IBAN IT70 P076 0103 2000 0002 2521 009 - codi-ce BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, con clausola «Commissioni a carico dell’ordinante»
Autorizzazione del Tribunale di Roma al n. 944 del Registro con decreto7-6-49
PeriodicitàBimestrale
© Tutti i diritti riservatiTutte le foto a corredo degli articoli, ove non altrimenti indicato, sonodell’Agenzia Cine Foto Televisiva e Mostre dello SMEL’editore si dichiara disponibile a regolarizzare eventuali spettanze dovutea diritti d’autore per le immagini riprodotte di cui non sia stato possibilereperire la fonte o la legittima proprietà
I teatri operativi hanno messo in luce la grave mi-naccia rappresentata dagli EOD (Improvised Explo-sive Devices). Mine, congegni inesplosi, ordigniesplosivi improvvisati sono le varie facce di un ne-mico subdolo e sempre in agguato.
virtù che hanno sempre distinto questi uomini e che hanno consentito loro di supe-rare le prove più dure, imponendosi sempre all’ammirazione e al rispetto di quanti,
combattendo al loro fianco o essendo loro avversari, li videro sul campo di battaglia.Il volume si articola in sei capitoli che scandiscono le epoche principali della
vita del Corpo:• dalla fondazione (18 aprile 1659) al Congresso di Vienna;
• dal Congresso alla dichiarazione della Prima guerra mondiale;• la Prima guerra mondiale;
• il Ventennio tra i due grandi conflitti;• la Seconda guerra mondiale;
• dal termine del Secondo conflitto al 31 dicembre 2009 (trecentocinquantesimo di vita).Ogni capitolo si articola in una presentazione del periodo interessato, a cura dell’autore,
in tabelle che riassumono le varianti ordinative e i principali combattimenti o attività opera-tive, nella descrizione particolareggiata di ogni episodio fondamentale, combinando tra loro
immagini, testimonianze e documenti.Inoltre il filo conduttore, che l’autore intende fare emergere tra le righe, è la continuità tem-
porale della Specialità che, specie nei momenti più tragici della storia del Piemonte prima (di-scesa in Italia di Napoleone) e dell’Italia successivamente (8 settembre 1943), è rimasta «in vita»
nelle varie strutture ordinative e salda nelle virtù e nelle tradizioni.Nell’ultimo capitolo, infine, sono riportate le testimonianze e le immagini delle cerimonie di Tori-
no dell’aprile 2009, di Goito, giugno 2009, e di Roma, ottobre 2009, nel corso delle quali, tra l’altro,è stata concessa la cittadinanza onoraria di tutte e tre le città al 1° Reggimento Granatieri.Per la realizzazione dell’opera è doveroso ricordare l’apporto fondamentale del Comando Re-
gione Militare Nord e dell’Associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino1706 e ringraziare la Fondazione CRT: questo libro è venuto alla luce solo grazie alla loro sensibi-
lità e al loro concreto e importante contributo. La pubblicazione è reperibile presso l’AssociazioneGranatieri di Sardegna, Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 7 - Roma.
Nell’aprile del 2009, la città di Tori-no ha ospitato il XXIX Raduno Naziona-
le dei «Granatieri di Sardegna». L’eventoè stato particolarmente importante in
quanto sono stati celebrati trecentocin-quanta anni da quel 18 aprile 1659 che
vide il Duca Carlo Emanuele II di Savoiafirmare l’editto che istituiva il «Reggimento
Guardie» o «Reggimento di Guardia», diret-to progenitore degli attuali «Granatieri di
Sardegna».L’occasione ha fornito al Generale Ernesto
Bonelli, Presidente del Centro Studi dell’Asso-ciazione Nazionale Granatieri di Sardegna, l’op-
portunità per scrivere un testo in chiave modernache potesse diffondere la storia della Specialità,
un racconto che fosse gradevole per tutti perchè ègiusto che coloro che amano l’Italia rivolgano lo
sguardo alla storia gloriosa di questi uomini cer-cando di cogliere, ciascuno nel proprio intimo, il
perchè di un così lungo passato e trarne insegna-menti e propositi per l’avvenire.
Il testo (tra l’altro voluminoso: circa seicento pagine,ovviamente per le innumerevoli gesta dei Granatieri) è
ricco di immagini, documenti e testimonianze, moltedelle quali inedite e, cosa importante, tutte conservate ed
esposte nelle sale del Museo Storico dei Granatieri, cheevidenziano, oltre alla famosa possanza fisica, le virtù
principali del Corpo: l’Onore Militare e la ferrea disciplina,
RUBRICHE - 6
Sono davvero tanti i secoli che hanno fatto lastoria dell’Esercito Italiano, quasi quattro conside-rando l’epoca preunitaria legata alle imprese mili-tari del reggimento delle «Guardie», precursoredell’attuale Forza Armata di professionisti, istitui-to nel 1659 dal Duca Carlo Emanuele II di Savoia.Un passato lungo e importante, scandito da gestamemorabili nella cornice storica del nostro Paese.Un lungo percorso che ha toccato il suo punto piùalto in epoca risorgimentale con il compimentodell’Unità d’Italia e la costituzione del neonatoEsercito Italiano, che quest’anno spegne le sue
149 candeline a memoria di quel lontano 4 mag-gio 1861, quando il Ministro della Guerra, Gene-rale Manfredo Fanti, decretava la fine dell’ArmataSarda e la nascita della nuova formazione militare.Un momento decisivo per la nostra identità nazio-nale, da ricordare e celebrare, come viene fattoormai dal 1998, anno in cui l’allora Capo di StatoMaggiore dell’Esercito, Tenente Generale France-sco Cervoni, istituì la Festa dell’Esercito. Da alloraun susseguirsi di emozioni che prendono forma incerimonie, eventi artistici e iniziative culturali tuttevolte a mettere in luce la storia e l’evoluzione del-la nostra Forza Armata dalle origini fino alla suaattuale configurazione. Ne emerge un camminostorico affrontato sempre con professionalità ededizione che hanno fatto dei nostri militari i piùaffidabili e preparati sullo scenario internazionale.Lo confermano le numerose missioni in teatri co-me il Kosovo, il Libano, l’Afghanistan, l’Iraq. Maanche sul piano interno hanno saputo distinguersiper i numerosi interventi nella salvaguardia dellelibere Istituzioni e nella tutela della collettività na-zionale nelle pubbliche calamità.
L’immagine attuale è quella di un Esercito incontinua evoluzione, sempre più moderno e alpasso coi tempi, un Esercito tecnologico, vicinoalla gente, orgoglio e vanto per il nostro Paese.
L’ESERCITO ITALIANOCELEBRA IL 149° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE
7 - RUBRICHE
Rivista Militare n. 3/2010
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, GIORGIO NAPOLITANO, AL CAPODI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, GENERALE DI CORPO D’ARMATA GIUSEPPE VALOTTO,
IN OCCASIONE DEL 149° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELL’ESERCITO ITALIANO«In occasione del 149° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, rivolgo il mio deferente pen-
siero alla bandiera della Forza Armata, simbolo di onore e valore militare, e ai soldati di ogni grado, Armae Specialità caduti nell’adempimento del dovere.
Nato il 4 maggio del 1861, subito dopo la proclamazione del Regno d’Italia, dalla fusione dell’ArmataSarda e di altre formazioni militari pre-unitarie, l’Esercito è stato protagonista della storia nazionale esaldo presidio della Patria negli eventi drammatici, dalla terza Guerra di Indipendenza alla Grande Guerra,dal Secondo conflitto mondiale alla Guerra di Liberazione, che ne hanno segnato l’esistenza, collocandoinfine l’Italia come grande democrazia nella Comunità delle Nazioni libere del XXI secolo.
L’Esercito, sin dalle sue origini, ha riflesso al suo interno la complessità e le diversità culturali e socialidel Paese, ha fatto di esse un proprio carattere distintivo e qualificante, una ricchezza di valori, un con-fronto di idee la cui amalgama ha contribuito, in pace e in guerra, alla nascita e alla condivisione di uncomune sentimento nazionale e, per questa via, al coronamento dell’unità d’Italia.
Attraverso un lungo e difficile processo di razionalizzazione e riorganizzazione ancora in corso, l’Esercitotradizionale del passato, basato sulla coscrizione obbligatoria e ancorato alla difesa dei confini nazionali, siè trasformato in un moderno strumento militare professionale, proiettabile in lontane regioni, capace dioperare in contesti diversificati multinazionali e multidisciplinari, impegnato in complesse missioni per lastabilizzazione di aree di crisi e per la pace.
Ufficiali, Sottufficiali, Volontari, Personale civile, potete essere a buon titolo orgogliosi di far parte di unaistituzione prestigiosa e determinante per il futuro dell’Italia. A voi e ai vostri familiari, anche a nome ditutti gli italiani, rivolgo un riconoscente e affettuoso augurio ed esprimo il mio più vivo apprezzamentoper quanto avete fatto e state facendo per il nostro Paese e per la comunità internazionale.
Viva l’Esercito Italiano, viva le Forze Armate, viva l’Italia!».
Roma, 4 maggio 2010.
RUBRICHE - 8
ORDINE DEL GIORNO ALL’ESERCITOFesta dell’Esercito
Il 4 maggio di 149 anni fa, il Ministro della Guerra del Governo «Cavour», Generale Manfredo Fanti, decretòche il Regio Esercito assumesse l’appellativo di Esercito Italiano; era la diretta conseguenza della solenne pro-clamazione del Regno d’Italia, avvenuta a Torino il 17 marzo 1861 e confermava la volontà di rendere la ForzaArmata, oggi custode di 351 anni di storia, artefice dell’Unificazione delle tradizioni degli Eserciti preunitari.
Da allora, accogliendo tra le sue file, sotto il Tricolore, uomini e reparti provenienti da ogni regioned’Italia, l’Esercito, oltre ad essere stato protagonista delle campagne per la conquista dell’Indipendenza edell’Unità nazionale, assurse anche al ruolo di fattore di aggregazione e diffusione di valori unitari e pa-triottici, nel tormentato e laborioso processo di unificazione degli italiani.
Nel corso dei due conflitti mondiali la Forza Armata, forte di quell’inestimabile retaggio acquisito ancheattraverso le guerre risorgimentali, ha saputo far fronte, con determinazione e saggezza, a durissimeprove che ne hanno cimentato la capacità di reazione e lo spirito, non intaccandone mai l’integrità moraleanche in contesti politici e militari critici e controversi. l soldati italiani si batterono ovunque con onorecontribuendo, durante la Guerra di Liberazione, con consapevole e decisiva prova, a gettare le fondamen-ta di un nuovo ordinamento nazionale eretto sui valori della libertà e della democrazia.
La storia più recente, caratterizzata da cambiamenti epocali nell’assetto geopolitico e geostrategico mon-diale, ha visto l’Esercito assumere una accresciuta valenza quale strumento non solo al servizio della so-vranità nazionale, ma, anche e soprattutto, a sostegno della politica estera e di sicurezza del Paese. Lo te-stimoniano le Unità dell’Esercito che, impiegate in molteplici aree di crisi internazionali e con una presenzamedia di oltre settemila soldati fra uomini e donne, hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore pro-fessionalità, flessibilità e capacità di proiezione nei contesti più disparati, guadagnandosi così riconosci-menti in ambito internazionale, ma pagando, purtroppo, un pesante tributo in termini di vite umane.
L’impegno dell’Esercito non si esaurisce con le attività all’esterno dei confini nazionali. È proprio sul no-stro territorio, infatti, che la Forza Armata è chiamata a recitare un ruolo principale nel fornire supporto intutte quelle situazioni di crisi che vanno dal soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, come ilterremoto dell’Abruzzo, allo svolgimento delle attività di controllo del territorio in concorso alle forze dipolizia. I risultati lusinghieri conseguiti parlano chiaro: la presenza dei soldati per le strade è riuscita adare un nuovo impulso al contrasto alla criminalità organizzata, ha rafforzato la presenza dello Stato e hagarantito condizioni di sicurezza per i cittadini. Con l’intervento in Campania per l’emergenza rifiuti,l’Esercito ha anche dimostrato di essere una risorsa disponibile per risolvere situazioni di particolare di-sagio per la popolazione.
Celebriamo quindi con legittimo orgoglio l’odierna fausta ricorrenza, grati alle Istituzioni e ai cittadiniper la loro vicinanza, il loro sostegno e la loro affettuosa partecipazione alla nostra vita di ogni giorno.
Con questi sentimenti, mi è gradito inviare a tutti gli uomini e le donne della Forza Armata il mio piùconvinto ringraziamento per l’impegno profuso al servizio della Nazione e l’augurio di sempre maggio-ri fortune.
Roma, 4 maggio 2010.
IL CAPO DI SM DELL’ESERCITOGenerale di Corpo d’Armata Giuseppe Valot-
Ma anche un Esercito che non dimentica la tradi-zione, il proprio passato, quel sapore antico chesolo può conferire il senso di identità e dare si-gnificato all’azione presente.
Il primo degli eventi celebrativi, in ordine ditempo, il 13 aprile, è il concerto tenuto dallaBanda musicale dell’Esercito, alla presenza delCapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale diCorpo d’Armata Giuseppe Valotto, e di altre per-sonalità civili e militari, presso la sala Sinopolidell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Larappresentazione musicale, oltre all’esecuzionedi prestigiose musiche della Banda Militare, havisto anche l’esibizione di due artiste di fama in-ternazionale, Katia Ricciarelli e Ivana Spagna.Quest’ultima ha riproposto tra l’altro la canzone«Sentinella» dedicata ai nostri soldati. Inoltre,nel corso della serata è stato premiato il CaporalMaggiore Giuliano Razzoli, neo campione olim-pico di sci ai Giochi invernali di Vancouver. Se-gno questo del grande prestigio raggiunto dagliAtleti della nostra Forza Armata.
Successivamente, il 4 maggio, il Capo di SME hainaugurato una mostra statica di mezzi e tecno-
9 - RUBRICHE
Rivista Militare n. 3/2010
logie, presso l’Altare della Patria e il Foro Traia-no, e una mostra storica al Vittoriano che rimarràaperta al pubblico fino al 4 novembre. Dal 4 al 6maggio i mezzi e gli equipaggiamenti dell’Eserci-to hanno attirato l’attenzione di un pubblico, co-stituito anche dai tanti turisti di passaggio, inte-ressato e vicino ai nostri soldati. Antichi mezzidel Regio Esercito e soldati a cavallo in uniformestorica hanno fatto da contraltare alla modernitàdella nostra Forza Armata, rappresentata da si-mulatori di volo, dall’elicottero «Mangusta», dai
RUBRICHE - 10
veicoli robot, dalla Blindo «Centauro» e dal su-pertecnologico e moderno Veicolo Blindato Medio(VBM) «Freccia», il cui primo esemplare è statoconsegnato nel 2009. Tutto ciò sulla scia di quelprogetto di digitalizzazione che costituisce il va-lore aggiunto a quella dedizione e professionalitàche hanno sempre contraddistinto gli uomini e ledonne «con le stellette».
La mostra al Vittoriano, «Storia dell’Esercito Ita-liano. Il Volontariato dal Risorgimento alle mis-sioni internazionali», scandisce le tappe più im-portanti di un affascinante percorso storico cheha visto protagonista l’Esercito nelle tante vicis-situdini della nostra Patria. È dedicata alla storiadel Volontariato militare dalle origini ai giorninostri, caratterizzati dagli impegni internazionaliche vedono i nostri soldati in prima linea nel-l’opera di normalizzazione e ricostruzione perrestituire a tante popolazioni la speranza di unfuturo migliore.
Ma è stata la cerimonia del 6 maggio il momentoculminante delle celebrazioni. Alla presenza delPresidente della Repubblica Giorgio Napolitano,del Ministro della Difesa Ignazio La Russa e dellealte cariche civili e militari, sul prato dell’ippodro-mo militare di Tor di Quinto si sono schierate laBandiera di Guerra dell’Esercito e una Brigata diformazione su tre reggimenti. È questa una piccolarappresentanza dei nostri soldati, motivo di orgo-glio per tutti gli italiani, come anche sottolineatodal Ministro della Difesa, On. Ignazio La Russa:
RUBRICHE - 14
«Sapere che i nostri ragazzi con le stellette ognigiorno fanno davvero qualcosa, sia in Patria cheall’estero, per la nostra sicurezza e tranquillità esono garanzia di libertà e democrazia delle istitu-zioni ci riempie di orgoglio». Sullo stesso tono leparole del Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Generale di Squadra Aerea Vincenzo Camporini,che ha rimarcato come l’Esercito sia «in prima li-nea chiamato a sostenere l’onere più consistentenell’ambito dei dispositivi interforze, a confermadelle caratteristiche di flessibilità, di proiezione, diefficienza ed efficacia dei suoi reparti». Tutto ciòpresuppone un impegno concreto da parte delleistituzioni: «Farò tutto ciò che è in mio potere», haaggiunto il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito,Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Valotto,«affinché ogni risorsa disponibile sia impiegataavendo sempre ben chiaro lo scopo ultimo del no-stro essere soldati: servire il Paese e i suoi cittadi-ni».
Al termine dei discorsi ufficiali, il Capo delloStato ha consegnato, tra le varie onorificenze, le«Croci d’Onore alla Memoria» ai familiari dei ca-duti nell’attentato di Kabul del 17 settembre2009. Segno questo della riconoscenza e vicinan-za del nostro Paese a quanti credono nel sacrodovere della difesa della Patria e dei fondamentalidiritti umani.
15 - RUBRICHE
Rivista Militare n. 3/2010
MM YY AA NN MM AA RR OO BB II RR MM AA NN II AA ::DD II AA LL OO GG OO PP II ÙÙ CC HH EESS AA NN ZZ II OO NN II
La Birmania o Myanmar, non è mai stata nota algrande pubblico fino al 26 ottobre del 2007, quan-do la Giunta Militare, guidata dal Generale ThanShwe, ha deciso di impiegare la 66° Divisione del-l’Esercito, la stessa che aveva messo a tacere pocotempo prima la ribellione della minoranza Karen,per reprimere la pacifica protesta dei monaci bud-disti e dei laici. Era dal 18 settembre che i monacimarciavano in forma non violenta per risponderealla dura repressione, avvenuta qualche tempo pri-ma, della manifestazione pacifica di Pakokku con-tro il rincaro (del 500%) dei carburanti. Verso quelripetersi di marce, le unità dell’Esercito, tra i più ef-ficienti dell’Asia, tenevano un atteggiamento mo-derato e, in alcuni casi, simpatizzante. Sino ad al-lora, i monaci avevano dato luogo a proteste non
politiche con obiettivo il Paese e il rispetto della re-ligione. Ma quando la Lega Nazionale per il Partitodella Democrazia (AFPEL), quello della Nobel per lapace Aung San Suu Kyi, ha chiesto ai monaci di is-sare i suoi vessilli, la protesta da pacifica ed apoli-tica si è trasformata in politica. È così iniziata labrutale repressione della Giunta, di cui abbiamoavuto testimonianze televisive. In quei giorni, ilmondo intero, in segno di solidarietà coi monaci ecol popolo birmano, indossò qualcosa di rosso.
ORIGINI STORICHE
Risale al 289 a.C. la preistoria degli indigeniMiamma o Brama o Birmani, che vivono in un ter-ritorio di 670 000 kmq con più di 50 milioni diabitanti. Inizialmente senza unità politica, questapopolazione è retta da un Governo dispotico di va-ri Re e capi tribù, costantemente in guerra tra lo-ro, spinti solo dal desiderio di saccheggio o di se-te di vendetta. Il solo legame tra i birmani è reli-gioso, ed implica un esagerato spirito di sottomis-sione al Sovrano. La religione buddista dei birma-
OIKOS - 18
MYANMAR O BIRMANIA:DIALOGO PIÙ CHE SANZIONI
Myanmar è l’acronimo indicante la vecchia Birmania, formato dalle iniziali delle sette etnie componenti loStato. Si deve alla Giunta Militare nel 1988 il cambio di denominazione, quando sperava di contrastare lespinte secessioniste, specie dei Kachin del Nord, degli Shan del Centro e dei Karen del Sud.Dopo la dura repressione attuata dal Governo contro i monaci e la popolazione nell’ottobre 2007, sono sce-se in campo le più importanti organizzazioni internazionali per sostenerne le istanze di libertà e benesserevolte a un sano sbocco democratico della situazione. Tuttavia, aziende statali indiane, cinesi, tailandesi epersino europee e americane non esitano a fare «affari d’oro» con la Giunta. Quest’ultima intende procede-re a riforme burocratiche e sociali, perché sente «il fiato sul collo» dei consoci dell’ASEAN, (l’Associazione deiPaesi del Sud-Est Asiatico), di cui fa parte dal 1997. La comunità internazionale vorrebbe che fosse la Cinaa far pressione sulla Giunta per i suoi eccessi sulla popolazione e sui prigionieri politici. Tutti, Italia compre-sa, sono d’accordo nel privilegiare il dialogo per pervenire a una ragionevole soluzione. La situazione si è poiulteriormente aggravata con lo spaventoso tsunami che ha colpito il Paese all’inizio di maggio 2008.
A sinistra.La bandiera nazionale del Myanmar.
In apertura.Il fiume Irrawaddy.
ni è di benevolenza e non di terrore, come il bra-mismo degli indiani. Il Prete, o Punghi, è amato enon temuto. È mantenuto dalla comunità e, incambio, educa i giovani nella scuola monastica. Letruppe, poco disciplinate, sono armate e mante-nute da pubbliche spese e ogni maschio adulto èsottoposto gratuitamente alla milizia del Sovrano.
Dopo varie vicende storiche, la popolazione è af-flitta da un’interminabile guerra (1824-1886), chesi rivela disastrosa per i birmani. Si combatte con-tro i successori di Re Alaung Paya, unificatore del-l’Alta e Bassa Birmania, detro-nizzato da Tharawadi, acerrimonemico degli inglesi. Questi ul-timi, appoggiati da una coali-zione di Principi, sbarcano nel1845 a Rangoon ed estendono illoro dominio a tutto il territorio.Nel 1886 la colonia è dichiarataprovincia dell’Impero indiano.Nel 1943 diventa autonoma. LaLega per la Libertà nel 1944conquista un po’ di potere, maun gruppo di reazionari uccide il leader, il giovaneAung San, padre della Nobel, e altri. Per tutta ladurata della Seconda guerra mondiale la Birmaniaè occupata dai giapponesi. Il Paese nel 1945 è li-berato da truppe americane, inglesi e cinesi. L’ac-cordo di Londra del 1947 concede l’indipendenza
alla Birmania che assume il nome di «RepubblicaSocialista di Birmania» e nel 1948 quello di «Unio-ne Federale Birmana».
MA LE DENOMINAZIONI NON BASTANO
Il Primo Ministro della nuova Unione, impegnatodal 1948 al 1954 contro la guerra civile scatenatadall’etnia dei Karen, ribelli comunisti, e dalle scor-rerie dei soldati cinesi nazionalisti fuggiti dalla Ci-na di Mao, non ha il tempo per dedicarsi all’orga-nizzazione politica e amministrativa del giovaneStato, ove prevalgono corruzione e affarismo.
Nel 1958, si instaura la prima dittatura milita-re anticomunista del GeneraleNewin e inizia l’isolamento dalmondo; nel 1960 l’AFPEL ot-tiene una schiacciante vittoriaelettorale e viene istallato unsecondo Governo. Ma Newinnel 1962, con un colpo di Sta-to, ripristina la dittatura mili-tare, proclama nuovamente lalotta ai comunisti e naziona-lizza le banche contrastandoferocemente la coltura del-
l’oppio. Due anni più tardi sopprimerà tutti ipartiti.
Nel 1981 si intensifica la campagna d’isolamen-to e la Birmania esce dall’associazione dei Paesinon allineati. Nel 1990 si tengono le prime elezio-ni libere dal 1962. Vince la Lega Nazionale per la
19 - OIKOS
Rivista Militare n. 3/2010
...quando la Lega Naziona-le per il Partito della Demo-crazia...ha chiesto ai monacidi issare i suoi vessilli, laprotesta da pacifica ed apo-litica si è trasformata in po-litica
“
”
Una manifestazione di protesta di monaci buddisti nel2007.
Democrazia con l’80% dei suffragi sotto la guidadella figlia di Aung San, la signora Aung San SuuKyi. Ma le elezioni vengono annullate dal regimemilitare, che reinstaura il potere assoluto del1988. In seguito all’istituzione del Consiglio per ilripristino della legge e dell’ordine, lo SLORC, e,dopo una rivolta popolare soffocata nel sangue, ilnome del Paese muta da «Repubblica Socialistadell’Unione di Birmania» a «Myanmar», o «Unionedei Myanma» in lingua birmana, ossia l’acronimo,formato dalle iniziali di tutte le etnie componentilo Stato. Nell’ottobre del 1991, Aung San Suu Kyiottiene il premio Nobel per la pace. Nell’aprilesuccessivo il Generale Saw Maunh è costretto a la-sciare il potere e gli subentra l’attuale Capo dellaGiunta Militare, il Generale Than Shwe. Il nuovoCapo, quale atto di clemenza, nel settembre dellostesso anno, revoca parzialmente le misure ecce-zionali in vigore dall’89. Nel 1994 viene approva-ta la nuova Costituzione, elaborata appositamen-te per impedire alla Nobel di essere nominata Pre-sidente. Quest’ultima viene messa agli arresti do-miciliari, poi revocati. Nel novembre 1997 il Go-verno assume la denominazione di «Consiglio diStato per la Pace e lo Sviluppo». Intanto Aung SanSuu Kyi continua la sua opera di contestazionetanto che viene riarrestata, liberata e poi rimessaagli arresti domiciliari. In questo periodo la Bir-mania è all’attenzione internazionale per viola-zione dei diritti umani e traffico di cocaina. Nel2003 la Giunta arriva alla chiusura delle Universi-tà e lancia lo slogan «Grano, riso e mais al postodell’oppio». Da allora la produzione di droga è
scesa del 40%, ma i produttori l’hanno diversifica-ta con metanfetamine, subendo così poche perdi-te. Nel 2004 la Lega Nazionale per la Democraziarifiuta il dialogo col Governo. Si dichiara a favoredi una convenzione nazionale e della liberazionedella figlia di Aung San. Il Primo Ministro si dimo-stra aperto al dialogo con l’opposizione ma vienesostituito col Ministro Soe Win, vicino al Presiden-te. Ciò allontana la speranza di una svolta politi-ca del Paese, sempre più isolato sul piano regio-nale, dove alcuni Stati ne reclamano l’espulsionedall’Organizzazione, e sul piano internazionale,dove la politica illiberale del regime è stata con-dannata con sanzioni economiche dalla Russia, UEe Giappone, ma non da Cina e India.
Ad aggravare la situazione economico-sociale,si è aggiunto il ciclone «Nargis», che nella nottetra il 3 e il 4 maggio 2008 ha provocato uno tsu-nami che nel sud del Myanmar ha ucciso 100 mi-la persone e ne ha lasciate senza tetto più di unmilione. Trasformando la tragedia da umanitariain politica, il Governo ha autorizzato subito Cina,India e Russia, Paesi che non si pongono tantedomande sul rispetto dei diritti umani, a interve-nire. Per contro, cedendo al tragico bisogno, solodopo 5 giorni la Giunta Militare ha consentito l’in-gresso alle zone colpite sia all’ONU sia alle nume-rose ONG, i cui aspiranti soccorritori hanno fattola coda fuori dall’Ufficio Visti della propria Amba-sciata a Bangkok sin dal primo giorno. Anchel’Italia ha partecipato ai soccorsi offrendo un mi-lione di euro per tende, depuratori d’acqua, gene-ratori, kit sanitari e altro. Da parte sua il Governoè intervenuto con durezza nello sgombero forza-to di alcune migliaia di sopravvissuti che avevanooccupato abusivamente alcuni istituti scolastici.
OIKOS - 20
Monaci buddisti.
Altri sgomberi forzati sono stati eseguiti nellearee d’interesse di un progetto di sfruttamento digas naturale, per far spazio a ditte cinesi che vilavoravano. Si dice anche che molti sopravvissutiabbiano ricevuto aiuti e assistenza in cambio delvoto a favore della bozza di Costituzione sottopo-sta a referendum il 24 maggio. Molti aiuti sonostati sequestrati, dirottati e venduti in concomi-tanza del succitato referendum, che, secondo laGiunta, ha avuto il 98,1% di votanti col 92,4% disuffragi a favore. In questo periodo sono staticreati nuovi prigionieri «di lungo corso» tra i dis-sidenti pacifisti, per lo più poeti, commediografi,scrittori e gente di spettacolo.
Tra questi privilegiati prigionieri, non poteva es-sere tralasciata la Premio Nobel Aung San Suu Kyi,che l’11 agosto 2009 è stata condannata a 3 annidi lavori forzati, mutati in 18 mesi di arresti domi-ciliari su ordine speciale del Generale Than Shwe.Pur sfruttando, per comodo, un articolo della vec-
chia Costituzione del 1974, abolita nel 1988, ilCapo della Giunta Militare spera così di tener fuo-ri della mischia il Partito della Nobel in occasionedelle elezioni politiche del 2010. La Signora SuuKyi ha scritto una lettera alla Giunta Militare di-chiarandosi disposta a rafforzare la cooperazionetra il Governo e l’opposizione democratica permetter fine alle sanzioni della comunità interna-zionale. La Giunta Militare, a seguito della richie-sta, ha nominato un Ministro apposito per i rap-porti con la Nobel, che sembra essersi ammorbidi-ta nei confronti del regime. Essa intende anche in-contrare i diplomatici dei Paesi intenzionati a to-gliere le sanzioni economiche. Anche il Presidente
Obama e il suo Segretario di Stato hanno mostra-to interesse alla collaborazione, tesa a favorire ilprocesso di «riforme politiche» e a contrastarel’influenza economico-commerciale della Cina. Il 9ottobre 2009 l’UE ha fatto sapere di essere dispo-sta a rispondere positivamente, se vi sarà la ricon-ciliazione politica con la nuova era di cooperazio-ne e l’instaurazione di una vera democrazia.
Col nuovo anno, non temendo nemmeno la nuo-va aria di rivolta che spira nella vicina Thailandia,il regime ha varato una legge elettorale, definita«ingiusta e repressiva» dalla comunità internazio-nale. Tale legge prevede che «i detenuti, qualiAung San Suu Kyi, non possano appartenere a unpartito». Pertanto, se la Lega Nazionale per la De-mocrazia (LND), partito vincitore delle elezioni del1990, non espellerà il suo Capo, oggi agli arrestidomiciliari, verrà sciolta. Per rivalsa, l’LND non si èregistrata alle prossime elezioni, a causa delle li-mitazioni imposte dal regime.
LE MINORANZE ETNICHE, UN GROSSO PROBLEMA
Nel corso del 1999 la campagna d’intimidazionee di repressione contro gli aderenti alla Lega Na-zionale per la Democrazia si intensifica e si esten-de alle minoranze etniche dei Kachin, dei Shan edei Karen. Il Paese è difficilmente governabile perla sua natura plurietnica. L’Unione del Myanmar è
21 - OIKOS
Rivista Militare n. 3/2010
Sopra.Il Presidente della Giunta Militare, Generale Than Shwe.
A sinistra.Il Premio Nobel per la pace e leader dell’opposizione,Aung San Suu Kyi.
costituita da sette Stati etnici, più sette divisioniamministrative. Il grosso problema sono le etnieche costituiscono le sette lettere del nuovo nomedella Birmania, studiato apposta per «ammorbidi-re» le forti pretese d’indipendenza di tali Stati. Inparticolare, è dal 1961 che i Kachin, uno dei piùimportanti gruppi etnici, insediatisi nel territorioposto tra l’Assam indiano e lo Yunnan cinese, so-no in conflitto con Rangoon. L’Esercito per l’Indi-pendenza del Kachin, il Kio, inizialmente si alleacon i comunisti per opporsi all’Esercito birmano enel 1994 sembra aprirsi uno spiraglio di speranzacol Governo centrale. Le cose, però, non vanno peril verso giusto, perché mentre da un lato il Kioesercita il contrabbando di legname da costruzio-ne coi trafficanti cinesi, dall’altro l’Esercito nazio-nale costringe gran parte della popolazione ai la-vori forzati; lo Stato degli Shan, posto più a sud delKachin in un desolato altipiano, è dal 1948 in lot-ta contro il potere centrale che non gli ha ricono-sciuto l’indipendenza prevista dagli accordi diLondra. Le due milizie, che da oltre 50 anni sonoin conflitto con Rangoon, lo Shan State Army e loShan State National Army, si sono fuse da qualcheanno in un’unica milizia etnica, guidata da un exsignore della droga di origini cinesi. I colloqui colpotere centrale sono durati per dieci anni, ma lamancata osservanza delle condizioni di consegnadelle armi e di apertura alle riforme democratichefa naufragare ogni dialogo.
A sud, al confine con la Thailandia vi è lo Statodei Karen, i cui tre milioni di abitanti costituiscono
il gruppo etnico maggiore dopo quello birmano. Sivocifera che i continui attacchi dell’Esercito cen-trale contro i villaggi dei Karen siano finalizzati acreare una cintura di sicurezza attorno alla nuovacapitale Naypyidaw, voluta dalla Giunta Militare inosservanza di un antico principio strategico chepone la capitale al centro dello Stato. L’insistenteoffensiva dei militari governativi potrebbe ancheessere conseguente ad accordi presi con la Thai-landia per la costruzione di una serie di chiuse nelfiume Sittang, che determinerebbe la deportazio-ne di gran parte della popolazione Karen. Comun-que, le operazioni militari comportano l’espatriocoatto di molte famiglie nella vicina Thailandia: almomento vi sarebbe un milione e mezzo di sfolla-ti nei campi profughi allestiti da organizzazioni in-ternazionali. Lungo il confine con lo Yunnan cine-se operano anche gli Wa, gruppo etnico di originecinese, forse diretti discendenti delle truppe cine-si che nel 1873, durante la disastrosa guerra bir-mana, ne invasero la parte settentrionale brucian-
OIKOS - 22
Sotto e a destra.Gli effetti del ciclone «Nargis».
do molte città. Un tempo, essi costituivano l’ossa-tura della guerriglia comunista repressa dalletruppe centrali. Hanno una milizia di 20 000 com-battenti che difendono i traffici di oppio prodottoin gran quantità nella zona. Si dice che esponentidella Giunta al potere siano in combutta con que-sti gruppi ribelli per il narcotraffico e ciò alimentail sospetto di commistione tra malavita e politica.
AFFARISMO A SCAPITO DEL RISPETTO UMANO
La Birmania è ricca di gas naturale, di legname, dipetrolio e di diamanti. Vi operano aziende cinesi,indiane, tailandesi, giapponesi e persino italiane,delle quali ben 78 hanno scambi commerciali e in-dustriali. Ma è il gas naturale la vera ricchezza. Ungrosso giacimento è stato scoperto non tanto tem-po fa di fronte alla costa dello Stato di Arakan. Nel-la città di Sittwe è stato costituito un consorzio peril gas tra la Myanmar Oil And Gas Enterprise, la sud-coreana Daewoo International e altre aziende stataliindiane e sudcoreane. Il 24 settembre 2007 l’azien-da indiana di proprietà statale Oil And Natural GasWidesh ha firmato un accordo con la Myanmar OilAnd Gas Enterprise per l’esplorazione di altri treterritori offshore del gas, impegnandosi per 150milioni di dollari. Mentre il Ministro indiano firmal’accordo, migliaia di manifestanti birmani scendo-no in piazza per chiedere libertà politica, fine degliabusi e miglioramento delle condizioni economiche.La stima produttiva per quei giacimenti va dai 37 ai45 miliardi di dollari, con un possibile introito tota-le dai 12 ai 17 milioni in venti anni per la Giunta eper i futuri Governi. È stato stimato che il 50% di taliproventi andranno all’Esercito. Nell’aprile 2007 vie-ne approvata la costruzione di ungasdotto di 2 380 km che dalporto birmano di Sittwe porterà ilgas a Kunming, capitale delloStato cinese dello Yunnan, attra-verso i Monti Arakan. In 30 anniporterà ben 170 miliardi di metricubi di gas dal Medio Orientesenza passare per lo Stretto diMalacca.
L’assistenza finanziaria del FMIe della Banca Mondiale, di cui èmembro dal 1952, è stata sospe-sa fin dal 1988, perché la Birma-nia è «Paese povero e fortemente indebitato». Il Go-verno ha quindi cercato di adottare efficaci strategieper ottimizzare le procedure di commercio conl’estero e per liberalizzare il commercio interno edestero. Gli investitori stranieri possono investire nelMyanmar e le banche possono aprire loro uffici dirappresentanza. Il Paese partecipa ai programmi dicooperazione regionale e collabora molto coi Paesi
sviluppati e in via di sviluppo per il proprio avanza-mento tecnologico. Il Governo centrale, a detta del-la Giunta, sta facendo di tutto per ridurre il gap eco-nomico tra la popolazione rurale e quella urbana.Comunque, tanto il FMI quanto la Banca Mondialeinviano spesso loro rappresentanti per monitorarela situazione economica del Paese. Al momento no-nostante venga ripetuta la richiesta di appoggioeconomico-finanziario, i due istituti si sono rifiuta-ti di togliere le restrizioni sul prestito per alleviare ildebito della Birmania. La Giunta è inserita nell’ASE-AN, che vuole partecipare alla creazione di una zo-na di libero scambio commerciale, di tipo europeo,con l’Australia e la Nuova Zelanda. Il 25 agosto2007 i 10 membri dell’associazione hanno deciso diespandere commerci e scambi finanziari con gli
USA. Ma l’obiettivo è eliminarele dogane all’interno del gruppoper contrastare la concorrenzadi India e Cina. E questo per oranasconde i problemi internicausati dal regime.
Nel 2005 lo scambio com-merciale tra USA e ASEAN èstato di 152 miliardi di dollari:ciò dovrebbe favorire un cam-biamento di rotta del Governodel Myanmar. In caso contrario,gli altri membri ASEAN esige-ranno la separazione tra gli im-
pegni assunti dal gruppo verso gli USA e le que-stioni interne di ogni singolo Stato.
Dal gennaio 2008 sono liberalizzati anche gliscambi commerciali con Australia e Nuova Zelan-da, che nel 2005 hanno raggiunto un volume di35,6 miliardi di dollari, pari a un aumento del 23%.Anche la Cina, entro il 2010, vorrebbe creare unazona di libero scambio con l’ASEAN, ma veri e tan-
23 - OIKOS
Rivista Militare n. 3/2010
La Birmania è ricca di gasnaturale, di legname, di pe-trolio e di diamanti. Vi ope-rano aziende cinesi, indiane,tailandesi, giapponesi e per-sino italiane, delle quali ben78 hanno scambi commer-ciali e industriali. Ma è il gasnaturale la vera ricchezza
“
”
Trasporto di aiuti umanitari dopo il ciclone «Nargis».
gibili progressi sono impediti dai problemi internidi ogni Stato, dalle sciagure naturali, dalla diffusapovertà e dalle differenze economiche e politiche.
PRIVILEGIARE IL DIALOGO
Le aziende cinesi e indiane fanno affari d’oro conla Giunta Militare, alla quale «richiedono» di aste-nersi dalle brutali repressioni con il pretesto cheogni Stato è libero di risolvere i propri problemisecondo la propria etica. Si ritiene, comunque,che, nonostante una certa influenza sulla Giunta,anche la stessa élite di Governo stia beneficiandodi queste relazioni, che si diramano sino alle ban-che di Singapore. Sono state proposte sanzionimirate a congelarne i conti per non opprimere ul-teriormente la popolazione con ristrettezze deri-vanti dall’embargo: uno strumento efficace per«ammorbidire» la repressione e sollecitare il rila-scio dei prigionieri politici. Con l’aiuto della Cina,però, permane una situazione di «doppio gioco»,nonostante anche gli USA ammoniscano l’ASEAN anon compromettere la propria credibilità per la si-tuazione birmana. Qualche tempo fa, la stampa hadato risalto all’arresto del noto cantante G-Tone,perché durante un’esibizione ha mostrato alla fol-la il suo «tatuaggio religioso». In esso erano raffi-gurate due mani giunte in segno di preghiera. E imilitari al potere temono la religione. Il 20 novem-bre 2007, il vertice annuale di Singapore ha re-spinto la richiesta USA di sospendere il Myanmardall’ASEAN, che, al contrario, intende risolvere laquestione attraverso il dialogo. Uno spiraglio diluce sembra aprirsi con la firma, annunciata dalMinistro degli Esteri birmano, Nyan Win, della Car-ta Regionale dell’ASEAN, che impegna al rispetto
degli accordi «anche in materia di democrazia e didiritti umani». A Pechino il Generale Than Shwe, hapromesso di accelerare i tempi per l’adozione dimisure «positive e pragmatiche» per dare corso al-la road map, varata dalla Giunta nel 2003, versoriforme burocratiche. Anche in Italia, il 13 settem-bre 2007, praticamente agli inizi della protesta deimonaci buddisti, e prima della sanguinosa repres-sione, il Senato ha approvato una Risoluzione sul-la Birmania. Nella relazione si lamenta che pressoil Consiglio di Sicurezza dell’ONU del gennaio2007 la Risoluzione, sostenuta anche dal nostroGoverno, ha incontrato il veto di Cina e Russia.
UNA PROTESTA CHE VIENE DA LONTANO
Ormai è cosa nota che il processo di decolonizza-zione, verificatosi nel periodo tra il 1945 e il 1950, èstato dettato più dalle esigenze politiche delle vec-chie potenze coloniali, che non dalla «maturità» del-le loro Colonie. Questo vale soprattutto per la Birma-nia, diventata, come detto, «Myanmar» per le molte-plici etnie che costituiscono il Paese e che pretende-vano l’autonomia e l’indipendenza. Nel 1988 laGiunta Militare sperava così di acquietare la mareamontante secessionista dei vari gruppi etnici. Il nuo-vo Stato si rivelò subito una creazione artificiale, et-nicamente eterogeneo, privo di una robusta struttu-ra politico-amministrativa, che oscillava tra un Go-verno forte e una democrazia più o meno liberale. Seavesse aderito al Commonwealth, come era statoproposto all’atto della concessione dell’indipenden-za, forse la Birmania avrebbe avuto un altro destino.Ma la classe dirigente considerava le risorse naturalidel Paese come ricchezze private.
La Guerra Fredda, poi, ha avuto il tragico effetto difar piovere sul continente asiatico i capitali con cui ledue superpotenze cercavano di conquistare la fedel-tà del Governo locale. Da qui colpi di Stato, guerre ci-vili, conflitti, di cui ancora oggi si vedono le conse-guenze. Lo Stato, quindi, ha sempre incontrato gran-de difficoltà nel ristabilire la pace e l’ordine. Con ilMyanmar, poi, gli affari degli investitori stranieri, ap-poggiati dai rispettivi Governi, hanno sempre sopras-seduto sulla necessità di pretendere la garanzia e ilrispetto dei diritti civili. E mentre l’ONU condanna ilregime, alcuni Paesi fanno affari d’oro. L’affarismointernazionale nel corso della Guerra Fredda, e anchedopo, per il traffico di armi e di droga, ha inventato ilsistema della «triangolazione». Le merci venivanovendute a uno Stato apparentemente neutrale che lecedeva al suo associato, bisognoso della stessa mer-ce. Anche nel nostro caso, sarebbe utile applicare lo
OIKOS - 24
La Pagoda Shwedagon a Yangon (Rangoon) vista dallasponda opposta del lago Yangon.
stesso principio nei confronti della Cina, molto «sen-tita» nei Paesi asiatici con cui ha rapporti commercia-li. Si tratterebbe di invitare Pechino a spingere laGiunta ad assumere un atteggiamento più moderato.Si garantirebbe così un po’ di respiro a chi protestaper avere pace, giustizia e ripartizione di ricchezza.
CONCLUSIONI
Nell’era della globalizzazione non esistono piùconflitti o crisi locali d’interesse esclusivo all’area incui si sviluppano. Essi riguardano tutti, in particola-re anche gli Stati europei, che non hanno confiniben definiti con il continente asiatico. Si sa che ilrappresentante speciale dell’ONU, Ibrahim Gamba-ri, ha ottenuto diversi importanti risultati: la libera-zione degli arrestati delle manifestazioni di settem-bre, la possibilità per Aung San Suu Kyi di riprende-re contatto col suo partito dopo tanto isolamento, lanomina di una rappresentanza della Giunta al pote-re per i rapporti con tale partito, il National Leaguefor Democracy, il NID, la dichiarazione della stessaleader di disponibilità a un vero, libero e incondi-zionato dialogo. Ciò interessa le comunità etniche,le espressioni civili e religiose, per elaborare e scri-vere una nuova Costituzione.
È importante capire che le sanzioni economichesono un mezzo, non un fine. È una leva che va usa-ta con prudenza, perché non colpiscano il popolobirmano. Per questo l’UE intende promuovere, attra-verso le istituzioni internazionali, la CRI, l’Organiz-zazione Internazionale del Lavoro, l’Alto Commissa-rio ONU per i Rifugiati e altre organizzazioni, deiprogrammi positivi di aiuto umanitario, di lotta allapovertà, di cooperazione nellascuola, nell’educazione e nel la-voro. In questo c’è buona volontàanche da parte della Giunta.
Dopo lo spaventoso tsunamiabbattutosi nel sud del Paese,agli inizi di maggio del 2008, laGiunta Militare è stata accusata dinon aver dato credito al preavvi-so del Dipartimento Meteo India-no, che aveva indicato il puntod’impatto e forza del ciclone «Nargis». Solo dopocinque giorni l’ONU è stata autorizzata a intervenireper far fronte a fame ed epidemie. L’aspetto più gra-ve è che sono accettati solo gli aiuti, permane cioèun atteggiamento di chiusura del Governo verso glistranieri; alle numerose ONG non è permesso entra-re, e si sono viste code fuori dall’ufficio visti delleambasciate a Bangkok sin dal primo momento. An-che la Farnesina ha offerto un milione di euro di soc-corsi in tende, depuratori d’acqua, generatori e kitsanitari. Il punto è chi distribuisce questi aiuti, vistoche non viene accettato il personale idoneo e lo si
vuole fare in proprio.La situazione, ha, quindi assunto le dimensioni di
una tragedia umanitaria, dalle conseguenze incalco-labili. In tale contesto non si è rinunciato nemmenoa far votare la popolazione per la bozza della nuovaCostituzione birmana che avrebbe ottenuto il 90%delle preferenze nel referendum del 10 maggio. Co-me annunciato dai media di Stato, secondo i qualicirca il 92,4% degli elettori ha detto sì. Caratterizza-ta da intimidazioni, brogli e ricatti sui cittadini per-
ché approvassero il testo, che neppure conoscono, laconsultazione «truffa» si è svolta in due terzi delPaese. In 47 Municipalità nelle Divisioni del delta del-l’Irrawaddy e Yangon, devastate dal ciclone, ha avu-to luogo il 24 maggio. In questo caso il voto è statoposticipato a causa del disastro abbattutosi nel Pae-se il 3-4 maggio che ha causato oltre 100 000 mor-ti. La nuova Costituzione non è un buon presagio,
perché consolida il potere deimilitari e di fatto legittima lo sta-tus quo: un regime dittatorialedei più cechi al mondo.
Infine, come per il Pakistan,dove la situazione dopo lamorte violenta della leader Be-nazir Bhutto e l’elezione di suomarito a Presidente della Re-pubblica, è alquanto precaria,anche per il Myanmar vi sono
confini incerti. I suoi vicini potrebbero essere po-tenziali avversari, la società è composta in buonaparte da etnie e tribù, fiere della propria autono-mia e insofferenti del potere centrale. La sua reli-gione, l’Islam, un tempo il solo elemento unifica-tore, oggi è fattore di divisione più che di unità.Anche qui vale il principio che, laddove la politicaè debole e non riesce ad affermare i suoi assiomi,le Forze Armate sono inevitabilmente forti.
Giovanni BucciolGenerale di Divisione (ris.)
25 - OIKOS
Rivista Militare n. 3/2010
Contadini al lavoro nei campi.
È importante capire che lesanzioni economiche sonoun mezzo, non un fine. Èuna leva che va usata conprudenza, perché non colpi-scano il popolo birmano
“
”
LEGAL ADVISOR, CONSULENTI E CONSIGLIERI
«Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Par-ti in conflitto in periodo di conflitto armato cure-ranno che dei consiglieri giuridici siano disponibi-li, quando occorra, per consi-gliare i comandanti militari dilivello appropriato circa l’appli-cazione delle Convenzioni e delpresente Protocollo, e circa l’in-segnamento appropriato da im-partire in materia alle Forze Ar-mate». Questa definizione, con-tenuta nell’art. 82 del I proto-collo dell’8 giugno 1977 addi-zionale alle convenzioni di Gi-nevra del 12 agosto 1949, rac-chiude l’essenza di una posizione che solo nel re-cente passato ha cominciato a essere formalmen-te e continuativamente prevista anche negli orga-nici dei contingenti nazionali impiegati all’estero.
La locuzione anglosassone Legal Advisor è, ad
oggi, quella più frequentemente utilizzata in ambi-to nazionale, anche a fronte dell’assenza di un cor-rispettivo e univoco termine in lingua italiana. Men-tre, infatti, con «consulente legale» si tende a iden-tificare l’Ufficiale che in Patria è investito della riso-
luzione di problematiche giuri-diche «nazionali», per quanto,invece, afferisce ai corrispon-denti incarichi nei Teatri Opera-tivi (T.O.) esteri coesistono:• la qualifica di «consigliere giu-ridico», formalmente attribuita(ai sensi del citato art. 82 del IProtocollo Addizionale del 1977)ai militari incaricati di consigliarei comandanti militari di livelloappropriato circa l’applicazione
del Diritto Internazionale Umanitario-DIU (1) ovve-ro, volendo più esaustivamente indicare l’interocomplesso delle regole connesse al fenomeno deiconflitti armati, del Diritto Internazionale dei Con-flitti Armati- DICA (2);
• la denominazione di «consigliere legale» (3), ri-ferita a Ufficiali posti, in operazioni all’estero, al-le dirette dipendenze del Comandante e aventil’incarico di fornire consulenza principalmenteper quanto attiene ai mandati delle missioni, al-le restrizioni all’uso della forza, al trattamentodegli autori o sospetti di crimini, all’applicazionedelle Regole di Ingaggio (Rules of Engagement-
LOGOS - 28
IL LEGAL ADVISOR «TATTICO» NELLE OPERAZIONI MILITARI
TERRESTRI ALL’ESTEROIl consulente giuridico è oggi, a pieno titolo, una delle componenti essenziali dello special staff del Coman-dante del Contingente schierato in Teatro di Operazioni. L’esperienza maturata nell’ambito delle operazioni militari all’estero dell’ultimo decennio ha, peraltro, evi-denziato come l’assolvimento delle «missioni» demandate al consulente giuridico presenti uno «spettro» dipotenziale implementazione fortemente differenziata.
...una posizione che solonel recente passato ha co-minciato a essere formal-mente e continuativamenteprevista anche negli organi-ci dei contingenti nazionaliimpiegati all’estero
“
”
In apertura.Blindo «Centauro» in Libano.
A sinistra.Un Alpino controlla il territorio di competenza.
ROE), agli accordi internazionali.Allo stato, si ritiene che, volendo trovare un’al-
ternativa alla denominazione anglosassone, po-trebbe essere utilizzata quella di «consulente giu-ridico» (4), in tal senso indicativa, come meglio siespliciterà in seguito, del duplice e inscindibilecampo d’azione (nazionale ed estero).
COLLOCAZIONE ORGANICA, DIPENDENZE ED AT-TRIBUZIONI
Le pubblicazioni militari nazionali emanate inmateria di operazioni all’estero fanno usualmentegenerico riferimento a una funzione di «consulen-za legale» inserita nel Modulo Comando e al di fuo-ri dello Stato Maggiore, ovvero a singoli Ufficiali,parimenti posti alle dirette dipendenze del Coman-dante del contingente, quali «consulenti speciali»(special staff). Le Direttive Operative Nazionali(D.O.N.), emanate dal Comando Operativo di Verti-ce Interforze (COI), analogamente, prevedono chela posizione sia ricoperta da un Ufficiale posto ge-rarchicamente alle dirette dipendenze del Coman-dante di Contingente. Dal punto di vista tecnicofunzionale, il Legal Advisor (LEGAD) dipende, inve-ce, in Teatro Operativo dal LEGAD del Comandosovraordinato e, verso la Patria, dall’Ufficio Legaledel COI, mente e motore di tutte le operazioni mi-litari all’estero delle Forze Armate nazionali. Ana-logamente, il consulente giuridico di Contingentecoordina e controlla gli omologhi Ufficiali eventual-mente presenti presso le dipendenti Task Force,rapportandosi costantemente anche con quelli deiComandi collaterali (figura 1).
In merito alle competenze, nonostante l’ormaicontinuativa presenza di contingenti nazionali inmolteplici T.O. esteri, l’effettiva sfera di azione deiLEGAD non è stata finora formalmente sancita inunivoche job description, bensì, di volta in volta,sostanzialmente rimessa alla discrezionalità delComandante che determina se e in quali terminifruire delle prestazioni del suo LEGAD che, dal-l’ipotesi di più ampio coinvolgimento nella dina-mica complessiva delle operazioni (come «filtro»di legittimità giuridica dei prodotti di tutte le areefunzionali), può limitarsi a particolari casi di con-sulenza giuridica «pura».
Ove si volesse tentare di individuare, comunque,l’ambito delle attività ordinariamente rimesse alLEGAD, si dovrebbero distinguere aspetti di carat-tere sia «nazionale» sia «internazionale».
LE COMPETENZE DI CARATTERE «NAZIONALE»
Le attività di carattere nazionale sono quelle ordi-nariamente svolte dal consulente legale «tattico» in
Patria, quale Ufficiale ormai organicamente postoalle dirette dipendenze del Comandante di Brigata.Tali competenze possono giungere a comprendere,nella loro massima espansione, la diretta trattazio-ne di tutte le pratiche aventi valenza disciplinare,penale, amministrativa, civilistica, etico-comporta-mentale e, in senso generale, giuridico-legale.
L’immissione in T.O. del consulente legale com-porta, quindi, che egli continui a rispondere, ancheall’estero, alle medesime attivazioni ascrittegli inPatria. In particolare, possono individuarsi le se-guenti aree:• attività in sede (stasi operativa): tutte le attività
di competenza del consulente legale in Patria;• approntamento: predisposizione di Standing Ope-
rational Procedures (SOP), Direttive a caratterepermanente (assetto formale e norme di compor-tamento del personale all’interno o all’esterno del-
le basi; limiti al consumo di alcolici; utilizzo distrumenti video-fotografici a carattere privato;molestie sessuali e attività discriminatorie; impor-tazione/esportazione di beni da/per il T.O.; liberauscita; fruizione delle postazione internet) nonchécircolari (a titolo indicativo: incidenti/eventi checoinvolgano personale e beni dell’A.D.; assicura-zione del personale della Difesa impegnato in mis-sioni Fuori Area; sanzioni disciplinari di Corpo; di-sciplina), finalizzate a uniformare a livello Contin-gente la trattazione di procedure routinarie a rile-vanza giuridico-legale ovvero a dettare norme co-muni di comportamento;
• condotta:•• redazione della messaggistica e delle relazioni
tecnico-disciplinari/relazioni tecniche (ovverocoordinamento e controllo sull’analoga attivitàdi competenza delle unità dipendenti), nei casidi incidenti/eventi che coinvolgano personale ebeni dell’Amministrazione della Difesa;
•• monitoraggio delle rilevanze penali e dei conse-guenti iter processuali (in collaborazione con ilpersonale dell’Arma dei Carabinieri);
29 - LOGOS
LOGOS
Rivista Militare n. 3/2010
Fig. 1
••verifiche di legittimità delle sanzioni discipli-nari e consulenze procedurali;
••partecipazione alle commissioni di monito-raggio della regolarità delle prestazioni di be-ni e servizi da parte delle imprese civili e co-ordinazione delle azioni da intraprendere neicasi di inadempienza;
•• rapporti con le Forze di Polizia, la Magistratu-ra (in coordinazione con l’Arma dei Carabi-nieri), l’Avvocatura dello Stato e, in generale,
con Avvocati e patrocinatori legali;•• redazione di direttive etico-comportamentali;••consulenza giuridico-legale alle cellule del
Comando e alle unità dipendenti;••eventuale assistenza legale generale al perso-
nale.
LE COMPETENZE DI CARATTERE «INTERNAZIONALE»
L’attività più spiccatamente peculiare del LEGAD inoperazioni all’estero è, comunque, quella afferenteall’ambito di interpretazione e applicazione del DICA.
In particolare, possono rilevarsi i seguenti ambiti:• attività in sede (stasi operativa):
••raccolta e aggiornamentodelle pubblicazioni e docu-mentazione di riferimento;
••rappresentazione alle Au-torità sovraordinate delleeventuali esigenze di ag-giornamento delle disposi-zioni in vigore;
•• indottrinamento e aggior-namento (diversificati se-condo i vari livelli di responsabilità) del per-sonale del reparto/ente;
••partecipazione alle attività addestrative delreparto, al fine di assicurarne l’aderenza aidettami giuridici;
••verifica dell’attuazione presso il reparto/ente
delle predisposizioni inerenti il DICA (con-trassegni, emblemi di protezione, tessere);
••aggiornamento sulla materia di interesse at-traverso la partecipazione a convegni, semi-nari e conferenze e l’acquisizione di docu-mentazione disponibile in ambito nazionale einternazionale;
• approntamento:••esame del mandato internazionale/nazionale
al fine di verificare i contenuti e la conformitàal Diritto di Bandiera; indirizzare il G2/J2 e ilG3/J5 nella stesura dell’Operation Order(OPORD) sotto il profilo del diritto; individua-re lo status giuridico delle parti in conflitto eulteriori informazioni di natura sociale; indi-viduare persone, luoghi e beni oggetto diprotezione;
••esame dello Status of Forces Agreement (SO-FA) allo scopo di individuare lo stato giuridi-co delle Forze e i limiti alla sovranità delloStato in cui la missione opera;
••redazione dell’Allegato «Legal» e «ROE» al-l’OPORD;
••effettuazione di cattedre itineranti in materiadi aspetti legali e ROE a favore dei reparti diprevisto impiego;
••predisposizione di vademecum di caratteregiuridico da distribuire ai partecipanti al-l’operazione;
••predisposizione di SOP, direttive, circolari edocumenti di approfondimento di tematichegiuridiche e codici comportamentali delle Or-ganizzazioni Internazionali entro le quali sidovrà operare;
• condotta:••consulenza al Comandante, alle Cellule e alle
Task Force in materia di applicazione del di-ritto internazionale;
••emanazione e aggiornamento di procedure edirettive;
•• verifica delle conformità al diritto delle armi edei mezzi impiegati e dei meto-di di condotta delle operazioni;•• verifica dell’aderenza delleROE al diritto, con individuazio-ne di eventuali difficoltà inter-pretative e applicative, anche fi-nalizzate a modifiche e varianti;•• intervento diretto in sede dipredisposizione o ricezionedelle procedure di standardiz-zazione del comportamento dei
militari della Forza, all’occorrenza di specificieventi indicatori di ostilità da parte di sogget-ti esterni;
••effettuazione di briefing/incontri con il per-sonale del contingente per approfondimentiinformativi;
LOGOS - 30
Un militare italiano sulla torretta di un «Dardo».
L’assolvimento delle fun-zioni assegnate al LEGAD ri-chiede la predisposizione diun adeguato «zaino normati-vo», in cui stivare gli stru-menti giuridici necessari...
“
”
••mantenimento dei contatti diretti con i LEGADcollaterali, sottordinati e sovraordinati;
••consulenza e diretta partecipazione, per gliaspetti di interesse, in merito alla stipula diaccordi, Memorandum of Understanding(MoU), protocolli d’intesa con le Autorità lo-cali e con le parti in conflitto;
••quotidiana coordinazione con il Provost Mar-shal e la Polizia Militare;
••redazione dei riscontri alle Autorità sovraor-dinate a seguito di incidenti;
•• instaurazione e monitoraggio delle pratiche (oattività di coordinamento e controllo sull’ana-loga attività delle Task Force) di assicurazio-ne del personale della Difesa impegnato inmissioni Fuori Area.
LO «ZAINO NORMATIVO»
L’assolvimento delle funzioni assegnate al LEGADrichiede la predisposizione di un adeguato «zainonormativo», in cui stivare gli strumenti giuridici ne-cessari per affrontare e risolvere ogni possibile atti-vazione nei settori di interesse. In particolare, sonoalmeno tre gli «scomparti» da riempire (figura 2): or-dinamento internazionale; ordinamento della HostNation; ordinamento dello Stato di bandiera e deglialtri Stati della Coalizione. Tali ambiti sono, ulterior-mente, connessi tra loro a mezzo di SOFA, norme dicoordinamento della Nazione ospitante e scambi dilettere a livello diplomatico. Dai predetti ambiti nor-mativi di riferimento generale, discendono, per cia-scuno Stato, i «prodotti» dell’attività di pianificazio-ne a livello strategico, operativo e tattico.
CONCLUSIONI
Il consulente giuridico è oggi, a pieno titolo, unadelle componenti essenziali dello special staff delComandante del contingente schierato in Teatro diOperazioni. L’esperienza maturata nell’ambito delle
operazioni militari all’estero dell’ultimo decennio ha,peraltro, evidenziato come l’assolvimento delle «mis-sioni» demandate al consulente giuridico presentiuno «spettro» di potenziale implementazione forte-mente differenziata. Nella prassi, infatti, l’effettivocoinvolgimento del LEGAD nel ciclo delle operazioni- pur a fronte degli sforzi, anche dottrinali, operatidal COI, vera «stella polare» nella costellazione giuri-dico-militare nazionale - resta sostanzialmente de-mandato alla volontà del Comandante, anche in rap-porto alla competenza e professionalità del suo col-laboratore. In tal senso, pertanto, applicando le cate-gorie della pianificazione operativa, si potrebbe sin-teticamente concludere che - dato l’End State dellamissione assolta in piena legittimità giuridica - ilCentro di Gravità (consulenza giuridica pronta, effi-cace e aderente) potrà essere raggiunto solo se, alconseguimento del primo Decisive Point (formalizza-zione di una condivisa job description), seguirà anchequello dell’organico e razionale inquadramento deiLEGAD quale Corpo o, almeno, Ruolo a se stante,magari unificato a livello interforze.
Enrico DubolinoMaggiore, in servizio
presso lo Stato Maggiore dell’Esercito, III RepartoImpiego delle Forze/Centro Operativo Esercito
NOTE
(1) Il Diritto Internazionale Umanitario tradizionalmente ri-comprendeva i cosiddetti «Diritto dell’Aja» (relativo alla di-sciplina dell’uso della violenza bellica tra i belligeranti edai rapporti tra belligeranti e neutrali, con fonte principal-mente nelle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907) e «Di-ritto di Ginevra» (relativo alla protezione delle vittime deiconflitti armati e della popolazione civile e sviluppatosidalla Convenzione di Ginevra del 1864). Tale dicotomia èstata, infine, superata, grazie ai 2 Protocolli Addizionalidell’8 giugno 1977 relativi alla protezione delle vittime deiconflitti armati internazionali e non internazionali.(2) Secondo la dottrina dominante, «Diritto Internazio-nale dei Conflitti Armati» sarebbe la dizione più onni-comprensiva, facendo riferimento a: ius ad bellum (ov-vero il diritto a ricorrere alla forza armata); condottadelle ostilità e i rapporti tra belligeranti e Stati terzi (iusin bello, diritto bellico o diritto dei conflitti armati insenso stretto); disarmo e controllo degli armamenti.(3) Stato Maggiore dell’Esercito, Reparto Impiego delleForze - Ufficio Dottrina, Addestramento e Regolamenti,Il Comando e Controllo, edizione 1999, Parte I, capitoloIII, paragrafo 2, pagina 63.(4) L’aggettivo «giuridico», inteso etimologicamente come:«di diritto, relativo al diritto» (dal latino iuridicus, compo-sto di ius iuris «diritto» e tema di dicere «dire»), sembrapreferibile a «legale», ristretto all’ambito «della legge»,dall’etimo latino legalis, derivato di lex legis «legge».
31 - LOGOS
LOGOS
Rivista Militare n. 3/2010
Fig. 2
Negli ultimi anni, a seguito delle radicali trasfor-mazioni che hanno caratterizzato la nostra ForzaArmata nell’ambito del delicato compito della for-mazione dei futuri Comandanti delle minori unità,un ruolo di primo piano è stato affidato alla Scuo-la Sottufficiali dell’Esercito, fucina dei nuovi Co-mandanti di plotone.
Per la formazione dei nuoviMarescialli, si è deciso di inve-stire sia sul personale prove-niente dalla vita civile o conuna limitata esperienza milita-re, sia sul personale già in ser-vizio permanente (VSP o Ser-genti) al quale viene così datala possibilità di potersi miglio-rare e contribuire, con il pro-prio bagaglio tecnico-professionale già acquisitonel reparto di provenienza, all’elevazione tecni-co-professionale di tutta la categoria dei Mare-scialli Comandanti di plotone.
Il cammino formativo degli Allievi Marescialli del-la Scuola (unico sia per il personale civile o con unalimitata esperienza militare del concorso «pubbli-co» che per quello già militare vincitore del concor-so «interno»), svolto a similitudine di quanto in at-to per gli Allievi Ufficiali, è volto a conferire un’ec-cellente qualificazione lavorativa e a perfezionarela preparazione professionale di ogni Allievo persvolgere l’incarico di Comandante di plotone.
Questo percorso se da un lato prevede la con-dotta di attività didattiche a livello universitarioche contemplano il conseguimento della laureadi primo livello in Scienze Organizzative e Ge-stionali (per gli Allievi Marescialli che scelgono laspecializzazione «Comando») e di Scienze infer-mieristiche (per gli Allievi che scelgono la spe-cializzazione «Sanità»), dall’altro mira alla for-mazione tecnico-professionale di ciascun Allievoche, oltre a distinguersi come militare, propo-nendosi come modello esemplare per tutti, do-vrà essere preparato al compito di comandaredegli uomini.
I VALORI DI RIFERIMENTO
Ogni frequentatore del corso apprende, nei treanni di studio, ad affermarsi come leader, a farsi
stimare, a ispirare fiducia e afarsi rispettare. Inoltre, com-prende a quali risultati può am-bire se comanda con la forzatrascinatrice dell’esempio, seriesce a coltivare le doti di ener-gia, decisione, iniziativa, costan-za e perseveranza ma compren-de anche cos’è il senso del do-vere, della disciplina, della re-sponsabilità perché, citando
Sant’ Agostino, alla Scuola si impara che «un Co-mandante deve saper servire perché colui che co-manda deve esercitare la propria autorità a vantag-gio del bene collettivo». È del tutto evidente che, per
LOGOS - 34
GLI ALLIEVI MARESCIALLI DI OGGIOggi l’incarico di Comandante di Plotone richiede sempre più responsabilità, motivazione oltre a un adegua-to bagaglio di conoscenze Tecnico-Militari. In tal senso la formazione professionale assume un’importanzadecisiva. Negli ultimi anni, in questo ambito, la Scuola Sottufficiali dell’Esercito ha ricoperto un ruolo centra-le divenendo «fucina» dei nuovi Comandanti di Plotone.
Ogni frequentatore del cor-so apprende, proprio nei treanni di studio, ad affermarsicome leader, a farsi stimare, aispirare fiducia...
“
”
Sopra.Una compagnia di Allievi Marescialli durante una ceri-monia.
In apertura.Allievi Marescialli in addestramento.
operare alla testa di altri uomini, è necessaria sial’assimilazione di valori di riferimento (senso del-l’onore e del dovere, sacrificio e coraggio morale efisico) sia una preparazione iniziale scientifica eumanistica più che adeguata.
Non a caso il nome di ciascun corso Allievi Ma-rescialli è una delle qualità che il Comandantedeve fare proprie per assolvere al meglio il com-pito a lui assegnato. Qualità come l’Esempio, ilDovere, l’Onore, la Fedeltà, l’Osare, la Fermezza,la Volontà, la Fierezza, la Dignità, la Tenacia el’Orgoglio.
L’iter formativo particolarmente complesso eprolungato nel tempo ha, quindi, lo scopo di for-nire agli interessati tutti gli strumenti professionaliper svolgere agevolmente i futuri incarichi. È im-portante una frequenza attiva e partecipe, la con-sapevolezza della valenza delle istruzioni ricevute,soprattutto alimentando giorno per giorno quellemotivazioni di fondo che lo hanno portato a sce-gliere tale professione.
LA MOTIVAZIONE
Ma cosa spinge una persona, uomo o donna chesia, ad aderire totalmente ai principi che caratte-rizzano la vita militare rinunciando agli agi e allecomodità di un lavoro più tranquillo?
35 - LOGOS
LOGOS
Rivista Militare n. 3/2010
CERIMONIA DI CONSEGNA DELLO SPADINOAL XII CORSO
Le spade, prime armi «specializzate» (solo per ilcombattimento), nascono nell’età del rame e si svilup-pano attraverso quella del bronzo e del ferro diventan-do l’arma regina del combattimento ravvicinato.
In quanto tale, nell’arco dei secoli, ha costituito og-getto di dono, di prestigio, d’Onore, di giustizia e diculto, divenendo così fonte di leggenda e di simbolo-gie di particolare fascino. La sciabola, giunta durantele invasioni turche, si affianca rapidamente alla spadae assorbe parte delle tradizioni e usanze a questastrettamente legate, per giungere, ai giorni nostri, asoppiantarla quasi del tutto.
Nel mondo moderno, con l’avvento dell’arma dafuoco, l’arma bianca lunga ha perduto ogni significa-to come tale ma ha assunto la caratteristica di arma didotazione di reparti d’Onore, accessorio per parate esimbolo per gli Allievi di Accademie e Scuole Militari.
Tra il 1871 ed il 1876, il Ministro della Guerra Ge-nerale Ricotti-Magnani, procedette ad una serie di ri-forme destinate a rendere più funzionale e omogeneol’Esercito del nuovo Regno d’Italia, lasciando l’utilizzodelle sciabole come prerogativa dei soli reparti a ca-vallo, degli Ufficiali e dei Sottufficiali.
Con la fine del Secondo conflitto mondiale, nel1945, e il riordinamento delle Forze Armate, le armibianche assumono un ruolo esclusivamente d’insegnae di grado, di rappresentanza, di cerimonia.
Con l’inizio degli anni Sessanta viene ufficialmentesancito il ripristino della sciabola per gli Ufficiali e Sot-tufficiali, con disposizione dell’allora Ministro della Di-fesa Giulio Andreotti, come arma di rappresentanza,mentre compaiono come simbolo della tradizione gli«spadini» per le varie Accademie e Scuole Militari.
La cerimonia di consegna dello spadino assume aigiorni nostri un importantissimo significato simboli-co: rappresenta l’investitura ufficiale di Allievi Mare-scialli per i neo reclutati.
Chi sono gli Allievi Marescialli di oggi? Qual è laloro estrazione sociale?
Da un’analisi effettuata su un campione di 455allievi (X, XI, XII Corso Allievi Marescialli) emergo-no dati significativi e utili a rispondere a questedomande.
Innanzitutto, grazie a un pregevole lavoro direclutamento, il personale vincitore di concorsorisulta altamente selezionato, a conferma delbuon riscontro che la professione militare in ge-nere, e il lavoro altamente qualificante nellospecifico, hanno nella società giovanile.
Per quanto riguarda il bacino di reclutamento,da un’analisi delle aree geografiche di provenien-za emerge palesemente che coloro che decidonodi intraprendere questo iter professionale pro-vengono per la maggior parte dalle regioni delsud Italia (43%), con una percentuale molto altasoprattutto per gli allievi del concorso pubblico(più della metà degli allievi dell’XI e del XII corsopubblico provengono dalle regioni del meridione),confermando i dati statistici dell’arruolamentonazionale.
Per quanto attiene al livello culturale medio c’è
stato un incremento significativo dei punti percen-tuale: se con il X Corso solo il 2% degli Allievi eragià in possesso di una laurea, ora con il XII Corsola percentuale è salita addirittura al 7% palesandoun alto livello di scolarità del personale che decidedi partecipare al concorso.
Altro dato significativo del triennio preso inconsiderazione, è relativo al numero degli allieviconiugati; la percentuale (10%) ha subito negli an-ni presi in esame un leggero aumento, a signifi-care che la motivazione a migliorarsi e all’accre-scimento professionale è radicata non soltantonel singolo individuo ma nell’intero nucleo fami-liare. Basti pensare alla forte assunzione di re-
LOGOS - 36
PASSAGGIO DELLA STECCATRA IL X E L’XI CORSO ALLIEVI MARESCIALLILa stecca nasce in origine come strumento di utilità
quotidiana, che i militari utilizzavano per lucidare ibottoni dell’uniforme prima di andare in libera uscita.
Essa non era altro che una verga di legno con unostretto intaglio che correva per tutta la lunghezza eterminava con un foro attraverso il quale venivanofatti entrare i bottoni metallici dell’uniforme, che sifacevano poi scorrere per la fenditura ed erano quin-di pronti per essere lucidati, senza sporcarne il tessu-to protetto dal legno.
Attualmente, la stecca, simile a quella vera, esistesolo in formato gigante presso alcune Accademie eScuole Militari quale simbolo di ordine, di precisionee di disciplina e come tale viene passata dagli «An-ziani» ai «giovani/nuovi arrivati» con un’appositacerimonia. L’atto vuole testimoniare il passaggio distoria, di tradizioni, di rispetto e di impegno che ilcorso giovane si ripromette di mantenere vive neltrascorrere degli anni.
Ogni Corso appone una targhetta che ricorda, neltempo, l’avvenimento.
sponsabilità da parte di quelle donne che accetta-no di vivere anni di sacrifici (dovuti alla lontanan-za e alla gestione delle problematiche familiari)per il raggiungimento degli obiettivi formativi eprofessionali del marito.
Questi dati presi in esame, confermano quindiche coloro che decidono di presentare la do-manda per l’ammissione al corso Allievi Mare-scialli, sono persone altamente motivate, consceche la professione militare è profondamente ap-pagante, richiede sacrificio ma è altamente qua-lificante.
Dai colloqui effettuati con alcuni Allievi emer-ge che molti di quelli che già hanno avuto unaesperienza militare concorrono perché spinti daldesiderio di un accrescimento professionale,per mettere a frutto quelle potenzialità e quellaesperienza maturata sul campo, per potersi«trasformare» da militare di truppa a Coman-dante di uomini. Un’Allieva del primo anno rias-sume così la sua scelta: «È la sfida di una vita:trovare fiducia in me stessa e poter poi infon-derla agli altri, essere da guida per i miei uomi-ni accettando così responsabilità rilevanti e ap-paganti, sicura che il mio ruolo sia necessarioquale elemento di congiunzione tra l’Ufficiale,che dirige, e il militare di truppa che opera sulterreno».
Per gli Allievi che invece provengono dalla vi-ta civile, la scelta appare determinata da fatto-ri diversi che si incentrano sia sull’aspetto cul-turale (la possibilità di conseguire un titolo distudio) sia sul fascino e sull’ammirazione che laForza Armata ha saputo guadagnarsi ricopren-do negli ultimi anni un ruolo di primo pianoquale Istituzione concreta che produce sicurez-za per il Paese con i continui impegni sia sulterritorio nazionale nell’ambi-to dei concorsi forniti alle al-tre Istituzioni dello Stato e al-la collettività in generale(Operazioni «Strade Sicure»,«Strade Pulite» e «Gran Sas-so») sia fuori dai confini na-zionali, nelle operazioni dimantenimento della pace e dirisposta alle crisi, in scenarioperativi particolarmentecomplessi.
CONCLUSIONI
Ricoprire l’incarico di Comandante di uominioggi significa, quindi, essere professionisti seri,responsabili e motivati, in possesso di un’eccel-lente base culturale, di un consistente patrimo-
nio di conoscenze tecnico-militari, psicologica-mente e fisicamente equilibrati per poter in ognicircostanza mettere in campo, con passione esacrificio, quei valori di spirito di servizio, retti-tudine e generosità che rendono unico il lavorodi ogni soldato.
Essere Marescialli dell’Eser-cito richiede coscienza, re-sponsabilità e dedizione, nellostesso tempo garantisce l’op-portunità di effettuare espe-rienze esaltanti e uniche nelloro genere, perché comanda-re è un privilegio concesso apochi.
Riccardo VenturiniCapitano,
Comandante della VI cp. Al-lievi Marescialli
presso la Scuola Sottufficialidell’Esercito
Luca GiovangiacomoCapitano,
Comandante della I cp. Allievi Maresciallipresso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito
37 - LOGOS
LOGOS
Rivista Militare n. 3/2010
Ricoprire l’incarico di Co-mandante di uomini oggi si-gnifica, quindi, essere pro-fessionisti seri, responsabili emotivati, in possesso di unaeccellente base culturale, diun consistente patrimonio diconoscenze tecnico-militari,psicologicamente e fisica-mente equilibrati...
“
”
UU NN II TT EE DD SS TT AA TT EE SSSS EE RR GG EE AA NN TT SS MM AA JJ OO RRAA CC AA DD EE MM YY
LOGOS
Il Sergeants Major Course si sviluppa su nove me-si (più due fasi propedeutiche per gli studenti stra-nieri, per l’inglese e per il metodo in uso nel corso)durante i quali gli studenti vengono messi alla pro-va tramite una serie di esami sotto forma di «tesine»o elaborati di vario tipo (analisi di operazioni milita-ri storiche, articoli o tesine sugli stili di leadership,analisi dei problemi di sviluppo delle organizzazionie tutto quello che è richiesto dal curriculum), che ri-calcano quelli richiesti agli Ufficiali statunitensi du-rante la frequenza del Command and General StaffOfficers Course (CGSOC) e dell’Army War College.L’obiettivo del corso, come specificato dal GeneraleMartin Dempsey, Comandante del TRADOC (Training& Doctrine), il 10 febbraio 2010 in visita all’Istituto,è sviluppare dei «senior leaders» tra gli NCOs capa-ci di fare da «battle buddy» (cioè di comunicare e
collaborare pariteticamente) ad Ufficiali in comandoo Staff a livello operativo e strategico. L’obiettivo è,quindi, quello di creare Sottufficiali in grado di pen-sare, pianificare, agire e criticare a livello operativo estrategico, in modo da fungere da «bilanciamento» oda appoggio per gli Ufficiali che ricoprono ruoli aquel livello. In tale ottica, il metodo adottato si basasu un modello andragogico (cioè insegnamento ri-volto agli adulti), per cui gli studenti sono parte at-tiva del processo di apprendimento.
UN MATURO METODO D’INSEGNAMENTO
Il metodo di insegnamento adottato nell’AnnoAccademico 2009-10 è radicalmente cambiato. Siè, infatti, passati da un «modello pedagogico»,normalmente in uso presso le Istituzioni formati-ve e orientato alla presentazione di informazioni aun’audience sostanzialmente statica, a un «mo-dello andragogico», ovvero un metodo di educa-zione orientato alle peculiarità degli adulti. Pre-supposto del corso è che, sebbene l’istruttore siasuperiore in grado e spesso in esperienza (sebbe-ne sempre un Sottufficiale), tutto il Corpo discen-te ha capacità, background e nozioni con cui puòarricchire la discussione e l’apprendimento delgruppo (si lavora in team di 14-16 persone). Inquesta prospettiva l’istruttore diventa un «con-duttore» che supervisiona la discussione e si ac-certa che gli allievi rimangano «in tema», oltre a
LOGOS - 40
UNITED STATESSERGEANTS MAJOR ACADEMY
La United States Sergeants Major Academy di El Paso, in Texas, rappresenta per i Sottufficiali dell’Esercitostatunitense la «casa madre» che crea, sostiene e completa la loro formazione. L’Istituto pone in essere di-versi corsi a beneficio del personale della categoria tra i quali il Sergeants Major Course che è l’apice dellaformazione, anche sul piano internazionale.
Formazione strategica d’eccellenza per i Sottufficiali
A sinistra.Il Monumento all’NCO (Elena Mazzucco).
In apertura.La consegna dei diplomi all’USASMA (NCO Journal).
fornire le informazioni di base per l’avvio del pro-cesso di apprendimento. Merita nota il fatto chel’istituzione sia completamente gestita da Sottuf-ficiali. È, infatti, un Sottufficiale (che riveste il gra-do di Command Sergeant Major - CSM) il Coman-dante dell’Accademia, come tutta la catena di co-mando fino ai singoli istruttori (che vengono chia-mati SGAs - Small Group Advisors - e rivestono ilgrado di Sergeant Major). Il corso, come molticorsi forniti dall’Esercito statunitense, è «frontloaded» cioè è diviso in due parti, la prima, piùimpegnativa, in cui le «materie» di studio sono di-vise in un «common core», os-sia materie fondamentali e altrenon meno importanti ma «pa-rallele» quali Leadership, Storia,Gestione delle Forze, warfi-ghting operativo, operazioni alivello divisionale e a livello Bri-gata, più una serie di seminarisu vari argomenti quali salute efitness, legge militare, pro-grammi per la protezione so-ciale, prevenzione dei suicidi,cui segue una fase in cui le no-zioni vengono applicate in esercitazioni pratiche(nel caso dell’SMC durante una esercitazione diposto comando o CPX - Command Post eXercise),
parallelamente a istruzioni meno teoriche come ladifesa personale o tesine.
PENSIERO CREATIVO E OPERAZIONI STRATEGICHE
Il corso comincia con un blocco propedeutico dilezioni in cui insieme al ripasso di nozioni di dot-
trina a livello tattico viene for-nita una panoramica sugli ar-gomenti del corso e un’intro-duzione sul pensiero creativo,sullo sviluppo della leadershipe sulla dimensione civile-mili-tare dei conflitti. Lo scopo èquello di instillare nel persona-le che sarà impiegato come«senior leader», concetti qualila creatività nella risoluzione diproblemi, la capacità di gestire«junior leaders» e di agire qua-
li trait d’union tra la truppa e la parte direttiva an-che in operazioni o situazioni differenti dalle tipi-che condizioni di impiego. Il corso di studi preve-
41 - LOGOS
LOGOS
Rivista Militare n. 3/2010
L’obiettivo del corso...èsviluppare dei «senior lea-ders» tra gli NCOs capaci difare da «battle buddy» (cioèdi comunicare e collaborarepariteticamente) ad Ufficialiin comando o Staff a livellooperativo e strategico
“
”
Il Comandante dell’USASMA, Command Sergeant MajorRaymond F. Chandler III, con una delegazione straniera(NCO Journal).
de un blocco di istruzione sulle capacità joint emultinazionali, in cui gli studenti vengono espostia lezioni e seminari sulle varie Forze Armate sta-tunitensi e le loro capacità, e all’illustrazione del-le organizzazioni multinazionali quali NATO, UN,coalizioni ad hoc, con riferimento alle piú comuniproblematiche che si presentano in tali ambiti la-vorativi. Il «blocco» è strutturato in modo da for-nire anche nozioni relative alla dimensione spazio(da intendere come spazio esterno al pianeta, sa-telliti e simili) che per gli Stati Uniti riveste ormaida anni un ruolo fondamentale nell’approccio alleoperazioni, soprattutto a livello strategico. Parti-colare attenzione viene posta, quindi, sull’analisidell’ambiente strategico e del ruolo dello stru-mento militare al massimo livello, esaminando idocumenti base della strategia statunitense, (Na-tional Defense Strategy, National Military Strategye via discorrendo) e le dottrine strategiche (peresempio logistica, operazioni, pubblica informa-zione/relazioni esterne) e applicandone i conte-nuti in case studies e in esercitazioni pratiche.Durante la prima fase vengono anche approfondi-ti argomenti quali la dottrina a livello operativo estrategico, sia a livello interforze che di Forza Ar-
mata (Esercito), fornendo elementi di arte opera-tiva, full-spectrum operations, battle command,logistica, per poi esaminare le funzioni interforze(Joint Fires, Command and Control, Intelligence,Sustainment, Protection, Movement and Maneu-ver, Information Operations) e la loro applicazio-ne in operazioni militari. Il «common core» termi-na, quindi, con le tecniche di pianificazione a li-vello strategico/operativo e tattico introducendoil Military Decision Making Process (MDMP) e ilJoint Operational Planning Process (JOPP) attra-verso una serie di lezioni teoriche e dettagliatiesercizi pratici che si estendono su più giorni. Indefinitiva, il corso si potrebbe pensare come ilcorso parallelo al Command and General Staff Of-ficers Course (CGSOC).
IL FATTORE INTERNAZIONALE
L’istituzione si prende cura degli studenti inter-nazionali che partecipano al programma (normal-mente attorno alle 35-45 unità) tramite un Ufficiodedicato che si occupa della gestione amministra-tiva (per coloro i quali percepiscono paga dal-l’Esercito statunitense) e disciplinare degli studen-ti internazionali. Al corso partecipano studenti cheprovengono da tutto il mondo, Africa, Europa,
LOGOS - 42
Attività parallele, il Safe driving brief (NCO Journal).
Asia, Australia e Americhe. L’Ufficio si occupa ditutta una serie di problematiche connesse all’arri-vo degli studenti, la loro sistemazione in abitazio-ni nella città di El Paso o dentro la base di Fort Blisse l’assegnazione di «sponsors» militari e civili lacui funzione è facilitare la vita (civile e accademi-ca) dello studente internazionale. Nelle intenzionidel programma di sponsorship, infatti, gli sponsorcivili agiscono quale «famiglia ospitante» introdu-cendo lo studente alla città, ai ritmi e al modus vi-vendi cittadino e in generale americano, nonchètutto quello che è relativo alla «vita spicciola», cioèprocurarsi un’automobile, un medico di famiglia,ecc.... Gli sponsors militari invece si dovrebberooccupare del lato accademico della questione, ac-certandosi che lo studente internazionale riesca a
«stare al passo» con gli studi e a seguire i mecca-nismi (a volte un po’ «alieni») dell’Accademia. Nel-la pratica i ruoli degli sponsors possono espander-si o contrarsi a seconda del rapporto che si crea tragli individui e delle necessità e affinità di ognuno,conferendo agli sponsor civili o militari un ruolopiù o meno importante. Ad aggiungere valore al-l’esperienza formativa contribuisce anche il pro-gramma di «field trips» sempre gestito dall’IMSOche prevede visite a Enti e installazioni militari lo-
cali e d’importanza nazionale. Da notare che alcu-ni studenti sono «invitati» dal Governo statuniten-se nell’ambito dell’International Military Educationand Training (IMET) program mentre altri sono in-viati dai propri Governi a partecipare al corso (tra-mite un programma di Foreign Military Sales -FMS), la differenza è inesistente nelle attività acca-demiche mentre diventa visibile in tutte quelle dicontorno. Gli studenti che partecipano al pro-gramma IMET «ricevono» vitto e alloggio pagati dalGoverno USA sotto la forma di appartamenti o ca-se singole, gli studenti nel programma FMS hannoin toto la responsabilità della loro sistemazionecon la (relativa) assistenza dell’IMSO. L’EsercitoItaliano ha partecipato alla class 60 inviando dueSottufficiali «FMS». In conclusione, l’IMSO arricchi-sce l’esperienza degli studenti internazionali for-nendo una serie di attività e contatti extrascolasti-ci che contribuiscono efficacemente a inserire lostudente nel contesto.
EDUCAZIONE LINGUISTICA AVANZATA
Dall’Anno Accademico 2009-2010, la frequen-za del Sergeant Major Course (SMC) presso laUnited States of America Sergeants Major Acade-my (USASMA) richiede, per tutti gli studenti di
43 - LOGOS
LOGOS
Rivista Militare n. 3/2010
Sopra.Il Command Sergeant Major of the Army Preston parlaallo Staff dell’USASMA (NCO Journal).
A sinistra.L'auditorium (NCO Journal).
madrelingua diversa dall’inglese, la frequenza diun corso di durata minima di otto settimanepresso lo U.S. Defense Language Institute (DLI)in Lackland Air Force Base - San Antonio, Texas.È qui che gli studenti internazionali vengono acontatto con il sistema scolastico militare statu-nitense. A dire il vero al DLI la sensazione èquella di essere ancora in un limbo. L’istituto èfunzionale, ha alloggi, aree didattiche, mensa eUfficio Postale accentrati nel raggio di meno diun chilometro, un centro sportivo e un mini-malla distanza di «passeggiata», dando allo studen-te tutto quello che serve per passare le otto set-timane concentrandosi sul corso d’inglese. Ilcorso in sè può essere frequentato a livelloavanzato o basico. Il livello di accesso dipendedal punteggio ottenuto in Patria (presso l’Amba-sciata statunitense a Roma) quando si sostiene laselezione per l’ingresso nel Paese, che viene dinuovo effettuato a Lackland con metodo compu-terizzato per conferma. Il corso si prefigge difornire a studenti che già hanno un’ottima cono-scenza della lingua gli strumenti per affrontarel’ambiente accademico. Si focalizza l’attenzionesulle tecniche di ricerca e stesura di testi acca-demici. Particolare attenzione viene rivolta anchealle tecniche di briefing. Durante il corso si se-
gue anche un programma di educazione fisica.
L’APPROCCIO ITALIANO E QUELLO STATUNITENSE
Il Sergeant Major Course, come già detto, è sta-to «rinnovato» appena prima della class 60 (AA2009-2010), introducendo materie e argomenticompatibili con la figura che l’Esercito statuniten-se si prefigge di creare nell’ambito della categoriaSottufficiali. L’obiettivo è quello di formare perso-nale appartenente al ruolo Sottufficiali e di prova-ta esperienza (si parla di personale con almeno18-20 anni di servizio e di grado non inferiore aE-8 o NATO OR-8 ovvero Master Sergeant) perservire quale collaboratore di Ufficiali superiori inincarichi di comando e di Staff. La similitudine col«corso di branca» in ambito Esercito Italiano è tut-ta qui. Mentre col nostro corso di branca si cercadi riqualificare i Marescialli, a circa metà carriera,per lavorare quali addetti in Staff da livello reggi-mento a superiore, l’Esercito statunitense vuolecreare il «battle buddy» o, per dirla all’italiana, «ilcoppio» di un qualsivoglia Comandante o Ufficialedi Staff (capo branca) da livello battaglione (corri-spondente al nostro reggimento) in su. Per questoil corso è articolato e complesso e, invece che con-centrarsi su una singola branca funzionale (S1-G1,S2-G2 e via discorrendo), spazia nelle nozioni ditutte le branche, fornendo, come già accennato,competenze «parallele» che possano aiutare il Sot-
LOGOS - 44
La consegna del diploma presso il Defense LanguageInstitute (Elena Mazzucco).
tufficiale nel compito di supporto e «consulenza»che avrà nei confronti dell’Ufficiale al quale saràaffiancato. In definitiva, l’obiettivo generale di ri-qualificare il Sottufficiale e renderlo abile a opera-re in contesti di Staff rimane lo stesso, cambia lamagnitudine della riqualifica. Per l’Esercito statu-nitense i Sottufficiali vengono esposti a dottrine epunti di vista strategici e vengono, durante i novemesi, abituati a considerare tutte le sfaccettaturedi un problema, sia esso strategico, operativo otattico. Differente dal corso di branca è anche ilmetodo d’insegnamento; mentre in Patria vengo-no fornite lezioni frontali e nozionistiche, che han-no comunque il loro valore, negli Stati Uniti si ca-pitalizza sull’esperienza collettiva del gruppo e sistimola l’apprendimento tramite la discussionedegli argomenti. Gli istruttori poi, come già accen-nato, sono tutti NCOs più anziani e più esperti deidiscenti e, in generale, l’ambiente che si tenta dicreare è positivo e aperto alle nuove idee. Il SMC,quindi, diversamente dal corso di branca, fornisceuna preparazione a spettro più ampio, paragona-bile a quella del Command and General Staff Offi-cers Course (CGSOC). Da notare che durante i no-ve mesi di durata del corso gli NCO americani han-no la possibilità di lavorare sulla propria formazio-ne scolastica in ambito civile grazie a corsi fornitinei locali dell’Accademia, fuori dall’orario di lezio-ne, da università in convenzione con l’US Army.
PICCOLI GRUPPI E DIVERSE PROSPETTIVE
Le classi, o small groups, sono in genere compo-ste da circa 14-16 elementi, istruttore compreso esono assemblate con elementi provenienti dallevarie unità e specializzazioni dell’Esercito regolare(servizio attivo) da elementi della Riserva, GuardiaNazionale, altre Forze Armate (Marina, Aeronauti-ca, Marines, Guardia Costiera) eda studenti internazionali. Que-sta composizione «mista» fa sìche nel gruppo vi siano semprepunti di vista differenti relativa-mente ai problemi che si affron-tano, così da esporre gli stu-denti a diversi approcci che inun contesto di singola Forza Ar-mata (o di singola Specialità in-terna alla Forza Armata) magarinon salterebbero nemmenofuori. Per esempio lo studente della Marina po-trebbe avere un approccio diverso alla soluzione diun problema strategico, o quello internazionalepotrebbe aggiungere una dimensione che gli stu-denti americani potrebbero non considerare dati iloro costrutti culturali. Il tutto forma un mini-gruppo di lavoro «combined-joint» che replica la
realtà lavorativa, soprattutto a livello di Staff e co-mando, che si trova normalmente nelle organizza-zioni operanti nei moderni teatri operativi, sianoesse la NATO, l’ONU, la Comunità Europea o coa-lizioni ad hoc. Il meccanismo ha, quindi, moltepli-ci pregi, innanzitutto i partecipanti arricchisconovicendevolmente il proprio bagaglio culturale, am-pliano le proprie vedute grazie all’apporto dei col-leghi stranieri o di altra Forza Armata ma soprat-tutto acquisiscono familiarità al lavoro in team mi-sti minimizzando lo «shock culturale» al momentodi dover lavorare in ambienti combined e joint nel«mondo reale».
SMC E SOCIAL NETWORKING
Uno dei pilastri fondamentali dell’Esercito statuni-tense è il Corpo dei Sottufficiali. Nell’organizzazionestatunitense il Corpo è un’istituzione nell’istituzio-
ne. I Sottufficiali amano definirsii «Keepers of the standards» inquanto garanti della disciplina edel buon andamentotecnico/tattico delle Unità. Talecoscienza è tenuta insieme da unsentimento di appartenenza aun’organizzazione che, comedetto prima, è un sotto-gruppocompatto e solidale il quale ha lasua espressione nei CommandSergeant Majors, cioè quelle fi-
gure anziane («senior») che nelle Unità fungono daguida, esempio e mentore dei militari più giovani diqualsiasi ordine e grado, mentre, come già detto,collaborano sullo stesso piano con gli Ufficiali cuisono affiancati. In alcuni casi i Sottufficiali statuni-tensi arrivano all’Accademia conoscendosi già l’unl’altro, soprattutto se della stessa Arma/Specialità. Il
45 - LOGOS
LOGOS
Rivista Militare n. 3/2010
Il SMC, quindi, diversa-mente dal corso di branca,fornisce una preparazionea spettro più ampio, para-gonabile a quella del Com-mand and General Staff Of-ficers Course
“
”
Learning Resource Center: la biblioteca dell’USASMA(NCO Journal).
SMC si propone, quindi, anche come «momento diincontro» tra Sottufficiali provenienti da realtà diver-se all’interno della stessa Forza Armata, di Forze Ar-mate diverse e di Paesi diversi. Le relazioni personalie professionali che si creano attorno al gruppo e alcorso si trascineranno inevitabilmente nella vita de-gli studenti che, nel futuro si ritroveranno a lavorarefianco a fianco in Comandi all’estero, in operazioni,sul territorio nazionale o in esercitazioni. Il vantag-gio è evidente, si potrà sempre contare in un colle-
gamento tra le categorie Sottufficiali dei diversi Pae-si e delle diverse Forze Armate, e ci sarà semprequalcuno dello stesso corso o comunque «diploma-to» all’USASMA con cui poter parlare e risolvere pro-blemi a qualsiasi livello.
FITNESS E SALUTE
La parte relativa all’educazione fisica per l’An-no Accademico 2009-10 non è stata implemen-tata. Infatti, nella prospettiva andragogica, il Co-mando dell’Accademia ha ritenuto opportuno la-sciare agli individui il tempo e la responsabilità dieffettuare il proprio programma di educazione fi-sica in base alle proprie individuali necessità.Non sono stati trascurati però gli altri elementichiave del fitness. Tutti i partecipanti al corso so-no infatti stati sottoposti a scrupolosi screeningmedici per determinare lo stato di fitness (intesocome stato di salute in senso lato) analizzando lacapacità metabolica, le condizioni cardiache tra-mite tomografie tridimensionali del cuore, lecondizioni generali tramite analisi chimico-fisi-che del sangue e della composizione corporea intermini di massa grassa, magra, acqua e ossa,
LOGOS - 46
Sopra.Istruzione Parallela, Guest speaker in auditorio (NCOJournal).
A sinistra.Frequentatori Italiani della Class 60 (Elena Mazzucco).
tramite una macchina dedicata (bod pod). Anchele condizioni psicologiche sono state valutatetramite la somministrazione di questionari. Il tut-to pilotato da un distaccamento dell’Army Physi-cal Fitness Research Institute che mette a dispo-sizione un team composto da medici generici,dietologi, specialisti della nu-trizione ed esperti di fitnessche possono fornire utili consi-gli su come migliorare il pro-prio stato di salute. I Sottuffi-ciali vengono poi comunquesottoposti ai normali controllisemestrali di altezza/peso ealle prove di efficienza fisica(con requisiti superiori a quelliitaliani, anche consideratal’età) come previsto dalle nor-mative per l’Esercito statuni-tense.
CONCLUSIONI
Il SMC è un corso impegnativo, cadenzato daesami, lavori di gruppo e intenso studio, ma so-prattutto in evoluzione. Il corso per la Classe 61cambierà, non nei contenuti ma nei tempi (sispenderà più tempo in classe e il corso sarà por-tato a 10 mesi di durata). È un «hub», un nodo incui vengono intessute relazioni e conoscenzeche i partecipanti si «porteranno dietro» nella lo-ro vita, personale e professionale, assieme al va-riegato bagaglio culturale e alle capacità che uncorso come l’SMC insegna. «Educating Today’s
Leaders for Tomorrow», il motto dell’Accademia,riassume bene il compito: fornire educazione per
lavorare in un ambiente incer-to (quale il moderno ambienteoperativo, caratterizzato dafluidità e situazioni fortemen-te asimmetriche) in opposizio-ne all’addestramento per ope-rare in un ambiente certo(quale il passato ambienteoperativo, fortemente codifi-cato, come ai tempi dellaGuerra Fredda). Il corso crea,quindi, figure professionalicapaci di proporsi quali colla-boratori e sostituti (se neces-sario) delle alte gerarchie mili-tari ai più alti livelli, profes-sionisti che per sempre porte-
ranno marchiata nella memoria la formula «Ulti-ma Strong» come significato di competenza,professionalità e appartenenza a un gruppo diuomini e donne dedicati all’eccellenza nel pro-prio lavoro.
Raimondo SpasianoMaresciallo Ordinario,
in servizio presso il 28º reggimentoComunicazioni Operative «Pavia»,
già frequentatore del Sergeants Major Course,Class 60 nell’Anno Accademico 2009-10
47 - LOGOS
LOGOS
Rivista Militare n. 3/2010
«Educating Today’s Leadersfor Tomorrow», il motto del-l’Accademia, riassume bene ilcompito: fornire educazioneper lavorare in un ambienteincerto, quale il modernoambiente operativo, in oppo-sizione all’addestramentoper operare in un ambientecerto, quale il passato am-biente operativo
“
”
Studenti internazionali in visita presso l’Air Force Aca-demy (NCO Journal).
TECHNE - 50
Negli ultimi due anni gli americani hanno impie-gato gli UAV «Predator» e «Reaper» su larga scalaper colpire obiettivi qaedisti e talebani nelle areeremote tribali pachistane. Rispetto all’epoca del-l’amministrazione Bush, che hadato avvio a questo tipo di stra-tegia, con l’AmministrazioneObama gli attacchi con droni inqueste aree sono aumentatiesponenzialmente, a dimostra-zione che le prime titubanze sulloro impiego in operazioni com-bat sono definitivamente cadute.I velivoli decollano dalle loro ba-si di Jacobabad o Shamsi in Pa-kistan e da qui raggiungono in pochissimo tempole aree tribali al confine con l’Afghanistan. Una vol-ta in area operativa, possono restare in volo fino a24 ore ad altissima quota e trasmettere in temporeale le immagini riprese ai Comandi a terra graziea ponti satellitari che consentono agli staff del Pen-tagono o della CIA, dall’altra parte dell’Oceano, diseguire la missione su grandi schermi comoda-mente seduti e di dare il via libera all’attacco una
volta identificato il bersaglio. A quel punto i velivolilanciano il loro missile «Hellfire» o una bomba aguida satellitare JDAM e possono colpire il bersa-glio con un’altissima precisione e minimizzando al
massimo i danni collaterali. Di-versi esponenti di Al Qaeda edei talebani sono stati uccisicosì, senza che potessero nem-meno accorgersene. Una mis-sione pulita che non mette a ri-schio la vita del personale e chegarantisce lo stesso ottimi ri-sultati. Mal che vada si perde ilveicolo, ma le aziende del set-tore stanno dando il meglio di
loro per realizzare UAV sempre meno costosi.Anche nel campo terrestre la robotica ha ormai
compiuto passi da gigante e nel prossimo futurovedremo sempre più robot in operazione a fiancodei soldati.
DALLE APPLICAZIONI ORIGINARIE AI ROBOT COMBAT
All’inizio i robot terrestri, i cosiddetti UGV (Un-manned Ground Vehicle), venivano utilizzati so-prattutto per la ricerca, l’identificazione e la neu-tralizzazione di ordigni improvvisati e mine. Il«PackBot» è stato uno dei primi veicoli del genere
LA ROBOTICASEMPRE PIÙ NEL FUTURO
La guerra del futuro vedrà un utilizzo sempre più massiccio di sistemi robotizzati. Già adesso l’espe-rienza maturata sui campi di battaglia negli ultimi anni, in particolare in Iraq, Afghanistan e Pakistan, vain questa direzione. Se gli americani sono stati i primi a sviluppare le applicazioni militari in tale setto-re, anche l’Italia si rivela un Paese all’avanguardia nell’ambito della robotica terrestre.
Anche nel campo terrestrela robotica ha ormai com-piuto passi da gigante e nelprossimo futuro vedremosempre più robot in opera-zione a fianco dei soldati
“
”
A sinistra.All’inizio i robot terrestri, i cosiddetti «UGV» (UnmannedGround Vehicle), venivano utilizzati soprattutto per laricerca, l’identificazione e la neutralizzazione di ordigniimprovvisati e mine.
In apertura.Negli ultimi due anni gli americani hanno impiegato gliUAV «Predator» e «Reaper» su larga scala per colpireobiettivi qaedisti e talebani nelle aree remote tribalipakistane.
ed è diventato presto un bestseller. L’azienda chelo produce, l’americana «iRobot», ne ha conse-gnati a migliaia. Il «PackBot» è un veicolo cingola-to di circa 20 kg controllabile in remoto da unoperatore tramite un PC portatile o un semplicejoystick. Può essere equipaggiato con sistemi esensori di diverso tipo: telecamere, camere termi-che, bracci manipolatori o cannoni a pressioneper la neutralizzazione degli ordigni. Famosa è laversione dotata del kit «Fido», che consente di ri-levare i vapori e le particelle di esplosivo rilasciatidagli ordigni nell’aria. Di recente i ricercatori del-l’Università della Florida si sono spinti addiritturaoltre mettendo a punto un’applicazione che con-sente di controllare il «PackBot» tramite iPhone.
Dal campo EOD, l’uso dei robot si è ben prestoesteso anche alle operazioni di ricognizione e sor-veglianza. Pertanto, se prima toccava sempre aisoldati ispezionare un edificio o controllareun’area considerata a rischio, adesso spetta inveceai robot essere mandati in avanscoperta, a tuttovantaggio della sicurezza del personale. Per que-
sto tipo di operazioni, i Marines americani usano il«Dragon runner», un piccolo veicolo 4x4, pesantesolo 4 kg e trasportabile a zaino. Il «Dragon run-ner» è controllato tramite un sistema senza fili edè dotato di una microcamera, un microfono e unsensore che può captare un qualunque movimentofino a oltre 9 metri di distanza. Il «Dragon runner»è particolarmente utile per l’ispezione di edifici.Sempre in questo settore va ricordato anche il ri-voluzionario «Throwbot», un cilindretto a forma dilattina pesante 400 g e dotato di due piccole ruo-te. Il soldato lo lancia dentro un edificio attraversouna finestra, o una porta, e il robot può trasmette-re quello che avviene all’interno grazie a una vi-deocamera. Le immagini vengono poi rimandateall’indietro tramite un trasmettitore con un raggiodi 30 metri.
Ma il terreno che promette sviluppi ancor piùinteressanti, e potenzialmente più rivoluzionari, èquello dei robot combat: robot che combattono alposto dei soldati. In molti Paesi si stanno studi-nando piattaforme robotizzate terrestri armatecon mitragliatrici o lanciagranate controllate inremoto dai soldati mediante semplici joystick. Re-sta il grande problema di affidare a una macchinal’azione di fuoco, con tutte le possibili implicazio-ni per la sicurezza dei civili e degli stessi soldati;tuttavia si stanno studiando meccanismi mediantei quali affidare all’operatore l’abilitazione dellasequenza di fuoco.
I CONCETTI PIÙ INNOVATIVI
Tra i concetti più innovativi nel campo della ro-botica militare va ricordato quello dei robot coo-peranti. In tale settore da tempo sono state con-
51 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Il «PackBot» è stato uno dei primi veicoli impiegato perle applicazioni EOD, divenendo presto un bestseller.
Per ispezionare un edificio, i Marines americani usano il«Dragon runner», un piccolo veicolo 4x4, pesante solo4 kg e trasportabile a zaino.
dotte delle sperimentazioni ispirate al comporta-mento sociale di alcune specie animali, come leformiche e i branchi di lupi, per verificare la pos-sibilità che anche un insieme di robot possa muo-versi in modo coordinato in vista del raggiungi-mento di un obiettivo comune. I robot devonoavere coscienza l’uno dell’altro, conoscere l’am-biente dove operano e la propria posizione in re-lazione a quella degli altri. Il principio è quellodella cosiddetta swarm intelligence basato, ap-punto, sullo studio del comportamento degli in-setti o di altri animali di tipo gregario in natura.Gli studi e le sperimentazioni fin qui condottehanno portato allo sviluppo di una serie di algo-ritmi in grado di regolare la cinematica e i movi-menti di cooperazione finalizzati a un obiettivo daparte di robot quasi completamente autonomi e ingrado di auto-organizzarsi. Il solo apporto del-l’operatore consiste nell’indicare l’obiettivo che losciame, o il gruppo, deve perseguire. Tuttavia, daun punto di vista tecnologico, l’implementazionedi questi concetti non è semplice. Strumenti di
geo-referenziazione come il GPS, soprattutto inambienti indoor, dove molto spesso gli sciami de-vono operare, sono inutilizzabili. Questo significache ciascun robot deve avere la capacità di rico-struire la mappa dell’ambiente esterno e scam-biarla con gli altri. Per quanto riguarda questo se-condo aspetto, sono in corso studi su nuovi pro-tocolli di comunicazione attraverso i quali far dia-logare lo sciame.
Le applicazioni più frequenti per l’utilizzo di ro-bot cooperanti rientrano generalmente nel grandebacino dell’homeland protection e della security.In tali contesti, ciascun membro di uno sciamepuò essere equipaggiato con sensori, così da po-ter formare delle reti mobili, piccoli bracci mani-polatori o pinze per la rimozione di oggetti. Neicasi di applicazioni di security, il concetto prevedelo suddivisione delle capacità svolte dal classicosistema remotato EOD tra tanti piccoli robot, cia-scuno responsabile per una singola funzione. Irobot agiscono in autonomia e l’operatore svolgeil mero compito di supervisore/pianificatore.
Un altro settore che promette interessanti svi-luppi è quello della cooperazione tra robot etero-genei, in particolare tra sistemi robotizzati terre-stri e mini/micro UAV. Il concetto è quello del«dog and his flea», ovvero del cane e la sua pulce.Nella fattispecie il cane può essere costituito daun UGV e la pulce da un mini UAV. In Italia, comevedremo meglio in seguito, sono già state ampia-mente sviluppate applicazioni del genere.
L’ESPERIENZA AMERICANA
Gli americani sono stati i primi a sviluppare ap-plicazioni militari nel campo della robotica e a fa-re un largo impiego di robot sui campi di batta-glia. Il Congresso ha chiesto al Pentagono che en-tro il 2015 il 15% dei veicoli delle Forze Armatesia robotizzato. Già oggi i droni e i robot impie-gati in Iraq e in Afghanistan sono oltre 5 000.Queste macchine vengono impiegate per lo svol-gimento di diversi compiti: ricognizione e sorve-glianza, ricerca e rimozione di mine e ordigniesplosivi. Ma si stanno sempre più affermandoanche UGV combat. Già qualche anno fa l’aziendaamericana Foster Miller aveva realizzato lo«Swords», il primo robot da combattimento dellastoria. Tre prototipi furono schierati in Iraq nel2007, ma dopo un breve periodo di sperimenta-zione l’US Army decise di tagliare i fondi al pro-gramma poiché il veicolo non aveva mostrato lenecessarie garanzie in termini di sicurezza. Per iltimore di incorrere in casi di fuoco fratricida, odanni collaterali, lo «Swords» non sparò mai.L’azienda non si è, tuttavia, data per vinta e dopodi allora ha proseguito nello sviluppo di applica-
TECHNE - 52
Lo «Swords» è stato il primo robot da combattimentodella storia, impiegato per una serie di sperimentazioninel 2007 in Iraq.
zioni riguardanti UGV di tipo combat realizzandoil «MAARS», un nuovo robot da combattimentocon un peso di meno di 160 kg, dotato di mag-giore velocità dello «Swords» ed equipaggiato conuna mitragliatrice o un lanciagranate o anche conarmamento non letale come granate «flash-bang»e laser abbaglianti. Per superare i problemi incon-trati con lo «Swords», sono state adottate alcunemodifiche atte, in particolare, a impedire all’armadi puntare verso l’area ritenuta «amica» dal com-puter di bordo del mezzo. Sviluppi come questohanno contribuito ad attenuare le legittime preoc-cupazioni riguardanti la sicurezza e il Pentagono,sempre più allettato dalla prospettiva della guerrasoft, «a zero morti», ha continuato a finanziare iprogrammi per lo sviluppo di robot combat.
Tra i progetti decisamente più maturi c’è il«Gladiator», un robot terrestre del peso di oltreuna tonnellata sviluppato dalla Carnagie MellonUniversity in cooperazione con l’azienda britanni-ca «BAE Systems». Il «Gladiator» costituisce ungrande passo in avanti rispetto a tutti i suoi pre-decessori. Per il momento sono stati realizzati giàalcuni esemplari, a un costo di 300/400 000 dol-lari ciascuno. I Marines stannoimpiegando il robot in Afgha-nistan nella segretezza più as-soluta. Il «Gladiator» è un vei-colo altamente flessibile capacedi svolgere diversi tipi di ope-razione. Per questo può essereequipaggiato con differenti tipidi sistemi: megafono, laser ab-baglianti, tubi per l’emissionedi gas stordenti o per il lanciodi granate lacrimogene e, per i compiti combat,mitragliatrice da 7,62 mm o lanciagranate. L’ope-ratore controlla il robot tramite una semplice con-solle, molto simile a quella di una play station,con la quale vengono comandati tutti i movimenti
e l’eventuale azione di fuoco. Le immagini ripresedal robot possono essere visualizzate direttamen-te in un monocolo, fissato su un casco specialeindossato dall’operatore. Entrambi potranno così
vedere le stesse immagini, inuna simbiosi perfetta.
Il «Gladiator» può essere con-siderato come una soluzione adinterim verso i robot di nuovagenerazione che gli Stati Unitistanno sviluppando nell’ambitodella componente unmanneddel programma Future CombatSystems. L’avveniristico pro-gramma dell’US Army prevede
la realizzazione di una famiglia di droni e robottutti collegati, secondo il cosiddetto concetto«plug-and-play», alla medesima rete informativa.Il «MULE» fa parte di questa famiglia. È un robot asei ruote, pesante oltre tre tonnellate, concepitoper supportare in tutto e per tutto la squadra difanteria. Un vero e proprio «mulo» che segue gliuomini ovunque, su tutti i tipi di terreno e chesvolge i compiti richiesti grazie all’adozione di unsistema di comandi verbali e gestuali in corso dimessa a punto. Il veicolo può essere controllato daun operatore, ma può eseguire la sua missioneanche in modo del tutto autonomo, senza nessuntipo di apporto umano. Una rivoluzione, resa pos-sibile dall’implementazione di algoritmi semprepiù complessi e dall’utilizzo di un computer diguida e da una serie di sensori che consentono alveicolo di avere «coscienza» della propria posizio-ne. Il «MULE» è disponibile principalmente in dueconfigurazioni: logistica e d’assalto. La versionelogistica permette al veicolo di trasportare fino adoltre 900 kg di equipaggiamenti e rifornimenti,sufficienti per il supporto di ben due squadre di
53 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Il «Gladiator» è un veicoloaltamente flessibile capace disvolgere diversi tipi di ope-razione. Per questo può es-sere equipaggiato con diffe-renti tipi di sistemi
“
”
Un’immagine del «MULE» in versione logistica. A causadel ridimensionamento del programma FCS, è stato can-cellato dal Pentagono.
Il «Gladiator» costituisce un grande passo in avantirispetto a tutti i suoi predecessori.
fanteria. La versione d’assalto, invece, può essereequipaggiata con missili anticarro o mitragliatrici.Tuttavia, a causa dei problemi e del ridimensiona-mento subito dal programma FCS, l’US Army hacancellato il «MULE». Tuttavia, sulla base del-l’esperienza del «MULE», «Lockheed Martin» hasviluppato una nuova soluzione più economica eleggera: lo Squad Mission Support System (SMSS).Lo «SMSS» si basa sui medesimi principi di auto-nomia del «MULE» e dovrebbe svolgere compiti si-mili. Il veicolo ha una configurazione 6x6 ed è ingrado di trasportare fino a oltre 450 kg di payload.Quest’anno alcuni esemplari dovrebbero essereimpiegati per una serie di prove in Afghanistan.
Sempre nell’ambito del programma FCS, stacontinuando lo sviluppo di un altro robot combat,l’«ARV». Quest’ultimo è un «UGV» cingolato basa-to sullo stesso telaio del «MULE», del peso di oltre5 tonnellate, disponibile in due configurazioni:una RISTA e una versione d’assalto. La prima ver-sione è equipaggiata con una torretta dotata disistemi elettro-ottici per l’osservazione, mentre laseconda è equipaggiata con una torretta dotata dimissili anticarro, «Hellfire» o «Javelin», e una mi-tragliatrice da 7,62 mm.
L’ESPERIENZA ITALIANA
Anche l’Italia è all’avanguardia nel settore dellarobotica terrestre grazie agli sviluppi portatiavanti dalle aziende del gruppo Finmeccanica, a
cominciare dalla spezzina Oto Melara. Tra le prin-cipali proposte dell’azienda bisogna menzionare il«PRAETOR» (Piattaforms Robotizzata Elettrica Te-le-Operata Remotata), un veicolo ruotato 6x6lungo 1,5 m, largo 90 cm e pesante 200 kg, ingrado di trasportare un carico utile massimo di 60kg. Il veicolo è propulso da un apparato con tremotori elettrici, due nella sezione anteriore e unonella sezione posteriore, in grado di conferirgliuna velocità massima di 50 km/h. Il «PRAETOR» ècontrollato da una Ground Station disponibile intre versioni: una veicolare, una portatile e una in-dossabile. Le versioni proposte sono diverse a di-mostrazione di un concetto ispirato alla massimaflessibilità. Per cui il veicolo può essere equipag-giato per compiti RISTA, mediante l’adozione ditorrette elettro-ottiche di diverso tipo, compiticombat, attraverso l’installazione di lanciagranateo mitragliatrici, compiti counter-IED, mediantel’adozione di appositi bracci meccanici per laneutralizzazione degli ordigni, e così via. Il«PRAETOR» è stato comunque pensato per essereplug-and-play in architetture network-centricheampie, assieme ad altri veicoli o velivoli.
Il «PRAETOR» può operare anche come veicolomadre, sia con altri «UGV» o per piccoli droni,quasi fosse una sorta di «piccola portaerei» se-condo il concetto già ricordato del «cane e la suapulce». In questa configurazione il veicolo è dota-to di un ampio piano di volo per il trasporto e leoperazioni di decollo e appianaggio di velivoliquali l’«Asio» - frutto della collaborazione tra il«Centro di Ricerche UTRI» e la «SelexGalileo» - ol’«Ibis» - prodotto da «Celin Avio», ma commer-cializzato da «Oto Melara» - e di un pod per rica-ricarne le batterie. L’«Asio» è un piccolo drone adecollo verticale con un peso di quasi 6 kg e un
TECHNE - 54
Il «PRAETOR» può operare anche come veicolo madre,sia con altri «UGV» o per piccoli droni, quasi fosse unasorta di «piccola portaerei» secondo il concetto giàricordato del «cane e la sua pulce».
Anche l’Italia è all’avanguardia nel settore della roboticaterrestre. Nella foto possiamo vedere un veicolo dellafamiglia «TRP» in configurazione combat.
payload di 500 grammi costituito da un sensoreIR e un sensore TV. L’Asio ha una velocità massi-ma di 25 nodi, una quota massima di tangenza di2 500 metri e un data link per la trasmissione deidati con una portata di 10 km. L’«Ibis» è inveceun piccolo elicottero unmanned equipaggiato conun motore elettrico e un sensore elettro-otticoper compiti di ricognizione e sorveglianza. Il veli-volo ha un peso di 10 kg, un payload di 3 kg, unalunghezza di 1,7 metri e un’altezza di 76 cm. Ilmotore garantisce l’erogazione di una potenza di2 kW per una velocità massima di 100 km/h.L’autonomia è di un’ora e mezza.
Un’altra famiglia di robot sviluppata da Oto Mela-ra è la «TRP». Il «TRP-1» è un «UGV» cingolato ca-pace di svolgere missioni in modo completamenteautonomo grazie all’adozione di un rivoluzionariosistema di guida. Quest’ultimo consiste in un mec-canismo di autolocalizzazione basato su una seriedi algoritmi comportamentali che ne consentonol’operatività in modalità automatica e su un pac-chetto di sensori che include un telemetro laser, unsonar e la classica «IMU» (Inertial MeasurementUnit). L’apporto dell’operatore si limita alla sempli-ce indicazione di way-point successivi che il veicoloraggiunge volta dopo volta selezionando il percorsoritenuto più adatto ed evitando eventuali ostacoli.In pratica il «TRP-1» è dotato di una vera e propriaintelligenza artificiale che gli consente di sapere inqualsiasi momento dove si trova. Il veicolo, che sipresenta molto compatto e robusto, con un pesomassimo, compreso il carico utile, di 150 kg, puòessere utilizzato in applicazioni tipiche dei contestidi calamità naturali o di homeland protection. Glialtri due veicoli della famiglia,«TRP-2/3», appartengono inve-ce alle categorie small e light, esono ruotati. Il «TRP-3» ha unpeso di soli 5,5 kg e può opera-re in abbinamento al «PRAE-TOR», da cui viene rilasciato. Il«TRP-2» è invece disponibile an-che in configurazione ElectronicSupport Measure (ESM). Nel ca-so, si tratta di un sistema fruttodella collaborazione tra Oto Me-lara ed Elettronica. Quest’ultimafornisce in particolare un senso-re passivo di nuova concezione,denominato Advanced TacticalCESM, comprendente un’anten-na omnidirezionale a banda lun-ga, e la «scatola» del processor group. Le dueaziende curano poi assieme l’integrazione. Il sen-sore è estremamente innovativo e può essere in-stallato su uno sciame di «UGV» dislocati in diverseposizioni a seconda delle diverse esigenze operati-ve. In questo modo è possibile rendere disponibile,
in tempo reale, l’Electronic Order of Battle (EOB) contutte le informazioni relative alle fonti di emissioneelettromagnetiche presenti nell’area di interesse e
operanti nelle bande delle tele-comunicazioni: dall’identifica-zione degli apparati e delle unitàche li utilizzano, alla posizionedel trasmettitore, caratteristichee contenuti della trasmissione.In prospettiva, attraverso l’inte-grazione di funzionalità «un-manned» con quella di identifi-cazione e localizzazione di sor-genti emittenti nello spettroelettromagnetico, le Forze Ar-mate potranno, preventivamentee senza il diretto coinvolgimentoumano, veder diminuire il ri-schio di subire attacchi innescatiattraverso dispositivi radio. At-tualmente è allo studio anche
una versione attiva, ECM, di tipo «responsive», ov-vero in grado di inibire solo la frequenza potenzial-mente pericolosa.
Pietro BatacchiGiornalista
55 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
...attraverso l’integrazionedi funzionalità «unmanned»con quella di identificazionee localizzazione di sorgentiemittenti nello spettro elet-tromagnetico, le Forze Ar-mate potranno, preventiva-mente e senza il direttocoinvolgimento umano, ve-der diminuire il rischio di su-bire attacchi innescati attra-verso dispositivi radio
“
”
Il «TRP-2» in configurazione Electronic Support Measure(ESM), un sistema frutto della collaborazione tra «OtoMelara» ed «Elettronica».
SSPPEECCIIAALLEE EEOODD
GG LL II OO RR DD II GG NN II EE SS PP LL OO SS II VV II ::LL ’’ AA RR MM AA DD EE LL GG EE NN II OOAA LL PP AA SS SS OO CC OO NN II TT EE MM PP II
TECHNE
QQuueessttoo ««SSppeecciiaa llee»» ss ii pprrooppoonnee ddii mmeetttteerree iinn eevviiddeennzzaa ii ll ll iivveell lloo ddiieeccccee ll lleennzzaa rraaggggiiuunnttoo ddaa ll ll ’’EEsseerrcc ii ttoo II ttaa ll iiaannoo nnee ll llaa lloott ttaa aaggll ii IIEEDDss(( IImmpprroovviisseedd EExxpplloossiivvee DDeevviicceess)) cchhee ccoosstt ii ttuuiissccoonnoo llaa mmiinnaacccciiaa ppiiùùiinnssiiddiioossaa nneeii tteeaattrr ii ooppeerraatt iivv ii ,, ll iivveell lloo ddii eecccceell lleennzzaa cchhee nnaassccee ccoonnllee pprr iimmee aatt tt iivv ii ttàà ssuull ccaammppoo ddeell lloo ssmmiinnaammeennttoo ffuuoorr ii ddaall tteerrrr ii ttoorr iioonnaazziioonnaallee ((OOppeerraazziioonnii SSAALLAAMM)) ee cchhee,, ssuull llaa bbaassee ddeell llee ccoonnoosscceennzzeeddii ll ii vvee ll lloo iinntteerrnnaazz iioonnaa llee aaccqquuiiss ii ttee ,, hhaa ccoonnsseenntt ii ttoo nnee ll tteemmppoo ll aaccrreeaazziioonnee ddii uunnaa ccaappaacc ii ttàà rree llaatt iivvaa aa ll llaa pprroobblleemmaatt iiccaa EEOODDss ((EExx--pplloossiivvee OOrrddnnaannccee DDiissppoossaall )) ,, IIEEDDss cchhee rraapppprreesseennttaa uunnaa nniicccchhiiaa ddiieecccceell lleennzzaa uunnaanniimmeemmeennttee rr iiccoonnoosscciiuuttaa aa ll iivveell lloo iinntteerrnnaazziioonnaallee..PPeerraall tt rroo,, ccoonn ll ’’ iinntteerrvv iissttaa aa ll GGeenneerraallee ddii BBrr iiggaattaa AAnnttoonniioo DDiibbeell lloo-- CCoommaannddaannttee ddeell llaa SSccuuoollaa ddeell GGeenniioo ee IIssppeettttoorree ddeell ll ’’AArrmmaa ddeellggeenniioo -- vv iieennee ddaattoo rr iissaall ttoo,, tt rraa ll ’’aa ll tt rroo,, aa ll CCeennttrroo AAddddeessttrraammeennttooCCoonnttrroo--OOssttaaccoolloo cchhee èè ddii ffaatt ttoo uunn CCeennttrroo ddii EEcccceell lleennzzaa,, ss iiccuurrooppuunnttoo ddii rr ii ffeerr iimmeennttoo iinn ccaammppoo iinntteerrnnaazziioonnaallee ee nnaazziioonnaallee ppeerr ii llCC--IIEEDDss ((CCOOUUNNTTEERR--IIEEDDss)) ..
TECHNE - 58
Tutto il materiale bellico residuato dei dieci annidi guerra seguiti all’invasione sovietica dell’Af-ghanistan provocava un vero e proprio «inquina-mento attivo del territorio», di dimensioni quanti-tative e qualitative macroscopiche. Dispositivipronti a funzionare che esplodendo provocavanovittime se oggetto di qualsiasi tentativo di mani-polazione, anche solo accidentale. Una situazione
che immediatamente si impose all’attenzione del-la comunità internazionale inducendo un Funzio-nario delle Nazioni Unite ad ammettere: «Le no-stre previsioni di pochi mesi addietro, secondo cuientro aprile o maggio di questo anno avremmopotuto vedere i primi profughi rientrare, si sonodimostrate ottimistiche. Per adesso dobbiamorassegnarci a vedere arrivare altri. È gente corag-giosa ed ha sopportato di tutto, ma la pelle è lapelle». L’ONU comunque iniziò ad avviare progettidi ricostruzione, in particolare canali per l’irriga-zione e case per accelerare il processo di ritornodei profughi. Ma il tutto fu limitato se non resoproibitivo dalla presenza di mine, UXOs ed ERWnascosti nel terreno e pronti ad esplodere.
L’OPERATION SALAM
Il 1° febbraio 1989 fu avviata l’Operation Salam,per fornire aiuto alla popolazione locale. L’Opera-zione ebbe un’importanza storica, destinata a du-rare nel tempo e a dimostrarsi essenziale per af-frontare uno dei macro problemi del periodo postbellico: la bonifica del territorio a salvaguardiadella sicurezza della popolazione ed a premessadi qualsiasi ripresa economica e sociale.
Stime dell’epoca riportavano che trentamilabambini e cinquemila donne in stato interessantesoffrivano di denutrizione. L’ospedale pediatricoIndira Ghandi di Kabul non riusciva più ad ospita-re degenti che invece aumentavano giorno dopogiorno. In particolare, bambini con complicazioni
AFGHANISTAN: OPERAZIONE SALAMIl 1° febbraio 1989, dopo dieci anni di presenza in Afghanistan, le truppe dell’ex Unione Sovietica iniziano alasciare definitivamente il Paese. Milioni di mine, ordigni bellici non esplosi (UXOs), materiale esplodenteancora attivo (Explosive Remnants of the War - ERW) lasciati sul terreno dalle Truppe Sovietiche e dalla resi-stenza afghana, rappresentano un pericolo di vaste proporzioni nei confronti di chiunque tenti di avventu-rarsi nel Paese. Principalmente mine anti uomo, mine anti carro e trappole esplosive antesignane dei mo-derni IED (Improvised Explosive Devices). «Armi esotiche», come erano definite da esponenti dell’Intelligen-ce statunitense, che i Mujahideen avevano imparato a costruire sul campo coordinati da esperti militari dellaCIA e dell’ISI pakistano.
A sinistra.Una comune trappola esplosiva costruita con una bom-ba a mano.
In apertura.Area search 2: attività addestrativa di Military Search diun’area con l’impiego di equipaggiamenti dedicati.
S P E C I A L E
respiratorie causate dallo stato di debilitazione,che vivevano in un territorio caratterizzato da in-verni polari e dove la tubercolosi era endemica.
In questo contesto ebbe inizio l’Operation Sa-lam voluta e coordinata dal Principe SadruddinAga Khan per far giungere aerei carichi di aiutiumanitari a Kabul. Tonnellate di viveri, medici-nali e generi di prima necessità ammassati adIslamabad ed a Peshawar, che la popolazioneafghana aspettava con ansia.
Il Principe, con impegno e capacità, riuscì a rac-cogliere ben 1,16 miliardi di dollari pari a 1 500miliardi di lire del 1989, per garantire l’afflusso dimedicinali e di almeno 600 tonnellate di cereali algiorno necessari per assicurare un minimo di nu-trizione alla popolazione.
Gli aiuti raggiungevano Kabul ed Herat, città incui era possibile utilizzare gli aeroporti, ma diffi-cilmente potevano essere portati all’interno per-ché le strade erano minate ed il territorio imper-corribile per la presenza di ordigni bellici nonesplosi. Situazione che non consentiva nemmenodi poter restituire la terra ai contadini ed ai pasto-ri nomadi e ricostruire le case per agevolare ilrientro dei profughi.
Si stimava, infatti, che le mine sparse sul territo-rio fossero circa 10 milioni, mine anti uomo posatedai sovietici che riducevano del 40% la potenzialitàagricola dell’Afghanistan. Ad esse si sovrappone-vano le migliaia di mine anti carro disperse in mo-do casuale dalla resistenza dei Mujahideen. Nessu-na delle parti aveva rispettato la regola umanitariadella mappatura topografica degli ordigni.
Il tutto accompagnato da un numero indefinitodi UXOs e di «trappole esplosive» che i Mujahi-deen avevano abbandonato sul territorio spessocamuffate come oggetti assolutamente appetibiliper una popolazione indigente. Attrezzi da cuci-na, utensili da lavoro, armi anche per uso vena-torio, suppellettili e quanto altro potesse na-scondere cariche esplosivepronte ad esplodere alla mini-ma manipolazione.
Una situazione che dovevaessere affrontata con immedia-tezza per consentire a 6-8 mi-lioni di profughi afghani, rifu-giati in Pakistan, di rientrare immediatamentenelle loro terre.
Il Principe Sadruddin Aga Khan sollecitò, quindi,le Nazioni Unite perché nell’ambito dell’OperationSalam fosse ricavato un «modulo» di «Mine Ac-tion» che rendesse possibile affrontare il pericolospecifico.
L’ONU avviò immediatamente l’iniziativa che dilì a poco si dimostrò essenziale per affrontare ilproblema dell’inquinamento post bellico dell’Af-ghanistan. Un’attività che avrebbe rappresentato
il motore di tutte le future iniziative di Mine Ac-tion realizzate dalle Nazioni Unite nel mondo, an-cora oggi necessarie ed attive.
Le Nazioni Unite attraverso UNGOMAP, MissioneONU già operativa in Afghanistan e in Pakistan,affrontarono il problema con determinazione econ il coinvolgimento di partner internazionali chegià disponevano di consolidata esperienza in ma-teria di bonifica bellica di territori.
Uno sforzo che coinvolse immediatamente altreAgenzie delle Nazioni Unite lecui iniziative umanitarie eranofrenate, se non ostacolate, dal-la presenza degli UXOs e dellemine. Il «World Food Program»impegnato a garantire 60 000tonnellate di cibo alla popola-
zione afghana ed ai rifugiati, la «Food and Agri-culture Organization» che assicurava la disponibi-lità di 6 800 tonnellate di sementi e più di 500000 alberelli di pioppo e da frutta necessari per ilfabbisogno interno afghano e per cercare di sot-trarre la terra agricola alla coltivazione del papa-vero da oppio.
In questo contesto fu immediato il coinvolgi-mento di Paesi in possesso della necessaria ex-pertise. Stati Uniti, Francia, Norvegia, Turchia,Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda ed Italia i
59 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
L’Operation Salam ebbeun’importanza storica, desti-nata a durare nel tempo...“
”
Un fabbricante di armi a Darra.
primi ad intervenire mettendo sul campo «teams»di esperti militari in grado di formare specialistidella bonifica e di sviluppare management nelsettore specifico.
Il modulo di bonifica dell’Operation Salam iniziòa produrre i suoi effetti già a metà marzo del1989, momento in cui fu attivata la struttura ope-rativa dislocata a Peshawar che, supportata logi-sticamente dall’Esercito pakistano, iniziò ad ope-
rare presso il campo militare di Risalpur avvalen-dosi di specialisti militari delle Nazioni che aveva-no aderito, distaccati temporaneamente presso leNazioni Unite con lo status di civili.
Questi esperti avviarono immediati cicli formativiche prevedevano anche lo sviluppo di programmidi sensibilizzazione della popolazione civile perinsegnare a convivere con lo specifico pericolo,senza subirne le conseguenze letali. Contempora-neamente si iniziò ad affrontare l’aspetto normati-vo volto a conferire la necessaria standardizzazio-ne alle attività operative di bonifica, per garantireagli operatori la massima sicurezza ed assicurarela necessaria affidabilità degli interventi.
Alla fine dell’Operation Salam, due anni dopo,furono raggiunti nel settore della Mine Action si-gnificativi risultati di elevata valenza umanitaria,fra cui la formazione di più di 15 000 sminatoriafghani, ai vari livelli di staff ed operativi. Molti dicostoro operano tuttora sul territorio afghano edin tutto il mondo anche ricoprendo considerevoliincarichi di management specifico in ambito inter-nazionale e nelle Agenzie delle Nazioni Unite, pri-ma fra tutte l’Agenzia UNMAS (UN Mine ActionService).
L’Italia è stato uno dei primi Paesi occidentali acontribuire a questa importante iniziativa. Sul fi-nire del 1988 il Governo Italiano approvava, infat-ti, la partecipazione all’iniziativa internazionalepromossa dall’ONU, nel più vasto programma diaiuti all’Afghanistan (UNOCA, United Nations Offi-
ce for Coordinating Relief in Afghanistan, «Opera-tion Salam») per sensibilizzare i rifugiati afghanisul problema degli ERW e formare gli specialistinecessari per la bonifica del territorio.
Lo stesso Ministro degli Esteri protempore,l’Onorevole Giulio Andreotti, attraverso il Segreta-rio Generale della Farnesina, Ambasciatore BrunoBottai, confermava ufficialmente al Principe Sa-druddin Aga Khan l’impegno italiano in favore delprogramma di ricostruzione. In questo contesto laFarnesina auspicava «che l’azione del coordinato-re possa rafforzarsi per mantenere aperte quellepotenzialità di intervento umanitario delle NazioniUnite che in altre circostanze ed in zone di crisihanno facilitato le condizioni politiche idonee allacomposizione di interessi contrapposti». Venivaanche ufficialmente dichiarato un aiuto italiano di14 milioni di dollari e l’invio di otto esperti italianicon il compito di facilitare le operazioni di smina-mento.
Domenica 26 marzo 1989 il quotidiano «La Re-pubblica» a pag. 13 informava, con l’articolo tito-lato Impegno ONU dell’Italia per sminare l’Afgha-nistan, che «... su richiesta delle Nazioni Unite,otto Ufficiali italiani appartenenti all’Arma del ge-nio fungeranno da istruttori per lo sminamentodegli immensi campi minati lasciati dai militarisovietici dopo il loro totale ritiro dal territorio af-ghano. Ecco i nomi degli Ufficiali italiani che pas-seranno al servizio dell’ONU per un periodo di al-meno sei mesi: sono il Tenente Colonnello Fer-nando Termentini, Tenente Colonnello Enzo Mi-chetti, Maggiore Vittorio Pennisi, i Capitani Fran-cesco Giannatiempo, Antonio Ciardo e MarcoCiampini ed i Tenenti Antonello Carpino ed EmilioBruno».
Il 1° marzo del 1989, per la prima volta dopo lafine del Secondo conflitto mondiale, un nucleoautonomo di esperti Ufficiali dell’Arma del geniodell’Esercito Italiano si stabiliva in Pakistan alconfine con l’Afghanistan, inserendosi immedia-tamente ed a pieno titolo nell’iniziativa interna-zionale che stava nascendo, l’Operation Salam.
A Peshawar gli esperti italiani addestrarono in seimesi più di 600 profughi afghani. Alcuni di loro,appena terminato l’iter formativo, iniziarono im-mediatamente ad operare in Afghanistan, sullastrada che da Jalabad portava a Kabul.
Tutte le attività addestrative, a fuoco ed in bian-co, venivano svolte a Risalpur presso un campo at-trezzato gestito dall’Esercito pakistano, dislocato acirca 60 km dalla città di Peshawar. Il tutto gestitoda uno Staff internazionale coordinato da un Uffi-ciale Superiore statunitense mentre, successiva-mente, una struttura analoga veniva aperta aQuetta e gestita da un Ufficiale Superiore inglese.
Gli esperti italiani hanno lavorato in completaautonomia decisionale, operativa e logistica, fa-
TECHNE - 60
La prima Delegazione italiana di esperti a Peshawar.
cendo solo riferimento alla loro professionalitàdi Ufficiali dell’Arma del genio e riscuotendo ilconsenso delle Autorità locali, delle altre Dele-gazioni internazionali che operavano nell’ambitodell’operazione e soprattutto degli «studenti af-ghani».
I Pionieri dell’Operation Salam, il 1° maggio1990, furono seguiti da altri colleghi che incre-mentarono ed esaltarono i risultati raggiunti dal-l’Italia operando nei campi di Quetta, sempre inPakistan.
L’attività
L’avvio dell’Operation Salam avveniva in un mo-mento non facile per l’Afghanistan ed anche in uncontesto internazionale teso per tali avvenimenti.
L’invasore sovietico aveva appena abbandonatoil Paese lasciando, però, un’eredità consistente sulpiano politico rappresentata dal partito filosovie-tico afghano che non vedeva di buon occhio l’in-terferenza, nelle faccende nazionali, dell’Occiden-te in generale e degli Stati Uniti in particolare. Fi-losovietici afghani che proprio a ridosso dell’arri-vo degli esperti italiani invitavano la ComunitàEuropea a prodigarsi in una mediazione con gliStati Uniti per far cessare gli aiuti alla guerrigliaislamica e contemporaneamente il Ministro degliEsteri britannico, Sir Geoffry Howe, annullava unavisita programmata in Pakistan per «motivi di si-curezza» conseguenti alle minacce rivolte dagliintegralisti islamici pakistani all’Inghilterra per lapubblicazione del libro di Salman Rushdie sui«versetti satanici», condannato da Komehini comeblasfemo.
Una situazione di instabilità palpabile nelle zonepakistane immediatamente a ridosso del confineafghano, incrementata anche dal fatto che in queigiorni i Mujahideen, fuggiti dal Paese, dopol’uscita dell’Armata Rossa si erano mescolati ai ri-fugiati cercando di fare proseliti per contrastarela componente filosovietica del Governo di Kabul.Rifugiati che spesso abbandonavano improvvisa-mente i campi in Pakistan per raggiungere Jala-bad, a circa 30 km da Peshawar, per parteciparealla «Jihad» anche con la partecipazione di circa500 militari regolari dell’Esercito pakistano («LaRepubblica», 26 marzo 1989).
Un clima di tensione elevato, percepibile viven-do fra i rifugiati afghani, contadini, pastori edanche molti intellettuali, alcuni dei quali ex Muja-hideen che avevano combattuto l’invasore sovie-tico.
Anche le condizioni locali pakistane non eranodelle migliori. Gli equilibri interni alla Provinciapakistana della «North West Frontiere» non erano,infatti, dei più facili. Una regione autonoma quasifuori del controllo del Governo Centrale di Isla-
mabad, immediatamente a ridosso del confinecon l’Afghanistan, lungo l’asse viabile principaledel Centro Asia. La strada del Kyber Pass, l’antica«via della seta» che da Oriente arriva ad Occidenteproprio attraverso il Pakistan, l’Afghanistan e laTurchia. Una zona dove anche le condizioni am-bientali non erano delle più facili. Caldo elevatocon un tasso di umidità prossimo al 95%, assola-ta, in alcuni punti desertica. Nel 1989 priva di ri-sorse logistiche seppure elementari. Anche le co-municazioni telefoniche erano difficili e rese pos-sibili solo grazie ad un unico posto telefonicopubblico, non sempre funzionante.
Quetta, dove sarebbe stata destinata la secon-da Delegazione italiana, era una realtà simile. Pertaluni aspetti ancora più difficile dal punto di vistagenerale in quanto lungo la strada che dal Paki-stan porta alla provincia afghana di Kandahar, chedi lì a poco sarebbe diventata una roccaforte del-l’emergente regime talebano.
Le giornate erano impegnative. Si iniziava a lavo-rare alle quattro del mattino per terminare a po-meriggio inoltrato, intervallando le attività adde-strative ad impegni normativi che vedevano i Con-tingenti coinvolti nella redazione dei primi manualioperativi e delle prime procedure di bonifica stan-dardizzate (Standard Operative Procedures - SOP).Una normativa che sarebbe diventata la base ditutte le attività di Mine Action nel mondo e che
ancora oggi, seppure attualizzata, rappresenta unriferimento essenziale e vincolante.
I frequentatori venivano scelti dai partiti politiciafghani o dai Comandanti partigiani dei Mujahi-deen presenti fra i rifugiati in Pakistan. L’identitàed affidabilità dei prescelti veniva successivamen-te verificata dall’Intelligence pakistana prima del-l’ammissione alla frequenza di corsi. Le classierano formate da allievi di età compresa fra i 22ed i 38 anni, scelti anche tenendo conto del grup-po etnico o del clan di appartenenza ed in base ai
61 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Una classe di frequentatori.
previsti tempi di rientro in Afghanistan, program-mati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite(UNHCR).
I corsi base per la formazione degli sminatoriavevano la durata di 2 settimane. Le aule di inse-gnamento erano ricavate in tende militari ed iprogrammi prevedevano materie teoriche e prati-che, fra cui l’uso di base degliesplosivi. Ogni ciclo di 15 gior-ni terminava con una validazio-ne teorico-pratica. Coloro chenon superavano l’esame pote-vano frequentare il corso unaseconda volta.
Un’attività complessa ed arti-colata che comprendeva finan-che elementi di pronto soccorsoreciproco in caso di incidentidurante le attività di bonifica edi sensibilizzazione al pericolo delle mine.
Ogni argomento veniva sviluppato con la curadel particolare e considerando le tradizioni locali.Venivano rispettati gli orari di preghiera, i periodidi digiuno e le donne venivano avvicinate solo dapersonale istruttore femminile.
Una preparazione sviluppata con la massima at-tenzione per evitare di dare informazioni tecnichedi carattere militare che potessero in qualche mo-do attualizzare le conoscenze specifiche pregres-se di qualcuno dei rifugiati già combattente dei
Mujahideen. In particolare venivano insegnateunicamente le tecniche e le procedure per indivi-duare gli ordigni e distruggerli sul posto senzafornire alcuna indicazione sulla neutralizzazione odisattivazione degli stessi che avrebbero consen-tito quanto meno di recuperare esplosivo e dispo-sitivi di accensione.
Le lezioni venivano svolte in inglese con la tra-duzione simultanea, da parte di militari pakistani,nelle lingue locali. Molte le difficoltà incontratesul piano didattico, in particolare per lo scarsissi-mo grado di scolarizzazione della maggior partedei rifugiati. Pochi erano in grado di leggere escrivere. Molti non erano abituati ad ascoltare perlungo tempo. Si imponeva quindi il ricorso fre-quente all’insegnamento per «immagini», moltoben accettato dai discenti che colmavano le lorocarenze culturali con doti accentuate di memoriavisiva. Difficilmente, infatti, gli studenti dimenti-cavano ciò che veniva loro insegnato attraversol’uso di appropriata cartellonistica.
Altrettanto grande fu l’impegno degli istruttoriper convincere i frequentatori a superare l’innatofatalismo della cultura islamica, a totale vantaggiodella sicurezza individuale nel corso nelle attivitàdi bonifica. In ogni caso da parte di tutti vi era unelevato interesse ad imparare.
Un’esperienza ricca di contenuti per gli Ufficialidel genio italiani, in quanto veicolo per entrare incontatto con culture e realtà assolutamente lonta-ne da qualsiasi modello di vita occidentale. Unmomento di crescita professionale conseguenteall’esigenza ricorrente di dover affrontare e risol-vere problematiche operative apprese fra i banchidegli Istituti di formazione militari, ma fino a quel
momento mai validate pratica-mente.
Le attività svolte e la com-petenza specifica dimostratadagli otto Ufficiali del genio fuimmediatamente apprezzatadal management internazio-nale dell’operazione e daglistessi afghani. Immediata,quindi, la decisione di affidarealla delegazione di espertiitaliani lo sviluppo del primo
corso per «futuri Istruttori professionali e Su-pervisori Tecnici della bonifica» destinato a for-mare i responsabili della gestione e dell’orga-nizzazione dei futuri cantieri di bonifica. Un pe-riodo formativo, questo, molto intenso ed im-pegnativo che comunque ottenne risultati rile-vanti considerando che ben tre dei dieci fre-quentatori nell’immediato futuro avrebbero ri-coperto incarichi di alta responsabilità nella Mi-ne Action internazionale, dove tuttora, a distan-za di venti anni, sono ancora impegnati.
TECHNE - 62
Le attività svolte e la com-petenza specifica dimostratadagli otto Ufficiali del geniofu immediatamente apprez-zata dal management inter-nazionale dell’operazione edagli stessi afghani
“
”
La distruzione di un residuato bellico.
I risultati
Il 1989 rappresenta l’anno zero per l’inizio delleattività di bonifica umanitaria nel mondo e il mo-mento in cui la comunità internazionale inizia adoccuparsi del pericolo specifico per la popolazio-ne civile costretta a vivere in un Paese che haospitato uno scontro armato. Una minaccia indot-ta dalla presenza di mine, ordigni bellici nonesplosi (UXOs) e quanto di ancora attivo rimastosul terreno dopo l’evento bellico (Explosive Re-mants of the War - ERW).
Definire, quindi, l’Operation Salam come la«madre della Mine Action Internazionale» non èazzardato. Le attività svolte nell’ambito dell’ini-ziativa umanitaria delle Nazioni Unite ha portato,infatti, risultati immediati, alcuni dei quali ancoraidentificabili nelle procedure e modalità applicatenella bonifica dei territori sia per quanto attieneall’approccio operativo sviluppato sia per quantoconcerne la gestione politica e di management.
Le attività svolte a Peshawar e a Quetta nonhanno avuto solamente ricadute locali. L’Opera-tion Salam oltre a formare più di 15 000 bonifica-tori, attraverso quello che può essere definito«training on the job», ha permesso, anche, di tra-vasare nel mondo le conoscenze e le esperienzespecifiche per affrontare il problema della MineAction in modo costruttivo, efficace e con un fa-vorevolissimo rapporto di costo-efficacia.
Ha consentito altresì di attirare l’interesse inter-nazionale su un problema specifico, rilevante perla sicurezza delle popolazioni residenti nei Paesi«affected» ed altrettanto importante sul pianodell’impegno socio-economico e sanitario peraiutare chi rimane coinvolto nelle esplosioni ed iportatori di handicap per danni fisici conseguenti.
Una serie di risultati di elevato contenuto con-cettuale ed operativo, forse mai raggiunti nel-l’ambito di altre iniziative di Cooperazione Inter-nazionale, e con una ricaduta assolutamente po-sitiva anche sugli interventi militari di Peace Kee-ping che dal 1989 ad oggi si sono sovrappostisugli scenari internazionali.
La valenza degli effetti dell’Operation Salam èancora più significativa tenuto conto dei risultatiche le attività svolte hanno permesso di raggiun-gere negli ambiti internazionali ed anche in quellinazionali dei Paesi che hanno partecipato a pienotitolo alle attività specifiche.
Aspetti questi di elevato contenuto se si consi-dera che l’Operation Salam ha evidenziato l’esi-genza di costituire centri di coordinamento delleattività specifiche. I «Mine Action Centre», di cui ilprimo costituito proprio a Kabul all’inizio degli an-ni ’90, fondato e diretto proprio da colui che sa-rebbe diventato il maggior responsabile presso leNazioni Unite delle attività di bonifica nel mondo.
Ed ancora, in occasione dell’Operation Salam èstata individuata ed affrontata l’esigenza dellaredazione delle Procedure Operative Standardiz-zate (SOP) che ancora oggi, seppure migliorateed affinate nel corso degli anni, sono applicate intutto il mondo. Normativa pensata e scritta pro-prio a Peshawar nella primavera-estate del 1989.Standards operativi implementati successivamen-te da altre procedure per la sensibilizzazione
della popolazione sul problema delle mine, degliUXOs e degli ERW in generale (Mine Risk Educa-tion - MRE) avviate a Peshawar e migliorate neltempo a Quetta.
Infine, in quei giorni, sono stati individuati edapplicati i primi «Flowchart» logici per la gestionedei problemi di bonifica, per la formazione delpersonale, per il controllo e monitoraggio del ter-ritorio (Survey tecniche - Area Reduction), per lasensibilizzazione della popolazione. Tutto «in-ventato» e sperimentato per la prima volta a Pe-shawar e a Quetta, in Pakistan.
63 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Addestramento al metal detector.
La maggior parte dei Paesi che hanno partecipa-to all’Operation Salam hanno ricavato fondamen-tali spunti per le organizzazioni nazionali di MineAction dalle lezioni apprese in occasione del lavo-ro svolto in Pakistan. Un bagaglio professionale diestrema importanza, i cui contenuti operativi fan-no ormai parte del DNA degli specialisti nazionaliesperti di bonifica.
In Italia, quanto appreso dalle attività svolte inPakistan a favore dei rifugiati afghani ha consentitodi migliorare l’expertise degli specialisti del genio edi creare nel tempo il Centro Operativo di Bonifica(COB), centro di eccellenza operativo presso laScuola dell’Arma del genio di stanza a Roma. Unastruttura oggi guardata con rispetto ed ammirazio-ne dagli operatori internazionali impegnati ad af-frontare il problema specifico, nata proprio dalleesperienze maturate sul campo dai primi espertiitaliani, prima nell’Operation Salam e, successiva-mente, in Kuwait subito dopo la fine della PrimaGuerra del Golfo.
Polo per la formazione degli esperti di Forza Ar-mata e delle Forze di Polizia, fondamentale per lagestione dei nuclei operativi in Aree di Contin-genza, garante della sicurezza dei militari impe-
gnati in Operazioni di Peace Keeping e delle po-polazioni locali costrette a convivere con il pro-blema specifico.
L’Operation Salam, in sintesi, ha consentito diaffinare tutte le metodologie di intervento diestrema validità nei diversi settori della bonificadei territori, come la formazione, lo sminamento,la bonifica di vaste aree contaminate da ERW (Bat-tle Area Clearance - BAC), le attività di neutraliz-zazione e distruzione degli Ordigni Bellici nonEsplosi (Explosive Ordnance Disposal - EOD), leattività antisabotaggio per individuare e neutra-lizzare le «trappole esplosive» (Improvised Explo-sive Device - IED).
LA MINE ACTION INTERNAZIONALE
Più volte si è accennato alla ricaduta positivadelle attività di Mine Action svolte nell’ambitodell’Operation Salam, comprendendo nella «Azio-ne contro le Mine» tutte le attività necessarie,concettuali ed operative.
In rapida sintesi e prima fra tutti l’individuazio-ne di procedure standard che consentano di lavo-rare in tutto il mondo con tecniche analoghe chegarantiscano l’ottimizzazione dei risultati e, qua-lora necessario, la sovrapposizione dei dispositivioperativi.
Ancora, il monitoraggio dei territori a rischio contecniche di «Survey», anche esse standardizzate enon solo finalizzate a sviluppare un approccio so-lamente tecnico ma anche e soprattutto applicandometodi di indagine socio-economica integrati conmoderne tecniche di «Global Information System»(GIS). La strutturazione di Data Base globali gestitisecondo criteri standardizzati che fanno capo a«International Management System for Mine Action- IMSMA» che consentono di individuare le prioritàda assegnare agli interventi internazionali di boni-fica e di allocare le necessarie risorse.
Inoltre, la formazione di personale specializzatolocale, essenziale per attuare una concreta ed ef-ficace Capacity Building specifica ed incrementarel’efficacia delle risorse economiche impegnatedalla Comunità Internazionale, e di quello desti-nato a sviluppare secondo criteri moderni le atti-vità di sensibilizzazione della popolazione localesul problema specifico.
Una serie di risultati oggettivi che fanno capo aduna struttura internazionale di gestione del pro-blema scaturita proprio dall’esperienza dell’Ope-ration Salam che, come detto, ha portato allastrutturazione organica della gestione della MineAction nel mondo. Dalla creazione dei Mine Ac-tion Centre, alla realizzazione, un anno dopo lafine dell’operazione, dell’Agenzia dell’UN MineAction Service (UNMAS), in crescita progressiva
TECHNE - 64
Sopra e nella pagina a fianco.Bonificatori in addestramento.
mano a mano che si accentuava l’interesse del-l’ONU sul problema delle mine.
Una Agenzia delle Nazioni Unite che gestisce ilproblema sul piano normativo e concettuale e,nelle fasi di emergenza, anche gestendo le risorseeconomiche finalizzate al problema specifico.Un’attività capillare, quella svolta da UNMAS,orientata soprattutto a sviluppare un’azione diCapacity Building, che qualsiasi iniziativa di Coo-perazione Internazionale deve porre come risulta-to preminente in quanto garante della formazionedi affidabili autonomie locali in grado di affronta-re e gestire in proprio lo specifico problema.
Un impegno operativo che ormai tocca in modosignificativo quasi un terzo del mondo, coinvol-gendo le Nazioni Unite attraverso UNMAS e altreagenzie preposte ai programmi di sviluppo a fa-vore dei Paesi Terzi, fra cui la principale UN Deve-lopment Programme (UNDP).
Angola, Bosnia Herzegovina, Afghanistan, Iraq,Iran, Fyrom, Sudan, Congo, Cambogia, Yemen etanti altri ancora i Teatri che ospitano il maggioreimpegno internazionale nel settore della MineAction in generale e della bonifica umanitaria inparticolare. Un impegno di fondamentale impor-tanza per la ripresa economica e sociale dellepopolazioni costrette a convivere con il problemae componente fondamentale a premessa di ogniiniziativa finalizzata a prevenire possibili conflittifuturi.
Un’attività, quella della bonifica umanitaria conuna valenza differenziata, non solo contingente efinalizzata alla eliminazione di ordigni pericolosi.Piuttosto un impegno di coope-razione internazionale che per-mette una immediata riconver-sione degli smobilitati ed un’al-trettanto immediata integrazio-ne operativa fra persone che fi-no a un momento prima eranonemiche, oggi impegnate adaffrontare ed eliminare un peri-colo grave a vantaggio dei lorofigli e di loro stesse.
Un’attività che coagula lacollaborazione e l’amicizia in quanto nell’ambi-to delle strutture di bonifica l’incolumità di cia-scuno è strettamente connessa e dipendentedall’impegno del collega.
Qualcosa che contribuisce, anche in modoconcreto, a possibili azioni per la prevenzionedei conflitti perché, oltre a favorire la crescitaeconomica, elimina ogni traccia del passatobellico. Mine, UXOs ed ERW che, se lasciati sulsuolo, potrebbero, nel corso dei decenni suc-cessivi al termine del conflitto, innescare all’at-to di una possibile esplosione nuove situazionidi vendetta e quindi di conflitto.
Rilevanti anche i risultati di natura politica,come il coinvolgimento della società civile nel1993 con la Campagna Internazionale per lamessa a bando delle mine anti uomo che, sensi-bilizzata da quanto arrivava dal campo, in parti-colare dall’Afghanistan, ha promosso la Con-venzione di Ottawa per la messa a bando didetti ordigni.
L’Italia, nella Mine Action Internazionale ha rag-giunto ormai un ruolo molto importante: sul piano
politico, su quello finanziario esu quello della professionalitàdei propri operatori che, a par-tire dalla Operation Salam,hanno contribuito e contribui-scono a esaltare i contenutidegli interventi di bonifica e asoddisfare le aspettative deibeneficiari.
I risultati raggiunti sonofondamentali nell’immediatoe nel lungo tempo. Nell’im-
mediato per affrontare in sicurezza e con affida-bilità interventi di Peace Keeping e di interposi-zione militare in Aree di Contingenza, nel brevetermine per consentire interventi di sviluppo co-me la ricostruzione, la ripresa delle attività eco-nomiche e dell’agricoltura. Nel lungo termine pergarantire attività sicure anche a distanza di tem-po come avviene tuttora in Afghanistan ed anchein Paesi europei ormai lontani dalla guerra, comel’Italia.
Fernando TermentiniGenerale di Brigata (ris).
65 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
L’Italia, nella Mine ActionInternazionale ha raggiuntoormai un ruolo molto im-portante: sul piano politico,su quello finanziario e suquello della professionalitàdei propri operatori...
“
”
TECHNE - 66
La missione, composta da quattro Ufficiali (Ca-pitano Mario Ruggero, Capitano Giuseppe Anzal-di, Tenete Davide Dannunzio e Tenente PierluigiScaratti) e due Sottufficiali (Maresciallo Pepe eSergente Maggiore Natalino Guarino) è stata con-cepita, organizzata e condotta esclusivamentedall’Arma del genio.
Sulla base dell’esperienza maturata nella prece-dente missione, è stata dedicata particolare at-tenzione, da parte dell’Ispettorato dell’Arma delgenio, alla selezione del personale, su scala na-zionale, e a una specifica formazione articolata supiù fasi.
In particolare, con la dinamica del «learning onjob», dopo aver scelto il personale sono stati pre-disposti e svolti dalla Scuola del Genio, un corsodi lingua inglese di circa 30 giorni e un aggiorna-mento sulle mine, in particolare, su quelle pre-senti in teatro operativo.
Ai primi di febbraio del 1990, con preavviso di 7giorni, è iniziato il trasferimento dall’Italia al Paki-stan. Dopo una prima tappa a Islamabad per unabreve presentazione al Comando della missionepatrocinata da UNOCHA sotto la supervisione del-l’Aga Khan siamo stati inviati a Quetta, nel deser-to del Baluchistan, per riaprire un campo di adde-stramento chiuso durante la stagione invernale.
Il Baluchistan, oggi noto alle cronache comecrocevia del terrorismo internazionale di matriceislamica (Al Qaida) e rifugio sicuro per i Talebani,è un altopiano desertico di circa 1 800 slm cheunisce senza soluzione di continuità Pakistan eAfghanistan. È caratterizzato da condizioni clima-tiche estreme con un terreno aspro e comparti-mentato e una natura sterile.
L’area, da un punto di vista prettamente antro-pico, è caratterizzata dalla presenza di tribù no-madiche (Baluchi) e da una fortissima comunità diprofughi afghani formatasi a ridosso del confine,durante la guerra sovietico-afghana. Le popola-zioni per cultura, tradizioni e qualità della vitapossono essere assimiliate alla società feudale
europea del X/XII secolo d.C..La direzione delle attività, che avremmo presto
iniziato, era stata affidata al contingente del Re-gno Unito, in particolare al Tenente ColonnelloMullins dei «Royal Engineer», che successivamen-te sarebbe diventato responsabile delle attività disminamento presso le Nazioni Unite a New York.
Oltre a noi sei italiani, facevano parte del con-tingente dieci militari della Gran Bretagna e, dopoqualche mese, due Ufficiali turchi.
Il Comando principale delle operazioni era di-slocato ad Islamabad, a 1 700 km da Quetta, rettoda un Generale turco coadiuvato da un Colonnellocanadese.
Nei pressi di Islamabad, precisamente a Pesha-war, era operativo un campo di addestramentogemello dove, tra l’altro, aveva prestato servizio ilprimo nucleo italiano.
La prima operazione che abbiamo dovutosvolgere a Quetta, dopo avere ricevuto le con-segne da due teams di «Green Berrets» statuni-tensi, è stata la riapertura del campo di adde-stramento, noto come «Beleli Camp», rimastochiuso nel periodo invernale.
Il campo di addestramento era organizzato egestito dall’Esercito pakistano che, all’interno diun poligono militare aveva costruito un attenda-mento completo per accogliere in maniera spar-tana, ma per tutta la durata del corso, i fre-quentatori.
L’area, durante il Secondo conflitto mondiale,era sede di un campo di prigionia di guerra ingle-se dove anche nostri connazionali sono stati de-tenuti.
Inoltre, il Comando ONU aveva ritenuto fonda-mentale, prima di iniziare i corsi, revisionare pub-blicazioni addestrative e relativi piani di lezione,per cui i primi quindici giorni sono stati trascorsia scrivere, preparare lezioni e perfezionare le at-trezzature per il supporto didattico.
I corsi di addestramento, generalmente di dura-ta quindicinale erano sostanzialmente mirati alla
OPERAZIONE SALAM 2Quetta-Baluchistan, febbraio-settembre 1990
Il 1° febbraio 1990 partiva, sotto l’egida dell’ONU con mandato semestrale, la seconda missione di ad-destramento per lo sminamento, a favore delle popolazioni afghane, nota come «Operation Salam», ov-vero «Operazione Pace».
S P E C I A L E
formazione di semplici operatori, di team e di di-rettori di bonifica.
Il personale ammesso a frequentarli, selezionatoda Capi tribù afghani, aveva un’età compresa trai 14 e gli 80 anni.
Dopo la selezione è stato suddiviso in classiomogenee di circa trenta persone a seconda dellalingua parlata: Urdu, Farsi o Pastun.
Le lezioni tenute da teams misti composti dadue internazionali, quattro o cinque aiuto istrut-tori afghani e due interpreti dell’Esercito pakista-no per tradurre dall’inglese alla lingua parlata, siconcludevano con un esame teorico e pratico.
Alla fine di ogni corso, gli allievi potevano rien-trare in Afghanistan, dotati di Kits da sminatore,un’assicurazione sugli infortuni, una carta razionidell’ONU, e iniziare la bonifica del territorio.
Degna di menzione è stata la visita del rappre-sentante dell’allora Segretario Generale dell’ONUStefan De Mistura, che con personale da noi ad-destrato aveva svolto con successo un’attività disminamento in territorio afghano.
La complessità della missione, che vedeva il pic-colo contingente in posizione di esperti civili del-l’ONU e non, quindi, militari, ha reso necessarioaffrontare e sviluppare quelle azioni oggi ricon-ducibili, per certi versi, alla Cooperazione CivileMilitare (CIMIC) piuttosto che a operazioni psico-
logiche (PSYOPS).In conclusione, possiamo dire che non è man-
cata la motivazione e la voglia di dimostrare lenostre capacità in un delicatissimo compito che,alla luce di quello che è avvenuto dopo (Guerradel Golfo, Mozambico, Somalia, Balcani, Iraq eAfghanistan) ha rappresentato la base fondantedel corso bonifica ordigni esplosivi (BOE) prima edell’Explosive Ordnance Disposal (EOD) dopo.
Il profondo senso di responsabilità, l’attacca-mento all’Istituzione e quel modo particolare tipi-co di noi italiani ha permesso di supplire alle ca-renze di esperienza della Forza Armata di queitempi ma soprattutto ha permesso un adattamen-to alla situazione contingente che ha portato al ri-conoscimento indiscusso del nostro operato tantoda richiedere, da parte dell’ONU, un’estensionedella missione per tutto il contingente.
Pierluigi ScarattiColonnello,
in servizio pressoil Combined Planning Group Strategy,
Plans and Policy DirectorateU.S. Central Command (CENTCOM)
67 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Un odierno addetto alla bonifica.
TECHNE - 68
In ogni conflitto moderno si è sempre fatto ri-corso all’uso di ordigni esplosivi quali mine, trap-pole antiuomo e mine anticarro di ogni forma edimensione. Ciò che invece caratterizza i nuoviscenari operativi è la costante minaccia rappre-sentata dagli ordigni esplosivi improvvisati (Im-provised Explosive Devices - IEDs), cioè manufatticonfezionati artigianalmente, composti da unacarica esplosiva in quantità non standardizzata,da materiale contundente inerte di varia natura,da un innesco e da un detonatore con relativoerogatore di energia per la sua attivazione.
La lotta contro tale tipo di minaccia, meglio notacome Counter-Improvised Explosive Device (C-
IED) consiste nell’insieme delle attività tese a pre-venire, ridurre o eliminare gli effetti di tutte le ti-pologie di IEDs utilizzate contro le Forze amiche ei non combattenti (pub. AJP-3.15 «Allied Doctrinefor Joint Operations C-IED» - 2nd Study Draft).
Le procedure operative, quindi, hanno dovutosubire un’inevitabile rivisitazione «sul campo» inchiave C-IED. Infatti, il ricorso a tali ordigniesplosivi rappresenta la principale e più remune-rativa alternativa a disposizione delle cellule ter-roristiche per infliggere perdite e minare la volon-tà delle varie Coalizioni. Essi, diversi per dimen-sioni e modalità di funzionamento, possono es-sere mascherati, distribuiti e impiegati nei modipiù vari. Per costruirli si possono utilizzareesplosivi sia di uso militare che civile, oppuremiscele di composti che, se presi singolarmen-te, risultano inerti. Il basso costo dei materialinecessari per il loro confezionamento, la facilitàdell’approvvigionamento e dell’occultamentodegli stessi, uniti agli effetti devastanti del loroutilizzo, hanno reso gli IEDs l’arma principaledel terrorismo nel contesto della guerra asim-metrica.
Il loro utilizzo riduce notevolmente la capacitàoperativa delle unità dislocate nei vari teatri ope-rativi, determinando inevitabili effetti tattici, ope-rativi, strategici e mediatici in grado di inciderepersino sulle decisioni dei vertici politici. Il loroimpiego può in sostanza essere paragonato a unavera e propria Effect Based Operation.
La C-IED non è finalizzata al mero disinne-sco/disattivazione dell’IED, attività questa chene rappresenta solo l’atto conclusivo.
LA LOTTA AGLI ORDIGNI ESPLOSIVIIMPROVVISATI: COUNTER-IED
La fine della Guerra Fredda ha generato una serie di instabilità locali che hanno dato luogo non solo a mis-sioni di Peacekeeping ma anche a conflitti asimmetrici. Le nostre Forze Armate, in tale contesto internazio-nale, sono chiamate a coadiuvare Governi locali nell’opera di Nation Building, con tutto ciò che ne deriva,ma anche a fronteggiare azioni terroristiche che possono contare su un elemento in più: il congegno esplo-sivo improvvisato (Improvised Explosive Device - IED), considerato il pericolo più incombente negli odierniscenari operativi.
A sinistra.Il cratere prodotto da un IED su un manto stradale.
S P E C I A L E
La NATO concepisce la lotta contro gli IEDs co-me quella in grado di garantire alle forze in cam-po la condotta delle operazioni, riducendo nelcontempo al minimo le perdite o, meglio, annul-landole.
Nei vari ambiti nazionali tale lotta è effettuataattraverso la revisione e l’elaborazione di direttivee dottrine, con l’utilizzo di specifici equipaggia-menti e la condotta di un addestramento mirato.
La casistica sino ad oggi riscontrata, relativa-mente alle aree urbane, annovera attacchi suicidicondotti con l’impiego di cinture esplosive (impro-priamente denominati Kamikaze), l’utilizzo di au-toveicoli imbottiti di materiale esplodente, attivaticon timer (Vehicle Borne IED - VBIED), telecoman-do (Radio Controlled Vehicle Borne IED - RCVBIEDo da attentatori (Victim Operated IED - VOIED) chesi lanciano contro il bersaglio prescelto.
Nelle aree rurali gli IEDs sono solitamente atti-vati da telecomando oppure facendo ricorso alclassico cavo elettrico. A questi si aggiungono al-tri metodi classici di attivazione quali «a rilasciodi pressione», «anti-rimozione» e «a pressione».Sono state, inoltre, riscontrate varie combinazionidei citati metodi di attivazione, che rendono l’IEDancora più insidioso.
Con riferimento ai vari teatri operativi, che ve-dono impegnate le forze NATO e delle coalizioni,è stato riscontrato che mentre in Afghanistan si faprincipalmente ricorso agli IEDs collocati in areeextraurbane, ai margini delle vie di comunicazio-ne (road side IEDs), ai Kamikaze e ai VBIEDs, inIraq, ove la tecnologia è più sofisticata, si privile-gia l’utilizzo degli stessi in areeurbane, ricorrendo a sensoripassivi all’Infrarosso abbinati atelecomandi a distanza.
Per i prossimi anni si stima unprogressivo sviluppo tecnologi-co di tali ordigni, che verrannorealizzati anche facendo ricorsoa internet per la progettazionee le modalità di assemblaggio.
I sistemi di attivazione sa-ranno, verosimilmente, sem-pre più efficaci e nell’eventualità non siano piùdisponibili alcune componenti o si sia indivi-duata un’efficace contromisura, saranno elabo-rate ulteriori modalità di confezionamento e/odi attivazione finalizzate a rendere la minacciaancora più imprevedibile.
Per un efficace contrasto agli IEDs è, quindi,fondamentale concentrare l’attenzione e com-prendere il contesto sociale nel quale essi sonoconcepiti, costruiti e utilizzati. Un quadro delleinterazioni tra popolazione civile e cellule, gruppiod organizzazioni terroristiche, può consentireuna previsione dei potenziali bersagli futuri.
La popolazione, in tale contesto, può essereparte attiva, fornendo supporto logistico, traspor-to, posizionamento e attivazione diretta degli or-digni, oppure passiva consentendo ai ribelli dioperare, muoversi, nascondersi tra la gente e im-pedendo fughe di notizie.
Pertanto il primo elemento chiave nella lottacontro gli IEDs è rappresentato da un valido ad-destramento del personale, focalizzato al ricono-scimento dei luoghi potenzialmente idonei all’at-tacco e delle caratteristiche principali, comuni al-l’attentatore suicida tipo, all’osservazione dei
possibili obiettivi, con atten-zione ai minimi dettagli, allametodologia di reazione, al-l’ottimizzazione delle proce-dure per l’impiego dei cinofili,alle lessons learned (lezioniapprese).
Il secondo elemento chiaverisulta essere la ricerca tecno-logica. Infatti, i progressi otte-nuti nel campo della ForceProtection dei veicoli ha porta-
to alla costruzione e all’impiego in teatro deimezzi «MRAP» (Mine Resistant Ambush Protec-ted), cioè veicoli caratterizzati da una cellula co-razzata con scafo a «V» in grado di defletteregran parte dell’energia prodotta da un’esplosionee garantire, quindi, maggiore integrità dell’abita-colo. Inoltre, per contrastare l’impiego di IEDscontrollati (Radio Controlled Improvised Explosi-ve Devices - RCIEDs), si stanno impiegando deisistemi elettronici, detti «Jammers», per distur-bo/annullamento delle radiofrequenze di attiva-zione. Tali sistemi possono essere a grande opiccola capacità in funzione dell’impiego areale o
69 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Per un efficace contrastoagli IEDs è, quindi, fonda-mentale concentrare l’at-tenzione e comprendere ilcontesto sociale nel qualeessi sono concepiti, co-struiti e utilizzati
“
”
Un robot impiegato per la bonifica di ordigni esplosivi.
puntiforme.Comunque sia, è anche fondamentale tentare
di «rompere» il legame esistente tra i ribelli e lapopolazione locale, impoverita da anni di guerra.Questo richiede un governo locale capace di ga-rantire sicurezza, sviluppo economico, sociale ebenessere rimuovendo le motivazioni che spin-gono ad appoggiare i ribelli: si deve supportareal massimo il Nation Building con attività e azio-ni volte a implementare la credibilità di tali go-verni (supporto e addestramento di forze di si-curezza, attività CIMIC, supporto sanitario e aiutialimentari). Ancora sono fondamentali: l’attivitàdi intelligence, le PSY OPS e le INFO OPS. Comeafferma il Generale Sir David Richards, Capo diStato Maggiore dell’Esercito britannico («RivistaMilitare n. 1/2010): «La battaglia per la conqui-sta delle menti delle persone sarà, come sempre,centrale, sebbene la rivoluzione nelle comunica-zioni trasformerà la maniera di combatterla ... ècruciale per noi capire e sfruttare appieno glistrumenti della superiorità nell’informazione».
Le cellule eversive e insorgenti presenti in tea-tro, nonostante non abbiano tutte la medesimastruttura, tendono a seguire similari modalità
operative. Solitamente sono indipendenti le unedalle altre e prive di una guida centrale, il che lerende ancora più insidiose, ma potrebbero an-che avere strutture piramidali. In esse si anno-verano distinti ruoli, fra i più importanti: piani-ficatori, reclutatori, addestratori, finanziatori,assemblatori dei manufatti esplosivi, posiziona-tori degli stessi, attivatori e incaricati delle ri-prese a uso mediatico-propagandistico.
I PILASTRI DELLA NATO NELLA LOTTA CONTROGLI IEDs
La NATO per combattere la minaccia asimme-trica prodotta dalla proliferazione degli IEDs haelaborato una strategia articolata su tre pilastri:• sconfiggere il Sistema (Defeat the IED System)
nel quale la C-IED è intrapresa attraverso lefunzioni di «predizione» e «prevenzione»;
• sconfiggere l’Ordigno Esplosivo (Defeat theIED) attraverso le funzioni di «Individuazione»,«Protezione», «Neutralizzazione/Distruzione»;
• valorizzare l’addestramento e l’istruzione (Trai-
ning and Education) anche mediante Pubblica-zioni, STANAGs, lezioni apprese.L’obiettivo della «predizione» consiste nel-
l’identificare gli elementi critici del sistema dicostruzione degli IEDs, in particolare quale tipodi dispositivo potrebbe essere impiegato, dovee quando. Essa è strettamente connessa alle ca-pacità di intelligence delle forze in campo e in-clude tutte le attività, tecnologie ed equipaggia-menti impiegati per identificare e comprenderele Tattiche, Tecniche e Procedure (TTPs) dell’av-versario, nonché il suo equipaggiamento, le in-frastrutture utilizzate e i meccanismi di suppor-to di cui dispone.
La «prevenzione» è costituita da quelle attivitàoffensive per loro natura, condotte con l’obiettivodi evitare la costruzione e la collocazione degli
TECHNE - 70
Sopra.Un artificiere si addestra alla rimozione di un VBIED.
A destra.Una colonna italiana in Afghanistan. Spesso gli IEDsvengono collocati in aree extraurbane, ai margini dellevie di comunicazione (road side IEDs).
IEDs. Essa include la raccolta di informazioni (os-servazione dei potenziali obiettivi) ed è stretta-mente connessa alle capacità d’intelligence.
Le Nazioni e la NATO necessitano di combinare leproprie attività di intelligence, le tecnologie e leprocedure al fine di identificare e conoscere il ne-mico, il suo equipaggiamento, le infrastrutture, e lesue TTPs. Ciò è fondamentale se si vuole prevedereun potenziale attacco condotto con IEDs.
Un’efficace prevenzione è volta a localizzare edeliminare le infrastrutture e le pedine incaricate diassemblare gli IEDs nonchè i depositi di materialeesplosivo, distruggerli e negarne l’accesso. Inol-tre, risulta necessaria la sorveglianza aerea con-dotta con aeromobili telecomandati e l’utilizzo disistemi di video sorveglianza.
Per «individuazione» si intende la scoperta e lalocalizzazione degli ordigni esplosivi e delle lorocomponenti. A tale scopo è in corso lo sviluppo disistemi portatili in grado di individuare i compo-nenti critici quali cariche esplosive (sniffer), mec-canismi di attivazione e amplificatori radio. Letecnologie utilizzate sono:• sistemi bio-molecolari, spettroscopia all’infra-
rosso, o ricorso ai cani per rilevare la presenzadi esplosivi;
• sistemi radar in grado di analizzare il sottosuolo;• dispositivi capaci di individuare i sistemi di atti-
vazione elettronici e all’infrarosso;• sistemi di «screening» fissi e portatili.
Il livello di «protezione» delle forze può essereinnalzato con una tecnologia più sofisticata perautomezzi e personale, una maggiore protezionedelle infrastrutture e un migliore sistema di pre-avviso (early warning).
Nella fattispecie: veicoli protetti progettati persopportare esplosioni e ingrado di ridirezionare l’ondad’urto e ridurre gli effetti delleschegge, indumenti protettiviin grado di incrementare lasopravvivenza individuale, au-mento della Force Protectionper le istallazioni mediante la-vori di rinforzo sul campo ediffusione di informazioni eallarmi.
Il requisito della «neutralizza-zione» e «distruzione» si ottieneponendo in essere tutte quelle misure finalizzate aevitare l’attivazione di IEDs già posizionati in pros-simità degli obiettivi o attraverso la forzata attiva-zione degli IEDs, inclusi eventuali ordigni ad essicollegati. Anche se varie tecnologie già esistono inquesto settore, tuttavia si rende necessario ridurre ilpiù possibile il contatto diretto con tali ordigni. Par-ticolare importanza rivestono le seguenti attività:• prevenzione della detonazione;
• pre-detonazione (attraverso emissione di ondeelettromagnetiche);
• rimozione e distruzione della carica esplosiva;• distruzione del circuito elettronico mediante
l’utilizzo di particolari impulsi elettromagnetici;• ricerca e distruzione degli IEDs con l’utilizzo di
dispositivi meccanici (robots).Particolare attenzione è stata posta dalla NATO
allo specifico settore «dell’addestramento e istru-zione» mediante seminari di formazione svoltipresso l’Allied Joint Force Command di Brunssum(Olanda) e presso la Scuola NATO di Oberammer-
gau (Germania), strutturati,condotti e concepiti in funzionedel livello di Comando e tenen-do conto delle lezioni apprese.
Altri elementi giocano unruolo importante nella lottacontro la minaccia IEDs, quali leinterazioni politico-militari e ilruolo svolto dalla cooperazionecivile-militare.
Per interazione politico-mili-tare si intende la chiara cono-scenza dell’obiettivo finale che
si vuole perseguire attraverso attività diplomati-che, sociali, religiose ed economiche che devonoarmonizzarsi con l’esecuzione delle attività mili-tari ai vari livelli di Comando.
La cooperazione civile-militare ha assunto unruolo sempre più determinante andando a inci-dere direttamente sullo sviluppo sociale ed eco-nomico dei Paesi in cui opera. Potendo rappre-sentare un ulteriore facile bersaglio per i terro-
71 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
...è fondamentale tentaredi «rompere» i l legameesistente tra i ribelli e lapopolazione locale, impo-verita da anni di guerra...sono fondamentali...l’atti-vità di intelligence, le PSYOPS e le INFO OPS
“
”
Un veicolo MRAP («Cougar») danneggiato.
risti e le varie fazioni in lotta, si rende necessa-rio armonizzare metodi e procedure prettamen-te militari con quelli utilizzati dalle organizza-zioni governative e non governative che opera-no nel settore della ricostruzione.
LE COMPONENTI IMPIEGATE NELLA LOTTA CON-TRO GLI IEDs
La lotta contro la minaccia posta in essere dagliIEDs si effettua ricorrendo indistintamente allecomponenti terrestre, marittima e aerea. Quellaterrestre, per la sua collocazione fisica, è quellache si fa carico del maggiore onere; tuttavia, èfondamentale l’integrazione, l’interoperabilità e laflessibilità delle altre.
La componente terrestre, ol-tre a possedere un adeguato li-vello di prontezza, dovrà pre-vedere truppe specificamentededicate a tale attività apparte-nenti al ruolo combattimento,supporto al combattimento esupporto logistico. Il loro inter-vento sarà focalizzato sui prin-cipali obiettivi dei ribelli, rap-presentati dalle linee di comu-nicazione. Dovranno essere in grado di individua-re gli elementi critici dell’organizzazione e del-l’ordigno ed eliminare la connessione esistentetra i vari elementi che compongono le cellule ter-roristiche. Per un’efficace lotta risulta necessariopredisporre anche un supporto di Comando e
Controllo dedicato, con forze all’uopo equipag-giate e appositamente addestrate, impiegate conil concorso di elementi delle forze speciali unita-mente a un adeguato supporto logistico.
Nell’ambito di tale componente terrestre unruolo particolare viene svolto dal genio, che incooperazione con le altre Armi e le varie ForzeArmate, assolve il suo compito con moltepliciattività quali:• la costituzione, il mantenimento e la condivisio-
ne delle informazioni sullo status degli esplosividi una determinata area;
• l’assistenza nella condotta di indagini in caso diincidenti provocati da IEDs;
• l’assistenza nella bonifica delle vie di comunica-
zione nonché nell’accantonamento e nella distru-zione del materiale esplosivo rinvenuto;
• la costituzione, il mantenimento e l’aggiorna-mento del database sugli incidenti verificatisi;
• fornire Comando e Controllo ai team specializ-zati nella bonifica;
• l’addestramento del personale sulla bonificadelle vie di comunicazione, sull’impiego degliequipaggiamenti e sugli esplosivi.
Nell’ambiente marittimo costi-tuiscono sicuramente un bersa-glio remunerativo i vascelli, iporti e le linee di comunicazionemarittima. La lotta contro gliIEDs della componente maritti-ma si concretizza nel localizza-re, classificare e controllare larotta di piccole unità che po-trebbero essere utilizzate comeVBIEDs, come pure nel verificarela presenza di elementi ostili
sotto la superficie dell’acqua. Fondamentale puòessere l’apporto nel campo dell’intelligence, dellasorveglianza, dell’acquisizione di obiettivi e delsupporto di fuoco alle operazioni sulla terraferma.
Relativamente alla lotta contro gli IEDs, losforzo principale compiuto dalla componente
TECHNE - 72
Attualmente in Afghani-stan l’utilizzo di IEDs daparte degli insorgenti co-stituisce la principale mi-naccia per le forze appar-tenenti alla NATO e allacoalizione
“
”
Sopra.Un VM-90 P con sistema Anti Radio Controlled Impro-vised Explosive Device.
A destra.Un ordigno esplosivo improvvisato a pressione, di rudi-mentale fattura.
aerea risiede, invece, nel supporto alle opera-zioni con: ricognizione e sorveglianza aerea,Comando e Controllo delle operazioni di avio-lancio, trasporto aereo tattico e strategico.Tutto ciò con assetti aerei necessariamentecommisurati alla situazione e alla missione as-segnata.
CONCLUSIONI
Attualmente in Afghanistan l’utilizzo di IEDsda parte degli insorgenti costituisce la principa-le minaccia per le forze appartenenti alla NATOe alla coalizione. Le perdite, in termini di viteumane e materiali, hanno imposto alle autoritàpolitiche internazionali di esercitare uno sforzocongiunto nella lotta contro l’utilizzo di tali di-spositivi.
La NATO, facendo proprie le istanze dei Paesi
membri, oltre a riempire il vuoto dottrinale me-diante la stesura di una nuova pubblicazionequale l’«AJP-3.15», sta investendo risorse umaneed economiche anche nel settore della ricerca edella sperimentazione al fine di rendere disponi-bili equipaggiamenti e attrezzature sempre piùefficaci.
A ciò occorre aggiungere programmi addestra-tivi interforze e internazionali svolti a livello siaindividuale sia collettivo presso vari istituti NA-TO. Tale addestramento consentirà di disporre dipersonale qualificato a cui si aggiungerannoesperti nel campo forense, nella sorveglianza,nell’intelligence, nell’attività investigativa, nellaguerra elettronica e nel management dello spet-tro elettromagnetico e nell’evacuazione dellepossibili vittime.
La lotta è, quindi, solo all’inizio e si presentanon priva di incognite per le varie Nazioni.
È pertanto necessario continuare a lavorareper realizzare una comune linea politica deiPaesi membri della NATO in questa specificamateria.
Giuseppe Fernando MusilloTenente Colonnello,
Redattore Capodi «Rivista Militare»
Domenico SpolitiMaggiore,Redattore
di «Rivista Militare»
73 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Sopra.I nuclei cinofili sono molto utili nella ricerca di IEDs.
A sinistra, in basso.Il timer di un IED.
TECHNE - 74
LA MINACCIA ASIMMETRICA
L’utilizzo di tecniche di lotta asimmetrica è unadelle caratteristiche principali degli attuali scenarioperativi e verosimilmente continuerà a esserlo inquelli futuri. Queste tecniche possono avere mo-dalità operative estremamente diversificate, manormalmente sono basate surapidità d’azione e caratteriz-zate dall’impiego degli «Impro-vised Explosive Devices» (IEDs)che, molto spesso, colpisconoindiscriminatamente bersaglisia civili che militari. Le recentioperazioni condotte in teatroiracheno e afghano evidenzianola dimensione della minacciacostituita dagli IEDs. Questa ti-pologia di ordigni ha provocatola maggior parte delle vittime tra le forze dei con-tingenti. La figura 1 (fonte: http://www.power -point-search-engine.com/taliban-and-state-ppt.html, briefing del Major General Flynn, docu-mento «isaf-state-of-the-insurgency-231000-dec.ppt») analizza, nel teatro afghano, il numerodegli attacchi condotti e le vittime causate.
In effetti, gli IEDs sono divenuti il cosiddetto«weapon of choice» degli oppositori: nonostantel’utilizzo sia al livello tattico, il loro impiego siste-matico sta provocando enormi ripercussioni edeffetti a livello strategico.
La figura 2 (fonte: medesima della figura 1),rappresenta graficamente l’evoluzione del livel-
lo di minaccia nel teatro af-ghano analizzato attraverso iltempo, dall’inizio del 2005alla conclusione del 2009.L’andamento degli attacchidimostra come ci sia stato unaumento costante delle capa-cità degli «insurgents» a con-durre azioni e come determi-nati eventi, quali i periodi delRamadan (le date sono indi-cate nei riquadri) o le elezio-
ni, sia presidenziali che provinciali, abbianoscandito in modo peculiare l’intensità degli av-venimenti. La legenda riporta, per categorie,tutte le tipologie di incidenti accaduti e le rela-tive colorazioni.
Di specifico interesse, in particolare per la trat-tazione del presente articolo, gli attacchi subìtitramite impiego di IEDs (e/o mine) e i ritrovamenti(«finds») di tali ordigni. In generale, questa lottaasimmetrica è - e deve essere - contrastata dallacomponente operativa pena la perdita del mante-nimento dell’iniziativa durante la condotta delleOperazioni. Ciò richiede l’adozione di misure chesi traducano in determinate capacità operativefunzionali a rispondere in modo adeguato allaminaccia. Queste capacità, nella maggior parte deicasi, sono di tipo difensivo e si concretizzano conl’opportuna formazione e addestramento delleforze amiche, ossia con l’applicazione di specifi-che TTPs (Tecniche, Tattiche e Procedure) e conl’impiego di mezzi, equipaggiamenti e dotazioniidonei a prevenire, ridurre, mitigare e/o neutra-lizzare la minaccia.
LE «MILITARY SEARCH»Le recenti operazioni condotte in teatro iracheno e afghano hanno messo in luce la grande minaccia co-stituita dagli «Improvised Explosive Devices» e la necessità di adottare appropriate misure operative at-te a fronteggiarla. In questo scenario assumono un ruolo determinante le Military Search che, supporta-te da un’adeguata Intelligence, costituiscono la maggiore attività volta al contrasto e alla neutralizza-zione del sistema IED.
L’utilizzo di tecniche dilotta asimmetrica è unadelle caratteristiche princi-pali degli attuali scenarioperativi e verosimilmentecontinuerà a esser lo inquelli futuri
“
”
S P E C I A L E
Fig. 1
Risulta significativo osservare come l’applica-zione di queste tecniche e l’accrescimento dellaformazione di base abbiano prodotto la capacitàdi individuazione di un numero sempre maggioredi ordigni. La figura 3 (fonte: medesima delle pre-cedenti) indica, nell’anno 2009, le tipologie di at-tacchi cui le forze della coalizione sono state sot-toposte e i ritrovamenti. Un dato evidente balzaall’attenzione: la maggior parte degli attacchi edei «finds» sono classificati come sconosciuti
(«unknown»): tale indeterminazione non consentedi analizzare in modo esaustivo la minaccia népermette di adeguare tempestivamente le proprieTTPs in modo da ottenere la miglior efficacia nelcontrastare le tattiche dell’avversario. Ma non èsolo la lotta all’ordigno a essere meno incisiva:non potendo analizzare rapidamente le compo-nenti degli IEDs ritrovate, tutta l’attività di «ex-ploitation», in particolare quella del 2° e del 3° li-vello, risulta penalizzata. Il risultato complessivoè una limitata lotta al sistema IED e, conseguente-mente, la possibilità degli «insurgents» di conti-nuare a eseguire attacchi.
Sebbene possa essere semplicisticamente as-sunto che a un maggior numero di ordigni posaticorrisponda statisticamente un maggior numerodi ritrovamenti, è necessario considerare che esi-ste una costante evoluzione di adattamento delletecniche dell’avversario per vanificare le contro-misure adottate dalle Forze della Coalizione, siain termini di TTPs che di materiali e mezzi. Pertali ragioni, al fine di poter rispondere in modoadeguato all’evoluzione della minaccia, diventafondamentale applicare una sempre maggiore si-nergia tra proprie procedure operative, utilizzo diapparati tecnologici e assetti specialistici, tempe-
75 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Fig. 2
Fig. 3
stivo scambio di dati informativi e analisi dellaminaccia. Dalla lettura dei dati della figura 3, ri-sulta significativo che a partire dal secondo se-mestre del 2007, il numero di ritrovamenti haeguagliato e spesso superato il numero degli at-tacchi condotti con successo da parte degli «in-surgents». Come dato ancora più significativo,merita osservare come dal-l’estate del 2008 i «finds» sia-no mediamente stati tra il 20%e il 30% superiori agli attacchisubìti con IEDs. Dall’estate del2009 va purtroppo registratoun peggioramento di questepercentuali, sebbene i ritrova-menti siano ancora superioriagli attacchi subìti. È il segnaleche imperativamente ci esortaa rispondere all’accresciutaabilità degli «insurgents»: lasoluzione principale consistenell’adeguamento delle nostre capacità operative.È doveroso puntualizzare che la percentuale diritrovamenti varia considerevolmente da RegionalCommand (RC) a RC. In effetti, la minaccia si ma-nifesta con diverse tipologie di IEDs e tecniche diconduzione di attacchi nei vari RCs.
Nonostante tutte le unità in teatro ricevano unaformazione di base standardizzata alla specifica
minaccia e apprendano le relative TTPs di risposta- (riferimento allo STANAG 2294 CIED, CounteringImprovised Explosive Device Training Standards) -le modalità con cui le operazioni sono condottepossono essere significativamente diverse tra iRCs, in relazione alle Nazioni che operano nellediverse aree. Ciò è soprattutto dovuto alla dispo-
nibilità o meno di determinatiequipaggiamenti tecnologicie/o materiali, ovvero di assettispecifici, e questa realtà condi-ziona i risultati o successi con-seguiti sia nella lotta al sistemaIED che nella lotta all’ordigno:• presso il RC East (Nazioneleader USA) si fa largo impie-go di sistemi meccanici fina-lizzati per la Route Clearance,modulati su appositi «pac-chetti»;• presso il RC South (Nazione
leader a rotazione), si fa ampio utilizzo della ca-pacità search e si impiegano teams IEDD, WIT e,spesso, search teams all’interno delle unitàoperative;
• presso i RC North (Nazione leader DEU), RC West(Nazione leader ITA) e RC Capital (alternanza diNazione leader), ci si basa essenzialmente sullaricerca di base, ossia sull’applicazione delle TTPsper contrastare la minaccia IEDs.Appare evidente che le modalità procedurali
eseguite nei vari RCs siano principalmente di tipodifensivo, mirate soprattutto alla cosiddetta lottaall’ordigno (Defeat the Ordnance), uno dei tre pi-lastri della strategia C-IED. Nel RC South, tramitel’utilizzo delle «Military Search» in supporto alle
TECHNE - 76
Appare evidente che lemodalità procedurali ese-guite nei vari RCs sianoprincipalmente di tipo di-fensivo, mirate soprattuttoalla cosiddetta lotta all’or-digno (Defeat the Ordnan-ce), uno dei tre pi lastridella strategia C-IED
“
”
A sinistra.Piatto di pressione artigianale VOIED (Victim Operated IED).
Sotto da sinistra.Veicolo HUMVEE, RC(E) in seguito ad attacco con VOIED.Scena dell’attacco a pattuglia di VTLM a Kabul, RC (C).
operazioni, l’atteggiamento è più marcatamenteoffensivo, e oltre alla lotta all’ordigno si attua conmaggior intensità la lotta al sistema IED (Defeatthe Network, ora Attack the Network), pilastroprincipale della strategia C-IED. La figura 4 indicala possibile composizione di una cellula IED e icollegamenti tra i vari membri.
In effetti, presso il RC(S) si registra il maggiornumero di ritrovamenti di IEDs e/o loro compo-nentistica, di siti di stoccaggio (cache) di armi,munizionamento o esplosivi; di documentazionedi qualsiasi tipo finalizzata alla raccolta e sfrutta-mento delle prove (DOCEX - Document Exploita-tion); di materiale informatico con analoghi fini(MEDEX - Media Exploitation).
Pertanto, nello specifico settore del C-IED, unadelle capacità operative necessarie risponde aicriteri fondamentali propri delle «Military Search».Le «Military Search» sono definite dall’ATP 73 (Al-lied Tactical Publication - STANAG 2283) come «lagestione e l’applicazione di procedure sistemati-che che, associate ad appropriati equipaggiamen-ti, consentono l’individuazione di specifici obietti-vi (considerati in termini di persone, informazionie risorse utilizzate da un avversario) in supportoalle Operazioni Militari».
Esse consistono praticamente in operazioni pia-nificate dagli organi di Staff, adeguatamente assi-stiti da esperti qualificati in «Military Search» esvolte da «search teams» che supportano le unitàdi manovra nello svolgimento di particolari opera-zioni sia in ambienti urbani che in zone rurali.
SCOPO E APPLICAZIONE DELLE MILITARY SEARCH
Nella considerazione dell’attuale specifica mi-naccia in teatro operativo, possiamo semplicisti-camente determinare lo scopo delle «Military Se-arch» come la riduzione dell’esposizione delleForze amiche e della popolazione alle minacceinerenti gli IEDs. Praticamente, soprattutto dove leoperazioni di «Military Search» sono supportateda adeguata intelligence, possiamo intendere le«Military Search» come l’attività finalizzata al piùampio contrasto e neutralizzazione del sistemaIED (ossia Defeat the Network/Attack the Net-work).
Le «Military Search» rappresentano uno stru-mento efficace a disposizione del Comandanteper potenziare le capacità degli assetti disponibiliper la condotta di Operazioni sia di natura offen-siva che difensiva: le prime tendono a minare lefondamenta sulle quali poggiano le attività degliavversari; le seconde servono a incrementare ilproprio livello di Force Protection.
In funzione della natura delle operazioni dacondurre (offensive o difensive), gli obiettivi chia-ve delle «Military Search» per le operazioni offen-sive, che si svolgono in un contesto in cui divienefondamentale il mantenimento dell’iniziativa no-nostante le possibili limitazioni per ridurre l’im-patto sulle normali condizioni di vita della popo-lazione locale, possono essere rispettivamenteriassunti in:• raccogliere dati e informazioni per produrre in-
telligence, vitale per la definizione di ulteriorioperazioni search;
• negare e privare l’avversario di risorse fonda-
77 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Dall’alto.Veicolo Husky, tra i mezzi del Pacchetto Route Clearan-ce statunitense.
Veicolo Buffalo, tra i veicoli del Pacchetto Route Clea-rance statunitense. Mezzo in dotazione anche al Con-tingente italiano.
Fig. 4
mentali in termini di materiali, strutture e op-portunità: ciò consente il mantenimento dell’ini-ziativa e il controllo dell’area d’operazioni;
• contrastare la sua «libertà di manovra»;• raccogliere prove a carico di individui a premes-
sa di successive azioni giudiziarie.Per quanto attiene alle operazioni difensive, gli
obiettivi chiave sono:• incrementare il livello di protezione delle Forze
amiche;• aumentare o ripristinare la propria «libertà di
manovra» lungo determinati itinerari ovvero inspecifiche aree;
• permettere l’utilizzo di fabbricati;• verificare l’assenza di ordigni come misura pre-
ventiva in caso di eventi pianificati con partecipa-zione di VIPs.Per il conseguimento del successo durante
un’operazione di «Military Search» è necessario il
coinvolgimento di tutte le pedine fondamentalidello Staff di un Comando, dal J1/G1 al J5/G5: lapianificazione, il coordinamento e la gestione delleattività deve essere efficace. In particolare, le ope-razioni devono essere pianificate in funzione del:• grado della minaccia (cosiddetto «Risk Asses-
sment») che si esprime normalmente tramite unvalore numerico che deriva dalla somma di para-metri con valori prestabiliti. In funzione di que-sto valore, si determina il tipo di risposta daeseguire, ossia quale tipologia di assetto (se a li-vello di ricerca basico, intermedio o avanzato) èidoneo/sufficiente - nel determinato contesto -a espletare con successo la missione. I parametriche vengono valutati sono, appunto, la minaccia- suddivisa tra possibili intenzioni dell’avversarioe sue reali capacità nell’attuarle - e le vulnerabi-lità proprie, intese come prevedibilità comporta-mentali e come sicurezza presente nel senso piùampio dell’accezione;
• rischio ambientale, ossia della presenza o possi-bilità di incontrare aree minate, zone con trappo-le o contaminate; presenza di animali pericolosi;spazi ristretti o chiusi in prossimità dell’obiettivo;
TECHNE - 78
Risorse degli «insurgents»: le Military Search sono orien-tate al loro ritrovamento a fini di intelligence, di sfrutta-mento delle prove (exploitation) e azioni giudiziare.
• grado di assicurazione (o certezza) richiestodal Comandante: esso è in funzione della cer-tezza di assenza di ordigni/materiali/personeche il Comandante intende conseguire, nel-l’ottica della valutazione di tutte le ripercus-sioni, potenziali o certe, che un eventuale«fallimento» nella ricerca possa provocare siasugli esiti dell’operazione militare nel suocomplesso, sia e soprattutto nell’influenzarel’opinione pubblica.La risultante dell’analisi permette di stabilire il
livello di operazione di search e conseguentemen-te le necessità in termini di risorse di personale,materiali ed equipaggiamenti. Tale analisi tende aevitare l’improprio impiego di teams altamentespecializzati (Advanced Search Teams) per compitiche potrebbero essere eseguiti da altri teams conspecializzazione inferiore (Intermediate o Basic).Come ricordato nella definizione di «Military Se-arch», gli obiettivi della ricerca militare riguardanospecificatamente materiali, persone e informazio-ni. Nel dettaglio:• materiali: includono IED veri e propri e loro
componenti; esplosivi, UXOs, armi e munizioni;luoghi fabbricazione ordigni, infrastrutture,equipaggiamenti e mezzi dell’avversario;
• persone: ci si riferisce principalmente alla com-ponente umana del sistema IED (vedasi succes-sivo paragrafo «La lotta al sistema IED»);
• informazioni: documenti, nomi, località, possi-bili obiettivi, livello di conoscenza nemico delleprocedure delle forze amiche.Sulla base dell’intelligence e la valutazione del
rischio, si impiegano quegli assetti specialisticidella ricerca tali da garantire l’individuazione dellerisorse presunte, la loro sottrazione all’avversarioovvero la loro neutralizzazione. Con l’aumento dellivello di rischio e del livello di assicurazione che sivuole raggiungere è necessario ricorrere a un li-vello di ricerca militare sempre più specialistico edelevato. Per contro, anche i tempi operativi si al-lungano, spesso in maniera considerevole.
LIVELLI DELLE «MILITARY SEARCH»
La ricerca militare si classifica su tre livelli, ossiaricerca di livello Base, Intermedio e Avanzato, conle seguenti caratteristiche:• livello Base («Basic Military Search»). Tutti i mili-
tari immessi in teatro devono possedere le co-noscenze e l’addestramento per effettuare Mili-tary Search di base, ossia devono possedere laconsapevolezza del rischio per presenza di IEDse abilità nell’applicare le TTPs amiche. I corsi C-IED pre-deployment, alcuni svolti presso laSCUG, attuale CeAC, ovvero presso i reparti du-rante la fase di amalgama, sono organizzati per
orientare e consentire al personale di raggiun-gere le specifiche capacità operative proprie diquesto livello;
• livello Intermedio («Intermediate Military Se-arch»). È la capacità di condurre Operazioni diMilitary Search da parte di unità specificatamen-te addestrate negli ambienti operativi ove sussi-stano le seguenti condizioni: minimo grado diminaccia per presenza di IEDs; discreto grado diassicurazione (o discreta certezza di assenza diordigni) voluto dal Comandante; rischi ambien-tali di medio livello;
• livello Avanzato («Advanced Military Search»). Èla capacità di condurre Operazioni Military Se-arch da parte di unità specializzate e appropria-tamente addestrate negli ambienti operativi oveesistano queste condizioni: elevato grado di mi-naccia derivante dalla presenza di IEDs ovverocertezza della loro presenza; alto grado di assi-curazione richiesto dal Comandante; alti rischiconnessi all’ambiente in cui si opera.
La relazione tra la disponibilità degli assetti im-piegabili per la condotta di ciascun livello di «Mi-litary Search», il livello di rischio e quello di assi-curazione (o certezza o affidabilità) che si vuoleottenere viene comunemente rappresentato dauna piramide (figura 5). Al crescere del livello dirischio si riduce il numero degli assetti speciali-stici che hanno le capacità (conoscenza, forma-zione, equipaggiamento) per l’esecuzione di taletipologia di ricerca militare. Pertanto il verticedella piramide rappresenta l’eccellenza della ca-pacità, riservata a pochi assetti: conseguente-mente esso indica che a maggiori capacità espri-mibili, maggiori sono i tempi richiesti per la loroesecuzione, maggiore è il quantitativo di equi-paggiamenti e il livello tecnologico richiesto, si-
79 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Piramide delle «Military Search»Fig. 5
gnificativamente maggiore sarà l’assicurazione ocertezza del controllo eseguito (se c’è qualcosa,esso sarà individuato).
La base della piramide (livello Base) è competen-za di tutte le unità delle Forze Armate. Il livellocentrale (livello Intermedio) diventa specifica attri-buzione di search teams del genio (reggimenti Ge-nio) e di alcuni assetti specificatamente formati edequipaggiati delle varie Armi (All Arms Intermedia-te Search Teams). Il livello apicale (livello Avanzato)è di pertinenza di search teams del genio.
LA LOTTA AL SISTEMA IED
Il Sistema IED viene definito dalla AJP 3.15 (Al-lied Joint Publication) come una «Combinazioned’individui, equipaggiamenti,procedimenti d’impiego, tecno-logie, capacità e conoscenzeche permettono la preparazio-ne dell’ordigno e successiva-mente l’attacco IED».
Il Sistema IED opera all’inter-no di un contesto socio-cultu-rale specifico: esso trova sup-porto in questo contesto e cer-ca di mantenere e accrescere ilconsenso della popolazione. Ineffetti, la chiave consiste proprio nel sostegno chegli abitanti del luogo garantiscono ai membri delSistema: la popolazione locale fornisce supportodi tipo attivo o passivo. Il supporto attivo siestrinseca tramite diverse attività, anche parteci-pando al ciclo dell’attacco IED. Questo coinvolgi-mento può essere su base volontaria, per com-
penso o per coercizione. Il supporto passivo per-mette l’impunità ai membri del Sistema IED inquanto gli «insurgents» non solo evitano di esseredenunciati ma la popolazione rifiuta di fornire in-formazioni sulle loro attività favorendone l’occul-tamento e, spesso, la fuga.
Il successo della lotta al Sistema IED passa pro-prio attraverso la riduzione del supporto della po-polazione ai membri delle cellule eversive. Il so-stegno ricevuto da queste cellule è variabile ed èin funzione del grado di consenso che l’organiz-zazione del Sistema IED riscuote in quello specifi-co contesto socio-culturale, dall’accettazione del-la motivazione ideologica, dalla fiducia della po-polazione verso le autorità locali - sia di poliziache di Governo - dalla stabilità dell’area e dallanecessità di sopravvivenza della popolazionestessa.
Il Sistema IED può essere considerato come uninsieme complesso di tre componenti: gli indivi-dui e le cellule (ossia la componente umana, gli«insurgents»), i mezzi e i materiali (ossia la com-ponente risorse) e le procedure consolidate percondurre la lotta asimmetrica (ovvero il ciclo del-l’attacco IED).
La componente umana ha varie connessioninel tessuto sociale locale, tribale e criminale, edè organizzata in una struttura non gerarchica,ma strettamente interconnessa tramite una retedi comunicazione che garantisce il rapido scam-bio di informazioni e l’adattamento delle tecni-che di attacco. Sono proprio queste peculiarità,il dinamismo e la capacità evolutiva, a contrad-distinguere il sistema e a rendere la lotta asim-metrica così vantaggiosa per gli «insurgents».Attraverso il sistema (network) stesso, le tatti-che, tecniche e procedure di lotta che hannoprodotto successi contro le forze della coalizio-ne sono affinate, modificate e diffuse. Le cellule
IED operative agiscono nor-malmente in modo autonomoe hanno le capacità di procu-rarsi i componenti per assem-blare gli ordigni, dispongonodi un’organizzazione per iltrasporto e posizionamentodegli stessi, conducono lapianificazione dell’attacco ene sfruttano gli effetti a scopipropagandistici. Una cellula ècomposta da vari membri ,
ciascuno responsabile di compiti differenti ov-vero di eseguire più di un compito. La figura 4,rappresenta graficamente una possibile struttu-ra organizzativa di tali cellule e indica le figurefondamentali che formano la componente uma-na del sistema IED. Esse sono: il finanziatore(fornisce il necessario supporto finanziario per
TECHNE - 80
Il Sistema IED opera al-l’interno di un contesto so-cio-culturale specifico: essotrova supporto in questocontesto e cerca di mante-nere e accrescere il consen-so della popolazione
“
”
Aula del CeAC. Corso ISA SA (International IntermediateSearch Advisor).
l’acquisizione dei componenti, l’addestramentodel personale, il sostegno degli «insurgents» edei loro nuclei familiari), il leader o pianificatore(potrebbe anche svolgere il ruolo di reclutatoredegli altri membri ed è solitamente l’elementopiù motivato), uno o più fornitori (suppliers, chedispongono dei componenti necessari alla fab-bricazione dell’ordigno per condurre l’attacco),un addestratore (trainer, che addestra la cellulaa eseguire tecniche e procedure specifiche per ildeterminato attacco), un assemblatore (il «bombmaker» o «builder», cioè lo specialista in esplo-sivi che confeziona l’ordigno), un trasportatore(transporter, con compiti logistici), un posatore(emplacer, spesso reclutato nell’area in cui l’at-tacco verrà condotto), un attivatore (trigger-man, che potrebbe anche essere un elementoesterno alle cellule pre-costituite) e un camera-man/exploiter (filma l’attacco IED per scopi dipropaganda, studio e identificazione di LL/Lid(«lessons learned/lessons identified»).
Il ciclo dell’attacco IED, seconda componente delsistema IED, si sviluppa attraverso fasi distinte,che sono:• sperimentazione e sviluppo (sia di TTPs che di
tipologie di ordigni);• pianificazione delle fasi dell’attacco IED, tra cui
ricognizione del sito dell’attacco, sorveglianzadello stesso, identificazione di punti di riferi-mento e delle vie di fuga, analisi dell’obiettivo;
• prova dell’attacco;• condotta dell’attacco;• valutazione degli effetti conseguiti;• valutazione della missione nel suo complesso
per apportare eventuali correttivi per l’attaccosuccessivo.Infine, per condurre un attacco, il Sistema IED
deve poter far uso di materiali e strutture: traquesti si elencano i componenti dell’IED; gli stru-menti di comunicazione, solitamente reperibili dallibero commercio; i mezzi di trasporto di ognifattispecie; strutture di vario tipo necessarie alsupporto logistico, quali centri di addestramento,alloggiamento del personale delle cellule, luoghiper la fabbricazione e l’assemblaggio degli ordi-gni, situati sia all’interno che oltre i confini delPaese in cui opera il Sistema IED.
LE ATTUALI CAPACITÀ NAZIONALI
Ad oggi, solo pochi Paesi alleati, e precisa-mente la Gran Bretagna, l’Olanda e la Francia so-no in grado di esprimere la capacità di ricerca(«Military Search») mentre pochi altri, tra cuil’Italia, hanno iniziato lo sviluppo della stessa.Tuttavia, va puntualizzato che, mentre la GranBretagna vanta una quarantennale esperienza nel
settore, maturata principalmente in Irlanda delNord, l’Olanda ha acquisito, sfruttando la colla-borazione offerta dalla Gran Bretagna, tale capa-cità solo recentemente.
L’Italia ha offerto di ospitare il primo corso pilo-ta «International Intermediate Search Advisor &Team Trainer Course», organizzato dall’EuropeanDefence Agency (EDA) presso il costituendo Cen-tro di Eccellenza C-IED nazionale (CdE C-IED) avalenza interforze, l’attuale CeAC (Centro Adde-stramento Contro-ostacolo) di Forza Armata, si-tuato all’interno della Caserma Ettore Rosso, sededella Scuola del Genio in Roma.
Questo dimostra l’interesse nazionale verso losviluppo di tale capacità e l’assunzione della lea-dership italiana in ambito europeo per le «MilitarySearch». In figura 6, la locandina di promozionedel corso dell’EDA.
Lo sviluppo della capacità «Military Search» na-zionale si può attuare attraverso l’adeguamentodei compiti e della formazione delle Unità chegià dispongono degli elementi, delle conoscenze
e degli equipaggiamenti (sebbene questi ultimisiano ancora in via di acquisizione) per svolgeretali particolari attività, e tramite l’adattamentodelle strutture di Comando e Controllo (C2) giàpresenti nei Comandi dei teatri operativi. In ef-fetti, i reggimenti genio dispongono delle pecu-liarità necessarie per essere resi operativi a ese-guire le Military Search in tempi relativamenteceleri, considerando il lasso temporale necessa-rio alla formazione dei teams per livelli sequen-ziali di capacità search. Considerando che il li-vello Base dovrebbe oramai essere completa-mente acquisito da tutte le unità operative, o al-meno dalla maggior parte, data la rotazione del-le medesime nei vari teatri, si deve ora raggiun-gere la capacità intermedia (Intermediate Se-arch), per alcuni assetti, e poi quella avanzata(Advanced Search), per un numero ancora infe-riore di teams, ma altamente specializzati.
81 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Fig. 6
Presso il CeAC si svolgono corsi di:• formazione di base per unità guastatori (Corsi
Minex);• formazione specialistica nel settore della bonifi-
ca (Corsi EOD di 1° e di 2° livello, Corsi EOD BCper interventi su ordigni a caricamento Biologicoo Chimico);
• formazione propedeutica nel settore C-IED,quali i corsi informativi nella fase di pre-de-ployment per il personale degli organi centrali oaltri augmentees;
• formazione avanzata C-IED, tra cui i corsi IEDD(per personale della Forza Armata, della Poliziadi Stato e dei Carabinieri);
• altri corsi nel settore C-IED, quali l’EOD SO(Staff Officer), il WIT, il corso per tecnico elet-tronico e il modulo C-IED per ACRT (AdvancedCombat and Reconnaissance Team).A breve si aggiungerà a questi il primo corso
nazionale finalizzato alla ricerca di livello inter-medio (Intermediate Search).
LO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ «SEARCH» NA-ZIONALE
L’acquisizione della capacità nazionale nelsettore delle «Military Search» in supporto dellastrategia nazionale C-IED si otterrà principal-mente attraverso l’ottimizzazione degli assetti edelle capacità già esistenti nell’ambito dell’Armadel genio e nel settore del C-IED. Le linee disviluppo seguiranno una road map già definita eche include il raggiungimento di precisi stan-dards addestrativi da conseguire gradualmente,al pari dell’acquisizione dei necessari materiali
TECHNE - 82
Sopra.Corso ISA SA, Scuola del Genio, CeAC: Route Search, at-tività di «isolation».
Sotto a destra.Corso ISA SA, Scuola del Genio, CeAC: fase di ricercaall’interno del fabbricato (attività di Building Search).
ed equipaggiamenti, della definizione dellequalifiche del personale (singoli elementi, unità,personale di Staff), le validazioni dei singoli edei teams, le modalità per il controllo del man-tenimento delle capacità raggiunte, l’interope-rabilità con altri Paesi. In sintesi, l’acronimoDOTLMPI (Doctrine, Organization, Training, Lea-dership, Materials, Personnel, Infrastructure)riassume tutti gli elementi chiave del program-ma nazionale.
L’addestramento appare attualmente come lanecessità più impellente. Il corso pilota per Istrut-tori «Intermediate Military Search Advisor & Trainthe Trainer Course» (al quale hanno partecipato19 Ufficiali provenienti da Paesi dell’Unione Euro-pea oltre a 12 frequentatori e 6 osservatori italia-ni), oltre a formare i futuri istruttori nel campodelle Military Search, ha trattato tutti gli argo-menti che permettono di realizzare la policy e la
governance per la costituzione della capacità Mili-tary Search. Un ulteriore corso a guida EDA sisvolgerà entro l’estate 2010 presso il costituendoCentro di Eccellenza C-IED (CdE CIED) nazionalecon lo scopo di formare il personale già abilitatocome Intermediate Search Advisor nella ricerca ditipo Advanced, pur con alcune significative limita-zioni, quali la non abilità a operare in ambientiparticolari come all’interno di aeromobili, natanti,WICS (Working In Confined Spaces), HES (Hazar-dous Environment Search) e SES (Special Equip-ment Search).
Considerando le specifiche necessità di standar-dizzazione e interoperabilità in contesti operativimultinazionali, la dottrina osserverà i contenutidei documenti NATO e dell’Unione Europea. Fon-damentale risulterà la sperimentazione in teatrooperativo per poter definire proprie TTPs nellemore degli assetti ed equipaggiamenti effettiva-mente disponibili. All’enfasi su appropriate TTPs eprocedure di C2, deve esserci un riscontro sulledotazioni assegnate, dato che l’efficacia della ca-pacità «search» è connessa - oltre alla prepara-zione del personale - agli strumenti che si utiliz-
83 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Corso ISA SA, Scuola del Genio, CeAC: preparazioneper la fase di ingresso in fabbricato (attività di Buil-ding Search).
zano, alla loro precisione e affidabilità. I principalimateriali da utilizzare variano in funzione della ti-pologia di ricerca e del livello di assicurazione chedeve essere garantito. In mancanza di specificheesperienze, sarà inizialmente difficile indirizzarel’approvvigionamento di tali materiali se non ba-sandosi sulle strumentazioni già in uso presso al-tri eserciti.
Per quando attiene ai livelli di «Military Search»e alle tipologie di assetti da impiegare in ciascunlivello, le Unità del genio Combat Engineer (reggi-menti guastatori) avranno capacità di Advanced edi Intermediate Search, le unità delle varie Armi(All Arms Search) avranno una capacità search dilivello Intermedio mentre tutte le rimanenti forze
potranno operare al livello basico. La componenteComando e Controllo sarà adeguata per collocarenelle strutture di Staff dei Comandi delle unitàquelle figure (esperti in «Military Search») conspecifiche qualifiche e conoscenze necessarie acoordinare l’attività di ricerca in sinergia con as-setti EOD, IEDD, MDD/EDD, WIT, ACRT, Minex eforze di manovra.
Gli esperti (cosiddetti SME, Subject Matter Ex-perts) ai vari livelli ordinativi di Comando, prepo-sti a coadiuvare le operazioni e consigliare i Co-mandanti su come meglio impiegare gli assetti,sono i seguenti:• Formation Search Coordinator (FSC) nella branca
JENG/C-IED presso i Comandi Brigata/Divisione; • Search Coordinator (SC), presso la cellula S3
ENGR;• Search Advisor (SA), nell’ambito delle unità a li-
vello compagnia/plotone.Di norma, i search teams operano all’interno di
una cornice di sicurezza e sono solitamente assi-stiti da altri assetti specialistici, quali ad esempionuclei cinofili, teams EOD (Explosive OrdnanceDisposal), IEDD (Improvised Explosive Device Di-sposal), WIT (Weapons Intelligence Team) o di po-lizia militare.
Nell’ambito dei reggimenti genio o Task Force(TF) genio saranno costituiti Advanced Search Te-ams e Intermediate Search Teams per la condottadi operazioni in contesti ad alto rischio e dove, ri-spettivamente, sia molto probabile o certa la pre-senza di ordigni e di loro componenti, ovvero talepresenza sia considerata solo come possibile. Al-l’interno delle TF di manovra troveranno invececollocazione gli All Arms Search Teams (personaleinterforze) che opereranno in contesti abasso/medio rischio con assenza o poco probabi-le presenza di ordigni.
GLI ASPETTI LEGALI DELLE MILITARY SEARCH
La tipologia delle «Military Search» ingloba atti-vità di ricerca - in determinati casi il termine piùappropriato è «perquisizione» - su:• persone («Person Search»);• veicoli («Vehicle Search»);• abitazioni private e fabbricati (tra le tipologie di
«Offensive Building Search», «Defensive Buildingsearch» - «Venue Search», «Disruptive Buildingsearch»), nel senso più generale del termineadibiti agli usi più diversificati (per esempio unostadio, un grande albergo, deposito di stoccag-gio dei carburanti);
• ricerca lungo itinerari («Route Search»); • ricerca di aree o luoghi particolari («Area Se-
arch»);• ricerca in ambienti specifici, come velivoli aerei
(«Aircraft Search») e natanti («Vessel Search») ingenere.Le TTPs apprese sono esaustive e hanno lo sco-
po di permettere al personale di eseguire le «Mili-tary Search» in modo completo, sistematico, masoprattutto legale.
«Search», come definizione, è la perquisizionedi una persona, dei suoi beni e proprietà perso-nali - inclusi beni non direttamente accuditi dalproprietario, cassetti e armadi aperti o altro mo-bilio - e/o del suo veicolo. Lo scopo principale ditale ricerca è impedire a un individuo di traspor-tare beni non permessi o vietati, ovvero di entrareappiedato, con bagaglio o con un veicolo, in luo-
TECHNE - 84
Corso IEDD, Scuola del Genio, CeAC: un operatore ef-fettua un approccio manuale su un oggetto sospetto.
ghi controllati o dove sussistono particolari esi-genze di sicurezza.
In effetti, al termine di una ricerca (o perquisi-zione) militare, il personale che ha condotto l’atti-vità compila un’esauriente documentazione cheha valore legale e che può essere utilizzata comeprova durante un procedimento giudiziario.
Esistono quattro categorie di «Person Search»,ossia la ricerca generale in pubblico («Initial BodySearch»), la ricerca dettagliata al chiuso («DetailedBody Search»), la ricerca con rimozione di abiti inluogo di custodia («Strip search») e quella intima,a cura di un medico («Intimate Body Search»). Cisono dei limiti ben precisi per questa attività: la«search» deve essere eseguita da una personadello stesso sesso, solo le donne possono esegui-re la ricerca su minori di 14 anni, solo le primedue tipologie possono essere eseguite da perso-nale militare addetto alla sicurezza. Ogni ricer-ca/perquisizione deve essere puntualmente docu-mentata tramite la compilazione di una specificamodulistica.
Ci sono due livelli di ricerca di base su veicoli(«Vehicle search»): verifica iniziale («Initial check»)e ricerca sistematica («Primary Search»). Analoga-mente, la ricerca eseguita va supportata da ade-guata documentazione.
La ricerca di Aree («Area Search») è solitamentecategorizzata come un’operazione offensiva cheha lo scopo di individuare nascondigli («Hide» oanche «cache») impiegati dagli avversari. Questipossono essere di tre tipi, ciascuno con determi-nate caratteristiche: di tipo logistico («Long TermHide»), di supporto a un’operazione («transit si-te»), a breve termine («Short Term hide»), inestrema prossimità del luogo di impiego.
La ricerca in edifici («Defensive Building Search»o «Venue search») richiede una pianificazionemeticolosa, è solitamente complessa e necessitadi molte risorse: si impiega per avvenimenti parti-colari e dove la presenza di personalità impone lamassima sicurezza di assenza di ordigni.
La documentazione da compilare è parte inte-grante dell’operazione di «search». A secondadell’attività di ricerca eseguita, tre sono i rapportida redigere:• rapporto di pattuglia, il Patrol Search Record
(PSR), documento generico specificatamente im-piegato per veicoli, individui e fabbricati qualorasi esegua una ricerca/perquisizione non pianifi-cata, ma dettata dalla situazione contingente;
• rapporto di perquisizione di edifici, il Venue Se-arch record (VSR), documento redatto sempre incaso di «Defensive building search»;
• rapporto di perquisizione, il Search Report Mili-tary (SRM), compilato quando si eseguono ricer-che pianificate. È un documento generico ido-neo a registrare tutte le ricerche condotte lungo
itinerari, aree, aeromobili, imbarcazioni e navi diogni tipo, edifici e fabbricati («Offensive Buil-ding search» e «Disruptive Building search»). Ilrapporto è concepito per garantire la comple-tezza della ricerca, assicurare che le procedurelegali siano osservate, fornire dati per pianifica-re successive operazioni, impugnato come pro-va legale in procedimenti giudiziari.Questa documentazione si riferisce completa-
mente alle procedure e modelli impiegati dal-l’Esercito inglese, dove solitamente l’Ufficialequalificato SA (Search Advisor) ha l’autorità perordinare l’esecuzione di una missione search. Talirapporti hanno valenza legale, ma si basano sulleproblematiche connesse con le operazioni con-dotte in Irlanda del Nord. Le leggi nazionali varia-no tra Paese e Paese: ne consegue che è necessa-rio definire con certezza l’ambito legale e le even-tuali limitazioni imposte in caso di operazioni se-arch condotte da forze italiane, considerando:• leggi internazionali; • leggi nazionali;• leggi del Paese ospitante in cui si conducono le
85 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Corso ISA SA, Scuola del Genio, CeAC: ricerca sistemati-ca su veicoli. Ritrovamento di componenti elettronici.
operazioni (HN - Host Nation);• ROE (Rules of Engagement) nazionali e di teatro; • STANAG 2 283 - «Military search»;• SOP (Standing Operating Procedures) di teatro.
Ne consegue che il ruolo dei LEGAD (Legal Ad-visor) diventa altresì fondamentale per informareil Comandante di eventuali limitazioni nelle ope-razioni. I moduli prevedono parti dedicate perregistrare eventuali danni provocati durante lefasi della ricerca (pre-search damage check epost-search damage check), in quanto soggetti acompenso.
Per la componente operativa, invece, oltre al-l’osservazione puntigliosa delle procedure nellaricerca, diventa fondamentale poter disporre neiteams search di personale femminile qualificatoalle Military Search.
CONCLUSIONI
Per una Forza Armata, poter esprimere una ca-pacità «search» significa essere in grado di opera-re spesso in maniera attiva e preventiva in am-bienti caratterizzati dalla minaccia IED, al contra-rio di quelle Forze Armate che, non avendola, inlarga parte ne subiscono gli effetti. Fondamental-mente, le Military Search rappresentano per leforze militari una rilevante opportunità di mante-
nere l’iniziativa e di decidere come, quando e do-ve agire. Esse possono pertanto influenzare leoperazioni in maniera determinante creando ipresupposti per il rinvenimento delle risorse a di-sposizione delle forze opponenti prima che que-ste possano utilizzarle.
L’acquisizione della completa capacità di MilitarySearch è uno strumento fondamentale nella stra-tegia C-IED ma, a premessa della sua funzionalità,la Forza Armata necessita di tempestiva intelligen-ce, basata su rapida capacità di analisi e accessibi-le condivisione delle informazioni. La maggiorparte delle attività di «Military Search» per i livelliIntermedio (Combat Engineer Intermediate Search)e Avanzato (Combat Engineer Advanced Search) fi-nalizzate al C-IED, possono realizzarsi impiegandoassetti del genio destinati al «Combat support en-gineering» e supportati da nuclei IEDD, WIT, EDD,cinofili. Le qualifiche acquisite dal personale deireparti «genio guastatori» (MINEX, ACRT) e le ca-ratteristiche intrinseche proprie della specialità inargomento, permettono ai guastatori di operarecon maggior efficacia negli ambienti tipici in cui leoperazioni di Search sono solitamente condotte, inparticolare nella ricerca lungo itinerari e in prossi-mità o all’interno di opere infrastrutturali. Gli «AllArms Search Teams» saranno capaci di condurresistematicamente operazioni in ambienti a rischiomedio/basso.
I Comandanti ai vari livelli ordinativi devono es-sere coscienti delle potenzialità e caratteristichedegli assetti che avranno a disposizione per effet-tuare le Military Search, soprattutto per un impie-go mirato degli stessi. Vanno comunque definitichiaramente gli aspetti legali connessi con le ope-razioni di search e le regole di ingaggio: da ciò sipotrà effettivamente comprendere quali obiettiviperseguire e quale tipologia di operazioni con-durre in teatro.
Sebbene i search teams siano di supporto alleforze di manovra, queste devono però fornire
TECHNE - 86
GLOSSARIO
Sistema IED: combinazione d’individui, equipaggia-menti, procedimenti d’impiego, tecnologie, capacitàe conoscenze che permettono la preparazione del-l’ordigno e successivamente l’attacco IED.Counter-IED (C-IED): insieme delle attività tese aprevenire, ridurre o eliminare gli effetti di tutte le ti-pologie di IEDs utilizzate contro le forze amiche ed inon combattenti.Force protection (FP): l’insieme delle misure e deimezzi per ridurre al minimo la vulnerabilità del per-sonale, delle installazioni, dei mezzi e delle opera-zioni rispetto a qualsiasi minaccia e in ogni circo-stanza, al fine di preservare la libertà d’azione e l’ef-ficienza operativa delle forze.Search: perquisizione di una persona, dei suoi beni eproprietà personali - inclusi beni non direttamenteaccuditi dal proprietario, cassetti e armadi aperti oaltro mobilio - e/o del suo veicolo.Military Search: gestione e applicazione di procedu-re sistematiche che, associate ad appropriati equi-paggiamenti, consentono l’individuazione di specificiobiettivi (considerati in termini persone, informazionie di risorse utilizzate da un avversario) in supportoalle Operazioni Militari.
Ricerca lungo itinerari (Route Search).
quella cornice di sicurezza - sovente per tempipiuttosto lunghi - che permetta a chi fa ricerca ailivelli Intermedio e Avanzato di poter effettiva-mente operare. La scelta del tipo e del livello diricerca da attuare in un determinato contesto di-penderà dal livello della minaccia (rischio operati-vo), dall’ambiente e dal livello di assicurazioneche il Comandante vuole.
In generale, per una efficace lotta al sistemaIED, è necessario perseguire sinergia di intenti eamalgama tra i vari assetti - quali i teams ACRT, ipacchetti Route Clearance, i teams search, IEDD,WIT - impiegandoli per le loro capacità effettive eper i compiti previsti. Di pari passo con l’incre-mento della capacità e - conseguentemente - conun quantitativo superiore di reperti da analizzare,anche la capacità di sfruttamento delle prove le-gali raccolte («exploitation») dovrà essere oppor-tunamente ri-modulata a livello di teatro, in par-ticolare per quanto concerne il cosiddetto 2° livel-lo. Solo così, ossia con un significativo aumentodi disponibilità di dati biometrici e tecnici, fornitisia all’intelligence che alle cellule C-IED, si po-tranno ottenere dei risultati apprezzabili versol’efficace lotta al Sistema IED e, in generale, un li-vello superiore di Force Protection.
Renato ScudicioTenente Colonnello,
in servizio presso la Scuola del Genio, CeAC
RIFERIMENTI DOTTRINALI
BIBLIOGRAFIA NATONATO Draft Policy on «Military Engineering» (Report ofthe June 2005 Engineer Standardization DevelopmentPanel Meeting);Pub. AAP-6 «NATO Glossary of Terms and Definitions»;Pub. AJP-3.15 «Allied Doctrine for Joint C-IED Opera-tions»;Pub. ATP-73 «Military Search»;ATP-3.4.1.1 «Peace Support Operations, Techniquesand Procedures»;
BIBLIOGRAFIA NAZIONALEPub. SMD-G-024 «Glossario NATO dei termini e delledefinizioni», Ed. 2005;Pub. SMD-AJ-001 «Direttiva per l’addestramento inter-forze», Ed. 2004;Pub. «Joint Integrating Concept» 004 C-IED, Ed. 2007;Pub. «Pacchetti di Capacità - Componente genio_Pro-getto Esecutivo 2003-2004», edito dallo Stato Maggio-re dell’Esercito;Pub. n. 6739 «Obiettivi formativi, aggiornamento e valu-tazione operativa del personale EOD/IEDD», Ed. 2006,edita dall’Ispettorato per la Formazione e la Specializza-zione dell’Esercito - Polo del genio.
87 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
LISTA DEGLI ACRONIMI
ACRT Advanced Combat and ReconnaissanceTeam
AJP Allied Joint PublicationATP Allied Tactical PublicationB/Div Brigata/DivisioneC2 Comando e Controllo CeAC Centro Addestramento Contro-OstacoloCdE C-IED Centro di Eccellenza C-IED nazionaleCIED Countering Improvised Explosive DeviceDEU GermanyDOCEX Document ExploitationDOTLMPI Doctrine, Organization, Training,
Leadership, Materials, Personnel, Infrastructure
EDA European Defence Agency EDD Explosive Detection DogENGR EngineerEOD Explosive Ordnance DisposalEOD BC Explosive Ordnance Disposal Biological
ChemicalEOD SO Explosive Ordnance Disposal Staff OfficerFA Forza ArmataFSC Formation Search Coordinator HES Hazardous Environment SearchHN Host NationIED Improvised Explosive DevicesIEDD Improvised Explosive Devices DisposalISA SA International Intermediate Search AdvisorITA ItalyGBR Great BritainJENG/C-IED Joint Engineering/Countering Impro-
vised Explosive DeviceLEGAD Legal AdvisorLid Lessons IdentifiedLL Lessons Learned MEDEX Media ExploitationNATO North Atlantic Treaty OrganizationNLD NetherlandsMDD Mine Detection DogPSR Patrol Search Record RC Regional CommandRC (C) Regional Command CapitalRC (E) Regional Command EastRC (N) Regional Command NorthRC (S) Regional Command SouthRC (W) Regional Command WestROE Rules of EngagementSA Search AdvisorSC Search Coordinator SCUG Scuola del GenioSES Special Equipment SearchSME Subject Matter ExpertsSOP Standing Operating ProceduresSRM Search Report Military STANAG Standardization AgreementTF Task Force TTPs Tactics, Techniques & Procedures
(Tecniche, Tattiche e Procedure)USA United States of AmericaUXOs Unexploded OrdnanceVIPs Very Important PersonsVOIED Victim Operated IEDVSR Venue Search Record WICS Working In Confined SpacesWIT Weapons Intelligence Team
TECHNE - 88
L’imminente trasformazione del Centro Adde-stramento Contro Ostacolo in Centro di Eccellenzanazionale per il C-IED, è l’occasione per andareindietro con la memoria e riepilogare tutte le tra-sformazioni che, a vario titolo e per vari motivi,hanno coinvolto l’Arma del genio. Tale excursusha consentito di ripercorrere un lungo camminodalla fine del Secondo conflitto mondiale a oggi inmerito alle sfide che i genieri in generale, e i gua-statori in particolare, hanno dovuto affrontare inquesti ultimi 65 anni traendone la conclusione chei Teatri Operativi moderni sono caratterizzati co-munque dalla presenza di nemi-ci antichi: gli ordigni esplosivinascosti nel terreno come le mi-ne, ovvero quelli celati sotto lepiù diverse e mentite spoglie,come lo sono gli ordigni im-provvisati. I guastatori, ora co-me allora, sono chiamati a com-battere la loro principale batta-glia contro questi nemici tantopiù subdoli, quanto più raffina-te, e per certi versi efferate, so-no diventate le tecniche di rea-lizzazione e di occultamentodegli ordigni e quanto più questisono utilizzati come mezzo in-discriminato di terrore nei con-fronti di chi è chiamato a partecipare a operazionimultinazionali sempre improntate al recupero del-la pace e della stabilità delle popolazioni.
Non a caso, attualmente, i nostri guastatori inLibano affrontano il problema dell’apertura divarchi nei campi minati della linea provvisoria diconfine e bonificano intere aree infestate dalle
cluster bombs dell’ultimo conflitto, mentre i lorocolleghi nelle regioni occidentali dell’Afghanistansi confrontano con il costante pericolo degli at-tacchi di matrice terroristica perpetrati dagli in-surgents con l’impiego di ordigni improvvisati.
Affidiamo ancora una volta alle pagine di questarivista qualche delucidazione sull’evoluzione deglistrumenti necessari per combattere questi antichinemici che, come noto, sono capaci di produrre iloro effetti nefasti per moltissimi decenni dal mo-mento della loro posa o disseminazione, con undispendio inaccettabile di vite umane e risorse
economiche.La memoria collettiva italiana
rispetto alla bonifica delle minee delle munizioni inesplose ri-sale immediatamente alle tristieredità della Grande Guerra edella Seconda guerra mondiale,eventi che hanno investito, ilprimo, tutta la frontiera setten-trionale del Paese e, il secondo,l’intero territorio. Entrambi fan-no ancora oggi sentire i loro ef-fetti con i circa 2 500 interventiper anno e un totale di alcunedecine di migliaia di ordigni re-cuperati e distrutti. Tuttavia an-che tempi più vicini ci rammen-
tano l’opera dei nostri Artificieri. Infatti, dagli anniSessanta dello scorso secolo con la questione del-l’Alto Adige fino ad arrivare agli anni Settanta eOttanta - i cosiddetti «Anni di piombo» - a causadi frange terroristiche operanti in Italia, ci si è do-vuti confrontare con l’insidia ancor più grave cau-sata dall’impiego di ordigni esplosivi improvvisati
IL NUOVO CENTRO DI ECCELLENZANAZIONALE PER IL C-IED
Per affrontare scenari operativi moderni e nemici antichi
Il delicato scenario internazionale, soprattutto nell’ambito di Teatri Operativi strategici come quello afgha-no, è minacciato dalla presenza di antichi nemici ancora pericolosi e attivi: mine, ordigni inesplosi, ordigniesplosivi improvvisati. Ciò ha portato alla messa a punto del progetto di costituzione di un Centro di Eccel-lenza Nazionale per il C-IED, a valenza interforze, in grado di fornire supporto addestrativo C-IED alle ForzeArmate oltre a un supporto concettuale e organizzativo allo Stato Maggiore della Difesa.
La memoria collettiva ita-liana rispetto alla bonificadelle mine e delle munizioniinesplose risale immediata-mente alle tristi eredità dellaGrande Guerra e della Se-conda guerra mondiale,eventi che hanno investito, ilprimo, tutta la frontiera set-tentrionale del Paese e, il se-condo, l’intero territorio
“
”
S P E C I A L E
collocati per compiere vere e proprie azioni di sa-botaggio.
Inoltre, è storia ormai da tutti conosciuta chel’Italia, dal 1989 in particolare, partecipa con leproprie Forze Armate, e più in particolare conl’Esercito, alle numerose Operazioni Multinazio-nali di Pace con compiti di bonifica di aree minate
e di veri e propri campi di battaglia in Paesi appe-na usciti da eventi bellici disastrosi, trovandosinella situazione, non usuale fino a quel momento,di dover cooperare con gli Eserciti di innumerevolialtri Stati - in gran parte del Patto Atlantico - ematurando così una sempre più adeguata atten-zione alle regole condivise di interoperabilità, pe-raltro sancite dalla ratifica di numerosi accordi distandardizzazione (STANAGs).
Proprio in quegli anni così innovativi per le no-stre Forze Armate, oltre all’idea di uno strumentomilitare professionale e ridotto nei numeri rispet-to al concetto scaturito dal dopoguerra, è matura-ta anche quella, divenuta poi fondamentale, dicostituire un’unica struttura capace di trattare inmodo univoco i problemi concernenti lo studio, ladottrina, la formazione delle professionalità el’addestramento sull’utilizzazione dei mezziesplosivi e sull’eliminazione di tutti gli ordigniinesplosi.
Il 1° ottobre 1998, a seguito di un’articolata di-rettiva sul riordino del settore relativo alla bonifi-
89 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Sopra e a sinistra.Artificieri intenti al disinnesco e distruzione di unabomba d’aereo dell’ultima guerra.
ca da ordigni esplosivi, si è costituito nella Scuoladel Genio il Centro Operativo di Bonifica di ForzaArmata quale «polo nazionale specialistico, adde-strativo, formativo e dottrinale nel settore degliesplosivi e della bonifica di tutti gli ordigni». Daquel momento, oltre a ereditare tutto il cospicuopatrimonio di esperienze fiorito e sviluppato neglianni del dopoguerra nelle diverse realtà delle Ar-mi del genio e dell’artiglieria, nelle quali eranostati formati gli Sminatori, gli Artificieri e gli Anti-sabotatori, il nuovo Centro ha assunto l’inderoga-bile impegno di affrontare un rigoroso ammoder-namento dello strumento anche in termini di ade-renza alla normativa NATO.
Il momento fu effettivamente propizio per rior-ganizzare tutti gli strumenti necessari alla forma-zione degli Operatori cominciando dalla sempliceadozione di sigle e acronimi inglesi utilizzati neidocumenti internazionali, non per mera smania diesotismo, bensì per lanciare l’idea di un chiaro eirrinunciabile mutamento di rotta soprattutto nel-le attività di preparazione degli Operatori. Infatti,cominciò da allora un lungo cammino di ammo-dernamento, per passi successivi e per certi versiancora in atto, al fine di adeguare tutto lo stru-mento alla realtà di una Forza Armata che si an-dava sempre di più affacciando fuori dei propriconfini e che doveva disporsi ad affrontare Ope-razioni di risposta a crisi internazionali semprepiù pericolose e articolate, da svolgere di concer-to con tutti i Paesi alleati.
Concentrare nell’Arma del genio tutte le compe-
tenze riguardanti la bonifica da ordigni esplosivisembrò allo Stato Maggiore dell’Esercito la via mi-gliore per ottimizzare gli sforzi nel settore.
Infatti nella Scuola del Genio erano iniziati i corsiBOE (Bonifica Ordigni Esplosivi) dal 1989 per af-frontare il problema di bonifica dei campi minatidapprima in Afghanistan dopo il ritiro delle truppesovietiche, successivamente nei territori della So-malia scossa da guerre intestine e in Bosnia Herze-govina all’indomani del cessate il fuoco che ha lace-rato i territori della Ex Jugoslavia, tanto per citarealcune delle situazioni più rilevanti. Ma ancora nellaScuola del Genio si istituirono i primi corsi anti-sa-botaggio, come già accennato per fronteggiare lacrisi in Alto Adige (Sud Tirolo), che ebbero vita limi-tata come corsi specifici per trasformarsi poi in ma-teria di insegnamento in altri corsi di elevata quali-ficazione denominati «Corsi Ostacolo Attivo, Demo-lizioni e Anti Sabotaggio». Questi erano svolti a fa-vore di Ufficiali e Sottufficiali destinati a espletare lefunzioni peculiari del Genio in situazioni operativepropriamente dette. L’impiego dell’Arma del Genio,infatti, ha sempre compreso tutte le competenzeoperative relative alle mine, ai campi minati, alletrappole esplosive e alla bonifica integrale dell’areadella battaglia.
Il compito più arduo è stato quello di adeguareuno strumento vecchio di cinquant’anni, costi-tuito da Artificieri e da Genieri formati con i cri-teri del secondo dopoguerra, dopo averne amal-gamato le rispettive conoscenze ed esperienze,per farne uno strumento adeguato alle necessitàdel momento. Contemporaneamente è stato ne-cessario però qualificare il personale giovanepartendo direttamente con i nuovi criteri, cosaresa possibile grazie alla determinazione dei piùilluminati fra i vecchi istruttori, capaci di metter-si in discussione e di sapersi adeguare alle esi-genze dei tempi.
Si cominciò così, per la prima volta, a parlare diorganizzazione EOR (Explosive Ordnance Recon-naissance) mirata alla ricognizione, ricerca e rico-noscimento di ordigni esplosivi; di organizzazio-ne EOD (Explosive Ordnance Disposal) per la neu-tralizzazione e l’eliminazione degli ordigni rego-lamentari inesplosi; e di quella IEDD (ImprovisedExplosive Devices Disposal) mirata a contrastaregli ordigni esplosivi improvvisati, calandole tuttenel tessuto organico di ogni unità del genio ope-rante sul territorio nazionale.
L’attuazione di questo nuovo modello organiz-zativo, come già detto in linea con gli accordi distandardizzazione che la Nazione aveva da temporatificato, ha comportato il riallineamento a livelli
TECHNE - 90
Addestramento al Military Search con l’ausilio di ci-nofili.
di riferimento elevati di tutti i corsi di qualifica-zione delle varie figure professionali esigendo nelcontempo un forte aumento della difficoltà e,conseguentemente, della selettività per ottenerecon immediatezza un prodotto all’altezza dellasituazione.
L’impellente necessità di dotare l’Esercito di unaefficace componente EOD mediante la costituzionedi plotoni EOD/IEDD in tutti i reggimenti dell’Armasia di supporto diretto (guastatori), sia di supportogenerale (Pionieri, Pontieri e Ferrovieri) aveva assor-bito tutto lo sforzo didattico del Centro Operativo diBonifica, inducendo i vertici dell’Arma a utilizzare«fuori area» il personale qualificato EOD anche perincombenze riconducibili all’impiego precipuo deiGenieri, cioè quelle strettamente connesse all’utiliz-zazione degli esplosivi per le demolizioni e alle atti-vità di «mine clearance» (comprendenti «route andarea clearance») ovvero di bonifica integrale di areee campi minati.
Per conferire il ruolo appropriato a ciascuno de-gli attori, lo Stato Maggiore dell’Esercito nei primianni 2000 elaborò così un progetto di riordinodell’Arma del genio articolato sull’idea di modulispecifici di capacità nei settori canonici affidati al-l’arma (mobilità, contro mobilità, protezione e so-stenibilità delle truppe) e mirato a disciplinare lecompetenze fra le diverse specialità nei differentimomenti operativi. Il documento che ne scaturì,ancora oggi conosciuto con il nome di «ProgettoEsecutivo dei Pacchetti di Capacità per la compo-nente Genio» si è dimostrato ancora una volta de-cisivo per la vita del Centro, producendone un’ul-teriore riorganizzazione e determinandone, fral’altro, il cambiamento del nome in Centro Adde-stramento Contro Ostacolo, accezione forse unpo’ sibillina per i non addetti ai lavori e che meritacertamente un’appropriata spiegazione.
Due sono gli elementi fondamentali che emer-gono nettamente dal progetto: il primo, intorno alquale tutto sembra ruotare, consiste nel ruolofondamentale della specialità guastatori comeelemento indispensabile di supporto diretto alleOperazioni, tanto in ambiente «war» quanto in si-tuazioni, più probabili, di CRO (Crises ResponseOperations); l’altro è quello della definizione dellostrumento EOD, comunque sempre incentrato suabilità innestate sulla specialità guastatori, in ognireggimento dell’Arma, evitando alcune confusionidi competenze che le vicende degli ultimi anniavevano involontariamente ingenerato.
Si rendeva così necessario lavorare, ancora unavolta molto intensamente, sulle capacità e le abilitàdei guastatori per restituire loro le caratteristicheoperative di impiego proprie della specialità, affie-volite nel tempo, e per renderli idonei a operare ne-gli ambiti operativi richiesti e correlati intimamenteal nuovo modello professionale dell’Esercito.
L’impulso nuovo all’addestramento dei guasta-tori fu attuato mediante l’istituzione di un modu-lo didattico specifico chiamato MINEX riguardantela trattazione approfondita degli argomenti ine-renti agli esplosivi, alle mine, alle trappole, al ri-conoscimento e all’eventuale distruzione di alcu-ni ordigni inesplosi, alle attività di «breaching» edi «mine clearance». Tale modulo, considerata laspecificità degli insegnamenti venne affidato alnuovo Centro Addestramento Contro Ostacolo(nel Progetto in un primo momento chiamatoCentro di Eccellenza per la Poliorcetica modernacon riferimento all’antica disciplina dell’ostaco-lo), determinandone la riorganizzazione organi-ca. Altro fatto interessante emerso dal nuovoprogetto fu quello dell’istituzione di una capacitàACRT (Advanced Combat Reconnaissance Team)
e delle relative unità a livello squadra e plotonemirate a soddisfare l’irrinunciabile esigenza inoperazioni di uno strumento capace di acquisiredati e obiettivi di utilità per tutte le operazionidel Genio (Engineer Intelligence). Il provvedimen-to è stato assolutamente precorritore dei tempiin quanto il plotone ACRT, unico plotone nell’or-dinamento del Genio ancora comandato da unUfficiale subalterno, costituisce oggi in Afghani-stan l’elemento fondamentale di un assetto spe-cifico impiegato per la «route clearance» di itine-rari ad alto rischio di presenza di IED.
Per fronteggiare i nuovi compiti consistenti es-senzialmente nel complesso sviluppo del ModuloMINEX, come prima parte del Corso di Specializ-zazione dei guastatori di nuova immissione o co-me riqualificazione dei VSP specializzati con ilvecchio iter, è stato aggiunto, a quello EOD esi-
91 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Un artificiere in azione in Afghanistan.
stente, uno specifico Dipartimento Ostacolo Atti-vo forte delle Sezioni di peculiare interesse:Esplosivi e Demolizioni, Mine, Contro Mine eMOUT (Military Operations On Urban Terrain).
Con questo inserimento il Centro è divenuto co-sì un’unità complessa attraversata da un unico filologico che ha voluto incentrare sull’Arma del Ge-nio in generale, e sulla Specialità guastatori inparticolare, tutta l’attività di preparazione degliassetti specifici di settore, dalla nascita - conse-guimento delle abilità MINEX, e quindi professio-nalità di base - fino all’acquisizione delle qualifi-che specialistiche EOD 1° livello (Artificieri/Opera-tori capaci di intervenire su ordigni regolamentaridi dotazione), EOD 2° livello (Operatori idonei aneutralizzare/distruggere ordigni regolamentaricomunque complessi, compresi quelli stranieri e iresiduati bellici sul territorio nazionale e utiliz-zando anche tecniche di avanguardia), IEDD (Ope-ratori per l’intervento su ordigni esplosivi improv-visati di matrice terroristica), BC EOD/IEDD (ope-ratori idonei all’eliminazione degli ordigni appar-tenenti alle categorie già menzionate ma caricaticon aggressivi chimici o biologici).
Inoltre, in ragione delle eredità del passato e delpatrimonio di esperienze accu-mulate nel tempo, il Centro hacontinuato a svolgere i corsi diqualificazione per il personaledelle altre Forze Armate e deiCorpi Armati dello Stato: fra tuttiemerge l’impegno di preparareCarabinieri e Poliziotti per ilconseguimento della qualificaIEDD necessaria per svolgere illoro compito istituzionale di an-tisabotaggio/antiterrorismo sulterritorio nazionale.
Le vicende internazionali hanno purtroppo con-tribuito in modo determinante alla necessità diaffrontare con estrema decisione e risolutezza ilproblema del contrasto all’utilizzazione degli or-digni improvvisati (IED) nell’ambito dei TeatriOperativi che vedono attualmente impegnate lenostre truppe, segnatamente in Afghanistan, doveproprio quegli ordigni hanno inflitto la gran partedi perdite e di lutti.
Proprio quelle perdite e quei lutti hanno indottonel 2006 lo Stato Maggiore della Difesa a istituireun Gruppo di Progetto C-IED (Counter ImprovisedExplosive Devices) per stabilire l’insieme di misu-re idonee a contrastare la minaccia degli IED e cheha trovato la sua massima espressione di pro-gramma in un documento di concetto generaleinterforze (C-IED JIC 004).
Il dispositivo C-IED - contrasto agli ordigniesplosivi improvvisati - consiste essenzialmentenell’insieme delle attività tese a prevenire, ridurre
o eliminare gli effetti di tutte le tipologie di IEDutilizzate contro le forze amiche e i non combat-tenti, secondo la definizione ripresa dal documen-to NATO di riferimento. Si tratta quindi di metterein atto una strategia unitaria basata su quelli chesono definiti i tre pilastri: lotta al sistema IED, ov-vero tutta la serie di azioni o interventi volti a in-terrompere la catena degli eventi IED contrastandola minaccia dalla fase di pianificazione fino all’im-piego dell’ordigno (è in corso una rivisitazione delconcetto in chiave più «offensiva» di attack thenetworks, cioè di attacco preventivo al sistema IEDai fini di una maggiore e più efficace attività diprevenzione); lotta all’ordigno, consistente sianell’incremento dei livelli di «force protection» permitigare gli effetti di un eventuale attacco con IED,sia nel condurre le azioni per individuare, identifi-care e neutralizzare gli ordigni esplosivi mediantel’adozione di tecniche e procedure idonee ad au-mentare il livello di protezione del personale; dot-trina, formazione e addestramento, ovvero lamessa in campo di tutta la serie di discipline e diattività didattiche tese a fornire al personaleun’adeguata preparazione per acquisire, a secondadei casi, la consapevolezza del rischio, la capacità
di adottare i comportamentiidonei a evitare situazioni di ri-schio, mitigare gli eventuali ef-fetti di un’esplosione, metterein atto azioni tese a sconvolge-re le azioni di «targeting» uti-lizzate dal sistema IED, sfrutta-re le prove rilevate sul terrenoai fini della conoscenza dellaminaccia e, infine, la capacità diaggiornare continuamente leproprie Tecniche, Tattiche eProcedure per contrastare effi-
cacemente quelle avversarie.In questo articolatissimo ambito si è mosso il
Gruppo di Progetto per adottare tutta la serie diprovvedimenti tesi a garantire al meglio l’incolumitàdel personale nello svolgere i difficili compiti di«peace keeping», particolarmente nell’ambito del-l’Operazione ISAF, dando mandato allo Stato Mag-giore dell’Esercito di elaborare un progetto per latrasformazione/potenziamento del Centro Adde-stramento Contro Ostacolo della Scuola del Genio inCentro di Eccellenza Nazionale per il C-IED.
Questa trasformazione è subito apparsa come lapiù vantaggiosa e congruente partendo dalla posi-zione, oramai consolidata, del CeAC, quale unicopolo di competenza per la formazione del perso-nale EOD e IEDD di tutte le Forze Armate e le Forzedi Polizia. Infatti, la sua già operante caratteristicadi strumento «interforze» e «interagenzia», insie-me al fatto di avere organizzato, oltre ai canonicicorsi tecnici, anche quelli specifici finalizzati alla
TECHNE - 92
La nuova struttura, vedeaggiungere a quella già esi-stente un intero Diparti-mento C-IED comprendentetutti gli strumenti necessariper affrontare l’intera tema-tica dai punti di vista dottri-nale, didattico e operativo
“
”
lotta al sistema IED: Corsi per Istruttori C-IEDAwareness (train the trainers), Seminari di C-IEDPredeployment Training, Corsi per EOD Staff Offi-cers e Corsi di formazione per Weapon IntelligenceTeam ai fini dello sfruttamento - exploitation -delle evidenze tecniche sul terreno, lo ha reso lostrumento più idoneo a essere trasformato in unCentro di Eccellenza del settore, cioè un Centronel quale riunire, secondo il concetto NATO, l’ap-proccio completo al problema secondo l’ormaiconsolidato orientamento DOTMLPI (Dottrina, Or-ganizzazione, Addestramento, Materiali, Leader-ship, Personale, Infrastrutture).
Lo Stato Maggiore dell’Esercito, condividendo ta-le ipotesi operativa, ha sviluppato un progettoesecutivo di concerto con le altre Forze Armate perla costituzione del Centro di Eccellenza C-IED sullastruttura del CeAC, perché diventasse Ente specia-listico di riferimento per la diffusione della culturaC-IED fino ai minimi livelli di ogni ambiente ope-rativo (land, maritime, air), con le competenze ge-nerali di seguito sintetizzate che si aggiungono aquelle già possedute:• elaborazione e aggiornamento delle TTPs e della
dottrina dello specifico settore;• aggiornamento del personale tecnico di settore
sulle nuove tecniche e tecnologie impiegate inattacchi con IED;
• referente diretto per le esigenze specifiche disettore provenienti dai Teatri Operativi;
• polo di riferimento nazionale nei consessi inter-nazionali, anche in chiave interagency, per losviluppo delle capacità C-IED in ambito NATO eUnione Europea.Il progetto, approvato dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa nel settembre del 2009, ha iniziato ilsuo iter di attuazione per la costituzione del Centrodi Eccellenza Nazionale per il C-IED che vedrà inpochi mesi la nascita di una struttura ordinata se-condo i lineamenti generali descritti in figura 1.
La nuova struttura, oltre al completamento delDipartimento Combat Engineer con l’inserimentodell’importante disciplina Military Search, vede ag-
giungere a quella già esistente un intero Diparti-mento C-IED comprendente tutti gli strumenti ne-cessari per affrontare l’intera tematica dai punti divista dottrinale, didattico e operativo. Realizzata emodellata come detto sull’attuale Centro Adde-stramento Contro Ostacolo, ne erediterà il rag-guardevole bagaglio di conoscenza e di expertisedi cui si faceva precedentemente cenno, sarà apieno titolo incardinata nell’Arma del genio del-l’Esercito, quale principale attore e fruitore - ForzeOperative Terrestri - in termini di professionalitàtecniche da mettere in campo, ma contempora-neamente avrà una maggiore connotazione inter-forze rispetto alla struttura di partenza, avvantag-giandosi anche di personale delle altre Forze Ar-mate inserito nel suo tessuto organico per soddi-sfare le rispettive esigenze operative.
Con questo provvedimento si intende pervenirealla messa in opera di un organismo che si confi-gurerà come un Centro di capacità nel settore C-IED, a valenza interforze, in grado di fornire:• supporto addestrativo C-IED alle Forze Armate e
ai Corpi Armati in funzione della tipologia di as-setti impiegati;
• supporto dottrinale, ovvero di consulenza daparte di esperti del settore, agli Stati Maggiori diForza Armata/Comandi della struttura di Verticedella Difesa che lo richiedano;
• supporto concettuale e organizzativo allo StatoMaggiore della Difesa, che eserciterà sul Centrostesso la funzione di autorità di coordinamentoper quanto attiene alle tematiche sullo sviluppodi capacità, concetti, studi, direttive del livellostrategico/pianificazione strategica nello specifi-co settore.
CONCLUSIONI
Quello sopra sinteticamente delineato apparecome un progetto ambizioso, ancora una voltacarico di ostacoli da oltrepassare, di sfide da vin-cere e anche di diffidenze da superare. Esso co-stituisce tuttavia il presupposto fondamentaleper dotare le Forze Armate del migliore e piùavanzato possibile strumento per vincere la sfidapiù grande, quella costituita, come richiama ilsottotitolo dell’articolo, da nemici antichi - mine,ordigni inesplosi, ordigni esplosivi improvvisati -che, siamo certi, non troveranno i nostri uominiimpreparati, bensì professionisti consapevoli chela sconfitta di questi nemici significherà in so-stanza far ritrovare a interi popoli la pace perdutae la certezza di un futuro migliore.
Roberto ArcioniColonnello, Comandante del
Centro Addestramento Contro Ostacolo
93 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Fig. 1
CENTRO DI ECCELLENZA NAZIONALE PER IL C-IED
TECHNE - 94
Signor Generale, come Comandante della Scuoladel Genio e anche Ispettore dell’Arma, può illu-strarci brevemente le peculiarità dei due incarichie come sono espletate le funzioni?
Fino ad alcuni anni fa le funzioni erano distinte ela Scuola dipendeva dall’Ispettorato della stessa Ar-ma. Dopo la riorganizzazione dei vertici militari edell’Esercito si è arrivati a una fusione delle duecompetenze. Le funzioni peculiari di un Ispettored’Arma sono essenzialmente quelle dello sviluppodottrinale e tecnico-tattico di impiego dell’Armastessa, armonizzato con il concetto generale di im-piego stabilito dallo Stato Maggiore dell’Esercito. Inparticolare, per quanto attiene all’Ispettore del ge-nio si aggiungono compiti peculiari quale l’eserciziodella leadership in campo nazionale nel settore re-lativo alla bonifica di ordigni esplosivi - funzioneespletata avvalendosi del dipendente Centro Adde-stramento Contro-Ostacolo (già Centro Operativo diBonifica) - e rilascio agli aventi diritto della certifi-cazione per il conseguimento dell’abilitazione al-l’esercizio della professione di ingegnere.
I compiti della Scuola d’Arma hanno una connota-zione maggiormente addestrativa, che si espleta inmassima parte con una funzione didattica finalizza-ta all’addestramento di specializzazione e di quali-ficazione delle diverse componenti in tutti i campid’azione dottrinali e di impiego affidati all’Armastessa. La sintesi delle due competenze si manifestacon il ruolo di consulenza tecnica che la Scuola hasulle unità del genio fino a presiedere la commis-sione per il cosiddetto giudizio di Combat Readi-ness Evaluation cui si devono sottoporre i reggi-menti periodicamente e comunque prima del di-spiegamento in operazioni.
Quali sono, nell’ambito dell’Esercito, le attivitàfondamentali devolute all’Arma del genio?
I compiti fondamentali dell’Arma del genio che,peraltro, l’hanno caratterizzata in ogni tempo,possono essere sintetizzati in quelli concernentila mobilità, la contro mobilità, la protezione e ilsupporto allo schieramento. Il primo è volto es-senzialmente a garantire la libertà di movimentomantenendo attive tutte le possibili linee di co-municazione. Quindi si tratta di costruire strade,
Accanto alle funzioni istituzionali relative allo sviluppo dottrinale e tecnico-tattico dell’Arma stessa, si ponel’esercizio della leadership nel settore della Counter-IED e il ruolo svolto in seno a organismi internazionali.Di questo e altro abbiamo discusso con il Generale Dibello, evidenziando i lusinghieri risultati raggiunti e lesfide future che attendono l’Arma del genio.
Intervista al Generale di Brigata Antonio DibelloIspettore dell’Arma del genio
PRESENTE E FUTURODELL’ARMA DEL GENIO
Il Generale di Brigata Antonio Dibello.
S P E C I A L E
ponti e collegamenti su corsi d’acqua inguadabilima anche di eliminare ostacoli quali campi minati,aree infestate da ordigni inesplosi regolamentari enon. Il secondo, più caratteristico del tempo diguerra propriamente inteso, si riferisce al lavorodi interdizione della libertà di movimento dell’av-versario per garantire il successo delle operazioni.Il terzo - la protezione - si riferisce a tutti i lavoriche consentono alle truppe di operare in un ade-guato ambiente di sicurezza e, contemporanea-mente, di vivere in operazioni in condizioni accet-tabili. il quarto ed ultimo compito, il supporto alloschieramento, intimamente legato alla Force Pro-tection, afferisce a tutte quelle attività che con-sentono la sopravvivenza e l’operatività delletruppe. in questo ambito rientrano le capacità ri-feribili alle maestranze edili, alla produzione e di-stribuzione di energia elettrica, la captazione edistribuzione delle risorse idriche.
Per quanto attiene in particolare al settore dellabonifica da ordigni esplosivi, quale ruolo svolgel’Arma del genio e quali sono i compiti specificiaffidati alla Scuola?
Come ho poc’anzi accennato, in questo campola Scuola esercita la leadership in campo nazio-nale ed espleta questa sua funzione attraverso ilCentro Addestramento Contro-Ostacolo che, tral’altro, si trova nel mezzo di una nuova trasfor-mazione in Centro di Eccellenza nazionale per ilCounter IED a valenza interforze di cui parlerò inseguito. L’intera problematica affonda le sue ra-dici in tempi lontani, precisa-mente alla fine della GrandeGuerra, e ha preso definitiva-mente piede all’indomani dellaconclusione del 2° ConflittoMondiale per fronteggiare losminamento e la bonifica inte-grale del territorio nazionaledalle miriadi di mine, munizio-ni e bombe inesplose di varietipologie lasciate dai lunghianni di conflitto e dal passag-gio di molte truppe sul nostrosuolo. Le mine e l’impiego de-gli esplosivi sono stati da sem-pre materia di studio e compe-tenza dell’Arma del genio, co-me pure quella che era definita la bonifica del-l’area della battaglia. Dopo il 25 aprile 1945, da-ta simbolica che segnò la definitiva cessazionedelle ostilità, ebbe inizio la bonifica sistematicadel territorio nazionale, cominciando dai campiminati utilizzati come sistemi antisbarco o comeostacoli di interdizione per l’avanzamento delle
truppe. Le attività furono affidate sia al genio, siaall’Artiglieria del ricostituito Esercito. Al geniofurono assegnate le attività di sminamento e dieliminazione di tutti gli ordigni inesplosi interra-ti, all’Artiglieria il rastrellamento delle munizionidiverse dalle mine giacenti sulla superficie. La si-tuazione, per lo più finalizzata alla bonifica delterritorio nazionale, si è protratta più o meno congli stessi schemi fino agli anni novanta del secoloappena passato quando, i grossi cambiamentiprovocati dal dissolvimento del Patto di Varsaviahanno portato l’Italia a partecipare a pieno titoloal Patto Atlantico attraverso l’intervento nelle pri-me operazioni multinazionali di supporto alla pa-ce e a confrontarsi quindi con le attività relativeallo sminamento e alla bonifica nel campo piùpropriamente operativo. Per completezza di trat-
tazione occorre rammentareche nei primi anni Sessanta delsecolo scorso si dovette af-frontare anche il problema delseparatismo alto-atesino con-dotto spesso con atti terrori-stici, per cui si svilupparono iprimi Corsi Anti-Sabotaggio.Questo tipo di addestramento,intensificato successivamentedurante i cosiddetti «Anni dipiombo», fu offerto da allorain poi anche alle Forze dell’Or-dine, Carabinieri e Polizia diStato, deputate a svolgere leattività antiterrorismo sul ter-ritorio nazionale.
Il 1998 costituì un momento di svolta nel setto-re poiché, a seguito dell’emanazione da partedello Stato Maggiore dell’Esercito della Direttivasul riordino del settore relativo alla bonifica daordigni esplosivi, si costituì il Centro Operativo diBonifica (oggi Centro Addestramento Contro-Ostacolo) con competenza formativa e normativa
95 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
...la Scuola esercita la lea-dership in campo nazionaleed espleta questa sua fun-zione attraverso il CentroAddestramento Contro-Ostacolo che, tra l’altro, sitrova nel mezzo di unanuova trasformazione inCentro di Eccellenza nazio-nale per il Counter IED a va-lenza interforze...
“
”
Un’opera di Force Protection per un Helipad.
su tutto il settore concernente gli esplosivi in ge-nere e, più in particolare, le attività di sminamen-to (mine clearance), la bonifica di ordigni regola-mentari inesplosi (EOD), la bonifica di ordigni dicircostanza o improvvisati (IEDD). Con la citata di-rettiva si determinò il passaggio delle competenzedi bonifica del territorio nazionale da residuatibellici ai reggimenti del genio che ancora oggi, aoltre sessanta anni dalla fine della guerra, effet-tuano una media di 2 500 interventi all’anno.
Undici anni di ininterrotto lavoro del Centrohanno condotto principalmente alla unificazionedei criteri addestrativi e di impiego degli Operato-ri del settore in termini di interoperabilità conquelli di tutte le più importanti Nazioni dell’Alle-
anza, consentendo la quasi totale implementazio-ne degli accordi di standardizzazione NATO ratifi-cati dalla Forza Armata. Particolare rilievo assumeanche il ruolo svolto dal Centro nel formare ilpersonale delle altre Forze Armate e dei Corpi Ar-mati dello Stato evidenziando di fatto una conno-tazione e una valenza interforze.
A proposito di IED, cioè di ordigni esplosivi im-provvisati, le notizie che provengono dai Teatridove sono impegnate le nostre truppe li indicanocome la maggiore minaccia oggi esistente. Comesi intende farvi fronte?
I Teatri Operativi attuali dove sono condottequelle che oggi vanno comunemente sotto il nomedi Crisis Response Operations, pur essendo scena-ri in cui si persegue la pace, sono molto prossimialla guerra; infatti, sono caratterizzati da attività
terroristiche perpetrate da frange estremiste con-trarie a qualsiasi azione mirata alla stabilizzazioneufficiale del Paese ospite. Tali attività connotanotutta l’azione come una lotta asimmetrica in unoscenario ad alta intensità e, quindi, a elevatissimorischio. In effetti, purtroppo le ultime cronache lotestimoniano, gli IED sono la minaccia maggiore eil loro impiego da parte degli insurgents provocala maggior parte delle vittime nelle fila della coali-zione internazionale.
Per fare fronte a questo pericolo immanente, loStato Maggiore della Difesa ha costituito un Grup-po di Progetto Interforze e ha emanato nel 2006una direttiva di pianificazione volta a fornire a tut-te le Forze Armate le linee guida fondamentali perlo sviluppo e la messa in atto di una completastrategia di risposta agli IED, nel complesso chia-mato «Sistema Counter IED» (C-IED), basata su trepilastri fondamentali: lotta al sistema IED (percontrastare mandanti: finanziatori, procacciatori dimateriali, allestitori di ordigni, in una parola tutti ipossibili perpetratori delle azioni criminose), lottaall’ordigno (per garantirne la neutralizzazionesenza conseguenze, in particolare per le persone)e addestramento e diffusione capillare di una cul-tura C-IED (finalizzati a indurre nel singolo milita-re impiegato in operazioni la consapevolezza delpericolo derivante dalla presenza di tali ordigni,fornendo altresì mezzi, metodi e stili di comporta-mento idonei a fronteggiare efficacemente la mi-naccia).
Anche in questo campo le incombenze di naturapiù tecnica sono state affidate al Centro Adde-stramento Contro-Ostacolo che, in attuazione diun progetto recentemente approvato dal Capo diStato Maggiore della Difesa, si sta trasformandoin Centro di Eccellenza Nazionale per il C-IED.
Vale la pena di sottolineare che la parola «eccel-lenza» sta a significare che nell’unico Centro sa-ranno sviluppate attività di studio, di emanazionedi documenti dottrinali, di addestramento, di va-lutazione dell’efficacia operativa degli attori delsettore e di analisi degli eventi per il necessariosfruttamento delle lezioni apprese. Con la nuovaconfigurazione, il Centro - seguendo una roadmap già avviata - dovrebbe giungere al vero eproprio atto costitutivo nell’autunno del 2010:continuerà ad essere a guida Esercito/Arma delgenio e avrà una più marcata valenza interforze,trattandosi dell’unico organismo nazionale depu-tato alla trattazione di tutto l’articolato settore;con la partecipazione di alcuni effettivi prove-nienti dalle altre Forze Armate.
Quindi, si evince che il C-IED costituisce il com-plesso di attività finalizzate a minimizzare gli ef-fetti degli IED contro le forze delle coalizioni che
TECHNE - 96
Un artificiere in addestramento EOD di 2° livello.
partecipano alle operazioni multinazionali. Comesi pone l’Esercito, e in particolare l’Arma del ge-nio, nei consessi internazionali quali NATO eUnione Europea?
Come ho accennato in precedenza, la massimaespressione dell’Arma del genio per contrastarel’utilizzazione degli IED è costituita dall’attivitàdel Centro Addestramento Contro-Ostacolo che,tra l’altro, cura l’addestramento dei guastatori(Combat Engineers) per quanto attiene al ModuloMINEX, cioè un’importante fase preliminare del-l’addestramento di specializzazione dei guastatoriche costituisce anche un forte strumento di sele-zione. Questa fase è focalizzata sull’impiego degliesplosivi, ricerca e riconoscimento di ordigniesplosivi («mine e route clearance») e attività con-tro trappole esplosive nelle diverse situazionioperative. Se superato, gli allievi terminano il lorocorso di specializzazione nel reggimento Adde-strativo della Scuola, incaricato anche di svolgere,per quanto attiene allo specifico settore, i corsiACRT (Advanced Combat Reconnaissance Team).Questi ultimi sono finalizzati alle ricognizioniavanzate per l’acquisizione dei dati di intelligencetecnica del genio e al contrasto alla minaccia IED,con capacità di bonifica speditiva.
Per quanto attiene alle relazioni internazionali, ilpersonale del Centro Addestramento Contro-Ostacolo, oltre ad essere periodicamente impie-gato nei Teatri d’Operazione, è avviato - quandopossibile - alla frequenza di corsi specifici al-
l’estero (Inghilterra, Spagna, Germania, Israele)per ampliare il patrimonio di conoscenze e di vi-suale generale della problematica in questione. Intale contesto, sono state sviluppate recentementele prime esperienze di corsi svolti dal Centro a fa-vore delle altre Nazioni della NATO e dell’UnioneEuropea.
Le attività di maggiore rilievo, perciò foriere dirisultati tangibili sia in termini di efficienza ope-
97 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
Sopra.Artificieri si addestrano al Military Search.
Sotto.L’effetto di una mina su di un autoveicolo.
rativa e, perché no!, anche di prestigio, sonoquelle relative alla partecipazione ai gruppi di la-voro specifici. Al momento, la Scuola del Geniofornisce con personale del Centro AddestramentoContro-Ostacolo il delegato nazionale del NATOEOD Working Group, la chairmanship del Chemi-cal Biological Radiologic Nuclear EOD Project Te-am in seno all’Agenzia di Difesa Europea (Europe-an Defence Agency - EDA) e si appresta a fornireil delegato nazionale per il NATO EOD WorkingGroup e quello per il Military Search Project Teamdell’EDA.
Pertanto, l’Italia aspira giustamente a una posi-zione di leadership nel settore almeno in ambitoeuropeo?
Certamente! L’Italia ha offerto la propria dispo-nibilità ad assumere la leadership per quanto at-tiene allo sviluppo della capacità Military Search inseno all’Agenzia di Difesa Europea. Ancora unavolta personale del Centro Addestramento Con-
tro-Ostacolo ha concorso in modo determinantealla redazione del concetto europeo di MilitarySearch (collaborando con personale dell’EDA) e diquello nazionale che costituirà, una volta emanatodallo Stato Maggiore della Difesa, il documento diriferimento per l’attuazione dell’intero progetto.Nel periodo 30 novembre-18 dicembre 2009 la
TECHNE - 98
Sopra e a destra.Due momenti addestrativi del Military Search AdvisorsCourse.
Scuola del Genio ha ospitato il corso patrocinatodall’EDA, svolto da una Team di Contractors bri-tannici a favore di circa 12 Paesi dell’Europa e fi-nalizzato alla qualificazione di Military Search Ad-visors che si occuperanno, al rientro in patria, disviluppare la capacità nel proprio Paese.
Progetto interessantissimo, che consentirà, unavolta attuato, di avere a disposizione un ulteriorevalidissimo strumento di sal-vaguardia. Strumento che siinserirà anch’esso nella lotta alsistema e nella lotta all’ordi-gno ma secondo un’altra pro-spettiva. Cioè, se mi si passa lasemplificazione, mentre l’atti-vità IEDD (Improvised Explosi-ve Device Disposal) consistenel neutralizzare e rendereinoffensivo un ordigno im-provvisato nel quale ci si im-batte, con le attività di Military Search si andrà «acaccia» dell’ordigno cercando di impedirne amonte l’utilizzazione.
Quindi, Generale, grande fermento?
Assolutamente, grande impegno e piena deter-
minazione nel perseguire i migliori risultati possi-bili per la garanzia dei nostri soldati e per il suc-cesso delle missioni cui la Forza Armata è chia-mata a partecipare.
Con questo spirito, tra il 10 e l’11 dicembre2009 si è svolto un SeminarioC-IED al quale hanno parteci-pato tutti i Comandanti deireggimenti genio, nonchè Uffi-ciali dello Stato Maggiore dellaDifesa, dello Stato Maggioredell’Esercito e del ComandoOperativo di vertice Interforze(COI). L’iniziativa, che ci si pro-pone di reiterare con cadenzaannuale, è finalizzata a riunirein un unico consesso privilegia-
to tutti i responsabili delle unità genio per fare ilpunto della situazione, avere un momento di con-fronto e discutere sui risultati ottenuti, sulle diffi-coltà incontrate, sulle necessità più urgenti dasoddisfare.
a cura di Marco CiampiniDirettore di «Rivista Militare»
99 - TECHNE
TECHNE
Rivista Militare n. 3/2010
L’Italia ha offerto la pro-pria disponibilità ad assu-mere la leadership perquanto attiene allo sviluppodella capacità Military Se-arch in seno all’Agenzia diDifesa Europea
“
”
Un momento del Seminario C-IED.
ANTHROPOS - 102
Non esistono pagine bianche nel grande librodella storia. La storia è, infatti, l’accadimento,l’avventura, lo sconvolgimento; per dirla in lin-guaggio hegeliano essa «non è il terreno della fe-licità. I periodi di felicità sono pagine vuote nellastoria, perché sono i periodi di concordia, neiquali manca l’antitesi». Antitesi, capovolgimento,opposizione sembrano dunque essere connaturatiallo sviluppo storico. Il cammino umano è un af-fascinante intreccio di sconvolgimenti e assesta-menti che qualcuno ha visto come funzionali allasana evoluzione della società, altri come l’espres-
sione massima del volto malvagio della naturaumana, assolutamente da combattere e sradicare.
Topos ricorrente nelle poesie, nelle arti figu-rative, nelle opere letterarie (racconti, poemiepici), la guerra è stata sovente oggetto di ri-flessione in numerosi pensatori. Molte correntifilosofiche hanno visto la guerra come un malenecessario, addirittura funzionale al progressosia morale, in quanto diffonde l’esercizio di vir-tù (coraggio, eroismo), sia sociale in quantorende possibile l’unione di genti diverse in co-munità sempre più vaste, sia tecnico, poichéstimola l’intelligenza creativa dell’uomo. Altre,invece, ne hanno condannato ogni aspetto, po-nendo la pace come l’ideale supremo cui devo-no tendere gli uomini. Ne costituisce un esem-pio la concezione politica di Hobbes che consi-dera lo stato di natura una guerra universale eperpetua, condizione dalla quale l’umanità devenecessariamente uscire per perseguire lo statodi pace, ossia la società civile. Questo è il mo-dello «hobbesiano» dove la contrapposizione traguerra e pace, viste rispettivamente come malee bene assoluto, è netta.
Diverse sono state le accezioni attribuite a que-sto concetto, e la sfera semantica in cui spessoviene collocato varia profondamente a secondadell’epoca e del contesto socio-culturale domi-nante. Pur nella varietà di significati e sfaccettatu-re, il dibattito sulla guerra ha origini antichissimee ha sempre esercitato un profondo fascino suipiù grandi filosofi.
La storia del mondo è dominata dall’antagonismo e dal conflitto. Un percorso tortuoso fatto di sentieri im-pervi e sconnessi, tutt’altro che lineari. Questo perché il mondo umano è un fitto e complesso reticolato dirapporti e le relazioni tra uomini e Nazioni non sono altro che incastonate in un imperfetto e fragile mecca-nismo di equilibrio. Fin dall’antichità la guerra, intesa come puro scontro, ha affascinato i più grandi pensa-tori dell’Umanità, divenendo oggetto di approfondita discussione.
LA GUERRANEL PENSIERO FILOSOFICO
A sinistra.Eraclito di Efeso, olio su tavola (1628).
In apertura.Napoleone alla battaglia di Austerlitz, nel 1805.
LE ORIGINI: ERACLITO E PLATONE
Già nelle prime forme della filosofia, dove ilpensiero è ancora intessuto di forti elementi fan-tastici e la frattura tra logos e mito non è ancoraben delineata, sembra dominare un’interpretazio-ne del mondo e dell’origine di tutte le cose fon-data sul concetto di opposizione e di caos.
Infiniti sono i personaggi, le imprese, le guerrenarrate nella «Tegonia» di Esiodo, in cui nulla ècasuale ma tutto si conforma all’esigenza di in-terpretare sistematicamente il mondo.
La prima concezione organica della guerra nellastoria della filosofia è quella formulata da Eraclito,filosofo di Efeso del 540 a.C., nei suoi circa 130frammenti che dipingono l’universo come uneterno e incessante fluire di forme in cui non vi èniente di stabile e definitivo cosicché «non è pos-sibile scendere due volte nello stesso fiume nétoccare due volte una sostanza mortale nellostesso stato». Noi stessi siamo e al contempo nonsiamo, perché esistere vuol dire mutare la propriacondizione attuale per un’altra, dove tutto scorree nulla permane e «il Sole è giovane ogni giorno».Questo divenire è l’essenza stessa delle cose, è ilpántha rheî, sintesi della dottrina eraclitea del di-venire. L’identità delle cose, ciò che le rendequelle che sono, è il loro essere sempre diverse, illoro reciproco opporsi. Non può esistere vita sen-za antagonismo: «Pólemos (la guerra) è padre ditutte le cose, di tutte è il Re; e gli uni disvela co-me dèi e gli altri come uomini; gli uni fa schiavi,gli altri liberi». Eraclito riesce a cogliere il contra-sto tra elementi opposti non solo nella forma po-litica ma come immanente e radicato nella naturastessa: la notte è tale in quanto guerreggia colgiorno, e il giorno in quanto guerreggia con lanotte, «così la quiete della lira o dell’arco nascedalla lotta tra le corde, tese acontrastare la prepotenza dellegno ricurvo e le cose freddesi scaldano, quelle calde si raf-freddano; ciò che è umido sisecca, ciò che è arido si inumi-disce». Ciò che governa il mon-do è, dunque, la guerra ma es-sa sottende una legge di armo-nia che dà equilibrio e senso altutto. Tra gli opposti vi è unconflitto costante ma anche una segreta armonia,il cui carattere è necessario e reciproco. Del resto,non può esserci salute senza malattia, sazietàsenza fame, non può esistere una salita che nonsia al contempo anche una discesa. Ciò che è op-posto si concilia e da questa guerra, «dalle cosedifferenti nasce l’armonia più bella e tutto si ge-nera per via dei contrari» (1).
Il contrasto non è mera sopraffazione o caos, o
almeno lo è solo in apparenza. Esso si risolve inun ordine, in una ragione superiore, il logos, es-senza e linfa vitale di tutte le cose. La verità dellogos si rivela solo all’uomo saggio che riesce ascorgere nel conflitto la condizione essenzialedell’armonia che sta al di sopra delle parti in
guerra e le concilia in un unicoe immutabile disegno.
Emerge chiaramente dallaconcezione eraclitea dellaguerra, che stabilisce gerarchiee assicura ordine, la formazio-ne di matrice aristocratica delfilosofo di Efeso che non na-sconde il proprio disprezzo perla massa di uomini dormienti,incapaci di comprendere il lo-
gos e la verità degli eventi.La particolare connessione tra guerra e politica
comincia a profilarsi nelle opere di un altro filoso-fo dell’antichità. Platone (428-347 a.C.), nel pri-mo libro de «Le leggi», riporta la discussione tral’Ateniese, identificato con il filosofo stesso, e ilcretese Clinia riguardo la legislazione di Creta e diSparta. Clinia afferma che la legislazione di Cretaè basata sulla guerra e tutte le attività svolte nel A
NTHROPOS
103 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
Pur nella varietà di signifi-cati e sfaccettature, il dibat-tito sulla guerra ha originiantichissime e ha sempreesercitato un profondo fa-scino sui più grandi filosofi
“
”
Platone.
ANTHROPOS - 104
cosiddetto «tempo di pace» sono finalizzate allapossibilità di un conflitto: «Quella che la maggiorparte degli uomini chiamano pace non è nient’al-tro che un nome, ma nella realtà delle cose, perforza di natura, c’è sempre una guerra, se purnon dichiarata di tutti gli Stati contro tutti».
Alla celebrazione del militarismo cretese e spar-tano, l’Ateniese sostituisce una concezione de-mocratica che interpreta la guerra e la pace comeeventi privati ed esorta a vivere come se il conflit-to non esistesse. Secondo Platone queste opposteposizioni determinano l’indebolimento della città,poiché ne organizzano la quotidianità come seesistesse soltanto la guerra oppure la pace. Purriconoscendo il carattere ineliminabile di entram-be, egli delinea una legislazione basata sull’adde-stramento militare, il quale deve costituire il ful-cro della società, l’elemento essenziale sul qualefondare la nostra vita quotidiana, ma tutto ciò invista non della guerra ma della pace e del suomantenimento.
Nel dialogo «A Protagora», Platone descrive ilmito di Prometeo ed Epimeteo incaricati in origineda Zeus di dotare gli esseri viventi delle qualitàper sopravvivere. Avendo Epimeteo dimenticato laspecie umana, Prometeo donò agli uomini il fuocoe la tecnica dopo averli sottratti a Efesto e ad Ate-na. Purtroppo gli uomini vivevano disordinata-mente e in uno stato di perenne conflitto, inevita-
bile conseguenza del misconoscimento dell’artepolitica. Solo l’intervento di Zeus avrebbe diffusoil senso del pudore e della giustizia, rendendopossibile la fondazione delle città e lo sviluppodell’arte politica, di cui quella bellica è parte in-scindibile.
Vi è una stretta correlazione anche etimologicatra polis, politichè techne e polemichè techne.L’esercizio dell’arte politica appare, quindi, fun-zionale alla sopravvivenza dell’umanità, in quantogarante della sicurezza della città attraverso lostrumento bellico. Quest’ultimo svolge una fun-zione essenziale nell’ambito dell’attività di gover-no: il mantenimento dell’ordine e della pace al-l’interno della polis.
Il tema del rapporto tra guerra e politica vieneripreso da Platone in maniera più ampia nella«Repubblica». Qui viene esaltata la funzione poli-tica del polemos visto come strumento di transi-zione verso forme più progredite di Stato, dovepiù diffusa è l’armonia e la concordia tra i cittadi-ni. A proposito del rapporto tra polemos e stasis,il filosofo dice: «Mi sembra che, come si usanoquesti due nomi di guerra e di discordia, così an-che siano due le cose, che si riferiscono a duesorte di dissensi. Queste cose sono, una, per mefamiliare e congenere, l’altra estranea e straniera.Ora l’inimicizia con quella familiare si chiama di-scordia (stasis), quella con l’estranea guerra (po-lemos)».
La connessione, quasi strutturale, tra politica eguerra, trova nelle leggi platoniche una più rigo-
Scena di battaglia tra soldati romani e germanici.
ANTHROPOS
105 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
rosa giustificazione teoretica: da un lato, il filoso-fo pone sempre la guerra a fondamento della vitapubblica e privata, dall’altro però ne ribadisce ilcarattere funzionale al mantenimento dell’ordinee della pace all’interno della comunità, tanto cheafferma che «un acuto sarà colui che ordinerà leopere della guerra in funzione della pace».
LA GUERRA NEGLI SCRITTI FILOSOFICI CRISTIANI
Sant’Agostino
La funzione, il significato e l’opera della pacediventeranno il tema centrale della riflessione fi-losofica cristiana. Negli scritti biblici l’origine del-la pace viene collocata nel cuore di ogni uomo ri-conciliato con Dio: si tratta di una pace interiore,fondamento di ogni altra pace, che ha la proprialinfa nel continuo ritorno dell’uomo a Dio, attra-verso la conversione. Ed è qui che nasce il rifiutodi ogni forma di violenza, compresa la guerra,sanzionata come «peccato mortale» dal comanda-mento «Non uccidere». Il discorso sulla pace, vol-to e trionfo del bene, è però strettamente connes-so a quello sull’esistenza del male, di cui la guer-ra viene vista come inevitabile manifestazione.
Che cos’è il male? Se Dio ha creato il mondo, hacreato anche il male sotto ogni forma, quindi an-che la guerra? Dove nasce la tendenza degli uo-mini a compiere azioni malvagie? Il mistero che sicela dietro queste domande ha sempre affascina-to e turbato l’essere umano ed è il motivo domi-nante nella riflessione religiosa e teologica cri-stiana. Tra i più grandi filosofi a scandagliarel’arcano fu Sant’Agostino (354-430 d.C.), definito«il massimo pensatore cristiano del primo mil-lennio e uno dei più grandi geni dell’umanità inassoluto», di certo il più impor-tante tra i Padri della Chiesa,insostituibile cerniera tra ilmondo antico e la civiltà cri-stiana. Nelle «Confessioni»Agostino dice di Dio: «...ma inquanto buono creò cose buone,e così le avvolge e riempie», epoi si chiede: «Allora dov’è ilmale, da dove e per dove è pe-netrato qui dentro? Qual è lasua radice, quale il suo seme?».La soluzione agostiniana èsemplice: il male in sé non esi-ste, ma esiste solo in quanto assenza del bene, èpuro non-essere. L’unica forma di male esistentenel mondo è la disubbidienza alla legge divina.Ma dove nasce la tendenza dell’uomo a peccare?L’anima umana è naturalmente portata alla mal-vagità e compie il male per il solo gusto di farlo,
per questo l’unico aiuto per salvarsi può veniredall’intervento di Dio (2).
Ferma è la sua condanna della guerra, anche se«non è affatto da porsi tra i mali peggiori», vistacome «negazione della vita». «Il nostro bene è lapace» dice Agostino, «non quella che regna fra gliuomini, infida, instabile, incerta, e nemmenoquella che ha l’uomo con se stesso. Gli uominiche non vivono di fede cercano affannosamente la
pace terrena come uno dei be-ni e dei piaceri di questa vitatemporale. Gli uomini inveceche vivono di fede sono in at-tesa delle eterne promesse e siservono delle realtà terrene etemporali con l’animo di chi sadi star compiendo un viag-gio.... La città celeste si servedunque anch’essa, finché è incammino, della pace terrena edifende l’accordo tra le discor-danti volontà su quanto puòessere utile a questa vita mor-
tale, per quanto è possibile, purché non sia incontrasto con i doveri verso Dio». Questa rifles-sione sui concetti di pace e guerra è chiaramenteispirata da uno spirito profondamente religioso eva letta in un contesto teologico cristiano. La pa-ce, secondo il filosofo, in quanto tranquillitas or-
La pace, dunque, vienedescritta come uno statocui l’uomo anela continua-mente, a causa del forte di-sagio che l’animo avverte insua assenza, quello causatodalla violazione della leggefondamentale della vita edell’essere
“
”
Sant’Agostino.
dinis, è aspirazione universale degli uomini. Nonè possibile non desiderare la pace; anche coloroche vogliono la guerra mirano a vincerla per rag-giungere una pace gloriosa. Ogni uomo è, infatti,indotto dalle leggi della propria natura a costruirel’armonia con tutti gli altri. La pace, dunque, vienedescritta come uno stato cui l’uomo anela conti-nuamente, a causa del forte disagio che l’animoavverte in sua assenza, quello causato dalla viola-zione della legge fondamentale della vita e del-l’essere.
La riflessione sulla pace non mutò radicalmentenei secoli successivi ma risentì senza dubbio del-l’influsso di un contesto religioso segnato da pro-fonde trasformazioni e lacerato da un processo dimondanizzazione e corruzione che non poteva es-sere tollerato. Di fronte a una simile degenerazio-ne nasceva «l’uomo nuovo», relativamente eman-cipato e secolarizzato, il quale esprimeva l’esigen-za di una nuova religiosità, un’esigenza così forteche avrebbe portato a una vera e propria scissioneall’interno del Cristianesimo e a quel movimento,che ha interessato la Chiesa Cattolica nel XVI se-colo, denominato Riforma Protestante.
IL PACIFISMO UMANISTICO
Erasmo da Rotterdam - Tommaso Moro
Gli ambienti culturali europei non furono estra-nei a questi fermenti e furono investiti da un’on-data di rinnovamento spirituale e intellettuale cheponeva al centro la dignità umana e il «ritorno alpassato». Questo movimento culturale, definito«Umanesimo», si specificava tra l’altro nel recu-pero dei testi antichi e nella rilettura dei classici,
con l’intento di riscoprirne i valori morali e intel-lettuali e confrontarli con quelli attuali.
Uno dei massimi esponenti dell’Umanesimo,forse il più grande del suo tempo, fu Erasmo daRotterdam (1466-1536), che si fece interpretedell’ideale in cui la nuova educazione dell’uomoattraverso le bonae litterae si congiungeva allanecessità di un ritorno al Cristianesimo originario.La ferma convinzione della possibilità di istruire efar progredire la natura umana lo portò ad analiz-zare la formazione del Principe cristiano, dovel’ideale platonico del Principe-filosofo si fondecon l’ideale cristiano del Principe che si ispira agliinsegnamenti del Vangelo.
L’uomo è eticamente predisposto oppure è libe-ro di scegliere tra bene e male? Ha ragione Luteroquando sostiene la naturale malvagità dell’uomo?Questa sul libero arbitrio è una delle questionifondamentali sulle quali si impernia il discorso diErasmo. In polemica con Lutero, egli afferma chese l’uomo può peccare vuol dire che è in grado diesercitare arbitrariamente la sua volontà, ma ilsuo arbitrio non lo porta alla salvezza per rag-giungere la quale ha bisogno di rivolgersi a Dio.Questa concezione sottende anche la sua visionepolitica, in particolare la riflessione sulla guerrache Erasmo non vede come un mero fatto che si
ANTHROPOS - 106
Tommaso Moro.
Erasmo da Rotterdam.
impone dall’esterno alla nostra coscienza ma co-me un male che ha la sua origine nelle passionidegli uomini e negli errori dei governanti. Nella«Querela pacis» descrive la condizione dell’uma-nità perennemente lacerata dai conflitti e denun-cia le responsabilità della guerra esortando i Prin-cipi a perseguire l’ideale della pace. Secondo il fi-losofo, chi vuole la guerra è malvagio perché nonrispetta il supremo comandamento divino, mamanifesta anche stoltezza dal momento che nonsa dominare con la ragione gli scomposti motidell’animo.
Un altro umanista di grande spicco, tra l’altroamico di Erasmo, fu l’inglese Tommaso Moro(1478-1535). All’interno della sua maggiore ope-ra «Utopia» vi è un paragrafo intitolato «La guer-ra» dove l’autore prende posizioni precise riguar-do questo tema: «Il Bellum, la guerra è profonda-mente detestata in Utopia, dove, contro l’uso ditutti i popoli, nulla si reputa così inglorioso quan-to la gloria acquistata con le guerre. Perciò, perquanto si addestrino di continuo in esercizi mili-tari, e non gli uomini solo, ma anche, in giornistabiliti, le donne, per non trovarsi, al bisogno,disadattati alla guerra, non intraprendono questada sconsiderati, ma o per difendere il loro territo-rio, o per ricacciare i nemici che abbiano invaso leterre di amici, o per pietà di un popolo oppressoda tirannide allo scopo di liberarlo con le proprieforze dall’oppressione e dalla schiavitù. Vero èche donano il loro aiuto ad amici, non sempre ac-ciocché questi si possano difendere, ma taloraanche per rendere le offese patite e vendicarle...». Moro evidenzia ancora come: «Una vittoriasanguinosa suscita tra gli Utopiani rincrescimentonon solo, ma anche vergogna». Ferma è, dunque,la condanna della guerra anche se Moro si distac-ca da Erasmo considerando giusti alcuni casi diguerra, come ad esempio combattere per la difesadel territorio. A volte la lottaarmata è inevitabile ma è anchenecessario lavorare sulla diplo-mazia di pace per evitare chediventi uno strumento abitualeper la risoluzione delle contro-versie. Di notevole interesse estraordinaria modernità è il ri-ferimento alla possibilità per ledonne di partecipare alle attivi-tà belliche. Ecco, dunque, delinearsi la figura delladonna-soldato anche se non del tutto autonoma eancora fortemente legata al contesto familiare:«Ma così come lo Stato non manda nessuno inguerra contro la propria volontà, allo stesso modonon impedisce alle donne di seguire i mariti, se lovogliono; anzi, le incoraggiano, lodandole se lofanno. Sul campo ognuna avanza a fianco del ma-rito [...]. Viene considerato un disonore per l’uo-
mo tornare senza la propria moglie, così comeper la moglie tornare senza il marito o il figliosenza il padre».
La Guerra in Machiavelli
Una figura di grande spicco nell’ambiente politi-co e culturale rinascimentale è quella di NiccolòMachiavelli (1469-1527), per molti anni SecondoSegretario della Repubblica fiorentina, con il com-
pito di sovrintendenza agli Af-fari interni e alla guerra. La suaindagine sul rapporto tra mo-rale e politica è ancora oggioggetto di controversie e di-scussioni.
La politica, secondo Machia-velli, deve essere autonormativaperché ha in se stessa la propriagiustificazione. Il Principe non
deve essere indifferente al bene o al male ma avolte la crudeltà gli è indispensabile per la creazio-ne e lo sviluppo dello Stato: «E tra tutti i principi, alprincipe nuovo è impossibile fuggire il nome delcrudele, per essere li Stati nuovi pieni di pericoli....Nasce da questo una disputa: se è meglio essereamato che temuto, o viceversa. Rispondesi che sivorrebbe essere l’uno e l’altro; ma perché è difficileaccozzarli insieme, è molto più sicuro essere te- A
NTHROPOS
107 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
Machiavelli è stato uno deiprimi a intuire il profondocambiamento che il concet-to di guerra ha subito inepoca rinascimentale
“
”
Niccolò Machiavelli.
muto che amato, quando si abbia a mancare del-l’uno dei due». E il Principe ha come obiettivo pri-mario la guerra, perché essa è il tramite per ilmantenimento del potere. Egli deve esercitarsi al-l’arte militare anche in tempo di pace perché laguerra è sia strumento di difesa che di conquista esu di essa si fonda l’esistenza stessa della Signoria.
Machiavelli è stato uno dei primi a intuire il pro-fondo cambiamento che il concetto di guerra hasubito in epoca rinascimentale. Uno Stato fortenon può più affidarsi agli eserciti cavallereschi omercenari, ma ha bisogno di un esercito che lorappresenti nella sua unità e potenza. Supremalegge del Principato è la conservazione di se stes-so e la milizia cittadina ne è l’espressione: «UnPrincipe non deve avere altro obiettivo, altro pen-siero e altro fondamentale dovere se non quello diprepararsi alla guerra e a tutto ciò che essa com-porta. Questa infatti è la sola prerogativa che ci siaspetta da chi comanda. È talmente importanteche mantiene al potere non solo quelli che principisono nati, ma molto spesso fa sì che semplici cit-tadini possano diventarlo; al contrario, i Principiche si sono dedicati più ai piaceri della vita che al-l’arte militare hanno perso il loro potere. Ciò chesoprattutto lo fa perdere è il non conoscere que-st’arte, mentre ciò che lo fa conquistare è l’esser-ne esperto.... Il Principe non può non occuparsidell’arte della guerra e lo può fare in due modi:
con la pratica e con lo studio. Quanto al primoaspetto non solo deve tenere in ordine e in eserci-zio i suoi uomini, ma anche dedicarsi alla caccia inmodo da abituare il suo corpo ai disagi e impararea conoscere la natura dei luoghi.... Il Principe chenon si è fatto tale esperienza manca della primaprerogativa di un condottiero: quella che gli con-sente di scovare il nemico, di individuare i luoghidove accamparsi, di organizzare le giornate e diassediare castelli e città con vantaggio.... Quantoallo studio, il Principe deve leggere i libri di storiaed esaminare le azioni degli uomini migliori, vede-re come questi si sono comportati in guerra, ana-lizzare le ragioni delle loro vittorie e delle lorosconfitte per poter imitare le une o evitare le altree soprattutto deve fare ciò che in passato feceroalcuni Principi eccellenti che già presero a modelloun uomo il quale prima di loro era stato lodato eglorificato, tenendo presente le gesta da lui com-piute: Alessandro Magno imitava Achille, CesareAlessandro, Scipione Ciro» (3). E in tempo di guer-ra la crudeltà diventa imprescindibile: «Tra le mi-rabili azioni di Annibale si enumera questa, che,avendo uno Esercito grossissimo, misto di infinitegenerazioni, condotto a militare in terre aliene nonvi sorgesse mai alcun dissenso, né fra loro né con-tro al Principe, così nella cattiva come nella suabuona fortuna».
IL GIUSNATURALISMO
Thomas Hobbes
Il ritorno dell’organizzazione politica alla suasostanza razionale, il concetto di sovranità e an-che il dibattito sulla guerra avranno una profondaeco nel pensiero filosofico del XVII e XVIII secolo.È proprio dalla riflessione sulla guerra che sonodesunte le regole fondamentali e l’essenza stessadel diritto naturale proprie della concezione giu-snaturalistica moderna. La guerra è uno stato incui la validità delle leggi positive è sospesa, cosìcome gli accordi tra i singoli Stati; ma nessunconflitto può sospendere l’efficacia di quelle nor-me fondate sulla stessa natura umana. Uno deimassimi teorici del concetto di legge naturale,legge morale e legge positiva, nonché dell’assolu-tismo politico, è Thomas Hobbes (1588-1679), lacui fama è legata a un’opera di grande levatura «IlLeviatano». Egli definisce diritto soggettivo «la li-bertà che ciascuno ha di usare secondo la rettaragione delle proprie facoltà naturali» e la primalegge di natura scaturisce proprio dalla riflessionesulla condizione del genere umano in perennelotta per la sopravvivenza. «La natura ha dato aciascuno il diritto su ogni cosa»; quindi, se tuttihanno diritto a tutto si viene a creare uno stato di
ANTHROPOS - 108
Thomas Hobbes.
continua competizione e di ostilità reciproca cheporta a un conflitto perpetuo e alla sicura distru-zione. Così la ragione umana si raffina ed elaborauna serie di leggi che possono aumentare la pro-babilità di sopravvivenza della specie. Secondo laprima legge di natura risulta più adatto alla con-servazione ricercare la pace piuttosto che la guer-ra, ma se è necessario fare la guerra, allora è me-glio allearsi con altri individui.
Per il giusnaturalismo moderno, la legge natu-rale è un prodotto della ragione umana, è definitada Hobbes «una tecnica calcolatrice» capace dioperare, in vista delle circostanze future, le sceltepiù convenienti. Pertanto le norme fondamentalidella legge naturale sono dirette a sottrarre l’uo-mo al gioco spontaneo e autodistruttivo degliistinti e a imporgli una disciplina che gli procuriun certo grado di sicurezza. A differenza di Ari-stotele, Hobbes non considera la società umana ilprodotto di un istinto naturale. Negli animali, co-me le api e le formiche, vi è una socialità istintivache la creatura umana non possiede. Una dellefondamentali differenze sta nel fatto che «traqueste creature, il bene comune non differisce dalprivato ed essendo esse, per natura, inclini al lorobene privato, procurano con ciò il beneficio co-mune». Invece, «la gioia dell’uomo sta nel para-gonarsi con gli altri uomini...». Solo la societàumana conosce la guerra dal momento che «gliuomini sono continuamente in competizione perl’onore e per la dignità, cosa che non accade traqueste creature; per conseguenza tra gli uomini
sorgono, su quel fondamento, l’invidia e l’odio, e,infine, la guerra». Inoltre, gli animali non hannol’uso della ragione e non sanno vedere il malenell’amministrazione degli affari pubblici, mentregli uomini «pensano di essere più saggi e più ca-paci di governare la cosa pubblica degli altri; que-sti si sforzano di riformare e di rinnovare, chi inun modo, chi in un altro, e portano alla divisionee alla guerra civile» (4).
La società umana è, dunque, fondata su un con-tratto sociale, un patto originario e artificiale sti-pulato tra gli uomini per porre fine allo stato dinatura, ossia a un’esistenza di precarietà segnatadal pericolo costante della morte. Solo ricono-scendosi come sudditi di un’autorità esterna esottomettendosi a un sovrano assoluto gli indivi-dui possono superare questo stato di guerra per-manente. Infatti, fine precipuo dello Stato, di cui ilsovrano è l’incarnazione, è il perseguimento dellapace e la comune difesa contro nemici esterni.
DALLA KANTIANA PACE PERPETUA ALLA GUERRAMORALE HEGELIANA
L’ideale della pace, come fine perseguibile erealizzabile, costituisce uno degli elementi costi-tutivi della concezione etica e politica di Kant(1724-1804), indiscutibilmente il più grande filo-sofo dell’era moderna. Non è un caso che il filo-sofo tedesco abbia dedicato dei celebri scritti allaquestione facendone un tema di assoluta centrali-tà nelle sue riflessioni. Il saggio «Per la pace per-petua» è un famoso scritto politico dove il dise-gno di una pace permanente comincia a delinearsicome progetto filosofico. Kant scrisse l’opera, nel1795, in seguito a un evento storico di grande ri-levanza: nella primavera di quello stesso anno,infatti, la pace di Basilea aveva sancito la fine del-la ostilità tra la Repubblica francese e la Prussiacon il conseguente riconoscimento dell’esistenzadello Stato rivoluzionario francese. Kant non na-scose il suo entusiasmo per quell’evento che raf-forzò una visione profondamente ottimistica dellastoria, che già echeggiava in diversi suoi scritti.Pur riconoscendo l’aggressività come elementofondante e ineliminabile della natura umana, eglimostrava una piena fiducia nell’ideale della pace.
Nella concezione kantiana, infatti, non c’è un ri-chiamo al valore etico che ogni uomo può scopri-re dentro di sé, quanto piuttosto la consapevolez-za della necessità di un progetto concreto, un or-dinamento giuridico che ponga fuori legge laguerra che egli stesso definisce «il male peggioreche affligge la società umana», «fonte di ogni ma-le e di ogni corruzione morale». La sua riflessioneè incentrata su tre articoli definitivi:• in ogni Stato la Costituzione civile deve essere A
NTHROPOS
109 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
Immanuel Kant.
repubblicana;• il diritto internazionale deve essere fondato su
un federalismo di liberi Stati;• il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle
condizioni dell’ospitalità universale.Non può esserci conflitto in uno Stato di diritto
basato sull’uguaglianza, la libertà e la divisione deipoteri. La Costituzione repub-blicana è la sola che possa dareorigine a una tale forma politicae porta con sé dei caratteri uni-ci perché, «oltre alla limpidezzadella sua origine, il suo esserescaturita dalla pura sorgentedell’idea di diritto, ha anchequella prospettiva di quell’esitodesiderato, la pace perpetua».Solo trasformando i sudditi incittadini protagonisti attivi dellapolitica, si eviteranno le guerre.Infatti, «se per decidere [...] sedebba esserci o no la guerra viene richiesto il con-senso dei cittadini, allora la cosa più naturale èche, dovendo decidere di subire loro stessi tutte lecalamità della guerra [...] rifletteranno molto primadi iniziare un gioco così brutto».
Perché la Costituzione repubblicana possa at-tuarsi pienamente e il progetto di pace globalediventare concreto, è necessario che i singoli Statistabiliscano nuovi rapporti internazionali; questo
perché la paura costante dell’aggressione impedi-sce a ogni Nazione di vivere secondo l’idea di di-ritto. Di qui l’idea di una federazione di liberi Statiche risponda all’esigenza razionale di ogni indivi-duo di uscire dallo stato selvaggio di guerra, fon-te di insicurezza e di pericolo.
Il terzo articolo sul diritto cosmopolitico delinea laforma dei rapporti tra gli Stati, garantisce la liberacircolazione di tutti i cittadini del mondo e il princi-pio universale dell’ospitalità.
La pace deve diventare il fine e la motivazionefondante di qualunque politica e deve esseresempre considerata un evento possibile, il finedella storia. È la natura stessa a garantire il futurosuccesso dell’ideale della pace, perché essa per-segue lo stesso scopo che la ragione fa persegui-re all’uomo; quindi, il suo operato favorisce l’atti-tudine morale dell’uomo e realizza il fine dellastoria anche ricorrendo a mezzi coattivi. L’uomo,infatti, «è costretto a essere, se non buono moral-mente, almeno un buon cittadino. Il problemadella Costituzione di uno Stato è risolvibile, perquanto l’espressione possa sembrare dura, ancheda un popolo di diavoli, purché siano dotati di in-telligenza» (5).
La riflessione kantiana sul tema della pace ac-quista ulteriore interesse nello scontro dialetticocon un altro grande filosofo, Wilhelm FriedrichHegel (1770-1831), il quale nega categoricamen-te la possibilità di una lega mondiale di Stati ca-pace di garantire la pace perpetua. Non è possi-bile costituire una repubblica dell’umanità, poi-ché non esiste uno spirito dell’umanità ma solouno spirito di popoli. Hegel concepisce gli Staticome grandi individualità che inevitabilmente en-
trano in conflitto tra loro, per-ché essendo mosse da volontàparticolari, si trovano recipro-camente «nella situazione dellostatus naturae» e non vi è pre-tore o mediatore che possa di-rimerne le controversie. Il sologiudice è lo Spirito universale,cioè la Storia, la quale ha comesuo momento strutturale laguerra. Di qui il limite inevita-bile del diritto statuale esternoe l’impossibilità della kantianapace perpetua, definita utopi-
stica e irrealizzabile. «Kant non si accorge», diceHegel, «che gli Stati sono individui e l’individuali-tà implica sempre negazione». Se un certo nume-ro di Stati stipula un’alleanza, si viene a creareun’unione che è per definizione un’individualitàe, in quanto tale, inevitabilmente «deve crearsiun’antitesi e generare un nemico». Nella conce-zione filosofica hegeliana non vi è una sempliceaffermazione della necessità della guerra ma una
ANTHROPOS - 110
Nella concezione filosofi-ca hegeliana non vi è unasemplice affermazione dellanecessità della guerra mauna vera e propria esalta-zione della stessa...Laguerra non acquista solo uncarattere di necessità maanche un alto valore etico
“
”
Wilhelm Friedrich Hegel.
vera e propria esaltazione della stessa. La guerranon è solo inevitabile, essa è essenziale per lasalute dei popoli, la cui identità è rafforzata pro-prio dal contrasto con il nemico. È vero che du-rante i periodi di pace la vita civile si espande dipiù ma «a lungo andare, è un ristagno per gli uo-mini». Il conflitto è dunque necessario e, anchese produce insicurezza, rafforza l’unità internadegli Stati: «Dalle guerre risultano non soltantorafforzati i popoli; ma Nazioni che sono in di-scordia in sé, acquistano, mediante guerre al-l’esterno, pace all’interno. Certamente dallaguerra proviene l’insicurezza nella proprietà, maquesta insicurezza delle cose è null’altro che ilmovimento, il quale è necessario». La guerra nonacquista solo un carattere di necessità ma ancheun alto valore etico. Con un famoso paragone, ilfilosofo tedesco sostiene che come «il movimentodei venti preserva il mare dalla putredine, nellaquale sarebbe ridotto da una quiete durevole»,allo stesso modo «la guerra preserva i popolidalla fossilizzazione alla quale li ridurrebbe unapace durevole o perpetua» (6).
LA GUERRA NEL MARXISMO
Lo studio sulla natura del conflitto e sulla suanecessaria presenza nella storia dell’umanità èpresente anche nella filosofia marxista, che attri-buisce al concetto di guerra una pluralità di signi-ficati. Non è possibile non rilevare nel pensiero diMarx(1818-1883). la profonda influenza della teo-ria militare elaborata da Carl Phillip Gottlieb vonClausewitz, Generale e teorico militare prussiano(1780-1831) che, attraverso una suggestiva simi-litudine, così definiva la guerra: «La guerra dun-que, non soltanto è un vero camaleonte, perché inogni concreto caso modifica la sua natura, ma èanche nel complesso delle sue manifestazioni, perle tendenze che la dominano, una meravigliosatrinità costituita dalla forza originaria del suo ele-mento: l’odio e l’ostilità, che vanno considerati co-me un cieco istinto naturale dal gioco delle proba-bilità e del caso, che la rendono un’attività liberadell’animo: e dal carattere subordinato di stru-mento della politica, per il quale rientra nel campodel puro intelletto». Il paragone con il camaleontedà proprio il senso della mutevolezza e dell’im-prevedibilità del conflitto ma dalla descrizioneemergono anche l’elemento contingente, la speci-ficità del contesto e il coinvolgimento delle pas-sioni umane. E Marx nell’elaborazione della suastrategia tiene conto proprio di questi aspetti. Inparticolare, l’insegnamento che il filosofo tedescotrae da Clausewitz è l’impossibilità di condurreuna guerra mossa da finalità politiche senza coin-volgimento popolare e proprio del coinvolgimento
popolare farà l’elemento sul quale basare il suc-cesso della sua rivoluzione sociale.
Marx non considera la guerra sotto una luce ne-gativa anche se la concepisce solo nel quadro dellarivoluzione proletaria, come strumento di libera-zione delle classi oppresse e come mezzo per l’in-staurazione di un regime di pace all’interno dellasocietà comunista.
Nell’ambito della concezione materialistica dellastoria, la guerra dunque non è male dal punto divista etico, in quanto distruzione di valori morali,ma può essere un elemento di progresso perl’umanità dal momento che determina un’accele-razione delle trasformazioni sociali. Il motore del-lo sviluppo storico risiede non negli ideali o nellenorme giuridiche bensì nelle condizioni materialied economiche della società. La lotta di classe ap-pare un elemento fisiologico e, dunque, funziona-le all’evoluzione e al progresso sociale, la rivolu-zione un esito inevitabile.
NIETZSCHE
«Io conosco la mia sorte, si legherà al mio nomeil ricordo di una crisi, come non ce ne fu un’altra A
NTHROPOS
111 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
Karl Marx.
sulla terra [...]. Io non sono un uomo, sono dina-mite [...] io contraddico come mai è stato con-traddetto», sta in queste celebri parole la profeziaforse più spaventosa del XIX secolo. Ben oltre iconfini della filosofia, la figura di Friedrich Nietz-sche (1844-1900) si staglia sul panorama cultu-rale europeo come il pensatore più influente delloscorso secolo. Non troviamo nei suoi scritti unariflessione sulla guerra come fenomeno storicospecifico ma il motivo del conflitto riecheggia inconcetti fondamentali della filosofia nietzschiana,basti pensare alla concezione della realtà comecaos dionisiaco o della volontà di potenza. Dioni-siaco e apollineo sono i due impulsi dell’animagreca; il dionisiaco è una sorta di forza vitale, didivenire caotico, l’apollineo è il principio dellaforma che cerca di dare ordine a tale divenire. Inogni creazione artistica vi è la fondamentale pola-rità dello spirito apollineo e dionisiaco. L’artistaapollineo interpreta la vita come fosse un sogno;quello dionisiaco vive come se fosse in costantestato di ebbrezza. Si tratta di due aspetti essen-ziali in ogni opera creativa e in ogni spiritualità,perché la forza dionisiaca ha bisogno di esseremoderata dal suo contrario: «...lo sviluppo del-l’arte è legato alla duplicità dell’apollineo e deldionisiaco: alla stessa stregua in cui la generazio-ne dipende dalla dualità dei sessi, attraverso unacostante lotta e un rappacificamento che avvienesolo periodicamente». Il mondo è pervaso dall’al-ternanza di questi opposti, Apollo e Dioniso, ossia
caos e forma, divenire e stasi, guerra e pace, dovela guerra è l’impulso incontrollato che distruggel’ordine mentre la pace significa creazione di or-dine e di armonia. Questa tensione conflittuale èanche alla base del concetto della volontà di po-tenza, caratteristica basilare del Superuomonietzschiano, ossia l’uomo dionisiaco, il folle chevive senza mediazioni, superando i limiti tra sestesso e il mondo, tornando a immergersi nellanatura di cui è parte indivisibile. La volontà di po-tenza può esprimersi pienamente solo di fronte aun opposto: «la volontà cerca quel che le si con-trappone ...L’appropriazione e l’assimilazione èanzitutto un voler sopraffare, un formare, un mo-dellare e rimodellare, finché il vinto sia passatointeramente sotto il potere dell’aggressore accre-scendolo». Essa ha bisogno dello scontro, perchéè attraverso di esso che il superuomo si definiscee si rafforza, diventando l’emblema di una razzasuperiore che si distinguerà dalla massa. «E Zara-thustra così parlò al popolo: Io vi insegnerò checos’è il Superuomo. L’uomo è qualcosa che deveessere superato. [...] Che cos’è la scimmia perl’uomo? Qualcosa che fa ridere, oppure suscita undoloroso senso di vergogna. La stessa cosa saràquindi l’uomo per il Superuomo: un motivo di risoo di dolorosa vergogna. [...] Il Superuomo, ecco ilvero senso della terra. La nostra volontà quindidica: il Superuomo diventi il senso della terra» (7).
Il Superuomo è colui che vive come se tutto do-vesse tornare e diviene misura di tutte le cose,perché dalla sua volontà di potenza ogni cosa as-sume il suo senso. Il Superuomo è, dunque, coluiche si riappropria di quella forza dominatrice chel’uomo ha perso nei secoli a causa della moraliz-zazione cristiana che ha avvelenato l’anima umanainsegnandogli l’umiltà al posto dell’orgoglio, lapietà al posto del dominio. Di qui la riflessione at-torno a un dirompente evento, la morte di Dio, cheNietzsche interpreta in coincidenza dell’affermarsidella cultura illuminista, con la conseguente seco-larizzazione della società, il trionfo dello «spiritolibero» e dell’amore per la verità. La morale andràincontro al suo inevitabile destino, il nichilismo,che abbatterà tutti i supremi valori svuotandoli disignificato e condannandoli al nulla. La morale cri-stiana, animata dal risentimento, ha prodotto dif-fidenza verso la realtà e ha condannato se stessaalla violenza della propria volontà di verità. Infatti,saranno proprio i «devoti», gli «esecutori dellamorale cristiana» a uccidere il Dio della morale. E ildilagante nichilismo condurrà a questo evento su-premo e cruciale della modernità. Dio è stato ucci-so dagli uomini, e questo è il presagio di un ri-scatto epocale che porterà all’avvento del Supe-ruomo, il quale non ha più bisogno delle rassicu-ranti favole religiose perché è spirito dionisiacoche accetta la vita nella sua intrinseca mancanza di
ANTHROPOS - 112
Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz.
senso. Quando Nietzsche parla della morte di Dio,non intende solo il Dio cristiano, ma tutte le divi-nità, e con esse tutti gli ideali tradizionali. Nietz-sche coglie pienamente l’angoscia dell’uomo con-temporaneo che, di fronte al crollo degli idealimorali, religiosi e metafisici, ha dinanzi a sé unvuoto assoluto e incolmabile. È la diagnosi di una«fragile, già frantumata età di trapasso», un corpomalato che produce i germi che piano piano lo di-struggeranno, un corpo morente affetto da quellapericolosa tendenza all’eccesso che i greci chia-mavano hybris, di cui l’esito nichilistico è la con-danna annunciata, il trionfo del nulla, l’afferma-zione del non-senso.
Pur considerando il Cristianesimo la più grave«malattia psichica» dell’uomo occidentale, Nietz-sche non crede sia funzionale distruggerlo, perchél’ideale cristiano si pone in rapporto antagonisticocon lo spirito dei Superuomini, i quali necessitanodi «avversari forti per diventare forti». Ritornasempre il motivo del conflitto nel pensiero diNietzsche, la necessità di mantenere l’opposizionetra i diversi elementi che permeano la realtà, per-ché dalla loro lotta trae forza lo spirito del Super -uomo. «Dioniso contro il Crocifisso: eccovi l’anti-tesi. Non è una differenza in base al martirio - so-lo esso ha un altro senso. La vita stessa, la suaeterna fecondità e il suo eterno ritorno determina-no la sofferenza, la distruzione, il bisogno di an-nientamento [...]» (8). La differenza sta nel fattoche la morte di Gesù enfatizza l’innocenza dellavittima, mentre la morte del dio pagano enfatizzal’innocenza degli uccisori, nonché la colpa dellavittima. Dioniso racchiude in sé tutte le passioniumane, persino il folle desiderio di distruggere. Èl’esaltazione stessa della violenza, che secondo ilfilosofo tedesco non deve essere contenuta inquanto fondamentale per la cultura umana. Vi silegge il trionfo di una «morale aristocratica» cheammette le peggiori forme di violenza, come uninevitabile pegno che la società deve pagare per ilpieno affermarsi della volontà di potenza.
CONCLUSIONI
La riflessione filosofica dalle origini fino all’etàcontemporanea mostra come il tema del conflittosia una costante nelle opere di molti grandi pen-satori. Sia esso una riflessione sulla pace, comeesortazione a trovare una soluzione possibile epermanente ad antagonismi e contrasti, sia essoun’indagine sulla natura della lotta armata e sulsuo carattere inevitabile e funzionale al camminostorico, certo è che il motivo della guerra, con isuoi molteplici significati e risvolti, mostra la suaessenza di elemento immutabile e costante del-l’esperienza umana. La guerra può essere consi-
derata come la matrice della nostra storia e, quin-di, è quanto mai attuale e significativo il concettoeracliteo del polemos come «padre di tutte le co-se». D’altro canto per millenni il contatto con cul-ture e società diverse è avvenuto attraverso ilconflitto, quasi esso fosse una forza inevitabileverso il cambiamento e l’evoluzione. Se nella teo-rizzazione hobbesiana lo Stato viene a essere unrecinto in grado di contenere questo istinto in-controllato verso la violenza e la sopraffazione,Horkheimer e Adorno nella «Dialettica dell’Illumi-nismo» hanno mostrato come la ratio sia lo stru-mento di dominio dell’uomo nei confronti della
natura e di se stesso. L’Illuminismo, nato con«l’obbiettivo di togliere agli uomini la paura e direnderli padroni. Ma la terra interamente illumi-nata splende all’insegna di trionfale sventura», simanifesta come logica di dominio. In «Eclisse del-la ragione», Horkheimer osserva che «la follia col-lettiva imperversante oggi, dai campi di concen-tramento alle manifestazioni apparentemente piùinnocue della cultura di massa, era già presente ingerme nell’oggettivazione primitiva, nello sguar-do con cui il primo uomo vide il mondo come unapreda». Il desiderio dell’onnipotenza spinge gliuomini a usare la ragione come strumento di do-minio, senza cercare la verità delle cose. La ragio-ne diventa così «utensile universale», un’armacontro se stessi e gli altri: «quanti più meccanismio congegni inventiamo per dominare la natura,tanto più dobbiamo far loro da schiavi se voglia- A
NTHROPOS
113 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
Friedrich Nietzsche.
mo sopravvivere», un’affermazione quanto maiattuale che evidenzia la fragilità della vita umanae l’ipotesi reale di un suicidio collettivo sotto for-ma di catastrofe nucleare o ambientale. La ratio,concepita come strumento per proteggerci dallaviolenza della natura, diviene strumento di domi-nio, razionalizzazione del pole-mos. Non è un caso che l’uomoabbia continuato a belligerareproprio in nome della ragione eabbia giustificato tramite essale violenze più efferate (il co-munismo sovietico, il nazismo).Si è creato un circolo vizioso dacui la civiltà umana non riesce auscire: da una parte la consa-pevolezza che la natura è lasorgente della guerra; dall’altra l’ammissione chela ragione, che dovrebbe proteggerci da essa, èdiventata lo strumento per compierla e per rego-larizzarla. Non è più sufficiente, dunque, rifugiarsisotto l’ala protettiva di quel grande «Leviatano» dicui parlava Hobbes, perché esso stesso è il pro-dotto della razionalità umana che istituzionalizzae legalizza la violenza. C’è forse un seme che ri-
nasce e germoglia continuamente su questa terraed è qualcosa che fa parte di noi, della nostra es-senza umana, qualcosa di ineliminabile. In quasitutte le concezioni filosofiche emerge questoaspetto della natura, questa tendenza all’afferma-zione di sé, alla conquista del potere e del domi-no sugli altri. Persino quei filosofi che hanno de-stato in noi la speranza e che attraverso i loroscritti, permeati da un profondo ottimismo, ci
hanno ispirato la fede nellapossibilità di costruire unmondo migliore, basato sul-l’armonia e sulla concordia, daltranquillitas ordinis, in quantoaspirazione universale degliuomini, da Sant’Agostino alprogetto kantiano di pace per-petua, hanno ammesso l’innatamalvagità dell’uomo e la ten-denza all’aggressività come
elemento fondante e insopprimibile della naturaumana. Oggi appare assurdo anche solo ipotizza-re la possibilità di un reale cambiamento, cheporti alla costituzione di una società basata sullapace, un ideale meramente illusorio e utopistico.Non è pessimismo, sono i corsi e i ricorsi storiciche ci hanno insegnato che il conflitto è nel natu-rale svolgersi degli eventi. La guerra c’è sempre
ANTHROPOS - 114
La ratio, concepita comestrumento per proteggercidalla violenza della natura,diviene strumento di domi-nio, razionalizzazione delpolemos
“
”
La battaglia di Legnano, 29 maggio 1176.
stata, perché la natura umana è animalesca; silotta per l’affermazione del proprio egoismo e in-teresse e ci si serve dello strumento intellettivo,che dovrebbe essere il peculiare elemento di di-stinzione dalle specie inferiori, non per elevarsi efare cose buone ma per legalizzare il sopruso e laviolenza a proprio esclusivo vantaggio.
Da sempre l’uomo ha cercato di legittimarel’uso delle armi celando dietro il paravento di no-bili ed elevati ideali il reale motivo del ricorso allaviolenza: il desiderio di potenza, l’affermazione disé, la brama di salire in vetta all’Olimpo del mon-do. Paradossalmente è stato proprio Nietzsche,nel suo folle delirio, a denunciare l’utilizzazionevile e ipocrita di valori religiosi, etici e umani perperpetrare le peggiori nefandezze, ciò che oggichiamiamo il «politicamente corretto», per dirlacon René Girard «uno sfruttamento spesso disgu-stoso della nostra preoccupazione vittimaria»,tanto che «perfino i ricorsi più sensazionali allaviolenza tendono oggi a mascherarsi da virtuosebattaglie in difesa delle vittime» (9). Nietzscheodiava questa perversione anche se poi la sua fol-lia ne ha distorto il senso scambiandola per l’es-senza stessa del Cristianesimo. Egli ha saputovedere, però, che non esiste la compassione au-tentica, gli uomini non ne sono capaci, se non inrare eccezioni. L’unica cosa che i nostri occhipossono vedere sono «le parodie degli intrigantidel politicamente corretto», e ciò ha portato il fi-losofo a negare «la possibilità di una sensibilitàper le vittime che, anziché essere una strategiadel ressentiment, fosse genuina» (10).
In realtà, vi sono state nel corso della storiaopere umane eccezionali che hanno dimostratoche nel cuore dell’uomo alberga un profondosentimento di solidarietà e di giustizia, ed è unsentire vero e genuino, a differenza di quanto so-steneva Nietzsche. Si tratta però di un valore chenon è mai riuscito a trionfare e a imporsi definiti-
vamente, anche se ha mantenuto intatta nei secolila sua validità e la sua forza resistendo persinoalla potenza distruttiva della genealogia nietz-schiana, il famoso «martello» usato per la demi-stificazione della morale occidentale. In particola-re, la condizione attuale ci fa avvertire in manierainequivocabile il fallimento di ogni sforzo teso ariaffermare il valore indiscutibile della vita, questoperché la condizione umana della nostra epoca èsegnata da un paradosso perverso e all’apparenzaineliminabile: «Quello in cui viviamo» afferma Gi-rard «è il mondo che salva il maggior numero divittime ma, a causa dei nostri ostinati conflitti edei mezzi di distruzione sempre più potenti di cuidisponiamo, il nostro è anche il mondo che lemoltiplica quasi all’infinito, cosa per cui noi ci di-sprezziamo» (11).
Sara GreggiGiornalista
BIBLIOGRAFIA
(1) Ubaldo Nicola: «Antologia illustrata di Filosofia»,Giunti Editore, 2008.(2) Ubaldo Nicola, op.cit.(3) N. Machiavelli: «Il Principe», Cap. XIV, Il Principe ele armi.(4) T. Hobbes: «Il Leviatano», Laterza, 1997.(5) G. Mancini, S. Marzocchi, G. Vicinali: «Corso di Filo-sofia», diretto da Salvatore Veca, Bompiani, 1995.(6) N. Abbagnano, G. Foriero: «Protagonisti e testi dellaFilosofia», Paravia, 1996.(7) Ubaldo Nicola, op.cit.(8) René Girard: «Il caso Nietzsche. La ribellione fallitadell’Anticristo», Marietti, 2009.(9) Ubaldo Nicola, op.cit.(10) Ubaldo Nicola, op.cit.(11) Ubaldo Nicola, op.cit. A
NTHROPOS
115 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
La battaglia delle Ardenne, Seconda Guerra Mondiale.
Guerra di trincea durante la Prima Guerra Mondiale.
ANTHROPOS - 118
L’operazione «United Shield» fu caratterizzatada numerosi aspetti assolutamente innovativi (ta-bella 1) rispetto sia allo sviluppo delle pur nume-rose precedenti Peace Support Operations (PSO),sia alla diversificata partecipazione ad esse delnostro Esercito (1). Fra taliaspetti, l ’ inserimento dellacomponente Esercito in unaforza da sbarco interforze ecombinata e il primo impiegodi sole unità composte da vo-lontari a ferma prolungata. No-nostante le significative novitàche caratterizzarono lo «UnitedShield»/«Ibis 3», questo impe-gno dell’Italia e del suo Esercitoè poco noto (2). Molteplici sonole ragioni di tale «oblio» o diquesta rimozione dalla co-scienza collettiva. A livello in-ternazionale, l’insuccesso di«UNOSOM II» rappresentò la prima vera sconfittapolitica e militare dell’ONU. Le aspettative ripostesu un più incisivo ed efficace ruolo di tale Orga-nizzazione, nella risoluzione delle conflittualitàcontingenti e nella costruzione di «un nuovo or-
dine mondiale» nel periodo successivo alla Guer-ra Fredda, furono disilluse in maniera cocente. Alivello nazionale, la partecipazione allo «UnitedShield», pur rappresentando un indubbio succes-so, politico e militare, non fu in grado di far di-menticare alla «opinione pubblicata» italiana lepolemiche interne che avevano accompagnato lapresenza del nostro contingente in Somalia, du-rante lo sviluppo delle precedenti «Ibis 1» e «Ibis
2», dal 1992 al 1994. «Opinio-ne pubblicata» che è cosa bendiversa dall’«opinione pubbli-ca», anche se la prima ha qua-si sempre la presunzione dirappresentare e/o di formarela seconda. A ciò si aggiungache, in ambito militare, si èsempre un po’ restii a parlaredella partecipazione a una«manovra in ritirata» - che è lapiù difficile manovra da attua-re - a meno che essa non sia ilpreludio di una successivacontroffensiva condotta consuccesso. Ma questo non si è
verificato in Somalia. A quindici anni di distanzasembra, quindi, opportuno e necessario colmareil vuoto conoscitivo sulla «Ibis 3», per evidenziar-ne gli aspetti innovativi e per attribuire il giustomerito a chi vi ha preso parte. Non ultimo, per ri-cordare idealmente i 16 italiani militari e civiliche sono caduti, dal 1992 al 1995, in terra so-mala e il cui sacrificio non deve essere conside-rato vano (3).
Operazione «Ibis 3» o «Somalia 3» è la denominazione italiana dell’operazione multinazionale chiamata«United Shield» («Scudo Unito»). L’operazione è stata sviluppata per consentire la ritirata del contingente dei«Caschi Blu» dell’ONU dalla Somalia, nel 1995.Con lo sviluppo dello «United Shield» aveva termine l’operazione «UNOSOM II» e con essa le speranze dellacomunità internazionale di avviare un processo di pacificazione in quella terra. Problema tuttora insoluto, icui effetti negativi agitano ancora quell’area e generano rischi per la sicurezza internazionale.
SOMALIA 1995:OPERAZIONE «IBIS 3»
L’operazione «UnitedShield» fu caratterizzata danumerosi aspetti assoluta-mente innovativi... Fra taliaspetti, l’inserimento dellacomponente Esercito in unaforza da sbarco interforze ecombinata e il primo impie-go di sole unità composteda volontari a ferma pro-lungata
“
”
In apertura.Un VCC-1 a Mogadiscio (Ibis 2).
Un’operazione dimenticata
Le opinioni espresse nell’articolo riflettono esclusi-vamente il pensiero dell’autore.
IL PROLOGO
Il ripiegamento del contingente ONU dalla So-malia non è stato il frutto di una decisione im-provvisa, presa sotto la spinta del precipitare de-gli eventi, come si potrebbe pensare. La Risolu-zione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU (UN Se-curity Council Resolution - UNSCR) n. 814 del 26marzo 1993, che diede l’avvio all’operazione«UNOSOM II», era il risultato di un’attività diplo-matica (4) che prevedeva quale termine di taleoperazione il marzo del 1995. Quindi, l’orizzontetemporale di questa operazione era stato fissato«ab origine» in due anni. Tutte le UNSCR che so-no state emanate successivamente, inoltre, han-no più volte confermato tale scadenza (5). Quelloche muterà radicalmente nel 1995, rispetto alle
previsioni del marzo 1993, sarà lo scenario checaratterizzerà la fine di «UNOSOM II». La man-canza di progressi nel processo di riconciliazionenazionale, anzi l’acuirsi delle rivalità fra le variefazioni somale, l’incremento degli attacchi alleforze dell’ONU e gli effetti di errori politici e mili-tari fatti operazione durante, resero sempre piùdifficile l’acquisizione degli obiettivi posti a basedell’operazione stessa. Questi aspetti originaronola decisione di numerosi Stati contributori di riti-rare i propri contingenti militari e/o di poliziadalla Somalia fin dai primi mesi del 1994. Ritirogiocoforza accettato dal Consiglio di Sicurezzadell’ONU e formalizzato con l’emanazione del-l’UNSCR n. 897 del 4 febbraio 1994. Così, la Tur-chia a gennaio, gli Stati Uniti e la Tunisia a feb-braio e l’Italia a marzo - unitamente ad ArabiaSaudita, Belgio, Emirati Arabi Uniti, Francia, Ger-mania, Kuwait e Norvegia - lasciarono la Somalia.A fine marzo, quindi, l’entità complessiva delcontingente ONU era di circa 19 700 soldati, benal di sotto dei 22 000 previsti da quella Risolu-zione e dai 26 000 presenti all’inizio del 1994.Tali ritiri generarono, e non poteva essere checosì in quello scenario, un’ulteriore accelerazionedella conflittualità locale, una progressiva e nettariduzione delle attività dell’ONU e delle aree sottoil suo controllo e, infine, il ritiro o il ridimensio-namento dei contingenti di altri Stati (6). L’ONUlascerà la Somalia dopo aver vinto la battagliacontro l’eccidio di molti somali per fame, maperdendo nettamente quella per la ricostruzionedi quello Stato.
L’OPERAZIONE «UNITED SHIELD»
(Sequenza degli avvenimenti in tabella 2). Il Consi-
ANTHROPOS
119 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
LE ASSOLUTE NOVITÀDELLO «UNITED SHIELD»/«IBIS 3»
• Costituzione di una Combined Joint Task Forcecon unità navali e terrestri di 7 Stati non membridi una stessa alleanza.
• Partecipazione di unità italiane (della Marina e del-l’Esercito) ad una forza anfibia combinata.
• Formazione della componente Esercito della forzaanfibia basata su unità paracadutiste.
• Impiego di unità italiane composte soltanto da vo-lontari a ferma prolungata.
• Amalgama e addestramento interforze sviluppatoa bordo delle navi, navigazione durante.
• Sinergica e sincrona preparazione politica e mili-tare dello sbarco.
• Impiego operativo di unità italiane in uno sbarcoanfibio notturno e in ambiente ostile.
• Sbarco effettuato allo scopo di realizzare una cor-nice di sicurezza per il ripiegamento e imbarco diforze amiche.
• Impiego di innovativi sistemi d’arma e materiali.• Reimbarco della forza anfibia sotto la pressione di
forze ostili.
Tab. 1
OPERAZIONE «UNITED SHIELD»/«IBIS 3»- Sequenza degli Avvenimenti -
• 4 novembre 1994, emanazione della UNSCR n. 954.• 16 dicembre 1994, gli Stati Uniti dichiarano di voler partecipare e di guidare lo «United Shield».• 10 gennaio 1995, il personale del «Nembo», «Col Moschin» e del «Leonessa», con i relativi materiali/mezzi/muni-
zionamento, si imbarcano su Nave «San Giusto» nel porto di Livorno.• 11 gennaio, il personale delle «Guide», con i relativi materiali/mezzi/munizionamento, si imbarca su nave Nave
«San Giusto» nel porto di Napoli.• 11 gennaio, il Consiglio dei Ministri italiano decide la partecipazione nazionale all’operazione.• 12 gennaio, il personale/materiali/mezzi/munizionamento di «Italfor Ibis 3» giunge a Brindisi, inizia l’imbarco sulle
navi «Garibaldi» e «San Giorgio».• 17 gennaio, il Governo italiano emana il Decreto Legge n. 11 che autorizza la partecipazione nazionale all’operazione.• 20 gennaio, il 26° Gruppo Navale, con a bordo «Italfor Ibis 3», parte dal porto di Brindisi per la Somalia.• 3 febbraio, il 26° Gruppo Navale giunge nelle acque di Mombasa (Kenya).• 8 febbraio, tutta la Forza Multinazionale è schierata nelle acque di fronte la città di Mogadiscio.• notte fra il 27 e il 28 febbraio, la forza da sbarco italo-statunitense prende terra e realizza la necessaria cornice di
sicurezza fra il Porto Nuovo e l’aeroporto della città.• 1 marzo, viene ultimato l’imbarco del personale di «UNOSOM II».• 2 marzo, viene ultimato il reimbarco del personale della forza anfibia italo-statunitense.• 3 marzo, il 26° Gruppo Navale lascia le acque prospicienti Mogadiscio e inizia la navigazione per il ritorno in Italia.
Breve sosta nel porto di Eilat ( Israele).• 21 marzo, il 26° Gruppo Navale ritorna a Brindisi.• 23 marzo, il personale del 183° reggimento paracadutisti «Nembo» sbarca da Nave «San Giorgio» nel porto di Livorno.
Tab. 2
ANTHROPOS - 120
glio di Sicurezza dell’ONU - con l’emanazione dellasua ultima Risoluzione per la Somalia, la n. 954 del4 novembre 1994 - chiese agli Stati membri di for-nire assistenza per consentire la ritirata delle forzedi «UNOSOM II» ancora lì dislocate. Questo appellofu accolto da Stati Uniti, Italia, Francia, Gran Breta-gna, Malesia e Pakistan. Gli Stati Uniti dichiararonoufficialmente di voler partecipare il 16 dicembre1994. Il Consiglio dei Ministri italiano deliberò lanostra partecipazione l’11 gennaio 1995 e formaliz-zò tale decisione con il Decreto Legge 17 gennaio1995 n. 11. Con questo Decreto, veniva autorizzatala formazione di un contingente nazionale compo-sto da unità della Marina Militare e dell’Esercito. Taledecisione fu una delle ultime prese dal primo Go-verno Berlusconi. Lo «United Shield» si sviluppò, adifferenza di «UNOSOM II», sotto la direzione politi-ca generale del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che
delegò la direzione diretta agli Stati Uniti. A livellodella forza militare, venne costituita, veramente inpoco tempo, una Combined Joint Task Force (CJTF)posta sotto comando statunitense. Per svilupparetale operazione, quindi, si diede vita a un complessodi unità multinazionali e interforze «ad hoc». Questaè la prima delle rilevanti novità dell’operazione. Ri-levanza che può essere apprezzata se si considerache solo sul finire degli anni ’90, la NATO iniziò ateorizzare, nell’ambito del suo «Nuovo ConcettoStrategico», la formazione delle Combined JointTask Force. Formazioni ritenute le più idonee per farfronte efficacemente alla conflittualità tipica del no-stro tempo. Tuttavia, mentre le CJTF della NATOnacquero nell’ambito di consolidate dottrina e pro-cedure comuni, la Forza Multinazionale (FM) dello«United Shield» fu costretta a «inventare» organiz-zazione e procedure per consentire a unità di Statimolto diversi di cooperare fra di loro. Analogo pro-blema a livello delle unità italiane. Infatti, non c’era-no procedure interforze che definivano comuni mo-
dalità in caso di sbarco anfibio condotto da unitàdell’Esercito e della Marina. Al Comandante dellaCJTF fu attribuita l’autorità di esercitare il controllotattico sulle forze assegnate dai vari Stati. Tali forzefurono raggruppate in due componenti:• navale, composta da 23 unità, di cui 9 statuni-
tensi, 5 italiane ( costituenti il 26° Gruppo Nava-le), 3 francesi, 3 pakistane, 2 malesi e 1 britan-nica; fra queste, 2 incrociatori (1 portaeromobilie 1 missilistico), 1 cacciatorpediniere, 4 fregate(di cui 3 missilistiche), 1 corvetta missilistica,più navi d’assalto anfibio e logistiche; inoltre, sutale componente erano imbarcati 86 fra aerei edelicotteri;
• da sbarco, composta dai Marines della 13a Ma-rine Expeditionary Unit (MEU), dai fucilieri dimarina del «San Marco», dai paracadutisti della«Folgore» e dai «Cavalleggeri Guide»; la forzada sbarco, perno della manovra, sarebbe stata,quindi, esclusivamente italo-statunitense.Il supporto aereo era anche assicurato da aerei
dislocati in Kenia, fra i quali aerei da trasportodell’Aeronautica Militare italiana. Nella fase finaledell’operazione, anche una Brigata pakistana e unbattaglione del Bangladesh di «UNOSOM II», chepresidiavano l’ultima linea di difesa nella città diMogadiscio, furono posti sotto il controllo tatticodel Comandante della CJTF.
Complessivamente, la FM era formata da 16 485militari, dei quali 8 569 statunitensi. Il contingen-te italiano era per qualità e quantità il secondodella FM e il vice comando della CJTF fu attribuitoall’Italia, al Comandante del 26° Gruppo Navale(GN). Questo GN era particolarmente significativo.Era composto dall’unica «portaerei» italiana, la«Garibaldi» che imbarcava 10 elicotteri e 3 cacciaa decollo verticale Harrier «AV-8 B», alla loro pri-ma missione operativa, la fregata missilistica «Li-beccio», 2 navi anfibie, la «San Giorgio» e la «SanMarco» e il rifornitore di squadra «Stromboli». SulGN saranno imbarcati 350 marò del «San Marco»,31 incursori del «Comsubin» ed i 198 militari del-l’Esercito. L’intero contingente italiano sarà com-posto da circa 2 000 uomini.
A chi ricorda o studierà in futuro i contenuti e itoni di quanto fu detto e scritto in Italia, negli an-ni 1992-1994, sui nostri rapporti con l’ONU e gliStati Uniti a causa dell’intervento in Somalia, lanostra successiva adesione allo «United Shield» hao avrà il sapore della «inspiegabilità». Infatti,sembra inspiegabile che, per un’ulteriore opera-zione da condurre ancora in Somalia, ancora sottola direzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU einsieme agli statunitensi:• un Governo italiano, ancorché di composizione
politica diversa dal precedente, si dichiari di-sponibile a partecipare;
• quella Organizzazione Internazionale non frap-
Contatti con la popolazione civile (Ibis 2).
ANTHROPOS
121 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
ponga difficoltà alla nostra partecipazione;• le Forze Armate statunitensi accettino di ritor-
nare a operare strettamente con i militari italia-ni, ai quali affidano, inoltre, un ruolo operativosignificativo;
• gli Stati Uniti, leader dell’operazione, affidino ilvice comando della FM ad un Ammiraglio italiano.Questo complesso di eventi apparentemente
«inspiegabili» non può essere ascritto solo alnuovo clima politico instaurato dal Governo elettodopo il nostro disimpegno dalla Somalia (primoGoverno Berlusconi).
Forse e soprattutto, la percepita «inimicizia»dell’ONU e degli Stati Uniti nei nostri confronti -tanto enfatizzata nelle dichiarazioni e sullastampa nazionale dell’epoca - non era tale nellarealtà dei fatti (7). Ci fu sicuramente, da partenostra, un’enfatizzazione eccessiva, un po’ pro-vinciale, delle differenti visioni politiche e milita-ri su come tradurre «sul terreno» un mandatointernazionale non sempre chiaro e realistico.Difficoltà, è bene precisarlo, che ebbero anchealtri Stati e relativi contingenti nazionali. Enfa-tizzazione, forse, anche utilizzata per coprirequalche errore politico e militare commesso nel-l’impostazione e nello sviluppo della nostra par-tecipazione (8). In ogni caso, tale presunta «ini-micizia» fu chiaramente smentita, nel volgere dipochi mesi, dal ruolo e dal rilievo che l’ONU e gliStati Uniti attribuirono alla nostra partecipazioneallo «United Shield».
LA COSTITUZIONE DI ITALFOR IBIS 3
L’assolvimento del compito assegnato all’intero26° Gruppo Navale e alla componente Esercito inesso inquadrato, implicò l’esecuzione di un’asso-luta novità per le unità delle due Forze Armate:uno sbarco anfibio, per di più notturno e in uncontesto ostile. Particolarità nella particolarità, a
questo sbarco parteciparono per l’Esercito dei pa-racadutisti.
Le unità designate a contribuire alla costituzionedella componente Esercito furono:• 183° reggimento paracadutisti «Nembo», con
sede a Pistoia;• 9° battaglione d’assalto paracadutisti «Col Mo-
schin», con sede a Livorno;• reggimento «Cavalleggeri Guide» (19°), con sede
a Salerno;• 5° reggimento AVES «Rigel», con sede a Casarsa
della Delizia (PN);• 11° reggimento trasmissioni «Leonessa», con
sede a Civitavecchia (RM).Secondo le prime ipotesi di impiego, la compo-
nente Esercito doveva basarsi, essenzialmente, suun complesso minore paracadutista su «VCC-1»,rinforzato da due Distaccamenti Operativi (D.O.) diincursori paracadutisti, da una minore unità diblindo «Centauro» e da alcuni elicotteri d’attacco.Tutte queste unità sarebbero state alle dirette di-pendenze del Comandante del 26° GN, che si sa-rebbe avvalso di un nucleo di collegamento/coor-dinamento per esercitare la sua autorità su di es-se. Tenuto conto della complessità dell’azione dasviluppare, anche in un innovativo ambito inter-forze e combinato, e delle possibili difficoltà delComandante del 26° a «gestire» direttamente lavariegata componente Esercito, il Comando del183° reggimento paracadutisti «Nembo» proposeallo Stato Maggiore dell’Esercito (SME) di dar vita aun gruppo tattico (gr. tat.) ove includere e raccor-dare tutto il contributo della Forza Armata. In talmodo, inoltre, il Comandante del gr. tat. avrebbepotuto:• affiancarsi al Comandante del 26° Gruppo Nava-
le, diventandone il consulente per le operazioniterrestri;
• decidere quali unità dipendenti distaccare peruna funzionale articolazione della forza dasbarco. Lo SME accolse quella proposta e ilgruppo tattico, al quale fu attribuita la denomi-nazione di «Italfor Ibis 3», assunse la strutturariportata in tabella 3.I tempi di concezione e organizzazione di «Ital-
for Ibis 3» furono estremamente ridotti e ancheconvulsi. Basti pensare che, nonostante i primipreavvisi d’impiego arrivassero alle unità solo adicembre 1994 inoltrato, si riuscì a imbarcare ireparti paracadutisti e delle trasmissioni, con i re-lativi mezzi, materiali e munizionamento, a Livor-no il 10 gennaio 1995. Questo, grazie allo spiritodi sacrificio del personale, a tutti i livelli, che nontenne assolutamente conto del periodo delle fe-stività natalizie e di fine anno. In vero, nella storiarepubblicana del nostro Esercito, la maggior partedegli impegni operativi sviluppati dalle nostreunità, sia sul territorio metropolitano sia fuori di
Tab. 3
esso, sono stati iniziati e condotti in coincidenzadei fine settimana e di tutte le festività laiche ereligiose del calendario. È una singolare coinci-denza che è necessario sottolineare a chi poco sadel mondo militare e degli oneri che derivano dal-l’indossare un’uniforme.
Può creare qualche perplessità il fatto che «Ital-for Ibis 3» si sia imbarcato prima della formaledecisione governativa di partecipare all’operazio-ne. Come sempre accaduto, e quasi sicuramentecontinuerà ad accadere, le formali decisioni poli-tiche del nostro Governo/Parlamento vengonoadottate dopo l’inizio delle attività militari di pia-nificazione e approntamento delle unità e, anche,del loro movimento verso il futuro Teatro di Ope-razione. Questa realtà trova una sua spiegazionenel fatto che lo sviluppo delle attività militari ri-chiede, per la loro elevata complessità, molto piùtempo di quello prevedibile per le attività politi-che. Quindi, per far sì che alla decisione politicasegua, dopo poche ore o giorni, l’inizio della suaattuazione, è necessario che gli Stati Maggiori In-terforze e di Forza Armata ricevano, anche in viainformale, dalle Autorità gover-native dei preavvisi sui loro in-tendimenti. È da ritenersi nor-male, pertanto, che i militariavviino le loro attività moltotempo prima che la decisionepolitica di partecipazione aun’operazione sia adottata nellesedi istituzionali.
I VOLONTARI DI «IERI»
Le unità predesignate a fornire il personale per ilgr. tat. furono scelte sulla base di un principio deltutto nuovo: essere in grado di destinare all’ope-razione personale, sia pure di leva, a ferma pro-lungata. Questa novità non riguardava, ovviamen-te, gli incursori paracadutisti, gli equipaggi di volodegli elicotteri e i team delle trasmissioni, quanto iparacadutisti e i cavalieri.
Alle precedenti operazioni hanno partecipato so-prattutto militari di leva. A questi, talvolta, era sta-to chiesto di dichiarare formalmente la propria«volontarietà» a essere inclusi nelle unità di previ-sto impiego. Quando attuato, questo obbligo della«volontarietà» ha avuto effetti negativi sulla com-posizione, addestramento, amalgama e attività dicomando delle unità predesignate per l’impiego.Infatti, è stato sempre necessario utilizzare «volon-tari» di altre unità/specialità per riempire i «buchi»che si creavano in quelle predesignate, a causa dichi non desiderava partecipare all’operazione. Allafine, quindi, le unità erano formate da personaleche in gran parte non aveva una conoscenza reci-
proca, un addestramento comune e che, cosa piùgrave, non era noto ai Comandanti che dovevanoimpiegarlo in scenari ad alto rischio. Nel tentativodi ovviare a tali rilevanti e pericolosi inconvenienti,si pianificavano, per queste unità eterogenee e apremessa dell’impiego, periodi di amalgama adde-strativa. Periodi spesso teorici, visti i sempre con-tratti tempi di approntamento delle unità, con con-seguenti ricadute sull’amalgama stessa. L’amalga-ma operativa di un’unità è sì un risultato del comu-ne addestramento svolto, ma anche del tempo vis-suto insieme dal personale e dell’azione di coman-do quotidianamente svolta dai Comandanti ai varilivelli. L’applicazione del principio della dichiara-zione di «volontarietà» alla partecipazione a unaoperazione fu una decisione felice dal punto di vi-sta della politica nazionale di quegli anni. Sulla ba-se dell’esperienza acquisita nelle precedenti opera-zioni, fu deciso pertanto di impiegare per la «Ibis3» solo volontari in ferma prolungata (VFP) e/o mi-litari a ferma prolungata (MFP).
Oggi è ampiamente nota la figura del volontario,adesso a ferma prefissata o in servizio permanen-
te. Non altrettanto può dirsi,soprattutto per le giovani ge-nerazioni, del militare di levache decideva di prolungare i 12mesi del servizio di leva obbli-gatorio. All’epoca, i militari dileva venivano chiamati e im-messi nelle unità sulla base discaglioni mensili, cioè 12 in unanno. I militari potevano com-mutare il servizio di leva in fer-ma prolungata al 15° o al 180°giorno dall’arruolamento. La
stragrande maggioranza dei militari operavanoquesta scelta in coincidenza della seconda sca-denza temporale. Questo era molto positivo per igiovani e per le unità di appartenenza degli stessi.Infatti, i giovani di leva avevano avuto tempo emodo di apprezzare la vita militare e di verificarela sua rispondenza alle loro aspettative, nonché diprendere consapevolezza dello «spirito di corpo»dell’unità alla quale erano stati assegnati e pressola quale sarebbero rimasti se decidevano di di-ventare MFP. La rafferma ai militari di leva venivaconcessa solo a seguito del positivo giudizio diidoneità espresso su di loro dal Comandante direggimento/Corpo, che si avvaleva, ovviamente,dei pareri formulati dai Comandanti sovraordinatial richiedente. In tal modo, il reggimento/Corpoera in grado di «autoalimentarsi» con personalemotivato, le cui capacità/qualità erano state datempo verificate e che era stato selezionato daiQuadri dello stesso. Erano, quindi, dei volontarimilitarmente molto affidabili. Questi avrebberogarantito una presenza nella stessa unità di altri
ANTHROPOS - 122
L’amalgama operativa diun’unità è sì un risultato delcomune addestramento svol -to, ma anche del tempo vis-suto insieme dal personale edell’azione di comando quo-tidianamente svolta dai Co-mandanti ai vari livelli
“
”
due anni e potevano aspirare, al termine della fer-ma, alla promozione al grado di Sergente di com-plemento. Queste prime unità, formate soltantoda volontari, chiudono il ciclo storico del servizioobbligatorio di leva nell’Esercito. Servizio obbli-gatorio di leva che, non bisogna dimenticare, harealmente dato un contributo essenziale per «faregli italiani». I cittadini che, in forza di quell’obbli-go, hanno indossato un’uniforme hanno caratte-rizzato comunque la storia dell’Esercito Italianonell’ultima fase del Risorgimento, durante leguerre in Africa, le due guerre mondiali, il con-fronto bipolare e le prime PSO. Non è assoluta-mente poco. La loro presenza, il loro ruolo e il lo-ro sacrificio non può essere offuscato dall’attualericorso a soli volontari, né condurre a un’acriticaesaltazione di quest’ultimi. Non esistono scelteche hanno solo aspetti positivi. Quei primi volon-tari, soprattutto quelli che operavano il transitodal dovere della leva alla libera scelta del mondomilitare, possono offrire qualche indicazione permigliorare quelli attuali.
L’APPRONTAMENTO DI «ITALFOR IBIS 3»
Lo Stato Maggiore dell’Esercito scelse per l’«Ibis
3» il 183° «Nembo» poichè questo era, a queltempo, l’unico reggimento della Brigata «Folgore»ad avere personale a ferma prolungata, sia VFP esia MFP. Il reggimento «Cavalleggeri Guide» (19°),invece, era la prima unità dell’Esercito interamen-te formata da VFP. Pertanto, a premessa dell’im-piego, non si rese necessario alcun tipo di «rime-scolamento» del personale in essi inquadrato. Inparticolare, i volontari del «Nembo» apparteneva-no a vari scaglioni - dal 1°/93 al 7°/94 - e datempo, erano unitariamente inquadrati in unacompagnia fucilieri meccanizzata (la 20a «Puma»)e in un plotone mortai pesanti (della compagniaarmi di sostegno «Pegaso»). Altri VFP/MFP eranoeffettivi alle altre tre compagnie fucilieri del I bat-taglione «Grizzano», in qualità di Comandanti disquadra, e nella compagnia Comando e Servizi delreggimento. Questi paracadutisti e i loro Coman-danti formavano delle unità con elevati addestra-mento, amalgama ed esperienza operativa. Il tut-to, rafforzato dalla consapevolezza di essere«doppiamente» volontari, come parà e per la fer-ma contratta, e dal fortissimo spirito di corpo delreggimento. Nella «Folgore», infatti, il 183° reggi-mento rappresenta le tradizioni e la storia dell’al-trettanto eroica Divisione paracadutisti «Nembo».Il 22 % di questi volontari erano già stati in Soma-lia. Il 183°, infatti, era stato impiegato durantel’«Ibis 2», dal maggio al settembre 1993, e il 2 lu-glio aveva partecipato al combattimento presso il A
NTHROPOS
123 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
Una blindo 6614 a un check-point (Ibis 2).
check-point «Pasta». Quel combattimento fu ilprimo sostenuto dal nostro Esercito dopo la finedella Seconda guerra mondiale. Durante quellagiornata, il reggimento ebbe 20 feriti. Prima chesi sapesse di un suo ritorno in Somalia, il Presi-dente della Repubblica concedeva, il 5 ottobre1994, alla Bandiera di Guerra del «Nembo» la Me-daglia d’Argento al Valore dell’Esercito, proprioper la partecipazione alla «Ibis 2» e a quel com-battimento. Bandiera di Guerra che è la più deco-rata fra quelle «amaranto».
L’approntamento e l’amalgama dei parà, quindi,non rappresentarono un problema significativo.Tenuto conto della scarsità del tempo disponibile,il personale della 20a compagnia fu sottoposto aun breve ciclo di addestramento finalizzato al tipodi operazione da sviluppare, dal 2 al 7 gennaio1995. Fu deciso, quindi, di continuare le attivitàpreparatorie a bordo delle navi e durante la navi-gazione verso le acque somale. Anche questo rap-
presentava una novità per le unità dell’Esercito.L’approntamento dei materiali e dei mezzi ne-
cessari per lo sviluppo dell’operazione fu, al con-trario di quello del personale, particolarmenteoneroso. I due anni di costante e rilevante impe-gno dell’Esercito in Somalia - contemporaneo, nonbisogna dimenticarlo, con quello altrettanto signi-ficativo in Mozambico - avevano molto usurato imateriali e mezzi in dotazione alle unità. Inoltre,l’entità delle scorte centrali non era elevata. Inparticolare, alcuni tipi di materiali/mezzi («VM-90», corazzature aggiuntive per «VCC-1», elmet-ti/caschi in kevlar, giubbetti antischegge e anti-proiettili, uniformi da combattimento/occhiali/buffetterie/stivaletti desertici, copricapo/fregiONU) erano stati approvvigionati in quantità com-misurata alle sole esigenze delle unità impiegatenelle PSO, non per tutto l’Esercito. Per alcuni diquesti materiali/mezzi, inoltre, fu deciso che ve-nissero passati in consegna fra le unità che si av-
vicendavano nei lontani Teatri di Operazione (laSomalia e il Mozambico distano dall’Italia, rispetti-vamente, circa 6 000 e 8 000 km). Decisione che,tuttavia, determinò il rapido raggiungimento deltermine della loro vita operativa. Lo stato e la di-sponibilità dei materiali/mezzi presso le unità e idepositi centrali erano conseguenza della scarsadisponibilità di risorse finanziarie della Forza Ar-mata che, come si vede, non è una caratteristicasolo del tempo presente. Pertanto, ultimate leoperazioni «africane», ma considerando comeprobabile un futuro coinvolgimento dell’Esercito inaltre PSO, gli Organi Centrali decisero di tenereaccentrate le limitate risorse in materiali/mezzinuovi o efficienti disponibili. Risorse che furonoallocate in specifici centri/reparti/stabilimenti lo-gistici dislocati su tutto il territorio nazionale, dadistribuire all’esigenza e solo alle unità di previstoimpiego. Quindi, le unità designate per l’«Ibis 3»,dalla seconda metà del mese di dicembre 1994 ai
primi giorni del gennaio 1995, furonocostrette a «peregrinare» presso que-sti enti per acquisire il tanto di cuiavevano bisogno, anche per la specifi-ca operazione anfibia, e per il preleva-mento del quale venivano via via auto-rizzati. Significativa la quantità di ma-teriale e munizionamento da prelevaree approntare, anche in considerazionedella autonomia logistica che le unitàdovevano avere: cinque giornate dicombattimento. Pochissimo di quantoautorizzato al prelevamento fu conse-gnato «a domicilio» delle unità in par-tenza. Si dimostrò giusta la decisionedi mantenere accentrate le scarse ri-sorse disponibili, ma decisamente nonefficace il permanere della mentalità
logistica dei rifornimenti «dall’avanti verso l’indie-tro». Fra i mezzi, sistemi d’arma e materiali prele-vati, qualcuno sarà impiegato per la prima volta oin modo diverso rispetto al passato. Infatti, in re-lazione all’esperienza maturata durante le Ibis 1 e2, fu deciso di rinforzare le unità paracadutiste. Inparticolare, i «VCC-1» furono tutti dotati di coraz-zature aggiuntive, ogni plotone fucilieri ricevette,oltre alle armi in dotazione normale, due sistemid’arma «MILAN» attrezzati con visori notturni IRT,furono distribuiti numerosi lanciarazzi c/c «Pan-zerfaust-3» e le bombe da fucile MECAR. Materialee armamento questi ultimi, tutti di recentissimaintroduzione in servizio.
Tutti i materiali, i mezzi, il munizionamento deiparacadutisti e del personale delle trasmissionifurono caricati su Nave «San Giusto» il 10 gennaionel porto di Livorno e quello delle «Guide» il gior-no successivo nel porto di Napoli. È giusto ricor-dare che questa nave era stata da poco consegna-
ANTHROPOS - 124
«ITALFOR IBIS 3»- COMPOSIZIONE -
Unità 183° 9° 19° 5° 11° Altre Totali
- Personale -U. 10 4 1 15 1 - 31SU. 25 20 14 24 3 2 88VFP/MFP 65 - 14 - - - 79Totali 100 24 29 39 4 2 198
- Mezzi -VCC-1 (*) 16 5 - - - - 21Centauro - - 4 - - - 4ACM 4 1 3 - - - 8VM-90 1 - - - - - 1A-129 - - - 4 - - 4Totali 21 6 7 4 - - 38
(*) Tutti con corazzature aggiuntive tranne quello attrezzato ambulanza.
Tab. 4
ta alla Marina Militare ed essa doveva ancora ef-fettuare le prove di caricamento di personale/ma-teriali/mezzi. Quindi, si utilizzò «Italfor Ibis 3»per «testare» Nave «San Giusto». Fu sicuramenteun efficace addestramento interforze ma, unavolta giunti a Brindisi, fu necessario scaricarequella nave - non destinata a far parte del 26°Gruppo Navale - e ricaricare il tutto sulla «Gari-baldi», in piccola parte, e sulla «San Giorgio», larimanente. Ad approntamento ultimato, «ItalforIbis 3» sarà composto dal personale e dai mezziriportati in tabella 4. Fra il personale, spiccano i100 parà del 183° reggimento. Non era la primavolta nella storia delle unità che si sono fregiatedel nome «NEMBO» che una «centuria» di paraca-dutisti fosse chiamata a rappresentare le qualità ele capacità dell’intera unità (9).
La navigazione verso la Somalia fu utilizzata daiparacadutisti e dai cavalieri per amalgamarsi con imarò del «San Marco» e per apprendere le proce-dure peculiari di uno sbarco anfibio, ovviamentesconosciute ai primi. Gli uomini dell’Esercito rapi-damente impararono a vivere, muoversi e adde-strarsi a bordo di una nave. Ambiente decisamen-te diverso dalle fusoliere dei velivoli «C-130» e«G-222» e dagli scafi delle «Centauro» ai qualierano abituati. A bordo, l’addestramento svolto fuparticolarmente efficace, anche se condizionato
dalla ristrettezza delle «aree addestrative» dispo-nibili e dalle esigenze di navi da guerra in naviga-zione. In particolare, gli uomini di «Italfor Ibis 3»ebbero modo di addestrarsi nel:• imbarco dei «VCC-1» e delle «Centauro» sulle
MEN, cioè i mezzi da sbarco;• decollo e appontaggio, diurno e notturno, degli
elicotteri su una nave in navigazione;• discesa da elicottero in «hovering», in completo
assetto da combattimento, utilizzando la tecnicadella «fast rope»;
• impiego dei nuovissimi lanciarazzi «Panzer-faust-3», anche grazie agli specifici simulatoridi tiro, e dei visori notturni del «MILAN», maiutilizzati prima.Questo, oltre al normale addestramento fisico,
al tiro con le armi individuali e di reparto, e al-l’imbarco e sbarco da elicotteri. Soprattutto, fupossibile utilizzare il tempo della navigazione perun costante esame delle fasi e ipotesi dello sbar-co, da elicotteri e/o da mezzi anfibi, da effettuarea Mogadiscio.
LO SBARCO ANFIBIO: LA PREPARAZIONE
Gli sbarchi in Somalia non sono mai stati effet-tuati secondo la metodologia che la cinematogra-fia, soprattutto quella statunitense, ci ha traman-dato descrivendo quelli realizzati durante la Se-conda guerra mondiale. Il primo, che diede l’avvio A
NTHROPOS
125 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
Un carro M-60 a un check-point sulla via imperiale (Ibis 2).
all’operazione «Restore Hope», ancorchè effettua-to nella notte tra l’8 e 9 dicembre 1992, è stato losbarco più «illuminato» della storia militare. Mari-nes e Navy SEAL statunitensi sbarcando non in-contrarono l’opposizione dei nemici somali, mal’accoglienza di un grosso reparto di operatori te-levisivi i cui fari illuminavano a giorno la scena abeneficio, in real time, dei telespettatori di tutto ilmondo. I militari statunitensi non furono moltocontenti di questa inattesa spettacolarizzazionedel loro arrivo.
Il secondo, che avrebbe posto termine a «UNO-SOM II», fu effettuato dalla forza anfibia italo-sta-tunitense, nella notte tra il 27 e il 28 febbraio1995, su una spiaggia ancora controllata dalleforze amiche, ma potenzialmente sotto il fuocoavversario. Allo sbarco non seguì una prosecuzio-ne in profondità o un’alimentazione delle forzeamiche, ma la realizzazione di una cornice di si-curezza che consentisse la manovra in ritirata diquelle forze. Questa manovra implicava notevolirischi, anche per lo scenario incerto e fluido pro-prio della conflittualità somala. Può sembrarefuori da ogni logica che di fronte a una dichiarata,imposta o comunque nota volontà di una partebelligerante di ritirarsi da un territorio, quellacontrapposta intenda attaccarne le forze in ritira-
ta. Questo, invece, è perfettamente normale. Nonsolo nei conflitti asimmetrici, ma anche in quellisimmetrici. Quante battaglie nella storia dell’uo-mo, gli Eserciti hanno combattuto pur sapendoche il nemico, poco tempo dopo, sarebbe statocostretto comunque ad abbandonare le posizioniche si attaccavano? Tantissime. Le motivazioni ditali decisioni sono quasi sempre da ascriversi aragioni di prestigio politico e/o militare di chi at-tacca: acquisire una vittoria «facile» dopo tantesconfitte, migliorare il proprio ruolo agli occhidelle fazioni/forze alleate, potersi vantare del ti-tolo di «liberatori» di una data area, di aver co-stretto l’avversario a ritirarsi o di aver acceleratotale decisione, sminuire il prestigio del Coman-dante avversario e accrescere quello dei propri,dimostrare l’inesistenza di «complessi d’inferiori-tà» nei confronti del nemico. Altre volte, questedecisioni sono il risultato di un chiaro obiettivopolitico: arrivare a essere i primi a gestire il patri-monio materiale e umano presente nel territorioche il nemico sta abbandonando, condizionare ilfuturo politico e/o territoriale di quell’area e diquelle contermini. Una guerra, simmetrica oasimmetrica, non si sviluppa secondo il modelloideale del duello cavalleresco. Attaccare chi ab-bandona il terreno è sempre remunerativo. A me-
ANTHROPOS - 126
Fig. 1
no che, il rafforzamento del dispositivo difensivoe l’incremento della capacità di reazione di chi siritira non dissuada chi voglia attaccarlo. In ognicaso, una dichiarata volontà di ritirarsi non metteal riparo chi la enuncia da ulteriori attacchi, anzispesso ne determina l’incremento. Anche di re-cente e in altre situazioni conflittuali, si è speratodi evitare ulteriori attacchi o attentati ai propricontingenti annunciando pubblicamente di volersiritirare da una determinata area. Speranza atroce-mente distrutta. Ci si è dimenticati di questa «le-zione» della storia politico-militare.
La fase finale dello «United Shield» doveva svi-lupparsi in quattro tempi:• primo: sbarco della forza anfibia italo-statuni-
tense (Landing Force IT-US) nel Porto Nuovo esulla spiaggia adiacente l’aeroporto (figura 1) eacquisizione delle posizioni assegnate;
• secondo: organizzazione a difesa della testa disbarco in sistema con l’ultima linea di resistenzadelle residue forze di «UNOSOM II»;
• terzo: abbandono delle posi-zioni da parte delle forze di«UNOSOM II», loro trafilamen-to attraverso l’organizzazionedifensiva italo-statunitense eimbarco presso il Porto Nuovo;
• quarto: progressivo abbandonodelle posizioni da parte dellaLanding Force IT-US e suoreimbarco sulle unità navali.Il tutto doveva essere attuato
soprattutto durante le ore not-turne e sotto un costante soste-gno aereo.
L’8 febbraio, tutta la FM era schierata nelle ac-que prospicienti Mogadiscio. In questa, anche il26° Gruppo Navale con a bordo «Italfor Ibis 3». Loscenario nel quale si dovevano sviluppare gli attitattici connessi con i citati quattro tempi presen-tava rilevanti rischi per la FM. Per ridurre tali ri-schi, circa tre settimane furono utilizzate per per-fezionare la preparazione politica e militare dellafase finale dell’operazione. Anche questo tipo dipreparazione rappresenterà una novità rispettoalle precedenti PSO.
La preparazione politica dello sbarco, ritirata,reimbarco si polarizzò sul mettere a conoscenza icapi delle fazioni somale degli obiettivi dell’ope-razione, sulla loro non convenienza ad interferiresulle attività che sarebbero state attuate e a proi-bire ad altri di farlo. Pena, la sicura reazione dellarilevante FM, già schierata in modo visibile a tutti.Reazione che verosimilmente avrebbe determina-to, tra l’altro, la distruzione del Porto Nuovo, del-l’aeroporto e delle relative infrastrutture.
La preparazione militare si incentrò sull’areadello sbarco e sulle unità che vi avrebbero opera-
to. Quella dell’area, consistette nel miglioramentodelle sue capacità di difesa e di movimento, per li-nee interne, verso le posizioni da presidiare e lezone di imbarco. In particolare, furono realizzatilavori di fortificazione campale, anche a protezio-ne dei siti di reimbarco, camminamenti e opereper facilitare il ripiegamento della retroguardia di«UNOSOM II», posti di osservazione e di controllo,postazioni «a scafo sotto». Altrettanto intensa, lapreparazione delle unità. Quasi giornalmente, iComandanti a tutti i livelli operavano ricognizionidel terreno e definivano le modalità di coordina-mento reciproche. L’efficacia di tali modalità eraessenziale. L’abbandono delle posizioni, l’avvicen-damento in esse, i trafilamenti da attuare nell’arconotturno, le poche ore a disposizione per svilup-pare la manovra in ritirata e, soprattutto, l’etero-geneità delle unità della FM e di quelle di «UNO-SOM II», indicavano nel coordinamento uno deglielementi critici della manovra stessa. In assenza diprocedure comuni, fra unità di ben sette Stati di-
versi non membri della stessaalleanza, e per migliorare il li-vello di interoperabilità, si feceun largo ricorso al reciprocoscambio di Ufficiali e nuclei dicollegamento. Parimenti signi-ficative furono le preliminariattività aeree di ricognizione edi pianificazione di un aderentesostegno alla componente ter-restre. A bordo delle navi, lapreparazione fu incentrata su-gli aspetti tecnici dello sbarco:scelta e modalità di caricamen-
to dei mezzi da sbarco, influenza delle maree cheavevano escursioni molto forti di 2-3 m. Inoltre,furono sviluppate delle esercitazioni di presa diterra per individuare le finestre temporali ottimaliper lo sbarco e i successivi reimbarchi. Nei giorniimmediatamente precedenti lo sbarco, la deter-renza messa in atto dallo «United Shield», favorìl’evacuazione per via aerea di circa 8 000 soldatidi «UNOSOM II».
LO SBARCO ANFIBIO: L’ATTUAZIONE
La preparazione effettuata non poteva, ovvia-mente, fugare ogni dubbio o rischio. L’atteggia-mento ostile di uno dei clan o di una banda di mi-liziani fuori controllo potevano innescare una si-tuazione molto difficile da gestire. La LandingForce IT-US, inoltre, doveva affrontare le incogni-te relative al comportamento, spontaneo o forza-to, della popolazione civile. Tante volte in passa-to, gruppi di civili, donne e bambini inclusi, sonostati coinvolti o volutamente usati come «scudi A
NTHROPOS
127 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
In assenza di procedurecomuni, fra unità di ben set-te Stati diversi non membridella stessa alleanza, e permigliorare il livello di intero-perabilità, si fece un largoricorso al reciproco scambiodi Ufficiali e nuclei di colle-gamento
“
”
umani» nei combattimenti sviluppati nel tessutourbano di Mogadiscio. La presenza di civili nel-l’area di sbarco avrebbe, in ogni caso, condizio-nato l’uso della forza da parte delle unità, anchesolo per l’autodifesa.
L’area dello sbarco era suddivisa in tre settori(figura 2): orientale, incentrato sul Porto Nuovo;centrale, polarizzato sulla parte settentrionaledell’aeroporto; occidentale, relativo alla parte me-ridionale della pista di atterraggio. Alla spiaggiaprospiciente l’aeroporto venne dato il nome con-venzionale di «Green Beach». Alle unità italianedella Landing Force fu assegnato il settore centra-le dello schieramento. Questo settore è di tuttorilievo poiché include le collinette che dominanola maggior parte dello sviluppo dell’intera pista diatterraggio (lunga poco più di 3 km). Il settore eraampio circa 1,5 km ed era ripartito in due sotto-settori. A sinistra, il complesso minore (cpls. min.)costituito dal «San Marco», con Posto Comando(PC) a q. 22, e a destra, il cpls. min. formato daiparacadutisti del «Nembo», con il proprio PC a q.36. A sottolineare l’importanza del settore asse-gnato alle unità italiane, i «Caschi Blu» realizzava-no nelle vicinanze di q. 36 il loro PC tattico, percoordinare e controllare il ripiegamento delle pro-prie forze. PC che fu poi utilizzato anche dal Co-mando della Landing Force.
Il mattino del 27 febbraio, la maggior parte dellaorganizzazione C3I e delle forze speciali della Lan-ding Force IT-US furono immesse nell’area di sbar-co mediante elitrasporto. Le forze speciali diedero
vita a più team di snipers in grado di eseguire tiridi precisione contro eventuali elementi ostili. Sem-pre quel giorno, si effettuarono gli ultimi controllisul fondale prospiciente la spiaggia e si posiziona-rono i segnali di identificazione del canale di sbar-co. Lo sbarco della forza anfibia italo-statunitense,sotto la protezione del poderoso sostegno di fuocoerogabile dalle navi, dagli aerei ed elicotteri dellaFM, iniziò alle 00.01 del 28 febbraio 1995 e inte-ressò contemporaneamente il Porto Nuovo e laGreen Beach. I primi a sbarcare sono i Marines, se-guiti subito dopo dai marò del «San Marco», alle02.30, e dai paracadutisti del «Nembo». I parà pre-sero terra alle 03.30 circa e si diressero, con 10«VCC-1», verso le posizioni assegnate sulla testataNord dell’aeroporto. I militari italiani, che avevanolasciato giusto un anno prima Mogadiscio, in unclima di roventi polemiche, vi tornarono da attoriprotagonisti. Sulle navi, come riserva del nostrocontingente, le restanti forze di «Italfor Ibis 3»: unplotone di paracadutisti del 183°, un distaccamentooperativo degli Incursori paracadutisti del 9° e ilplotone blindo dei «Cavalleggeri Guide». Unità cheerano orientate a essere immesse nell’area, on call,rispettivamente con un elisbarco o con uno sbarcoanfibio. Le unità in primo scaglione della LandingForce IT-US, dopo lo sbarco, raggiunsero in brevetempo le posizioni assegnate e rilevarono quelletenute dalle forze di «UNOSOM II» nei propri setto-ri. Il secondo scaglione della Landing Force, com-posto solo da Marines, rimase sulla Green Beachper assicurare la difesa dei punti di reimbarco.
ANTHROPOS - 128
Fig. 2
Punti essenziali non solo per la manovra della Lan-ding Force stessa, ma anche per le rimanenti unitàdi «Caschi Blu». Infatti, era previsto che qualora lasituazione tattica non avesse consentito il loro im-barco in sicurezza nel Porto Nuovo, quelle unitàsarebbero state avviate alla Green Beach. Alle06.00, l’assunzione del dispositivo previsto, daparte delle unità italiane, era ultimato. Da quel mo-mento, l’attività fu incentrata, soprattutto, sull’os-servazione del comportamento dei somali e delleloro «tecniche» (10). L’osservazione terrestre, adifferenza di quanto potrebbe sembrare, non è unaattività di poco conto per la sicurezza delle unità.In quella circostanza, tutte le «ottiche» disponibili,dei binocoli, dei meccanismi di puntamento dei ti-ratori scelti, delle armi di reparto e dei mezzi cin-golati, sono impiegate per scrutare il terreno, edifi-ci e movimenti nei settori assegnati. In quelle pri-me ore, il comportamento e il fuoco dei milizianisomali e delle loro tecniche non era diretto controle posizioni tenute dagli italiani, ma destava co-munque preoccupazione. Era sempre immanente ilrischio che il ripiegamento della retroguardia di«UNOSOM II» avvenisse sotto l’incalzare delle fa-zioni somale e delle bande disaccheggiatori. Una volta sosti-tuite sulle loro posizioni, le unitàdi «UNOSOM II» iniziarono il lororipiegamento. Trafilarono attra-verso l’area ormai sotto control-lo della Landing Force IT-US e sidiressero verso il Porto Nuovoper essere imbarcate su navimercantili messe a disposizionedall’ONU. Il loro ripiegamento eimbarco proseguirono per tuttoil 28 e il 1° marzo (11). Alle 07.00 del 1° marzo, leunità pakistane lasciarono l’ultimo presidio dei«Caschi Blu» in Somalia: l’aeroporto. Appena i pa-kistani lo abbandonarono, i somali e le loro tecni-che vi fecero irruzione in massa. Fu il momentodella loro «vittoria», che venne festeggiata con ca-roselli sulla pista da parte di circa venti tecniche,dal nutrito fuoco di «gioia» di centinaia di miliziani,dal saccheggio del tanto abbandonato e dai timiditentativi delle locali «forze dell’ordine» di teneresotto controllo la situazione. Il tutto a poca distan-za dalle posizioni tenute dalle nostre unità. I mili-ziani somali aumentarono sempre più di numero,fino a diventare più numerosi dei militari italiani.Nella mattinata, la folla dei somali si adunò per«celebrare l’evento» alla presenza dei loro capi eforse anche dello stesso Generale Aidid, il capostorico di una delle due principali fazioni locali. Fuun momento di forte provocazione per gli italiani.Marò e parà mantennero il sangue freddo ed evita-rono una pericolosa spiralizzazione degli eventi.Sopra di loro, gli elicotteri Mangusta e i cacciabom-
bardieri e dietro le unità navali schierate in pienavista, concretizzarono un’efficace deterrenza. Il ri-piegamento e l’imbarco del personale, dei materialie mezzi di «UNOSOM II», grazie alla sua ottima at-tuazione, si conclusero prima dei 7-10 giorni pre-visti all’inizio dell’operazione. Questo consentì dianticipare il ritorno della Landing Force IT-US sullenavi. Il movimento retrogrado per il reimbarco nonera simultaneo per tutte le unità della Landing For-ce, ma è differenziato secondo cadenze e modalitàpianificate. Era necessario, infatti, contemperarel’esigenza di continuare a esercitare un’efficace di-fesa della testa di sbarco, con quella di disimpe-gnare unità da avviare verso i punti di reimbarco. Iltutto, realizzando un progressivo restringimentodella testa di sbarco verso la Green Beach. Dalle00.01 alle 02.00 del 2 marzo, un’unità dei Marinesrileva i parà sulle loro postazioni. Questi iniziano illoro movimento verso la zona di attesa per il reim-barco. Il movimento retrogrado avvenne sotto ilfuoco somalo che, a causa del buio, non provocòdanni. Dalle 02.00, i parà e i loro «VCC-1» inizia-rono a reimbarcarsi sulle MEN e alle 04.00 eranotutti a bordo di Nave «San Giorgio». Poco dopo, an-
che i marò iniziarono a disim-pegnarsi e si avviarono verso laspiaggia. Ultimi i Marines. Colpassare del tempo, la baldanzae la pressione dei miliziani so-mali crebbero e con esse il vo-lume di fuoco diretto contro leunità della Landing Force. I Ma-rines, infatti, furono costretti acombattere retrocedendo daterra verso il mare. Alle 23.42del 2 marzo, il reimbarco della
Landing Force IT-US era ultimato. Dallo sbarco alloro reimbarco, i militari italiani non subirono alcu-na perdita. Fu un grosso risultato, tenuto conto deirischi affrontati. Il 3 marzo, venne sciolta la FM el’operazione «United Shield» si concluse. Il 26°Gruppo Navale lasciò le acque prospicienti Mogadi-scio e iniziò la navigazione verso l’Italia. Riattraver-sò il Canale di Suez, effettuò una breve sosta nelporto di Eilat (Israele) e rientrò a Brindisi il 21 mar-zo, dopo più di due mesi di permanenza in mare edopo aver percorso 12 430 miglia marine. I para-cadutisti proseguirono la navigazione a bordo della«San Giorgio» e sbarcarono a Livorno il 23 marzo.L’operazione «Ibis 3» era terminata. Qualche tempodopo, quegli stessi paracadutisti e altri VFP/MFPdel «Nembo», inseriti però in altre unità della «Fol-gore», sarebbero stati inviati in Bosnia-Erzegovina.Ma questa è un’altra operazione.
CONCLUSIONI
ANTHROPOS
129 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
Era necessario, infatti, con-temperare l’esigenza di con-tinuare a esercitare un’effi-cace difesa della testa disbarco, con quella di disim-pegnare unità da avviare ver-so i punti di reimbarco
“
”
Come è noto ai veri storici e professionisti militari,l’importanza di una battaglia o di un’operazionenon è funzione del grado dei Comandanti sul cam-po, della numerosità delle forze contrapposte, delleperdite arrecate o subite, del suo sviluppo tempora-le o, infine, del livello di notorietà acquisito presso icontemporanei. Anche il successo sulla parte avver-sa può non rappresentare la condizione necessariae sufficiente affinchè i posteri possano attribuire aquella battaglia od operazione il ruolo di «svolta»,di «punto di non ritorno» nella storia di un popolo onel pensiero politico e militare. La condizione ne-cessaria e sufficiente per acquisire tale ruolo è sem-pre rappresentata dal rilievo delle novità attuate inquella battaglia/operazione. Novità di azione politi-ca, di strategia militare, di impiego tattico di unità odi armamenti. Senza alcun dubbio, lo «UnitedShield»/«Ibis 3» rappresenta un significativo suc-cesso politico e militare per gliStati che vi hanno partecipato.Successo ottenuto nella condottadi una sempre difficile manovrain ritirata, che era stata per di piùannunciata da tempo. L’acquisi-zione di quel livello di successonon era assolutamente scontato,per la sensibilità acquisita dalconsesso internazionale sulle vi-cende somale, per l’elevata com-plessità di coordinare forze eterogenee, per la flui-dità della situazione a Mogadiscio e per i comporta-menti che potevano essere adottati da chi stava per«vincere». Gli Stati contributori si sono assunti,quindi, dei rischi politici e militari rilevanti. Soprat-tutto l’Italia, che aveva lasciato nel 1994 la Somaliain un clima di roventi polemiche. Quell’anno, di fat-
to uscivamo battuti da una PSO che, da subito, ciaveva emotivamente coinvolti. Tante erano state lepositive attese, da parte dei più, per il futuro dellanostra vecchia colonia. A maggior ragione brucianteil risultato acquisito. Ritornare in Somalia dopo po-co meno di un anno, è stato un atto di coraggio e diconsapevolezza del ruolo internazionale che l’Italiadeve sempre esercitare. L’importanza dello «UnitedShield»/«Ibis 3», tuttavia, non risiede soltanto nelsuo successo, ma nella numerosità delle assolutenovità politiche e militari che l’hanno caratterizzata.Di sicuro, la novità che colpisce di più è l’impiego disoli militari a ferma prolungata. Si chiude un ciclostorico per l’Esercito Italiano. Oggi tutte le unità so-no formate da volontari, ma quei volontari di «ieri»possono offrire qualche indicazione per migliorarela selezione di quelli attuali. Le novità apportatedallo «United Shield»/«Ibis 3» ai modelli concettualie organizzativi precedenti, configurano questa ope-razione come uno «spartiacque» fra le PSO svilup-pate prima e dopo di questa. Linea di separazioneche, come spesso accade, non è stata percepita co-me tale dai contemporanei. Lo scopo ultimo di que-sto articolo consiste nel far prendere consapevolez-za al lettore di oggi del rilievo politico e militare diquesta operazione ingiustamente dimenticata.
Leonardo PrizziGenerale di Divisione (aus.),
già Comandantedel 183° reggimento paracadutisti «Nembo»
NOTE
(1) Le altre operazioni «oltremare» alle quali avevano par-tecipato unità dell’Esercito sono: Libano 1 e 2, in Libano,dal 1982 al 1984; Airone 1 e 2, in Kurdistan, nel 1991;Pellicano, in Albania, dal 1991 al 1993; 2 operazioni Ip-pocampo, in Somalia ed Etiopia, nel 1991; Ibis 1 e 2, in
Somalia, dal 1992 al 1994; Albatros1 e 2, in Mozambico, dal 1993 al1994; 3 operazioni Ippocampo, inRuanda e Yemen, nel 1994.(2) Le pubblicazioni ufficiali del-l’Esercito non la citano. Né esistetraccia di tale operazione nel sitodella Forza Armata. Di essa, tutta-via, si parla in: rivista «Quadran-te», in articoli contenuti nei nume-ri 3 e 6 del 1995; rivista «Informa-
zione della Difesa», in un supplemento al numero 5 del1995; libro del Generale Leonardo Prizzi: «Le Operazio-ni di Sostegno della Pace (1982-1997). Il ruolo dell’Ita-lia e del suo Esercito», «Rivista Militare», Roma, 2000,pagg. 112-113. (3) Gli italiani caduti sono stati: 12 militari, 1 InfermieraVolontaria della CRI e 3 giornalisti; ed esattamente:
ANTHROPOS - 130
Ritornare in Somalia dopopoco meno di un anno, èstato un atto di coraggio e diconsapevolezza del ruolo in-ternazionale che l’Italia devesempre esercitare
“
”
Sopra e nella pagina a fianco.Militari italiani per le vie di Mogadiscio.
Dott.ssa Alpi, par. Baccaro, lanc. Carrozza, Serg. Magg.Cuomo, Sig. Hrovatin, Mar. Ca. Licausi, I.V. Luinetti,par. Mancinelli, S.Ten. c. Millevoi, Sig. Palmisano, Serg.Magg. par. Paolicchi, C.le par. Righetti, Ten. f. Ruzzi,Serg. Magg. Stabile, par. Strambelli e C. le par. Visioli;inoltre, 107 militari sono stati feriti. L’ultimo dei cadutiè stato il cineoperatore del TG 2 Marcello Palmisano,morto durante la «Ibis 3» in un agguato teso dai mili-ziani somali a lui e alla giornalista Carmen La Sorella.(4) Durante lo sviluppo di «UNOSOM I»/«Ibis 1», l’ONUorganizzò, il 15 marzo 1993 ad Addis Abeba, una Con-ferenza di Riconciliazione Nazionale per la Somalia, allaquale parteciparono, tra l’altro, i leaders di 15 movi-menti politici somali. Questa Conferenza, che consentìdi raggiungere un accordo fra tutti i partecipanti, pre-vedeva le attività da sviluppare, in un arco temporale didue anni, per ripristinare la pace in Somalia con l’aiutodell’ONU. I contenuti di tale accordo diedero origine al-la UNSCR n. 814 del 26 marzo 1993, che sancì l’avviodella operazione «UNOSOM II». Quest’ultima operazio-ne, a differenza di «UNOSOM I», è stata condotta sottola direzione politica diretta del Consiglio di Sicurezza efu effettivamente avviata il 4 maggio 1993.(5) Oltre alla citata Risoluzione, il Consiglio di Sicurezzaha emanato per la Somalia, nel biennio 1993-1994,ben 10 UNSCR e precisamente: nel 1993, la n. 837 del6 giugno, la n. 865 del 22 settembre, la n. 878 del 28ottobre, la n. 885 del 16 novembre e la n. 886 del 18novembre; nel 1994, la n. 897 del 4 febbraio, la n. 923del 31 maggio, la n. 946 del 30 settembre, la n. 953del 3 ottobre e la n. 954 del 4 novembre.(6) Gli Stati membri dell’ONU che parteciparono a«UNOSOM II», con contingenti militari e/o di polizia,furono ben 34. Di questi, 11 si ritirarono entro il marzo1994. Rimasero o giunsero successivamente in Somaliacontingenti di 23 Stati: Australia, Bangladesh, Botswa-na, Canada, Egitto, Filippine, Ghana, Grecia, India, In-donesia, Irlanda, Korea del Sud, Malesia, Marocco, Ne-pal, Nigeria, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Romania,Svezia, Zambia e Zimbabwe. I maggiori contingenti era-no quelli forniti, nell’ordine, da: Pakistan, India ed Egit-to. A novembre 1994, il contingente ONU era formatoda circa 15 000 soldati e poliziotti. A febbraio 1995,mantenevano ancora propri contingenti 15 Stati: Au-stralia, Bangladesh, Egitto, Filippine, Ghana, India, In-donesia, Korea del Sud, Malesia, Nigeria, Nuova Zelan-da, Olanda, Pakistan, Zambia e Zimbabwe.(7) Sulla presunta «inimicizia» dell’ONU nei confrontidell’Italia, cfr. il libro «Le Operazioni di Sostegno dellaPace (1982-1997). Il ruolo dell’Italia e del suo Eserci-to», a pag. 99.(8) Sugli errori politici e militari commessi dall’Italia,cfr. il già citato libro «Le Operazioni di Sostegno dellaPace (1982-1997). Il ruolo dell’Italia e del suo Eserci-to», pagg. 103 e 111-112.(9) Il 20 aprile 1945, esattamente cinquanta anni primadella «Ibis 3», una centuria del reggimento «Nembo» eun’altra dello Squadrone «F» - unità quest’ultima an-
ch’essa formata da paracadutisti della Divisione «Nem-bo» - furono i protagonisti dell’ultimo lancio di guerradella Seconda guerra mondiale, l’operazione «Herring».Lancio effettuato esclusivamente da paracadutisti ita-liani che, imbarcati nell’aeroporto di Rosignano su aereida trasporto «Dakota» statunitensi, furono aviolanciatinell’area compresa fra Modena, Mantova, Ferrara e Bo-logna, a sostegno di quella che sarà l’ultima offensivaalleata per la liberazione dell’Italia.(10) Questi mezzi (tipo pick-up) e le loro scorrerie sonostati il simbolo della conflittualità in Somalia. Sul loropianale posteriore era normalmente montata una mi-tragliatrice oppure un cannone c/c senza rinculo.(11) Oltre alle citate unità, fu imbarcato personale delComando di «UNOSOM II» e più di 100 fra rifugiati,giornalisti e impiegati dell’ONU.
ANTHROPOS
131 - ANTHROPOS
Rivista Militare n. 3/2010
Questo articolo è dedicato al Tenente Colonnello f. (par.)Fabio Falco, che ci ha lasciato pochi mesi or sono. DaCapitano del 183° reggimento paracadutisti «Nembo», èstato uno dei protagonisti della «Ibis 3».
RUBRICHE - 132
L’arte si è spesso colorata di contenuti bellici, at-tingendo emozioni da contesti percorsi da un livellodi pathos assai elevato. E il campo di battaglia hasempre offerto eccezionali spunti per l’espressionedell’emozione. Raffigurazioni pittoriche e scultoreedei combattimenti, poesie e racconti di guerra necostituiscono un esempio. Il poema epico è, poi,per eccellenza la celebrazione dell’evento bellico edei suoi eroi, uomini in carne e ossa, che si inna-morano, combattono, provano nostalgia per la Pa-tria lontana e per la donna amata, assolvono ai do-veri militari assurgendo quasi allo status di divinità.
«Arte militare», «poesia di guerra», «canzoni disoldati» sono espressioni che, pur definendo ambitidiversi, hanno il comune denominatore di coniugarel’evento bellico all’arte nella sua espressione piùpura e romantica. Arte e guerra, un’associazioneapparentemente contraddittoria, quasi un ossimoro.In realtà, un connubio forte, da sempre interscam-bio reciproco di significati e valori molto vicini. Loscontro bellico è sempre stato fonte inesauribile divitalità artistica, ispirazione del pensiero e della
sensibilità. Una fucina di creatività e di cultura, in-treccio inestricabile di emozioni. Come quelle chedanzano sulle note di «Sentinella», canzone scritta emusicata da Antonino Iaria, Tenente Generale delruolo d’Onore del Corpo degli ingegneri dell’Eserci-to, e interpretata da Ivana Spagna, che ha presenta-to per la prima volta il motivo in occasione del terzoraduno interregionale, tenutosi a Rapallo, di uno deipiù noti Corpi dell’Esercito, quello dei «Bersaglieri».
Un altro suggestivo scenario, questa volta l’Audi-torium Parco della Musica di Roma, ha fatto dasfondo a un’ulteriore esibizione dell’artista in occa-sione del primo degli eventi celebrativi previsti peril 149° Anniversario della costituzione dell’Esercito.Il 13 aprile, infatti, alla presenza del Capo di StatoMaggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata,Giuseppe Valotto, si è svolto il Concerto della Bandamusicale dell’Esercito, nell’ambito del quale le per-sonalità militari e civili intervenute hanno avuto unulteriore «assaggio» della bravura dell’artista, cheha riproposto il motivo. Segno questo della profon-da stima che nutre l’artista nei confronti dei tantiuomini e donne che rischiano ogni giorno la propria
LE NOTE DI IVANA SPAGNA TOCCANOIL CUORE DI OGNI «SENTINELLA»
Sopra.Una fanfara dei Bersaglieri a Rapallo.
Sotto a sinistra.L’artista Ivana Spagna indossa la «vaira», il tipico coprica-po dei Bersaglieri.
vita per ridare la speranza alle tante popolazioniprostrate da anni di guerra. Spagna, una delle piùimportanti cantanti del panorama artistico italiano einternazionale, ha dato, dunque, la voce a questostraordinario componimento musicale dedicato alla
133 - RUBRICHE
Rivista Militare n. 3/2010
Sopra.Ivana Spagna durante la manifestazione di Rapallo.
Sotto.La copertina del CD raffigurante Ivana Spagna e il Ge-nerale Iaria.
SentinellaSentinella che di notte fai la guardiacon le stelle che ti fanno compagnia
la tua casa, il tuo Paese, ed il tuo amoresono attimi di grande nostalgia.
Quando pensi e chiudi gli occhi per sognarepensa a me che son lontana dal tuo cuore
pensami e se questo tu faraison sicura che non ti addormenterai.
Fai la guardia, non dormirepensa a me che son lontana
che ti voglio rivederepensa a chi in silenzio ti ama
e se questo tu farai son sicura che non ti addormenterai.
Tu ti trovi in un Paese per la pacema ogni giorno vedi morte e distruzione
non capisci il perchè di tutto questoe ti sforzi a voler dare una ragione.
Sii tu fiero di portare il tricolorequei colori il bianco, il rosso e il verdesono il simbolo, il vessillo dell'Italia
sono amore, amore di chi non si arrendeFai la guardia, non dormirepensa a me che son lontana
che ti voglio rivederepensa a chi in silenzio ti ama
e se questo tu farai son sicura che non ti addormenterai.
Il Paese ti ha mandato per la pacema ogni giorno vedi morte e distruzione
non capisci il perchè di tutto questoe ti sforzi a voler dare una ragione.
Fai la guardia, non dormirepensa a me che son lontana
che ti voglio rivederepensa a chi in silenzio ti ama.
Fai la guardia, non dormirepensa a me che son lontana
e se questo tu farai son sicura che non ti addormenterai.
«I giorni passano, i mesi volano,e gli anni svaniscono,
ma io son qui per Te».
Testo: Antonino Iaria (Cod. SIAE 44560).Musica: Ivana Spagna - Giorgio Spagna - A. Iaria.
«famiglia militare» e più in generale al sentimento. È l’amore l’autentico filo conduttore del brano,
l’amore da cui si attinge il coraggio e la forza diguardare avanti e di svolgere al meglio il propriodovere. «Sentinella» racconta, infatti, l’amore di unadonna per un militare che una missione di pace inluoghi lontani ha portato a contatto con la devasta-zione dalla guerra, risvegliando nel suo animo unaprofonda inquietudine e soprattutto un senso dinostalgia per il suo Paese e per la donna amata.Una nota romantica percorre l’intero testo, lo per-vade e ne definisce la struttura profonda. L’imma-gine dell’amata ispira il pensiero, motiva l’azione,dà senso all’avvenire. Anche laddove non è possibi-le attribuire un significato, perché c’è morte e di-struzione, ci si sforza comunque di trovare una ra-gione, il senso del proprio compito, del destino delmondo, di una pace continuamente negata. Ed eccoche l’amore per la donna lontana collima e si in-treccia con quello, non meno romantico, per la Pa-tria perché quei colori il bianco, il rosso e il verdesono il simbolo, il vessillo dell’Italia sono amore,amore di chi non si arrende. Dalle note della can-zone, semplici ma di grande impatto emotivo, si di-pana un filo che idealmente collega ogni «sentinel-
la» ai suoi affetti più cari, alla donna amata, ai pro-pri familiari e a quella grande famiglia che è l’Italiae che mai ha fatto mancare il proprio sostegno e lapropria ammirazione per i soldati impegnati nellaoperazioni di pace. Quasi una sorta di urlo pacatoche vuole tener desto ciascun soldato dicendogli:«non sei solo, c’è tutta una Nazione accanto a te,pronta a sostenerti nei momenti più difficili».
Il Generale Iaria, definito dalla stessa Spagna «per-sona eccezionale e un vero vulcano di idee», ha ri-
velato una profonda sensibilità «umana» e artistica.Una figura, la sua, che, mettendo da parte l’aspettoretorico, non può non colpire. Non solo un ruoloprestigioso e di responsabilità nell’Esercito Italiano,ma anche «moto perpetuo» nella cultura e nell’arte.Plurilaureato (sette lauree in bacheca) ed eclettico,sempre aperto a nuove esperienze e sempre pronto,si potrebbe quasi dire, a «reinventarsi». Provenientedal 19° corso dell’Accademia Militare di Modena,continua a mantenere saldo quel legame come rela-tore e correlatore delle tesi di laurea di tanti giovaniUfficiali delle Accademie Militari. Altrettanto forte è ilsuo impegno negli Atenei di diverse città italiane, siacome docente che come membro di commissioni.
RUBRICHE - 134
Sopra.Il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Valotto, Capo diStato Maggiore dell’Esercito, saluta Ivana Spagna primadel concerto tenutosi a Roma il 13 aprile scorso, primodegli eventi celebrativi previsti per il 149° Anniversariodella costituzione dell’Esercito Italiano.
A destra.L’artista durante l’esibizione di Rapallo.
Tutto ciò non gli ha impedito di coltivare un’altrapassione, altrettanto forte, quella per la musica,leit-motiv della sua esistenza. Una passione genui-na, che interagisce, quasi chimicamente, con il ge-nio matematico. E non c’è repulsione tra le due so-stanze ma connubio perfetto, mescolanza di ele-menti, assonanza perfetta. «Un matematico, comeun pittore o un poeta, apre dei sentieri. Se i suoi du-rano più dei loro, è perché sono fatti con le idee»,ha scritto il matematico britannico Godfrey HaroldHardy, ma sono le parole di Sofia Kovalevskaya asuggellare il sottile legame: «È impossibile essere unbuon matematico se non si è, nello stesso tempo,un po’ poeta». E non si può omettere Aristotele: «Lescienza matematica in particolare mostra ordine,simmetria e limitazione; e queste sono le più mera-vigliose forme della bellezza». L’insieme dei numericome opera d’arte, armonia e perfezione. Note mu-sicali e numeri si equivalgono, quindi, quasi si con-fondono, come spiega lo stesso Iaria: «La mia musi-ca nasce dalla grande passione per la matematica.Numeri, note e armoniche convergono nella trasfor-mata di Fourier e da qui è nato il testo dedicato atutti i soldati italiani che sono in giro per il mondo edei quali, dedicando un pensiero particolare a quelli
scomparsi durante le diverse missioni italiane, vo-glio far restare vivo il ricordo». Una dedica speciale eimportante che esplicita il messaggio della canzone,la forza dell’amore e il senso della missione, affin-ché possa arrivare, attraverso la magia delle note, alcuore di ogni soldato impegnato a svolgere il pro-prio dovere. Ulteriore conferma, questa, del legamesimbolico-funzionale tra musica e combattente.
D’altronde, da sempre la musica ha cadenzato imomenti più salienti della storia militare. Emblema-tica è la presenza delle Bande Militari nei diversiCorpi Armati del nostro e degli altri Paesi. La si vo-glia vedere come canti di guerra, inni nazionali o in-citamenti al valore del soldato, la musica va sempredritta al cuore, veicolando parole semplici ma rievo-cative di un vero e proprio patrimonio identitario.Sia che infiammi il cuore delle truppe o amplifichi leemozioni del combattente, la musica è suggestione,tende a rafforzare il legame di appartenenza, dà so-stegno nei momenti di sconforto. Ma è anche veico-lo di sentimenti che ogni Paese nutre nei confrontidella propria Forza Armata: orgoglio, ringraziamen-to, vicinanza e sostegno per il diuturno impegno diquanti, oggi come ieri, sono disposti a sacrificare lapropria vita in nome di nobili ideali, della salvaguar-dia della Patria e delle libere istituzioni.
GRELAUR
135 - RUBRICHE
Rivista Militare n. 3/2010
A destra.Ivana Spagna durante il concerto tenutosi per il 149° An-niversario della costituzione dell’Esercito Italiano.
Sotto.Il Tenente Generale Antonino Iaria con Ivana Spagna.
RUBRICHE - 136
Le «Operazioni Speciali» sono quelle operazionicondotte da forze militari o paramilitari specifica-tamente addestrate, organizzate ed equipaggiateper raggiungere obiettivi politici, militari o econo-mici, utilizzando mezzi non convenzionali, in ter-ritorio ostile o politicamente sensibile. Questa de-finizione, abbastanza generica, può essere utiliz-zata per tutto il periodo storico dell’evoluzionedelle FS (Forze Speciali) italiane. Detto questo, pe-rò, dobbiamo notare che gli obiettivi e l’addestra-mento sono mutati nel tempo. Gli «Arditi» dei Re-
parti d’Assalto, nati il 29 luglio 1917, svolgevanoun compito di rottura, per sbloccare la situazionedi stallo che si era venuta a creare nella guerra ditrincea, molto diverso dall’azione di sabotaggio econtro-sabotaggio svolta dal X reggimento «Ardi-ti» (creato nell’aprile del 1942 come battaglioneSabotatori) nel secondo conflitto mondiale. Ilcambiamento operativo e dottrinale nelle opera-zioni speciali, reso necessario dal diverso teatrodi battaglia e dall’avanzamento della tecnologia,continuò anche nel secondo dopoguerra. Graziealle intuizioni di due Ufficiali del battaglione Sa-botatori Paracadutisti (creato nel 1961), il Capita-no Rossi e il Capitano Angioni (che seguirono al-cuni corsi negli Stati Uniti), alla metà degli annisessanta si sviluppò una «dottrina italiana delleoperazioni speciali». Questa era basata sui con-cetti di bivalenza operativa (i sabotatori dovevanosaper svolgere sia azioni dirette sia indirette, co-me la guerriglia o l’addestramento di forze locali),polivalenza climatico-ambientale degli operatori(ogni compagnia doveva poter operare in qualsia-si teatro) e l’uso del distaccamento operativo co-me unità di base. Nel 1975 il battaglione assunsela denominazione di IX Reparto d’Assalto Paraca-dutisti «Col Moschin» (in onore al IX Reparto d’as-salto del Maggiore Messe, che si distinse nellaPrima guerra mondiale) e prese in consegna labandiera del X reggimento «Arditi», portandoneavanti le gloriose tradizioni. Gli anni novanta se-gnarono un altro periodo fondamentale nella cre-scita professionale delle nostre Forze Speciali,grazie alla partecipazione a numerose missioniall’estero. Dalla Somalia (Missione «IBIS», 1992),alla Bosnia, al Kosovo e a Timor Est, i nostri in-cursori acquisirono una preziosa esperienza dal
RICCARDO DOMINI DISCUTE LA SUA TESI DI LAUREA,SULLA STORIA DELLE FORZE SPECIALI
DELL’ESERCITO ITALIANO, ALL’UNIVERSITÀ DI FIRENZEProsegue la collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Cesare Alfieri» di Firenze,questa volta con un testo sintesi di una tesi di laurea sulla Storia delle Forze Speciali dell’Esercito Italianodagli «Arditi» al «Nono».
Operatori delle Forze Speciali in addestramento.
punto di vista tattico-procedurale e operativo daicolleghi americani, inglesi, francesi e di altre Na-zioni. L’utilizzo delle Forze Speciali (FS), visti gliesigui numeri del personale e l’elevato costo diaddestramento ed equipaggiamento, richiede unospreco di risorse minimo sia in ambito operativosia addestrativo. Nelle Nazioni occidentali, questanecessità si è concretizzata con l’istituzione diComandi centralizzati per l’utilizzo dei reparti FSdi qualunque Forza Armata (spesso di Esercito eMarina, in alcuni Paesi anche dell’Aeronautica).Dagli anni ottanta i vari Paesi hanno iniziato l’isti-tuzione dei Comandi unificati, a partire dalla Nor-vegia nel 1981 (Norwegian Defence Special Com-mand, FSK), seguita dagli Stati Uniti e dalla GranBretagna nel 1987. Il nostro Paese istituì il «Co-mando interforze per le Operazioni delle ForzeSpeciali» (COFS) nel 2004, su iniziativa del Mini-stro della Difesa, Onorevole Antonio Martino, edel Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammira-glio Di Paola. Il COFS compie un’operazione di ar-monizzazione tecnico-procedurale e operativa trale FS italiane (9° reggimento Paracadutisti d’Assal-to «Col Moschin», Gruppo Operativo Incursoridella Marina, Reparto Incursori dell’Aeronautica eil Gruppo Interventi Speciali dei Carabinieri) avva-lendosi delle FOS (4° reggimento Alpini Paracadu-tisti, 185° reggimento Acquisizione Obiettivi e Re-parto Elicotteri Operazioni Speciali) come suppor-to nelle azioni operative. Dopo l’attacco dell’undi-ci settembre 2001 e l’evoluzione della situazioneinternazionale, i Paesi occidentali hanno incre-
mentato l’utilizzo delle FS per contrastare il feno-meno, non convenzionale, del terrorismo e lapresenza di comandi unificati (anche a livello NA-TO dal 2006, con la nascita del NATO SOF Coor-dination Center) ha favorito un uso più razionaledi questa risorsa strategica. La presenza di un ne-mico sfuggente, con un’organizzazione flessibilee decentralizzata, richiede un contrasto altrettan-to non convenzionale e particolarmente addestra-to (il periodo addestrativo arriva quasi a due anniper gli incursori del 9° reggimento «Col Mo-schin»), che gli Stati hanno trovato nelle FS.
In conclusione questo lavoro ha voluto mette-re in evidenza un’eccellenza del nostro Paese,che ha segnato la storia mondiale della speciali-tà (gli Arditi della Prima guerra mondiale sonostati i primi reparti speciali del novecento). LeFS, quindi, non devono essere considerate comedei gruppi di «super-uomini», che utilizzanometodi poco ortodossi per risolvere ogni sortadi situazione critica che si viene a creare, masemplicemente come un eccellente mix di com-petenze culturali, tecniche e militari utili perraggiungere gli obiettivi strategici del proprioStato (definiti dalla leadership politica).
Riccardo DominiDottore in Studi Internazionali
137 - RUBRICHE
Rivista Militare n. 3/2010
Il laureando Riccardo Domini, mentre discute la suatesi di laurea alla presenza anche di personale dellaBrigata Paracadutisti «Folgore».
RUBRICHE - 138
Il tema educativo e pedagogico correlato allaformazione nelle varie professioni è un working inprogress: le dinamiche mutevoli della società, cosìcome le diverse culture a confronto, impongonooggi una sempre più forte rivisitazione dell’ambi-to formativo, soprattutto in campo addestrativo-militare.
La stessa riforma della scuola italiana si pone ilgrande fine educativo di una rivisitazione dell’ar-chitettura pedagogica correlata alle esigenze delmondo del lavoro ma anche formative, coniugan-do i valori fondamentali dell’uomo all’evoluzionedelle tecnologie e dei saperi.
Questo fa la differenza. «Hic et nunc», ovverol’evolversi della conoscenza nel presente non è ilfine di un’educazione o formazione professionale,ma un aspetto di un impianto poliedrico di saperi,comportamenti, che si fondano su credo e valoritrasmessi da generazioni.
Abnegazione, tenacia, coerenza, spirito d’inizia-tiva, altruismo sono solo alcuni aspetti dell’Io del«soldato del futuro» o l’essenza dell’educazionefin dai primi passi dell’uomo?
La pedagogia formativa in ogni fase evolutivadell’uomo, oggi, fa riferimento ad una costanteeducazione civica o viene lasciato tutto al nozio-nismo?
Superato ampiamente il postulato dello scorsosecolo per cui l’alunno non è un soggetto dariempire, ma un individuo le cui potenzialità van-no portate in superficie, a contatto con l’ambienteesterno ed il mondo della conoscenza, attraversoun rapporto circolare in cui educatore, educandoe mondo sono immersi in una rete con molti fat-tori esterni determinanti, allora si può affermareche l’educazione e la trasmissione dei valori sonoaspetti mutevoli della vita, che iniziano dalla fa-miglia per ampliarsi alla società.
In tale scenario si collocano anche coloro che,per professione e per missione, decidono di inve-stire sul proprio capitale umano per intraprenderela carriera militare.
Sì, perché trattasi di investimento, non di sceltacasuale o dettata da una moda.
Già questa precisazione fa capire come ci si de-ve porre davanti a scelte che condizionerannotutta la propria vita, di uomo e «lavoratore».
Da Sparta ad Atene nel corso dei secoli «l’artemilitare» così come la preparazione del soldatosono mutati in relazione alle dinamiche sociali,alle usanze locali, alle conoscenze dei materiali edelle loro lavorazioni, ai cambiamenti climatici, aimercati, ai voleri di imperatori, stati, nazioni.
Oggi la tecnologia, quale fattore che influenzaenormemente la formazione, in qualunque settoree sfera dell’agire umano, pone però dei limiti: sicorre il rischio del tecnicismo della didattica, diuno spinto nozionismo, lasciando poco spazio al-la formazione civile e valoriale dell’uomo.
Un passo ulteriore verso un modello educativointegrato, multidisciplinare lo si è avuto con lalegge n. 382 dell’11 luglio 1978 «Norme di prin-cipio sulla Disciplina militare», che ha fatto emer-gere un’etica militare codificata in norme, dove fi-losofia ed addestramento «corrono» insieme.
All’art. 1, secondo capoverso di tale norma, silegge: «compito dell’Esercito, della Marina e del-l’Aeronautica è assicurare, in conformità al giu-ramento prestato e in obbedienza agli ordini ri-cevuti, la difesa della patria e concorrere allasalvaguardia delle libere istituzioni e al benedella collettività nazionale nei casi di pubblichecalamità».
Si fa, quindi, esplicito riferimento alla «salva-guardia delle libere istituzioni», indicando spe-cificatamente un modello sociale universale acui l’impianto normativo culturalmente fa riferi-mento.
A ciò si affiancano altri documenti tra cui la cir-colare 1000/A/2 «Il manuale del combattente»edita dallo Stato Maggiore dell’Esercito, che enu-clea principi elaborati e condivisi in convenzioniinternazionali, a cui ne seguono altri sotto il pro-filo procedimentale, normativo ed etico.
Pensiero ed azione, credo e professione, Es edIo, si integrano nel professionista militare, comegià evidenziato da luminari nel settore ieri comeoggi.
In tale contesto, quindi, si cala l’azione educati-va, un percorso complesso ed articolato a livellomultidisciplinare, che sa coniugare etica e tecnica,scienza e formazione umanistica in ogni cadetto,giovane in armi a servizio della nazione, del po-polo, del mondo.
Infine, occorre evidenziare che ciò che fa ladifferenza è la preparazione umana, il costanteriferimento ai valori universali, lo sviluppo ditutte le potenzialità dell’uomo fin dai suoi primipassi, senza lasciare coni d’ombra, vuoti da affi-dare al motto «hic sunt leones», solo perché nonsi è data l’opportunità di scoprire quante più«terre» proprie di ogni uomo per costruire solidefondamenta.
Fabrizio PizzamiglioGiornalista
GIOVANI IN ARMIValori oltre la professione
Myanmar o Birmania: dialogo più che sanzioni, di GiovanniBucciol (pag. 16).Myanmar è l’acronimo indicante la vecchia Birmania, formatodalle iniziali delle sette etnie componenti lo Stato. Si deve allaGiunta Militare nel 1988 il cambio di denominazione, quandosperava di contrastare le spinte secessioniste, specie dei Kachindel Nord, degli Shan del Centro e dei Karen del Sud.Dopo la dura repressione attuata dal Governo contro i monacie la popolazione nell’ottobre 2007, sono scese in campo le piùimportanti organizzazioni internazionali per sostenerne leistanze di libertà e benessere volte a un sano sbocco democra-tico della situazione. Tuttavia, aziende statali indiane, cinesi,tailandesi e persino europee e americane non esitano a fare«affari d’oro» con la Giunta. Quest’ultima intende procedere ariforme burocratiche e sociali, perché sente «il fiato sul collo»dei consoci dell’ASEAN, (l’Associazione dei Paesi del Sud-EstAsiatico), di cui fa parte dal 1997. La Comunità Internazionalevorrebbe che fosse la Cina a far pressione sulla Giunta per isuoi eccessi sulla popolazione e sui prigionieri politici. Tutti,Italia compresa, sono d’accordo nel privilegiare il dialogo perpervenire a una ragionevole soluzione. La situazione si è poiulteriormente aggravata con lo spaventoso tsunami che ha col-pito il Paese all’inizio di maggio 2008.
Il Legal Advisor «Tattico» nelle operazioni militari terrestri al-l’estero, di Enrico Dubolino (pag. 26).Il consulente giuridico è oggi, a pieno titolo, una delle compo-nenti essenziali dello special staff del Comandante del Contin-gente schierato in Teatro di Operazioni. L’esperienza maturata nell’ambito delle operazioni militari al-l’estero dell’ultimo decennio ha, peraltro, evidenziato comel’assolvimento delle «missioni» demandate al consulente giuri-dico presenti uno «spettro» di potenziale implementazione for-temente differenziata.
Gli Allievi Marescialli di oggi, di Riccardo Venturini e Luca Gio-vangiacomo (pag. 32).Oggi l’incarico di Comandante di plotone richiede sempre più re-sponsabilità, motivazione oltre a un adeguato bagaglio di cono-scenze Tecnico-Militari. In tal senso la formazione professionaleassume un’importanza decisiva. Negli ultimi anni, in questo am-bito, la Scuola Sottufficiali dell’Esercito ha ricoperto un ruolo cen-trale divenendo «fucina» dei nuovi Comandanti di plotone.
United States Sergeants Major Academy, di Raimondo Spasiano(pag. 38).La United States Sergeant Major Academy di El Paso, in Texas,rappresenta per i Sottufficiali dell’Esercito statunitense la «ca-sa madre» che crea, sostiene e completa la loro formazione.L’Istituto pone in essere diversi corsi a beneficio del personaledella categoria tra i quali il Sergeants Major Course che è l’api-ce della formazione, anche sul piano internazionale.
La robotica sempre più nel futuro, di Pietro Batacchi (pag. 48).La guerra del futuro vedrà un utilizzo sempre più massiccio disistemi robotizzati. Già adesso l’esperienza maturata sui cam-pi di battaglia negli ultimi anni, in particolare in Iraq, Afghani-stan e Pakistan, va in questa direzione. Se gli americani sonostati i primi a sviluppare le applicazioni militari in tale settore,anche l’Italia si rivela un Paese all’avanguardia nell’ambito del-la robotica terrestre.
Speciale EOD-Afghanistan: Operazione Salam, di FernandoTermentini (pag. 58).Il 1° febbraio 1989, dopo dieci anni di presenza in Afghanistan,le truppe dell’ex Unione Sovietica iniziano a lasciare definitiva-mente il Paese. Milioni di mine, ordigni bellici non esplosi(UXOs), materiale esplodente ancora attivo (Explosive Rem-nants of the War - ERW) lasciati sul terreno dalle Truppe Sovie-
tiche e dalla resistenza afghana, rappresentano un pericolo divaste proporzioni nei confronti di chiunque tenti di avventurar-si nel Paese. Principalmente mine antiuomo, mine anticarro etrappole esplosive antesignane dei moderni IED (ImprovisedExplosive Device). «Armi esotiche», come erano definite daesponenti dell’Intelligence statunitense, che i Mujahideen ave-vano imparato a costruire sul campo coordinati da esperti mi-litari della CIA e dell’ISI pakistano.
Speciale EOD - Operazione Salam 2, di Pierluigi Scaratti (pag. 66).Il 1° febbraio 1990 partiva, sotto l’egida dell’ONU con manda-to semestrale, la seconda missione di addestramento per losminamento a favore delle popolazioni afghane nota come«Operation Salam», ovvero «Operazione Pace».
Speciale EOD - La lotta agli ordigni esplosivi improvvisati:Counter-IED, di Giuseppe Fernando Musillo e Domenico Spoli-ti (pag. 68).La fine della Guerra Fredda ha generato una serie di instabilitàlocali che hanno dato luogo non solo a missioni di Peacekee-ping ma anche a conflitti asimmetrici. Le nostre Forze Armate,in tale contesto internazionale, sono chiamate a coadiuvareGoverni locali nell’opera di Nation Building, con tutto ciò che nederiva, ma anche a fronteggiare azioni terroristiche che posso-no contare su un elemento in più: il congegno esplosivo im-provvisato (Improvised Explosive Device - IED), considerato ilpericolo più incombente negli odierni scenari operativi.
Speciale EOD - Le «Military Search», di Renato Scudicio (pag. 74).Le recenti operazioni condotte in teatro iracheno e afghanohanno messo in luce la grande minaccia costituita dagli «Impro-vised Explosive Devices» e la necessità di adottare appropriatemisure operative atte a fronteggiarla. In questo scenario assu-mono un ruolo determinante le Military Search che, supportateda un’adeguata Intelligence, costituiscono la maggiore attivitàvolta al contrasto e alla neutralizzazione del sistema IED.
Speciale EOD - Il nuovo Centro di Eccellenza nazionale per il C-IED, di Roberto Arcioni (pag. 88).Il delicato scenario internazionale, soprattutto nell’ambito diTeatri Operativi strategici come quello afghano, è minacciatodalla presenza di antichi nemici ancora pericolosi e attivi: mi-ne, ordigni inesplosi, ordigni esplosivi improvvisati. Ciò haportato alla messa a punto del progetto di costituzione di unCentro di Eccellenza nazionale per il C-IED, a valenza interfor-ze, in grado di fornire supporto addestrativo C-IED alle ForzeArmate oltre a un supporto concettuale e organizzativo alloStato Maggiore della Difesa.
Speciale EOD - Presente e futuro dell’Arma del genio - Intervi-sta al Generale di Brigata Antonio Dibello, Ispettore dell’Armadel genio, a cura di Marco Ciampini (pag. 94).Accanto alle funzioni istituzionali relative allo sviluppo dottri-nale e tecnico-tattico dell’Arma stessa, si pone l’esercizio del-la leadership nel settore della Counter-IED e il ruolo svolto inseno a organismi internazionali.Di questo e altro abbiamo discusso con il Generale Dibello, evi-denziando i lusinghieri risultati raggiunti e le sfide future cheattendono l’Arma del genio.
La guerra nel pensiero filosofico, di Sara Greggi (pag. 100).La storia del mondo è dominata dall’antagonismo e dal conflit-to. Un percorso tortuoso fatto di sentieri impervi e sconnessi,tutt’altro che lineari. Questo perché il mondo umano è un fittoe complesso reticolato di rapporti e le relazioni tra uomini eNazioni non sono altro che incastonate in un imperfetto e fra-gile meccanismo di equilibrio. Fin dall’antichità la guerra, inte-sa come puro scontro, ha affascinato i più grandi pensatoridell’Umanità, divenendo oggetto di approfondita discussione.
Somalia 1995: Operazione «Ibis 3», di Leonardo Prizzi (pag. 116).Operazione «Ibis 3» o «Somalia 3» è la denominazione italianadell’operazione multinazionale chiamata «United Shield» («ScudoUnito»). L’operazione è stata sviluppata per consentire la ritiratadel contingente dei «Caschi Blu» dell’ONU dalla Somalia, nel 1995.Con lo sviluppo dell’«United Shield» aveva termine l’operazio-ne «UNOSOM II» e con essa le speranze della comunità interna-zionale di avviare un processo di pacificazione in quella terra.Problema tuttora insoluto, i cui effetti negativi agitano ancoraquell’area e generano rischi per la sicurezza internazionale.
139 - RUBRICHE
Rivista Militare n. 3/2010
Myanmar or Burma: Dialogue Rather than Sanctions, by Giovan-ni Bucciol (p. 16). Myanmar is the acronym indicating the former Burma and ismade up by the initials of the seven ethnic groups forming upthe State. The change of name, in 1988, was due to the Milita-ry Junta who hoped to counter the secessionist forces, espe-cially the Kachin in the North, the Shan of the Centre and theKaren in the South.After the Government’s harsh crackdown against the monksand the population in October 2007, the most important inter-national organizations intervened in support of the demandsfor freedom and prosperity, aimed at achieving a sound anddemocratic outcome of the situation. However, Indian, Chine-se, Thai and even European and American state-owned compa-nies did not hesitate to make «a big buck» with the Junta. Thelatter intends to make bureaucratic and social reforms, becau-se it feels «rushed off their feet» by the copartners of ASEAN(Association of Southeast Asian Nations) of which has beenmember since 1997.The international community would want China to put pressu-re on the Junta for their excesses on the population and on po-litical prisoners. All, including Italy, have agreed to give priori-ty to dialogue, in view of reaching a reasonable solution. Besi-des, the situation has further worsened with the terrible tsuna-mi that struck the Country in early May 2008.
The «Tactical» Legal Advisor in Land Military Operations Abro-ad, by Enrico Dubolino (p. 26).The legal advisor is now rightly an essential component of thespecial staff of the Commander of a Contingent deployed in theOperations Theatre.The experience gained in military operations abroad in the lastdecade has however brought to light how the performance ofthe «missions» entrusted to the legal advisor present a highlydifferentiated «spectrum» of potential implementations.
Today’s Marshal Cadets, by Riccardo Venturini and Luca Gio-vangiacomo (p. 32).Today the task of Platoon Leader requires more and more re-sponsibility and motivation, besides an adequate stock of te-chnical and military knowledge. In this sense, professional trai-ning is of the utmost importance. In recent years, in this con-text, the Army Noncommissioned Officers School has played acentral role, becoming a «breeding ground» of the new PlatoonLeaders.
The United States Sergeants Major Academy, by Raimondo Spa-siano (p. 38).The United States Sergeants Major Academy in El Paso, Texas,is the «mother house» of the U.S. Army Noncommissioned Of-ficers, which creates, supports and completes their educationand training. The Academy provides various courses for thepersonnel of the category, including the Sergeants MajorCourse which is the apex of their training, also at internatio-nal level.
Robotics More and More in Our Future, by Pietro Batacchi (p. 48).The war of the future will see the more and more massive useof robotized systems. The experience acquired in the battle-field in recent years, particularly in Iraq, Afghanistan and Paki-stan, already goes in that direction. Although the Americanshave been the first to develop these military applications, alsoItaly proves to be in the forefront in the sector of land robotics.
EOD (Explosive Ordnance Disposal)-Special Afghanistan: Ope-ration Salam, by Fernando Termentini (p. 58).On February 1, 1989, after ten years of presence in Afghani-stan, the troops of the former Soviet Union begin to leave theCountry definitively. Millions of mines, unexploded ordnance
(UXOs) and still active explosive material (Explosive Remnantsof the War - ERW) left on the ground by the Soviet troops andthe Afghan resistance represent a danger of vast proportionsfor anyone trying to venture in the Country. They are mostlyantipersonnel mines, antitank mines and booby traps, forerun-ners of the modern IEDs (Improvised Explosive Devices). «Exo-tic Weapons», as they were defined by the U.S. intelligence of-ficials, that the Mujahideen had learned to build on the field,with the supervision of military experts from the CIA and thePakistani ISI.
EOD Special - Operation Salam 2, by Pierluigi Scaratti (p. 66).On February 1, 1990 the second demining training mission insupport of the Afghan population began. It is known as Opera-tion «Salam» (Peace).
EOD Special - The Fight Against the Improvised Explosive De-vices: Counter-IED, by Giuseppe Fernando Musillo and Dome-nico Spoliti (p. 68).The end of the Cold War has generated a number of local in-stabilities which resulted not only in missions of Peacekeeping,but also in asymmetric conflicts. In this international environ-ment, our Armed Forces are called to assist the local Gover-nments in their task of Nation Building, with all that comes withit, but also to deal with terrorist actions that can count on anadditional element: the Improvised Explosive Device (IED), con-sidered the most impending danger in today’s operational sce-narios.
EOD Special - The «Military Search», by Renato Scudicio (p. 74).The recent operations conducted in the Iraqi and Afghan thea-tres have highlighted the serious threat constituted by the «Im-provised Explosive Devices» and the need to adopt appropria-te operational measures to face up to it. In this scenario, theMilitary Search operations assume a determinant role because,supported by an adequate intelligence, they are the most cru-cial activity for contrasting and neutralizing the IED system.
EOD Special - The New National Centre of Excellence for C-IED,by Roberto Arcioni (p. 88).The delicate international scenario, especially in strategic Ope-rational Theatres such as the Afghan one, is threatened by thepresence of old enemies, still dangerous and active: land mi-nes, unexploded ordnance, improvised explosive devices. Thishas led to develop a project for the constitution of a nationaljoint Centre of Excellence for C-IED, which can provide C-IEDsupport to the Armed Forces, as well as a conceptual and or-ganizational backing from the General Staff of Defence.
EOD Special - Present and Future of the Engineers - Interviewwith Brigadier General Antonio Dibello, Inspector of the Engi-neer Corps, by Marco Ciampini (p. 94).Besides the institutional functions related to the doctrinal andtechno-tactical development of the Corps itself, there is theexercise of the leadership in the Counter-IED sector and therole played within the international bodies.Of this and more we have discussed with General Dibello, hi-ghlighting the results achieved and the future challenges facingthe Engineer Corps.
War in Philosophical Thought, by Sara Greggi (p. 100).World history is dominated by antagonism and conflict. A win-ding route made of impassable and rugged paths, anything butlinear. This is because the human world is a dense and com-plex network of relations, and the relations between men andNations are only inserted in an imperfect and fragile mecha-nism of balance. Since ancient times, war, intended as pureconflict, has fascinated the greatest thinkers of humanity, be-coming the subject of extensive discussions.
Somalia 1995: Operation «Ibis 3», by Leonardo Prizzi (p. 116).Operation «Ibis 3» or «Somalia 3» is the Italian denomination ofthe multinational operation called «United Shield». The opera-tion was developed to in order to allow the withdrawal of thecontingent of UN «Blue Berets» from Somalia in 1995.With the development of «United Shield», «UNOSOM II» ended,and so did the hopes of the international community to start aprocess of pacification in that land. This is still an unsolvedproblem, whose negative effects continue to trouble the areaand cause risks to international security.
RUBRICHE -140
Myanmar ou Birmanie: Le dialogue à la place des sanctions, parGiovanni Bucciol (p. 16).Myanmar, l’acronyme employé pour désigner l’ancienne Birmanie, estformé par les initiales des sept ethnies qui composent la populationdu pays. Il fut forgé par la Junte militaire en 1988 dans l’espoir quecette nouvelle dénomination aurait contribué à contrecarrer les pres-sions sécessionnistes, en particulier celles des Kachin du Nord, desShan du Centre et des Karen du Sud. Après la dure répression du Gouvernement contre les moines et con-tre la population en octobre 2007, les principales organisations in-ternationales sont descendues sur le champ de bataille pour soutenirleurs instances de liberté et de bien-être visant à trouver une issuedémocratique. Et pourtant, des entreprises indiennes, chinoises,thaïlandaises, voire européennes et américaines font des «affairesd’or» avec la Junte, qui, face à la pression des autres membres del’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) dont elle faitpartie depuis 1997, envisage des réformes bureaucratiques. La Com-munauté Internationale voudrait que la Chine fasse pression sur laJunte en raison des excès commis sur la population et les prisonnierspolitiques. Tous les pays, y compris l’Italie, sont d’accord pour don-ner la priorité au dialogue pour parvenir à une solution raisonnable.De plus, la situation s’est aggravée par suite du tsunami qui a frap-pé le pays début mai 2008.
Le Legal Advisor «Tactique» dans les opérations militaires terrestresà l’étranger, par Enrico Dubolino (p. 26).Aujourd’hui, le conseil juridique est, de plein droit, l’une des com-posantes essentielles du «special staff» du Comandant du Contin-gent déployé dans les théâtres opérationnels. L’expérience acquise dans le cadre des opérations militaires menéesau cours de cette dernière décennie à l’étranger a montré que les«missions» attribuées au conseil juridique présentent un «spectre» deréalisation potentielle extrêmement différencié.
Les Elèves Sous-officiers d’aujourd’hui, par Riccardo Venturini etLuca Giovangiacomo (p. 32).Aujourd’hui, la fonction de Comandant de Peloton implique des re-sponsabilités sans cesse croissante, une forte motivation et un ba-gage de connaissances techniques et militaires adéquat. Ainsi, laformation professionnelle revêt une importance décisive. Au coursde ces dernières années, l’Ecole de Sous-officiers de l’Armée a jo-ué un rôle primordial, devenant une véritable pépinière de nouve-aux Commandants de Peloton
United States Sergeants Major Academy, par Raimondo Spasiano(p. 38).La United States Sergeants Major Academy de El Paso, Texas, repré-sente pour les Sous-officiers de l’Armée américaine la «maison mè-re» qui crée, soutient et complète leur formation. L’Institut organi-se plusieurs cours pour les sous-officiers, dont le Sergeants MajorCourse qui constitue le plus haut niveau de la formation, même surle plan international.
La robotique: une présence grandissante dans notre futur, par Pie-tro Batacchi (p. 48).La guerre du futur aura de plus en plus recours à l’utilisation massivede systèmes robotisés. Aujourd’hui déjà, l’expérience acquise sur leschamps de bataille au cours de ces dernières années, notamment enIrak, en Afghanistan et au Pakistan, en est la preuve. Si les Américainsont été les premiers à mettre au point les applications militaires dansce secteur, il n’en est pas moins vrai que l’Italie est, elle aussi, un paysà l’avant-garde dans le secteur de la robotique terrestre.
Spécial EOD - Afghanistan: Opération Salam, par Fernando Ter-mentini (p. 58).Le 1° février 1989, après dix ans en Afghanistan, les troupes de l’an-cienne Union Soviétique commencent à quitter définitivement lepays. Des millions de mines, des engins non-explosés (UXOs), desrestes explosifs de guerre (Explosive Remnants of the War: ERW)
laissés sur le terrain par les troupes soviétiques et par la résistanceafghane, constituent un risque majeur pour tous ceux qui voudra-ient s’aventurer dans le pays. Notamment, mines antipersonnel, mi-nes antichar et pièges explosifs, précurseurs des Engins ExplosifsImprovisés modernes (IED: Improvised Explosive Device). Des «Ar-mes exotiques», comme les avaient nommées les représentants duService de Renseignement américain, que les Mujahideen avaientappris à construire sur le terrain avec l’aide d’experts militaires dela Cia et de l’ISI pakistanais.
Spécial EOD - Opération Salam 2, par Pierluigi Scaratti (p. 66).Le 1° février 1990, sous l’égide del’ONU avec un mandat semestriel,commence la seconde mission d’instruction pour le déminage enfaveur des populations afghanes, connue sous le nom de «Opéra-tion Salam», soit «Opération Paix».
Spécial EOD - La lutte contre les engins explosifs improvisés: Coun-ter-IED, par Giuseppe Fernando Musillo et Domenico Spoliti (p. 68).La fin de la Guerre Froide est à l’origine d’instabilités locales qui ontdonné lieu à des conflits asymétriques et rendu nécessaires desopérations de Peacekeeping. Dans ce contexte international, lesForces armées italiennes, sont appelées à prêter assistance auxGouvernements locaux dans l’œuvre de Nation Building, avec toutce qui en dérive, mais aussi à contrecarrer l’action des terroristesqui comptent sur un éléments de plus: l’Engin Explosif Improvisé,(Improvised Explosive Device IED) considéré comme le danger leplus redoutable dans les théâtres opérationnels modernes.
Spécial EOD - Les «Military Search», par Renato Scudicio (p. 74).Les opérations conduites récemment dans les théâtres irakien etafghan ont mis en évidence la gravité de la menace représentée parles Engins Explosifs Improvisés et le besoin d’adopter des mesuresopérationnelles appropriées pour y faire face. Dans ce contexte lesMilitary Search qui, avec l’appui du Service de Renseignement, re-présentent la principale activité visant à contrecarrer et à neutrali-ser le système des Engins Explosifs Improvisés, sont appelées à jo-uer un rôle primordial.
Spécial EOD - Le nouveau Centre d’Excellence national pour la lut-te contre les Engins Explosifs Improvisés (C-IED), par Roberto Ar-cioni (p. 88).L’équilibre délicat du scénario international, pour ce qui est surtoutdes théâtres opérationnels stratégiques tels que l’Afghanistan, estmenacé par la présence de vieux ennemis, encore actifs et dange-reux: mines, engins non-explosés, engins explosifs improvisés.D’où le besoin de mettre au point un projet visant à la création d’unCentre d’Excellence National interarmées pour la C-IED, capable defournir aux Forces armées un soutien dans le cadre de l’instructionen matière de C-IED et d’assurer l’appui organisationnel de l’EtatMajor de la Défense.
Spécial EOD - Présent et futur du Génie militaire - Interview au Gé-néral de Brigade Antonio Dibello, Inspecteur du Génie militaire, parMarco Ciampini (p. 94).Les fonctions institutionnelles liées au développement doctrinal et te-chnico-tactique de l’Armée, la leadership dans le secteur de la Coun-ter-IED, le rôle au sein des organismes internationaux, les résultatsflatteurs obtenus et les défis futurs que devra relever le Génie. Telssont les thèmes abordés lors de l’interview au Général Dibello.
La guerre dans la pensée philosophique, par Sara Greggi (p. 100).L’Histoire du monde est marquée par les conflits et les antagonismes.Un parcours tortueux fait de sentiers impraticables et disloqués. Et ceparce que le monde humain est un réseau de rapports serré et com-plexe et que les relations entre les hommes et les nations sont en-châssées dans un mécanisme d’équilibres imparfait et fragile. Depuisl’antiquité, la guerre, en tant que simple affrontement, ne cesse deséduire les plus grands penseurs de l’Humanité, devenant l’objet dedébats approfondis.
Somalie 1995: Opération «Ibis 3», par Leonardo Prizzi (p. 116).Opération «Ibis 3» ou «Somalie 3». Telle est l’appellation italienne del’opération multinationale appelée «United Shield» («Bouclier Uni»).L’opération a été mise au point en vue du départ de la Somalie ducontingent des «Casques Bleus» de l’ONU en 1995.Avec le «Bouclier Uni» l’opération «UNOSOM II» prenait fin, dissipantainsi tous les espoirs de la communauté internationale quant à la mi-se en place d’un processus de pacification dans le pays. Un problè-me non résolu, dont les effets négatifs se font encore sentir dans larégion et menacent la sécurité internationale.
141 - RUBRICHE
Rivista Militare n. 3/2010
Myanmar oder Birmanien: Dialog eher als Sanktionen, von Giovan-ni Bucciol (S. 16).Myanmar ist das Kürzel, das das ehemalige Birmanien kennzeichnet;es besteht aus den Anfangsbuchstaben der sieben Ethnien die denStaat bilden. Der Namenswechsel ist auf die Militärjunta im Jahre1988 zurückzuführen, als die Hoffnung bestand, die sezessionisti-schen Bestrebungen, vor allem der Kachin im Norden, der Shan imZentrum und der Karen im Süden könnten zurückgewiesen werden. Nach der scharfen, Oktober 2007 von der Regierung verordneten Re-pression gegen Mönche und Bevölkerung, sind die wichtigsten inter-nationalen Organisationen ins Feld gezogen um die Forderungennach Freiheit und Wohlergehen im Rahmen einer gesunden Demo-kratie zu unterstützen und zu verteidigen. Doch die bestehende Si-tuation hindert indische, chinesische, thailändische und sogar euro-päische und amerikanische Unternehmen nicht daran, mit der Juntagroßartige Geschäfte zu betreiben. Letztere beabsichtigt bürokrati-sche und soziale Reformen, denn sie fühlt sich von den anderen Mit-gliedsländern des ASEAN (Verband der Lander Südost-Asiens), demsie seit 1997angehört, «sehr beobachtet». Die Internationale Ge-meinschaft wünscht, China möge Druck auf die Junta ausüben, we-gen ihrer Übergriffe auf die Bevölkerung und wegen der politischenHäftlinge Alle sind einverstanden, Italien inklusive, dem Dialog denVorrang einzuräumen um zu einer angemessenen Lösung zu gelan-gen. Die Situation hat sich durch den fürchterlichen Tsunami, der dasLand Anfang Mai 2008 heimgesucht hat, zusätzlich verschlechtert.
Der «taktische» Legal Advisor bei den militärischen terrestrischenOperationen im Ausland, von Enrico Dubolino (S. 26).Der Legal Advisor oder Rechtsberater ist heute ein wesentliches Te-am-Element des Kommandanten eines Kontingents das an entspre-chenden Schauplätzen stationiert ist. Die im Bereich der Militäroperationen im Ausland gemachten Erfa-hrungen im Laufe des letzten Jahrzehnts haben unter anderem da-zu geführt zu erkennen, dass die Ausführung der dem Rechtsbera-ter übertragenen «Missionen» ein «Gespenst» potentieller, starkdifferenzierter Implementation darstellen.
Die Feldwebel-Ausbildung heute, von Riccardo Venturini und LucaGiovangiacomo (S. 32).Heute erfordert der Auftrag als Abteilungs-Kommandant nicht nur einumfassendes technisch-militärisches Wissen sondern auch immer mehrVerantwortung und Motivation. In diesem Sinne kommt der Berufsau-sbildung eine immer grössere Bedeutung zu. In den letzten Jahren hatdie Unteroffiziers-Schule des Heeres eine zentrale Rolle gespielt, und istzur «Werksatt» neuer Abteilungskommandanten geworden.
United States Sergeants Major Academy, von Raimondo Spasiano(S. 38).Die United States Sergeants Major Academy von El Paso, in Texas, ist fürdie Unteroffiziere der US-Armee das «Mutterhaus», das ihre Ausbildunggestaltet, unterstützt und vervollkommnet. Das Institut führt eine gan-ze Reihe unterschiedlicher Kurse zu Gunsten des Personals der entspre-chenden Kategorie durch, unter anderem den Sergeants Major Course,höchster Ausdruck der Ausbildung auch auf internationaler Ebene.
Der Robotik gehört die Zukunft, von Pietro Batacchi (S. 48).Die Kriege der Zukunft werden immer mehr mit großem Einsatz vonrobotisierten Systemen geführt werden. Bereits heute geht derTrend in diese Richtung, wie die Erfahrungen insbesondere im Irak,Afghanistan und Pakistan zeigen. Wenn die Amerikaner auch dieersten gewesen sind, die die militärische Anwendung der Robotikausgearbeitet haben, so beweist sich Italien jedoch als Vorreiter imBereich der Terrestrischen Robotik.
EOD Spezial - Afghanistan: Operation Salam, von Fernando Ter-mentini (S. 58).Am 1. Februar 1989, nach zehn Jahren Anwesenheit in Afghanistan,beginnen die Truppen der ehemaligen Sowjetunion endgültig dasLand zu verlassen. Millionen Minen, Blindgänger (UXOs), noch ex-
plosionsfähiges Material (Explosive Remnants of the War - ERW),das vor Ort zurückgelassen wurde, sind eine große Gefahr für je-den, der versucht das Land zu bereisen. Vor allem handelt es sichum Landminen, Anti-Panzer-Minen, sowie um explosive Fallen,Vorgänger der heutigen IED (Improvised Explosive Device). «Sowje-tische Waffen», sagten Vertreter des US-Geheimdienstes, die dieMujaheddin, im Feld herzustellen gelernt hatten, unter Anleitungvon Militärexperten der CIA und des pakistanischen ISI.
EOD Spezial - Operation Salam 2, von Pierluigi Scaratti (S. 66).Unter der Schutzherrschaft der UNO begann am 1. Februar 1990,mit halbjährlichem Mandat, die zweite Ausbildungs-Mission zu En-tminungs-Maßnahmen zugunsten der afghanischen Bevölkerung,bekannt als «Operation Salam», bzw. «Operation Frieden».
EOD Spezial - Der Kampf gegen die IED-Waffen: Counter-IED, vonGiuseppe Fernando Musillo und Domenico Spoliti (S. 68).Der Ende des Kalten Krieges hat eine Reihe von lokalen Ungleichgewi-chten verursacht, die wiederum zu einer Reihe nicht nur von Peace-keeping Missionen geführt haben, sondern auch zu asymmetrischenKonflikten. Unsere Streitkräfte sind in diesem internationalen Kontextaufgefordert, die nationalen Regierungen beim «Nation Building» undallem was dazugehört, zu unterstützen, sondern auch Terroraktionenzu bekämpfen, die auf eine gefährliche Waffe bauen können: die IED-Waffe (Improvised Explosive Device), die in den heutigen operativenSzenarien als größte Gefahr erachtet wird.
EOD Spezial - «Military Search», von Renato Scudicio (S. 74).Die jüngsten, auf dem irakischen und afghanischen Schauplatz ge-führten Operationen haben die grosse, von den IED-Waffen (Impro-vised Explosive Devices) ausgehende Gefahr hervorgehoben, sowiedie Notwendigkeit, angemessene Maßnahmen zur Bekämpfungihres Einsatzes vorzusehen. In diesem Szenario gewinnt die Milita-ry Search eine besondere Bedeutung, die mit Hilfe einer angemes-senen Intelligence das angemessendste Mittel zur Bekämpfung undNeutralisierung der IED bildet.
EOD Spezial - Das neue nationale Exzellenzzentrum für C-IED, vonRoberto Arcioni (S. 88).Das heikle internationale Szenario, vor allem das der strategischen ope-rativen Schauplätze wie z.B. Afghanistan, ist vom Vorhandensein alter,immer noch wirksamer und gefährlicher Feinde bedroht: Minen, Blin-dgänger, improvisiertes explosives Material. Dies hat zur Definition desProjektes geführt, durch das ein nationales Exzellenzzentrum für C-IEDeingerichtet werden soll, das den verbundenen Kräften dienen und Un-terstützung bei der C-IED Ausbildung leisten soll, sowie eine konzep-tuelle und organisatorische Unterstützung des Generalstabs des Heeres.
EOD Spezial - Gegenwart und Zukunft des Pionierkorps - Interviewmit Brigadegeneral Antonio Dibello, Inspektor des Pionierkorps,von Marco Ciampini (S. 94).Neben den institutionellen Funktionen hinsichtlich der doktrinalensowie technisch-taktischen Entwicklung des Heeres besteht die Au-sübung der Leadership im Bereich Counter IED und die innerhalbder internationalen Organismen gespielte Rolle. Darüber und über weitere Aspekte haben wir mit General Dibello ge-sprochen, die äußerst positiven Resultate ansprechend und die zu-künftigen Herausforderungen, die auf das Pionierkorps zukommen.
Der Krieg im philosophischen Gedanken, von Sara Greggi (S. 100).Antagonismus und Konflikt dominieren die Geschichte der Welt. Einsteiniger, schwieriger Weg, der alles andere als linear verläuft. Dies er-gibt sich aus der Tatsache, dass die Menschheit auf einem dichtenNetz von Beziehungen aufbaut, im Rahmen dessen die Beziehungenzwischen Menschen und Nationen nur fragile Elemente eines unper-fekten Gleichgewichtsmechanismus sind. Seit der Antike hat der Krieg,als reine Auseinandersetzung verstanden, die größten Denker derMenschheit fasziniert und zu tiefgehenden Diskussionen geführt.
Somalia 1995: Operation «Ibis 3», von Leonardo Prizzi (S. 116).Operation «Ibis 3» oder «Somalia 3», ist die italienische Benennungder multinationalen, «United Shields» genannten, Operation. DieOperation wurde entwickelt, um 1995 den Rückzug des Kontin-gents der UN-Blauhelme aus Somalia zu ermöglichen.Mit der Ausarbeitung von «United Shields» endete die Operation«UNOSOM II» und mit ihr gingen die Hoffnungen der internationa-len Gemeinschaft verloren, in diesem Land einen Befriedungspro-zess verwirklichen zu können. Das Problem ist noch immer unge-löst, die negativen Auswirkungen erschüttern noch immer das Ge-biet und verursachen Risiken für die internationale Sicherheit.
RUBRICHE -142
Myanmar o Birmania:más diálogo y menos sanciones, GiovanniBucciol (pág. 16).Myanmar, el acrónimo usado para designar la que fuera en unaépoca Birmania, está formado por las iniciales de las siete etniasque integran el Estado. Lo acuñó la Junta militar en 1988 en laesperanza de que este cambio de denominación habría contribuidoa contrarrestar las presiones secesionistas, y en particular las de losKachin del Norte, de los Shan del Centro y de los Karen del Sur. Tras la dura represión del Gobierno contra los monjes y la pobla-ción en octubre de 2007, se lanzaron al ruedo importantes organi-zaciones internacionales para apoyar sus instancias de libertad ybienestar encaminadas a un sano restablecimiento de la democra-cia. Sin embargo, empresas públicas indias, chinas, tailandesas yhasta europeas y norteamericanas, no vacilan en hacer «negociosde oro» con la Junta. Esta tiene intensión de emprender reformasburocráticas y sociales, al sentirse presionada por los otros sociosde la ASEAN (Asociación de las Naciones del Sureste Asiático), a laque adhirióen 1997. La Comunidad internacional quisiera que fue-ra China la que presionara la Junta para que dejara de cometer ex-cesos contra la población y los presos políticos. Todos los países,Italia inclusive, coinciden en privilegiar eldiálogo para encontraruna solución razonable. Además, la situación se agravó con el ter-rible tsunami que azotó el país a principios de mayo de 2008.
El Legal Advisor «Táctico» en las operaciones militares terrestres enel extranjero, Enrico Dubolino (pág. 26).Hoy en día, el asesor jurídico es, de pleno derecho, uno de los com-ponentes esenciales del «special staff» del Comandante del Contin-gente desplegado en el teatro de operaciones. La experiencia adquiridaen el ámbito de las operaciones militaresen el extranjero durante este último decenio, evidenció, entre otrascosas, que el desempeño de las funciones atribuidas al asesor ju-rídico presenta un «espectro» de implementación potencial extre-madamente diferenciado.
Los cadetessubtenientes de hoy, Riccardo Venturini y Luca Giovan-giacomo (pág. 32).Hoy día, el cargo de Comandante de Pelotón implica responsabilida-des cada vez mayores y fuerte motivación además de un bagaje apro-piado de conocimientos técnico-militares. Así, la formación profesio-nal cobra una importancia decisiva. En estos últimos años, la Escuelade Suboficiales del Ejército desempeñó un papel primordial,convir-tiéndose en una «fábrica» de nuevos Comandantes de Pelotón.
United States Sergeants Major Academy, Raimondo Spasiano(pág. 38).La United States Sergeants Major Academy de El Paso, en Texas, re-presenta para los Suboficiales del Ejército estadounidense la «casamadre» que crea, apoya y completa su formación. El Instituto orga-niza varios cursos para el personal, y en particular el Sergeants Ma-jor Course, que es el punto culminante de la formación, inclusive anivel internacional.
La robótica cada vez más presente en el futuro, Pietro Batacchi(pág. 48).La guerra del futuro hará uso cada vez más masivo de sistemas ro-botizados. Lo confirma la experiencia madurada en estos últimosaños en los campos de batalla, en particular en Irak, Afganistán yPakistán. Que los americanos hayan sido los primeros en desarrol-lar las aplicaciones militares de dichos sistemas, no quita que Ita-lia es un país a la vanguardia en el sector de la robótica terrestre.
Especial EOD -Afganistán: Operación Salam, Fernando Termentini(pág. 58).El 1° de febrero de 1989, tras diez años de presencia en Afganistán,las tropas de la ex Unión Soviética empezaron su retirada definiti-va. Millones de minas, municiones no explotadas (UXOs), restos ex-plosivos de guerra aún activos (Explosiv Remnants ofthe War-ERW)dejados en el terreno por las tropas soviéticas y la resistencia afga-
na, constituyen un ingente peligro par cualquiera que se aventureen el país. Principalmente minas antipersonal, minas anticarro ytrampas explosivas precursoras de los modernos artefactos explo-sivos improvisados (IED: Improvised Explosive Device), «armas exó-ticas», como las denominaban los representantes de la Inteligenciaestadounidense, que los Mujahideen habían aprendido a construiren el terreno mismo, con la ayuda de expertos militares de la CIA ydel ISI pakistaní.
Especial EOD - Operación Salam 2, Pierluigi Scaratti (pág. 66).El 1° de febrero de 1990, partía, bajo la égida de la ONU con man-dato semestral, la segunda misión para el desminado en beneficiode la poblaciones afganas, conocida como «Operation Salam», esdecir, «Operación Paz».
Especial EOD - La lucha contra los artefactos explosivos improvisa-dos: Counter-IED, Giuseppe Fernando Musillo y Domenico Spoliti(pág. 68).El término de la Guerra Fría originó instabilidades locales que volvie-ron necesarias misiones de Mantenimiento de la Paz pero que tam-bién generaron conflictos asimétricos. En semejante contexto lasFuerzas armadas italianas habrán de brindarle asistencia a los Go-biernos locales en las operaciones de Nation Building, con todo lo re-lacionado, sino que también deberán contrarrestar acciones de ter-roristas que cuentan con un elemento más a su favor: el artefacto ex-plosivo improvisado (Improvised Explosive Device - IED), considera-do como el mayor peligro en los teatros operativos modernos.
Especial EOD - Las «Military Search», Renato Scudicio (pág. 74).Las recientes operaciones llevadas a cabo en los teatros iraquí y af-gano evidenciaron la grave amenaza que representan los artefactosexplosivos improvisados y la necesidad de adoptar medidas opera-tivas apropiadas para afrontarla. En este escenario, desempeñan unpapel primordial las Military Search que, con el apoyo de un Servi-cio de Inteligencia eficiente, constituyen la principal acción encami-nada a contrarrestar y neutralizar el sistema de los IED.
Especial EOD - El nuevo Centro de Excelencia nacional para los C-IED, Roberto Arcioni (pág. 88).El equilibrio delicado del escenario internacional, sobre todo en elámbito de los Teatros Operativos estratégicos como el afgano, estáamenazado por la presencia de antiguos enemigos aún peligrososyactivos: minas, municiones no explotadas, artefactos explosivosimprovisados. De ahí la necesidad de un proyecto para la constitu-ción de un Centro de Excelencia nacional para el C-IED; un centrointerfuerzas encargado de la instrucción de la Fuerzas armadas enmateria de C-IED además de asegurar el apoyo conceptual y orga-nizativo del Estado Mayor de Defensa.
Especial EOD - Presente y futuro del Cuerpo de Ingenieros - Entre-vista con el general de brigada Antonio Dibello, Inspector del Cuer-po de Ingenieros, Marco Ciampini (pág. 94).Además de las funciones institucionales relacionadas con el desar-rollo doctrinal y técnico-táctico del Cuerpo de Ingenieros, cabemencionar el liderazgo en el sector de la Counter-IED y el papel de-sempeñado en los organismo internacionales. De esto y de mucho más hemos hablado con el General Dibello,evidenciando los resultados lisonjeros logrados y los retos futurosque habrá de afrontar el Cuerpo de Ingenieros.
La guerra en el pensamiento filosófico, Sara Greggi (pág. 100).La historia del mundo está dominada por el antagonismo y el conflic-to. Un recorrido tortuoso hecho de senderos intransitables e incomu-nicados, en absoluto lineares. Eso se debe a que el mundo de los hu-manos es una red compleja y tupida de relaciones y las relacionesentre hombres y naciones encajan en un imperfecto y frágil mecani-smo de equilibrios. Desde la antigüedad, la guerra, considerada co-mo mero enfrentamiento, viene fascinando a los grandes pensadoresde la Humanidad, volviéndose objeto de profundizadas discusiones.
Somalia 1995: Operación «Ibis 3», Leonardo Prizzi (pág. 116).Operación «Ibis 3» o «Somalia 3», es la denominación italiana de laoperación multinacional llamada «United Shield» («Escudo Unido»).La operación ha sido desarrollada para permitir la retirada de So-malia del contingente de los Cascos Azules de la ONU en 1995.Con el «United Shield» finalizaba la operación «UNOSOM II» y conésta se agotaban las esperanzas de la comunidad internacional deiniciar un proceso de pacificación en ese territorio. Un problemaaún pendiente, cuyas repercusiones siguen atormentando esa re-gión y haciendo peligrar la seguridad internacional.
143 - RUBRICHE
Rivista Militare n. 3/2010
Myanmar ou Birmânia: diálogo mais do que sanções, de Gio-vanni Bucciol (pág. 16).Myanmar é o acrónimo que indica a antiga Birmânia, formadopelas iniciais das sete etnias que compõem o Estado. Deve-seà Junta Militar, em 1988, a mudança de denominação, quandoesperava contrastar as correntes separatistas, especialmentedos Kachin do Norte, dos Shan do Centro e dos Karen do Sul. Após a dura repressão efectuada pelo Governo contra osmonges e a população em Outubro de 2007, desceram à are-na as mais importantes organizações internacionais paraapoiar as instâncias de liberdade e de bem-estar viradas pa-ra um são desembocar democrático da situação. Todavia,empresas estatais indianas, chinesas, tailandesas e até euro-peias e americanas não hesitam em fazer «negócios de ouro»,com a Junta. Esta última pretende proceder com reformas bu-rocráticas e sociais, porque sente a pressão dos com-sóciosda ASEAN, (Associação dos Países do Sudeste Asiático), daqual faz parte desde 1997. A Comunidade Internacional que-ria que fosse a China a pressionar a Junta pelos seus exces-sos sobre a população e sobre os prisioneiros políticos. To-dos, incluindo a Itália, estão de acordo em privilegiar o diálo-go para conseguir uma solução razoável. A situação agravou-se ulteriormente com o assustador tsunami que atingiu o paísno início de Maio de 2008.
O Legal Advisor «Táctico» nas operações militares terrestres noestrangeiro, de Enrico Dubolino (pág. 26).O consultor jurídico é hoje, a título completo, um dos compo-nentes essenciais do special staff do Comandante do Contin-gente formado no Teatro de Operações.A experiência maturada no âmbito das operações militares noestrangeiro da última década evidenciou, para além do mais,como a isenção das «missões» delegadas ao consultor jurídicoapresente um «espectro» de potencial implementação forte-mente diferenciada.
Os Alunos Marechais de hoje, de Riccardo Venturini e Luca Gio-vangiacomo (pág. 32).Hoje, o cargo de Comandante de Pelotão requer sempre maiorresponsabilidade, motivação, para além de uma adequada baga-gem de conhecimentos Técnico-Militares. Neste sentido, a for-mação profissional assume uma importância decisiva. Nos últi-mos anos, neste âmbito, a Escola de Sub-Oficiais do Exército re-cobriu um papel central tornando-se a «forja» dos novos Co-mandantes de Pelotão.
United States Sergeants Major Academy, de Raimondo Spasia-no (pág. 38).A United States Sergeants Major Academy de El Paso, no Texas,representa para os Sub-Oficiais do Exército dos Estados Unidosa «casa-mãe» que cria, mantém e completa a sua formação. OInstituto põe em prática vários cursos em benefício dos pesso-al da categoria entre os quais o Sergeants Major Course que éo ápice da formação, mesmo no plano internacional.
A robótica cada vez mais no futuro, de Pietro Batacchi (pág. 48).A guerra do futuro verá uma utilização cada vez mais maciça dossistemas robotizados. Já hoje, a experiência maturada nos cam-pos de batalha nos últimos anos, em particular no Iraque, Afe-ganistão e Paquistão, vai nesta direcção. Se os americanos foramos primeiros a desenvolver as aplicações militares em tal sector,também a Itália se revela um país de vanguarda no âmbito da ro-bótica terrestre.
Especial EOD - Afeganistão: Operação Salam, de Fernando Ter-mentini (pág. 58).A 1 de Fevereiro de 1989, após dez anos de presença no Afe-ganistão, as tropas da ex-União Soviética começam a deixar de-
finitivamente o país. Milhões de minas, ordenhos bélicos não-explodidos (UXOs), material explosivo ainda activo (ExplosiveRemnants of the War - ERW) deixados no terreno pelas TropasSoviéticas e pela resistência afegã, representando um perigo devastas proporções para quem quer que se tente aventurar nopaís. Principalmente minas anti-homem, minas anti-carro e ar-madilhas explosivas precursoras dos modernos IED (ImprovisedExplosive Device). «Armas exóticas», como eram definidas porexponentes do Intelligence dos Estados Unidos, que os Mujahi-deen tinham aprendido a construir em campo coordenados porespecialistas militares da CIA e do ISI paquistanês.
Especial EOD - Operação Salam 2, de Pierluigi Scaratti (pág. 66).A 1 de Fevereiro de 1990 partia, sob a protecção da ONU e commandato semestral, a segunda missão de treino para o desmi-namento a favor das populações afegãs conhecida como «Ope-ration Salam» ou seja, «Operação Paz».
Especial EOD - A luta contra os ordenhos explosivos improvi-sados: Counter-IED, de Giuseppe Fernando Musillo e Domeni-co Spoliti (pág. 68).O fim da Guerra Fria gerou uma série de instabilidades locaisque deram lugar não só a missões de Peacekeeping mas tam-bém a conflitos assimétricos. As nossas Forças Armadas, em talcontexto internacional, são chamadas a coadjuvar Governos lo-cais na obra de Nation Building, com tudo aquilo que daí deri-va, mas também a enfrentar acções terrorísticas que podemcontar com mais um elemento: o engenho explosivo improvi-sado (Improvised Explosive Device - IED), considerado um pe-rigo mais incumbente nos cenários operativos odiernos.
Especial EOD - As Military Search, de Renato Scudicio (pág. 74).As recentes operações conduzidas em teatro iraquiano e afegãopuseram em foco a grande ameaça constituída pelos ImprovisedExplosive Devices e a necessidade de adoptar apropriadas medi-das operativas aptas a enfrentá-la. Neste cenário assumem umpapel determinante as Military Search que, suportadas por umaadequada Intelligence, constituem a maior actividade virada pa-ra o contraste e a neutralização do sistema IED.
Especial EOD - O novo Centro de Excelência Nacional para o C-IED, de Roberto Arcioni (pág. 88).O delicado cenário internacional, sobretudo no âmbito de Tea-tros Operativos estratégicos como aquele afegão, é ameaçadopela presença de antigos inimigos ainda perigosos e activos:minas, ordenhos não-explodidos, ordenhos explosivos impro-visados. Isto levou a um aperfeiçoamento do projecto de con-stituição de um Centro de Excelência nacional para o C-IED, opoder inter-forças, capaz de fornecer apoio adestrativo C-IEDàs Forças Armadas para além de um apoio conceptual e orga-nizativo do Estado Maior da Defesa.
Especial EOD - Presente e futuro da Arma del genio - Entrevi-sta ao General da Brigada António Dibello, Inspector da Armadel genio, ao cuidado de Marco Ciampini (pág. 94).Ao lado das funções institucionais relativas ao desenvolvimen-to doutrinal e tecnico-táctico da própria Arma, põe-se o exér-cito da leadership no sector da Counter-IED e o papel desem-penhado no seio de organismos internacionais.Sobre isto e muito mais, discutimos com o General Dibello, evi-denciando os satisfatórios resultados atingidos e os desafiosfuturos que esperam a Arma del genio.
A guerra no pensamento filosófico, de Sara Greggi (pág. 100).A história do Mundo é dominada pelo antagonismo e pelo con-flito. Um percurso sinuoso feito de caminhos impérvios e de-sconexos, tudo menos lineares. Isto porque o mundo humanoé um cerrado e complexo reticulado de relações e as relaçõesentre Homens e Nações não estão nada mais do que encastoa-das num imperfeito e frágil mecanismo de equilíbrio. Desde aantiguidade a guerra, entendida como um puro combate, fasci-nou os maiores pensadores da Humanidade, tornando-se ob-jecto de discussão aprofundada.
Somália 1995: Operação «Ibis 3», de Leonardo Prizzi (pág. 116).Operação «Ibis 3» ou «Somália 3», é a denominação italianada operação multinacional chamada «United Shield» («EscudoUnido»). A operação foi desenvolvida para consentir a retira-da do contingente, dos «Capacetes Azuis» da ONU, da Somá-lia, em 1995.
RUBRICHE -144