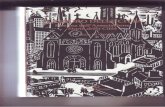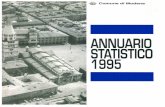La linea daziaria e gli uffici di barriera: il Comune chiuso di Cagliari
Procreazione e bene comune
-
Upload
franciscan -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Procreazione e bene comune
LA DIGNITÀ DELLA PERSONA E IL BENE COMUNE: LA LORO RECIPROCA IMPLICAZIONE NELLA PROCREAZIONE UMANA
MICHAEL W ALDSTEIN
Presidente dell'Istituto Internaifonale per gli Studi su Matrimonio e Famiglia, Gaming, Austria.
Membro del Pontificio Consiglio per la Famiglia
Il documento del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Famiglia e procrea:;jone umana, stabilisce un prudente equilibrio tra due enfasi. Da una parte enfatizza la dignità della persona come «un centrale criterio assoluto» (n. 15), che proibisce il mero uso delle persone come cose o mezzi da parte del potere statale, o da parte di qualsiasi altro potere umano. Dall'altra, oppone resistenza «all'individualismo» enfatizzando «la solidarietà» tra le persone (n. 8) nell'impegno per il« bene comune», una solidarietà in cui (qui il documento cita San Tommaso D'Aquino) «ogni singola persona è rispetto all'intera comunità una parte dell'intero» 1 (n. 20).
Una cosa è chiara: l'equilibrio tra la dignità della persona e il bene della comunità non è qualcosa di ovvio. Il ventesimo secolo ha conosciuto gli effetti devastanti che entrambi gli estremi sono in grado di generare: rispettivamente, il violento collettivismo dei regimi nazista e stalinista, che trattano le persone come meri mezzi in vista del (supposto) bene dello Stato, e il violento individualismo delle società liberali, che sottopongono il debole (come i non nati, gli anziani e i malati terminali) alla personale e libera scelta del forte.
Come è possibile mantenere un equilibrio tra la dignità della persona umana e il bene comune in modo che non sia un falso e instabile compromesso tra opposti inconciliabili, ma un'implicazione naturale e necessaria di ogni aspetto nell'altro? Due sezioni del documento sono particolarmente importanti per la risposta a tale domanda. Là dove lette
1 SAN ToMMAso, Summa Theo!., II-II, q. 64, a 2, c.
125
Pontificio Consiglio per la Famiglia, Famiglia e procreazione umana: Commenti sul documento (Libreria Editrice Vaticana: Vaticano, 2005) 125-150.
insieme queste mostrano come la dignità della persona e il bene comune siano profondamente uniti nella procreazione umana:
• «La trasmissione della vita e la dignità della persona umana» (Famiglia e procreaifone umana, n. 15)
• «La famiglia e la società» (Famiglia e procreaifone umana, n. 20).
La Dignità della Persona
Il documento del Pontificio Consiglio per la Famiglia spiega il concetto eli dignità della persona in parziale accordo con la «norma personalistica» proposta da Emanuele Kant.2 Allo stesso tempo il documento espone il vero fondamento della dignità (n. 15).
L'affermazione della dignità della persona costituisce, senza alcun dubbio, una delle realtà più ricche e importanti della civiltà contemporanea. Kant indica la differenza tra cosa e persona; quella è un mezzo, questa è sempre un fine. La cosa ha un prezzo e si può scambiare, la persona è di un valore infinito e non ammette scambio con nient'altro. Il pensiero cristiano non solo assume questa considerazione, ma ne mostra anche il fondamento: la persona umana ha un valore infinito perché è immagine di Dio; e ancora di più, perchè è amata da Dio.
Questo testo formula come prima cosa la norma personalistica: la persona non è mai un semplice mezzo, ma sempre un fine; poi spiega la norma indicando il suo vero fondamento: la persona è immagine eli Dio ed è amata da Dio. Una certa convergenza con Kant nell'affermare la norma personalistica procede di pari passo con una profonda divergenza da questi nella spiegazione eli questa norma. È importante (in particolare al fine eli afferrare la relazione tra la persona e il bene comune nella procreazione umana) essere consapevoli eli entrambi gli aspetti del concetto eli dignità umana in Famiglia e procreaifone umana.
2 Per il concetto di «norma personale» vedi KAROL W OJTYLA, Amore e Responsabilità, San Francisco: Ignatius Press, 1993, 27-8. I concetti « personalismo » e « personalistico » non sono usati da Kant. Ciononostante si può parlare con buone ragioni di « personalismo kantiano ». Vedi KAROL W OJTYLA, La persona che agisce, Boston: Reidel, 1979, 302, nota finale 8; e CHARLES DE KoNINCK, «Sulla Priorità del Bene comune contro il Personale», Rivista Aquinas 4 (1997): 1-71, qui 68, nota a piè di pagina 72.
126
a) Concetto della Dignità Umana in Kant
A fondamento del concetto di dignità umana in Kant c'è quello di autonomia. Per affrontare il suo concetto di autonomia è bene cominciare dalla sua distinzione tra «materia» e « forma» del volere. La «materia» del volere è il bene e il male che noi incontriamo nella nostra esperienza. Ad esempio, il cibo è qualcosa di buono per noi quando siamo affamati. Quando desideriamo mangiare, quest'azione è, nella sua attrattiva per noi, la «materia del volere». La «forma» del volere è invece l'universalità (fai questo sempre) o la particolarità (fai questo adesso, in questo caso) della norma per mezzo della quale la volontà orienta se stessa.
Kant sostiene che la materia del volere, cioè il bene e il male nella nostra esperienza, condivide una caratteristica con l'intero regno dell'esperienza dei sensi: essa è empirica, particolare, caotica e, in ultimo, irrazionale. Quello che a noi sembra bene dipende dalla nostra inclinazione (Neigung), cioè da quello che al momento comporta piacere. «Di nessun oggetto che ci si presenti, qualsiasi esso sia, possiamo sapere a priori se questo sarà conforme al piacere o al dolore o se sarà indifferente». 3 Kant conclude che quindi «la materia» del volere non può essere posta a fondamento di una legge morale universale.
Alla luce di questa conclusione è possibile scorgere sia la fondamentale convergenza che la divergenza di Kant dal suo nemico principale: l'Utilitarismo. Kant è d'accordo con l'Utilitarismo nel ritenere la nostra inclinazione verso il piacere o la felicità ciò attraverso cui noi giudichiamo qualcosa come «bene» o «male» nella nostra esperienza. «Bene» è ciò che è utile in quanto comporta piacere o felicità, «male» è ciò che non è utile in questo senso, ma dannoso. Egli si oppone invece all'Utilitarismo in quanto rifiuta di considerare il piacere o la felicità motivi legittimi di azioni morali.
Tutte le inclinazioni insieme (che possono anche venir ridotte in un sistema tollerabile, e la soddisfazione delle quali in questo caso si chiama felicità) costituiscono l'egoismo (solipsismus). Questo è l'egoismo dell'amore di sé, di una benevolenza verso se stesso (philautia) che supera tutto, o l'egoismo della compiacenza di se stesso (arrogantia). 4
Il principio della propria felicità, che alcuni innalzano a principio supremo della moralità, si pone in serio contrasto con il comandamento [che prescrive, «Ama Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te
3 KANT, Critica della Ragion Pratica [traduzione nostra]. 4 KANT, Critica della Ragion Pratica (Laterza) 129.9.
127
stesso»]. Il comandamento dovrebbe essere riformulato come: Ama te stesso sopra ogni cosa, e sia Dio che il tuo prossimo per il tuo interesse.5
Il principio per cui noi agiamo in vista della nostra felicità è il più biasimevole ... perché pone a base della moralità moventi che invece la affossano e annientano tutta la sua sublimità, in quanto collocano nella medesima classe [cioè, piacere o felicità] i motivi della virtù e del vizio, e insegnano solo a far meglio i calcoli, dissolvendo interamente la loro differenza specifica; per contro il sentimento morale, questo preteso senso speciale ... resta tuttavia più prossimo alla moralità e alla sua dignità, poiché rende alla virtù l'onore di attribuirle immediatamente il compiacimento e l'alta stima per essa, e non le dice in faccia, per così dire, che a legarci ad essa non è la sua bellezza, ma solo il nostro vantaggio.6
La volontà, dunque, per guidare se stessa non deve guardare alla «materia», ma solamente alla «forma» del volere. Ad esempio, nella massima «Agisci sempre in modo da aiutare i tuoi amici nel bisogno » la materia è il particolare bene in questione O' aiuto offerto ad un amico è qualcosa che rende felici noi stessi), mentre la forma è l'universalità della massima («Agisci sempre»). La volontà non deve guardare alla materia, ma solo alla forma, all'universalità della norma.
L'imperativo categorico deve dunque astrarre da ogni oggetto per tanto che esso non abbia alcun influsso sulla volontà, affmché la ragione pratica (volontà) non amministri semplicemente un interesse estraneo [cioè, l'interesse alla felicità], ma dimostri la propria semplice autorità di comando [Ansehen] come suprema legislazione. Così, ad esempio, io devo cercare di promuovere la felicità altrui, non in quanto sia interessato in qualche modo alla sua esistenza - per inclinazione immediata o per qualche sentimento di compiacimento, indirettamente attraverso la ragione - bensì soltanto perché la massima che escluda quella felicità non può essere concepita, in uno stesso e identico volere, come legge universale. 7
In corrispondenza con la natura razionale della volontà, la forma del volere deve essere universale affinché la volontà sia razionale o buona. Kant arriva così, coerentemente, a quello che chiama «imperativo categorico», che deve informare ogni atto che voglia essere moralmente buono. «Agisci soltanto secondo quella massima per mezzo della quale
128
5 KANT, Critica della Ragion Pratica [traduzione nostra]. 6 KANT, Fonda:::jone della Metafisica dei Costumi (Laterza) 442.11. 7 KANT, Ibid (Laterza) 441.15.
puoi insieme volere che essa divenga una legge universale ».8 «Agisci in modo che la massima del tuo volere possa essere sempre e allo stesso tempo valida come principio di una legislazione universale ».9 Questo imperativo è «categorico» in quanto richiede semplicemente un'azione: «Agisci!». Sarebbe, invece, «condizionale», e non categorico, se suggerisse semplicemente un'azione in quanto mezzo per raggiungere un fine desiderato, come sostengono gli Utilitaristi: «Se vuoi essere felice, agisci in questo modo!».
L'imperativo categorico prescrive solamente la forma universale dei principi morali; non dice nulla sulla materia del volere. La volontà, dandosi questa legge pratica universale, è così completamente indipendente dal regno del bene e del male, regno che Kant considera essere tutto per gli U tilitaristi.
Dunque non può mai esser tenuto per legge pratica un precetto pratico, che implichi una condizione materiale e quindi empirica. Infatti la legge della volontà pura, che è libera, pone questa in una sfera del tutto diversa dall'empirica; e la necessità che essa esprime può consistere semplicemente nelle condizioni formali della possibilità eli una legge in genere. Ogni materia delle regole pratiche si fonda sempre su condizioni soggettive, le quali non procurano loro, per esseri razionali, nessun'altra universalità se non l'universalità condizionata (nel caso io desideri questa o quella cosa, che cosa debbo fare per effettuarla), e si riferiscono tutte al principio della .ftlicità propria.1 0
Se si agisce secondo l'imperativo categorico la volontà non segue una legge al di fuori di se stessa ma essa detta la legge a se stessa. «La volontà non è dunque soltanto sottoposta alla legge, bensì le è sottoposta in modo tale che deve necessariamente essere considerata anche come auto-legislatrice e, appunto perciò, prima di tutto sottoposta alla legge della quale può considerarsi autrice essa stessa ».11 La volontà, come potere razionale che agisce secondo l'universale e non secondo condizioni empiriche, comanda a se stessa di agire come legislatrice universale. Questo è il vero significato dell'imperativo categorico. Questo è un imperativo di autonoma e universale legislazione per se stessi e per ogni essere razionale.
8 KANT, Ibid. (Laterza) 421.6. 9 KANT, Critica della Ragion Pratica [traduzione nostra].
1° KANT, Critica della Ragion Pratica (Laterza) 60. 11 KANT, Fonda:::jone della Metafisica dei Costumi (Laterza) 431.21.
129
Il concetto kantiano eli autonomia ed eteronomia è radicato in questa proprietà della volontà eli essere auto-legislatrice. L'autonomia può essere definita negativamente come la completa indipendenza della volontà da ogni motivo del bene o del male, ossia, da ogni oggetto eli desiderio. In senso positivo essa può essere definita come assoluta autodeterminazione della volontà secondo la forma della legge universale. L'eteronomia, al contrario, è la condizione della volontà quando è motivata da qualche bene o male incontrato nell' esperienza.12
È importante essere chiari su queste definizioni kantiane. Queste sono così radicali che vi è la tentazione di ridurle al senso comune, contrariamente a quella che è invece l'intenzione eli Kant. In greco classico, una città è chiamata eteronoma quand'è dipendente e sottomessa alla legge (nomos) eli un'altra (heteros) città; è invece autonoma quando è indipendente e sottostà alla propria legge (nomos), una legge che essa applica a se stessa (autos). Per Kant, però, la distinzione tra autonomia ed eteronomia non si fonda su queste distinzioni eli persone o eli corpi politici. Essa, invece, si fonda sulle due sfere che si trovano in ciascun essere umano: la sfera dell'esperienza con cui ci rapportiamo al bene e al male, e la sfera della ragion pura antecedente a ogni esperienza, antecedente a ogni bene e male. Io sono autonomo quando voglio ciò che voglio senza essere motivato da qualsivoglia bene o male, cioè, quando agisco secondo l'imperativo categorico. Cado nell'eteronomia quando voglio qualcosa perché è buona. Raggiungo l'autonomia e la libertà solo quando la mia volontà è completamente indipendente dall'intera sfera dell'esperienza. «La libertà sarebbe la proprietà eli tale causalità per cui essa può essere efficiente indipendentemente da cause estranee (un'indipendenza che la ragione deve sempre rivendicare per se stessa) che la determinino».13
Il concetto kantiano eli dignità dell'essere umano deriva dal suo concetto eli autonomia. Kant elice «l'idea della dignità eli un essere umano che obbedisce a nessun'altra legge se non a quella che egli simultaneamente dà a se stesso ».14 La bontà e il valore eli una volontà che obbedisce alla legge non deriva dalla sua obbedienza alla legge in quanto legge che è saggia e buona, ma dalla forza della volontà in quanto vera e universalmente legislatrice. Essere un inizio causale assoluto nella forma eli autolegislazione universale, antecedente alla distinzione tra bene e male, questo
130
12 Vedi il IV Teorema in Kant, Critica della Ragion Pratica (Laterza) 58.16. 13 KANT, Fonda;;;jone della Metafisica dei Costumi (Laterza) 446.5. 14 KANT, Fonda;;;jone della Metafisica dei Costumi [traduzione nostra].
è il cuore della dignità umana. Per Kant, sicuramente, questa priorità rispetto al bene e al male non significa essere semplicemente liberi, come legislatori, di determinare cosa sarà moralmente buono o cattivo. La legge morale sorge necessariamente dalle strutture della ragion pura.
Alla luce di questo concetto della dignità umana, si coglie l'insegnamento di Kant sulla norma personalistica, la quale comanda che le persone non possono essere mai trattate come meri mezzi, ma sempre come fini.
Mentre l'uomo è abbastanza profano, l'umanità nella sua persona deve essere a lui sacra. In tutta la creazione, ogni cosa che uno può volere e sulla quale esercita potere può essere usata come un mero mezzo. Solo l'uomo stesso e con lui ogni essere razionale è fine in se stesso. Perché, in virtù dell'autonomia della sua libertà, egli è il soggetto della legge morale, che è sacra. 15
Kant sostiene che solo quello che ha valore intrinseco può essere un fine in se stesso. «La sola condizione sotto la quale qualcosa può essere fine in se stesso è quando questo qualcosa ha un valore che non è meramente relativo, cioè ha un prezzo, ma quando ha un valore proprio, cioè, la dignità». 16 Ma nella sfera dell'esperienza ogni bene ha solamente un valore relativo, un prezzo, perché il bene e il male nella sfera dell'esperienza dipendono da quella che è l'inclinazione del soggetto. La sola cosa veramente preziosa alla quale qualsiasi altra cosa deve conformarsi, e che di per sé è un fine, è l'autonomia della persona.
Per quanto riguarda l'uomo (e tutti gli esseri razionali nel mondo) come essere morale non si può chiedere di più: per quale fine (quem in finem) egli esiste? La sua esistenza ha il suo fine ultimo in se stessa. Egli può, per quanto è possibile, piegare la natura intera a quel fine. Quanto meno, egli non deve sottomettersi a nessuna influenza della natura contraria al suo scopo. Adesso, se gli esseri del mondo, in quanto esseri che sono contingenti nella loro esistenza, hanno bisogno di una causa superiore per agire secondo il proprio fine, allora l'uomo è il fine ultimo della creazione. Perciò senza l'uomo la catena dei fini subordinati l'uno all'altro non sarebbe spiegata nella sua interezza. È solamente nell'uomo, e nell'uomo solo in quanto soggetto di moralità, che vi può essere una legislazione incondizionata riguardo ai fini, legislazione per
15 KANT, Critica della Ragion Pratica; vedi anche Fonda::jone della Metafisica dei Costumi, e Metafisica dei Costumi [traduzione nostra].
16 KANT, Fonda::jone della Metafisica dei Costumi [traduzione nostra].
131
cui lui solo diviene il flne ultimo al quale l'intera natura è teologicamente subordinata.17
La grandezza cosmica della visione kantiana in questo testo non dovrebbe oscurare un semplice fatto aritmetico. Ogni persona è il fine cltimo dell'universo. Ci sono tanti fini cltimi quante sono le persone. Ogni persona è veramente una totalità, un universo in se stesso, inteso nel senso più forte possibile, vale a dire, il fine cltimo dell'intero universo. Le diverse persone non si uniscono come se fossero parti di un più grande insieme avente un fine più alto. Ognuno è, in un senso finale e definitivo, l'intero in quanto lui o lei è il fine cltimo dell'intero.
Il personalismo kantiano: secondo Kant l'uomo è un flne in se stesso. Il flne ultimo ... è la persona in se stessa nella propria dignità. Questa dignità non proviene dalla persona in quanto è in grado di raggiungere il flne ultimo dell'universo, cioè, un flne che è altro rispetto alla persona; la persona riceve la dignità da se stessa perché essa è il proprio fme e realizza in se stessa la libertà dell'autonomia. 18
Questo concetto della dignità della persona umana ha un profondo impatto sci concetto kantiano del bene comune. La persona ha già in sé il fine cltimo come un bene personale e privato. Nessun bene comune potrebbe competere con la bontà di questo fine. Si può osservare particolarmente bene la posizione kantiana nel seguente testo.
Un governo che fosse fondato sul principio della benevolenza verso il popolo, come di un padre verso i suoi flgli, vale a dire un governo paterno (imperium paternale), dove dunque i sudditi, come i flgli minorenni, che non sanno decidere cosa sia loro veramente utile o dannoso, siano costretti a comportarsi in modo puramente passivo, così da dover aspettare soltanto dai giudizi del capo dello Stato come debbano essere felici, e quando questi pure lo conceda loro, solo sulla bontà: questo governo è il massimo dispotismo pensabile (la costituzione che toglie ogni libertà ai sudditi, che perciò non hanno affatto diritti). Non paterno, ma patriottico (imperium non paternale, sed patrioticum) è invece solo quel governo che possa essere pensato solo per uomini capaci di diritti, anche in rapporto alla benevolenza del sovrano.19
17 KANT, Su un Tono Nobile recentemente assunto in Filosofia, AK 8.435-6 [traduzione nostra].
18 DE KoNINCK, ((Sulla Suprema'(ja del Bene Comune su quello Personale;>, 68, nota a piè di pagina 72 [traduzione nostra].
19 KANT, Sul Detto Comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi, (Laterza) p. 138.
132
Il superlativo in questo testo è sbalorditivo: il più grande dispotismo immaginabile. Qual'è il più grande dispotismo immaginabile? Sarà uno Stato schiavista nel quale il suo capo non agisce per il bene comune dei cittadini, ma li governa per i suoi scopi privati? Se si risponde: « Sì! Questo è il più grande dispotismo immaginabile!» ci si imbatte nella controquerela di Kant: «No, uno Stato posto sotto la benevolenza di un padre che si propone il bene comune dei cittadini, questo è il dispotismo superlativo. La paternità è la suprema forma di dispotismo, la condizione di figlio la suprema forma di schiavitù».
Questo superlativo sbalorditivo può essere compreso alla luce della visione kantiana dell'autonomia. Se lo Stato avesse come scopo la felicità dei suoi cittadini, getterebbe gli stessi in quel ruolo che hanno i figli sotto un padre benevolo. Poichè la condizione di figlio implica dipendenza dal padre, questa è incompatibile con la dignità umana quale dignità che risiede nell'autonomia. La sottomissione filiale ad un padre benevolo distrugge l'autonomia ancor più radicalmente di quella degli schiavi sottomessi ad un violento padrone, perché implica una sottomissione spirituale e interiore oltre a quella esterna nelle azioni. Il cuore di uno schiavo può appartenergli; il cuore di un vero figlio appartiene al padre. Lo scontro diretto tra l'insegnamento di Kant sull'autonomia e la preghiera del Signore è notevole. Se «Padre Nostro» è in effetti la preghiera paradigmatica dei Cristiani, allora la distruzione della dignità umana, cioè l'eteronomia della condizione di figlio, è al ·centro della Cristianità.
Kant, almeno a parole, integra il bene comune nel suo sistema ma in un modo totalmente differente rispetto a quello della filosofia classica e della teologia cattolica.
La massima safus publica suprema civitatis !ex est [il bene pubblico è la suprema legge dello Stato] rimane in tutto il suo valore e autorità, ma la salute pubblica, che deve per prima essere presa in considerazione, è proprio quella costituzione legale che assicura ad ognuno la sua libertà per mezzo di leggi; dove rimane impregiudicato per ciascuno cercare la felicità per la via che gli sembra migliore, purchè non rechi danno a quella universale libertà secondo leggi, e dunque ai diritti degli altri con sudditi.20
2° KANT, Sul Detto Comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi, (Laterza) p. 145.
133
Che cosa è esattamente la salus publica, il bene comune dello Stato, secondo questo testo? Un primo punto da notare è che il bene comune non è di per sé collegato alla felicità. La ricerca della felicità è una ricerca radicalmente individuale o personale, perché avviene nell'irrazionale, individuale, accidentale e caotico mondo dei sensi dell'esperienza che è, secondo Kant, correttamente analizzato dall'Utilitarismo. Al contrario, la legge che impone armonia tra tutte le volontà (nel senso in cui impedisce che le persone violino gli uni i diritti e le libertà degli altri) procede dalla ragion pura come necessaria implicazione del movimento degli esseri razionali che interagiscono l'uno con l'altro. Quest'armonia non è ricercata per amore della stessa, cioè in quanto è qualcosa di buono. In quanto buona dovrebbe, dunque, appartenere alla sfera dell'esperienza e alla ricerca individuale della felicità, non a quella della ragione e della legge.
Kant applica il titolo salus publica direttamente alla «costituzione legale» dello Stato che esiste «per assicurare ad ognuno la propria libertà attraverso le leggi». Il bene comune dello Stato è così un bene meramente utile ordinato al bene privato di ciascun individuo nella propria autonomia. Attraverso le sue leggi, lo serve la libertà personale di ciascuno. Questa conclusione si adatta con la tesi chiave di Kant per cui, in virtù dell'autonomia, l'individuo è la sola cosa che può essere considerata fine in modo assoluto. Nessun bene comune può competere con questo fine personale e privato che è già presente in ogni persona. Essere una persona ed essere una parte di un più grande insieme unito dal bene comune è contrario alla dignità stessa della persona. Non esiste bene più grande che quello privato della dignità di ogni persona.
b) Il vero fondamento della dignità umana
È evidente che il documento Famiglia e procreazione umana non segue Kant, non può, in questa visione radicalmente individualistica e anticristiana della dignità personale. L'accordo con Kant sulla norma personalistica va di pari passo con un profondo disaccordo sul vero fondamento e significato di questa norma. Come affermato al n. 15, «la persona umana ha un valore infinito, perché è immagine di Dio; e ancora di più, perché è amata da Dio». Per spiegare il significato di queste affermazioni, il documento si riferisce alla sezione del Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) relativa all'« Immagine di Dio».
134
Di tutte le creature visibili, soltanto l'uomo è « capace di conoscere e di amare il proprio Creatore»; [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et Spes, 12] «è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa»; [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et Spes, 12] soltanto l'uomo è chiamato a condividere, nella conoscenza e nell'amore, la vita di Dio. A questo fine è stato creato ed è questa la ragione fondamentale della sua dignità. Quale fu la ragione che tu ponessi l'uomo in tanta dignità? Certo l'amore inestimabile con il quale hai guardato in te medesimo la tua creatura e ti sei innamorato di lei; per amore infatti tu l'hai creata, per amore tu le hai dato un essere capace di gustare il tuo Bene eterno [Santa Caterina da Siena, Dialogh~ 4, 13, cf Liturgia delle Ore, IV, Ufficio delle letture della diciannovesima domenica]. Essendo ad immagine di Dio, l'individuo umano ha la dignità di persona; non è soltanto qualche cosa, ma qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con altre persone; è chiamato, per grazia, ad una alleanza con il suo Creatore, a dargli una risposta di fede e di amore che nessun altro può dare in sua sostituzione (CCC 356-7).
«La ragione fondamentale» della dignità della persona, secondo questo testo, sta nel fine per cui la persona è stata creata, cioè per condividere la vita di Dio, la sua felicità. Ciò che viene prima nell'ordine della fondazione è questo fine, la vita di Dio, che è infinitamente buona e felice. La bontà e la felicità infinita di questa vita è la ragione per cui è il fine ultimo. Ciò che segue è la decisione di Dio, per un disegno di pura bontà, di creare l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata (cf CCC, 1).
Questo è ciò che si vuol significare quando si afferma che la persona umana «è l'unica creatura sulla terra che Dio ha voluto per se stessa». «Per se stessa» significa «per il suo beneficio». Dio tratta l'uomo «come un fine», non come il bene infinito a cui tutte le cose sono ordinate, ma piuttosto come l'essere diletto con il quale vuole condividere quel bene, che è la sua felicità. 21 Per rispondere alla domanda se Dio ha fatto tutte le cose per amore dell'uomo, San Tommaso scrive:
È in modi differenti che l'uomo e la divina bontà sono chiamati « fine ». Poiché, da patte dell'agente [cioè di Dio come creatore] la bontà divina è il fine delle cose come fondamentalmente inteso dall'agente. La natura umana, al contrario, non è intesa da Dio come quella che muove la sua volontà, ma come quella al cui beneficio l'effetto [di quella volontà] è ordinato.22
21 Cf SAN ToMMASO, Contra Genti/es, 3.112. 22 SAN ToMMAso, Il Sent., d. 1, q. 2, a. 3, c [traduzione nostra].
135
«La persona è eli un valore infinito» (Famiglia e procreazione umana, n. 15). Nessuna persona creata ha un valore infinito nel senso di essere il bene infinito, la felicità divina, ma piuttosto nel senso di esserne capace e eli essere chiamato dall'amore eli Dio a condividerla. La condizione fondamentale di questo valore infinito è la natura che rende una persona, in primo luogo, una persona. È questa natura che permette alla persona di comprendere i fini e perseguirli.
[La] persona non può essere per gli altri solo un mezzo. È la natura stessa della persona, ciò che essa è, ad escluderlo. Nella sua interiorità noi scopriamo il suo duplice carattere di soggetto in grado contemporaneamente di pensare e di potersi auto-determinare. Ogni persona è quindi, per natura, capace di definire i propri fini. Trattandola unicamente come un mezzo, si lede la sua stessa essenza, quel che costituisce il suo diritto naturale.23
In Kant, il punto chiave non è che la persona possa comprendere e perseguire i fini, ma che essa è il fine ultimo. La dignità della persona, che consiste nell'autonomia, è essa stessa il valore più alto e, pertanto, il solo e unico fme. Ogni cosa nel cosmo può e deve esservi subordinata. A questo riguardo, la norma personalistica, così come la intende Kant, è il diretto opposto della norma stessa come la intende Wojtyla.
Emanuele Kant ha formulato il seguente imperativo: agisci in modo tale da non trattare mai la persona altrui semplicemente come un mezzo, ma sempre anche come il fine della tua azione. Alla luce delle considerazioni precedenti, questo principio personalistico ordina: ogni volta che nella tua condotta una persona è oggetto della tua azione, non dimenticare che non devi trattarla soltanto come un mezzo, come uno strumento, ma tieni conto del fatto che anch'essa ha, o perlomeno dovrebbe avere, il proprio fine. Così formulato, questo principio si trova alla base di ogni libertà rettamente intesa e soprattutto della libertà di coscienza?4
La comprensione eli Wojtyla della norma personalistica, che esprime il consenso della philosophia perennis e la tradizione teologica cattolica, è «piuttosto differente» da quella eli Kant. Essere un fine differisce dall'avere un fine; essere il bene più alto differisce dall'essere il beneficiario del bene più alto; essere Dio differisce dall'avere Dio.
136
23 WoJTYLA, Amore e Responsabilità, Ed. Marietti, Torino, p. 17. 24 lbid., p. 18.
Procreazione e bene comune
a) La norma personalistica e il bene comune dell'uomo e della donna
Immediatamente dopo aver discusso della norma personalistica in Amore e Responsabilità, Wojtyla solleva la questione di come l'uomo e la donna possono trattarsi come persone, con fini propri, più che semplici cose, come strumenti per un qualche fine. Egli vede la risposta nel bene comune che unisce l'uomo e la donna. Senza questo bene comune, afferma, l'autentico amore è impossibile.
Noi sappiamo che è permesso tendere a che un'altra persona voglia lo stesso bene che vogliamo noi. È evidente che bisogna che essa conosca il mio fine, che lo riconosca come un bene e lo adotti. Allora, tra questa persona e me, si crea un legame particolare che ci unisce: il legame del bene e quindi del fine comune. Questo legame non si limita al fatto che due esseri tendano insieme a un bene comune, ma unisce anche dall'interno le persone che agiscono, e in questo modo costituisce il nucleo di ogni amore. In ogni caso non si può immaginare un amore tra due persone senza questo bene comune che le leghi e che sarà nello stesso tempo il fine che avranno scelto insieme.25
In questo testo, Wojtyla mostra l'esistenza di una connessione necessaria ed organica tra la norma personalistica e il bene comune. La norma personalistica proibisce l'uso di altre persone come semplici strumenti per i propri fmi e richiede che si permetta il fatto che anche l'altra persona ha fini propri. Quando un fine verso il quale un uomo e una donna si dirigono è unico e uguale, cioè, quando questo fine è un autentico bene comune, allora è costituito il nucleo essenziale dell'amore. Senza questo nucleo, non si può evitare di usare l'altra persona, il che è contrario alla dignità della persona. «Quel che determina la capacità di amare è il fatto che l'uomo sia disposto a cercare il bene coscientemente, insieme ad altri uomini, e che sia pronto, in considerazione degli altri, a subordinarsi a questo bene ».26
Il rapporto sessuale tra un uomo e una donna, sostiene Wojtyla, è particolarmente incline al mero uso di una persona da parte dell'altra, in parte a causa della grande intensità del piacere sessuale. È pertanto par-
25 WoJTYLA, Amore e Responsabilità, Ed. Marietti, Torino, p. 19. 26 Ibid., p. 20.
137
ticolarmente necessario, in questa relazione, che l'amore si formi attorno al bene comune.
Come impedire che una persona diventi per l'altra - la donna per l'uomo, l'uomo per la donna - un oggetto di cui ci si serve per raggiungere i propri fini? Per riuscirvi, bisogna che tutte due abbiano un bene comune. Nel matrimonio, sarà la procreazione, la discendenza, la famiglia, e nello stesso tempo la crescente maturità nei rapporti di due persone su tutti i piani della comunità coniugale. 27
Nella sua Lettera alle Famiglie1 Giovanni Paolo II torna in maggiore dettaglio alla discussione del bene comune del matrimonio che apre la sua discussione sull'amore sponsale in Amore e Responsabilità. Partendo dalle parole del consenso pronunciate dal marito e dalla moglie nel matrimonio (cf LF, 10,1), egli dirige l'attenzione sulla comunione di persone da esso create: «l'amore, la fedeltà, l'onore, la durata della loro unione fino alla morte» (n. 10,2). Questo bene della comunione di persone nel matrimonio è il bene di entrambi e, allo stesso tempo, di ciascuno. «Il bene comune, per sua natura, mentre unisce le singole persone, assicura il vero bene di ciascuna» (n. 10,2). Poiché il matrimonio è un sacramento, il bene comune in questione è più profondo di una mera comunione umana di persone. È un «grande mistero» (Ef 5,32) di grazia, di partecipazione alla vita della Trinità (cf LF, 10,2).
Il bene comune della comunione tra marito e moglie si estende allora per diventare il bene comune della famiglia. Prima che gli sposi diano il loro consenso, la Chiesa chiede loro se sono preparati ad accettare i figli e ad educarli nella fede. Procreazione e educazione sono bene comune chiave di moglie e marito che specificano la natura del loro consenso, e diventano bene comune chiave dell'intera famiglia.
Le parole del consenso esprimono, dunque, ciò che costituisce il bene comune dei coniugi e indicano ciò che deve essere il bene comune della futura famiglia. Per metterlo in evidenza la Chiesa domanda loro se sono disposti ad accogliere e ad educare cristianamente i figli che Dio vorrà loro donare (LF, 10,3).
Il bene comune della famiglia è particolarmente evidente nella preghiera.
27 Ibid., p. 21.
138
La preghiera conferma più saldamente tale bene, proprio come bene comune familiare. Anzi, essa dà anche inizio a questo bene, in modo sempre rinnovato. Nella preghiera la famiglia si ritrova come il primo «noi» nel quale ciascuno è «io» e «tu»; ciascuno è per l'altro rispettivamente marito o moglie, padre o madre, figlio o figlia, fratello o sorella, nonno o nipote (LF, 10,5).
Padre, madre, figlio, figlia, fratello o sorella, tutti sono membri della famiglia. Ciascuno è definito da particolari relazioni di appartenenza nella famiglia come un intero. Ogni singola persona è rispetto all'intera comunità una parte dell'intero, in questo caso ogni persona è parte della famiglia (cf Famiglia e procreazione umana, n. 20). Essere parte dell'intero sotto un bene comune non minaccia la dignità della persona, al contrario l'afferma, l'esprime e l'aumenta.
In forma più condensata, il documento traccia la stessa argomentazione usata da Wojtyla per mostrare che la norma personalistica porta logicamente al bisogno di un bene comune. La dignità personale del bambino esige che egli sia nato in una famiglia veramente unita dal bene comune di comunione.
All'essere umano spetta non solo essere generato, ma esserlo nell'ambito di una famiglia. Soltanto la famiglia, realtà sorta dall'amore poiché un uomo e una donna si consegnano reciprocamente, costituisce l'ambiente adeguato perché venga alla vita un nuovo essere umano, cioè un essere dotato di dignità e chiamato ad essere amato (FPU, 15).
In questo contesto, il documento del Pontificio Consiglio indica anche le numerose conseguenze etiche che derivano dalla dignità della persona nella procreazione, e che sono elaborate in Humanae Vìtae, Donum Vìtae e Evangelium Vìtae, tra altri documenti (cf FPU, 15-17).
b) <<Bene comune J) e «essere parte;;
Prima di andare avanti nella spiegazione dell'equilibrio tra dignità della persona e bene comune nell'esposizione sulla procreazione umana da parte del documento del Pontificio Consiglio, è utile fare un passo indietro e chiedere in termini più generali, cosa è un «bene comune»? cosa significa «essere parte» di una comunità sotto un bene comune?
Un bene comune è un bene che molte persone possono condividere senza doverlo dividere o ridurre. Il suo opposto è un bene privato, che è diviso o ridotto quando le persone lo condividono. Una torta di compleanno
139
può essere condivisa da una famiglia e in questa maniera è in un certo modo comune all'intera famiglia. Eppure una torta è essenzialmente e necessariamente un bene privato. Ogni membro della famiglia riceve solo un pezzo di torta, non tutta. Ognuno si appropria di quel pezzo mangiandolo. Gli altri membri della famiglia sono esclusi dal mangiare lo stesso pezzo. La torta di compleanno è divisa e ridotta quando è condivisa dalla famiglia. La pace di una famiglia, per contrasto, è un bene comune in senso pieno, ammesso che sia una pace autentica dell'intero, da cui nessun membro della famiglia è escluso. Quando i membri della famiglia condividono questa pace, essi non diminuiscono la condivisione degli altri familiari. Ogni membro non riceve solo un pezzo di pace, ma la pace intera. Infatti, a meno che ogni membro non partecipi alla pace intera, la parte di tutti gli altri diminuisce, in quanto la pace può esistere solo se ogni persona la condivide.
È importante sottolineare un punto implicito nell'esempio di pace come autentico bene comune. Quando si afferma che «la pace è un bene comune della famiglia,» ciò non vuol dire che è un bene della famiglia contrapposto ai membri della famiglia, un bene della comunità contrapposto alle persone. «Il bene quanto più è comune, tanto più è anche proprio: mio- tuo- nostro» (LF, 10,6). In questo senso il bene comune è, per sua natura, un bene personale. È il bene di molte persone. È questo che vuol dire essere comune.
È difficile essere chiari su questo punto. C'è una tendenza persistente a concepire il bene comune come bene dell'intero sociale come tale, non come il bene delle persone in quell'insieme. L'esempio delle imposte dirette mostra una delle ragioni di questa confusione: beni comuni imperfetti quali il denaro proveniente dal pagamento delle tasse sono, infatti, beni dell'intero sociale in quanto tale, più che veri beni comuni. In un certo senso l'imposta sul reddito raccolta dallo stato è comune, raccolta per il beneficio di tutti. Non si tratta di proprietà privata di nessuna persona nello stato. Persino quando lo stato prende i soldi dai propri cittadini, questi sono consapevoli del fatto che erano un loro bene privato e che ne sono stati privati. Naturalmente, possono attendersi che ciò che lo stato ha preso tornerà a loro beneficio in qualche modo, ad esempio sotto forma di strade o di scuole. Se non tornasse ai cittadini in questo modo, il denaro non potrebbe, in giustizia, essere preso da loro. Neppure questo limitato afflusso di denaro dedicato all'« utilità comune» può na-
140
scondere la natura essenzialmente privata del denaro, che è il bene privato quintessenziale.
Quando è preso dallo stato ai cittadini, il denaro diventa un bene alieno per loro, il bene di un altro. Esso pertanto non soddisfa il requisito basilare di un vero bene comune, cioè, che sia veramente comune. Il denaro derivante dal pagamento delle tasse è un bene della totalità, un bene dell'intero considerato come un quasi individuo nel proprio diritto. In quanto quasi individuo, lo stato può competere con i cittadini che ne sono parte. Possiamo definire un regime totalitario parzialmente in questi termini: un regime è totalitario quando trasforma i cittadini in semplici parti al servizio del bene dell'intero stato considerato come un quasi individuo.
[Il] bene comune non ha il carattere di un bene alieno - bonum alienum - come nel caso di un bene di un altro considerato tale. Non è questo che, nell'ordine sociale, distingue profondamente la nostra posizione dal collettivismo; il secondo si allontana dall'astrazione, richiedendo un'alienazione dal bene proprio in quanto tale e di conseguenza dal bene comune in quanto l'ultimo è il più grande dei beni propri? Coloro che difendono il primato del bene del singolo individuo si oppongono a questa falsa nozione del bene comune.28
In questo testo, «bene proprio» non vuol dire «bene privato». Esso si riferisce ad un bene che è veramente posseduto dalle persone che compongono lo stato. Un vero bene comune è comune solo quando è un «bene proprio » o un «bene personale» in questo senso. Se si prende lo stato come un quasi individuo e si pretende che i beni che gli appartengono in quanto individuo, p.e., il denaro derivante dalle tasse, devono avere, nel cuore dei suoi cittadini, il primato assoluto sul loro bene, si alienano i cittadini dal proprio bene e si sacrificano allo stato. Il risultato è la schiavitù, una completa servilità a scopi che non sono i propri, ma di un altro. Invece, quando c'è un autentico bene comune, come la pace di uno stato, questo appare come un intero e non come un individuo che compete con le persone che lo costituiscono, ma come un tutto costruito precisamente da un vero bene comune, che è veramente il bene di ogni persona.
Nelle discussioni sulla relazione esistente tra bene della persona e bene dello stato, viene posta spesso la domanda se la persona esiste in
28 DE KoNINCK, "On the Primacy of the Common Good against the Personalists", 18 [traduzione nostra].
141
vista dello stato, o lo stato in vista della persona. Non si può rispondere senza prima rispondere a un paio di altre domande, e cioè: «Lo stato è un quasi individuo che può competere con i propri cittadini? O lo stato come un intero composto di persone come parti in quanto tutte queste persone condividono un vero bene comune?». Bisogna pensare mediante ciascuna di queste due alternative. Se le singole persone vivono per il bene dello stato nella prima alternativa, sono ridotte ad una schiavitù in cui non vivono per il loro bene, ma devono servire il bene di un altro in quanto altro, un bene strettamente alieno.29 Se, invece, i membri dello stato vivono per il bene dello stato nel secondo senso, ad es. uno stato in quanto unito da un autentico bene comune, questa schiavitù non esiste. Vivendo per un bene veramente comune, ad· esempio un'autentica pace, i cittadini vivono in vista di un bene che è veramente loro in quanto persone. Non è il bene dello stato opposto alloro, comune opposto a personale, ma loro personalmente in quanto genuinamente comune.
Perciò il bene comune non è un bene diverso dal bene degli individui, un bene che è semplicemente il bene della collettività considerata come un tipo di singolo. In questo caso sarebbe comune soltanto accidentalmente; propriamente parlando sarebbe singolo, o, se volete, differirebbe dal singolo essendo nullius [cioè che non appartiene a nessuno]. Ma quando distinguiamo il bene comune dal bene particolare non vogliamo dire in questo modo che esso non è il bene degli individui; se non lo fosse, allora non sarebbe veramente comune.30
Questo punto è estremamente importante. È facile cadere nella falsa impressione che il bene comune è un bene alieno, particolarmente quando si considera una delle immagini tradizionali usate per illustrare il primato del bene comune, e cioè l'immagine del corpo e delle sue parti, e il sacrificio della parte a favore dell'intero.
Vediamo che ogni parte lavora, per una certa inclinazione naturale, per il bene dell'intero, anche con rischio o danno per il proprio bene, come è chiaro quando qualcuno espone la propria mano ad una spada per difendere la testa, da cui dipende il bene dell'intero. E quindi è naturale che ogni parte ami il bene dell'intero più che se stessa. Secondo questa
29 V d. DE KoNINCK, "On the Primacy ofthe Common Good against the Personalists," 16-7.
30 Jbid, 17 [traduzione nostra].
142
inclinazione naturale, e con la virtù politica, un cittadino espone se stesso al pericolo di morte per il bene comune.31
Questa immagine tradizionale del corpo può facilmente suggerire che il bene comune è un bene alieno. La persona come parte deve sacrificare se stessa per il bene di un altro, cioè della comunità. Si possono chiaramente notare alcune differenze fondamentali tra l'immagine del corpo e la comunità umana. La vita non è un bene comune della mano e della testa nel corpo umano. La vita è un bene proprio dell'intera persona. La mano serve in maniera radicale all'intero, poiché non è un vero beneficiario del bene dell'intero. Essa non conta niente quando è in gioco il bene di tutto il corpo. Naturalmente, questa non è schiavitù per la mano, in quanto essa non è una persona. L'autentico bene comune di uno stato, per contrasto, è il bene di ogni cittadino. Per questa ragione, i cittadini non sono radicalmente serviti allo stato, non sono usati come meri strumenti per preservare il bene di un altro. Le persone che sono parte dello stato valgono qualcosa sotto un bene comune. Essi sono i principali beneficiari del bene comune, non nel senso di trarne un guadagno privato, ma nel senso di condividerlo veramente.
Per chiarire questo punto possiamo usare un esempio tratto dalla vita familiare. Quando un padre sacrifica la vita per la famiglia, il bene comune della famiglia è, proprio in questo momento di sacrificio, maggiormente il suo bene, e non un bene alieno. Se egli si rifiuta di morire e permette la distruzione della famiglia, ad esempio, mangiando tutto il cibo disponibile durante una carestia e riducendo alla fame la moglie e i figli, distrugge il proprio bene, un bene che è maggiore per lui come persona del bene individuale e privato della sua vita.
Il fatto di non riuscire ad essere chiari su questo punto può essere una ragione per cui alcuni sostengono che la nozione di «parte» è radicalmente e universalmente contraria alla dignità della persona.
Soltanto comprendendo ogni funzione sociale parziale come un tipo di maschera, come qualcosa che non contiene in sostanza la profondità del proprio essere personale; soltanto comprendendola come qualcosa che, pur importante, anche per lo sviluppo di una persona in quanto persona, non può mai fornire alla persona la sua intera ragion d'essere, assorbendola come parte della comunità; soltanto comprendendo una società o una comunità come un «tutto composto di interi»: soltanto
31 SAN ToMMAso, Quodlib. 1.4.3 c [traduzione nostra].
143
allora una persona può rimanere intatta come persona nel compiere la funzione. Se viene messo in rilievo un aspetto dell'individualità personale affermando che la persona non è un mezzo strumentale, allora viene messo in rilievo un altro aspetto della stessa individualità affermando che la persona non è mai una semplice parte. Questa incapacità di essere una parte sembra avere lo stesso fondamento metafisica che abbiamo notato prima. Per la nostra consapevolezza morale sembra importare poco se si cerca di fare gli esseri umani parti della società o parti di Dio; la de-personalizzazione inflitta su di loro non è meno penosa nell'ultimo che nel primo caso. Qualunque sia l'intero, anche se è Dio stesso, le persone non possono mai funzionare come mere parti di esso. La religione panteistica esalta ma degrada anche gli esseri umani: rendendoli parti di Dio li rende divini, ma facendoli parti di Dio li annulla come persone?2
Al fine di separare in questo testo la verità dalla falsità, bisogna distinguere tre relazioni parte-intero fondamentalmente differenti.
• Essere parte di un'intera sostanza, così come la mano è parte di un essere umano, è contrario all'essere una persona. È in questo senso che San Tommaso afferma che «l'aspetto di parte è contrario all'aspetto di persona, ratio partis contrariatur rationi personae».33 In questo senso di tutto e di parte, una persona creata può essere solo un tutto, mai una parte.
• Essere parte di uno stato nel senso di servire un bene alieno che appartiene allo stato come un quasi individuo, come nel caso dei regimi totalitari, è una forma di schiavitù ed è contrario alla dignità della persona. In questo senso di intero e di parte, la persona è prima di tutto un intero.
• Essere parte di una comunità condividendo il vero bene comune di quella comunità non è contrario alla dignità della persona. Invece, è richiesto da questa dignità e l'accresce. In questo senso di intero e di parte, le persone create sono alla fine parti e non interi.
32 ]OHN F. CROSBY, The Selfhood of the Human Persona, Washington DC: Catholic University of America Press, 1996, 18-9 [traduzione nostra].
33 SAN ToMMASO, III Sent., d. 5, q. 3, a. 2, c.
144
c) Famiglia e società
Immediatamente dopo aver citato l'affermazione di San Tommaso secondo cui «ogni singola persona è rispetto all'intera comunità una parte dell'intero »,34 il documento Famiglia e procreazione umana ne cita un altro testo importante. «Man is not ordered to the politica! community according to the whole of himself and all that is his » 35 (n. 20, nota 49). Il bene comune proprio della comunità o società politica è un bene specifico tra gli altri. Il Concilio Vaticano II lo definisce «la somma di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente, summa eorum vitae socialis condicionum quae tum coetibus, tum singulis membris permittunt ut propriam peifectionem plenius atque expeditius consequantur» (Caudium et Spes 26,1). In due direzioni, sia prima che dopo, la persona umana va oltre i confini della comunità politica.
Il bene comune della famiglia viene prima di quello della comunità politica. «La famiglia, società naturale, esiste anteriormente allo Stato e a qualsiasi altra comunità e possiede diritti propri, che sono inalienabili» 36
(FPU, 21). La famiglia non è creata dalla comunità politica e non è ad essa soggetta sotto ogni aspetto. «La famiglia, fondata sul matrimonio ... , deve essere considerata il nucleo naturale ed essenziale della società. Verso di essa vanno usati i riguardi di natura economica, sociale, culturale e morale ... » (FPU, 20).37
Dopo il bene comune della comunità politica, troviamo, ad esempio, il bene comune della Chiesa, che è l'Eucaristia. Se la persona umana fosse ordinata alla comunità politica secondo l'intero che la costituisce e il tutto che le appartiene, l'Eucaristia dovrebbe essere negata, come nei regimi comunisti, o lo stato dovrebbe assorbire la Chiesa in sé, come nell'Impero Bizantino.
Il punto di San Tommaso deve essere applicato non solo alla comunità politica ma anche alla famiglia. La persona umana non è ordinata alla famiglia secondo l'intero che la costituisce e il tutto che le appartiene. «Nella società l'orizzonte della vita si apre ad altre dimensioni. La società umana presuppone la famiglia e questa trova nella società il suo compi-
34 SAN ToMMASO, Summa Theol., 11-II, q. 64, a 2, c. 35 Ibid., I-11, q. 21, a. 4, ad 1. 36 Carta dei Diritti della Famiglia, pubblicata dalla Santa Sede nel 1983, Preambolo, D. 37 GIOVANNI XXIII, Pacem in Terris, 9.
145
mento» (FPU, 20). Deve quindi essere chiaro a tutte le famiglie il carattere parziale del bene comune realizzato nella famiglia. Le famiglie non esistono semplicemente per se stesse, ma condividono beni comuni più grandi e universali. Esse educano i bambini affinché questi possano trovare il posto che compete loro e una più grande realizzazione della società.
In questa luce, il documento ramiglia e procreazione umana indica una circolarità tra famiglia e società. «Si verifica una specie di circolarità: la famiglia viene ordinata alla società e questa si ordina al servizio della famiglia. Da un lato la persona e la famiglia sono anteriori, e dall'altra la società si ordina al bene comune della persona e della famiglia» (n. 20).
Questo testo esprime una doppia circolarità tra famiglia e società. La prima è la seguente: da un lato, la famiglia è ordinata alla società nel senso che la società contiene beni comuni che oltrepassano il bene comune della famiglia. Ad esempio, essa contiene il bene comune della giustizia politica. I figli devono essere educati in maniera tale che possano amare tali beni comuni e servirli, collaborando a proteggerli e a nutrirli. Per fare un altro esempio, la maggior parte delle società occidentali soffrono di un grave inverno demografico. Il fatto che le famiglie debbano compiere uno sforzo sostenuto per avere molti figli, sembra far parte del servizio che esse devono rendere alla società. Dall'altro lato, la società è ordinata al servizio della famiglia. Deve proteggerla e nutrirla. Ad esempio, non deve sostituire il lavoro di educazione che ha luogo nella famiglia, ma complementarlo.
La seconda circolarità: da un lato, poiché la persona e la famiglia vengono prima, la società o la comunità politica non possono rivendicare il diritto di disporre di persone e famiglie così come si pensa sia opportuno, ma devono ticonoscerne la preesistente dignità e diritti. Dall'altro lato, pur se la persona e la famiglia vengono prima, la società non è irrilevante per loro. I beneficiari dei beni comuni realizzati dalla società sono proprio queste persone e queste famiglie. La società non è un super-individuo che cerca il proprio vantaggio contro le persone e le famiglie. Se i beni a cui partecipa sono veramente beni comuni, saranno beni delle persone e delle famiglie.
d) Procreazione umana come servizio al bene comune
Esaminiamo ora un punto importante nel ricco insegnamento del documento, e cioè la tesi secondo la quale la procreazione e l'educazione dei figli sono un servizio importante che la famiglia rende alla società e senza il quale la società crollerebbe. Molti mariti e molte mogli possono non essere
146
consapevoli del fatto di avere quest'obbligo pubblico e politico di servire il bene comune della comunità politica. Il loro matrimonio e la loro vita familiare sarebbero arricchiti se fossero consapevoli di questo compito.
Le famiglie hanno un compito simile in relazione alla Chiesa come corpo di Cristo. In un matrimonio sacramentale, la procreazione e l'educazione dei figli è un servizio importante reso al bene comune del corpo di Cristo. In un testo pubblicato per la prima volta nel 1865, poco più di cento anni prima di Humanae vztae, Matthias ] . Scheeben esprime questo servizio al bene comune con grande eloquenza.
Quando si uniscono l'uno all'altro [uomo e donna] possono farlo in giustizia solo per lo stesso scopo per cui Cristo persegue il suo legame con la Chiesa, per estendere il suo corpo mistico. Essi possono agire solo nello Spirito dell'unione di Cristo e la Chiesa e, analogamente, possono agire solo in nome di Cristo e della Chiesa, poiché i loro corpi appartengono a Cristo e alla sua Chiesa. Di conseguenza, il diritto di disporre di loro appartiene in prima istanza non alla coppia terrena, ma al matrimonio celeste (connubium). Pertanto la loro unione presuppone l'unione di Cristo con la sua Chiesa, e lo porta a collaborare con essa per un singolo scopo sovrannaturale. Essi devono cooperare precisamente come membri del corpo di Cristo nella sua Chiesa, e perciò come organi dell'intero, e quindi devono unirsi l'uno all'altro come organi del corpo di Cristo, come organi dell'intero che è stato creato dall'unione di Cristo con la Chiesa. Pertanto la loro unione, la loro alleanza, diventa un membro organico nella grande e riccamente articolata alleanza tra Cristo e la sua Chiesa, un membro che è circondato, pervaso, e sostenuto da questa alleanza mistica, che partecipa al carattere elevato, sovrannaturale e sacro dell'intero e nella sua essenza più intima rappresenta e riflette quell'intero.38
È degno di nota il fatto che, in questo testo, Scheeben intende il legame matrimoniale come una «alleanza (Bund) », anticipando l'insegnamento del Vaticano II sul matrimonio in quanto «alleanza d'amore, foedus dilectionis» (Gaudium et Spes, 48). Il matrimonio è un'alleanza che riceve il proprio potere interiore dallo Spirito d'amore che anima l'avvolgente alleanza tra Cristo e la sua Chiesa. Scheeben usa quattro volte, con grande enfasi, il termine « organ(ico) » per insistere sul fatto che l'alleanza tra l'uomo e la donna deve essere compresa come parte di un
38 MATTHIAsjosEF ScHEEBEN, Die Mysterien des Christentums, Freiburg: Herder, 1865 [1941], 496-7 [traduzione nostra].
147
grande intero, il corpo m1st1co, pervaso dal potere di quell'intero, e al servizio del bene comune di quell'intero. Questo scopo non è un bene alieno per l'uomo e la donna ma il loro bene, pur restando il bene di tutto il corpo, cioè di ogni persona in quel corpo.
Il grande teologo del corpo mistico, Émile Mersch, parla in modo simile del servizio che uomini e donne rendono all'umanità come un tutto:
Vogliamo dire che, nel matrimonio, gli individui sono gli strumenti, quasi passivi, di una forza che va oltre di loro, che è in loro, ma non per loro, e che, nell'usarli, fa più di quello che fanno essi stessi. Nel matrimonio, l'umanità si fa valere, assume una posizione definita, si completa e trova unità e pienezza negli individui e non in sé, poiché in sé non può esistere. Incarnando l'unità dell'umanità, l'amore è solenne e venerabile con tutta la nobiltà della nostra razza.39
L'amore, in effetti, trova la propria ragion d'essere, le proprie energie, e quindi i propri requisiti, non dai singoli, ma dalla specie. L'individuo è il vettore e l'agente, non il padrone. L'amore è un atto delle specie, nel senso che è destinato a perpetuare la specie, e nel senso che, in esso, la specie realizza se stessa e agisce nella misura in cui può essere realizzato e agire.40
Colpisce in modo particolare la frase finale del primo di questi testi. «Incarnando l'unità dell'umanità, l'amore è solenne e venerabile con tutta la nobiltà della nostra razza». Come qualcuno che sa cosa è un vero bene comune, Mersch non intende dire che la procreazione è un bene della specie in opposizione agli esseri umani e che l'uomo e la donna sono strumenti sub-personali. L'amore tra un uomo e una donna in un certo modo incarna l'unità della razza umana. In sé, come amore personale, porta l'augusta e venerabile nobiltà del bene comune della razza umana. Un bene comune più grande rifulge in quell'amore che potrebbe essere spiegato semplicemente dall'affetto di due persone l'una per l'altra. Quel bene comune è esattamente un bene dell'uomo e della donna che sperimentano questo amore, sebbene non solo per
39 ÉMILE 1\fERSCH, Lave, Marriage, Chastity, New York: Sheed and Ward, 1939, ~09. Il capitolo di Morality and the Afystical Body in cui si trova questo testo risale a EMILE MERSCH, "Amour, Mariage, Chasteté," Nouvelle Revue Théologique 50 (1928) [traduzione nostra].
40 MERSCH, Love, Marriage, Chastity, 210 [traduzione nostra].
148
loro. Il seguente testo di Giovanni Paolo II tende con forza in una direzione analoga:
N o n è forse una «particella» di quel bene comune, senza del quale le comunità umane si frantumano e rischiano di morire? Come negarlo? Il bambino fa di sé un dono ai fratelli, alle sorelle, ai genitori, all'intera famiglia. La sua vita diventa dono per gli stessi donatori della vita, i quali non potranno non sentire la presenza del figlio, la sua partecipazione alla loro esistenza, il suo apporto al bene comune loro e della comunità familiare. Verità, questa, che nella sua semplicità e profondità rimane ovvia, nonostante la complessità, ed anche l'eventuale patologia, della struttura psicologica di certe persone. Il bene comune dell'intera società dimora nell'uomo, che, come è stato ricordato, è «la via della Chiesa». Egli è anzitutto la« gloria di Dio»: «Gloria Dei vivens homo», secondo la nota affermazione di sant'Ireneo, che potrebbe essere tradotta anche così: «La gloria di Dio è che l'uomo viva». Siamo qui in presenza, si direbbe, della definizione più alta dell'uomo: la gloria di Dio è il bene comune di tutto ciò che esiste; il bene comune del genere umano (LF, 11).
Conclusione
Il documento Famiglia e procreazione umana mostra l'intima unità tra la dignità della persona e il bene comune della comunità nella procreazione umana. Queste due non sono opposte l'una all'altra, ma essenzialmente e necessariamente connesse. Un esempio di questa connessione è il diritto di un bambino a nascere come bene comune dei suoi genitori in una famiglia unita dal bene comune della comunione. In questo modo, il documento è in profonda continuità con la tradizione cattolica esemplificata da San Tommaso. La rilegge in chiave personalistica, seguendo l'insegnamento di Giovanni Paolo II e applicandolo alle necessità del momento presente.
n documento sviluppa la propria considerazione personalistica con una certa continuità esplicita con Kant, ma con una chiara consapevolezza che il vero fondamento della dignità personale non sta in ciò che Kant supponeva. Lo stesso Giovanni Paolo II indica ripetutamente che ci sono tipi differenti di personalismo. Egli parla di« personalismi pseudo-liturgici »41 e del pericolo
41 Discorso al Consiglio del Centro di Azione Liturgica, 30 novembre 1984, Insegnamenti 7/2 (1984) 1340-3.
149
di« personalismi egoistici ».42 Così si rivolge a Maria: «Tu sei più forte di ogni egoistica e personalistica ambizione ».43
Il personalismo kantiano giustifica pienamente la cautela espressa in questi testi. Si tratta di un personalismo che vede il valore più alto nell'autonomia morale della singola persona umana, interpretata come autolegislazione universale della persona prima della distinzione tra buono e cattivo. La paternità è il peggiore dispotismo immaginabile; lo stato di figlio la peggiore schiavitù immaginabile. Non sorprende che Kant neghi che lo stato dovrebbe perseguire un bene comune volto alla felicità dei suoi cittadini. Esso deve limitarsi a proteggerne i diritti. Come l'intera natura, lo stato è teleologicamente ordinato al bene privato di ogni suo cittadino, che consiste nella sua autonomia e libertà morale.
In contrasto con questa visione radicalmente individualistica della dignità personale, il documento Famiglia e procreazione umana mostra una intima interrelazione tra matrimonio e società nella procreazione. La procreazione umana serve il bene comune della famiglia e della società. Poiché il bene che serve è veramente un bene comune, i suoi beneficiari sono le persone e le famiglie che formano la società.
42 Discorso ai religiosi, Quito (Ecuador), 30 gennaio 1985, Insegnamenti 8/1 (1985) 273-7' § 4.
43 Prayer to Mary, Vaduz (Iiechtenstein), settembre 1985, Insegnamenti 8/2 (1985) 638-40. La traduzione della preghiera italiana non riproduce la parola "personalistico", ma recita: "alles eigensiichtige Streben nach Selbstverwirklichung", ogni sforzo egotistico per autorealizzarsi.
150
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA
FAMIGLIA E PROCREAZIONE UMANA
Commenti sul documento
LIBRERIA EDITRICE V ATICANA