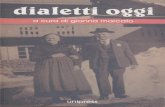TESI DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI PROCESSI INDUSTRIALI E DEI MATERIALI PANNELLI FOTOVOLTAICI
Processi di sviluppo urbano e tecnologie informatiche di analisi dei dati territoriali (GIS):...
Transcript of Processi di sviluppo urbano e tecnologie informatiche di analisi dei dati territoriali (GIS):...
EditoreAssociazione Italiana di CartografiaC.P. 88 – VI 2 – Via IV Novembre 13 – 36100 Vicenzatel./fax 0444.325775 - e-mail: [email protected] del Tribunale di Firenze n. 1564 del 30/12/1964
Direttore responsabileGiuseppe Scanu (Presidente AIC)e-mail: [email protected]
Redazione Ida Zanetti e-mail: [email protected] Borruso, Andrea Favretto, Giovanni Mauro.
Comitato ScientificoGiuseppe Borruso (Presidente)e-mail: [email protected] Ajmar, Milena Bertacchini, Andrea Favretto, Giovanni Mauro,Alessandro Nobili, Raffaela Gabriella Rizzo, Sandro Savino, Domenico Tacchia
ImpaginazioneSprint sas di Rosanna ZanascoCaldogno (VI)
ATENA.NET srl, Torri di Quartesolo (VI)
Gli articoli inviati al Bollettino vengono sottoposti, in forma anonima, al giudizio di due o più referees. Gli scritti pubblicati impegnano solo la responsabilità dell’autore.
Anno XLIX, n. 144-145-146 aprile-settembre-dicembre 2012
AIC nr.144-145-146 Sommario_Layout 1 06/02/13 16:24 Pagina 3
Massimiliano Bencardino*, Ilaria Greco**, Luigi Valanzano *1
RiassuntoLo sviluppo urbano di un territorio è un processo complesso, dettato in parte da tra-sformazioni spontanee dagli esiti incerti, in parte da azioni, piani e programmi di go-vernance territoriale il cui scopo è quello di territorializzare, ovvero pianificare eprogrammare lo sviluppo futuro secondo logiche che mutano profondamente nel tempoe nello spazio. Gli spazi urbani contemporanei non esulano da questi processi e si pre-sentano oggi come complesse conurbazioni estese, costituite da una molteplicità di in-sediamenti di diversa dimensione, forma ed importanza, le cui dinamiche evolutivelasciano spazio ad interessanti analisi e riflessioni.Lo scritto ricostruisce i tratti della «geografia urbana» della città di Battipaglia e delsuo territorio nel più ampio sistema urbano salernitano a partire dalla nascita del co-mune nel 1926 come villaggio rurale fino alla Città media di oggi, utilizzando un ap-proccio che combina l’analisi dei processi storici e le rilevazioni geografiche attraversotecnologie informatiche di analisi di dati territoriali. L’obiettivo è quello di studiare diacronicamente le direttrici, la velocità e la direzionedello sviluppo urbano della città di Battipaglia ma, anche, di effettuare una prima va-lutazione dell’efficacia dello strumento urbanistico del Piano Regolatore Generale (PRG)nei suoi quarant’anni di attuazione.L’uso di dati spaziali e l’analisi di cartografie storiche e digitali e di immagini satellitariè da considerarsi un'operazione importante per la gestione ed il controllo delle trasfor-mazioni spaziali che hanno investito gli spazi urbani, rendendoli iperestesi e difficil-
Bollettino A.I.C. nr. 144-145-146 / 2012
57
PROCESSI DI SVILUPPO URBANO E TECNOLOGIE INFORMATICHE DI ANALISI DEI DATI TERRITORIALI:
L’EVOLUZIONE URBANISTICA DELLA CITTÀ DI BATTIPAGLIAE L’EFFICIENZA DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO URBANO (PRG)
ATTRAVERSO LA CARTOGRAFIA
URBAN DEVELOPMENT PROCESSES AND TECHNOLOGYFOR THE ANALYSIS OF SPATIAL DATA: THE URBAN EVOLUTION
OF THE CITY OF BATTIPAGLIA AND EFFICIENCY OF URBAN DEVELOPMENT PROGRAMS (PRG)
1 *Università degli Studi di Salerno; **Università degli Studi del Sannio. Il presente articolo scaturisce da un’attivitàdi ricerca riguardante i sistemi urbani regionali, ed in particolare quelli della R egione Campania, che il gruppo di lavorosta svolgendo con il supporto del Laboratorio SIGOT “Sistemi Informativi per l’Organizzazione del Territorio” dell’Uni-versità di Salerno. Pur frutto di una comune riflessione degli autori, le singole parti vanno così attribuite: a MassimilianoBencardino i paragrafi 2 e 5, ad Ilaria Greco i paragrafi 1 e 3; a Luigi Valanzano il paragrafo 4.
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:11 Pagina 57
mente modellizzabili, ma soprattutto utile per effettuare delle valutazioni di cui tenerconto nella futura programmazione e pianificazione territoriale. Parole chiave: Cartografia, Gis, Sviluppo urbano.
AbstractThe urban development of an area is a complex process, dictated in part by spontaneoustransformations with an uncertain outcome, in part by actions, plans and programs ofterritorial governance whose aim is to territorialize, or plan and program the future de-velopment according to factors that change over time and space. Contemporary urbanspaces are not excluded from these processes, assuming the form of complex conurbationsextended, consisting of a multiplicity of settlements of different size, form and importance,whose evolutionary dynamics leave room for interesting analyzes and reflections.The paper reconstructs the features of the "urban geography" of the city of Battipagliaand its territory in the wider urban system of Salerno, from the birth of the municipalityin 1926 as a rural village to the Middle City of today, using an approach that combinesthe analysis of historical processes and geographical surveys through information tech-nology analysis of spatial data.The objective is to study diachronically the lines, the speed and direction of urban devel-opment of the city of Battipaglia but, also, to make a first assessment of the effectivenessof the planning instrument of the General Regulatory Plan (PRG) in his forty years ofimplementation.The use of spatial data and the analysis of historical cartography and digital and satelliteimages is considered an important task for the management and monitoring of spatialtransformations that have affected urban spaces, making them hyper extended and diffi-cult to analyze, but especially useful for assessments to be taken into account in futureplanning.Keywords: Cartography, Gis, Urban development.
1. PremessaInformazione geografica, cartografia e tecnologia: un rapporto in continua evoluzioneLa produzione cartografica, quale importante strumento di rappresentazione visiva e di conoscenza e com-prensione degli elementi del territorio, ha da sempre operato in stretto rapporto con il testo nel docu-mentare, conservare e trasferire l’informazione geografica. La carta geografica non è uno specchio passivodella geografia del mondo o di una sua parte: essa è un prodotto di specifici periodi storici e, in quantotale, è uno strumento istituzionale che va interrogato, indagato e, infine, svelato (Wood D., 2010).
Le carte, sia nella loro tradizionale funzione descrittiva che in quella interpretativa e progettuale assuntasuccessivamente, hanno nel tempo mantenuto inalterato il loro valore conoscitivo, come è inalterato ilrapporto di complementarietà tra geografia e cartografia; ciò che continua incessantemente a rivoluzionarsiè la modalità con cui le carte (o meglio di coloro che in qualità di esperti e non esperti) elaborano, visua-lizzano e diffondono l’informazione geografica.
Una prima grande rivoluzione è stata segnata dall’introduzione dei Sistemi Informativi Geografici (GIS)per la produzione di cartografica digitale in ambiente GIS, in cui alle funzioni di una tradizionale carta sisommano potenzialità informatiche che, almeno all’apparenza, consentono di superare i limiti strutturaliinsiti in una metrica topografica di matrice geometrico -euclidea insufficiente a leggere ed interpretare lacomplessità territoriale.
Nell’arco di pochi anni, l’utilizzo dell’informatica e la parallela diffusione dei Sistemi informativi Geograficiha determinato una progressiva evoluzione della cartografia digitale da semplice “disegno” del territorio a “dato
58
Nr. 144-145-146 / 2012
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:11 Pagina 58
numerico” e ad “informazione geografica” (database geografico) utile per attività di analisi spaziale. L e criticheche nel corso degli anni si sono sviluppate all’interno della stessa tecnologia GIS ne hanno dettato un’evoluzioneed un perfezionamento attraverso software più flessibili, pensati per una maggiore operatività anche nel campodella ricerca sociale qualitativa. Attualmente ai GIS si può riconoscere una triplice funzione insita nella (s) del-l’acronimo: S come System, Science e Services (Nyrges T.L., Couclelis H., McMaster R., 2011).
I Location Based Services (LBS), nonché i programmi che consentono il posizionamento o la visualiz-zazione di luoghi e oggetti della superficie terrestre grazie a immagini satellitari (si pensi a software comeGoogle maps e Google Earth e simili che ne permettono la visualizzazione on line), moltiplicano ognigiorno i propri ambiti di applicazione, rendendo possibile l’utilizzo di una quantità enorme di informazionigeografiche (dati spaziali) o di basi cartografiche “a basso costo” e di immediata applicazione almeno perprimi livelli di analisi territoriali.
Il facile accesso a strumentazioni ed applicazioni geografico-informatiche ha reso, dunque, ancora piùsemplice e diffusa la produzione e la circolazione di “nuova informazione geografica” sulla base anche didati geografici forniti volontariamente da utenti privati (Volunteered Geographic Information), secondo mo-delli dinamici ed interattivi (Goodchild, 2007). Alcuni esempi di questo fenomeno sono Wikimapia, Open-StreetMap e Google Map Maker.
Nel discorso sugli obiettivi di una carta, sulle tipologie, sull’evoluzione della metodologia cartografica,sui limiti o, ancora, sul “potere” della carta (o di chi la realizza) molto probabilmente è interessante rifletteresu un passaggio fondante, ovvero quello dalla “visualizzazione”, intesa quale atto privato nel processo dicostruzione della carta, alla “comunicazione” intesa come atto pubblico (Tyner J. A., 2010).
Sempre più la cartografia, qualsiasi sia la sua forma e, quindi, al di là della sua specifica funzione, assumeinfatti valore di atto pubblico in quanto elemento fondamentale nei processi di analisi, rappresentazione egestione di elementi e relazioni territoriali ma, soprattutto, in quanto elemento di progettazione a supportodei processi istituzionalizzati di partecipazione locale.
Il presente contributo, anch’esso con la presunzione di contribuire alla diffusione dell’informazione geo-grafica attraverso la combinazione di “testo” e “carte”, si serve dell’insieme di queste fonti e di queste tec-niche (dati spaziali, cartografie storiche, cartografie digitali create in ambiente GIS, immagini satellitari ecc.)per lo studio dei processi di trasformazione degli spazi urbani contemporanei ed, in particolare del comunedi Battipaglia nell’ambito del più ampio sistema urbano salernitano.
L’attività di ricerca viene svolta, infatti, secondo un approccio descrittivo a partire dall’analisi dei processidi trasformazione urbana della città di Battipaglia attraverso la raccolta e la successiva digitalizzazione dellacartografia storica comunale, per approdare ad un’analisi di tipo interpretativo e costruttivista attraverso unaprima valutazione delle trasformazioni indotte dal PRG comunale del 1972, primo e ad oggi ancora unicostrumento urbanistico della città. La verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati rappresentanon solo per il ricercatore, ma per la collettività intera e gli amministratori locali, una prima base di analisiper riflettere sugli sviluppi passati della programmazione locale e, soprattutto, sulle direttrici future.
Lo studio, si chiude, infatti, tenendo conto del ruolo che viene riconosciuto (passato) e assegnato (fu-turo) al sistema urbano battipagliese nel futuro disegno policentrico del sistema provinciale e regionale daglistrumenti pianificazione e programmazione territoriale di recente definizione come il DOS e di prossimaattuazione come il PUC.
L’intento non è solo quello di studiare gli esiti territoriali delle “scelte” passate ma, anche, di comunicarlial fine di orientare l’agire sociale di oggi (dalla visualizzazione alla comunicazione geografica). La stessa attivitàdi raccolta, digitalizzazione e sistemazione delle numerose fonti cartografiche e dati territoriali comunali èun primo ma importante passo di un processo di patrimonializzazione non solo dell’informazione geograficain essi contenuti, bensì del territorio rappresentato. Nel passaggio dalla “visualizzazione” alla “comunica-zione” il Web potrà rivestire un ruolo fondamentale.
59
M. BENCARDINO - I. GRECO - L. VALANZANO
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:11 Pagina 59
2. Le trasformazioni ed i tratti principali dei nuovi spazi urbanizzati del sistema urbano salernitanoL’interesse per i processi di trasformazione urbana nasce sia dal bisogno continuo di conoscenza delle mo-dificazioni morfologiche, strutturali e funzionali dello spazio urbano che dalla con sapevolezza crescenteche ad essi siano strettamente connessi la competitività, il potenziale di crescita nonché la coesione socialedel territorio in cui le città vivono.
Nel corso degli ultimi anni, infatti, la città come oggetto geografico si è nuovamente imposta in mododirompente negli studi urbani vedendosi riattribuire il vecchio ruolo di fattore pre-ordinatore dei processidi sviluppo territoriale e la nuova funzione di nodo a supporto dello sviluppo locale. Oggi, dunque si assistead un “ritorno alla città” come centro di mediazione tra le componenti fondamentali della territorialità. Lacittà, quale sede privilegiata di interazione tra dinamiche locali e globali, è infatti al centro delle attuali politichee progettualità comunitarie, nazionali e regionali, in quanto assegnataria della funzione di crescita e com-petitività del Paese; ma vi sono delle condizioni necessarie perché questo avvenga.
Perché un determinato sistema urbano possa, completamente o parzialmente, realizzare il proprio po-tenziale è necessario che esso riesca a conseguire anzitutto un’intesa territoriale volta alla valorizzazionedelle proprie risorse, una diffusa qualità della vita, una qualità delle relazioni orizzontali, un contenimentodel consumo di territorio, un’ottima accessibilità ai luoghi, una qualità dell’edificato e dell’ambiente costruitoin genere ma, anche, una governance locale integrata e partecipata.
È evidente come la crescita, la competitività e la valorizzazione territoriale siano solo la cartina al tornasoledi un complesso processo multidimensionale volto a creare le condizioni a che le prime si realizzino.
Nell’ambito del percorso di studi affrontato dal SIGOT riguardante l’analisi dei processi di trasformazionedell’intera maglia urbana regionale, l’attenzione, per questo lavoro, si è soffermata sullo sviluppo del nucleourbano di Battipaglia, città di circa 51.000 abitanti e cuore pulsante del sistema della Piana del Sele, chenegli ultimi 50 anni ha vissuto un vorticoso processo di urbanizzazione, il quale non può dirsi ancora arre-stato. La città, la terza del sistema urbano salernitano per numero di abitanti dopo Salerno e Cava de’ Tir-reni, è entrata a far parte di quella rete di “ città medie” attraverso le quali passa il programma strategicourbano a medio-lungo termine della regione Campania per la costruzione di un sistema di governancemultilivello regionale (Bencardino F., Cresta A., Greco I., 2010).
Storicamente sul territorio campano, a causa della scarsa distribuzione gerarchica delle città e della ca-renza di poli intermedi, l’erogazione dei servizi e la diffusione dei poteri direttivi è avvenuta in modo ano-malo, concentrandosi nell’unico centro metropolitano a scapito di un equilibrio più armonico del territorio(Mautone M., Sbordone L., 1983).
Solo negli ultimi anni, sia per la forma fisica e funzionale che va assumendo il tessuto urbano regionaleche per la stessa visione contenuta negli attuali documenti di pianificazione territoriale e di programmazioneeconomica regionale, si scorgono processi di riequilibrio dello sviluppo regionale ed un’evoluzione dell’as-setto urbano regionale verso un modello di tipo “policentrico integrato ed equilibrato” (Bencardino M.,Greco I., 2012). Tra le aree urbane emergenti, confermando dinamismi economici e residenziali già in attoda diversi anni, vi è sicuramente il sistema urbano di Salerno tra l’Agro sarnese-nocerino e la P iana delSele, a cui più recentemente si aggiungono le aree di densificazione della fascia litoranea da Salerno fino aicontrafforti del Cilento incuneandosi nell’ampia piana del Sele (Amato, 2007).
Nel sistema urbano salernitano va ricompresa un’area molto più vasta rispetto a quella considerata nelPiano Territoriale Regionale (PTR) come Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) “Sistema urbano Salerno”,che si estende lungo diverse direttrici includendo 23 comuni in cui vive il 56,7% dell’intera popolazioneprovinciale. Dal comune di Salerno, identificato come area urbana di livello superiore (Riitano M., Bencar-dino M., 2007; Bencardino M., 2012), si dipanano tre direttrici, quella della V alle dell’Irno, quella che da
Nr. 144-145-146 / 2012
60
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:11 Pagina 60
Pontecagnano arriva ad Eboli attraversando proprio Battipaglia e quella di Cava dei Tirreni; due di questea loro volta incrociano due sistemi periferici, definibili per la posizione geografica: uno mediano, da NoceraSuperiore ad Angri ed uno interno, da Mercato S. Severino a Sarno. In tale contesto urbano molte attivitàeconomiche, commerciali e della formazione risultano, ormai, delocalizzate rispetto al comune di Salerno.In tale sistema complesso vivono molte delle interrelazioni multi dimensioni prima citate.
La direttrice principale è, senza dubbio, quella meridionale. Lungo questa direttrice, infatti, già a partiredagli anni ’80 si notava la presenza di alcune aree di sviluppo urbano emergenti per dinamismi economicie residenziali, in particolare a partire dal nodo di Salerno verso l’Agro sarnese-nocerino e nella P iana delSele (Coppola, Viganoni, 1994), a cui si sono aggiunte, poi, le aree di densificazione della fascia litoranea(Amato, 2007). Infatti, la morfologia del territorio, che vede Salerno costretta nel lato settentrionale daiMonti Lattari e dai Monti Picentini ha fatto sì che l’espansione urbana si sviluppasse maggiormente nel ver-sante meridionale, laddove si apre un grande spazio pianeggiante quale è la P iana del Sele e tale rimanefino ai bastioni del Cilento. Nella Piana, quindi, si è sviluppato un unicum abitativo, seppur in attenuazione,da Salerno Fino ad Eboli lungo la SS18.
La Piana del Sele, quindi, se da un lato è localizzata lungo una direttrice di sviluppo ben definita del si-stema urbano salernitano, dall’altro assume le fattezze di un “sistema periferico” che oscilla tra interdipen-denza con la città di Salerno ed autonomia funzionale.
La Piana rappresenta storicamente un sistema complesso in espansione ed un’area in forte evoluzione:da sistema a carattere prevalentemente agricolo è divenuto prima a carattere rurale e poi sempre più unsistema produttivo agroindustriale ed industriale ed, anche, un sistema turistico o quanto meno snodo disistemi turistici. Tale articolazione sistemica è accresciuta dalla sua complessità territoriale 2, dalla sua orga-nizzazione politico-amministrativa e dall’evoluzione storica del territorio.
Fin dagli anni ’60-’70 la P iana ha rappresentato, infatti, assieme a Salerno un’area di attrazione della po -polazione non solo dagli altri comuni della provincia ma, anche, da province limitrofe quali Potenza e Cosenza(Cataudella, 1975). Tra gli anni ’80-90 mentre Salerno inizia la sua fase di declino demografico cominciandoa presentare chiari segni di disurbanizzazione, i comuni della fascia costiera della Piana del Sele come Ponte-cagnano, Montecorvino Rovella, Battipaglia, Eboli crescono con tassi significativi, talvolta superiori al 10%, traprocessi di dispersione e di urbanizzazione diffusa. Lo studio dello sviluppo urbano del comune di Battipaglia,oggetto di analisi nei paragrafi successivi, rappresenta uno snodo interessantissimo sia riguardo allo sviluppopassato e futuro dell’intero sistema urbano salernitano, sia per la sua centralità nella Piana del Sele.
Nell’ultimo decennio (2001-2011), invece, mentre questi comuni vedono stabilizzarsi la propria po -polazione, si colgono fenomeni di crescita nei centri appartenenti alle altre due direttrici (V alle dell’Irno eCava de’ tirreni), con tassi che arrivano al 50% e più 3 (Tab. 1 e Fig. 1).
Se l’incremento dell’edificazione lineare si è principalmente concentrato lungo gli assi e i nodi infrastrut-turali, lungo i tratti costieri ad elevata residenzialità turistica si è avuto un consistente fenomeno di dispersione
61
M. BENCARDINO - I. GRECO - L. VALANZANO
2 Tale complessità territoriale si avverte ad esempio dall’evoluzione dei sistemi locali del lavoro (SSL) - individuati dall’I-stat-Irpet in base ai dati relativi agli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro - i quali nelle tre definizioni dal ’81 al 2001sono sempre cambiati. Nell’81 erano tre distinti, quello di Salerno, quello di Battipaglia e quello di Eboli. Nel ’91 Pontecagnano,facente prima parte del SSL di Salerno, ricadrà in quello di Battipaglia, nel 2011 i tre SSL si fondono in un unico sistema localedi Salerno. Ciò rappresenta bene l’evoluzione convulsa del territorio nell’ultimo trentennio ed il trasformarsi continuo dellepolarità di questo territorio.
3 La crescita dei comuni della Piana tra il 1991 ed il 2008 è di circa 18.000 abitanti nel suo complesso (di cui 15.000solo nei comuni litoranei quali Battipaglia, Eboli, P ontecagnano, fino a Capaccio. Il solo altro comune non litoraneo increscita è Campagna che sfrutta la sua prossimità fisica e relazione con il comune di Eboli.
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:11 Pagina 61
edilizia, che ha progressivamente trasformato il territorio erodendo spazio agricolo e producendo informie dequalificate forme di residenzialità.
Ciò trova conferma nel fatto che a tale espansione residenziale non sempre è associata una adeguatadotazione di servizi. Il “grado di urbanità” di questo contesto, misurato attraverso una valutazione compa-rativa di fattori quali sportelli bancari, consulenti contabili, finanziari e del lavoro, contabili, notai, ma anche
62
Nr. 144-145-146 / 2012
Tab. 1 – Andamento demografico dei comuni della Piana del Sele tra il 1991 ed il 2008.Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT
Fig. 1 – Evoluzione demografica della Piana del Sele tra il 1991 ed il 2008 Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT, realizzata in ambiente GIS.
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:11 Pagina 62
agenzie di viaggi e di trasporti, biblioteche e musei, studi medici, laboratori, ristoranti, attività alberghiere,locali, ecc. (Riitano M., Bencardino M. et alii, 2007), mostra delle evidenti criticità e si avverte un certo ri-tardo da quelle che sono le medie di altri contesti urbani regionali ed italiani.
Dal punto di vista produttivo, invece, il sistema della Piana si dimostra molto vitale ed in rafforzamentosia in termini assoluti che rispetto al resto della provincia. L’ambito ha visto, infatti, nell’ultimo decennio(1999-2009) un aumento considerevole delle Unità L ocali da 14.675 a 20.820, con un incremento dioltre il 40%, ed un raddoppio degli addetti, da 19.150 a 40.740. Il settore maggiormente dinamico in ter-mini di UL è quello terziario, con un incremento nel periodo considerato di oltre il 60%, seguito da quelloindustriale con il 48% e dall’agricolo con il 19,9%; in termini di addetti è, però, proprio il settore agricoloa registrare un tasso di incremento straordinario, passando dai poco più dei 2700 addetti del 1999 aglioltre 13.200 del 2009, segno evidente di un rurale produttivo sempre più intensivo.
Buona parte del territorio conserva, infatti, evidenti caratteri di ruralità e costituisce un sistema ruraledi altrettanto interesse, con una ricca presenza agro-industriale e un potenziale turistico rurale. Tutta l’areaè classificata, nel Piano Territoriale Regionale, tra i Sistemi costieri a dominante paesistico ambientale-cul-turale, al pari della costiera amalfitana.
Queste aree, infatti, possiedono risorse culturali da valorizzare e hanno buone potenzialità produttive,non solo nel campo dell’agricoltura intensiva, ma anche in quello dei prodotti agroalimentari tipici. In que-st’ottica vivono progetti quali il recupero delle antiche masserie di epoca borbonica, nate nella seconda metàdel XVIII secolo, allorquando molti neoborghesi utilizzarono la Piana per investimenti agricoli dopo le boni-fiche iniziate nei decenni precedenti. Per queste aree può vivere uno sviluppo rurale basato sulla messa apunto di un’offerta turistica alternativa o complementare, a seconda dei casi, rispetto al modello costiero.
3. Nascita ed evoluzione della città di Battipaglia: sviluppo economico, dinamiche insediative e trasformazioni urbane Di fondazione recente e di sviluppo recentissimo, Battipaglia ha rappresentato fin dalla sua elezione a co-mune un nodo di convergenza delle direttrici di popolamento e sviluppo dell’intera Piana del Sele, andandoa costituire il primo insediamento a carattere urbano al limite della fascia attiva campana. Alla base dellafunzione di sviluppo assunta dal territorio in un ambito di area vasta, che si estende dalla Piana del Sele al-l’intera provincia, la sua posizione geografica e la sua posizione strategica rispetto al sistema urbano saler-nitano. Battipaglia è, infatti, al centro di un sistema di scambi territoriali che la vedono interagire a nord-ovestcon il polo urbano di Salerno verso cui si colloca quale elemento di “cerniera” lungo la conurbazione urbanadell’asse Pontecagnano-Battipaglia-Bellizzi-Eboli, a nord-est con le Valli del Sele e del Tanagro che hannointerrelazioni sia con la provincia di Avellino che con la Basilicata, e a sud-est con il Cilento configurandosiquale “gateway” di sviluppo per il vasto ma isolato e denso di fratture sistema del Cilento-Vallo di Diano.
Scopo dell’analisi è ricostruire le principali fasi del processo di sviluppo socio-economico e territorialeche hanno dettato i caratteri dei diversi modelli di sviluppo urbano ascrivibili all’evoluzione urbanistica dellacittà di Battipaglia. A tal fine si è proceduto al recupero e alla rielaborazione digitale delle cartografie storichecomunali e di piano e all’elaborazione di dati alfanumerici utilizzati in analisi monovariate e bivariate. L ostudio si sviluppa attraverso archi temporali decennali ed ha tenuto conto delle differenti destinazione d’usodell’edificato (residenziale, produttivo, interesse pubblico, interesse storico), rappresentato mediante ele-menti poligonali. I differenti “Modelli di città”, quali idealtipi così individuati ed analizzati, sintetizzano dia -cronicamente le direttrici, la velocità e la direzione dello sviluppo urbano della città di Battipaglia.
Nata come colonia agricola nel 1858 all’indomani di un violento terremoto che colpisce il Vallo di Teg-giano e la Basilicata, Battipaglia diviene Comune autonomo con Regio Decreto del 28 marzo 1929 per as-segnazione di parti del territorio dei Comuni confinanti di Montecorvino R ovella e di Eboli. Il territorio
63
M. BENCARDINO - I. GRECO - L. VALANZANO
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:11 Pagina 63
assume già nei suoi primi anni di vita un peso rilevante nell’ambito sociale ed economico della provincia diSalerno, grazie ad un’attività agricola in continua espansione che sottrae terreni alle aree paludose dell’interapiana ed alimenta nell’arco di due decenni (anni ’30 -’50) l’impianto di un primo circuito industriale di tra-sformazione di prodotti agricoli con la nascita dell’industria conserviera, dello zuccherificio e del tabacchificio,ponendo le basi per un futuro sistema industriale (Parente A., 1998). Lo sviluppo sociale ed economico diquesti anni rendono Battipaglia il primo comune rurale del regime fascista nel Mezzogiorno d’Italia, allapari delle «città nuove» dell’agro redento (Littoria, Sabaudia e Pontida) (Rocco Carbone L., 1999 p. 45).
Dal punto di vista insediativo il territorio vive in questi anni una fase di forte inurbamento, spinto anchedalla rapida ricostruzione che segue la distruzione della Seconda Guerra Mondiale 4: a partire dal primonucleo urbano la città si espande lungo l’asse di collegamento alla stazione ferroviaria sotto la spinta di unaforte pressione demografica proveniente dall’immigrazione dai centri vicini, ma senza un disegno pianifica-torio e regolatore del paesaggio costruito e senza prestare attenzione all’estetica e alla cultura urbana.Come evidente dalla destinazione d’uso dell’edificato, aumentano infatti gli spazi produttivi e quelli resi-denziali (funzionali a quelli economici), mentre si riducono le aree di pubblica utilità (Cfr. Fig. 2).
La legge stralcio del 1950 e la Riforma agraria, con l’espropriazione dei terreni ai latifondisti, l’assegna-zione dei lotti ai contadini e la costruzione di una fitta rete di canali d’irrigazione e di strade interpoderali,gettano le basi per la creazione di un sistema moderno e specializzato di produzione agricola nell’interaPiana del Sele. Allo stesso tempo, Battipaglia si avvia a diventare un polo di sviluppo industriale nell’ambitodella politica meridionalista perseguita dal Governo dopo la fase di ricostruzione e di infrastrutturazionedel territorio, con l’insediamento di moderne industrie a ciclo continuo e stagionale operanti dapprima nelsettore siderurgico e poi, in linea con le trasformazioni dell’età post-industriale, nei settori ad alta tecnologia,dai cavi elettrici alle fibre ottiche, alle telecomunicazioni.
Ciò ha tra le sue conseguenze più significative l’aumento inevitabile della migrazione dalle aree interneed il conseguente abbandono dei piccoli centri, ed un forte consumo di suolo per uso abitativo a causa diuna sfrenata speculazione edilizia: sorgono quartieri di edilizia popolare in prossimità del centro (quartiereStella e Serroni) e si creano i nuclei dei futuri quartieri Taverna, Turco e Schiavo. Il modello di sviluppo ur-bano segue quello produttivo ed è, quindi, di tipo polarizzato (Fig. 3). Il processo di industrializzazione in-nescato dalla politica dei poli di sviluppo si viene, però, ben presto a scontrare sia con il prevalente carattererurale del territorio, sia con l’industria tradizionale, creando una crisi del sistema che, con la chiusura dellozuccherificio e le difficoltà del tabacchificio, porta ai tragici fatti della rivolta operaia del 9 aprile 19695.
Una crisi che, in parte, viene superata con la nascita della zona industriale per effetto dell’inserimento delComune di Battipaglia nel piano provinciale ASI (Area per lo Sviluppo Industriale) che se da un alto, porta alladefinitiva scomparsa di molte delle industrie storiche di trasformazione dei prodotti agricoli, dall’altro favoriscel’insediamento di nuovi settori merceologici come la plastica, che in parte riescono ad assorbire la manodoperain esubero dal settore agroindustriale, avviando la fase della ristrutturazione sociale ed economica.
In questi anni la città subisce le scelte di una pianificazione urbanistica di tipo comprensoriale che fondail nuovo assetto urbanistico, sociale, economico e produttivo intorno all’area ASI, a ridosso della città.
64
Nr. 144-145-146 / 2012
4 Battipaglia, insieme a Cassino, è la città del Mezzogiorno più colpita dagli attacchi aerei americani: tra il 21 giugnoed il 14 settembre del ‘43, cinque diverse incursioni aeree degli alleati hanno quasi completamente raso al suolo la cit-tadina.
5 La chiusura dello zuccherificio aperto nel 1935 e che dava lavoro ad alcune migliaia di operai e la minacciata chiusuradel tabacchificio provocò una rivolta durata tre giorni e la morte di due giovani.
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:11 Pagina 64
65
M. BENCARDINO - I. GRECO - L. VALANZANO
Fig. 2 – Digitalizzazione e classificazione funzionale dell’urbanizzazione di Battipaglia nel 1930 e nel 1950 Fonte: Elaborazione digitale tratto da Cartografia «Urbanisticare. Tra piano e progetto» (Parente, 1998 p. 70; p. 74).
Fig. 3 – Digitalizzazione e classificazione funzionale dell’urbanizzazione di Battipaglia nel 1960 e nel 1970 Fonte: Elaborazione digitale tratto da Cartografia «Urbanisticare. Tra piano e progetto» (Parente, 1998 p. 76; p. 79).
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:12 Pagina 65
Nel 1972 si ha l’approvazione del primo (ed unico) P iano Regolatore Generale che, in realtà, nonriesce ad imprimere un’azione di controllo allo sviluppo urbanistico che esplode nel corso degli anni Ottantain modo disordinato con la creazione di nuovi quartieri (quartiere Sant’Anna e Belvedere).
Un processo che prosegue per tutto il decennio successivo determinando la formazione di vuoti urbanied evidenti fratture sociali. Dal punto di vista demografico, però, dopo una crescita sostanzialmente inin-terrotta, la città entra in una nuova fase segnata da una progressiva stabilizzazione demografica, ricalcandole dinamiche degli anni Ottanti del «core» del sistema urbano superiore di Salerno (Tab. 2 e Fig. 4).
Negli ultimi anni, le trasformazioni hanno interessato prevalentemente gli spazi produttivi con nuoviterritori comunali che entrano nell’area ASI, e quelli infrastrutturali con l’avvio del progetto di creazionedell’interporto, il potenziamento dello svincolo autostradale e la riqualificazione dello scalo ferroviario.
Battipaglia, con più di 50.000 abitanti, inserita nella rete delle “città medie”, si candida secondo q uantostabilito dalla programmazione regionale, a rappresentare una dimensione territoriale strategica su cui intervenireper lo sviluppo competitivo dell’intero contesto regionale campano ed innescare un processo di riequilibrioterritoriale in favore delle aree interne, svolgendo sia la funzione di centralità urbano-territoriale di livello so-vralocale, sia di nodo di un ambito sovracomunale (Asse Pontecagnano-Bellizzi-Battipaglia-Eboli), preposto allosviluppo dell’intera Piana del Sele (Obiettivo operativo 6.1 – Città medie, PO FESR 2007-2013).
Dall’altra parte, però, dall’analisi emerge chiaramente come le dinamiche insediative e lo sviluppo urbanodella città rispecchiano le fasi e, dunque, le contraddizioni insite nel passaggio, in poco più di qualche decennio,da una cultura ed un’organizzazione contadina ad una industriale e terziaria, i cui segni e fratture nel modello
66
Nr. 144-145-146 / 2012
1951/61 1961/71 1971/81 1981/91 1991/01 2001/10
Tab. 2 – Variazione della popolazione italiana, regionale, provinciale e battipagliese a confronto.Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.
Fig. 4 – Digitalizzazione e classificazione funzionale dell’urbanizzazione di Battipaglia nel 1998. Fonte: Ns. elaborazione su una fotocomposizione da «Urbanisticare. Tra piano e progetto» (Parente, 1998 pp. 99-129)
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:12 Pagina 66
di sviluppo territoriale sono ancora molto evidenti; la stessa crescita urbanistica della città per anni non è stataprogrammata, bensì indotta da dinamiche urbane che hanno caratterizzato gli aggregati di livello superiore(provinciale e regionale), associate alla discrezionalità delle trasformazioni spontanee dettate dalla cittadinanza.
4. Le trasformazioni indotte dal PRG dagli anni Settanta ad oggi: un’analisi qualitativaNel marzo del 1972 si ha l’approvazione del Piano Regolatore Generale (PRG) del territorio comunale diBattipaglia che rappresenta il primo e unico strumento urbanistico della città ed ha come primo effetto laformazione del nucleo dei futuri quartieri periferici di Battipaglia. Sono passati cinque anni dall’approvazionedella Legge Ponte n° 767 del 1967 che modificava e integrava la legge urbanistica del 1942. In questo qua-dro, il PRG si configura come uno strumento di regolamentazione che, pur non potendo avere una portatarivoluzionaria, mira ad un’attuazione programmata dello sviluppo urbanistico della città. Il PRG, redattodagli ingegneri Fuccella e Coraggio, prende infatti in esame l’intero territorio di Battipaglia nell’ottica dellapolitica espansionistica operante su tutto il territorio nazionale (Parente, 1998).
Partendo da queste considerazioni, l’indagine ha avuto come obiettivo la valutazione dell’efficacia delPRG attraverso un’analisi degli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato a distanza di 40anni. A tal fine, alla digitalizzazione del PRG, è seguita un’attività di verifica, avvenuta attraverso rilevazioniindirette (analisi delle aerofotogrammetrie) e dirette. L’unità d’analisi considerata nello studio sono i quartierio comprensori urbani, così come riconosciuti dal Comune nel 2010, anno in cui sono stati istituiti i Comitatidi Quartiere. In ogni quartiere, si è ritenuto metodologicamente corretto analizzare solo quattro delle aree
67
M. BENCARDINO - I. GRECO - L. VALANZANO
Tab. 3 – Quadro di sintesi dei “Modelli di città”. Fonte: Ns. elaborazione
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:12 Pagina 67
68
Nr. 144-145-146 / 2012
Fig. 5 – Esempio di analisi a scala di quartiere. Fonte: Ns. elaborazione
monofunzionali coerenti con la dimensione urbana, (quelle classificate come residenziali, produttive, di in-teresse generale e di verde semplice)tralasciando l’uso del suolo a fini agricoli e le aree di salvaguardia am-bientale in quanto assenti nel sistema in oggetto.
Per l’intero territorio si è provveduto alla digitalizzazione e georeferenziazione della tavola del PRGcosì come archiviata negli uffici comunali. Questa è stata integrata dalla digitalizzazione di mappe topografichedel 1970, precedenti all’approvazione del PRG, al fine di evidenziare l’impatto del programma urbanisticosul territorio allo stato di fatto alla fine degli anni ’60.
Utilizzando un applicativo GIS, si è proceduto evidenziando i singoli quartieri in rispettivi layers e perognuno di essi si sono costruiti dei poligoni corrispondenti alle Zone Territoriali Omogenee (Fig. 5). Il ri-scontro empirico di attuazione del PRG è avvenuto utilizzando come riferimento le aerofotogrammetriedel territorio del 2006 e del 2010. Nei numerosi casi in cui non è stato possibile rilevare la natura degli in-terventi urbanistici ed il conseguente stato di attuazione dalle aerofotogrammetrie, sono state eseguite ri-levazioni dirette. Un intervento necessario spesso a verificare se le aree non edificate corrispondessero adaree di pubblica utilità o ad interventi inattuati (terreni in condizione di degrado o inutilizzati).
Sovrapponendo i poligoni delle aree monofunzionali ricavate dalla fase di digitalizzazione alle aerofoto-grammetrie, è stato possibile costruire una mappa di sintesi che illustra il risultato finale dell’analisi, dove icolori evidenziano i diversi livelli di realizzazione degli interventi programmati nel PRG. Ad ogni colore cor-risponde, infatti, una “Area di analisi dell’efficacia del PRG” ossia una delle categorie che sono state utilizzateper valutare il grado di attuazione del piano: 1) preesistente al PRG, 2) attuato, 3) trasformato, 4) convertitoa pubblica utilità, 5) convertito ad uso privato, 6) non attuato 7) da riqualificare (Tabb. 4.1 e 4.2).
All’analisi visiva si affianca un’analisi quantitativa. Il software GIS, lavorando in scala, permette infatti dirilevare la dimensione della superficie delle diverse categorie per quartieri e zone omogenee quantificandolain metri quadri. Ciò consente un confronto numerico tra quanto previsto e quanto realizzato attraversotecniche di analisi monovariata e bivariata.
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:12 Pagina 68
69
M. BENCARDINO - I. GRECO - L. VALANZANO
Tab. 4 – 1) Estensioni delle aree di analisi. 2) Estensioni delle aree di attuazione. Fonte: Ns elaborazione
I risultati di questa analisi sono esposti nelle tabelle seguenti:
Il quartiere centrale, ad esempio, da quanto si legge nella relazione del PRG, avrebbe dovuto rappre-sentare l’area di intervento strategico su cui intervenire per la rivitalizzazione strutturale della città, risanandogli interventi edili scoordinati e anomali del decennio 60-70. Nello specifico, il piano per questo quartierenon prevedeva interventi nella zona residenziale (C) né in quella produttiva (D), ma stabiliva misure volteall’incremento delle aree di interesse generale (F) e di verde pubblico (G). In realtà, come ha dimostratol’analisi, le intenzioni del piano, pur se incisive a livello normativo, sono state in gran parte disattese: gli in-terventi di interesse generale (F) sono stati solo parzialmente attuati, molti interventi di carattere pubblicosono stati convertiti ad uso privato (residenziale) mentre la maggior parte di quelli destinati al verde pubblicoè rimasta ad uno stato progettuale.
Sintetizzando i risultati complessivi dell’analisi, i programmi di edilizia residenziale risultano quasi piena-mente attuati (88%). Il maggiore investimento residenziale si raggruppa in tre quartieri, Belvedere,Sant’Anna e Serroni, dove si concentrano i programmi residenziali comunali. Anche i programmi di sviluppoproduttivo nell’area ASI sono stati in larga parte attuati (71%), mentre per buona parte disattesa risulta larealizzazione di aree di verde semplice pubblico, previste in particolare nei quartieri Belvedere, Sant’Annae Serroni dove si concentrano i due terzi dei programmi di verde semplice. Quasi lo stesso destino per lestrutture di interesse generale, inattuate per il 36%. T ali strutture, programmate soprattutto per dotaredei servizi basilari di interesse collettivo i quartieri periferici in un’ottica di riqualificazione delle periferie più
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:12 Pagina 69
popolate, sono state realizzate complessivamente solo per un quarto (la restante parte era infatti preesi-stente o è stata convertita ad altri usi). Le maggiori inefficienze si riscontrano nei quartieri Belvedere e Turcodove tali strutture risultano totalmente disattese.
Alcuni programmi di intervento di interesse generale riguardano investimenti in infrastrutture di forma-zione quali edifici scolastici di ogni ordine e grado (50% del totale). Su un totale di 44 interventi previsti,ne sono stati realizzati 14 (8 erano già preesistenti). Altri programmi di interesse generale che prevedevanola realizzazione di servizi sanitari (ambulatori e centri di cura) dovevano assolvere ad un ruolo di supportosociale per i quartieri periferici. Anche questi interventi sono stati completamente elusi. L’unica opera rea-lizzata, infatti, è l’ospedale civile S. Maria della Speranza mentre gli altri due centri di servizi sanitari che at-tualmente sono in funzione (ambulatori della Cassa Mutua e della guardia medica) risultano preesistenti alPRG e localizzati, comunque, al centro della città. L’unica biblioteca esistente è situata nel municipio mentrele 3 biblioteche programmate nel PRG (2 previste a Belvedere e 1 a Sant’Anna) non sono state realizzate.I programmi riguardanti gli impianti sportivi e i servizi sociali sono stati, invece, parzialmente attuati.
Disattesa resta anche la creazione di un indotto turistico ricreativo e culturale che avrebbe valorizzatole risorse naturali e archeologiche (con siti di particolare interesse storico risalenti al 4.000 a.C.) non solodella fascia litoranea ma, anche, di quella collinare. Nessuno dei programmi di sviluppo previsti per la fasciacostiera, attraversata solo da interventi sporadici, è stato realmente attuato.
5. Il futuro del sistema urbano di Battipaglia tra spontaneismo e pianificazioneL’obiettivo del lavoro di ricerca svolto è stato quello di studiare diacronicamente le direttrici, la velocità ela direzione dello sviluppo urbano della città di Battipaglia ed, anche, di effettuare una valutazione dell’efficaciadello strumento urbanistico del Piano Regolatore Generale (PRG) nei suoi quarant’anni di attuazione.
Oggi, l’uso di cartografica digitale prodotta in ambiente GIS rende questo tipo di analisi di più facile rea-lizzazione e consente una continua verifica delle “quantità” coinvolte nelle trasformazioni territoriali di unprocesso di pianificazione. Infatti, attraverso la misura numerica di quelle che sono state qui definite “Areadi analisi dell’efficacia del PRG”, è possibile monitorare facilmente l’evoluzione di un processo di piano equantificare in itinere le aree in cui il piano risulta attuato, non attuato o convertito ad altro uso. L a cartanon è più, dunque, un semplice strumento di rappresentazione del progetto pianificatorio, ma diventa unmezzo di analisi quantitativa e di monitoraggio dello stesso. Queste intenzioni e questo approccio soggiac-ciono all’analisi del PRG di Battipaglia.
Il Piano Regolatore Generale, essendo stato sviluppato nel 1972, non poteva che risultare datato edormai inadeguato alle esigenze della città e, attraverso lo schema delle “Area di analisi dell’efficacia delPRG”, se ne è data una misura dell’efficacia. Il risultato dell’analisi mostra come esso sia stato in gran parteinapplicato (Fig. 6). Interi quartieri, in particolare quelli di grande espansione edilizia degli anni ’80 comeBelvedere e Serroni, sono risultati addirittura in completa contraddizione con i dettami del PRG.
Inoltre, se molte delle scelte fatte durante il breve ma intenso e, a tratti tumultuoso, processo di crescitadella città di Battipaglia, come quella di innestare stabilimenti industriali in zone ad alto potenziale agricoloo di lasciare che lo sviluppo urbano fosse guidato per lo più da interessi privati, restano discutibili nel meritoanche il loro risultato, con l’aggravio di una serie di problematiche che esulano dal confine locale, diventanon più chiaramente definibile.
Il fenomeno di una iper-urbanizzazione, che solo parzialmente può essere associato ad un sistema discelte di tipo localistico ma che si riconduce perfettamente alla urbanizzazione dispersa, diffusa, estesa delterritorio che è avvenuta negli anni ’80, oltre a rappre sentare una fotografia della espansione delle cittàavutasi negli anni del “boom” edilizio italiano mostra chiaramente – e per questo Battipaglia diventa uncaso di studio interessante – la storia dell’evoluzione dello strumento urbanistico stesso e dei limiti che
70
Nr. 144-145-146 / 2012
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:12 Pagina 70
esso ha avuto nella capacità di cogliere e governare le trasformazioni urbane che man mano andavanoprendendo forma.
Lo stesso contesto culturale e politico dominante negli anni ’70 ed ’80, epoca in cui una gran parte deiPRG viene redatta, ha fatto sì che questi strumenti tendessero ad essere una sommatoria di scelte già dipianificazione esecutiva e che, quindi, la pretesa che essi avevano di poter prefigurare tutti i possibili scenarievolutivi si rivelasse di per sé effimera se non addirittura colpevolmente sbagliata.
La constatazione della eccessiva rigidità dello strumento urbanistico ha, di fatto, dato l’avvio alla dere-gulation urbanistica a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni. Ecco che, in molti territori, i PRG sonorimasti un bel disegno inattuato se non addirittura configgente con lo sviluppo endogeno.Oggi l’attenzione agli strumenti di pianificazione urbana e territoriale è profondamente cambiata, paralle-lamente all’evoluzione della sensibilità collettiva verso le problematiche ambientali, della qualità della vita edel consumo di territorio. Attraverso un percorso di introduzione graduale di diversi strumenti di program-mazione negoziata, si è da tempo arrivati alla definizione legislativa di procedure quali quelle di V .I.A. eV.A.S.6, le quali fanno del processo pianificatorio non un “disegno d’artista” ma un percorso più partecipativoda un lato e più controllato dall’altro.
L’esigenza di un superamento del vecchio piano e la nascita di una legislazione urbanistica rinnovata,stavolta di emanazione regionale, potrebbe, infatti, solo apparentemente far credere che la direzione siacambiata verso una legislazione più liberale, meno dirigistica e meno burocratica. In realtà, le problematichecontemporanee che hanno portato alla nascita di strumenti quali quelli che prima venivano richiamati (V.I.A.e V.A.S.) impongono a tutta la comunità scientifica uno sforzo per trovare forme nuove di rappresentazioneed analisi della “città” (Prezioso M., 2003; Bencardino M., 2007).
La VIA ma anche e soprattutto la VAS, nate solo in seguito a direttive comunitarie, ben rappresentanol’esigenza di una verifica di sostenibilità delle scelte promosse da piani e programmi territoriali. A tale volontà,però, non è seguito un pari fervore di metodi e metodologie quantitative di analisi, prima, e di supportoalle decisioni, poi.
In questo caso di studio, attraverso il disegno delle Aree di analisi dell’efficacia del PRG e dello Stato diattuazione della programmazione comunale (Fig. 6), si è voluta sperimentare una modalità di verifica quan-titativa della attuazione degli interventi, introducendo, quindi, una modalità di screening territoriale, cheandrebbe sempre e comunque svolto prima di ogni nuova pianificazione e che ben si inserisce nella dire-zione tracciata dalle procedure di valutazione e monitoraggio delle scelte pianificatorie.
Nel dettaglio dell’analisi del comune di Battipaglia, la ricostruzione storica e geografica delle trasforma-zioni territoriali della città, da un lato, e la verifica empirica dello stato di attuazione di quanto programmatodal PRG comunale del 1972, dall’altro, rendono evidente due problemi interconnessi: il primo riguardal’assenza di una qualunque forma di pianificazione territoriale nei primi quaranta anni di sviluppo del comune,il secondo l’assenza di una programmazione settoriale e di un monitoraggio in itinere circa lo stato di at-tuazione di un piano di per sé rigido nella sua impostazione e con una serie di contraddizioni fattuali neisuccessivi quaranta anni, ovvero dal 1972 ad oggi.
Il quadro delle caratteristiche generali e delle strutture spaziali, economiche e sociali assunte dalla cittàdi Battipaglia nelle diverse epoche storiche e delle sue criticità pone in primo piano la necessità di azioni diriqualificazione e valorizzazione differenziate e complementari, da stabilire all’interno di una strategia diriassetto d’ambito e provinciale.
71
M. BENCARDINO - I. GRECO - L. VALANZANO
6 Valutazione di Impatto Ambientale (85/337/CEE) e Valutazione Ambientale Strategica (2001/42/CE).
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:12 Pagina 71
Al momento, sebbene molti interventi di recupero urbanistico sono nella sostanza non più fattibili per-ché sostituiti da altre opere, resta l’opportunità di completare il processo di riqualificazione del patrimonioedilizio ed urbanistico esistente e di integrazione delle diverse anime della città attuando gli interventi delPRG di pubblica utilità lasciati pendenti al fine di equilibrare il centro e la periferia, la città e la campagna.
Un’occasione che si prospetta per la città di Battipaglia con il nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale)di prossima attuazione; il PUC, insieme agli altri strumenti di programmazione pluriennale come il DOS dipreparazione al Programma Integrato Urbano PIÙ EUROPA7 ed i PUA (Piano Urbanistico Attuativo) sipresenta, dunque, come una grande opportunità per prospettare interventi strategici di riqualificazione edi nuovo sviluppo dell’area urbana, nonché per ripensare lo sviluppo della città in una visione rinnovata.
Si prospetta la creazione di una “città moderna, dinamica e competitiva che ambisce ad essere partequalificata del sistema locale e regionale capace di generare dai suoi punti di forza (agricoltura, industria,turismo, ecc.) e dalla soluzione dei suoi problemi (mobilità, ambiente, ecc.) nuove potenzialità di sviluppo”(DOS Città di Battipaglia, Obiettivo Generale, p.8).
Rimuovere il vincolo dell’ammodernamento degli strumenti urbanistici è un passo obbligato per dareattuazione ad interventi di miglioramento della “qualità della vita urbana del territorio” e di rigenerazioneurbana (DOS, Asse strategico I) che passa per la qualità del sistema ambientale e, di riflesso, della “qualitàdella vita e promozione culturale” (Asse II) ma, anche, per la promozione della “competitività economica
72
Nr. 144-145-146 / 2012
Fig. 6 – Stato di attuazione della programmazione comunale. Fonte: Ns. elaborazione, realizzata in ambiente GIS
7 Il 23 gennaio 2012 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma “Più Europa Città di Battipaglia”. Tale atto sanciscel’avvio effettivo delle attività relative al “Più Europa” con l’accesso ad finanziamento di circa 17 milioni di euro per il primointervento del programma di riqualificazione urbana denominato “Centro integrato di interscambio modale per il trasportodi persone”. Il Documento di Orientamento Strategico (DOS) è stato approvato nel maggio 2010.
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:12 Pagina 72
ed innovazione” (Asse III), creando nuove opportunità insediative per attività produttive e commercialivolte a rivitalizzare l’economia della città e dell’intera provincia.
Di recente approvazione il PUA Rione Turco (Comprensorio C) destinato al recupero degli standardurbanistici nell’area di Rione Turco, senza la realizzazione di nuove volumetrie marendono utilizzabili quelleesistenti sul territorio e finora inespresse. L a Stessa operazione sarà portata avanti anche per le ex areePeep di Belvedere, Viale della Libertà e di via F iorignano, interventi che costituiscono la base del nuovoPUC di Battipaglia in fase di elaborazione.
Un altro passaggio obbligato è legato al rafforzamento del “sistema dell’accessibilità e della mobilità”(Asse IV). Tale sistema rappresenta un tassello fondamentale nel processo di riorganizzazione fisica e fun-zionale della città sia al suo interno, con la funzione di riordino dei flussi e di connessione delle diverse partidella città creando convenienza localizzativa di attività produttive, terziarie e direzionali, sia all’esterno nelpotenziare il ruolo che Battipaglia ha quale snodo fondamentale nel sistema stradale, ferroviario e da ultimointermodale del sistema provinciale e regionale. È in questa direzione che vanno le linee di intervento pre-viste nell’ambito del progetto PIU EUROPA e in progetti regionali e provinciali (P.T.R. e programmi dellaR.F.I.) prevedono azioni integrate di connessione e riqualificazione dell’area attraverso (Fig. 7):- la creazione di un centro di interscambio modale per i viaggiatori;l - a realizzazione di nuovi spazi pubblici quali piazze, parchi e parcheggi;i - lavori di restyling della stazione ferroviaria di Battipaglia (completato nel novembre 2011);
73
M. BENCARDINO - I. GRECO - L. VALANZANO
Fig. 7 – Programma Integrato Urbano Più Europa, planimetria degli interventi.Fonte: DOS, Comune di Battipaglia - Settore Pianificazione e Politiche Comunitarie, maggio 2010
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:12 Pagina 73
- il potenziamento dei collegamenti viari dalla stazione alle principali arterie stradali comunali ed extra-comunali;
- il quadruplicamento della tratta Napoli-Battipaglia;- il possibile adeguamento a terminale dell’alta velocità/alta capacità;- il terminale della metropolitana leggera di Salerno.
Si tratta di un sistema di azioni che va nella stessa direzione del ruolo assegnato alla città dal recentissimoPTCP di Salerno (approvato con D.P.C. del 30.03.2012), in cui si ribadisce la funzione di Battipaglia qualenodo strategico della conurbazione Pontecagnano-Bellizzi-Battipaglia-Eboli, considerata come articolata cen-tralità in ragione delle potenzialità produttive ed infrastrutturali – esistenti o in programma – funzionale adun ambito più vasto (Picentini da una lato e sistema Sele/Alburni dall’altro) e con forti interrelazioni sia in in-gresso ed in uscita con l’area salernitana. In questa prospettiva, è possibile ridisegnare lo scenario attuale in-dirizzandone l’assetto verso un’organizzazione policentrica strutturata su reti di centralità urbano-territoriali.
Riferimenti bibliograficiAMATO F. (2007), Dall’area metropolitana di Napoli alla Campania plurale, Viganoni L. (a cura di), “Il Mez-
zogiorno delle città. Tra Europa e Mediterraneo, Franco Angeli, Milano, pp. 175-211.BENCARDINO F. (1980), L’armatura urbana nell’area metropolitana di Napoli, “Bollettino della Società Geo-
grafica Italiana”, Roma, Serie X, 9, pp. 55-83.BENCARDINO F., CRESTA A., GRECO I. (2010), Le «città medie» nello sviluppo territoriale della Campania: al-
cune riflessioni, Viganoni L. (a cura di), “A P asquale Coppola. Raccolta di scritti”, Collana «Memoriedella Società Geografica Italiana», LXXXIX, Roma, pp. 385-396.
BENCARDINO F., CRESTA A., GRECO I. (2010), Vecchie e nuove polaritá nella geografia urbana della Campania:alcune riflessioni, “Bollettino della Società Geografica Italiana” - Serie XIII, vol. III, Roma, pp. 801 - 821.
BENCARDINO M. (2007), Qualità della vita nel sistema urbano salernitano: organizzazione del database eclusterizzazione, La Foresta D. (a cura di), “Scenari territoriali del Governo della Sostenibilità e delloSviluppo Urbano”, Aracne Editore, Vol. 290/II, Roma, pp. 211-240.
BENCARDINO M. (2007), Un modello intepretativo complesso per la Valutazione Ambientale Strategica delPiano Urbanistico Comunale di due comuni rurali , Monti S. (diretto da), “L.O .T.M. Annali III-2007”,Loffredo Editore. Napoli, pp. 233-242.
BENCARDINO M. (2012), A quantitative methodological approach for the definition of the urban systems ofBenevento and Salerno, Borruso G., Bertazzon S., Favretto A., Murgante B., Torre C. M. (eds), “Ge-ographic Information Analysis for Sustainable Development and Economic Plan-ning: New Technolo-gies”, IGI Global, Hershey PA, USA, pp. 20-30.
BENCARDINO M., GRECO I. (2012), Processes of adaptation and creation of a Territorial Governance. Theexperience of the cities of Benevento and Salerno (Campania region, Italy),“Journal of Sociology Study”,David publishing Company, USA (pp. 1-15).
BENCARDINO M., GRECO I., REIS LADEIRA P. (2012), The comparative analysis of urban development in twogeographic regions: the State of Rio de Janeiro and the Campania R egion, Murgante et al., (Eds) “In-ternational Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA 2012)”, Part II, LNCS,Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 548-564.
BIANCHI S.A. (2007), Fra storia e geografia: la cartografia come strumento di riflessione e di ricerca storica,“Bollettino A.I.C. ”, n. 129-130-131, pp. 39-53.
74
Nr. 144-145-146 / 2012
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:12 Pagina 74
BOLOCAN GOLDESTEIN M. (2008), Città senza confini, territori senza gerarchie, “Rapporto annuale 2008.L’Italia delle città. Tra malessere e trasfigurazione”, Società Geografica Italiana, Roma.
CATAUDELLA M. (1974), La piana del Sele: popolazione e struttura insediativa, Pubblicazioni dell’Istituto diGeografia Economica», vol. XIII, Università di Napoli.
COMUNE DI BATTIPAGLIA (2010), Programma Integrato Urbano Più Europa, Documento di OrientamentoStrategico (DOS) Città di Battipaglia, Settore pianificazione e Politiche Comunitarie, maggio 2010, Bat-tipaglia.
COPPOLA P., VIGANONI L. (1994), Note sull’evoluzione recente dell’area metropolitana di Napoli, CitarellaF. (a cura di) “Studi geografici in onore di Domenico Rocco”, Loffredo, Napoli, pp. 471-486.
DE VECCHIS G., PESARESI C. (2011), Dal banco al satellite. Fare geografia con le nuove tecnologie, CarocciEditore, Roma.
FORTE E., (2003), Il ruolo delle aree metropolitane costiere del Mediterraneo. Area metropolitana di Napoli,Alinea, Firenze.
GOODCHILD M.F. (2007), Citizen as sensors: the World of volunteered geography, “GeoJournal”, 69, (4),pp. 211-221.
LODOVISI A., TORRESANI S. (2005), Cartografia e informazione geografica. Storia e tecniche, Pàtron, Bolo-gna.
MAUTONE M., RONZA M. (2005), La Campania, complessità paesaggistica e specificità identitarie, “AmbienteSocietà e Territorio. Geografia nelle scuole”, n. 05, pp. 61-68.
MAUTONE M., SBORDONE L. (1983), Città e organizzazione del territorio in Campania, Edizioni ScientificheItaliane, Napoli.
NYRGES T.L., COUCLELIS H., MCMASTER R., (2011) (eds), The Sage Handbook of Gis and Society, Sage,London.
PARENTE A. (1998), Urbanisticare. Tra piano e progetto: Battipaglia, quale piano?. La riqualificazione dopol’espansione, Salerno edizioni.
PREZIOSO (2003), Pianificare in sostenibilità. Natura e finalità di una nuova politica per il governo del terri -torio, Adkronoslibri, Roma.
PROVINCIA DI SALERNo, Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno (PTCP), D.C.P. n. 15del 30/03/2012, www.provincia.salerno.it.
RIITANO M. (2007), Qualità della vita nel sistema urbano salernitano, L a Foresta D. (a cura di), “Scenariterritoriali del governo della sostenibilità e dello sviluppo urbano”, 2nd, Vol. 290/II, Roma, pp. 211-218.
ROCCO CARBONE L. (1999), Battipaglia: 70 anni nella sua storia, Massa editore, Napoli.SOMMELLA R. (2008) (a cura di), Le città del Mezzogiorno. Politiche, dinamiche, attori, Franco Angeli, Mi-
lano.TYNER J.A. (2010), Principle of map design, Londra, Guildford Press.WOOD D. (2010), Rethinking the Power of Maps, The Guilford Press, New-York London.www.google.com/earth/index.htmlwww3.istat.it/dati/db_siti/
75
M. BENCARDINO - I. GRECO - L. VALANZANO
Bencardino p57_Layout 1 06/02/13 16:12 Pagina 75