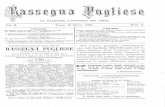L’improbabile eterarchia dei Gruppi di azione locale. Una ricerca sul Gal pugliese «Terra dei...
-
Upload
unisalento -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of L’improbabile eterarchia dei Gruppi di azione locale. Una ricerca sul Gal pugliese «Terra dei...
Istituzioni per lo sviluppo tra Comune e Regione
Unione Europea e prove di ente intermedio in Italia
a cura di Renato D’Amico e Stefano De Rubertis
Rubbettino
© 2014 - Rubbettino Editore88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 - tel (0968) 6664201
www.rubbettino.it
L’autore o gli autori delle pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei diritti nella misura minima del contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione.
5.
5. L’improbabile eterarchia dei Gruppi di azione locale . Una ricerca sul Gal pugliese «Terra dei Messapi»*
di Angelo Belliggiano e Angelo Salento
1. Introduzione
La denominazione «Gruppo di azione locale» (Gal) individua, come è noto, un’organizzazione (preesistente o costruita ad hoc) delegata all’implementazione del programma Leader, una delle più riuscite iniziative comunitarie promosse con la riforma dei fondi strutturali del 1988 (Ray, 2000). Il successo che ha caratterizzato le tre edizioni del programma (Leader I, II e plus) ne ha favorito la definitiva isti-tuzionalizzazione, nella programmazione 2007-’13, nell’ambito del II pilastro della politica agricola comunitaria (Pac). All’approccio Leader è stato infatti dedicato il quarto e ultimo asse della politica di sviluppo rurale, con il fine di ampliarne la diffusione attraverso l’aumento delle risorse finanziarie ad esso destinate (processo cosiddetto di mainstreaming), corrispondenti a una spesa regionale obbligatoria Feasr non inferiore al 5%.
L’importanza dei Gal e delle loro dinamiche di organizzazione e di intervento come oggetti di ricerca trascende certamente il rilievo solitamente attribuito a questi enti nel discorso pubblico. Essi sono di fatto rimasti attori istituzionali di secondo piano. Nondimeno, l’analisi della loro esperienza offre elementi di valutazione estremamente significativi sotto almeno due profili:a. innanzitutto, nell’esperienza dei Gal – nelle modalità con le quali essi han-
no interpretato la promozione dello sviluppo rurale – si possono cogliere le dinamiche (e anche le problematiche) del rapporto fra interventi settoriali e interventi prettamente territoriali; ossia fra interventi condotti nell’ottica dello sviluppo agricolo e interventi rubricabili nell’ambito dello sviluppo rurale. Come avremo modo di constatare, questo è uno dei profili più ampiamente e frequentemente discussi dalla letteratura, fortemente interdisciplinare, che si occupa delle prospettive dello sviluppo rurale;
* Questo saggio è frutto di una riflessione comune degli autori. Tuttavia, la redazione del saggio è da attribuire come segue: i paragrafi 1, 2, 3 e 6 sono stati scritti da Angelo Salento; i paragrafi 4 e 5 da Angelo Belliggiano.
90 angelo belliggiano e angelo salento
b. in secondo luogo, e soprattutto, l’analisi dell’esperienza dei Gal offre la possibi-lità di comprendere le prospettive e i limiti di quelle nuove modalità politiche di governo dei processi sociali che vanno comunemente sotto il nome di governan-ce: modalità che hanno trovato proprio nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale uno dei luoghi privilegiati di sperimentazione e di messa a punto.
Sulla questione della governance dello sviluppo locale e dello sviluppo rurale si è prodotta una letteratura pressoché sterminata, riferibile a diversi ambiti disciplinari. Gran parte di questa produzione ha un’impostazione in senso lato «normativa»: essa istituisce, per così dire, una dottrina della governance che costruisce l’idea di governance, nell’apparenza di descriverla. Una parte probabilmente meno estesa ma comunque molto rilevante dei contributi di ricerca restituisce un’immagine dei processi di governance difforme, talora non di poco, da quella che si potrebbe definire la versione mainstream della governance. Ogni volta che si guarda non alle astratte potenzialità dei processi di governance, ma alle loro performance reali, emerge una divaricazione fra obiettivi e risultati.
Se l’interesse per la governance dei processi di sviluppo non declina – mo-strando invece di resistere alle numerose testimonianze di fallimento – ciò si deve probabilmente a quell’atteggiamento che Bob Jessop (2006) ha chiamato ironia romantica pubblica, ovvero un «ottimismo della volontà» che spinge gli attori a procedere come se il successo fosse possibile, pur non potendo fare a meno di riconoscere le probabilità del fallimento della governance.
È questo, del resto, lo spirito con il quale abbiamo inteso condurre questa ricerca: ci interessa proporre una valutazione realistica e disincantata, però sul presupposto, filosoficamente e politicamente costruttivo, che l’analisi dei limiti degli strumenti di governance si possa tradurre in uno sforzo di trasformazione orientato a superarli.
La nostra indagine si articola sia sul piano teorico, provando a costruire una griglia di riferimento per l’analisi delle esperienze di governance dello sviluppo ru-rale; sia sul piano empirico, proponendo, in via esemplificativa, lo studio di un caso.
Nel prossimo paragrafo, dopo una breve ricostruzione della storia del Gal come strumento di governance, individuiamo alcune chiavi di lettura teoriche per definire la collocazione «ideale» del Gal in una prospettiva di governance dello sviluppo rurale. Nel paragrafo 3, proponiamo una griglia teorica per l’analisi del fallimento – o dei fallimenti – che si registrano nell’esperienza dei Gal quando si paragonano le loro performance reali con gli obiettivi che ufficialmente sono loro ascritti. I paragrafi 4 e 5 sono dedicati all’analisi di un caso, quello del Gal Terra dei Messapi (operante nella provincia di Brindisi), che si presenta per molti versi come un caso esemplare, poiché – come diremo – si presta bene ad analisi e considerazioni che riguardano sia la relazione fra interventi settoriali e sviluppo rurale, sia le difficoltà di strutturare una governance dello sviluppo rurale entro
91l’improbabile eterarchia dei gruppi di azione locale
condizioni politico-istituzionali per certi versi poco consone a una gestione inte-grata, partecipata (o bottom-up) dei processi deliberativi.
2. Elementi per una teoria dei Gruppi di azione ocale
La storia dei Gal è legata a doppio filo alle trasformazioni delle politiche agrico-le europee. Risale alla fine degli anni Ottanta la scelta della Commissione europea di abbandonare progressivamente la politica agricola basata su un approccio «dall’alto» fondato su progetti e su settori, e di privilegiare invece – almeno nominalmen-te – un approccio «dal basso», per così dire endogeno e integrato. Con The Future of Rural Society (1988), e in seguito con la Dichiarazione di Cork (1996) e con il documento Rural Developments (1997), l’attenzione fu spostata progressivamente sulla dimensione territoriale e su un approccio orientato alla promozione di uno sviluppo endogeno, sostenibile e partecipativo.
Secondo una tipizzazione diffusa in letteratura (Sotte, 2006), nel corso del-la seconda metà del Novecento si può osservare una transizione evolutiva, che muove da un modello di «ruralità agraria», a un modello di «ruralità industriale», per finire a un (incompiuto, o addirittura ancora incipiente) modello di «ruralità post-industriale». Il terzo modello emergerebbe, a partire dagli anni Novanta, da un mutamento del «mandato sociale» delle aree rurali, alle quali verrebbe richie-sto – anche sulla base delle possibilità di spostamento fisico e virtuale offerte dalle nuove tecnologie del trasporto e della comunicazione – di farsi teatro di insedia-menti residenziali come anche di attività di leisure caratterizzati dalla domanda di beni immateriali come la sostenibilità, la qualità della vita, la tipicità, l’autenticità, l’originarietà, la specificità; ossia – in breve – dal legame con il territorio rurale. Da qui l’affermarsi dell’idea di una multifunzionalità dell’agricoltura (Basile e Cecchi, 2001), come anche delle idee di filiera corta e offerta di utilità immateriali.
Alla nozione di sviluppo rurale inteso come prodotto di politiche di «riequi-librio territoriale», si viene sostituendo la prospettiva di uno sviluppo endogeno, fondata sulla creazione di valore innescata e controllata da attori locali. Sul piano delle politiche, questa prospettiva prefigura lo spostamento dagli interventi settoriali alla promozione del territorio. E a questa domanda di diversità e di differenza fa riscontro la ricerca di una nuova forma di distribuzione delle responsabilità, quindi la riarticolazione delle dinamiche di governo e deliberazione rispetto alle scelte di programmazione e di investimento, ovvero di valorizzazione.
Questo processo di trasformazione – che si può definire sinteticamente come transizione a un «modello post-industriale» o, meglio, «post-produttivistico» della ruralità (Marsden et al, 1993; Ploeg e Renting, 2000) – non può essere interpretato semplicemente, come spesso avviene, alla stregua di un esito «naturale» di una trasformazione evolutiva delle idee e delle pratiche di sviluppo. Esso non è sempli-
92 angelo belliggiano e angelo salento
cemente il frutto di un «superamento» di precedenti approcci che si sono rivelati insoddisfacenti. Piuttosto, si tratta di una trasformazione che pare rispondere a un triplice ordine di esigenze e di interessi.a. Per un verso, esso esprime un quadro di bisogni «post-materialistici» (Inglehart,
1977) elaborati prima dalla «critica estetica» (Boltanski e Chiapello, 1999) della modernizzazione capitalistica e poi attraverso il diffondersi di una cultura e di una sensibilità ambientaliste.
b. In secondo luogo, si configura come un processo di riaggiustamento delle stra-tegie di valorizzazione capitalistica, che tende a spostare il baricentro della pro-duzione di profitto dall’interno all’esterno dell’impresa, mettendo a valore gli oggetti stessi di quel rinnovato quadro di bisogni. Nel declino della dimensione prettamente industriale delle imprese, è il territorio a essere interpretato – come ammettono gli economisti aziendali – alla stregua di «giacimento di vitalità per l’impresa»1. Se la ricerca di esternalità positive è – secondo l’approccio dello sviluppo locale – la chiave del successo delle imprese radicate nella dimensione territoriale, la cosiddetta valorizzazione del territorio appare come l’estrema conseguenza di questa ricerca.
c. In terzo luogo, ma non da ultimo, esprime la tendenza a una costruzione dell’Europa come uno spazio della competizione fra territori: sono gli attori sociali che operano nel contesto (rurale) a doversi mantenere in una condizione di continua mobilitazione in vista dell’automantenimento del proprio benessere economico; è a ciascun territorio che spetta di individuare e mettere a valore le «proprie» risorse in un quadro di competizione globale.
In questo quadro va compresa la genesi degli istituti della governance dello sviluppo rurale: una genesi che si colloca a cavallo fra la fase della «ruralità indu-striale» e quella della «ruralità post-produttiva».
Dall’inizio degli anni Novanta, l’Iniziativa Comunitaria Leader è stata il ba-ricentro della sperimentazione di una nuova modalità di governo dei rapporti fra processi sociali e sistema istituzionale: sperimentazione, cioè, di dispositivi astrattamente in grado di generare un «possibile incontro fra politiche istituzio-nali e pratiche sociali» (Magnaghi, 2000, p. 114). I Gal – incaricati della gestione di questa Iniziativa comunitaria su base territoriale (subprovinciale) – sono stati pensati come il cardine di processi di governance radicalmente rinnovati nell’ottica di percorsi di sviluppo bottom-up, sulla base del presupposto che non esista un modello di sviluppo standard, valido per qualsiasi contesto rurale.
Come i Gal, anche i Piani di azione locale (Pal) – ossia gli strumenti di pia-nificazione redatti dai Gal (e sottoposti al vaglio comunitario) per definire il per-corso di sviluppo da porre in essere – rispondono, in linea di principio, a requisiti
1. Al tema è dedicato il numero 90/2013 della rivista «Sinergie».
93l’improbabile eterarchia dei gruppi di azione locale
di integrazione e di intersettorialità. La caratteristica basilare di questi strumenti è quella di generare un incontro fra attori locali in vista di un comune obiettivo di valorizzazione a beneficio del territorio rurale di riferimento.
Beninteso, al pari di quanto si può affermare in via generale per le dottrine e gli approcci dello sviluppo locale, l’idea dello sviluppo rurale non pone affatto un’alternativa radicale rispetto agli imperativi della valorizzazione capitalistica delle risorse. Piuttosto, esprime una concezione dello sviluppo come competi-zione su scala globale, un continuo «competing with everyone from everywhere for everything» (Sirkin et al, 2008). Non si tratta, dunque, di una mutazione delle regole del gioco fondamentali del libero mercato, ma di una trasformazione delle modalità della competizione: l’idea di sviluppo rurale muove dal presupposto che la competizione non può essere giocata sulla base di una razionalità assoluta, univoca e predeterminata, ossia secondo una one best way dello sviluppo. Va assecondata, al contrario, la più ampia apertura cognitiva, allo scopo di apprendere costante-mente nuove risorse e nuove modalità di valorizzazione. Conseguentemente, le interdipendenze fra attori sociali non economici, attori economici e attori istitu-zionali non devono essere gestite attraverso strumenti, come la gerarchia, che ne riducono la complessità, ma attraverso dispositivi che permettano di interpretare la complessità come una risorsa.
La vastissima letteratura sulla governance ne ha messo in luce aspetti diversi, non necessariamente alternativi. Ci pare in ogni caso difficilmente contestabile che la governance si debba ritenere una modalità «post-moderna» (e probabilmente post-democratica) di regolazione dell’economia, che chiama le compagini locali a compiti di «lubrificazione» delle dinamiche economiche in un contesto di riduzione dell’azione diretta dello Stato nell’economia (Jessop, 2006).
Prescindendo dalla questione dei fondamenti politici ed economici degli stru-menti di governance, in questa sede il nostro sforzo sarà quello di comprendere la logica operativa degli strumenti di governance dello sviluppo rurale, mettendo a confronto i loro «modelli di riferimento» e le modalità tipiche delle loro fallimenti totali o parziali.
I concetti e le tematizzazioni più efficaci per comprendere dinamiche e falli-menti dei dispositivi di governance ci sembrano quelli disponibili nell’ambito della teoria e della sociologia dell’organizzazione. Rinviando al prossimo paragrafo la ricostruzione delle modalità tipiche del fallimento della governance, qui ci soffer-miamo su quel che è «positivamente» ascritto agli strumenti di governance. Al di là di tutte le definizioni possibili della governance, termine che individua in pari tempo «[un] concetto teorico, [un] paradigma politico e [una] prescrizione normativa» (ivi, p. 190), ci pare possibile affermare che:1. per definire la modalità di coordinamento delle interdipendenze che essa
esprime, o pretende di esprimere, si può fare riferimento al concetto di ete-rarchia;
94 angelo belliggiano e angelo salento
2. la forma organizzativa che esprime meglio le forme di coordinamento delle interdipendenze reciproche cui la governance dà luogo, o pretende di dare luogo, è quella della rete.Riteniamo perciò che una teoria dei Gal debba in primo luogo insistere su
questi due aspetti fondamentali.1. Eterarchia. Chiara espressione di un approccio regolativo fondato sulla go-
vernance, i Gal sono fondati, in linea di principio, su un’interazione di natura eterarchica, ovvero sull’auto-organizzazione riflessiva. È questa (Stark 2009) una modalità di coordinamento delle interdipendenze che, sempre in termini di prin-cipio, si differenzia nettamente sia dal coordinamento di mercato, sia dal coordi-namento di governo. Laddove questi ultimi si fondano sull’esercizio di un tipo di razionalità (razionalità economica nel primo caso, razionalità politica nel secondo caso), il coordinamento eterarchico assume che debbano essere messi in gioco attori portatori di razionalità diverse e di istanze che in regime di mercato o in regime di governo apparirebbero incompatibili e incommensurabili.
L’eterarchia, in sintesi, è una forma di controllo della complessità che si fonda sulla rinuncia alla riduzione unilaterale della complessità: una modalità di coor-dinamento che fa leva sulla possibilità di un apprendimento continuo e fa quindi affidamento sulla disponibilità degli attori all’esercizio di riflessività.
Si tratta, evidentemente, di un principio di regolazione di tipo procedurale, astrattamente idoneo a costruire consenso negoziato per un’azione concertata, in presenza di attori portatori di prospettive differenti.
È esattamente sulla base di questi presupposti che intende fondarsi, in prin-cipio, l’istituzione dei Gal. Essa si presenta appunto come l’istituzionalizzazione di negoziazioni, ovvero di dinamiche di apprendimento e di mediazione, volte a generare consenso intorno ad acquisizioni messe in comune o addirittura sviluppate in comune. È chiaro che, così concepiti, i Gal si presentano come strumenti idonei a individuare in maniera flessibile il livello ottimale di governo dello sviluppo ru-rale, perché si possono «modellare» sulla base di ciascuna specifica configurazione territoriale. Sulla carta, dunque, si tratterebbe di strumenti estremamente efficaci per superare i vincoli posti dagli assetti politico-amministrativi. A ciò va aggiunto che, sempre in linea di principio, i Gal sono in grado sia di fare leva su risorse private, sia di integrare le strategie del territorio con quelle di settore.
2. Rete. Come nota Stark (2009), due aspetti fondamentali sono in pari tempo implicati nell’organizzazione eterarchica: il primo riguarda un principio di ordine sostanziale-procedurale – del quale abbiamo appena detto – ossia l’assenza di un ordinamento gerarchico di principi di valutazione. Il secondo riguarda un principio di ordine strettamente organizzativo: la forma organizzativa «naturale» dell’eterar-chia è quella della rete.
Negli ultimi vent’anni, nella letteratura sociologica si è sviluppata la consa-pevolezza che esistono modalità di coordinamento diverse da quello di mercato
95l’improbabile eterarchia dei gruppi di azione locale
come anche da quello gerarchico e verticale. Un riferimento essenziale, sotto questo profilo, è stato e continua a essere il lavoro di Powell (1990). Da allora, è stato argomentato in maniera via via più chiara che le modalità di coordina-mento «terze» non sono semplicemente forme ibride delle prime due – come invece si tende ad affermare in seno al neo-istituzionalismo economico (Wil-liamson, 1985) – ma forme di coordinamento reticolare che sono chiaramente diverse sia dalle relazioni di mercato, per loro natura «occasionali», sia dalle relazioni gerarchiche, nelle quali opera di necessità un’autorità legittima (Po-dolny e Page, 1998).
Benché negli studi sullo sviluppo locale si sia dato ampio rilievo a nozioni elaborate «al confine» fra teoria economica e analisi sociologica – prima fra tutte quella di capitale sociale (con particolare riferimento allo sviluppo rurale, si veda Pagan, 2009) – per lungo tempo, come ha notato Pichierri (2002), la dimensione organizzativa «è stata tutto sommato scarsamente compresa dagli studiosi di svi-luppo locale».
Recentemente, si sono sviluppati alcuni tentativi di ricostruzione organica degli usi possibili dei concetti della sociologia dell’organizzazione nell’analisi dei processi di sviluppo. Nella proposta di Piras e Salivotti (2012), ad esempio, anche il concetto di rete – come sviluppato nella sociologia dell’organizzazione – trova spazio nella tematizzazione della governance dello sviluppo.
Almeno su un piano di astrazione, la configurazione dei Gal è riferita a un’idea di coordinamento reticolare, ossia alla costruzione e alla gestione di rapporti simme-trici, non gerarchici. Da una «rete di fatto» – la rete di conoscenze, di competenze, di enti e livelli deliberativi che comunque opera nelle dinamiche del mutamento socio-economico – si transita, per così dire, verso una «rete di diritto», ovvero verso l’istituzionalizzazione del coordinamento reticolare.
3. Elementi per una teoria del fallimento dei Gruppi di azione locale
Se negli ultimi vent’anni, come abbiamo detto, si è sviluppata e messa a punto l’idea che esistano forme di governo delle interdipendenze che sono neither market nor hierarchies, nell’ultimo decennio la letteratura sociologica è venuta sviluppando anche la consapevolezza che le dinamiche di governance e gli assetti organizzativi reticolari che esse sottendono, lungi dal poter essere concepiti come la soluzione dei fallimenti dello Stato e del mercato, sono soggetti essi stessi a frequenti e ma-nifesti fallimenti.
Come ha avvertito Bob Jessop, «la crescente attrattività [dei] meccanismi di governance non deve spingerci a sottovalutare i rischi connessi alla sua sostituzione allo scambio e al comando e a ignorare le probabilità di fallimento della governan-ce. [...] Perché non sono solo il coordinamento imperativo e quello del mercato
96 angelo belliggiano e angelo salento
a fallire; anche la governance tende al fallimento, anche se per ragioni diverse, in modi diversi e con effetti diversi» (Jessop, 2006, pp. 198-199).
Sono in effetti innumerevoli, in letteratura, le testimonianze e le analisi di casi di fallimento, parziale o totale, di forme di coordinamento reticolare e, in princi-pio, eterarchico. Recentemente, Andrew Schrank e Josh Whitford (2011) hanno proposto l’idea di costruire una sorta di «teoria generale» del fallimento delle reti, in grado di rendere conto delle cause della mortalità (o della nascita mancata) delle reti, come anche dei casi in cui le reti vengono mantenute in vita nonostante le loro scadenti performance. La tassonomia dei fallimenti proposta dai due socio-logi statunitensi distingue quindi fra fallimenti assoluti e fallimenti relativi (ivi, p. 153). I primi si verificano in caso di (i) rottura di relazioni già esistenti, che si può qualificare come dissoluzione della rete, oppure di (ii) mancata formazione di reti potenzialmente produttive o redditizie, che si può qualificare come aborto della rete. Quanto ai fallimenti relativi, gli autori distinguono fra (iii) rete involuta, che ricorre nei casi di un fallimento permanente dovuto a carenza di competenze e (iv) rete contestata, che ricorre nei casi di eccesso di opportunismo.
Il pur vasto repertorio proposto da Schrank e Withford – forse pienamente idoneo a dare conto delle vicende di reti costituite da attori economici privati, che operano entro un campo organizzativo inteso come sfera della concorrenza fra imprese – sembra però non prendere in conto ulteriori fonti di compromissione della performance delle reti che si generano allorquando la natura degli attori coinvolti, e quindi anche la natura delle negoziazioni, è più estesa. La governance dei processi di sviluppo ha, almeno in linea di principio, connotati decisamente più complessi rispetto alle configurazioni reticolari passate al vaglio da Schrank e Whitford.
Altre analisi, come quella proposta da Bob Jessop (2006), offrono ulteriori spunti d’analisi proprio perché sono riferite espressamente a processi di governance nei quali sono coinvolti attori economici insieme ad attori sociali non economici e ad attori politico-istituzionali. Secondo Jessop, ci sono almeno quattro grandi categorie di problemi che possono risultare insormontabili per una governance pur ben architettata:1. innanzitutto, la governance nulla può a fronte di esigenze di governo di radi-
cale complessità. In altri termini, il sociologo di Lancaster suggerisce che alla governance si chiede troppo; e le si imputano insufficienze che sono in realtà il portato di contraddizioni che la governance non può comunque risolvere.
2. In secondo luogo, ci possono essere problemi legati alla possibilità di effettivo apprendimento a fronte di oggetti particolarmente soggetti a cambiamenti o inseriti in un ambiente troppo turbolento.
3. In terzo luogo, si possono registrare problemi legati alla rappresentanza. Co-loro che sono coinvolti negli atti di comunicazione e negoziazione in cui la governance si sostanzia, non sono i soggetti immediatamente interessati dalle
97l’improbabile eterarchia dei gruppi di azione locale
azioni e dalle decisioni intraprese, ma appunto rappresentanti. Le lacune della rappresentanza diventano, dunque, lacune della governance.
4. Infine, si presenta un’area di problemi legati alla formazione dei soggetti della governance e alle condizioni soggettive del coordinamento. Qui viene in rilievo «la lotta per la definizione delle posizioni dominanti o egemoniche entro spe-cifici ambiti politici o di governance, nonché di più ampie formazioni sociali» (ivi, p. 201).
Nel complesso, le ampie categorizzazioni offerte da Schrank e Whitford, e so-prattutto quelle proposte da Jessop, paiono sufficienti a disegnare una sorta di «teoria dei fallimenti della governance». Esse definiscono un quadro di potenziali aree problematiche nel quale è possibile collocare la maggior parte delle criticità che nel corso del tempo sono state individuate dalla letteratura con specifico rife-rimento alla governance dello sviluppo rurale. Fra queste, si possono annoverare, a titolo esemplificativo, problematiche relative vuoi alle condizioni «di contesto» nelle quali i processi di governance sono chiamati a operare (e che sono in astratto chiamati a modificare); vuoi alle dinamiche «interne» al circuito della governance.
Fra le prime, possiamo ricordare:a. la contraddittoria relazione fra politiche settoriali e politiche di sviluppo rurale;b. più in generale, una scarsa consapevolezza circa la natura di ciò che si definisce
rurale e ruralità (si veda Sivini, 2003, pp. 35-39), permanendo dunque grandi incertezze su quali siano gli attori dei processi di trasformazione;
c. la asimmetria fra i luoghi nei quali sono poste le «determinanti» del cambia-mento e i luoghi nei quali viene esercitata la governance;
d. la scarsità di competenze deliberative delle strutture della governance, che talora si trovano confinate entro un compito di mera gestione di programmi d’azione già in larga misura delineati. Il «collo di bottiglia» delle competenze contribuisce a far sì che le nuove forme di organizzazione mista pubblico-privata tendano a operare come strumenti di accesso ai finanziamenti dei programmi comunitari, senza riuscire a esprimere una progettualità apprez-zabilmente innovativa.
Fra le condizioni di fallimento «interne» alla struttura di governance, si possono annoverare:e. la formazione, o la perpetuazione, di protagonismi che portano ad asimmetrie
rilevanti nella composizione della rete (Timpano, 2005), assicurando il coin-volgimento preminente degli attori più integrati nel sistema locale di potere (Murdoch, 2000);
f. la convergenza delle parti su scelte che non rispondono a criteri di efficienza ed efficacia, ma a un compromesso «al ribasso» fra le esigenze degli attori stessi, che permette di coagulare il consenso (Piras e Salivotti, 2012);
98 angelo belliggiano e angelo salento
g. l’insufficiente livello di partecipazione ai processi deliberativi. Nel Libro Bian-co Ue sulla governance, partecipazione è una parola-chiave, se non il termine fondamentale. E tuttavia l’inadeguatezza della partecipazione reale è una con-statazione estremamente diffusa.
Nel prossimo paragrafo, ricostruiremo alcuni profili critici dell’esperienza di uno dei Gal operanti nella Regione Puglia. Quello che emergerà dalla ricerca, come vedremo, è un repertorio di problemi di diversa natura, che tuttavia ci pare possibile comprendere mettendo a valore il quadro teorico che abbiamo sin qui ricostruito.
4. Una ricerca sul Gal «Terra dei Messapi». Precisazioni metodologiche
All’approccio Leader, come è stato osservato in altre parti del volume, è stato dedicato il quarto e ultimo asse della politica di sviluppo rurale della programma-zione Feasr 2007-2013, con il fine di ampliarne la diffusione attraverso l’aumento delle risorse finanziarie ad esso destinate (cosiddetto mainstreaming) e sancire il definitivo superamento del carattere sperimentale delle precedenti edizioni (Mar-garian, 2013).
Che il mainstreaming abbia aumentato considerevolmente le risorse destinate al Leader (Mantino, 2008) è certamente un aspetto interessante. Tuttavia, ben più rilevante, per l’analisi scientifica, è la dimensione metodologica e organizzativa degli interventi: è fondamentale approfondire le modalità con cui il modello è stato declinato localmente, analizzandole attraverso parametri di natura in senso lato culturale, quali ad esempio il grado di coinvolgimento e di partecipazione degli attori, l’organizzazione della governance e il significato attribuito al rurale nella prospettiva delle politiche bottom-up di sviluppo locale.
Su tali presupposti è stato affrontato il caso di studio proposto nel presente capitolo, che ha riguardato il Gal Terra dei Messapi in provincia di Brindisi.
La scelta di lavorare su un caso di studio non è casuale. Quello che ci interessa in questa sede, infatti, non è indagare le performance complessive dei Gal in un deter-minato contesto, ma dare «spessore empirico», per così dire, a quel quadro di criticità che la letteratura ha individuato in maniera al tempo stesso frammentaria e idealtipica.
Se fra i molti Gal operanti in prossimità delle nostre sedi di lavoro abbiamo scelto quello denominato Terra dei Messapi, ciò si deve a tre circostanze, che ren-dono lo stesso particolarmente interessante. Innanzitutto, i Comuni partecipanti a tale Gal sembrano esprimere una forte vocazione identitaria, che è stata registrata chiaramente, nel 2012, allorché essi hanno dichiarato la volontà di essere ricom-presi nella stessa Provincia (Lecce) nell’eventualità di un riordino istituzionale del territorio regionale. Secondo, perché questi Comuni hanno dimostrato nel tempo una spiccata sensibilità per le forme di coordinamento intercomunale: lo dimostra
99l’improbabile eterarchia dei gruppi di azione locale
il fatto che, in una fase in cui erano impossibilitati ad accedere a finanziamenti nella forma del Gal, hanno deciso di costituirsi in Consorzio intercomunale, conser-vando così la partnership sviluppata in una precedente esperienza Leader (Leader II). Infine, analizzare questo Gal rende agevole anche studiare i rapporti fra lo stesso e l’Area Vasta, dal momento che il territorio del primo ricade interamente nell’Area Vasta Brindisina.
Lo studio si è concentrato prevalentemente sulle modalità di organizzazione della governance e sulle tensioni interne generate dalla contrapposizione tra spinte (post-) moderne allo sviluppo rurale e resistenze settorialiste, retaggio della vecchia Pac.
Abbiamo selezionato una serie di figure dotate di ruoli diversi, ma ugualmente rilevanti, nell’ambito della governance del Gal (tab. 5.1). Complessivamente sono state svolte 19 interviste semi-strutturate2, che una volta trascritte sono state analiz-zate in dettaglio riconducendo ogni dichiarazione dei rispondenti a uno dei quattro temi fissati per l’analisi (governance, sovrapposizione di strumenti e di obiettivi di policy, limiti di partecipazione, interpretazione dello sviluppo rurale). I pattern individuati in ciascuno di essi sono stati quindi codificati e poi sintetizzati in strut-ture tematiche, la cui combinazione ha permesso l’elaborazione di argomentazioni sovraordinate, proposte nel paragrafo successivo in forma di narrazioni articolate.
L’analisi è stata affrontata seguendo l’impostazione dell’Interpretative Pheno-menological Analysis (Ipa), che, come è noto, prevede un approccio induttivo «[…] adatto allo sviluppo di temi complessi e interrelati» (Convery et al, 2010) e capace di fornire un’interpretazione basata sulla prospettiva degli attori locali. L’ipa, in-fatti, tenta di esplorare l’esperienza personale nell’ambito del fenomeno indagato, basandosi sulle percezioni dei rispondenti, piuttosto che sulle dichiarazioni puntuali degli stessi (Smith e Osborne, 2008). Pur non avendo la pretesa di convalidare le ipotesi sottese al quadro teorico proposto nel paragrafo precedente, l’indagine ha tuttavia consentito di interpretare alcune questioni che lo stesso sollevava e che effettivamente sono state riscontrate nel caso di studio.
2. Le interviste sono state raccolte tra il 22 novembre 2012 e il 14 novembre 2013 da Cosimo Talò, psicologo e dottore di ricerca in Psicologia di Comunità e Modelli Formativi.
100 angelo belliggiano e angelo salento
Tabella 5.1 - Composizione del campione per categorie e attori
Categoria AttorePosizione
rispetto al gal
Management
PresidenzaDirezioneDirezione Amministrativa
internainternainterna
Soci pubblici
Comune di MesagneComune di S. PancrazioComune di FrancavillaConsorzio di Comuni
internainternainternainterna
Soci privati
Cooperativa socialeAzienda agrituristicaPro-locoCNAIGP Carciofo brindisino
internainternainternainternainterna
Gruppi d’interesse
Fondazione culturaleStampa localeCCIAAWWF
esternaesternaesternaesterna
Progettisti Studio di consulenza esterna
Regione Puglia Autorità di gestione esterna
AV Area vasta brindisina esterna
5. I risultati dell’analisi empirica
Come abbiamo osservato nei paragrafi precedenti, la vocazione dei Gal, come di altri dispositivi di organizzazione degli interventi di sviluppo, è una vocazione estremamente impegnativa: quella di produrre interazioni di natura eterarchica. L’azione dei Gal dovrebbe essere rivolta esclusivamente alla ricerca di soluzioni di governance finalizzate alla condivisione delle risorse locali, definendo le strategie e gli strumenti più adatti a tenere insieme la complessità degli interessi e delle idee, che attori pubblici e privati condividono, o comunque intendono rappresentare, nell’ambito del partenariato (Lizzi, 2009). Come abbiamo osservato, questa modalità di concepire la governance implica per gli attori sociali, almeno su un piano di astra-zione, la rinuncia a ogni tentativo di riduzione unilaterale della complessità, una piena disponibilità e capacità di apprendimento continuo, un continuo esercizio di
101l’improbabile eterarchia dei gruppi di azione locale
riflessività. Sul piano organizzativo, questa modalità di concepire il coordinamento richiama una configurazione reticolare.
Sulla scorta di alcuni contributi di vasta portata analitica, come quelli di Jessop (2006) e di Schrank e Whithford (2011), nel paragrafo 3 abbiamo individuato una sorta di inventario delle fattispecie (ipotetiche) di fallimento dei programmi di gestione reticolare degli interventi, proponendo che fra essi possano essere distinti, analiticamente, fattori esogeni o di contesto (politiche conflittuali; scarsa consape-volezza del rurale; vincoli di programmazione, competenze deliberative), e fattori interni alla stessa governance (asimmetrie della rete, inefficienze progettuali, deficit di partecipazione).
Nel seguito di questo contributo, la tematizzazione empirica di questi profili di criticità sarà ricondotta a quattro aree tematiche (a cui saranno rispettivamente dedicati i quattro sottoparagrafi che seguono), secondo la connessione illustrata nella tabella 5.2.
Tabella 5.2 - Le cause dei fallimenti delle reti: raccordo tra fattori teorici e tematizzazioni del caso di studio
Fattori teorici Tipo Tematizzazioni dell’analisi empirica
Asimmetria della rete I Composizione ed equilibri/squilibri della coalizione
Competenze deliberative E Sovrapposizione di strumenti e obiettivi (Gal, Consorzio e AV)Vincoli di programmazione E
Deficit di partecipazione ILimiti di partecipazione
Inefficienze progettuali I
Politiche conflittuali EInterpretazione dello sviluppo rurale
Scarsa consapevolezza del rurale E
5.1 Composizione ed equilibri/squilibri della coalizione
La ricerca empirica che abbiamo condotto mostra in maniera estremamente chiara quanto problematico sia il raggiungimento di una composizione del Gal che soddisfi alcuni requisiti minimi in grado di generare dinamiche di interazione prive di asimmetrie. L’analisi delle interviste ha restituito cinque elementi tematici di rilievo:a. la presenza di una leadership forte nell’ambito della componente pubblica. La
forza della leadership di uno degli otto Comuni del partenariato, Mesagne, pare derivare dal primigenio «radicamento» del Gal – risalente alla program-mazione Leader II – nell’ambito del Comune stesso. Dal medesimo Comune
102 angelo belliggiano e angelo salento
proveniva infatti il nucleo originario dei soggetti fondatori, rimasti i protagonisti assoluti anche nell’ultimo ciclo di programmazione, in virtù della loro caparbia determinazione a «presidiare» l’istituzione nel periodo in cui la stessa non aveva beneficiato dei finanziamenti comunitari (Leader+);
b. la diffidenza della componente privata. Sin dalla sua prima costituzione, l’espe-rienza del Gal è stata accompagnata dall’indifferenza – spesso generata da una fraintesa accezione di sviluppo rurale – o peggio dalla diffidenza della potenziale componente privata del partenariato. Eppure, tanto il documento strategico pre-liminare (Dst), quanto il piano di sviluppo locale (Psl), hanno testimoniato con una certa enfasi il contrario, dichiarando un’ampia partecipazione locale sostan-ziatasi in ben 81 schede progetto. Stando a quanto emerge dall’analisi, il coinvol-gimento della parte privata non è stato spontaneo, ma sollecitato in modo diretto e informale dal management del Gal, che ha puntato soprattutto sulle aziende, sulle organizzazioni sociali o i gruppi di interesse potenzialmente interessati alle opportunità di finanziamento offerte dalla ristretta griglia delle misure previ-ste dal piano (turismo) e capaci di coprire la quota privata del finanziamento, tanto che uno degli amministratori locali a tal proposito afferma che: «[…] è più facile contattare i grandi imprenditori, perché chi è interessato ad investire ha già un’attività economica rilevante o dispone di immobili importanti». Un atteggiamento di questo tipo, pur prestandosi a diverse interpretazioni, appare plausibilmente riconducibile al problema dei vincoli programmatici imposti ai Gal pugliesi, che ha impedito agli stessi di rispondere ai fabbisogni ritenuti più urgenti dal territorio, limitando per questo la partecipazione di una più ampia platea di attori: «questo territorio è ricco di prodotti tipici – di-chiara un rappresentante della CNA – e penso che si sarebbe dovuto investire prioritariamente sulla trasformazione agroalimentare».
c. La presenza di asimmetrie verticali. Il riferimento è in particolare ai rapporti con la Regione. Da parte del Gal si lamenta un rapporto asimmetrico e su-balterno nei confronti dell’amministrazione centrale («gli obiettivi sono stati prefissati dalla Regione – afferma il Presidente del Gal – noi abbiamo potuto raccogliere soltanto le proposte progettuali coerenti con quegli obiettivi»), che la stessa tuttavia riconosce ammettendo un’impostazione centralistica della policy:[…] la particolarità dell’ultima programmazione è che il processo di sviluppo non è stato lasciato alla libera iniziativa del territorio – afferma un funzionario dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia – il ruolo dei Gal è stato ridimensionato alla mera gestione di obiettivi predeterminati, offrendo a quelli meno operosi tra essi l’alibi di agire da semplici sportelli ter-ritoriali per le erogazioni comunitarie.
d. La gerarchizzazione delle procedure decisionali (asimmetrie orizzontali). Nelle vicende del coordinamento intercomunale, come abbiamo visto, un’im-portanza oggettivamente cospicua ha avuto, e continua ad avere, il Consorzio
103l’improbabile eterarchia dei gruppi di azione locale
intercomunale (dominato dalla rappresentanza del Comune di Mesagne e dal quale – ricordiamo – è escluso il Comune di Francavilla Fontana, che pure è fra tutti il più importante nell’ambito del Gal per abitanti e superficie). Secondo diverse testimonianze, molte deliberazioni del Gal non fanno che ratificare, nei fatti, precedenti decisioni assunte in seno al Consorzio interco-munale. Questa dinamica, a conti fatti, configura una modalità di controllo del processo attraverso il quale l’amministrazione del Comune di Mesagne, che di per sé resterebbe numericamente subordinata a quella di Francavilla Fontana in seno al Gal, riesce comunque a esercitare la propria egemonia. Peraltro, questa modalità deliberativa viene frequentemente giustificata come una scelta di efficienza: «una volta che è stata dipanata ogni singola questione all’interno del Consorzio – afferma il Responsabile tecnico-amministrativo del Gal – si arriva al Gal con l’accordo [concluso] senza alcun problema. Non voglio dire che è [come] avere una marcia in più, ma il percorso [deli-berativo] è molto veloce».
e. Il bisogno di competenze specifiche per la programmazione e la gestione dei programmi. Abbiamo registrato, fra gli attori intervistati, una diffusa consape-volezza della necessità di ricorrere a competenze specialistiche nella gestione del Gal. Da più parti è stato infatti rilevato che le performance dello stesso potrebbero migliorare attraverso l’organizzazione di settori specialistici in seno alle amministrazioni locali del partenariato. Un più elevato livello di competen-ze comporterebbe, probabilmente, anche una partecipazione più consapevole alle attività del Gal; le quali in realtà finiscono per essere praticate in maniera improvvisata, e spesso come occasione di opportunismo.
5.2 I limiti della partecipazione
Altrettanto insoddisfacente – almeno se rapportati a un astratto «dover esse-re» della governance dello sviluppo rurale – è la qualità dei processi partecipativi, processi che evidentemente costituiscono un elemento essenziale di un dispositivo organizzativo come il Gal.
Sotto questo profilo, le interviste hanno restituito tre aree di criticità:a. L’incerta promozione della partecipazione.
È diffusa fra gli intervistati la convinzione che la partecipazione costituisca il presupposto della costruzione e del funzionamento di una rete locale. Tuttavia, il giudizio dei rispondenti sul processo di partecipazione animato dal Gal nella fase iniziale della progettazione è risultato disomogeneo. Mentre infatti la compo-nente pubblica del partenariato e gli amministratori del Gal hanno manifestato soddisfazione per l’ampia partecipazione registrata durante la fase istruttoria del programma: «[…] quando abbiamo fatto gli incontri nel mese di ottobre – osserva
104 angelo belliggiano e angelo salento
il responsabile tecnico-amministrativo del Gal – non ci aspettavamo una parteci-pazione così alta. Sono venuti tutti!».
I giudizi della componente privata sono risultati invece più o meno severi in relazione dell’accoglimento o meno delle proprie istanze nel progetto finale. I giudizi più critici sono stati, inoltre, accompagnati dal sospetto di scarsa imparzialità da parte degli amministratori nei confronti delle proposte provenienti da ambienti estranei a quello agricolo: «Io non ho mai sentito affrontare argomenti sul mondo dell’artigianato», osserva un funzionario della CCIAA di Brindisi che è anche uno dei soci privati del Gal; mentre il responsabile di una fondazione culturale locale esterna al Gal nota che «[…] limitare l’azione del Gal ai settori affini all’agricoltura sarebbe riduttivo. Quei settori non vanno certo esclusi ma non vanno nemmeno ritenuti i soli».
Per quanto taluni rispondenti abbiano riconosciuto in alcune episodiche attività seminariali forme di prosecuzione del processo di partecipazione attivato inizial-mente dai progettisti, esso sembra di fatto essersi arrestato al termine della stesura del Dst, dimostrando che la partecipazione è stata intesa prevalentemente come un processo contingente e, soprattutto, delegabile a un soggetto esterno come un progettista. Non sorprende quindi che alcuni attori abbiano segnalato con interesse il timido avvio di nuclei embrionali di rete locale, considerata, evidentemente, tutt’altro che scontata, nonostante l’ultradecennale attività del Gal sul territorio. Come osserva il presidente del Consorzio di valorizzazione del carciofo brindisino, che figura tra i componenti privati del Gal, «io credo che il prossimo passo del Gal […] debba essere quello di mettere in rete le attività produttive del territorio. Il percorso è avviato, ma è ancora nello stadio embrionale».b. Lo scarso potenziale del processo partecipativo e la diffusione di comportamenti
opportunistici.
Emerge chiaramente, dalle interviste, la diffusa consapevolezza che i processi di partecipazione hanno, in definitiva, scarse potenzialità. In ultima analisi, questa percezione viene ricondotta al fatto che gli obiettivi strategici del Psl sono indivi-duati in maniera sostanzialmente eterodiretta. In effetti, al contesto locale è riservata soltanto la possibilità di declinare discrezionalmente le misure che paiono più adatte al proprio progetto di sviluppo. Questa limitata possibilità di intervento riduce ex ante le potenzialità del processo partecipativo. Privo di una congrua capacità deli-berativa, esso viene quindi diffusamente percepito come una sorta di superfetazione organizzativa. Si spiega così – ci pare – che la partecipazione sia stata sollecitata soltanto nella fase iniziale della programmazione, in ragione della presenza di mec-canismi premiali nella fase di valutazione dei progetti. Questo ha spinto i promotori ad avviare comunque, e in tempi molto rapidi, processi di consultazione, che essi stessi dichiarano di ritenere scarsamente efficaci e sostanzialmente opportunistici. Come osserva un responsabile dello studio di consulenza che ha curato il Dst e
105l’improbabile eterarchia dei gruppi di azione locale
progettato il Psl, «[…] la strutturazione del questionario [finalizzato a facilitare il processo partecipativo e l’individuazione dei bisogni del territorio] è stata molto complessa dati i vincoli sulle misure, sulle azioni e sui beneficiari imposti dal Psr. […] Dovevamo fare in modo di recepire le istanze dei partecipanti, inducendo gli stessi però a definirle nello stretto ambito delle misure già programmate dal Psr».
Quanto ai moventi opportunistici della partecipazione, lo stesso testimone ricorda che «[…] questo grande sforzo di animazione territoriale fu programma-to insieme al comitato promotore perché avrebbe portato vantaggi in termini di valutazione della candidatura del Gal, considerato che si potevano ottenere punti aggiuntivi con l’attivazione delle azioni partecipative».
In definitiva – come ammonisce l’amministratore di uno dei Comuni soci del Gal – questa «non è partecipazione, è simulazione della partecipazione. Legare la partecipazione al bando non va bene […] e i Gal dovrebbero promuovere co-stantemente iniziative riconducibili alla partecipazione, indipendentemente dai bandi». In un contesto organizzato, il Gal, esplicitamente orientato alla gestione partecipata degli interventi di sviluppo, la «cultura della partecipazione» pare ma-nifestare carenze rilevanti.
Va aggiunto che, secondo quanto emerge da diverse testimonianze, la promozio-ne di deliberazioni partecipate sarebbe stata ridotta al minimo indispensabile non soltanto perché ritenuta superflua, ma anche perché percepita come politicamente «pericolosa», in quanto capace di minare consensi già consolidati. Secondo questa interpretazione, sarebbe stata soprattutto la componente politica del partenariato a produrre «reazioni difensive» nei confronti della partecipazione, finalizzate a ridimensionarne l’importanza.c. Il diffuso bisogno di partecipazione.
Stando a quanto emerge dalle testimonianze degli intervistati, la partecipa-zione, benché intrinsecamente priva di una portata decisionale all’altezza delle sfide, è ritenuta, almeno in potenza, uno strumento molto importante per l’avvio o il consolidamento dei processi di sviluppo rurale. La carenza di procedure co-dificate per le deliberazioni partecipate viene considerata il maggiore fattore di criticità del Gal oggetto di studio. Il bisogno di confrontarsi per verificare o per mettere a punto obiettivi e pratiche condivisi è stata superata attraverso forme di integrazione estemporanee, soprattutto orizzontali, indipendentemente dal diretto coinvolgimento degli attori nel partenariato del Gal: «Se esiste qualche forma di rete – dichiara la titolare di un’azienda socia del Gal – io non ne ho conoscenza. Se partecipiamo a delle reti, sono reti esterne al Gal. Oppure sono reti che uno crea personalmente».
Il mancato riconoscimento del processo partecipativo come linfa vitale del Gal ha impedito che si sviluppassero all’interno del partenariato le professionalità che quel processo presuppone. Anche su questo tema abbiamo registrato un bisogno di
106 angelo belliggiano e angelo salento
formazione delle competenze. A tale riguardo, tuttavia, si è colto un atteggiamento tendenzialmente passivo del partenariato: il quale, percependo la pratica della par-tecipazione più come un’imposizione eteronoma che come un’esigenza propria, non avverte il bisogno di generare al proprio interno le competenze necessarie, ma si limita tutt’al più a rivendicare servizi formativi nei confronti dell’amministrazione.
5.3 La sovrapposizione di enti e strumenti di coordinamento intercomunale
Com’è stato argomentato da altri contributi in questo volume, la sovrapposizio-ne di dispositivi di coordinamento è uno dei problemi più evidenti – benché troppo poco avvertiti – della governance dello sviluppo. La nostra ricerca ha registrato chiaramente alcuni profili critici riconducibili a questa inflazione caotica di enti. Si sono evidenziati in particolare tre profili di criticità:a. La sostanziale intercambiabilità fra Gal e Consorzio intercomunale.
Il Consorzio è stato istituito per consolidare la partnership di sette Comuni, maturata attraverso una precedente esperienza Leader (Leader II), quando, vi-gente la programmazione Leader Plus, il Gal Terra dei Messapi era risultato non poter accedere ai finanziamenti. Per scongiurare lo scioglimento del sodalizio in-tercomunale, l’istituzione di un consorzio si era rivelata una strada percorribile; e ciò avrebbe reso comunque possibile accedere ai finanziamenti previsti da altri programmi europei (Ipa-Adriatico, Interreg). Pur rivelando un’importante de-terminazione dei partner nel salvaguardare il capitale relazionale maturato nella precedente esperienza Leader, questa vicenda solleva alcune criticità sul piano della sostenibilità istituzionale dei Gal (Fighera, 2009; Lanzalaco, 2009). Nell’ultimo ciclo di programmazione dello sviluppo rurale, la ritrovata possibilità per il Gal Terra dei Messapi di accedere ai finanziamenti avrebbe potuto comportare la fine dell’esperienza del Consorzio (a meno di una sua riconversione in istituzione di erogazione a cui però le amministrazioni comunali non sembrano interessate).5. La conflittualità competitiva fra Gal e Area Vasta.
Più problematico del precedente appare l’overlap fra Gal e Area Vasta. Elementi di conflittualità fra i due enti sono emersi con l’emarginazione del Gal nella fase di implementazione del Piano Strategico di Area Vasta (Psav). Le testimonianze degli attori intervistati fanno risalire questa esclusione a tre circostanze: l’incapa-cità dell’Area Vasta – a detta degli operatori del Gal – di perseguire una visione organica del territorio, privilegiando invece le istanze dei Comuni di maggiore dimensione (a cominciare dal capoluogo di provincia, Brindisi); la scarsa cultu-ra associativa degli amministratori locali, che avrebbe impedito di comprendere l’importanza delle esperienze maturate all’interno del Gal e quindi l’opportunità di metterle a valore; infine, la presenza di una latente competizione tra territorio
107l’improbabile eterarchia dei gruppi di azione locale
urbano e rurale, che avrebbe indotto la cabina di regia dell’Area Vasta a escludere tacitamente le istanze provenienti dal contesto rurale, sulla base del presupposto che esse potessero comunque trovare soddisfazione in ambiti di programmazione dedicati (Psr). Tuttavia, alcuni testimoni hanno osservato che l’esclusione si è consumata anche in senso inverso – chiamando in causa anche il Gal Terra dei Messapi per lo scarso coinvolgimento dell’Area Vasta brindisina. Inoltre, si fa notare che la scarsa interazione fra Area Vasta e Gal non è un fenomeno generalizzabile a tutta la regione, considerati gli esiti positivi che quest’interazione ha fatto registrare in provincia di Foggia3.b. L’influenza della scala di programmazione sugli esiti del processo.
Gli attori intervistati esprimono in diversi casi la convinzione che la scala degli interventi di sviluppo sia un elemento tanto decisivo quanto problematico. Peraltro, su questo fronte le criticità non sono riferite tanto al Gal, la cui scala di intervento viene considerata adatta a permettere un buon radicamento del progetto nel tessuto economico e sociale locale. Piuttosto, secondo gli intervi-stati l’elemento più problematico è la parcellizzazione degli interventi del Psav, riguardanti quasi esclusivamente le infrastrutture comunali piuttosto che le at-tività produttive locali.
5.4 L’interpretazione dello sviluppo rurale
Un problema nient’affatto trascurabile ci pare il dato per così dire «culturale» che emerge diffusamente dalle testimonianze degli intervistati, ossia una latente quanto diffusa incertezza sull’oggetto – e se vogliamo, per dir così, sulla natura stes-sa – dello sviluppo rurale. Si oscilla tra riferimenti più o meno espliciti all’universo agricolo – inteso prevalentemente come l’ambito delle proprietà fondiarie, piuttosto che delle imprese agricole – e i riferimenti a una parte dell’universo economico e sociale che con l’agricoltura ha (nei fatti o in potenza) qualcosa a che fare, ovvero principalmente al sistema della produzione alimentare e dei servizi turistici.
Benché da lungo tempo la concezione di ruralità sottesa agli interventi di svi-luppo rurale sia stata ampiamente slegata da un riferimento diretto all’agricoltura in quanto tale, negli attori che abbiamo intervistato resiste – e non sappiamo se per interessata e consapevole perseveranza, oppure per un deficit di consapevo-lezza – l’idea che lo sviluppo rurale sia una questione che riguarda l’agricoltura e il suo intorno economico-sociale. È per questo che abbiamo avuto modo di registrare un patente livello di insofferenza e frustrazione per l’impossibilità di realizzare, nell’ambito delle misure Leader, azioni esplicitamente attinenti allo sviluppo agricolo.
3. Riconducibile verosimilmente a una maggiore concentrazione del «capitale sociale» (Nardone et al, 2010).
108 angelo belliggiano e angelo salento
Questo territorio è ricco prodotti alimentari molto apprezzati e penso che è su questi che si sarebbe dovuto investire – afferma un funzionario della CNA di Brin-disi – tante volte invece ci siamo trovati davanti bandi che hanno escluso proprio la trasformazione agroalimentare, perché a essa sarebbero destinati finanziamenti specifici, che però non rispondono affatto ai bisogni delle imprese locali.
6. Conclusioni
L’analisi empirica dell’esperienza del Gal Terra dei Messapi mostra chiara-mente quale sia lo scarto fra i due «pilastri» teorici dei Gruppi di azione loca-le – eterarchia e reticolarità – e la configurazione relazionale che si viene strut-turando, di caso in caso, sulla base di condizioni intrinsecamente storiche e contestuali. La nostra analisi – condotta su un livello micro – ha messo in luce, in maniera puramente esemplificativa, alcune condizioni di ordine per così dire locale o congiunturale, legate alla storia della specifica esperienza di governance presa in considerazione.
Alcune delle criticità rilevate, peraltro, rimandano manifestamente a questioni di ordine più generale ed estrinseco rispetto alla storia del Gal che abbiamo stu-diato. Fra le criticità che la nostra indagine empirica ha rilevato, anche quelle che a prima vista si direbbero legate alla dimensione «evenemenziale», alla «microstoria» del Gal che abbiamo analizzato, possono essere tematizzate come espressione di questioni di portata più ampia. I comportamenti opportunistici, la formazione di protagonismi, e – se vogliamo – la stessa moltiplicazione e parziale sovrapposizione di ambiti politico-amministrativi competenti su questioni largamente assimilabili esprimono non già una singolare peculiarità della specifica esperienza che abbiamo analizzato, ma un quadro di criticità alquanto diffuso nei contesti del Mezzogiorno italiano.
Si manifestano anche su questo piano, dunque, le tensioni proprie della dia-lettica fra territorializzazione e deterritorializzazione (sulle quali si veda il saggio di Stefano De Rubertis, in questo volume). Si assiste al paradosso per cui, da un lato, ai soggetti chiamati a dare vita alla governance dello sviluppo locale/rurale si domanda di esprimere scelte di sviluppo embedded nella dimensione territoriale; dall’altro, ci si aspetta che le loro modalità di azione siano disembedded rispetto alle dinamiche della regolazione sociale propria del contesto e della sua storia. Siamo di fronte a un doppio legame: vige per un verso l’aspettativa di un’azione radicata nel cosiddetto territorio, ma dall’altro l’aspettativa che la regolazione dell’azione risponda a criteri di governance alieni rispetto alle pratiche politico-amministrative (clientelari, familistiche e comunque incapaci di efficacia e di efficienza) che sono parte costitutiva della vicenda storica del contesto locale: una vicenda nella quale l’arretratezza delle istituzioni esprime «l’interiorizzazione dell’arretratezza», intesa
109l’improbabile eterarchia dei gruppi di azione locale
come «funzione materiale e politica» dello sviluppo capitalistico (Ferrari Bravo, 1972/2007).
All’esito della nostra ricerca, non possiamo quindi permetterci di trarre alcuna conclusione propriamente detta. Piuttosto, ci pare di vedere emergere la necessità di una comprensione delle politiche istituzionali, che permetta di trascendere la semplice constatazione dello scarto fra la logica «ufficiale» degli strumenti messi in campo e la loro logica operativa reale. La storia delle iniziative comunitarie sullo sviluppo rurale – e più in generale la storia della edificazione di un «terri-torio europeo» come spazio della competizione fra sub-territori – è ancora di là dall’essere compiutamente ricostruita. Prima che una conoscenza di questo tipo si sia consolidata, non si potrà affermare con certezza – come pure qualcuno sugge-risce – che la ristrutturazione istituzionale europea in tema di sviluppo rurale sia stata pensata e realizzata «come tentativo di governabilità politica e sociale delle pratiche conflittuali» (Vitale, 2006, p. 97). Ci pare fuor di dubbio tuttavia, anche alla luce della reale distribuzione delle risorse economiche destinate ai contesti rurali, che l’iniziativa Leader, con la sua insistenza sulla centralità della governance, riesca a produrre nulla più che un modesto palliativo rispetto alle contraddizioni «sistemiche» intrinseche al modello di sviluppo di fatto perseguito; contraddizioni delle quali la permanenza del dualismo Nord-Sud è un aspetto non secondario.