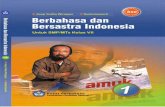Missing Letters: Seven stories and one novella - Digital ...
Priori di Santa Maria Novella di Firenze 1221-1325, «Memorie domenicane» 17 (1986) 253-284.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Priori di Santa Maria Novella di Firenze 1221-1325, «Memorie domenicane» 17 (1986) 253-284.
Priori di Santa Maria Novella di Firenze 1221-1325,
«Memorie domenicane» 17 (1986) 253-84.
1 dirigenza conventuale e politica cittadina
2priorati e praedicatio conventuale | priore, né abate né re: prior et ipsi fratres cum eo
3 elenco priorale: problemi di metodo4 governo conventuale e promozione culturale: Nicola
Trevet e Paolo dei Pilastri,
5
Tolomeo da Lucca, Riccoldo; Giordano da Pisa; Bartolomeo da San Concordio e il sallustiano Neri di Cambio (quale? → http://www.e-theca.net/emiliopanella/nomen2/neri.htm
priori 1221-1279 1282-1300 1301-1311 1312-1325
http://www.e-theca.net/emiliopanella/governo/priori.htm
http://archivio.smn.it/emiliopanella/governo/priori.htm
1. «Tra i monaci emigrati insieme con i Guelfi, per i quali naturalmente l’esilio era meno doloroso che per gli altri, si trovava l’omonimo nipote del proposto del Duomo, il domenicano Pagano degli Adimari, come pure Aldobrandino de’ Cavalcanti, priore di Santa Maria Novella. Ora Aldobrandino divenne capo del convento di San Romano a Lucca; il martirio politico fu molto utile tanto all’uno quanto all’altro: Pagano fu più tardi priore del convento domenicano di Firenze, e Aldobrandino fu elevato al grado di Superiore della provincia di Roma e più tardi a quello di vescovo di Orvieto e di vicario della città di Roma».
Così Robert Davidsohn nella Storia di Firenze, ed. 1972, II,699, a proposito delle famiglie guelfe che abbandonarono Firenze e si rifugiarono a Lucca all’indomani della disfatta guelfa di Montaperti (4 settembre 1260) che permise ai ghibellini di rientrare in Firenze e insediarsi nel potere cittadino. Di fatto sia gli Adimari che i Cavalcanti sono nelle liste dei casati esuli nel settembre 1260. Ma a parte il fatto che non necessariamente tutti i membri di ciascun casato andarono esuli[1], il rapporto tra ecclesiastici e sorte politica delle loro famiglie potrebbe
configurarsi in termini meno meccanici di quanto faccia intendere il brano del Davidsohn, non foss’altro perché istituzioni ecclesiastiche (diocesane o conventuali) erano rette da autonome norme statutarie, godevano di tradizionali franchigie, e comunque vantavano in proprio unnotevole peso di soggetti politici entro il dinamismo dellavita cittadina. Fr. Pagano di messer Iacopo Naso degli Adimari[2], autorevole frate di SMN, andò esule con i suoi consorti, come suppone il Davidsohn? Nessuna testimonianza documentaria corrobora l’ipotesi. Fr. Aldobrandino dei Cavalcanti era stato priore conventuale di SMN nella prima metà degli anni ’50, di San Romano di Lucca nel 1261-62, provinciale della provincia Romana nel 1262-68[3]. Non è tentante mettere in rapporto i priorati conventuali d'Aldobrandino con le vicende politiche della città? Appartenente al potente casato guelfo dei Cavalcanti, Aldobrandino fu priore fiorentino durante il “primo popolo”guelfo (1250-60); successivamente, dopo l’esilio dei Cavalcanti in settembre 1260, priore a Lucca, quando in Firenze si erano insediati i ghibellini.
Ma ci fu veramente tale rapporto causale tra vicende delguelfismo fiorentino e priorato lucchese di fr. Aldobrandino? Su quale base, oltreché sull’ironia dello storico di Firenze, riallacciare le successive cariche pubbliche di fr. Pagano e di fr. Aldobrandino al loro esilio («il martirio politico fu molto utile tanto all’uno quanto all’altro»)? Il priore, sia conventuale che provinciale, non veniva nominato ma eletto dai frati dei rispettivi capitoli.
In primavera 1300 Lapo di Guido dei Salterelli sventò una congiura contro Firenze tramata da taluni fiorentini presso la curia papale di Bonifacio VIII e resistette pubblicamente all’intromissione del papa nelle cose fiorentine al punto che Bonifacio nell’indignata lettera alvescovo di Firenze e all’inquisitore di Toscana dette dell’eretico a Lapo sul gioco della “derivatio nominis”: «qui vere dictus est lapis offensionis et petra scandali». Il ceto dirigente operante nelle istituzioni politiche del
comune fiorentino non ne fece gran conto, inviò anzi un segnale di resistenza se elesse Lapo alla carica di priore cittadino nel bimestre aprile-giugno 1300. Nel medesimo anno (da autunno 1299 a luglio 1300) priore conventuale di SMN era fr. Simone dei Salterelli, fratello di Lapo. A quali monocordi propositi i priorati cittadino e conventuale dei due Salterelli possono far pensare se Noffodi Quintavalle, uno dei congiurati nella curia papale contro Firenze, aveva un figlio frate in SMN[4]?
2. I priorati di SMN suscitano altre curiosità allo storico interessato a cogliere i modi in cui il convento mendicante a matrice urbana reagisce in occasione dei perturbamenti politici più acuti della città. Ricordiamo che il reclutamento delle vocazioni era strettamente confinato alla praedicatio del convento, cioè alla circoscrizione geografica che delimitava i termini dei diritti d’attività apostolica (predicazione, confessioni, reclutamento, questua) del singolo convento. La praedicatio coincideva, in linea di principio, col territorio amministrativo dei comuni toscani. Così, per intenderci, uncandidato del territorio della repubblica lucchese (città econtado) era filius nativus del convento di Lucca, poco importase per motivi contingenti avesse preso l’abito in altro convento. Le Cronache conventuali registrano strettamente ifrati figli del convento, anche se deceduti altrove, e fanno intravedere non infrequentemente i contrasti connessiai raggiustamenti dei termini della praedicatio susseguenti alle alterne vicende delle conquiste territoriali nelle lotte comunali[5]. La provincia Romana dei frati Predicatoricomprendeva anche il territorio dei comuni toscani. Le lotte intracittadine e le lotte d’egemonia tra i comuni condizionavano in qualche modo anche la selezione del ceto direttivo religioso della provincia e dei conventi? Duranteil governo ghibellino in Firenze (1260-66) abbiamo una solatestimonianza certa del priore di SMN, fr. Giovanni da Viterbo. Dopo gli Ordinamenti di giustizia (gennaio 1293), con cui la borghesia urbana si assicurava più stretto
controllo del potere cittadino imponendo severissimi freni alle casate magnatizie, Firenze fu agitata da un’accentuataconflittualità politica, al punto che in luglio 1295 si dovette mitigare la legislazione antimagnatizia. Nel 1295 risulta priore fiorentino fr. Cinzio da Roma. In maggio 1300 esplosero le lotte tra le fazioni bianca e nera, che si consumarono in ogni genere di violenze, condanne, esili,espropri, da gennaio a ottobre 1302, dopo che in novembre dell’anno precedente i neri avevano sopraffatto la fazione avversa. In quegli anni priori fiorentini sono fr. Tolomeo da Lucca e fr. Iacopo da Siena. Il convento elegge un priore esterno quando le lotte tra fazioni e consorterie cittadine scuotono la città e rompono l’equilibrio delle forze al potere? Ne è rimasto in qualche modo coinvolto anche il convento? Nessun frate pisano risulta priore in SMN negli anni qui considerati. Le dissonanti solidarietà intrattenute dai due conventi domenicani in congiunture politiche d’ampia portata (parabola conclusiva dell’impero svevo in territorio italiano, politica degli Angioini in Toscana, campagna militare d’Enrico VII di Lussemburgo contro Firenze)[6] avranno dissuaso i frati di SMN dall’eleggere alla carica priorale un frate di Pisa, città a tradizione filo-imperiale e che sola riusciva a contendere alla repubblica fiorentina l’egemonia in Toscana?
Questi e simili quesiti si presentano a chi voglia studiare il rapporto convento-città. Ricerche sistematiche sulle famiglie dei frati e loro ruolo cittadino potranno aiutare non poco a definire il modo specifico e proprio in cui il convento vive all’interno e all’esterno i conflitti cittadini e stabilisce di volta in volta pubbliche solidarietà; e potranno aiutare a individuare occasioni in cui i conflitti vengono eventualmente assorbiti o risolti in mediazioni di pace[7]. Il priorato conventuale (ma anche altre cariche direttive come quelle dei definitori e dei lettori) potrebbe rivelarsi di notevole importanza per intendere la funzione pubblica del convento mendicante a matrice urbana. La documentazione attuale non permette di
sostenere meccaniche solidarietà conventuali formatesi e consumatesi sullo spartiacque delle lotte cittadine e dellapolitica comunale. Appella semmai a più sistematiche e affidabili testimonianze.
Restituiamo tuttavia al priorato dell'ordinamento costituzionale domenicano il suo retto significato: non personificazione del governo monocratico, significativo della sola persona o del casato che ne detiene il titolo; ma carica che attiva e coinvolge altri soggetti di governo e di participazione conventuale ad esso. Prior, né abate né re. Il priore, in altre parole, convoca il consiglio o il capitolo conventuale, secondo il caso; propone la materia di decisione alla comune discussione; la votazione (maggioranza richiesta due terzi) definisce il consenso comunitario e regola la fase esecutiva delle decisioni prese. I soggetti coinvolti legalmente nella transazione sono il "priore insieme con i suoi frati": «consensu suo etipsi fratres cum eo», si legge nella prima lista finora nota dei frati capitolari di SMN, con registrazione nominativa degli aventi diritto, 31.I.1245; frati capitolari co-attori del negozio, da non declassare a testi(came capita talvolta di leggere). Il priorato dunque raccoglia in sé il governo condiviso della comunità domenicana. Documentare nome e attività priorale significa abbozzare una storia reale della comunità conventuale; urbana, per natura; intrecciata dunque con le vicende quotidiane della città, dalle sue componenti sociali alle forme della sua pietas. In tempi - ricordiamolo - nei quali spazi di chiese e conventi erano anche pubblico cimitero!
3. Stefano Orlandi in Necr. II, 600 ss dà la serie dei priori di SMN. Gli studiosi vi fanno ricorso a vario titoloe interesse. Purtroppo, per il periodo qui preso in esame (1221-1325), la lista è tutt’altro che attendibile. L’Orlandi avverte sì che l’elenco è compilato sulla Cronica annalistica (1757-60) di Vincenzo Borghigiani (ASMN I.A.28 ss) e del Compendium necrologii (1783) di Luigi M. Cingia (ASMN I.A.37), ma poi sia nell’elenco priorale che nelle
notizie biografiche sui singoli frati dà sproporzionato credito ai due compilatori settecenteschi. Già le poche integrazioni originali dell’Orlandi erano sufficienti a mettere in guardia dall’affidabilità della lista; sufficienti se non altro a individuare i criteri (non dichiarati) con i quali la lista era stata compilata. Se sieccettua un uso sporadico degli atti dei capitoli provinciali (e delle pergamene conventuali?), del Liber novuse d’altre compilazioni conventuali, Borghigiani-Cingia attingono prevalentemente dalla Cronica; la quale, se attesta che questo o quel frate fu priore fiorentino, non dà l’anno del priorato. Gli estensori della lista, quando non dispongono di testimonianze esterne alla Cronica (ed è il caso più frequente), attribuiscono per congettura l’annodel priorato a partire dagli estremi d’entrata in religionee di morte del frate-priore. L’esito è troppo fragile per servire una qualsivoglia elaborazione storiografica.
Si ripropone qui l’elenco dei priori di SMN dal 1221 (anno d’entrata dei frati Predicatori nella primitiva chiesetta fiorentina) al 1325. Sono accolte solo le testimonianze coeve che non lascino dubbi su nome e data. Quest’ultima è posta in esponente e testimonia il tempo delpriorato. Va da sé che la successione degli esponenti in linea di principio né afferma la continuità della carica daun esponente all’altro (così, ad esempio, Giovanni da Viterbo priore nel 1263 non lo fu necessariamente fino al 1268, priorato di Gerardo d’Arcetri) né esclude altri priorati tra un esponente e l’altro. Criteri alquanto severi, ne convengo; ma tali da lasciare intatta la perentorietà delle testimonianze e permettere l’inserimentod’altri dati, frutto d’ulteriori spogli archivistici.
La severità dei criteri è mitigata, comunque, dall’interpretazione da dare a talune sequenze priorali. Ricordiamo che nella legislazione domenicana di questo periodo la durata dell’ufficio priorale (conventuale e provinciale) non è a termine. Il priore conventuale, elettodai frati capitolari e confermato dal priore provinciale, dura a tempo indeterminato. È il capitolo provinciale,
celebrato annualmente, a porre termine al priorato («Absolvimus priores..., He sunt absolutiones...»). La prassi sta ampiamente a favore d’una rotazione frequente delle cariche direttive. Salvo dunque casi eccezionali (decesso, promozione, deposizione ecc.), il priorato termina con il rilevamento dalla carica (absolutio) deciso dal capitolo provinciale; entro lo spazio di trenta giorni,come stabilivano le costituzioni II 2 De electione prioris conventualis, il capitolo conventuale procede all’elezione del nuovo priore[8]. Sfortunatamente gli atti dei capitoli provinciali a noi pervenuti (1243-1344) trasmettono le absolutiones solo a parire da anni tardivi, e anche qui non sistematicamente. I copisti che a distanza di anni trascrivono gli atti non si comportano come nella trasmissione di testi letterari; hanno sottomano un testo amministrativo e trascrivono (in parte) in funzione del vigore legale delle deliberazioni capitolari (cf. MOPH III,32/24-26: un quaderno conventuale registri annualmente gli atti dei capitoli; bisogna far spazio per i nuovi atti? si cancelli solo quanto revocato!). Le assoluzioni dei priori rientrano nella sezione legislativa a valore decaduto (e così le nomine e le assoluzioni dei lettori). I copisti semmai introducono la rubrica ma troncano l’elenco: «Absolvimus priores etc.»; «He sunt absolutiones etc.». Ma talvolta l’elenco viene trascritto, e presumibilmente per intero, specie là dove alla lista delle assoluzioni fa seguito la lista parallela della cura conventus, cioè dell’incarico interinale della responsabilità d’un conventofinché il capitolo conventuale non abbia proceduto all’elezione del nuovo priore.
■ Caso di testimonianze diplomatiche pervenuteci circaprocedura, forma elettiva prescelta, lettere di notifica d'elezione priorale e richiesta di conferma: P. GLORIEUX, Une élection priorale à Gand en 1309, AFP 7 (1937)246-67.Il nostro elenco dei priori fiorentini riporta dunque
sistematicamente le disposizioni capitolari sulle
assoluzioni dei priori quando possano aver incidenza sui termini della carica priorale; e riporta, a ridosso dei priorati, il tempo di celebrazione del capitolo provincialequando attestato (per consuetudine i capitoli provinciali sono celebrati in settembre, più raramente in luglio o agosto; subito dopo quello generale, settimana di Pentecoste, quando celebrato nella medesima città). Un priorato dura almeno un anno, da capitolo a capitolo provinciale. Talune concatenazioni permettono d’inferire con sufficiente certezza la durata di questo o quel priorato. Qualche esempio. Ugo degli Ubertini risulta priore in giugno 1286: lo era almeno dal mese successivo alcapitolo provinciale 1285 e lo sarà fino al capitolo 1286 convocato per il 29 settembre; priore ancora in febbraio 1288: lo era almeno dal mese successivo al capitolo provinciale 1287 e lo sarà almeno fino al capitolo provinciale 1288, celebrato in Lucca subito dopo quello generale nella medesima città; non lo era più almeno da settembre 1289 perché il capitolo provinciale di quell’annoassolve dalla carica il priore fiorentino. Cinzio da Roma, priore nel capitolo provinciale 1295, lo era almeno dal capitolo provinciale 1294 e lo sarà almeno fino a quello 1296. Tolomeo da Lucca risulta priore in agosto e settembre1301, e in giugno 1302. Poiché il capitolo provinciale 1301era stato convocato per il 14 settembre (Tolomeo vi comparepriore e lo era già prima del capitolo) e quello del 1302 era stato convocato per il 22 luglio, Tolomeo dev’essere stato priore fiorentino da poco dopo luglio 1300 (mese legale per l’elezione priorale dopo il capitolo convocato per il 22 luglio 1300) fino a luglio 1302. Dopo luglio 1302fu eletto priore fr. Iacopo da Siena, ché tale risulta il 5novembre 1302.
Di taluni priori fiorentini conosciamo il nome ma non iltempo del priorato; o comunque il tempo tradizionalmente assegnato non appare sufficientemente sicuro. Se ne dà la lista a fine elenco.
Nelle date annuali con doppia cifra separata da barra (es. 1253/4), la prima indica l’anno del documento, la
seconda del computo moderno. Le date in esponente sono sempre del computo moderno. Le citazioni dei fondi diplomatici danno la data come nella segnatura d’archivio, che non sempre corrisponde - o per errore di regestazione oper concorrenza di più negozi legali nella medesima pergamena - alla data effettiva della testimonianza.
[1] Giovanni Villani [† 1348], Nuova cronica, ed. critica G. Porta, Parma 1990-91, VII, 74-79. RICORDANO MALISPINI, Storia fiorentina c. 182 (ed. V. Follini, Firenze 1816, rist. Roma 1976, 138-39). Detentori = S. RAVEGGI, M. TARASSI, D. MEDICI, P. PARENTI, Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Dugento, Firenze 1978, c. 2 (I fuorusciti guelfi del 1260), 13 n. 1 e ss.[2] Relazioni parentali di fr. Pagano stabilite su ASF, SMN 13. IV.1287: «Cursus filius emancipatus Botti Guittonis populi Sancti Stephani de Ungnano... vendidit... fr. Pagano de ordine fratrum Predicatorum de conventu ecclesie Sancte Marie Novelle et filio condam d. Iacobi Nasi [non «di Nero»: Necr. I, 249 n. 10] de Adimaribus, executori testamenti d. Pagani filii condam d. Gherardi de Adimaribus et procuratori hospitalis Sancti Dominici de Fighino, recipienti... nomine dicti hospitalis». Fratelli di fr. Pagano sono Boccaccio, Mari (o Adimari) e Berlinghieri (o Benghi): «Adimari et Benghi fratres filios quondam d. Iacobi Nasi»(ASF, Acquisto Marchi 6.VIII.1241, di fatto 1261); «d. Boctaccius et d. Mari d. Iacobi Nasi de Adimaribus» (La pace 240 = I. LORI SANFILIPPO, La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280. La sentenza e gli atti complementari, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo» 89 (1980-81); «Adimarius et Berlingherius olim d. Iacobi Nasi» (Delizie XI, 226: anno 1267). L’omonimo zio di fr. Pagano, il proposto fiorentino Pagano di messer Gherardo degli Adimari, era morto il 7.IV.1265 (Arch. dell’Opera del Duomo di Firenze, Necrologio del cimitero della canonica f. 17r).[3] Lucca, Capitolo San Romano, giugno 1261: «Omnibus clareat evidenter quod fr. Aldibrandinus de Cavalcantibus prior fratrum Predicatorum lucani conventus videlicet Sancti Romani...» (ASL, Dipl, S. Romano giugno 1261). Medesimo luogo, 10.IX.1262: «Bullione et Albissellus... vendiderunt fr. Gerardo suppriori et vicario fr. Aldebrandini prioris fratrum Predicatorum conventus Sancti Romani de Luca» (ASL, Dipl. S. Romano 10.1X.1262). In
ambedue gli atti appare come teste «Rosso filio Fornarii de Florentia», cioè Rosso del Fornaio dei Rossi, membro d’un casato esule nel 1260 (Detentori 14 n. 2, 117-18 e ad indicem); il 10.VI.1266 Rosso è in Firenze, teste in atto del monastero domenicano S. Iacopo a Ripoli (ASF, NA 995 (già A 981), f. 44), e in Firenze è suo fratello Bagherello in gennaio 1267 (ib., f. 47r:19.1.1266/7). Capitolo di S. Romano in Lucca, 6.VIII.1261: testamento di messer Tegghiaio d’Aldobrando degli Adimari, che nomina tra i tutori di suo figlio «fratres Ildebrandinum de Cavalcantibus et Paganum de Adimariis de ordine fratrum Predicatorum», incaricati anche della restituzione delle usure. Fr. Aldobrandino, con altri frati domenicani del convento lucchese, è presente all’atto; non è attestata invece la presenza di fr. Pagano degli Adimari (ASF, Acquisto Marchi sotto la data 6.VIII.1241). Probabilmente è da questo documento che R. Davidsohn(Forschungen zur Geschichte von Florenz IV, Berlino 1908, 169, 370-71), presumendo la presenza in Lucca di fr. Pagano, ha parlatodel suo esilio. Palese invece risulta la solidarietà tra consorterie fiorentine esuli in Lucca. Per il priorato provinciale(1262-68) di fr. Aldobrandino: ASL, Dipl. S. Romano 1262; AFP 4 (1934) 132. Come vescovo d’Orvieto corrobora col proprio sigillo vescovile una donazione del convento urbevetano a favore di quellolucchese (ASL, Dipl. S. Romano 15.VII.1276).[4] G. LEVI, Bonifacio VIII e le sue relazioni col comune di Firenze, Roma 1882, 90-92 (primo intervento papale, 24.IV.1300), 95-88 (15.V.1300); a pag. 97 per gli attributi riservati a Lapo dei Salterelli. Vedi anche DAVIDSOHN IV, 138-44, 160, 167-68, 185-86; A. D’ADDARIO, Lapo Saltarelli, «Enciclopedia dantesca» IV (1973) 1084-86. Relazioni parentali: «Ego Lapus Guidonis Salterelli de Monte Crucis» (ASF, Arte dei giudici e notai 5, f. 22r). «Fr. Symon Guidonis de Salterellis» (Cr SMN n° 320). Un terzo fratello è Cerbino detto Bino: «Cerbinus qui Binus dicitur filius Guidi Saltetelli» (ASF, NA 995 (già A 981), f. 31v: 11.VIII.1264). Figlidi Bino sono Andrea († 1333) e Michele († 1373), sepolti in SMN (Libro dei morti: MD 1980, 105, 175). Priorato fiorentino di fr. Simone vedi sotto esponente 2.II.1300. Tra i fiorentini che presso la curia papale tramarono contro Firenze c’era Noffo di Quintavalle (LEVI, op. cit. pp. 90, 95); unfiglio di Noffo, fr. Gherardo, era frate di SMN, ricevuto nell’ordine in Grecia, dove anche morì nel 1311 (Cr SMN n° 201).
[5] Per lo statuto legale deIIa praedicatio in quanto territorio deIIa giurisdizione deI convento cf. M.-H. VICAIRE, Dominique et ses Prêcheurs, Fribourg 1977, 124-26. Ma testimonianze diplomatiche fanno toccare con mano i casi concreti, e fanno altresì intravedere l'instabilità dei confini deIIa praedicatio làdove il convento copre territori contesi tra unità politiche rivali. I definitori del CP Perugia 1262 determinano i confini deIla praedicatio tra i conventi di Lucca e Pistoia in VaI di Lima(montagna pistoiese) e assegnano al convento lucchese il territorio del piviere di Controne e deIIe parrocchie di Benabbio,LugIiano e Corsena fin verso il ponte a Chifenti, là dove la Lima confluisce neI Serchio, e al convento pistoiese il territorio finoal piviere di Controne escluso (ASL, Dipl. S. Romano 1262). I definitori deI CP Gaeta 1286 definiscono la predicazione tra i medesimi conventi; per compensare i territori (non menzionati) passati al convento di Pistoia assegnano a quello lucchese la pieve di Santa Maria a Monte, e le parrocchie di Montecalvoli e Pozzi, a destra del Valdarno inferiore là dove la diocesi luccheseconfina con quella pisana; ma si precisa: «quamdiu et quotiens dicta castra vel terre fuerint sub dominio lucanorum; et quando dicte terre fuerint sub dominio pisanorum, durante dominio, sint de predicatione pisana», cioè del convento domenicano di Pisa (ASL, Dipl. S. Romano 5.X.1286). Per incarico del CP Siena 1306 due frati ritoccano la predicazione di Lucca e Pistoia (proprio inquegli anni definitivamente conquistata da Firenze) in VaI di Nievole; assegnano a Lucca il territorio che si estende fino all'ospedale San Marco, «quod est prope burgum Montis Catini», e ai frati pistoiesi le terre di Maona, Montecatini, Monsummano e Montevettolini, «ut antiquitus soliti erant habere» (ASL, Dipl. S.Romano 7.IV.1307). La predicazione di Lucca (provincia Romana) eragià venuta in controversia con i conventi di Genova e Parma (provincia di Lombardia) per la ripartizione dei territori della diocesi di Luni; il CG Strasburgo 1260 definisce i termini della predicazione dei tre conventi (ASL, Dipl. S. Romano 1260). «FraterHermannus de Sancto Miniate. Illud enim municipium fuit de predicationis terminis nostri conventus, et ideo illi ad nostrum conventum omnes originaliter pertinebant. Hic | 6r | vir bonitatis magne et sensatus homo et dulcis pater fuit supprior in conventu pisano, ubi cum magna devotione migravit» (Cr Ps n 12).[6] Cr Ps n 137: «Unde illustrissimus rex Robertus [d’Angiò], contra Pisanos odio et furore turbolentus...». Corradino di Sveviaera stato ricevuto in convento (ib. n 39). Per il rapporto del convento con Enrico VII nel 1313: ib. p. 491. Fr. Oddone da Sala
OP, vescovo pisano, benedice il carroccio per l’esercito che infliggerà una gravissima sconfitta alla lega fiorentino-angioina in Montecatini 29.VIII.1315 (ib. p. 491). I sentimenti filo-angioini del convento fiorentino (in sintonia con la politica di Firenze) sono ampiamente documentati nei sermoni di fr. Remigio dei Girolami (cf. E. PANELLA, Per lo studio..., MD 1979, 213, 227,231; Note di biografia domenicana tra XIII e XIV secolo, in AFP 1984, 276-77). Quando in gennaio 1313 Enrico VII, che aveva posto in Pisa il suo quartier generale, assediava Siena (alleata con Firenze), le autorità del comune fiorentino dovettero rassicurare gli amici senesi della fedeltà alla causa senese-fiorentina di fr.Remigio. Ma la situazione è ancora più intrigante: al cardinale Niccolò da Prato OP (a suo tempo provinciale Romano), che in qualità di legato papale in appoggio a Enrico VII incorona Enrico imperatore a Roma in giugno 1312, il cronista del convento perugino associa con entusiasmo fr. Annibaldo dei Guidalotti da Perugia, che cantò il vangelo della messa d’incoronazione (Cr Pg f. 59v). Fr. Bernardino da Montepulciano, del convento d’Orvieto, «meruit commorari cum serenissimo principe et domino domino Henricho imperatore nonagesimo sexto, sub annis Domini M°CCC°XIII°, suus carus cappellanus existens et conffexor» (Cr Ov 69, ed. 101).[7] Tornaquinci e Girolami nel 1304 si azzuffarono in Mercato Vecchio; nel 1306-07 giurarono atto di pace. In SMN convivevano fr. Giovanni di messer Ruggeri dei Tornaquinci, priore nel 1306-07, e fr. Remigio del Chiaro dei Girolami (Dal bene comune..., MD 1985, 54-56). Entrambi i frati compaiono nella transazione in ASF,SMN 29.VII.1307.[8] Constitutiones antiquae [1241] II, 2: «Priores conventuales a suis conventibus secundum formam canonicam eligantur, et a priore provinciali, si ei visum fuerit, confirmentur, sine cuius licentiade alio conventu eligendi non habeant potestatem. Si vero infra mensem non elegerint, prior provincialis conventui provideat de priore» (ed. R. Creytens in AFP 1948, 49). Cf. Constitutiones antiquae [1216-36] II, 24 (ed. A.H. Thomas, Lovanio 1965, 359). Dal 1269-71 per il diritto al voto attivo nell'elezione si esigonoquattro anni dall'emissione della professione (AFP 1948, 49 n. 15).
4. A margine dei priorati di Santa Maria Novella, ma ad essi in qualche modo connesse, cadono talune vicende letterarie di grande interesse e che dai priorati fiorentini potrebbero essere illustrate e precisate in più punti.
Il browser in uso non supporta frame non ancorati oppureè configurato in modo che i frame non ancorati non siano visualizzati. Nel 1966 Ruth J. Dean, studiosa del domenicano inglese Nicola Trevet (ancora in vita nel 1334),faceva conoscere la lettera con cui Nicola presentava al suo amico Paolo, che in Pisa l’aveva esortato a intraprendere l’opera, il commento alla Philosophiae consolatiodi Boezio. Dopo la Consolatio, Nicola commenterà le tragedie di Seneca (1315 ca.) e gli Ab Urbe condita di Livio (1316-19)immettendosi con autorevolezza nel movimento culturale di nuove curiosità per testi classici che fermenterà nel ventennio 1320-1340 «gonfio di vicende retoriche tra le piùforti che mai si siano svolte nella penisola italiana» (BILLANOVICH, Dal Livio di Raterio 134).
R.J. DEAN, The Dedication of Nicholas Trevet’s Commentary on Boethius, «Studies in Philology» 63 (1966) 593-603.G. BILLANOVICH, Dal Livio di Raterio (Laur. 63,19) al Livio del Petrarca (B. M., Harl. 2493), «Italia medioevale e umanistica» 2 (1959) 134; su Nicola Trevet pp. 154-58. ID., Tra Dantee Petrarca, ib. 8 (1965) 1-44, specie pp. 10-11.36-38.SOPMÆ III, 187-196; IV, 213-215. LORD, Virgil's Eclogues. G. BRUNETTI. DHN 20 (2011) p. 246 n° 1519.
Nicola cita il proprio commento alla Philosophiae consolationel quodlibeto disputato in Oxford nel 1304 (F. EHRLE, Gesammelte Aufsätze zur englischen Scholastik, Roma 1970, 334-35 n.6). L’incontro con l’amico Paolo ebbe luogo in Pisa, come attesta la lettera. Nicola era certamente in Oxford nel 1303, e molto probabilmente anche negli anni 1300-02. Cosicché l’incontro pisano con Paolo andrebbe collocato anteriormente al 1300, mentre la precedente residenza oxoniense di Nicola è testimoniata per l’anno 1297.
La lettera, conservata in un solo manoscritto, l’Ambrosiano A 58 inf., presenta brani alquanto oscuri. La difficoltà d’intendere appieno il testo è da addebitare in parte allo stesso autore, quando vien meno nel sostenere ilpiacere del complesso periodo ipotattico con la perspicuitàdei raccordi sintattici, in parte alla tradizione manoscritta che, oltre a due lacune, tradisce lezioni corrotte, certamente molto sospette[1].
Anzitutto chi è Paolo? La Dean raccoglie convincenti indicazioni a favore d’un frate domenicano ma lascia sospeso il problema dell’identificazione. Il secolare Paoloda Perugia, propone Giuseppe Billanovich[2].
Solo il Kaeppeli, a quanto mi risulti, nella recensione delle opere di Nicola Trevet (SOPMÆ III, 191 n° 3143) suggerisce il nome di fr. Paolo dei Pilastri da Firenze OP.Il suggerimento merita d’esser raccolto e la proposta d’identificazione può produrre congruenze topiche e croniche di notevole peso. Lettera e prologo del commentario si completano: raccordano i vota quorundam fratrum che sollecitano il commentario con l'autore ex ordinis Predicatorum professione. Paolo di Gualduccio dei Pilastri, frate del convento fiorentino dal 1271, più volte sottopriore e priore, familiare del cardinale Niccolò da Prato dopo il trasferimento della curia papale ad Avignone,patriarca di Grado nel 1314, muore nello stesso anno quindici giorni dopo l’intronizzazione. Ora fr. Paolo dei Pilastri risulta priore di Santa Caterina di Pisa in settembre 1297[3], e verosimilmente lo è stato fino al capitolo provinciale (cui competeva l’absolutio dei priori) del 1298, convocato per il 14 settembre; non molto dopo il capitolo del 1298, Paolo viene eletto priore di SMN, e in tale carica rimane fino a settembre 1299. La visita di Nicola Trevet a Pisa trova eccellente congruenza tra cronologia del domenicano inglese stabilita dalla Dean e presenza di Paolo dei Pilastri in Pisa negli anni 1297 e 1298.
«Visita» del Trevet a Pisa, e poi a Firenze, non «composizione» del commento alla Philosophiae consolatio. La Dean infatti interpreta il brano centrale - quello di natura informativa - della lettera di Nicola nel senso che costui, lasciata Pisa per Firenze, abbia composto il commento boeziano nella stessa Firenze[4], presumibilmente nel convento domenicano di SMN[5].
In verità la lettera non offre né esplicite informazioni circa il luogo dove Nicola - nel corso delleotto settimane dalla domenica delle Palme a quella della Pentecoste - abbia composto il commento, né indizi per inferirne la composizione in suolo italiano. Indizi semmai sono a favore dell’ipotesi che composizione dell’opera e invio d’un esemplare all’amico Paolo abbianoavuto luogo altrove, lontano da Pisa e da Firenze. Rileggiamo il brano centrale della lettera.
Epistola fratris magistri Nicolai comentatoris ad Paulum- brano centrale -
ed. DEAN, The Dedication 601-02 ed. BILLANOVICH, La tradizione 36-37
Recordor itaque hactenus cum personaliter a tua amicitia (MS. amititia) Pisis diuerti Florentiam in capite scalarum te exemplariter uerbis Ouidii me allocutum fuisse: Demof[o]on, uentis [et] uela et uerba dedisti, Vela queror reditu, Verba carere fide. Hexitans ut comento siue lucido scripto superBoetio de Consolatione Phylosophie meo studio atque labore fultis iuxta (MS. iusta) promissionem a me pollicitam utique fores non quidem mee sponsioni modicam exibere fidem. Sed quia nimia uoluntate tam excellenti opere etiam [blank forseveral ketters] dignissime occupatus me iuxta posse sed non
Recordor itaque hactenus cum personaliter a tua amicitia (amititia, ms.) Pisis diverti Florentiam, in capite scalarum teexemplariter verbis Ovidii me allocutum fuisse: «Demofon, ventis vela et verba dedisti, Vela queror reditu, verba carere fide»; hexitans, ut comento sive lucido scripto super Boetio de Consolatione phylosophie meo studio atque labore fultus iusta promissionem a me pollicitam utique fores, non quidem mee sponsioni modicam exibere fidem. Sed quia nimia voluntate tam excellenti opere etiam . . . . . dignissime occupatus, me iuxta posse sed non firmiter pollicente, ambigue dubitabas.
firmiter pollicente ambigue dubitabas.
Verum [blank for several ketters]mea quam plurimum mensium temporis reditu caruerunt. Ductore autem deo extemplo (MS. -tim-) ad tuam expectantem residentiam applicabunt nequaquamte si delintea sequentia, que presto labili conuersione usque in hodierna tempora defecerunt. Verba autem mea a fecunda fide nullatenus virimerunt quemadmodumDemofontis profecto cessarunt. Demum autem imbutione temporis adueniente mea fides legalitate plena est, quoniam opus a te diu quesitum et procul dubio optitatum non sine maximo labore et frequenti solertia ad metam perduxi.
Verum <verba> mea quam plurimum mensium temporis reditu caruerunt. Ductore autem Deo extimplo ad tuam expectantem residentiam applicabunt; nequaquam te si de lintea sequentia que presto labili conversione usque in hodierna tempora defecerunt (sic). Verba autem mea a fecunda fide nullatenus diremerunt (dirimerunt, ms.), quemadmodum Demofontis profecto cessarunt. Demum autem, imbutione temporis adveniente, mea fides legalitate plena est, quoniam opus a te diu quesitum et proculdubio optitatumnon sine maximo labore et frequenti solertia ad metam perduxi.
latino disastrato, presuntuoso volgarizzamento (2009) di EP
Mi ricordo ancor oggi, quando mi separai da te, amico mio, a Pisa in partenza per Firenze (1297-98 ca.). In cima alle scale mi salutasti in metafora con versi d'Ovidio: «Al vento hai spiegato vele e parole, Demofonte; delle vele lamento il mancatoritorno, delle parole la mancata fede». Tu dubitavi di poter farconto d'un mio commentario o chiara esposizione della Consolazionedella filosofia di Boezio, benché io te l'avessi promesso. (...). Le mie vele in verità per mesi e mesi non hanno fatto ritorno; ma ora con la guida di Dio, approderanno presto a casa tua! (...). Le mie parole non hanno dirottato dalla promessa fatta, come invece vennero meno quelle di Demofonte. Finalmente, a tempo finito, le mia promessa si riveste di legalità! Ecco, il lavoro che hai a lungo richiesto e sinceramente desiderato, l'hoportato a temine. Non senza grossa fatica e intensa alacrità.
«Al vento hai spiegato vele e parole, Demofonte; delle vele lamento il mancato ritorno, delle parole la mancata
fede». La citazione ovidiana di Paolo (Heroides II, 25-26: «Demophoon, ventis et verba et vela dedisti: | Vela queror reditu, verba carere fide», nell'ed. G. Rosati, Milano 1989; distico diffuso dal manuale medievale Graecismus XV, 4-5, ed. J. Wrobel, Breslau 1887, 151) si è impressa nella mente di Nicola. Nell’inviare all’amico il commento finalmente portato a termine, Nicola riprende le parole d’Ovidio e assicura Paolo - il quale aveva dubitato dell’adempimento della promessa - che l’opera da tempo richiesta e desiderata è ora pronta. «Verba-reditu», «Verba-fide»: la coppia ovidiana si prolunga in istanza metaforica nella lettera di Nicola. Le mie parole non son venute meno alla promessa («Verba autem mea a fecunda fide...»: 602, 8-9). La mia nave, certo, da molti mesi non ha fatto ritorno; ma ora ecco che il mio dono approda versodi te. La coerenza della metafora, stabilita sul binomio ovidiano uerba-uela, suggerisce un non inverosimile restaurodel primo membro della metafora coincidente con la seconda lacuna testuale:
«Verum<tamen uela> mea quam plurimum mensium temporis reditu caruerunt» (602,3-4), corroborato dal susseguente verbo «applicabunt» (602, 6)
cioè «approderanno»; oppure:«Verum <quamuis uela> mea... reditu caruerunt, ductore autem Deo...» (602, 35)[6].
Non soltanto il testo non presenta tracce per concluderealla composizione dell’opera in Firenze, ma - benché oscuroin taluni brani - invita a ritenere che il commento alla Philosophiae consolatio sia stato composto lontano da Paolo, làdonde ora vengono spedite lettera e copia del commento; attesta inoltre a più riprese che tra richiesta di Paolo e invio dell’opera è trascorso un imprecisato ma considerevole lasso di tempo: «quam plurimum mensium temporis» (602, 4), «opus a te diu quesitum» (602, 10-11), «pabulum... diu quesitum» (602, 37-38); tempo distinto e più ampio delle otto settimane di lavoro impiegate alla composizione del commento - di cui Nicola dà separata
notizia[7] (602, 21-25) -, a sua volta distinto dall’ulteriore tempo occorso per trascrivere di proprio pugno due copie dell’opera appena portata a termine, la seconda destinata a Paolo[8] (602, 25-28). Anziché scusarsi del ritardo, Nicola avrebbe potuto vantare tempestività d’esecuzione se le espressioni «quam plurimum mensium temporis» e «diu quesitum» indicassero unicamente i tempi necessari alla composizione e copia dell’opera in Firenze subito dopo l’incontro pisano. Dopo il priorato pisano (1297-98), fr. Paolo dei Pilastri rientra a Firenze, dov’è priore di SMN da fine estate 1298 a settembre 1299; in Firenze risulta ancora presente nel 1300 e 1304[9]. Nicola Trevet, come sappiamo, cita il proprio commento alla Philosophiae consolatio nel quodlibeto del 1304; aveva promessol’opera a fr. Paolo durante l’incontro pisano, gliela inviadopo che era trascorso un considerevole lasso di tempo. Nonda Firenze, dove fr. Paolo risiede non appena terminato il priorato pisano e da dove sarebbe risultata incongrua la persistente metafora della navigazione per un dispaccio destinato a Pisa. Dall’Inghilterra, dobbiamo concludere, dopo il rientro in patria; qui la presenza di Nicola è attestata almeno a partire dal 1300.
[1] Edizione del testo in DEAN, The Dedication 600-03, con riproduzione fotografica del documento; anche in G. BILLANOVICH, La tradizione del testo di Livio..., I/1, Padova 1981, 35-38. Citerò il testo indicando pagina e rigo dell’edizione DEAN.[2] La tradizione del testo di Livio..., I/1, Padova 1981, 38-40. Presa visione di questo mio contributo, il Billanovich accede allanuova identificazione, con qualche riserva: G. BILLANOVICH, Il testo di Livio. Da Roma a Padova, a Avignone, a Oxford, «Italia medioevale e umanistica» 32 (1989) 88-93, tutto l'art. pp. 53-99; esemplare inviatomi gentilmente dall'A., sett. 1991.[3] Cr SMN n° 213: «Frater Paulus filius olim Gualducii de Pilastris, sacerdos et bonus predicator. Fuit vite solide et religionis çelator, et amicis affabilis. Fuit supprior in conventuflorentino in adolescentia sua, et magister novitiorum longo tempore. Fuit prior in conventu florentino et pluries ibidem supprior, et prior in conventu pisano et aretino, eugubino et
pratensi; et aliquando fuit provincialis capituli diffinitor, et vicarius totius provincie per capitulum generale in Romana provincia. Fuit dudum in aula venerabilis patris domini Nicolai, ostiensis episcopi, in familiarem et capellanum. Tandem sublimatus[28.III.1314] ad cathedram patriarchatus gradensis ecclesie et inthroniçatus ibidem, vixit post hec diebus xv vel circa. Vixit inordine annis xliiijor et menses aliquos». Necr. I, 268-70; HC I, 296. Cr Ps ed. p. 485 n. 151; il documento, del 16.IX.1298, è in stile pisano. Nessun altro Paolo, né del convento pisano né degli ACP, può concorrere con fr. Paolo dei Pilastri al titolo di destinatario della lettera di Nicola Trevet.[4] «Now we find that he had a friend named Paul, who may indeed have been a brother Dominican, and the content of the letter showsthat the commentary was written for him and under bis urging, and that it was done during a protracted stay in Italy» (DEAN, The Dedication 594); «but it is not clear whether he is presenting thework in person or sending it to Paul, so we do not know in what city either man was at the time of the presentation, nor indeed precisely when this took place» (p. 596); Trevet «made a stay of several months in Pisa and Florence before 1304; he wrote his Boethius commentary in Florence, working from a borrowed text of the Consolation; he had been in Florence for a time before he wrote it and in Pisa before that» (p. 600).[5] Ch.T. DAVIS, Dante’s Italy and other Essays, Philadelphia 1984, 267: «Not only did Trevet visit Tuscany and Florence, but hededicated his commentary on Boethius to an old teacher and friend in Pisa. The commentary itself was written in Florence (and probably at S. Maria Novella) between Palm Sunday and Pentecost, before 1304 and possibly before 1300. Trevet borrowed a copy of the De consolatione from outside the convento. It is curious that around 1300 Florence was a center of interest in classical studies(though not in philology), even though she was unusually poor in classical texts, and that it was wandering Dominicans like Trevet as well as resident notaries like Brunetto who helped to make her learning less provincial»; e in nota 39: «As for the De consolatione, Trevet's statement that he had to borrow a copy outside the convent is confirmation of Dante's assertion of its rarity (in Conv. 2.12.2 Dante called it a book "not known by many")». Trevet dice più esattamente che non aveva potuto portare a terminela promessa «nisi prius exemplar prestanti mea manu comentum unum exemplarer et scriberem. Sicque omni pretio cessante multisque
precibus rogantibus quasi gratis, postquam sibi prefatum librum scripsi, petitum exemplar optinui» (602, 18-21). La Philosophiae consolatio, come altre opere di Boezio, è citatissima da un fr. Remigio dei Girolami; ne cita anche i fortunati commentati che ne accompagnavano il testo; una sola segnalazione, De modis rerum l, 9 (Bibl. Naz. di Firenze, Conv. soppr. C 4.940, ff. 24vb-25ra); l'«expositor super III De consolatione» è Guglielmo da Conches: cf. Ch. JOURDAIN, Des commentaires inédits de Guillaume de Concheset de Nicolas Triveth sur la Consolation de la philosophie de Boèce, in «Noticeset extraits des manuscrits de la Bibliothèque lmpériale» 21 (1862) 75.[6] «tetigit Graias Amiclas - nomen civitatis in Grecia est, ubi applicuit Paris quando rapuit Helenam...; pinusque sacra, id est sacrata... Pinus enim, de qua fiebant naves Paridis quando transfretavit in Greciam»: NICOLA TREVET, Commento alle "Troades" di Seneca, a c. di M. Palma, Roma 1977, 10. Non è Nicola che tornadi persona al suo amico Paolo; vi ritorna col suo affetto e fedeltà d'amicizia testimoniati nel dono dell'opera promessa: «peristum mei presens cyrographum memorialiter reueho ut, quandocumqueleges supradicta, mei amicitiam contempleris. Isto namque modo, quamquam corporeis oculis sistam absens, mentalibus quidem tuo amicabili intuitu ubique exercitante amore prospiciar et uidebor, dignisque orationibus tuis per rectas spes precesque Altissimo intime recomendatus existam» (602, 30-36). La Cronica del conventofiorentino conferma felicemente l'indole amicale di fr. Paolo dei Pilastri: «amicis affabilis» (Cr SMN n° 213).[7] «Itaque iactatis a tergo omnibus aliis meis uicibus, incipiensa sancto die dominico Oliuarum usque ad Sacrum Pasca ac Floridum Pentecostes quasi per continuas dietas scribens, quibus insudans, noctis crepusculum vesperum et conticinium quoque addens, trecentarum consumaui scripturam cartarum» (602, 21-25).[8] «Ex quibus [sciI. cartis], uix interpolato labore, uolumina - ut predixi elicui quippe duo: unum uidelicet [ei] qui michi comodauit exemplar, aliud autem tue prorsus morigerate nec non gratuite iuuentuti» (602, 25-28).[9] Firenze 7.II.1300 (v. sotto lista dei priori alla data); tra ifrati capitolari di SMN del 20.XI.1304 «fr. Paulus Pilastri » (ASF, SMN 11.XI.1304, giunta del 20.XI.1304) e del 23.XI.1304 «fr.Pauli Pilastri» (ASF, NA 3141 (già B 2127), ff. 3v-4r). Per altri periodi segnalo soltanto notizie non raccolte in Necr. I, 268-70. Il 30.IV.1282 è teste, «fr. Paulo de Pilastris», nell’atto capitolare del monastero domenicano San Iacopo a Ripoli
che s’impegna a rilasciare dichiarazione di quietanza a Soldo di Pilastro e suo figlio Geri, tutori di Vanna del fu Gherardo di Pilastro futura monaca del monastero, quando questa avrà compiuto dodici anni di età (ASF, CRS, S. Iacopo a Ripoli 1 n° 40: regestato erroneamente 30.IV.1286). Priore del convento di Gubbio nel 1289 (AFP 1963, 247). ASF, Dipl. Cestello 18.II.1286; 3.IV.1291 (e in questo fondo diplomatico molte altre notizie sui Pilastri, patroni della chiesa S. Miniato tra le Torri). In Avignone 30.VI.1309, presente, col card. Niccolò da Prato, al testamento del card. Giovanni Boccamazza (PARAVICINI, I testamenti353-82), e in Viterbo 28.XI.1312 (AFP 1963, 256). Famiglia ghibellina del sesto S. Pancrazio, i Pilastri ebbero molti membri confinati nel 1268 dai guelfi vincitori (ASF, Capitani di parte guelfa, numeri rossi 20, Libro del chiodo pp. 129, 130).
5. Se fr. Tolomeo da Lucca è il continuatore del De regno
di Tommaso d’Aquino[1] - e le ragioni che militano a favore sono di grande peso[2] -, la continuazione dell’operatomasiana fu composta (o almeno portata a termine) nel convento fiorentino di SMN. Riprendendo un testo della Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii c. 13, Tolomeo nelDe regno III, 19, dice che da quando fu stabilita l’elezionedegl’imperatori del Sacro Romano Impero erano trascorsi circa 270 anni. Secondo Tolomeo, Determinatio c. 13, il sistema elettivo fu introdotto nell’anno 1030 per volontà di papa Gregorio V. L’anacronismo (Gregorio V fu papa dal 996 al 999) non intacca l’indicazione cronologica: che cioèTolomeo scriveva intorno all’anno 1300 (1030 + 270).
De regno III, 19: «Et ex tunc [tempo di Ottone I], ut historiae tradunt, per Gregorium v genere similiter Teutonicum provisa est electio, ut videlicet per septem principes Alamaniae fiat, quae usque ad ista tempora perseverat, quod est spatium ducentorum septuaginta annorum vel circa; et tantum durabit, quantum Romana Ecclesia, quae supremum gradum in principatu tenet, Christi fidelibus expediens judicaverit» (Opuscula omnia I, 420). Determinatio c. 13: «Tertia autem causa fuit
voluntas summi pontificis, qui tunc erat, videlicet Gregorii quinti, qui de Theutonia fuit natus et consanguineus Ottonis, ut infra dicetur. Possent et aliecause assignari, sed dicte sufficiant. Ista ergo electiousque modo perseverat, que incepit anno Domini MXXX, et perseverabit quantum ecclesia Romana permiserit, cuius est regna transferre et principes de sede sua deponere»(ed. M. Krammer, Hannoverae-Lipsiae 1909, 30-31)[3].
Lo stesso Tolomeo usa altre due volte simili indicazionicronologiche (il che rafforza l’attendibilità dell’annotazione): scriveva la Determinatio quand’erano trascorsi 250 anni dall’introduzione del sistema elettivo degli imperatori[4]; e iniziava a scrivere gli Annales quandoerano trascorsi circa 240 anni dal 1063[5]. Tolomeo è prioredi SMN da poco dopo luglio 1300 a luglio 1302. Sebbene l’indicazione dell’anno 1300 in cui Tolomeo attendeva alla continuazione del De regno sia formulata con qualche margined’oscillazione («vel circa»), i due anni di residenza fiorentina sono sufficientemente lunghi per coprire i tempidi composizione di un’opera di notevole ampiezza e di natura abbondantemente documentaria; almeno in parte, qualora si volesse rimettere alla precedente residenza lucchese l’avvio del lavoro[6].
Intorno al 1300 fr. Riccoldo da Monte di Croce, sempre in SMN, raccoglie la lunga esperienza tra musulmani e cristiani d’oriente in opere di straordinaria importanza, Liber peregrinationis, Contra
legem Sarracenorum e Libellus ad nationes orientales[7]. Fr. Remigio dei Girolami rientrato a Firenze dopo il baccellierato parigino, probabilmente a fine anno scolastico 1300, è pastoralmente e teologicamente impegnato in mediazione di pace tra parti bianca e nera che alimentano violente lotte cittadine. Non molto dopo la settimana di devastazioni susseguite al 5 novembre 1301 compone il De bono comuni. Convive nel convento fiorentino con Tolomeo da Lucca (insieme prendono parte al capitolo generale di Colonia in
maggio 1301), e con lui condivide spiccata simpatia per le formazioni politiche comunali. Ma nell’atto di elaborare progetti di teoria politica, il percorso intellettuale dei due si divarica (ma si era già divaricato in scritti precedenti) in molti punti, anche qualificanti. Eppure mentre in SMN compongono, l’uno il De bono comuni e l’altro la continuazione del De regno, s’incontrano in scritture, documentazione, utilizzazione dei modelli dell’amor patriae della romanità classica dalle sorprendenti coincidenze. Dante Alighieri fa diretta esperienza politica col governo bianco (è priore cittadino nel bimestre giugno-agosto 1300), ma il rovescio politico a favore dei neri lo costringe all’esilio dall’autunno 1301; sia nel Convivio chenella Monarchia (qui, il terzo libro agli antipodi di fr. Tolomeo) svolgerà taluni temi e s’imbatterà in taluni testiche rievocano insistentemente alla memoria dello storico leopere dei due frati domenicani[8].
Dal 1303, e forse dall’autunno dell’anno precedente, il medesimo convento ospita fr. Giordano da Pisa lettore e predicatore; i suoi ammiratori ne raccolgono la predicazione fiorentina assicurandoci un monumento della letteratura volgare trecentesca[9]. Nei medesimi anni e nel medesimo convento un altro eminente frate pisano, fr. Bartolomeo da San Concordio (figlio del convento pisano), apre un altro orizzonte letterario, quello della divulgazione: a messer Geri degli Spini dedica il Libro degli ammaestramenti degli antichi e a Neri di Cambio il volgarizzamento dei sallustiani De coniuratione Catilinae e Bellum Iugurthinum[10].
Una straordinaria fioritura di talenti e una felice congiuntura storica convergono nel convento fiorentino a inizio Trecento. La città è scossa da profonde conflittualità politiche, lacerata da feroci lotte di parte. L’attività apostolica e letteraria dei frati non ne è raffrenata, in gran parte anzi ne è alimentata, specie quando pubblica predicazione e scritti politici mirano a proporre nuovi modelli e nuove ragioni del bene comune; e del bene del comune. Felice congiuntura, si diceva. Ma non
del tutto casuale. La ricostruzione del funzionamento dellepubbliche istituzioni dell’ordine e l’individuazione dei processi formativi del ceto direttivo - nel governo così come nell’organizzazione della vita intellettuale - rendonomeno sorprendenti tali felici congiunture; certamente meno casuali.
[1] Tommaso lascia incompiuto il De regno a II, 8 «Opportunum est autem in conuersatione humana modicum delectationis quasi pro condimento habere, ut animi hominum recreentur» (Opera omnia t. 42,ed. Leonina, Roma 1979, 471), corrispondente a metà circa di II, 4delle edizioni volgate (Opera omnia t. 16, Parma 1865, 240b; Opuscula omnia I, ed. P. Mandonnet, Parigi 1927, 353).[2] Trattazione e bibliografia più aggiornata in DAVIS, Dante's Italy, op. cit. c. 9 (Roman Patriotism and Republican Propaganda: Ptolemy of Lucca and Pope Nicolas III), 224-53; c. 10 (Ptolemy of Lucca and the Roman Republic), 254-89.[3] Altra indicazione cronologica del De regno è in III, 20: «Quantum autem ad ista duo exemplum habemus etiam modernis temporibus quod electi sunt imperatores, videlicet Rodolphus simplex comes de Ausburg, quo mortuo assumptus est in imperatorem comes Adolphus de Anaxone, quo occiso [1298] ab Alberto Rodolphi filio, eodem modo assumptus est» (Opuscula omnia I, 422). Alberto Id'Asburgo, imperatore dal 1298 al 1308; a lui si arresta la lista.Se Tolomeo avesse scritto al tempo del successore Enrico VII di Lussemburgo (1308-13), non avrebbe mancato di farne menzione, perché Enrico, dal tempo di Federico II, gli offriva il primo casod'incoronazione susseguita all'elezione, condizione fondamentale per Tolomeo perché l'imperatore potesse esercitare la giurisdizione imperiale fuori i confini della Germania in qualità di «verus minister ecclesie» (cf. Determinatio c. 30, p. 60).[4] Determinatio c. 30: «De facto autem et consuetudine invenimus imperatores a CCL annis citra coronatos, antequam imperii prosequantur offitium» (p. 61). DAVIS, Dante's Italy 232-37, propone d'anticipare al 1277-78 la composizione della Determinatio, nonostante (ib. p. 233 n. 31) l'anno 1280 indicato da Tolomeo, sulla base di «dominus noster» riferito a Carlo I d'Angiò (Determinatio c. 18, p. 39), da intendere in riferimento al titolo di vicariato toscano detenuto da Carlo fino a settembre 1278. La datazione del Davis, e la reinterpretazione della Determinatio
che ne segue, sono degne d'attenzione. Ma l'implicazione del vicariato toscano nel «dominus noster» di Tolomeo appare così stringente? La politica degli Angioini verso i frati Predicatori della provincia Romana (fino al 1296 includente anche il territorio del regno di Sicilia) fu ispirata a un'indisturbata solidarietà che si tradusse in protezione e favori d'ogni genere. Gli atti dei capitoli provinciali testimoniano ampiamente il debito di devozione e riconoscenza dei frati (cf. ACP Index extraneorum). Speciale sentimento di affetto dei frati per i re Angioini potrebbe rendere soddisfacente ragione del «dominus noster» di Tolomeo senza necessaria implicazione della competenza giurisdizionale in territorio toscano, benché in opere di molto posteriori Tolomeo possa aver mutato i propri sentimenti nei riguardi dell'Angioino. Fr. Remigio dei Girolami nei sermoni in ricevimento di Roberto d'Angiò, re dal 1309: «Noster autem rex non solum sapiens sed etiam eloquens est» (BibI. Naz. di Firenze, Conv. soppr. G 4.936, f. 350vb); «quamquam istud verbum conveniat omni regi, tamen specialiter videtur congruere nostro regi presenti domino regi Roberto» (ff. 350vb-351ra); «verbum istud... veraciterpotest dicere de se filius Dei adoptivus et rex temporalis dominusnoster Robertus, qui est hic» (f. 351rb); «ad vos igitur, karissimi, est michi sermo de rege nostro honorificando» (f. 352ra); «dominus autem noster qui hic est non est degener sed legiptimus et verus rex» (ib.); «in persona omnium regratior vobis, dominus nosterrex amantissime» (f. 352rb); «ego offero domino nostro regi, in persona omnium, quinque missas» (f. 352va). Se dalle espressioni in corsivo si dovesse concludere che i sermoni furono predicati dopo maggio 1313, quando Firenze concesse la signoria della città a re Roberto, non sapremmo dove collocarli, visto che l'unica visita di re Roberto in Toscana prima del 1314-15 (data estrema dei sermoni) fu in settembre 1310. La signoria fiorentina inoltre non comportava il titolo di rex.[5] Cf. Annales, ed. B. Schmeidler, Berlin 1930, xxvi-xxvii; M. KRAMMER in Determinatio. ed. cit. p. x. Annotazioni simili si ritrovano sotto la penna d'altri scrittori; la qualcosa, mentre testimonia una consuetudine letteraria, avvalora l'intenzione cronologica. Anonimo lettore di Santa Croce di Firenze, Quodlibet II, 4 (Utrum Christus possit probari Iudeis iam venisse): «cum ipsi [sciI. Iudei] steterint 1296 annis sine sacrificiis, concedant nostrum sacrificium esse illud quo Deus petit honorari» (E. LONGPRÉ, Nuovi documenti per la storia dell'Agostinismo Francescano, «Studi Francescani» 9 [1923] 323). RICCOLDO DA MONTE DI CROCE OP, Liber peregrinationis: «Hec quidem referre verecundum est quidem, sed
magis tristandum quod per talem legem [sciI. alcorani] dyabolus magnam partem humani generis fere iam septingentis annis decepit» (Berlin, Staatsbibliothek lat. 4°. 466, ff. 20vb-21ra). ID., Contralegem Sarracenorum c. 9: «Nam Christus et apostoli fuerunt ante Mahometum sexcentis annis; Mahometus enim surrexit tempore Eraclii, qui incepit regnare anno Domini sexcentesimo decimo. Undenondum sunt septigenti anni quod Mahometus fuit. Sunt autem mille ducenti ed amplius quod fuerunt Christus et apostoli» (Bibl. Naz. di Firenze, Conv. soppr. C 8.1173, f. 200v); c. 13: «Devicto igitur Cosdrohe per supradictum Eraclium et reportata sancta cruce in Ierusalem cum triumpho anno Domini sexcentesimo vigesimo sexto. Eraclii autem anno quinto decimo, surrexit Mohometus arabs» (f. 208r). ID., Libellus ad nationes orientales c. 3 (De iudeis in quo differant a nobis): «Nulla enim alia causa potest reddi, nullum aliud peccatum potest inveniri in iudeis quod sit causa presentis captivitatis, que fuit tam contumeliosa tam periculosa tam universalis tam longa que iam duravit fere MCCCtis annis, quam quianegaverunt Christum et occiderunt» (ib. f. 230r). «Et notandum quod sex fecit Deus quasi eodem tempore et ordine quo de ipsis fuerat prophetatum que ostendunt Christum venisse et verum Deum fuisse; et hec duraverunt continue iam fere mille trecentis annis»(f. 231v). «Quid enim rationis potest habere quod Christus sit natus iam sunt mille trecenti anni et nondum venerit idest nondum apparuit vel manifestatus sit?» (f. 233r).[6] Il decennio di Tolomeo a cavallo dei secoli è ricostruibile con tale dovizia di dati che lo storico più non potrebbe ragionevolmente desiderare. In febbraio 1295 è priore nel conventodomenicano di Lucca (ASL, Dipl. S. Romano 6.II.1295); sempre nella medesima città appare in qualità di teste nel corso del 1295 (ASL,Dipl. S. Romano 22.II.1295 e 3.VII.1295), priore («fr. Tholomeus Fiadonis») in agosto 1297 (ASL, Dipl. S. Romano 11.VIII.1297), non più priore in settembre 1297 (ACP 127/23-27), teste in ottobre 1297 («coram fr. Tholomeo Fiadonis») (ASL, Dipl. S. Romano 19.X.1297), in giugno e settembre 1298 in una transazione commerciale di «Homodeus condam Raynonis Fiadonis» (ASL, Dipl. S. Romano 24.VI.1298 e 3.IX.1298, qui detto «fr. Tholomeo Fiadonis»),tra i frati capitolari in novembre 1298 (ASL, Dipl. S. Romano 7.XI.1298: «fr. Tholomeus Fiadonis»), teste in gennaio e giugno 1299 (ASL, Dipl. S. Romano 11.I.1299; Tuscia. Le decime degli anni 1295-1304, a c. di M. Giusti e P. Guidi, Città del Vaticano 1942, 290),in settembre 1299 nominato definitore al CG del 1300 (ACP 135/22),teste («coram fr. Tholomeo Fiadonis») in transazione di «Homoddeuscondam Rainonis Fiadonis» in novembre 1299 (ASL, Dipl. S. Romano
19.XI.1299), il 17.II.1300 riscuote da legato testamentario (ASL, Notarile, Paganello Bonaiuti n° 32, reg. 3°, f. 101r), mentre il 30.IX.1300 è rappresentato in Lucca da procuratore in riscossione da legato testamentario (ASL, Notar., Rabbito Torringelli n° 52, p. 22). Per il periodo del priorato fiorentino, 1300-1302, v. sotto nella lista dei priori. Elettore al CG Colonia maggio 1301 (Chron. rom. 116; non ci sono ragioni per sospettare - cf. A. Dondaine in AFP 1961, 167 n. 49 - di questa fonte; dal 1249 si vieta che i definitori eletti un anno fossero rieletti al medesimoufficio l'anno immediatamente successivo: MOPH III, 45, 50, 70, 74, 78; Tolomeo è definitore nel 1300 e 1302, mentre nel 1301 è elettore insieme a Remigio dei Girolami elettore-definitore; «tuncenim in nostri ordinis origine semper iidem fiebant diffinitoress»,annota Chron. pis. n° 37, ed. p. 424), definitore al CG Bologna 1302(ACP 142/30; Chron. rom. 117). Priore di Lucca in maggio 1303 (MOPHIII, 322; la pergamena del 4.XI.1302 di cui I. TAURISANO, I domenicani in Lucca, Lucca 1914, 63 n. 2 - ripreso da A. Dondaine in AFP 1961, 168 n. 50 - né esiste nel fondo Dipl. S. Romano né è registrata nel catalogo generale ottocentesco del diplomatico di ASL); priore ancora in dicembre 1303 (ASL, Dipl. Tarpea 5.XII.1303), elettore al CG Tolosa 1304 (Chron. rom. 117).Onomastica: dai docc. risulta che Tolomeus, o Tholomeus, è aferesi di Bartolomeus, esplicitamente testimoniato in ASF, SMN 11.VIII.1301, e pertanto Ptolomeus, che concorre talvolta con Tolomeus, è solo un iperetimologismo degli scribi, cosi come Loth èscrittura iperetimologica, per richiamo del biblico Loth, di Lottuso Loctus (Lotto). Tolomeo è figlio di Fiadone, e molto verosimilmente zio di Omodeo del fu Rainone di Fiadone, con cui compare più volte. Il nome del casato è formalmente testimoniato il 29.VI.1289: «fr. Tholomeus de Fiadonis de Luca» (Arch. Arcivesc. di Lucca, pergam. *0 n° 94 [non *0 n° 49 come nell'ed. astampa, Priori..., «Memorie domenicane» 17 (1986) p. 266 n. 28]: testamento d'Ughetto del fu Donato di Piero, fascicolo cartaceo inpessimo stato di conservazione; il nome di Tolomeo nel verso dellapenultima carta). A tergo d'uno dei due diplomi di ASL, Dipl. S. Romano 22.IX.1288 (rescritto di Niccolò IV che dà licenza all'arcidiacono di Lucca di confermare una transazione tra convento domenicano e ospedale di San Pellegrino in Alpi) una manocoeva ha scritto in modulo minuto ma chiaro: «frater Tolomeus prior Predicatorum pre(sentavit) eidem archidiacono has licteras in hospitali Sancti Martini, pre(sentibus) Guido Caldovillani notario et presbitero Ubaldo cappellano hospitalis et presbitero Dainese, a(nno) mcclxxxviii, die xxx octubris». La nota tergale
potrebb'essere, con tutta verosimiglianza, autografa dello stesso fr. Tolomeo.[7] La prima testimonianza della presenza fiorentina di Riccoldo, dopo la partenza per l'oriente a fine 1288, è del 21.III.1301 (ASF, NA 13364 (già M 293, II), f. 22r: 21.III.1300). Vedi edizione del Contra legem Sarracenorum, e Presentazione, in questo stesso volume: «Memorie domenicane» 17 (1986).http://www.e-theca.net/emiliopanella/riccoldo/sor.htm[8] CH.T. DAVIS, Dante’s Italy and other Essays, Philadelphia 1984, cc. 6, 8, 9, 10. In De bono pacis c. 5 (MD 1985, 176-79) Remigio risponde, a chi obiettava dalla Clericis laicos (1296) di Bonifacio VIII, che tale decretale è stata modificata dalla susseguente Quodolim (12.V.1304) di Benedetto XI. In Lucca, 5.XII.1303, i rappresentanti del clero regolare e secolare della diocesi lucchese nominano procuratori presso il papa i frati Predicatori Ugo dei Borgognoni da Lucca priore provinciale, Tolomeo priore delconvento di Lucca, Banduccio da Pistoia e i notai lucchesi Iacopo di Alfeo e Lamberto di Sornaco per ottenere l’assoluzione dalla scomunica o sospensione nelle quali fossero incorsi «occasione illicite et improvide solutionis et mutationis quam fecerunt seu consenserunt vel aliquis eorum, licet convicti et per timorem qui potuit cadere in constantem, de imposita seu tallia cuiuscumque mutationis seu solutionis vel subventionis quocumque nomine censeri posset eis imposite per lucanum comune et ab cis exacte cun effectu contra constitutiones bone memorie sanctissimi domini Bonifatii pape VIII» (ASL, Dipl. Tarpea 5.XII.1303: più pergamene cucite l’una all’altra contengono la lunga lista delle sottoscrizioni degli ecclesiastici e ratifica della procura). In dicembre 1303 papa era il domenicano Benedetto XI, residente in Perugia, dove Remigio compone il De bono pacis in maggio-giugno 1304. La Quod olim di papa Benedetto modifica la Clericis laicos nel dispositivo relativo agli ecclesiastici costretti dalle autorità laiche, senza loro consenso, a pagare le taglie; costoro, a differenza di quanto disponeva la bonifaciana Clericis laicos, non incorrono nella scomunica.[9] C. DELCORNO, Giordano da Pisa e l'antica predicazione volgare, Firenze 1975; ID., Nuovi testimoni della letteratura domenicana del Trecento, «Lettere italiane» 4/1984, 577-90. GIORDANO DA PISA, Quaresimale Fiorentino 1305-1306, a c. di C. Delcorno, Firenze 1974.[10] A Firenze, nei primissimi anni del Trecento, gli studiosi di fr. Bartolomeo collocano le due opere: cf. C. SEGRE, Bartolomeo da
San Concordio, «Diz. Biogr. degli Ital.» VI, 768-70. Nel 1304 fr. Bartolomeo era certamente in SMN: compare nella lista dei frati capitolari (n° 42) il 20.XI.1304 (ASF, SMN 11.XI.1304: «fr. Bartholomeus Pisanus»); e probabilmente è il «fr. Bartholomeus», senz'altra specificazione, che nella lista dei frati capitolari (n° 27) del 23.XI.1304 apre la sezione dei frati non figli del convento fiorentino (ASF, NA 3141 (già B 2127), ff. 3v-4r). Lettore alla Minerva di Roma nel 1299, ad Arezzo nel 1305 (ACP 132, 154).I volgarizzamenti delle opere di Sallustio furono fatti «a petizione del Nero Cambi di Firençe», senza specifici titoli o qualifiche. Volgarizzamenti del Due e Trecento, a cura di C. Segre, Torino 1980, 403. PATRICIA J. OSMOND, Princeps historiae romanae: Sallust in Renaissance political thought, «Memoirs of the American Academy in Rome»40 (1995) 104-05; Catiline in Fiesole and Florence, «International Journal of the Classical Tradition» 7 (2000) 5n (Catalogus translationum...), 22, 34.
NERI DI CAMBIO delle fonti comuni? senz'alcun raccordo con l'autore o convento domenicano: esponente, insieme a Geri degli Spini, dei neri d’inizio Trecento, «di sottile ingegno, ma crudoe spiacevole» (COMPAGNI indice 202b). Sia Nèri (da Rainerius) cheCambio sono comunissimi antroponimi nella Firenze del tempo e possono dar luogo a molte omonimie. Registriamo altre possibili alternative: a) Un Nero di Cambio (del Tedesco), senz’indicazione di popolo, appare nel libro d’amministrazione di Baldovino dei Riccomanni, 1272-78 (A. CASTELLANI, Nuovi testi fiorentini del Dugento, Firenze 1952, 248-83).
b) Un «Nero Cambi» è priore in dic. 1289 - febbr. 1290 per ilsesto d’Oltrarno [no! correggi in Porta San Piero], e un altro in dic. 1294 - febbr. 1295 per il sesto Porta San Piero (STEFANI rubr. 185 e 207); quest’ultimo è il «Nerius Cambii populi Sancti Simonis» (San Simone e Giuda, sesto Porta San Piero) iscritto all’arte della lana in novembre 1309 (ASF, Arte della Lana 18, f. 3r). No! Ricontrollo (genn. 2014!) il testo dello Stefani, e mi accorgo di aver fatto un errore quanto a rubr. 185: anche qui Nero Cambi è priore per il sesto Porta San Piero (vedi lista dell'ordine dei sestieri inrubr. 158). Correggi dunque questo brano di «Memorie domenicane» 17 (1986) p. 267 n. 32, e riscrivilo:
b) Un «Nero Cambi» è priore per il sesto Porta San Piero in dic.1289 - febbr. 1290, e in dic. 1294 - febbr. 1295 (STEFANI rubr.
185 e 207); verosilmente da identificare con«Nerius Cambii populi Sancti Simonis» (San Simone e Giuda, sesto Porta San Piero) iscritto all’arte della lana in novembre 1309 (ASF, Arte della Lana 18, f. 3r).c) Neri di Cambio del popolo Santa Maria Maggiore (ASF, NA 3140 (già B 2126), f. 132v: 16.V.1304), confinante col convento domenicano e deceduto poco prima di giugno 1306, deve aver intrattenuto speciali rapporti coi frati, se sceglie sepoltura nei recinti conventuali. Potrebbe candidarsi con buone ragioni al titolo di destinatario dei volgarizzamenti sallustiani di Bartolomeo da San Concordio. Firenze 27.VI.1306, «iuxta plateam novam» di SMN: «Mannus Attaviani, Cione Benintendi et Veri BelliBenintendi, officiales comunis Florentie ad infrascripta, una cum ser Berto magistro mensuratore comunis Florentie, existentesin dicta platea ad videndum et mensurandum et dirizandum terrenum dicte nove platee et etiam terrenum orti ipsius ecclesie pro danda posta muri noviter fiendi, visis mensuratis et dirizatis dictis terrenis, dederunt licentiam ipsius ecclesiefratribus edificandi seu edificari et murari faciendi super dicto terreno recta linea sicut trahitur et protenditur murus dictorum fratrum, qui est iuxta viam qua itur ad monasterium dominarum de Ripulis, usque ad palum infixum in angulo ipsius platee, et ab ipso palo recta linea iuxta dictam plateam usque ad murum noviter inceptum iuxta portam claustri ipsius ecclesie et sepulcrum factum pro corpore Nigri Cambii, salvo in omnibus predictis iure comunis florentini» (ASF, NA 3141 (già B 2127), f. 25v). L’8.I.1319/20 un atto è rogato «in domo fil(iorum) olimNeri Cambii in populo Sancte Marie Maioris» (ASF, NA 3143 (già B2129), f. 17r-v). Suo figlio è «Giambertus filius Neri Cambii populi Sancte Marie Maioris», che il 29.VIII.1303 provvede in proprio alla restituzione delle usure (ASF, NA 3140, f. 113v).http://www.e-theca.net/emiliopanella/nomen2/neri.htm
PRIORI DI SANTA MARIA NOVELLA DAL 1221 AL 1325
12 novembre 1221 Giovanni (da Salerno)Atto di donazione della chiesa di Santa Maria Novella da
parte del cardinale legato Ugolino:«Nos Hugolinus divina providentia hostiensis et
velletrensis episcopus et sancte Romane ecclesie cardinaliset apostolice sedis legatus,... auctoritate legationis qua fungimur instituimus et ponimus et ordinamus te fr. Iohannem ordinis Predicatorum, pro te et omnibus tuis fratribus dicti ordinis et pro toto ipso ordine accipientem, in ecclesia et de ecclesia Sancte Marie Novelle cum suis domibus et cimiterio et sex starioris terre circa ecclesiam pro orto faciendo ut in ipsa stetis habitetis et moremini in perpetuo, et divina officia in ea celebretis, statuentes ut hec nostra institutio permaneat illibata et perpetuo valitura... Acta sunt hec omnia Florentie in choro dicte ecclesie presentibus d.no Iohanne florentino episcopo, Chianni preposito et Dono archipresbitero florentino et quibusdam canonicis ecclesie Sancte Reparate» (ASF, SMN 12.XI.1221; cf. FINESCHI 30-31).
12 gennaio 1227 Giovanni (da Salerno)«... magistro Iohanni fratrum Predicatorum de Sancta
Maria Novella et eius successoribus» (ASF, SMN 12.I.1226;MEERSSEMAN, Dossier 180-81; FINESCHI 80-81).
20 giugno 1227 Giovanni (da Salerno)Gregorio IX «dilectis filiis magistro Iohanni priori
ordinis Predicatorum... et Bernardo canonico florentino» (ASF, SMN 20.VI.1227; FINESCHI 77-79).
14 novembre 1228 Giovanni (da Salerno) «presentibus magistro Iohanne priore SMN de ordine
fratrum Predicatorum et fratre Sinibaldo» (ASF, SMN 14.XI.1228; Dossier 181-83; FINESCHI 81-82).
maggio e giugno 1229 Giovanni (da Salerno)Dossier 226 n° 7 «maestro Iovanni priore», n° 8 «frate
Iovanni priore».
27 gennaio 1230 Giovanni (da Salerno)
ASF, SMN 14.XI.1228; Dossier 183-84 «magistri Iohannis prioris».
21 febbraio 1230 Giovanni (da Salerno)ASF, SMN 21.II.1229; Dossier 185 «magistri Iohannis
prioris»; FINESCHI 82-83.
16 marzo 1230 Giovanni (da Salerno)ASF, SMN 16.III.1229; Dossier 186-87 «magister Iohannes
prior»; FINESCHI 84-85).
17 giugno 1230 Giovanni (da Salerno)ASF, SMN 17.VI.1230; Dossier 187-88 «magister Iohannes
prior»; FINESCHI 86.
18 e 28 gennaio 1231 Giovanni (da Salerno)ASF, SMN 18.I.1230; Dossier 189-90 «magister Iohannes
prior»; FINESCHI 85-86. ASF, SMN 28.I.1231; FINESCHI 87-88 dove si corregga l'anno in 1231.
settembre 1232 Giovanni (da Salerno)ASS, Dipl. Arch. riformagioni 16.IX.1232 e 17.IX.1232: Siena,
chiesa San Cristoforo, trattati di pace tra Siena e Firenze. Presenti: Giovanni priore dei Predicatori di Firenze e Gualtieri priore dei Predicatori di Siena.
Trassi la nota dal solo inventario del diplomatico, ASS 1986, ma non ebbi tempo di controllare il diploma originale.
31 gennaio 1245 Alessandro«Coadunato capitulo fratrum Predicatorum de SMN more
solito in capitulo dicte ecclesie, fr. Alexander prior fratrum ipsius ecclesie, consensu et parabola fratris [segue lista nominale dei singoli frati capitolari], suo et ipsi fratres cum eo constituerunt ordinaverunt et fecerunt fr. Niccolaum subpriorem, presentem et recipientem, eorum et dicte ecclesie sindicum ad recipiendas cartas emptium terrarum platee nunc de novo facte ante ipsam ecclesiam et ad promittendum et solvendum pretium terre sibi vendite et
ad obligandum bona dicte ecclesie, promittentes observare et attendere totum id quod ab eo inde factum fuerit.
Actum in capitulo dicte ecclesie prope muros civitatis Florentie in burgo SMN. Testes rogati fuerunt Grillus filius olim Anghiolini et Guido filius Martini». Nei seguenti due negozi, Fr. Niccolò acquista suoli e terreni «platee nunc de novo facte ante dictam ecclesiam ex parte orientis», prezzo rispettivamente 12 e 38 denari pisani (ASF, SMN 31.I.1244): primitiva chiesetta e antistante piazza oggi denominata dell'Unità Italiana. Una delle due pergamene sotto la medesima segnatura d’archivio; l'altra registra sentenza dell'allora inquisitore fr. Ruggeri Calcagni da Firenze OP, «lata... apud ecclesiam SMN», diversi i testimoni.
Nessun fra Alessandro di questo periodo è registrato da Cr SMN: figlio nativo d’altro convento? ignoto al cronista che negli anni 1279-80 avvia Cr SMN ?
26 aprile 1245 Alessandro«Actum Florentie prope ecclesiam SMN, presentibus
testibus fr. Niccolao subpriore fratrum Predicatorum, fr. Aldebrandino et fr. Romeo eiusdem ordinis. - Domina Lamandina uxor Renaldi de Pulce iuravit...
Item eodem die, actum in coro Sancte Reparate, presentibus testibus fr. Alessandro priore fratrum Predicatorum de Florentia, fr. Aldobrandino et fr. Romeo eiusdem ordinis. - Dominus Renaldinus de Pulce iuravit...» (ASF, SMN 26.IV.1245; cf. F. TOCCO, Quel che non c'è nella Divina Commedia o Dante e l'eresia, Bologna 1899, 49).
27 aprile 1250 Aldobrandino dei Cavalcanti da Firenze«Fr. Ildebrandinus prior fratrum Predicatorum dicte
ecclesie SMN florentine, in presentia fratrum Pascalis, Uguiccionis, Guidonis pisani, Bertolomei, Henrici sacerdotis, Henrici diaconi, Pagani, Iacobi et Niccolai et pro eorum voluntate, elegit presbiterum Salvi filium Aldobrandini de Prato in cappellanum ecclesie Sancti Iacobique est sita in populo SMN predicte et est sub iurisdictione fratrum Predicatorum et in eorum dominio;
elegit autem eum hoc modo quod ipse ibi morari debeat et officium facere quam dium predicto priori placuerit vel eius successoribus, et ipsum possit removere sine lite et sine contradictione de predicto loco quondocumque ei vel qui pro tempore fuerit prior placuerit. Qui presbiter Salvipredictam electionem sic factam et sic ordinatam recepit etpromisit se in nullo contraire, promittens etiam quod quondocumque prior SMN dixerit ei quod recedat, quod in sequenti die recedet sine ulla contradictione» (ASF, SMN 27.IV.1250).
Fr. Aldobrandino dei Cavalcanti: «fuit prior in conventuflorentino multis annis, et postea prior provincialis» (Cr SMN n° 124). Testimonianza di fr. Remigio dei Girolami: «Fuit ergo dignus quia pastor, et in ordine prior longo tempore hic et Luce, et prior provincialis sex annis; viginti septem annorum erat quando fuit primo prior, semperquasi postea fuit prior. Fuit etiam pastor extra ordinem septem annis» (Note di biografia, AFP 1984, 235).
21 febbraio 1251 Aldobrandino dei Cavalcanti«Dominus Paganus prepositus canonice et capituli
florentini precepit presbitero Antonio, de voluntate ipsiuspresbiteri Antonii, ut die crastina per totum diem exiret de hospitali Sancte Marie de Fonteviva, qui pub(lice) dicitur hospitale de Bigallo, et recederet inde cun omnibussuis rebus, et quod observet hominibus et rectoribus predicti hospitalis qui sunt de sotietate Sancte Marie predicto hospitali in totum. (...) Acta sunt hec omnia in coro ecclesie et canonice florentine presentibus d. Ildebrandino priore et fr. Ottaviano de ordine PredicatorumSMN florentin(is) et domino Caponsaccho canonico canonice antedicte et Ildebrandino condam Drudoli,... et aliis multis de sotietate predicta qui ad hec testes vocati fiere[sic], anno Domini 1250, nona kalendas martii et indictione nona» (ASF, Dipl. Bigallo 5.VI.1250-29.V.1328 a quaderno, f. 3r; fascicolo carte 10, sec. XIV, vi sono regestati atti e donazioi relativi alla "Sotietas Sancte Marie").
28 agosto 1252 Aldobrandino dei Cavalcanti
«Dominus Turpinus, prior custos et rector canonice et ecclesie Sancti Pauli, connfessus fuit... et nominatim pro solvendo pretio emptionis quam facere intendit pro ipsa ecclesia, consensu et parabola presbiteri Talenti, presbiteri Cambii et Oddi et Turpini canonicorum..., vendiderunt... et concesserunt domino fr. Ildebrandino priori ecclesie SMN ementi... pro se et capitulo eiusdem ecclesie SMN... videlicet unam petiam terre et rei et posite Florentie in populo Sancti Pauli, cuius hii sunt confine: a j° murus ecclesie SMN scilicet fratrum Predicatorum, a ij° ecclesie Sancti Pauli, a iij° domine Niccildine uxoris olim Tornaquinci del Pecora, a iiij° hominum burgi Sancti Pauli..., que est ad rectam mensuram civitatis Florentie staior(a) quinque et pedes septem... pro pretio cuiuslibet star(ii) lib. 20 denariorum pisanorum, quod pretium est in summa libre centum una, de quibus pro dicta ecclesia vocaverunt se bene solutum... Actum Florentie in claustro ecclesie Sancti Pauli...» (ASF,SMN 28.VIII.1252).
11 febbraio 1254 Aldobrandino dei CavalcantiAtto di pace tra Pistoia da una parte e Firenze e Lucca
dall’altra, in Empoli 11.II.1253 /4, «ante plebem Sancti Andree»; tra i testi: «domino fratre Aldobrandino priore ordinis Predicatorum SMN de Florentia et fratre Ugo [Cr SMN n° 110] subpriore dicte ecclesie» (P. SANTINI, Documenti dell’antica costituzione del comune di Firenze. Appendice, Firenze 1952, 42).
FINESCHI 151 riporta un documento di donazione sotto l’anno MCCLXL [sic] attestante il priorato di fr. Aldobrandino dei Cavalcanti che non sono riuscito a rintracciare nei fondi diplomatici.
maggio-giugno 1257 Ambrogio di Ranieri di MarsilioCP Firenze 1257: «Diffinitor capituli generalis prior
Florentinus, socius eius fr. Iacobus de Benevento», ossia nominati definitore e suo socio al capitolo generale Tolosa1258 (ACP 21/32-33; il nome del priore lo si ricava dalla testimonianza parallela di Cr Ro: vedi esponente
successivo). Il CP Firenze 1257 fu celebrato a ridosso del CG 1257 nella medesima città (MOPH III, 84-89).
Fr. Ambrogio († 1274) «magnus predicator et prior in conventu florentino» (Cr SMN n° 100). Iacopo de Benevento:SOPMÆ II, 304-09; IV, 131.
maggio 1258 Ambrogio di Ranieri di MarsilioCG Tolosa 1258: «In hoc capitulo diffinitor fuit fr.
Ambrosius prior Florentinus, socius vero cius fr. Iacobus de Benevento» (Cr Ro 104).
1263 Giovanni da ViterboCP Roma 1263: «Electores magistri fr. Iohannes prior
Florentinus et fr. Laurentius Tudertinus. Diffinitor capituli generalis fr. Laurentius Tudertinus, socius eius fr. Iohannes Viterbiensis prior Florentinus» (ACP 28/22-25). Manca indicazione del tempo di convocazione del CP 1263 (settembre?).
Nel CG Parigi 1264 «fuit diffinitor fr. Laurentius Tudertinus, socius eius fr. Iohannis Viterbiensis» (Cr Ro 106); qui non si dice «prior»; bisogna dedurne che al tempodel CG 1264 fr. Giovanni non fosse più priore fiorentino? Non necessariamente. Sono documentabili casi in cui il titolo non è espresso per frati-priori, specie se questi non compaiono in qualità di priori. Ugo degli Ubertini, priore il 3.II.1288 (v. sotto questa data), in atti del 2 e3.II.1288 non è detto priore. Giovanni d’Oltrarno è certamente priore nel 1305 fino al CP del medesimo anno; risulta priore il 16.I.1305 e il 24.V.1305; come semplice teste, senza titolo priorale, è presente in un atto del 19.I.1305 (v. sotto la data 16.I.1305).
maggio-giugno 1268 Gerardo d’ArcetriCP Viterbo 1268: «Diffinitor capituli generalis fr.
Eufranon cui parcimus hoc anno a lectione, socius eius fr. Gerardus prior Florentinus» (ACP 35/1-2). Il CP Viterbo 1268 fu celebrato a ridosso del CG 1268 nella medesima città. Il CP 1268 era stato convocato a Pisa, «sed propter Conradinum, qui erat excommunicatus et a Pisanis receptus,
translatum fuit de mandato domini pape Clementis apud Viterbium» (Cr Ro 107; MOPH III, 140-44).
maggio 1269 Gerardo d’ArcetriCG Parigi 1269: «In hoc capitulo fuit diffinitor fr.
Eufranon, socius vero eius fr. Gerardus prior Florentinus» (Cr Ro 107).
Gerardo d’Arcetri «existens prior in conventu florentino... vitam finivit temporalem» (Cr SMN n° 104, tra i frati deceduti anteriormente al 1279, dei quali il cronista ignora l'anno di morte). Fr. Eufranon della Porta salernitano; nominato di nuovo definitore al CG Bologna 1275, muore sulla strada per recarsi al capitolo (MOPH III,182/19-20).
tra 1269 e 1276 Ugo Martellino da Firenze«Frater Ugo dictus Martellini [mano tardiva muta in de
Martellinis] de Ultrarno..., fuit prior multotiens in multis conventibus; et existens prior in conventu florentino et vitam finiens temporalem cum magna devotione adeptus est eternam» (Cr SMN n° 110); tra i frati decedutianteriormente al 1279, dei quali il cronista ignora l'anno di morte.
Fr. Hugo Martellinus in ACP 24/12-13 (1259). Il CP Viterbo 1268 (era stato convocato per la Pentecoste) istituisce il covento in Rieti e ne nomina primo priore fr. Ugo (ACP 34/29). Il 31.III.1270 priore reatino era un fr. Bonifacio (Arch. di Stato di Rieti, Raccolte e miscell., S. Domenico n° 5: 31.III.1270).
Morto durante il priorato fiorentino, Ugo fu priore tra gli estremi massimi 1269 e 1276, in base al nostro elenco; e verosimilmente un pò prima del '76, se il cronista fiorentino al lavoro nel 1279 a biografie ordinate cronologicamente su anno di morte, ne ignora tempo del decesso.
20 ottobre 1276 Ubertino di messer Ardingo degli Ardinghi da Firenze
«Omnibus hevidenter appareat has licteras inspecturis quod discretus sapiens et onestus vir fr. Ubertinus de ordine Predicatorum prior conventus fratrum Predicatorum ecclesie SMN florentin(e), habens curam tamquam procurator dicti conventus in spiritualibus et temporalibus ecclesie Sancti Iacobi de Polverosa rectore vacantis..., volens rectore dictam ecclesiam reformare..., nominavit... presbiterum Basilium presentem et consentientem in rectoremet gubernatorem ecclesie Sancti Iacobi supradicti... Actum Florentie apud ecclesiam SMN presentibus presbitero Talentorectore ecclesie Sancti Florentii, presbitero Fede cononicodicte ecclesie et Mosa serviente dominarum de Ripolis ad hec rogatis testibus» (ASF, SMN 20.X.1276; tre pergamene dall’identico contenuto sotto la medesima segnatura d’archivio).
Fr. Ubertino «in conventu florentino diversis vicibus, ter fuit <prior> » (Cr SMN n° 212). Testimonianza di fr. Remigio dei Girolami: «fuit enim prior hic pluries et Pistorii et Senis et Luce et Urbeveti» (Note di biografia, AFP 1984, 269).
8 febbraio 1277 Ubertino degli Ardinghi«Dominus Teglarius filius olim domini Iacobi de Scalis
de Florentia» rende quietanza a frater Iohannes de ordine S. Marie Novelle de Florentia per 400 flor. che lo stesso Teglarius aveva ricevuto, in persona del procuratore Plebanus filius domini Lapi de Cavalcantibus, a venerabili fratre Ildebrandino episcopo Urbevetano, somma per la quale il vescovo e il capitolo obligati erant prefato domino Teglario ex causa mutui. L'atto è redatto in capitulo fratrum Predicatorum civitatis Florentie; tra i presenti (= tra i testi?) frater Ubertinusolim domini A<r>dinghi prior fratrum SMN» (M. ROSSI CAPONERI - L. RICCETTI, Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei sec. XIII-XIV. Archivi di Orvieto, Perugia 1987, 178, tra gli atti di Aldobrandino dei Cavalcanti vescovo di Orvieto 1272-79; sotto la data 8.II.1276, che interpreto in stile fiorentino).
16 luglio 1277 Ubertino degli Ardingbi
«Discretus et honestus vir fr. Ubertinus prior predictus...» (ASF, SMN 20.X.1276; giunta del 16.VII.1277). Il CP Perugia 1277 era stato convocato per il14 settembre (ACP 48/5-6).
In febbraio 1279 fr. Ubertino era priore di Lucca (ASL,Dipl. S. Romano 27.II.1279).
22 febbraio 1278 Guarnieri di Bernardo dei Vecchietti da FirenzeTestamento di Lotto, detto Ciaccherius, del fu Amideo del
popolo SMN. Dopo lasciti ai frati del convento fiorentino affida, per restituzione «de incertis», a Tessa del fu Ildebrandino e a Beccia del fu Giaco, donne l’ordine della Penitenza, «libras 10 f. p. ab ipsis dominabus dandas et distribuendas ad earum voluntatem, cum consilio fr. Guernerii prioris ecclesie Sancte Marie predicte, illis personis et locis quibus utilius eis videbitur pro sua anima convenire. Item reliquid iussit et voluit quod dicte sue heredes incontinenti post eius obitum faciant fieri unam sepulturam sive avellum in cimiterio ecclesie SMN predicte... Actum Florentie in populo SMN, in domo Gilii condam Mercati notarii in qua moratur ductus testator, presentibus testibus ad hec rogatis fr. Gherardo Nasi et fr. Iacobo converso ordinis Predicatorum conventus ecclesieSancte Marie predicte» (ASF, SMN 22.II.1277).
Guarnieri dei Vecchietti (1246-1310): «fuit prior pluries in conventu florentino» (Cr SMN n° 195). Per un secondo priorato fiorentino vedi esponente 13.III.1309. Il 24 febbraio 1287 due suore dell’ordine della Penitenza fanno donazione d’una casa con terreno e pozzo, sita pressola piazza di SMN, «fratri Guernerio de Vecchiettis ordinis fratrum Predicatorum ecclesie SMN recipienti pro se ipso etomnibus fratribus dicte ecclesie et etiam pro capitulo» (ASF, SMN 24.II.1286). Il formulario («recipienti pro se ipso et... ») implica il priorato o semplicemente una procura? Il 4 aprile 1288 fr. Guarnieri è priore di Santa Maria in Gradi di Viterbo (APR, Dipl. 8.IV.1288; AFP 1963, 246). Il nome del casato è indifferentemente «de Vecchiettis» o «de Vecchis» nei documenti coevi; molte
notizie sui Vecchietti, incluso Bernardo padre di fr. Guarnieri, in ASF, NA 3140 (già B 2126), NA 3141 (già B 2127).
18 ottobre 1279 Pagano di messer Iacopo degli Adimari da Firenze«Fuit prior in conventu florentino, et tempore prioratus
sui bone memorie dominus frater Latinus natione Romanus cardinalis et sedis apostolice legatus fundavit ecclesiam SMN M°CC° septuagesimo IX°, in festo sancti Luce» (Cr SMN n° 172).
26 gennaio 1282 Ubertino degli Ardinghi da Firenze«Fr. Ubertinus prior fratrum capituli et conventus
ecclesie SMN ordinis Predicatorum de consensu voluntate licentia et autoritate infrascriptorum fratrum dicti capituli et conventus» nominano procuratori «Iacopinum dni Bellincionis [degli Adimari], Martinum fratrem de Penitentia, Cenni et Fantem conversos monasterii sororum deRipolis licet absetens» per prender possesso «terrarum domorum bonorum et rerum omnium et possessionum que olim fuerunt domini Gionnoççi de Giandonatis et in eius hereditate remanserunt..., et ispsas terras... pro eis et eorum nomine locandum... et ad recipiendum fructus redditus(...). Actum in capitulo dicte ecclesie, presentibus et rogatis testibus Lotto Benvenuti populi SMN et Giglio Brindoli coreggario» (ASF, Dipl. S. Domenico del Maglio 26.I.1281; inchiostro qua e là alquanto sbiadito).
27 agosto 1283 Ubertino degli Ardinghi da Firenze«Omnibus evidenter appareat quod... fr. Ubertinus de
ordine Predicatorum prior conventus fratrum Predicatorum ecclesie SMN, habens curam tanquam prior dicti conventus inspiritualibus et temporalibus ecclesie Sancti Iacobi de Polverosa», vacante il rettore, nomina a nuovo rettore di detta chiesa prete Rustico del fu Ranieri, presente e consensiente. «Actum Florentie apud ecclesiam SMN, testibuspresbitero Taddeo rectore ecclesie Sancte Marie Maddalene et Naccio olim Bencivenni populi Sancti Felicis in Piaça et
Corso filio olim Grossoli populi Sancti Remigii» (ASF, SMN 27.VIII.1283).
8 giugno 1286 Ugo degli Ubertini (d’Arezzo)«Actum in choro maioris ecclesie florentine...
Religiosus vir dominus frater Ugo prior fratrum ecclesie Sancte Marie Novelle presentavit has litteras dominis Iacopo preposito, Locterio archidiacono, Uguictioni et Mainecto canonicis florentinis et etiam clero florentino ibidem ad hec ad sonum campane cleri more solito congregato; quas litteras dictus dominus prepositus incontinenti reverenter in suis manibus recepit et alta voce legit ibidem coram clero predicto (Arch. Capitolo del Duomo di Firenze, Pergamena 1017 (1286/B), cassa 23).
has litteras = lettera d’Onorio IV (28.V.1286) che nomina vescovo di Firenze fr. Iacopo da Perugia OP = http://www.e-theca.net/emiliopanella/nomen1/iacopo.htmhttp://www.smn.it/emiliopanella/nomen1/iacopo.htm
Il CP Gaeta 1286 era stato convocato per il 29 settembre(ACP 72/23-24) e di fatto tenuto alla data di convocazione,come conferma ASL, Dipl. S. Romano 5.X.1286. Nella lista nominativa delle assoluzioni priorali del CP Roma 1287 è assente il priore fiorentino (ACP 77-78).
3 febbraio 1288 Ugo degli Ubertini (d’Arezzo)«Actum Florentie in domo ubi moratur dictus Cione
Villanuzi, presentibus testibus et rogatis fr. Ugone de Ubertinis priore conventus SMN de Florentia, fr. Pace Florentino de dicto ordine» (ASF, SMN 3.II.1287). Atti diufficiali nominati dal comune fiorentino per trattare questioni relative alla nuova piazza antistante la nuova chiesa SMN.
In ASF, SMN 2.II.1287 fr. Ugo appare come teste senza titolo priorale sia nel negozio del giorno che nella giunta3.II.1287/8; col titolo di priore nella giunta 21.II.1287/8(vedi esponente successivo).
21 febbraio 1288 Ugo degli Ubertini (d’Arezzo)
«Item postea eodem anno <scil. 1287> et indictione, die 21 februarii, apud ecclesiam SMN, presentibus testibus ad hec vocatis fr. Ugone de Ubertinis priore fratrum conventusdicte ecclesie, fr. Pace Florentino et fr. Borgense et fr. Iacobo conversis» (ASF, SMN 2.II.1287; giunta del 21.II.1287/8).
Necr. I, 252 rinvia a FINESCHI 259 e all’anno 1297 [= 1287/8] a proposito di documenti circa la nuova piazza di SMN. FINESCHI 257-60 fonde distinti documenti relativi alle provvisioni del comune fiorentino per la costruzione della nuova piazza (genn.-febbr. 1288); oggi essi sono: ASF, SMN 16.I.1287; 2.II.1287 (con giunte di atti fino al 21.II.1287/8); 3.II.1287; 20.III.1287 (cinque pergamene sotto la medesima segnatura). Qualcuno edito da G. PAMPALONI,Firenze al tempo di Dante. Documenti sull’urbanistica fiorentina, Roma 1973, 70-77.
Cr SMN non registra fr. Ugo degli Ubertini, e non vi sono ragioni per ritenerlo figlio del convento fiorentino (Necr. I, 251-53). Il potente casato ghibellino degli Ubertini aveva il suo ceppo principale in Arezzo e contado aretino, e del convento domenicano d’Arezzo fr. Ugo va considerato figlio nativo. Nella lista capitolare del convento di Città di Castello 1274: «fr. Ugolinus Aretinus»(ASL, Dipl. S. Romano 11.V.1274). ASMN I.A.3, Liber recordationumnovus, f. 2v: «dnus Guillelmus condam dni Raynerii de Ubertinis donavit fr. Ugoni de Ubertinis, recipienti pro ordine fratrum Predicatorum, unam domum ac etiam terram partim aratoriam et partim vineatam iuxta dictam domum positam in Leona pro uno hospitali quod vocatur Sancta Maria de Leona et est de comitatu aretino. Instrumentum de hoc fecit ser Iacobus de Magistris de Castro Aretino anno Domini Mcclxxxxvij. De hoc in predicto libro 76 car.» (Ospizio Santa Maria a Lèvane, nel piviere San Piero a Presciano, Arezzo). Donna Sibona, vedova di Perino da Volterra, nel proprio testamento (Arezzo 24.I.1304) «reliquit loco fratrum Predicatorum de Aretio decem libras pis(anorum) in subsidium exp(??) operis dicte ecclesie dicti loci, ad quam
ecclesiam suam elegit sepulturam; item iure legati reliquitfr. Ugoni de Ubertinis dicti ordinis decem libras pis(anorum) in subsidium unius tunice et unius cape ad dorsum eiusdem fr. Ugonis; item pro salute anime sue reliquit fr. Manno de Aretio eiusdem ordinis unum suum guanciale...»; in tutti gli altri suoi beni mobili e immobili istituì inoltre il predetto fr. Ugo [non fr. Ubertino come in ed. a stampa!] suo erede universale (ASF, S. Domenico d’Arezzo 24.I.1304). Una casa dell’eredità di donna Sibona, «posita in porta Fori in Burgo de Valle Longa», lasciata a fr. Ugo degli Ubertini e ora posseduta dai fratie dal convento aretino OP, era stata tassata in occasione di un’imposta fatta «domino Guidoni de Sasso de Ubertinis, qui nil iuris habet in dicta domo»; le autorità aretine accolgono la petizione inoltrata da fr. Angelo OP a nome del convento domenicano d’Arezzo e dichiarano in agosto 1316 che «conventum ordinis fratrum Predicatorum molestandum vel inquietandum non esse pro libra seu datiis impositis vel in posterum imponendis d. Guidoni de Saxo de Ubertinis» (ASF, S. Dom. d’Arezzo 23.VIII.1316). La parentela (non specificata) tra fr. Ugo e messer Guido potrebbe aver indotto l’ufficio aretino della libbra a computare la casa ereditaria del primo nell’imponibile del secondo. Ugualmente del convento aretino andrà considerato fr. Domenico degli Ubertini, non registrato da Cr SMN (ASF, NA3143 (già B 2129), ff. 43r-44v: 24.XII.1320; ff. 69r-70v: 5.XI.1321; ff. 76v-78r: 30.XII.1321).
CP Viterbo settembre 1289: «Absolvimus priores Florentinum, Aretinum, Tudertinum» (ACP 94/10). CP Aquila 1290: «Absolvimus priores» (ACP 95/30).
aprile 1291 priore innominatoChiostro di SMN 3.IV.1291: Niccolò camerario e notaio di
Niccolò IV trasmette al convento fiorentino lettera papale del 28.III.1291 che ordina d’affidare a Barduccio dei Canigiani e a Maso di messer Gianni dei Ridolfi, mercanti fiorentini, le suppellettili di Stefano dei Colonna, già rettore di Romagna, fatte depositare in SMN da B(onifacio) arcivescovo di Ravenna. Fr. Ranieri detto il Greco
sottopriore, «nomine suo et fratris . . (lac.) . prioris dicti conventus tunc absentis», s’impegna (ASF, NA 4111 (già C 102), f. 89r-v: 3.IV.1291).
CP Spoleto settembre 1291: nella lunga lista delle assoluzioni dei priori è assente quello fiorentino (ACP 98/29-34; ib. 99/1-14 per la cura dei conventi di cui è stato assolto il priore).
gennaio 1292 priore innominatoNiccolò IV, Roma, Santa Maria Maggiore, 18.I.1292.
Priore (innominato) e convento SMN hanno inoltrato petizione e dichiarato: taluni cittadini fiorentini hanno occupato e detengono i beni del fu Benvenuto di Cambio, chespettano invece per diritto ereditario ad Albertino, fratello germano del fu Benvenuto e frate di SMN; beni a loro volta spettanti al convento SMN, stante la dichiarazione della sede apostolica che «fratres eiusdem ordinis in temporalibus bonis, in quibus succederent in seculo existentes, licite possint succedere». Il papa ora nomina giudice della causa l'arciprete delle pieve di Colle, dioc. Volterra, con autorità di convocare e ascoltare le parti, emettere la sentenza, senza diritto di appello (ASF, Dipl. SMN 18.I.1292).
Fr. Albertino, detto Mazzante, figlio di Cambio da Firenze (pp San Michele in Orto), OP 1267, † 1319/20, «carpentarius, et in edificiis et oficinis fratrum construendis perutilis et subtilis» (Cr SMN n° 219).
11 giugno 1293 Ubertino degli Ardinghi da Firenze«Omnibus hiis licteris inspecturis clareat evidenter
quod fr. Ubertinus de ordine fratrum Predicatorum, prior conventus fratrum Predicatorum ecclesie SMN de Florentia, habens curam tamquam prior dicti conventus in spiritualibuset temporalibus ecclesie Sancti Iacobi de Polverosa sue ecclesie manualis», vacante il rettore, nomina a nuovo rettore di detta chiesa prete Vinci del fu Uberto, presentee consensiente, «dando eidem claves dicte ecclesie et bonorum eius, tali pacto... quod teneatur comunicare et infirmos inungere in populo SMN et in sepulturis puerorum
intendere... Actum Florentie presentibus ad hec rogatis testibus fr. Scholario filio Squarcie, fr. Pagano de Adimaribus, Olandino pinçochero» (ASF, SMN 11.VI.1293).
CP Anagni settembre 1293: «Absolvimus priores Florentinum, Castellanum... Curam conventus Florentini committimus fr. Remigio lectori» (ACP 111/28-31). Testimonianza di fr. Remigio: «Sicut vos scitis, nos ad presens caremus priore sed ipsum in brevi habebimus Domino concedente. Placuit autem, illis qui absolverunt priorem, curam huius conventus michi commictere in actis capituli provincialis» (MD 1979, 200; AFP 1984, 247). Fr. Ubertino in ottobre 1289 era priore di Pistoia (AFP 1963, 247).
luglio 1295 Cinzio (o Cencio) da RomaCP Siena 1295 convocato per l’ottava dei santi Pietro e
Paolo, 6 luglio (ACP 118/31-32): «Diffinitor capituli generalis fr. Cyntius prior Florentinus, socius eius fr. Salvus de Barga» (ACP 123/1-2). Nella lista dei priori assolti non è presente quello fiorentino (ACP 121/3-7).
7 settembre 1295 Cinzio da Roma«In burgo Sancti Laurentii, in domo condam Durantis de
Anchionibus, presentibus testibus fr. Marçuccho de Pisis ordinis fratrum Minorum Sancte Crucis de Florentia, fr. Lotto Moscheruoli de Florentia ordinis fratrum SMN, presbitero Iohanne canonico Sancti Laurentii de Florentia, et presbitero Bonsi cappellano eiusdem Sancti Laurentii.
Fr. Ciencius prior ordinis et conventus SMN fratrum Predicatorum de Florentia et dnus Ambrogius prior ecclesie Sancti Laurentii de Florentia et dna Ghita vidua uxor condam Durantis Fendi de Anchionibus... et fr. Philippus guardianus conventus fratrum Minorum de Florentia», commissari et esecutori testamentari dell’ultima volontà diDurante, fanno inventario dei beni (ASF, NA 13363 (già M 293, I), ff. 60v-62v: 7.IX.1295).
Testamento di Durante degli Anchioni del 14.IV.1289, esemplato il 2.XII.1322, in ASF, SMN 14.IV.1289; il testamento è ricordato in ASF, NA 19164 (già S 733), f. 75r
(12.VI.1299). Atti esecutori: Bibl. Laurenziana, Dipl. Capitolo S. Lorenzo 767 (14.IX.1295), 760 (26.III1297).
18 novembre 1295 Cinzio da Roma«dno Cienne presbitero capellano ecclesie Sancti
Laurentii et Cardino clerico ecclesie Sancti Laurentii ad hec vocatis in ecclesia SMN.
Pateat omnibus evidenter tenore presentis publici documenti quod religiosus vir fr. Cencius prior, ut dicituret asseruit idem ipse, ordinis fratrum Predicatorum de Florentia, existens in presentia d. Ambrosii prioris ecclesie Sancti Laurentii de Florentia et mei notarii infrascripti et testium suprascriptorum, dicens et asserensse requisitum de comparendo coram domino potestate et eius iudice sive curia ad iurandum super positionibus adversariorum commissariorum Durantis Fendi de Anchionibus,de quibus commissariis est idem ipse institutus per dictum condam Durantem in eius ultima voluntate, et dicens se nolle facere sacramentum quia sui conscientia et propositumest non facere sacramentum nisi faceret illud in casu fidei, et se velle ipsi fidecomissarie renuntiare potius quam iurare, ideo dicte comissarie renuntiat ac repudiavit eidem» (ASF, NA 13363 (già M 293, I), f. 77r: 18.XI.1295). Rubrica marginale: "Renuntiationis fr. Centii prioris comiiss(arrii)".
Gli altri tre commissari, fr. Filippo OFM guardiano di Santa Croce, Ambrogio priore di San Lorenzo e Ghita vedova di Durante, curano le pendenze ereditarie di Durante: ASF, NA 2962 (già B 1948), f. 35r-v (161.1298).
Cencio rifiuta giuramento su matera non di fede, richiesto da autorità civili: vedi PIETRO LOMBARDO, Sententiae III, 39 de periurio, ed. Grottaferrata 1971, II, 218-27, con indicazione di relative fonti bibliche e canoniche; TOMMASO D'AQ., Summa theol. II- II, q. 89 de iuramento.
CG Strasburgo 1296: «In isto capitulo fuit diffinitor fr. Cintius», senza titolo priorale (Cr Ro 115). Cencio muore di ritorno dal CG Marsiglia 1300 (MOPH III, 310/15-17).
1 marzo 1299 Paolo dei Pilastri da Firenze«In Dei nomine, amen. Millesimo ducentesimo nonagesimo
octavo, indictione duodecima, die kalendis martii. Fr. Cambius de Florentia ordinis fratrum Predicatorum in presentia mei Rustici notarii et testium infrascriptorum fuit confessus se recepisse et habuisse libras viginti lucanorum parvorum quas venerabilis pater d. frater Tedericus condam existens cerviensis in suo testamento eidem fr. Cambio legavit, et de licentia et consensu fr. Pauli prioris fratrum ordinis Predicatorum florentini conventus promisit michi Rustico notario subscripto stipulanti et recipienti pro omnibus quorum interest... Actum Florentie in sacristia ecclesie SMN, testibus fr. Pace Gualteronis et fr. Dominico Ianiani ambo ordinis Predicatorum» (ASL, Dipl. S. Romano 1.III.1299).
Paolo del fu Gualduccio dei Pilastri († 1314) «fuit prior in conventu florentino, et pluries ibidem supprior» (Cr SMN n° 213). Nelle fonti fiorentine de Pilestris scambia indifferentemente con de Pilastris. In settembre 1298/7 era stato priore in Pisa (Cr Ps ed. p. 485 n. 151).
CP Pistoia settembre 1299: il priore fiorentino è assolto dalla carica (ACP 131/16-20; per la data di convocazione di CP 1299 cf. MASETTI, Monumenta II, 269). Fr.Domenico dei Rimaldelli «sottopriore dei frati, del capitolo e convento di SMN» (ASF, SMN 8.X.1299). Nella licenza data dal vescovo fiorentino all’acquisto di taluni terreni nel popolo di San Paolo, il priore è innominato (ASF, SMN 25.IX.1299); nella transazione il convento è poi rappresentato dal «sottopriore e vicario» fr. Domenico dei Rimaldelli (ASF, SMN 4.XI.1299).
Liber recordationum novus (1365-1400 ca.), ASMN I.A.3, f. 2v: «Anno Domini Mcclxxxxviij° fr. Ubertinus filius olimdomini Adinghi de Adinghis existens prior conventus florentini OP…». Ma l’anonomo compilatore del secondo Trecento tradisce confusione di date (o di persone) quando scrive: «postea vero eodem anno fr. Munio magister ordinis...» (Necr. II, 421; dove si corregga MCCLXXXXVIIII in Mcclxxxxviij°). Munio da Zamora era
stato maestro dell’ordine dal 1285 al 1291. L’Orlandi non sembra aver notato l’incongruenza, e dunque l’inattendibilità della fonte (Necr. I, 267 e nota 8, 376 e n. 13). Cr SMN inoltre dice espressamente che fr.Ubertino degli Ardinghi era stato priore fiorentino tre volte (v. sopra esponente 2.X.1276), e tre priorati il nostro elenco documenta: 1276-77, 1282-83, 1293.
7 febbraio 1300 Simone dei Salterelli da Firenze«Actum Florentie in capitulo fratrum ecclesie SMN,
presentibus testibus fr. Symone Salterelli priore, fr. Riccholdo Beliocti, fr. Paulo de Pilastris, fr. Dominico, fr. Gratia Florentino dicti conventus, domino Beliocto Berlingherii iudice, Philippo Peruççi et Francisco Guidi populi Sancti Symonis. - Masus, Giottus et Arnoldus, fratres filii condam Arnoldi Peruççii de Florentia» cedono a Cambio di Domenico del popolo San Martino a Vico, sindacoe procuratore del monastero San Iacopo a Ripoli, terreni inSanta Lucia d'Ognissanti e altrove, in tutto staia 69 e panora 4, in permuta con terreno del medesimo monastero sito nel popolo San Marcellino in località detta Ripoli; quest'ultimo confinante «a ij° d. Lapi Salterelli» (ASF, Corporaz. relig. soppr. da Pietro Leop. [=CRS], S. Iacopo a Ripoli 1 n° 60: 7.II.1299).
Simone di Guido dei Salterelli (1281-1342) «fuit etiam prior in conventu florentino» (Cr SMN n° 320). Nessun documento in conferma di quanto in DAVIDSOHN IV, 925: «era stato priore nel 1298». Il CP Orvieto 1300 era stato convocato per il 22 luglio (ACP 135/20-21).
Roma 9.V.1299: «Naldus de Ceparello nepos condam fr. Bernardi de Summofonte [† Roma 17.IV.1299: Cr SMN n° 168] ordinis Predicatorum, affirmans per Deum se esse maiorem XXV annis, confessus fuit et recognovit se in depositum habuisse et recepisse a fr. Symone de Florentia ordinis Predicatorum duodecim florenos auri... Actum Rome apud Sanctam Mariam in Minerva presentibus fr. Petro de Castro et fr. Scangio de Viterbio ordinis Predicatorum cappellanisreverendi d. Iohannis Dei gratia episcopi tuscolani ad hec vocatis testibus et rogatis» (ASF, SMN 9.V.1299).
17 febbraio 1300 <Simone dei Salterelli>«Nigrus dni Iohannis de Platea de Cumis, frater et heres
nobilis viri dni Nicolai de Platea de Cumis olim sui fratris», nomima procuratore Duccio di messer Naso da Firenze, assente, «ad petendum et recipiendum a . . . priore, capituli et conventu fratrum Predicatorum loci de Florentia, quosdam libros legatos quod penes ipsos... olim dns Nicola prefatus deposuit conservando (...). Hec acta fuerunt in provincia Marchie anconitane in castro Montis Ulivi in palatio comunis eiusdem, ubi residet ad presens curia domini Marchionis» (ASF, SMN 17.II.1300). Priore innominato.
In aprile 1301 fr. Simone è lettore a Lucca: «... fr. Opithonem priorem conventus fratrum Predicatorum de Luca etfr. Simonem Saltarelli de Florentia lectorem conventus fratrum Predicatorem de Luca» (ASL, Dipl. S. Romano 6.IV.1301); nel 1302 priore a Pisa (Cr Ro 119).
14 agosto 1301 fr. Tolomeo da LuccaEsecuzione delle volontà testamentarie di Filippo di
Cisti dei Carini, popolo Santa Trinita (ASF, SMN 11.VIII.1301). In calce al medesimo diploma, giunta del 14.VIII.1301: «fr. Bartolomeus de Luca ordinis fratrum Predicatorum necnon prior capituli et conventus fratrum Predicatorum de Florentia... et fr. Aliottus de Ubriachis dicti ordinis» attestano entrata in possesso.
■ Tolomeo di Fiadone dei Fiadoni da Lucca († 1327), completi elementi onomastici. SOPMÆ IV, 318-25.
17 agosto 1301 Tolomeo da Lucca«Ser Paulus Cambii notarius, procurator subexecutor
deputatus... a religiosis viris dno Acçone abbate abbatie Sancte Marie de Florentia et a fr. Alamanno guardiano fratrum Minorum Sancte Crucis et fr. Tholomeo priore fratrum Predicatorum florentini conventus, executoribus - ut dicitur - deputatis olim per dnum Schiactam condam dni
Raynerii Rustichi de Abbatibus», loca terreno lavorativo con casa (ASF, SMN 17.VIII.1301).
■ «dnus Schiatta filius condam d. Bocche filii olim dni Raynerii Rustici de Abbatibus» nel testamento 9.II.1301; sceglie sepoltura in Santa Croce; dei commissari testamentari dà soltanto l’ufficio non il nome (ASF, SMN 9.II.1300).
settembre 1301 Tolomeo da LuccaCP Todi settembre 1301: «Diffinitor capituli generalis
fr. Ptolomeus prior Florentinus» (ACP 142/30); il CP era stato convocato per il 14 settembre (ACP 138/9-10). Supposta la celebrazione del CP 1301 alla data di convocazione, poiché anteriormente a tale data fr. Tolomeo risulta priore fiorentino, il suo priorato inizia con tuttaprobabilità dal mese successivo a CP 1300 convocato per il 22 luglio (ACP 135/20-21).
giugno 1302 Tolomeo da LuccaCG Bologna giugno 1302: «In hoc capitulo fuit diffinitor
fr. Tholomeus Lucanus tunc prior Florentinus» (Cr Ro 117).Il priorato fiorentino di Tolomeo va fino al CP 1302
convocato per il 22 luglio (ACP 142/27-28). In maggio 1303 (CG Besançon 1303) fr. Tolomeo è priore di San Romano di Lucca (MOPH III, 322/9).
5 novembre 1302 Iacopo da SienaSMN 5.XI.1302: «Religiosus et honestus vir fr. Iacobus
de Senis ordinis Predicatorum prior capituli et conventus fratrum Predicatorum florentini conventus, sindicus et procurator religiosi et discreti viri fr. Bernardi de Burdegalia magistri generalis ordinis Predicatorum, ut de procura scriptum est publice per Prosdocimum filium Bianchini cartolarii sacri palatii notarium..., fecit substituit loco sui et posuit fratres Lottum de Septimello presentem et recipientem et Raynerium Cardinalis dicti ordinis et quemlibet in solidum ad omnia et singula facienda procuranda et exercenda que idem prior habuerit inmandatis» (ASF, NA 3140 (già B 2126), f. 84v). Stesso giorno
e luogo: il priore fr. Iacopo da Siena istitutisce suo procuratore e nunzio speciale fr. Lotto da Settimello per muovere azione legale al fine di riscuotere dagli eredi delfu ser Michele del fu ser Iacopo di Ferraguidi quanto da questi donato in lascito «per manus dicti prioris pauperibus et piis locis» (ib. f. 84v).
Il CP Perugia 1302 era stato convocato per il 22 luglio (ACP 142/27-28), il CP Spoleto 1303 per l’8 ottobre (ACP 145/15-17).
29 luglio 1304 Giovanni di Falco d’Oltrarno (Firenze)Monastero San Salvatore a Settimo 29.VII.1304:
«Religiosi et honesti viri dominus donnus Gratia, abbas monasterii Sancti Salvatoris de Septimo cistersiensis ordinis, et fr. Iohannes condam Falchi, prior fratrum Predicatorum florentini conventus, commissarii et executores testamenti et ultime voluntatis olim bone memorie dni Andree filii condam dni Iacobi de Cerreto iudicis...» (ASF, NA 3140 (già B 2126), ff. 135v-136r).
Testamento del giudice messer Andrea del Cerreto ib., ff. 40v-43r (27.VII.1301), dove dei commissari testamentari(ai quali si aggiunge il guardiano dei frati Minori) si dà soltanto l’ufficio non il nome. Il guardiano di Santa Croceaveva rinunciato al commissariato (ASF, NA 3140, f. 136v: 29.VII.1304). Il CP 1304 era stato convocato per il 14 settembre (ACP 148/6-8).
novembre-dicembre 1304 Giovanni di Falco d’Oltrarno11.XI.1304. Il vescovo fiorentino autorizza i frati
dell’ordine della Penitenza a restituire al convento domenicano, e al suo priore fr. Giovanni d’Oltrarno, beni asuo tempo affidati alla loro amministrazione (ASF, SMN 11.XI.1304; Dossier 264-67).
20.XI. 1304. Medesima transazione del documento precedente (ASF, SMN 11.XI.1304, giunta del 20.XI.1304; Dossier 267-74).
23.XI.1304. Il priore «fr. Iohannes Falchi» e il capitolo conventuale fanno procura generale per ricuperare beni del convento (ASF, NA 3141 (già B 2127), ff. 3v-4r).
17.XII.1304. Medesima transazione sotto l’esponente 11.XI.1304 (ASF, SMN 11.XI.1304, giunta del 17.XII.1304; Dossier 274-75).
16 gennaio 1305 Giovanni di Falco d’Oltrarno«dns donnus Gratia abbas monasterii Sancti Salvatoris de
Septimo cistersiensis ordinis et religiosus vir fr. Iohannes Falchi prior fratrum Predicatorum florentini conventus, commissarii testamenti et ultime voluntatis olimbone memorie dni Andree condam dni Iacobi de Cerreto», nominano procuratore per eseguire le ultima volontà del defunto (ASF, NA 3141, f. 7r: 16.I.1304/5).
Monastero San Domenico a Cafaggio, 19.I.1305. Testi «fratre Iohanne Falchi, fr. Lotto de Septimello OP et fr. Mosca condam Cambii de Fondole converso dicti monasterii». Tana del fu Cambio di Falco, nipote di fr. Giovanni d’Oltrarno, si fa monaca («obtulit ac etiam dedicavit se etsua bona omnia mobilia et immobilia») nel monastero domenicano San Domenico nelle mani della priora suor Iacopadei Rimbertini (ASF, NA 3141, f. 7v: 19.I.1304/5).
24 maggio 1305 Giovanni di Falco d’OltrarnoMedesima transazione sotto l’esponente 11.XI.1304 (ASF,
SMN 11.XI.1304, giunta del 24.V.1305; Dossier 275).
29 luglio 1305 Giovanni di Falco d’Oltrarno«Actum apud monasterium Sancti Iacobi de Ripolis de prope
Florentiam, presentibus fratribus Iohanne priore, Guerneriode Vecchiis, Aliotto de Ubriachis et Petro de Florentia ad hec vocatis et rogatis testibus». Monacazione di donna Ravenna, vedova di Borghese di Domenico e figlia del fu Bindo di Boninsegna (ASF, Corporaz. relig. soppr. da Pietro Leop. [=CRS], S. Iacopo a Ripoli 1 n° 70: 29.VII.1305).
Nel CP Rieti settembre 1305 è assolto anche il priore fiorentino, e si stabilisce che i priori assolti non siano rieletti nei medesimi conventi (ACP 154/11-15). Le assoluzioni priorali di CP Siena settembre 1306 sono tronche della lista nominativa (ACP 162/15-17).
20 gennaio 1307 Giovanni di messer Ruggeri dei Tornaquinci da Firenze«Religiosus vir fr. Iohannes de Tornaquinciis prior
fratrum Predicatorum de Florentia, executor seu fidecommissarius testamenti olim conditi per Dinum notariumfilium quondam Gianni de parrochia Sancti Laurentii florentini..., tamquam executor... constituit suum procuratorem verum et legitimum fr. Lottum de Septimello OPad vendendum (...). Actum Florentie apud ecclesiam SMN, presentibus testibus Raynerio Bellondi..., Dominico olim Bindi de Alleis et fr. Petro di Florentia converso fratrum Predicatorum» (ASF, Dipl. S. Iacopo a Ripoli 20.I.1306).
«Frater Iohannes filius olim domini Rogerii de Tornaquincis, sacerdos et predicator. Fuit prior in conventu florentino et in Sancta Sabina», † 1313 (Cr SMN n°207).
31 gennaio 1307 Giovanni dei Tornaquinci«Religiosus vir fr. Lottus de Septimello ordinis
Predicatorum de florentino conventu, procurator religiosi viri domini fr. Iohannis de Tornaquincis prioris fratrum Predicatorum de Florentia executoris seu fideicommissarii testamenti ser Dini filii olim Gianni de populo Sancti Laurentii...» (ASF, CRS, S. Iacopo a Ripoli 1 n° 72: 31.I.1306).
9 febbraio 1307 Giovanni dei Tornaquinci«Cum olim Cosa Capi mercator artis de Calimala,
officialis dicte artis ad locandum possessiones et bona Opere Sancti Iohannis di Florentia, que Opera sub cura et gubernatione dominorum consulum et artis Callismale prout dicitur requiescit, ... locavit et concessit ad affictum ser Dino notario olim Gianni... unum petium terre (...). Hodie coram me Raynerio notario... fr. Lottus de Septimelloordinis Predicatorum... procurator religiosi viri domini fr. Iohannis de Tornaquinciis prioris fratrum Predicatorum de Florentia executoris testamenti dicti ser Dini,... vendidit... » (ASF, Dipl. S. Iacopo a Ripoli 9.II.1306).
29 luglio 1307 Giovanni dei Tornaquinci
SMN 29.VII.1307: alla presenza di fr. Pietro d’Orvieto priore provinciale e di fr. Giovanni dei Tomaquinci priore di SMN, fr. Pace di Gualterone esegue volontà testamentariadi Neri del fu Piero di Guardi (ASF, SMN 29.VII.1307).
Le assoluzioni priorali dei CP Foligno settembre 1307 e Perugia 1308 sono tronche della lista nominativa (ACP 166/7-10; 170/13-14; 171/20-22).
13 marzo 1309 Guarnieri dei Vecchietti da Firenze«dna Ciabe vidua uxor olim Masi d. Ruggerini de
Minerbettis et filia olim Schiatte Ubertini, et dna Lippa pinçochera de vestitis fratrum Predicatorum..., et ser Thomasus rector ecclesie Sancti Miniatis inter Turres et fr. Iohannes filius olim Falchi subprior ordinis fratrum Predicatorum, executores testamenti conditi a dicto Maso», vendono terreni relativi al testamento.
«Item eodem die. Fr. Guernerius filius olim Bernardi de Vecchiis prior, ut asserit, fratrum Predicatorum et executor dicti testamenti... adprobavit et affirmavit dictam venditionem» (ASF, Dipl. S. Domenico del Maglio 13.III.1308).
Fr. Giovanni di Falco d’Oltrarno qui sottopriore di SMN;nel 1307 e 1308 era stato priore di Santa Maria sopra Minerva in Roma (ACP 168/16-17; ASF, NA 3141 (già B 2127), f. 32v: 11.I.1306/7; Cr Ro 118).
1 agosto 1310 Giovanni di Falco d’Oltrarno (Firenze)Perugia, 1.VIII.1310, deposizione giurata di fr. Nicola
di Brunaccio da Perugia, priore perugino, sulla presunta indulgenza concessa da Benedetto XI alla chiesa domenicana di Perugia:
«Item cum ego essem Padue in capitulo generali [1308] rogavi fr. Iohannem de Ultrarno, priorem nunc fratrum Predicatorum de Florentia qui tunc erat sotius diffinitoriscapituli generalis [ACP 168/15-17; Cr Ro 118], quod ipse cumiturus esset Vicentiam (? ? ?) dignaretur domino episcopo vicentino et amore mei ex parte mea rogaret dictum d. Altogradum de indulgentia perusina, que dicitur esse in loco fratrum Predicatorum, manifestare dignaretur; et
gratia mei dictus dominus per predictum fratrem Iohannem, sicut ab ore eius audivi, in hec verba: Dicas fratri Nicolao [quantum?] novi ex parte mea quod indulgentia posita Perusii per d. Benedictum in loco Predicatorum est maxima; sed de ordine verborum domini pape non plene recordor, sed volo conferre cum domino episcopo ferrariensiet domino mantuano qui mecum fuerunt presentes» (ASPg, Corporaz. relig. soppr., S. Domenico, pergam. 25: 1.VIII.1310). La pergamena è lacera in più punti.
Cf. AA. VV., Indulgenza, città, pellegrini. Il caso della perdonanza di San Domenico di Perugia, Perugia (Ministero Beni Culturali, Archivio di Stato di PG) 2001.
Il CP Orvieto 1310 era stato convocato per il 14 settembre (ACP 175/22-23), e poiché in questa data fr. Giovanni d’Oltrarno era già priore fiorentino, il suo priorato deve rimontare a poco dopo CP 1309 convocato per il 14 settembre (ACP 171/28-29).
3 agosto 1310 Giovanni di Falco d’Oltrarno«Religiosa mulier d. Katerina, pinçochera de habitu
fratrum Predicatorum ordinis beati Dominici, filia condam Baldovini del Barone de populo Sancti Michaelis Bertelde morans in populo Sancti Petri Bonconsilii de Florentia,... dedit et donavit libere... religioso viro fr. Iohanni Falchi de Ultrarno priori florentìno conventus fratrum Predicatorum ecclesie SMN, recipienti pro monasterio dominarum Sancti Iacopi de Ripolis,... quendam cultum cum duabus domibus et puteo posit(um) in populo Sancti Petri deMonticellis». Tra condizioni e obblighi: «a die obitus prefate dne Katerine ad unum mensem proxime tunc futurum, dare et solvere fratri Baroni de ordine fratrum Predicatorum, fratri germano huius donatricis,... lib. 100 f. p.» (ASF, CRS, S. Iacopo a Ripoli 3 n° 86: 3.VIII.1310).
28 febbraio 1311 Giovanni di Falco d’OltrarnoMonastero San Iacopo a Ripoli. Dia, moglie di Giovanni
del fu Lapo di Barduccio da Campi e figlia di Avogado degliAvogadi di Porta Rossa, si dona insieme con le figlie Bartolomea e Giovanna al monastero col consenso del marito
Giovanni. «Presentibus ad hec testibus fr. Iohanne Falchi priore florentini conventus fratrum Predicatorum ecclesie SMN, fr. Ricculdo de eodem conventu» (ASF, CRS, S. Iacopo a Ripoli 3 n° 89a: 28.II.1310).
6 marzo 1311 <Giovanni di Falco d’Oltrarno>Religioso viro in Christo nobis carissimo fratri .
. priori fratrum ordinis Predicatorum de Florentia, vel eius vices gerenti, Arnaldus miseratione divina Sancte Marie in Porticu diaconus cardinalis salutem in eo qui est omnium vere salus.
Cum venerabilem patrem fr. Guidonem, Dei gratia ferrariensen episcopum, ab interdicti, suspensionis et excomunicationis sententiis quas incurrerat occasione cuiusdam contunacie sue, auctoritate domini nostri summi pontificis nobis commissa oraculo vive vocis duxerimus obsolvendum iuxta formam ecclesie consuetam, volumus et mandamus quat(inus) coffinos sive cassas cum libris et rebus aliis ad episcopum ipsum et episcopatum suum ferrariensem spectantes, quos et quas penes vos et in conventu vestro reponi et consignari mandavimus, fr. Guidoni ferrariensi episcopo supradicto vel eius fideli nuncio vice sui, quandocumque post receptionem presentium per se vel per alium vos requisiverit, secure tradatis et libere ac plenarie consignetis. In cuius testimonium presentes licteras exinde sibi fieri fecimus et sigilli notri munimine roborari. - Datum Avinione die VI mensis martii, pontificatus domini Clementis pape V anno sexto (ASF, SMN 6.III.1311).
Guido da Montebello o da Vicenza OP, fl. 1290-1332: SOPMÆ II, 78-80; IV, 98.
27 marzo 1311 Giovanni di Falco d’OltrarnoSMN 27.III.1311. Fr. Corrado da Pistoia OP, vescovo di
Fiesole, presiede l'ordinazione generale, celebrata in SMN;testi «fr. Iohanne priore conventus florenini et fr. Scolario Squarcie et fr. Iohanne Pilastris de Florentia dicti ordinis et conventus».
Ordinati al suddiaconato: «fr. Guido de Monte Grossoli, fr. Nicolaus de Soldaneriis de Florentia, fr. Iohannes de Bachannusciis [= Becchenugi] de Florentia, fr. Franciscus Amicini, fr. Iohannes Orlandi, fr. Dominicus Bonagratie, fr. Bartolus de Infangatis», frati domenicani del convento fiorentino; fr. Ambrogio da Pisa "ordinis heremitorum" del convento fiorentino, fr. Paolo da Firenze dell'ordine degliUmiliati del convento fiorentino (Arch. Vescovile di Fiesole, VIII.A.2 Liber ordinationum f. 14v).
marzo-luglio 1311 Giovanni di Falco d’OltrarnoUna lettera non datata di «fr. Iohannes fratrum
ordinis Predicatorum in conventu florentino prior indignus» al cardinal Niccolò da Prato OP raccomanda la causa dei frati nella vertenza col clero fiorentino sul lascito di panni preziosi al convento domenicano fatto infin di vita da messer Betto dei Brunelleschi. La lettera,presumibilmente andata perduta insieme al fondo diplomatico di San Domenico di Prato, fu pubblicata da V.FINESCHI, Supplemento alla vita del cardinale Niccolò da Prato religiosodomenicano, Lucca 1758 (stampato anonimamente), 38-39, a sua volta riprodotta in Necr. II, 423-24. Una trascrizione manoscritta del Fineschi (1754), inviata all'archivio generale dell'ordine OP, è conservata in AGOP XIV lib. A, I, ff. 90 e 93; esemplare con diritto diprecedenza alla stampa 1758 e sua riproduzione Necr. II, 423-24.
Necr. II, 423-2 AGOP XIV lib. A, I, ff. 90 e 93qui nos questium suo modo (II, 423) qui nos questiunt suo modo
qua dicti Clerici sibi deberi (II, 423) quas dicti clerici sibi deberi
Cuius autem auctoritate hoc faciunt, cum... (II, 424)
Cuius autem auctoritate hoc faciant, cum...
debuissent se amicum medium (II, 424)
debuissent saltem se amicum medium
sic prorupte hoc fulgurans tonitruum produxerunt (II, 424)
sic prorupte tonitruum hoc fulgurans produxerunt
La lettera suppone la morte di Betto dei Brunelleschi (†8.III.1311) e suppone l’emanazione delle ordinazioni del clero contro i frati: «... contra nos ordinationes mirabiles et indebitas fulminantes. Statuerunt enim per omnes clericos tam in civitate quam extra sub certa pecuniaria pena, quod nullus clericus vel sacerdos nobis elemosinam tribuat, nec ad hospitium vel comestionem recipiat, nec ad predicationem invitet nec patiatur nos in sua ecclesia predicare; quod etiam dehonestius est, predicatione maioris ecclesie in vesperis singulis diebus dominicis nos privarunt, quam a LX annis notorium est nos absque molestia libere ac continue habuisse; superaddentes etiam quod nullus fratrum nostrorum audeat eorum ecclesiam introire» (AGOP XIV lib. A, I, f. 93r; cf. Necr. II, 424). Questo brano riassume puntualmente le ordinazioni del clerocontro i frati, emanate «anno Domini 1310/1 de mense martii» come riferite nella lettera di Ruggeri da Casole OPvescovo di Siena delegato sulla lite (ASF, SMN 16.IV.1311). Il 31 luglio 1311 la lite era ricomposta, testimonia il sermone De pace IX di Remigio dei Girolami (MD1985, 195-98). La lettera di Giovanni è presumibilmente di poco posteriore allo scoppio della lite e alle sanzioni di marzo 1311.
■ Lista completa dei documenti del fondo diplomatico relativi alla lite: ASF, SMN 14.III.1310/1; 15.III.1310/1; 22.III.1310/1 (in FINESCHI 334-35 si corregga l’anno MCCCXII in «MCCCX» e conseguentemente in Necr. I, 311 n. 15); 16.IV.1311; 19.IV.1311; 21.IV.1311; 1.V.1311; 18.V.1311; 10.VI.1311 a quaderno; 15.VI.1311 a quaderno; 23.VI.1311 a quaderno.
10 maggio 1311 Giovanni di Falco d’OltrarnoCapitolo SMN. «Religiosus vir fr. Iohannes Falchi de
ordine Predicatorum prior fratrum capituli et conventus florentini» e frati capitolari nonominano fr. Iacopo Ghezzoda Siena, lettore del convento fiorentino, fr. Riccoldo da Monte di Croce e il giudice messer Ugolino di Cardinale deiTornaquinci procuratori nella lite tra frati OP e clero
secolare fiorentino (ASF, SMN 10.VI.1311 a quaderno, ff. 7v-8r).
3 luglio 1311 Giovanni di Falco d’OltrarnoCapitolo SMN. «Fr. Iohannes Falchi de ordine
Predicatorum prior fratrum capituli et conventus florentini» e frati capitolari nonominano ser Cello di Peruzzo procuratore nella lite col clero presso il vescovo fiorentino, arbitri della causa, podestà e capitano di Firenze (ASF, SMN 10.VI.1311 a quaderno, ff. 14v-15v).
Nella lista dei priori assolti dall’ufficio nei CP Viterbo settembre 1311, Orvieto settembre 1313, Siena 1314,non compare quello fiorentino (ACP 181/9-12; 188/4-11; 191/30-33); nessuna lista d’assoluzione in CP Lucca settembre 1312. Il 6.XII.1313 fr. Giovanni d’Oltrarno appare come sottopriore e vicario del priore (ASF, NA 11484(già L 76), f. 90r).
Il testo della Cronica (Necr. I, 38 n° 224) va letto: «Fr. Iohannes de Ultra Arnum sacerdos et predicator, vir magne religionis et discretionis ac ordinis sui çelator et promotor precipuus, in rebus tam agendis quam consulendis admodum providus et circumspectus, in procurandis etiam temporalibus rebus quam plurimum sollicitus et gratiosus».
24 luglio 1312 Ricovero di Iacopino da Guardavalle (Siena)«Cum Iohannes filius condam Lapi Barduccii populi Sancti
Michaelis Bertelde de Florentia, nunc autem frater IohannesBarduccii vocatur ord. fratrum Predicatorum, vendiderit iure proprio Bartolo filio Iohannis Bartoli quandam petiam terram... pro pretio 112 flor(inorum)..., et promisit predictus Bartolus emptor predicto Iohanni venditori... predictam terram revendere et tradere predicto pretio infraduos annos..., predictus Bartolus filius Iohannis Bartoli... vendidit... fr. Iohanni de Ultra Arnum filio olim Falchi ord. fratrum Predicatorum de Florentia ementi... de mandato voluntate et assensu predicti fr. Iohannis Barduccii ex licentia et de licentia fr. Recuperitunc prioris ipsorum fratrum et conventus florentini,
predictam petiam terre aratorie, executorio nomine Falcuccii germani predicti fr. Iohannis de Ultra Arnum, cuius testamenti predictus fr. Iohannes est relictus executor et etiam sindacario nomine pro conventu,... pro pretio 112 aurorum… - Actum Florentie in populo Sancte Lucie de Humiliatis, presentibus testibus... fratribus Latino, Aliotto, Burgense converso et Iohanne Barducci ord.fratrum Predicatorum» (ASF, SMN 17.VIII.1310, quarta pergamena del rotolo)
Altra transazione, medesimo giorno e luogo: donna Dina, vedova di Lapo di Barduccio, vende altro terreno a fr. Giovanni d’Oltrarno in esecuzione del testamento di Falcuccio suo fratello germano. «Que omnia et singula suprascripta fecit composuit tractavit et ordinavit dictus fr. Iohannes de consensu et licentia fr. Recuperi Senensis ord. fratrum Predicatorum tunc sui prioris et conventus florentini dictorum fratrum. - Ego fr. Finus ord. fratrum Predicatorum, condam Baldi de Barberino, imperiali autoritate notarius, predicta omnia coram me acta, de consensu et volutate prioris tunc dictorum fratrum et mei, rogatus publice scripsi et publicavi» (ASF, SMN 17.VIII.1310, quarta pergamena del rotolo).
Fr. Giovanni di Lapo dei Barducci, originario di Campi Bisenzio, del pp fiorentino San Michele Bertelde, OP 1310, † Prato 1333: Cr SMN n° 271.
Fr. Fino di Baldo da Barberino, notaio, OP 1300, †1333: Cr SMN n° 269.
Per il priore fr. Ricovero vedi SOPMÆ IV, 257-58.
agosto 1315 Tramo dei Monaldeschi da OrvietoCP Arezzo agosto 1315: «Facimus predicatores generales:
fratres Tramum Urbevetanum priorem Florentinum...» (ACP 198/13-14). Il CP 1315 era stato convocato per la festa di san Domenico, allora celebrata il 5 agosto (ACP 193/3-5); nella lista delle assoluzioni dei priori è assente quello fiorentino (ACP 195-96).
1 luglio 1316 Tramo dei Monaldeschi
SMN 1.VII.1316: «Fr. Tramus de Monaldeschis de Urbeveteri prior florentinus» dà licenza a fr. Caro di messer Iacopo di Belloccio d’eseguire volontà testamentariadella fu donna Letizia, madre del mdesimo fr. Caro (ASF, NA3142 (già B 2128), ff. 21v-22v).
Il testamento di donna Letizia in ASF, NA 3142, f. 11r-v (22.IV.1316), e in ASF, SMN 22.IV.1316, qui con giunta dell’esecuzione testamentaria del 1.VII.1316.
16 luglio 1316 Tramo dei MonaldeschiIl priore fr. Tramo dei Monaldeschi e frati capitolari
di SMN danno licenza a fr. Giovanni del fu Adimari di Rota dei Becchenugi di riscuotere da eredità paterna; «et specialiter ad accusandum et denuntiandum dominam Ravennam,que domina Venna vocatur, filiam condam magistri Rinaldi Leggerii populi SMN..., maxime de iniuria violentia et turbatione per dictam dominam Ravennam... commissis contra dictum capitulum et conventum in bonis et de bonis devolutis» al convento in quanto beni ereditari spettanti al detto fr. Giovanni, siti nel popolo SMN e altrove (ASF, NA 3142, ff. 23v-24v).
«Fr. Tramus domini Corradi de Monaldensibus dum esset insua iuventute lector urbevetanus, fuit primo factus prior florentinus et postmodum prior urbevetanus et perusinus» (Cr Ov ed. 123). Il padre di fr. Tramo, messer Corrado, era stato difensore e capitano di Firenze durante la podesteriad’Ugolino da Correggio (ASF, NA 2963 (già B 1949), f. 24r: 19.XI.1299). Orvieto 3.III.1307: «Nobiles viri et potentes silicet Mannus et ser Citta, filii condam d. Corradi d. Hermanni de Monaldensibus, pro se et Berardo eorum fratre et Vannutio filio Petri d. Aldrebandutii,... ex succexione d. Oduline, matris predictorum Manni, Berardi et Citte, et d. Ranaldesce matris ipsius Vannutii, que fuerunt filie nobilis viri d. Berardi condam d. Petti Ranaldi» (APR, Dipl.3.III.1307).
CP Perugia 1316: tra i priori assolti anche quello fiorentino; si stabilisce inoltre che i priori assolti non siano rieletti al medesimo ufficio nei medesimi conventi
(ACP 200/4-7). CP Anagni settembre 1317: nella lista dei priori assolti, che sembra data integralmente, non è presente quello fiorentino (ACP 203/26-30).
9 luglio 1318 Angelo da TivoliMonastero San Iacopo a Ripoli, monacazione di Bandecca
chiamata suor Mattea, e di Tinga chiamata suor Filippa, figlie di Lapo Alfani del popolo San Michele dei Visdomini.«Actum apud dictum monasterium presentibus testibus fr. Agnolo de Tibure priore fratrum Predicatorum SMN de Florentia et fr. Bene . . de populo Sancti Florentie, fr. Iohanne Aldobrandini et fr. Bartolo de Foraboschis de ord. fratrum Predicatorum predictorum ac fr. Lapo Martini converso prediciti ordinis et fratrum ad hec vocatis» (ASF,Corporaz. relig. soppr. da Pietro Leop. [=CRS], S. Iacopo a Ripoli 3 n° 113a; anche ib. n° 113b del medesimo giorno).
Nella lista dei priori assolti in CP Firenze settembre 1318 non compare quello fiorentino (ACP 206/5-9).
Angelo da Tivoli studente in filosofia naturale a Perugia 1295, assegnato allo studio parigino 1301, a Tivoliin febbraio 1304, lettore sentenziario a Firenze 1305, predicatore generale 1311, lettore a Perugia 1313, † 1322-26. (ACP, 122/5, 141/17, 155/8, 182/23, 188/18; AFP 1967, 206, 237; 1984, 157-58).
18 aprile 1319 Angelo da TivoliVicende dell’eredità di Neri di Piero di Guardi: «Item
quod in anno Domini MCCC°XVIIII°, indictione secunda, die XVIII mensis aprelis, dominus fr. Angelus de Tibure prior conventus Florentie fratrum Predicatorum SMN et domina Ghita predicta, non obstante quod dictus fr. Pace debitum humane carnis exsolverit et quod dictus guardianus fratrum Minorum per inibitionem constitutionum papalium dicatur se non posse intromictere..., volentes in parte tunc exequi indicta esecutione contenta, ad instantiam et rogatum dicte domine Guardine et ibiden present(is)..., declaraverunt fore pauperes Christi fratres Predicatorum de dicto conventu Florentie ecclesie SMN» (ASF, Corporaz. relig. soppr. dalgov. fr. 102 n° 105, f. 12v).
24 dicembre 1319 Tancredi dei Beccari da OrvietoChiesa SMN 24.XII.1319, testi «fr. Iohanne Falchi, fr.
Uberto de Querciuola, fr. Lotterio de Ubaldinis, fr. Gratiaet fr. Ardingo de Ardingis». «Pateat quod infrascripte domine de Penitentia, que pinzochere vulgariter appellantur, de ordine sive habitu fratrum Predicatorum, constitute in presentia mei Uguiccionis notarii, (...) solitam regulam resumpserunt refecerunt et reformaverunt dicentes se velle ipsam observare et ad illam observandam teneri sicut hattenus tenebantur, necnon renuntiationem ipsius regule olim per eas vel aliquas earum factam, scriptam per ser Feum Lapi notarium, voluerunt esse cassam et nullius valoris et pro non facta haberi et teneri. Quarum dominarum hec sunt nomina»: segue lista nominale di 145 donne dell’ordine della Penitenza dell’abito dei frati Predicatori (ASF, NA 3143 (già B 2129), ff. 15v-16v).
Subito dopo, medesimi luogo giorno e testi: «Fr. Tancredi de Urbeveteri prior fratrum capituli et conventus Florentie ordinis Predicatorum dixit et protestatus fuit quod in officio et negotio seu regimine dictarum dominarum se intromictere intendit in quantum non sit contra ius et constitutiones fratrum predictorum, aliter non» (ib. f. 16v).
Nel CP Firenze 1318 fr. Tancredi risulta priore in SantaMaria sopra Minerva di Roma (ACP 215/31-32).
«Fr. Tancredus de Becchariis... fuit prior urbevetanus, romanus in utroque conventu in Urbe, quam etiam Florentie» (Cr Ov ed. 115).
4 agosto 1321 Tancredi da OrvietoChiesa SMN 4.VIII.1321: «fr. Tancredus de Urbeveterio de
ordine Predicatorum prior fratrum capituli et conventus Florentie dicti ordinis» (ASF, NA 3143, f. 60v); segue lacuna in bianco, senza indicazione alcuna del negozio legale. Rubrica al margine sinistro: «delegatio abbatis Sancti Pancratii». Una cedola (bozza di redazione notarile)è annessa alla carta del registro notarile e rilegata al dorso del fascicolo. Dice: «fr. Tancredus... [come sopra]
impeditus etc. commisit voces et vices suas quas habet ex commissione sibi facta a summo pontifice in questione illorum de Cerreto in quantum potest etc. (? ?) in nullum sibi postea preiudicium gravetur in dominum abbatem monasterii Sancti Pancratii de Florentia ».
In ASF, NA 3143, f. 38r-v, 30 ottobre «pontificatus Iohannis pape XXII anno iiij°. Iacobus et Iohannes clerici florentini», figli emancipati di Niccolò [di Marito di messer Iacopo] del Cerreto, nominano procuratori «ad impetrandum a domino nostro papa... licteras... gratiam veliustitiam continentes»; e ib. NA 3143, f. 57r (7.III.1320/1)i medesimi nominano procuratore loro padre Niccolò «ad presentandum licteras domino preposito florentino».
5 novembre 1321 Tancredi da OrvietoCapitolo SMN 5.XI.1321: «fr. Tancredi de Urbeveteri de
ordine Predicatorum prior fratrum capituli et conventus Florentie eiusdem ordinis» e frati capitolari nominano procuratore fr. Ranieri degli Scolari per vendere talune proprietà appartenenti all'ospizio di San Casciano, proprietà del covento fiorentino; seguono lunghe formule diprocura a tutti gli atti legali inerenti alla transazione (ASF, NA 3143, ff. 69r-70v).
30 dicembre 1321 Tancredi da OrvietoCapitolo SMN 30.XII.1321: «fr. Tancredi de Urbeveteri
ordinis Predicatorum prior capituli et conventus Florentie»e frati capitolari nominano procuratori per acquistare mutuo di fiorini d'oro 500 (ASF, NA 3143, ff. 76v-78r); pertrattare questioni di proprietà relative agli ospizi di Figline e San Casciano, nonché al casolare del fu messer Gualtieri da Ganghereto (ib. ff. 78r-79r).
20 marzo 1322 Tancredi da OrvietoCapitolo SMN 20.III.1321/2: fr. Giovanni di Bindo da
Campiglia OP del distretto di Pisa, asserendo «se maiorem 14 annis esse et ipsam etatem excessisse et esse quasi etatis 15 annorum, fecit professionem in dicto ordine in manibus fratris Tancredi de Urbeveteri prioris fratrum
Predicatorum dicti conventus Florentie in hac forma et sub hiis verbis: Ego fr. Iohannes facio professionem et promicto obbedientiam Deo et beate Marie et beato Dominico et tibi fratri Tancredo priori conventus Florentie, vice fratris Hervei magistri ordinis Predicatorum et successorumeius, secundum regulam beati Augustini et institutiones ordinis fratrum Predicatorum quod ero obediens tibi tuisquesuccessoribus usque ad mortem. Rogans me Uguiccionem notarium quod de predictis conficiam publicum instrumentum»(ASF, NA 3143 (già B 2129), f. 89r).
Cf. A.H. THOMAS, La profession religieuse des Dominicains. Formule,cérémonies, histoire, AFP 39 (1969) 5-52. S. TUGWELL, Dominican Profession in the thirteenth century, AFP 53 (1983) 5-52. AFP 54 (1984) 31-33.
16 aprile 1325 Niccolò di Tello da SignaVicende dell’eredità di Neri di Piero di Guardi: «Die
vero presenti [16.IV.1325], cum dicta domina Guardina mortua sit iam sunt duo menses,... et volentes fr. Niccholaus prior dicti conventus fratrum predictorum de Florentia et domina Ghita ea omnia sicud debent» in conformità alla volontà della donatrice, procedono alla vendita e alla distribuzione del ricavato (ASF, Corporaz. relig. soppr. dal gov. fr. 102 n° 105, f. 13r; la data è a inizio dell’atto, f. 12r: «MCCCXXV, indictione 8a, die XVI aprelis»).
Fr. Niccolò di Tello da Signa (1286-1330) «fuit prior florentinus, aretinus et etiam eugubinus» (Cr SMN n° 259; poco oltre: «in orationibus assiduus, in quibus lacrimis perfundebatur», non «in orationibus assiduus ingentibus lacrimis perfundebatur» di ed.).
3 agosto 1325 Niccolò da SignaVicende dell’eredità di Neri di Piero di Guardi:
«MCCCXXV, indictione 8a, die III augusti. Cum ex forma distributionis dudum facte per fr. Niccholaum nunc priorem capituli et conventus fratrum Predicatorum de Florentia et d. Ghitam, fìliam olim d. Guardine uxoris olim d.
Cardinalis de Tornaquincis, viduam uxorem olim Branche de Scalis...» (ASF, CRS, 102 n° 105, f. 13v).
Priorati dalla data sconosciuta
Iacopo Rubaconte del Casentino († ante 1279): «fuit prior florentinus» (Cr SMN n° 8).
Ottavante dei Nerli († ante 1279): «fuit prior in conventu florentino» (Cr SMN n° 10).
Gherardo del popolo SMN (1234-1288): «fuit prior florentinus et in pluribus conventibus» (Cr SMN n° 140); ma quanto incorsivo è giunta tardiva. Le due date croniche, qui e in seguito, indicano entrata in religione e decesso.
Iacopo da Monte Carelli (1264-1289): «fuit pluries supprioret prior florentinus, et existens prior in conventu urbevetano, ubi gratiosus erat, obiit ibidem M°CC°LXXXIX°» (Cr SMN n° 144); quanto in corsivo è giunta interlineare tardiva.
Nevaldo da Petroio (1270-1296): «prior et etiam supprior inconventu florentino» (Cr SMN n° 158).
Remigio dei Girolami (1267-1319): «fuit... prior florentinus» (Cr SMN n° 220).
Riccoldo da Monte di Croce (1267-1320): «Florentie,ubi prior et supprior fuerat,... ad requiempertransivit» (Cr SMN n° 222). Nel 1316, comevuole Necr. I, 315, II, 603, non v’è posto per ilpriorato di Riccoldo, tanto più che in quel medesimo annoil CP lo punisce rimovendolo dal convento fiorentino e privandolo per un anno d’ogni diritto attivo e passivo nelle elezioni (ACP 200/9-20).
Nicola di Brunaccio da Perugia (1255-1322): «fuit lector...florentinus in studio generali legens ibidem annis tribus... Fuit nichilominus prior pistoriensis, perusinus, urbevetanus et florentinus» (Cr Pg ff. 37v-38r).
Ambrogio dei Rinuccini († 1334): «Fuit... prior in conventibus florentino, lucano...» (Cr SMN n° 272). Sarebbe stato priore, secondo Necr. I, 343, II, 603, nel 1320 fino al 1323. Senza titolo di priore appare in una transazione conventuale del 16.III.1321 (ASF, NA 3143 (già B 2129), f. 57v: 16.III.1320/1) e - per ironia dellasorte - il 5.XI.1321 è tra i frati capitolari convocati dal priore Tancredi da Orvieto (ASF, NA 3143, ff. 69r-70v).
ANTONIO PANELLA, Storia di Firenze, Firenze 1984 (la ed. Firenze 1949), p. 40, parla di fr. Ruggeri dei Calcagni († 1250-60 ca.): «priore di S. Maria Novella»; l’autore deve aver contaminato l’ufficio inquisitoriale con quello priorale. Nessuna testimonianza d’un priorato fiorentino di fr. Ruggeri (Cr SMN n° 14; AFP 54 (1984) 263-64).
finis!
http://www.e-theca.net/emiliopanella/governo/priori.htmhttp://archivio.smn.it/emiliopanella/governo/priori.htm