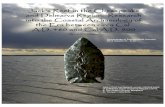Remigiana: note biografiche e filologiche, «Memorie domenicane» 13 (1982) 366-421. Due parti: una...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Remigiana: note biografiche e filologiche, «Memorie domenicane» 13 (1982) 366-421. Due parti: una...
Remigiana: note biografiche e filologiche,
«Memorie domenicane» 13 (1982) 366-421.
Premessa: edizione integrale (1981) del Contra falsos di Remigio dei Girolami
I Note biografiche e codicologiche, pp. 366-82
1 Lettorati di fra Remigio deiGirolami 7 Riordinamento, trascrizione,
sistemi di rinvio
2 Datazione del Contra falsos 8 Remigio non ha venduto codici dei propri scritti
3 Un attacco a Giovanni da Parigi? No 9 Codice dei trattati C 4.940:
datazione4 La decretale Quod olim 10 Copista A senza nome
5 Rapporti tra Distinctiones e Contra falsos 11 Cronista di Remigio non è fra Scolaio di Squarcia
6 Nota di possesso librario «Conventus SMN» 12 Quel che la cronaca dice
II Questioni filologiche e ricognizione delle edizioni, pp. 382-421
13 Corretto non equivale ad autentico | libri biblici
14 Grafia, parte integrante del sistema linguistico | oh epèntesi! e oggi?
15 Impasto mediolatino/volgare fiorentino | Moffla/Ghant | Vulgata biblica16 Caratteristiche grafologiche di Remigio | A-L, M-Z
17Taluni lessemi | actor | auctoritas | Britannia | cathetiçare |Huguiccio | Iesus | li | quadruvium |
18 Ricognizione delle edizioni
- Contra falsos, ed. Tamburini- De bono comuni, ed. De Matteis, ►ed. EP- De bono pacis, ed. De Matteis, ►ed. EP- De iustitia, ed. Capitani- De peccato usure, ed. Capitani- De subiecto theologie, ed.Panella
- De uno esse in Christo, ed. Grabmann- Distinctiones, ed. Panella- Divisio scientie, ed. Panella- De duratione monitionum, ed. Panella- Tabula, ed. Cavigioli-Imbach- Venditio ad terminum, ed. Capitani
Premessa
A distanza di appena due anni dal nostro Per lo studio di fra Remigio dei Girolami (†1319), Pistoia 1979 [= Studio d’ora in poi], dove si dava l’edizione critica dei cc. 5-37 del Contra falsos ecclesie professores, Filippo Tamburini ha pubblicato integralmente il grosso trattato del domenicano fiorentino: FRA REMIGIO DEI GIROLAMI O.P., Contra falsos ecclesie professores, edizione critica di F. Tamburini, prefazione di Charles Till Davis, Roma (Pontificia Università Lateranense, «Utrumque Ius» 6) 1981. La Prefazione del Davis (pp. III-XX), l’Introduzione (XXI-LVI)e il testo del Contra falsos (1-292) curati dal Tamburini costituiscono un notevole contributo agli studi su Remigio dei Girolami.
Il volume è centrato sull’importante trattato Contra falsos, contenuto in 169 colonne di fitta e abbreviatissima scrittura gotico-libraria di BNF, Conv. soppr. C 4.940. Disporre del testo integrale di tale opera in un’edizione scrupolosa nella cura del testo e ricca nella ricerca dellefonti significa poter far conto su una preziosa acquisizione nello studio di Remigio, la cui vasta produzione (ancora prevalentemente inedita), la lunga
carriera letteraria, la peculiare forma della traditio textus presentano delicati problemi critici ai fini di un’interpretazione d’insieme del ruolo del domenicano fiorentino nella vita cittadina di Firenze tra fine del XIII e inizio del XIV secolo, come dire nei decenni più floridi e più conflittuali della storia tardo-medievale delcomune fiorentino.
Ch. T. Davis - già riconosciuto studioso della cultura fiorentina del Due-Trecento e dello stesso fra Remigio - illustra con equilibrio e pertinenza nella Prefazione i caratteri generali del Contra falsos (d’ispirazione retorico-omiletica e destinato verosimilmente a uso dei confratelli domenicani quale materiale per la predicazione) e puntualizza i problemi connessi con l’interpretazione dellasezione capp. 5-37 sul potere papale, che aveva attirato l’attenzione degli studiosi d’ecclesiologia e teoria politica medievale.
Nell’Introduzione il Tamburini informa con accuratezza dei dati critici di base dei codici remigiani (codici d’autore, scritti nella maggior parte da un copista A, rivisti, corretti e integrati dallo stesso fra Remigio, mano B), delle caratteristiche codicologiche; riassume il dibattito sulla controversa datazione del Contra falsos; discute le fonti letterarie del trattato in questione. Quest’ultimo settore - seppure confinato alle fonti dell’opera pubblicata - costituisce l’apporto specifico delTamburini, anche quando il meticoloso tentativo d’individuare le fonti e di rintracciare la storia dei testi risulta pletorico o remoto dalla probabile fonte diretta di Remigio. Il soggetto - vista la decisiva importanza per fissare termini e interessi culturali di Remigio - merita una ricerca a parte, che rinviamo ad altraoccasione. Annotiamo soltanto che se nell’Introduzione (p. XLVII) il problema era stato prospettato con nettezza metodologica (si tratta «piuttosto di sapere i limiti esatti delle conoscenze dirette, quali le fonti intermedie... e quali le fonti segrete dello scrittore domenicano»); poi l’elenco dal titolo «Fonti letterarie» a
fine volume (pp. 308-341) raccoglie indistintamente sotto un solo indice sia gli autori o opere esplicitamente citatida Remigio sia quelli menzionati in nota dall’editore, ora nell’intento di suggerire una probabile fonte diretta, ora nel descrivere fasi remote - rispetto al dettato di Remigio- della formazione di testi, sia quelli evocati a titolo dicommento o di parallelismo tematico, e dunque anche posteriori a Remigio. Siffatta perequazione della lista «fonti» rende sfocato il proposito di recensire le fonti esplicite, d’individuare tra queste, quando possibile, le dirette dalle indirette, e d’appurare fonti taciute, da mantenere ben distinte da quelle invocate dall’editore a titolo di commento o di ricerca d’ascendenze letterarie nonpertinenti alle fonti probabili d’un autore scolastico del XIII secolo. Meglio sarebbe stato isolare in un indice indipendente le fonti esplicitamente dichiarate dall’autore, ed eventualmente annotare - quando possibile -se lette direttamente o raggiunte tramite fonti taciute.
La presente nota - riconosciuti nel suo insieme gl’indiscussi meriti del volume del Tamburini e traendo profitto da tale contributo - mira a riprendere taluni punti specifici o perché meritevoli di più ampia illustrazione o perché suscettibili di precisazioni o ancora perché capaci di sollecitare ulteriore ricerca. Raccoglierò le annotazioni in due parti, una prevalentemente biografica e codicologica (I), l’altra filologica rivolta al testo e alla scrittura di fra Remigio(II).
I rinvii alla Prefazione del Davis, all’Introduzione delTamburini e al testo del Contra falsos s’intendano sempre del volume summenzionato.
Cod. C, cod. G3, cod. G4, cod. D, cod. E, Postille, rinviano rispettivamente a BNF, Conv. soppr. C 4.940 (opere trattatistiche), G 3.465 (Extractio questionum per alphabetum), G 4.936 (sermonario de tempore et de diversis materiis), D 1.937 (sermonario de sanctis et festis solemnibus), E 7.937 (De modis rerum, contenuto anche in cod. C), Postille super Cantica Biblioteca Laurenziana, Conv. soppr. 516, ff. 221r-266v.
Edizioni (rinvio, secondo il caso, per capitolo e rigo, per pagina e rigo o per numero seriale dei righi):
Contra falsos: ed. F. Tamburini, Roma 1981.De bono comuni: ed. M.C. DE MATTEIS, La «teologia politica
comunale» di Remigio de' Girolami, Bologna 1977, 3-51.De bono pacis: ed. ib. pp. 55-71.De iustitia: ed. O. Capitani, «Bull. Ist. Stor. Ital. per
il M.E.» 72 (1960) 125-28.De peccato usure: ed. O. Capitani, «Studi Medievali» 6/2
(1965) 611-60.De subiecto theologie: ed. E. PANELLA, Il De subiecto theologie
(1297-1299) di Remigio dei Girolami, Milano (Studia Univ. S. Thomaein Urbe 14) 1982, 37-71.
De uno esse in Christo: ed. M. Grabmann, «Estudis Franciscans» 34 (1924) 260-77.
Distinctiones: ed. Studio, pp. 271-83.Divisio scientie: ed. E. Panella, MD 12 (1981) 82-124.Questio de duratione monitionum: ed. E. Panella, AFP 50
(1980) 97-101.Sermoni (d’occasione): ed. G. Salvadori e V. Federici,
in ID., I sermoni d’occasione, le sequenze e i ritmi di Remigio Girolami Fiorentino, Roma 1901 (rinvio per numero seriale dei sermoni).
Venditio ad terminum: ed. O. Capitani, «Bull. Ist. Stor. Ital. per il M.E.» 70 (1958) 343-45.
I - Note biografiche e codicologiche
1. Lettorati di fra Remigio dei Girolami
«Fra Remigio dei Girolami, O.P. taught at S. Maria Novella in Florence for most of the period from about 1273 until a few years before his death there in 1319» (DAVIS, Prefaz. p. III).
Non v’è dubbio che nella biografia del frate fiorentino,Firenze resta il luogo più documentato per quel che concerne l’attività d’insegnamento, di predicazione e d’impegno politico-religioso. A Firenze Remigio inizia il primo lettorato quando ancora semplice diacono; e a Firenzelo si ritrova il 3.VIII.1279 in occasione del sermone in morte di fra Aldobrandino dei Cavalcanti; nel 1286, 1289 e 1293 in qualità di lettore; dal 1293 al 1297, come testimoniato da una serie di sermoni d’occasione fiorentini; da agosto a novembre 1301, da luglio 1307 in poi (ma non tutti gli anni sono positivamente documentati).Si conoscono le permanenze a Parigi in qualità di baccelliere sentenziario a Saint-Jacques (1297/8-1300) e a Perugia quale lettore del convento della città ospitante lacuria romana (1303/4-1305, e forse fino al 1307) (Studio 208ss.; Un’introduzione, MD 1981, 54-56; Nuova cronologia).
Ma credo che ci si debba guardare dall’estendere a Firenze, quasi per tacita convenzione, la presenza di Remigio quando questa non sia esplicitamente attestata. I decenni 1270-80 - ma anche altri periodi - della biografia remigiana sono poco documentati. La mobilità dei lettori tra i conventi della provincia Romana del centro Italia colpisce chiunque scorra gli Atti dei capitoli provinciali del XIII e XIV secolo. Su quale base invocare un’eccezione per fra Remigio? Il cosiddetto «lettorato perpetuo» di Remigio a Firenze, trasmesso fino all’autorevole Necrologio di S. Maria Novella (1955) di Stefano Orlandi, ha all’ofigine un equivoco di lettura dell’articolo che la Cronica di SMN dedica a Remigio, e prende le mosse dalla poco attendibile Vita del beato fra Remigio di Firenze (1731) di Domenico Sandrini O.P. (Vite dei frati di SMN celebri in santità, ASMN I.A.21, p. 193).E molte datazioni in Firenze dei sermoni d’occasione sono viziate da tale premessa; se ne può rintracciare la catena risalendo dall’Orlandi a I. Taurisano a G. Salvadori a V. Fineschi a D. Sandrini.
Stando così le cose e mancando indizi interni, non risulta suffragata da alcuna evidenza l’affermazione che il
trattato Contra falsos sia stato composto «almost certainly inFlorence» (Prefaz. p. IV).
2. Datazione del Contra falsos
E per restare in tema di Contra falsos annotiamo che circala controversa questione della datazione del trattato Tamburini espone diligentemente quanto di comune possesso nella letteratura remigiana, ma non apporta elementi nuovi per collocare il Contra falsos rispetto al pontificato di Bonifacio VIII (1294-1303) e al conflitto con Filippo IV ilBello, e dunque rispetto all’abbondante letteratura canonico-teologica cui il conflitto dette occasione: «In conclusione, l’unico dato sicuro per la datazione del Contrafalsos è il rimando contenuto alla fine del trattato De bono communi» (Introduz. p. XXXVII).
3. Un attacco a Giovanni da Parigi? No
A proposito del «secundum quosdam sue mensure ignaros, presumptione insanos et carnalitate furiosos» (Contra falsos 27, 61-62) si dice in nota che il sottoscritto «pensa che fra Remigio si riferisca in particolare a Giovanni da Parigi († 1306), De potestate regia et papali» (p. 62 n. 61; cf. Prefaz. p. XIX).
Io avevo scritto che «la reazione di Remigio contro chi nega la regalità temporale del Cristo in quanto uomo non può non evocare alla memoria [dello storico] il nome di Giovanni da Parigi» che nel De potestate regia et papali (fine 1302, inizio 1303) aveva perentoriamente negato la regalitàtemporale del Cristo per averla riallacciata non alla natura umana del Verbo incarnato ma all’unione ipostatica (Studio 69); il che non ha nulla a che vedere con la questione se Remigio intendesse riferirsi in particolare alla posizione teologica del confratello Giovanni da Parigi. Tono e lessico del duro attacco di Remigio fanno pensare più a un riferimento a movimenti ereticali e dissidenti che a opposte tesi di uomini di schola. La domanda retorica che pongo in Studio 69 include palesemente
una risposta negativa; dico infatti, contro un’ipotesi di riferimento a Giovanni, che «la negazione della regalità temporale del Cristo era già stata tema costante degli Spirituali e gioachimiti in clima di critica al temporalismo e corruzione della chiesa» (Studio 69). Se cosìnon fosse, avrei dovuto datare il Contra falsos (almeno i cc. 5-37) dopo il De potestate regia et papali (1302-03) di Giovanni;mentre - come informa lo stesso Tamburini a p. XXXIII - inclino a ritenere il Contra falsos anteriore all’Unam sanctam(1302) e allo stesso Liber sextus decretalium (1298).
4. La decretale Quod olim... [= 12 maggio 1304][sopprimi in paragrafo §4 e le sue quattro righe, p.
369; errore mio, non del Tamburini, e me ne scuso!]
5. Rapporti tra Distinctiones c Contra falsos
Si dice nella Prefaz. p. VII: «This larger and more developed homiletic work [Contra falsos] represents, at least in part, an elaboration of distinction collections, a richer and more thematically organized storehouse of allegory than they could provide, just as distinction collections represent an elaboration of the references to the Scriptural appearances of a word provided by verbal concordances»; e in Introduz. p. XXXVI: «Inoltre - e questoci sembra il caso più emblematico - nei cc. 53,1-74; 54,93-109, e 77,49-67, ed anche 81,9-10 del Contra falsos sono riportati ad litteram e sviluppati alcuni lemmi (Arma, Armatos, Arbor) che si leggono nelle Distinctiones di fra Remigio, senza che si faccia alcun riferimento ad esse, benché altrove - ma nei Sermoni - compaiono due rinvii alleDistinctiones sotto i lemmi Sacerdos e Dulcedo». (Annoto che a questi due rimandi di mano B alle Distinctiones segnalati in Studio 264, se ne può aggiungere un terzo, anch’esso di manoB: cod. D, f. 12v, marg. sin.).
L’identificazione e l’edizione delle Distinctiones biblichedi Remigio (Studio 267-83) contribuirà non poco alla conoscenza della tecnica e fonti sia di opere d’ispirazione
omiletica che soprattutto dei sermoni. E la segnalazione ditaluni brani del Contra falsos paralleli alle Distinctiones ne sono una prima prova, oltreché un’eccellente conferma dell’autenficità remigiana delle Distinctiones. Ma quanto si afferma nelle due citazioni surriferite sembra dare per scontata la priorità temporale delle Distinctiones rispetto alContra falsos, visto che - si assume - quest’ultimo utilizza le prime. Ora cod. 516 della Laurenziana, e più precisamente la sezione contenente Postille super Cantica e Distinctiones autografe di Remigio, non offre nessun elemento preciso di datazione, né tale sezione di codice risulta in qualche modo riallacciabile agli anni 1314-16 del riordinamento e trascrizione delle altre opere di Remigio, di cui sono frutto codd. C, G3, G4, D. D’altra parte la collazione tra i testi paralleli nelle Distinctiones e nel Contra falsos non decide la questione se sia quest’ultimo a utilizzare le prime o siano le Distinctiones a rielaborare elementi di distinctiones sparsi nei diversi scritti (specie nei sermonari) di Remigio e quindi anche nel Contra falsos; senza parlare poi di brani di schietto genere letterario didistinctiones che rivendicano piena indipendenza compositiva dalle Distinctiones: così il brano del De via paradisi VII, 41 (cod. C, f. 312rb), dove gli otto membri della distinzione di aqua sono per numero e contenuto diversi dal lemma ‘Aque’ delle Distinctiones (Studio 278-79).
Nel primo testo, Contra falsos 53,1-74, si dice «omnes virtutes generaliter sunt arma habentia septem excellentes conditiones et laudabiles» (53,8-9); sono infatti «arma divina» (Eph. 6,11; Iac. 1,17), «arma fulgida» (Rom. 13,12), «arma potentia vel fortia» (II Cor. 10,4), «arma pretiosa» (II Mach. 11,8), «arma levia» (Mt. 11,30), «arma artificiosa» (Luc. 6,19; I Mach. 14,32), «arma utilia» (Ps.34,2). Il lemma ‘Arma’ delle Distinctiones ha: «virtutes dicuntur arma lucis... 1° propter celestem originem» (Iac. 1,17; Eph. 6,11), 2° propter impassibilitatem (II Mach. 10,29-30), 3° propter levitatem (Iudit 14,2; Mt. 11,30), 4°propter subtilitatem (II Cor. 10,4), 5° propter splendorem (I Mach. 6,39), 6° propter pulcritudinem (II Mach. 11,8),
7° propter hostium excecationem (II Mach. 10,30), 8° propter pretiositatem (Ps. 34,2)» (Studio 280). Sette membrinel primo testo, otto nel secondo. Corrispondenza testuale si dà solo nel primo, quarto e quinto membro del primo testo col primo, ottavo e terzo delle Distinctiones; le autorità bibliche dell’ottavo membro del testo delle Distinctiones sono diverse da quelle del quarto del testo del Contra falsos; gli altri membri sono diversi nel dettato e nelle autorità. I due testi certamente si richiamano, ma non presentano elementi redazionali che decidano della dipendenza dell’uno dall’altro.
Contra falsos 54,95-109 è identico, salvo minuti adattamenti redazionali, al lemma ‘Armatos’ di Distinctiones 362-76, e nessuna collazione testuale ne può stabilire il rapporto di dipendenza. La stessa cosa mi si deve dire dell’altro caso, Contra falsos 77,51-67 dalle evidenti coincidenze testuali (inclusa l’errata citazione «Apoc. ultimo» in luogo di «Eçech. 47» per contaminazione mnemonica) col lemma ‘Arbor’ di Distinctiones 300-22, dove le autorità per ogni membro sono due contro l’una del Contra falsos. Non mi pare pertanto prudente assumere come scontato che le Distinctiones siano state composte prima del Contra falsos.
Interessanti luoghi paralleli si riscontrano tra Contra falsos 63,7-71 e Quolibet II,14 (cod. C, ff. 88vb-89ra). Se iltesto di quest’ultimo corrispondente a Contra falsos 63,7-37 mostra notevoli varianti redazionali e l’inversione d’ordine nella distinzione tra mercatura in senso proprio ein senso improprio, il resto del brano è fondamentalmente identico a Contra falsos 63,38-71, ma con talune varianti redazionali che sembrano migliorare grammaticalmente il relativo brano del Contra falsos; il che farebbe pensare che sia Quolibet II a utilizzare - perfezionandolo - il testo del Contra falsos e non viceversa. Qualora la dettagliata collazione dei due testi confermasse questa prima impressione, il Contra falsos otterrebbe un solido termine ante quem rispetto a Quolibet II, sicuramente datato. Ma la
questione dovrà esser ripresa in occasione dell’edizione dei quodlibeti di Remigio.
Le Distinctiones invece sono legate, per una possibile datazione relativa, alle Postille super Cantica. Come abbiamo ricordato, Postille e Distinctiones sono trasmesse dal Laurenziano 516, rispettivamente ff. 221r-266v e ff. 266v-268v. Si tratta d’un codice composito, e le tre parti che attualmente lo costituiscono (commenti al Cantico di Egidio «de Brago», Enrico da Lexington e Remigio dei Girolami) «furono riunite tardivamente, dato che la segnatura a c. 220v è quattrocentesca» (POMARO, Censimento I, 455), molto probabilmente dopo l’inventario 1489 di fra Tommaso dei Sardi, visto che costui recensisce le opere separatamente (Studio 254). La sezione remigiana del codice (ff. 221r-268v) è costituita da quattro sesterni integri, di cui l’ultimo (ff. 257r-268v) comprende parte finale delle Postille e le Distinctiones della lettera A (con annuncio della lettera B). Nelle prime ci sono interventi autografi dell’autore, le seconde - incomplete - sono tutte autografe. Lo stato paleografico e redazionale delle Distinctiones testimonia una bozza di lavoro; Remigio vi è sorpreso in fase di prima redazione, per lo meno di elaborazione (Studio 268-69). Tale stato di cose non lega indissolubilmente le Distinctiones alla datazione delle Postille? Remigio ha abbozzato le Distinctiones sulle carte dell’ultimo sesterno rimaste in bianco quando le Postille erano state integralmente trascritte; in altre parole, le Distinctiones devono esser posteriori alle Postille.
Mentre i tre rimandi dai sermonari alle Distinctiones sonotutti di mano B, e dunque non implicano alcun termine temporale se non quello della morte di Remigio (1319), il prologo delle Postille è trascritto da mano A anche in cod. G4, ff. 314vb-316ra; il che permette d’inferire che queste ultime erano già state composte dall’autore quando mano A lavorava, tra novembre 1314 e agosto 1315, alla trascrizione di cod. G4. Resta il compito, per chi studieràle Postille, di accertarne il termine post quem.
6. Nota di possesso librario «Conventus SMN»
La nota di possesso «Conventus S. Marie Novelle de Florentia ordinis Predicatorum» in cod. C, ff. 1r e 352/1v,non è «di mano contemporanea», come asserisce Introduz. p. XXII n. 3; essa ricorre in molti altri codici del fondo librario di SMN e fa parte del riordinamento del fondo stesso tra fine ’400 e inizio ’500; è di mano «quattro-cinquecentesca», stima giustamente POMARO, Censimento I, 329e 333 (e nota di possesso della medesima mano ib. nelle tavole fuori testo, Tav. II.2).
Guarda con i tuoi occhi: BNF II.IV.167, f. 78v «Explicit vita beate Villane de Florentia scripta per me fr. Iohannem Karoli de Florentia OP anno Domini 1452 completa die 9 augusti feliciter»; cui segue la nota di possesso librario Conventus S. Marie Novelle de Florentia ordinis Predicatorum
7. Riordinamento, trascrizione, sistemi di rinvio
L’annotazione di mano B (Remigio) in cod. C, f. 231v, mg. d., importante perché testimonia la differenza di persona tra mano A e mano B, dice:
«Hic fuit erratum per scriptorem quia hoc exemplum positum est supra eodem passu» (non eodem parte) (cf. Introduz. XXVII n. 13).La nota è in De via paradisi, II° passu, in riferimento
all’exemplum del giocatore di dadi che stringe un patto coldemonio («Contingit in diocesi... »: f. 231va-b) raccontatoper intero. Il medesimo racconto era stato già trascritto per intero, sempre da mano A, nel medesimo «passu» della medesima opera (il De via paradisi è composto di dieci «passus») a f. 227rb-va. L’incidente, oltre alla ragione detta, è significativo ai fini d’intravvedere lo stato del testo da cui il copista A copiava (ricordiamo che nei codici remigiani non ci sono tracce d’errori d’ecografia o
da dettatura ma solo di copia, pertanto gli amanuensi trascrivevano da un esemplare). A giudicare dal caso or oramenzionato, si deve supporre che l’esemplare da cui il trascrittore A copiava non riportava - almeno per esteso - il testo degli exempla; questi dovevano esser richiamati almargine come promemoria del copista. Nel nostro caso il copista ha trascritto l’exemplum due volte nel «II° passu »del De via paradisi, la seconda volta per errore. Lo testimonia esplicitamente la nota di Remigio: «Hic fuit erratum per scriptorem...». Lo conferma un altro incidente nella medesima opera, cod. C, f. 312ra: il copista annuncianel testo in colonna «Exemplum Tullii in libro V De tuscolanis questionibus, ubi dicit sic», poi lascia più di mezzo rigo in bianco e riprende a scrivere, ma non quanto aveva introdotto con «ubi dicit sic». La lunga citazione dell’exemplum dal De tuscolanis si trova trascritta, sempre da mano A, nel margine inferiore di f. 312r e corre per tutto il margine inferiore di f. 312v; mentre il raccordo tra annuncio «ubi dicit sic» della citazione e seguito del racconto è scritto da mano B nello spazio lasciato in bianco da mano A: «Dyonisius, adulescentulo... ». L’esemplare da cui A copiava annunciava la citazione ma nonriportava il testo dell’exemplum; lo provvede Remigio in fase di trascrizione, ma troppo tardi perché possa essere inserito dal copista nel testo in colonna; costui lo trascrive in calce alla carta.
E lo stato del testo remigiano servito da antigrafo è d’estremo interesse, come si può intuire; sebbene vada subito detto, quanto al valore del testo tramandatoci, che gli attuali codd. C, D, G3, G4, E, della Nazionale di Firenze e cod. 516 della Laurenziana sono codici d’autore: rivisti, corretti, integrati e corredati di rimandi dallo stesso Remigio. Le caratteristiche degli interventi di manoB sono di chi soprintende all’edizione delle proprie opere (cf. Un’introduzione, MD 1981, 29-31). Rispetto ad esse l’editore si trova di fronte all’originale curato dall’autore, non autografo nel testo base, autografo nei numerosi testi di mano B. Il che, se restituisce alle
debite misure il valore dell’antigrafo a noi non pervenuto,non sottrae allo storico la curiosità d’intravvedere la forma dei testi trascritti dai copisti. La cosa sarà in parte possibile quando si potrà disporre d’una notevole massa di opere in edizione critica, dove tutti gl’incidentipaleografici, grafologici e redazionali siano descritti in apparato (e sotto questo aspetto l’edizione del Tamburini èencomiabile). Notiamo il caso di Contra falsos 43,28-30; mano A scrive:
Circa primum nota quod ita sanatur quis per credita, sicut sanatur [segue un intero rigo in bianco, poi a inizio del seguente] oculorumMano B interviene, integra il rigo in bianco e
sostituisce obiectorum a oculorum. Il testo sarà:Circa primum nota quod ita sanatur quis per credita, sicut sanatur oculus infirmus per aspectum viridium et conformium obiectorum.Perché A ha lasciato il rigo in bianco operando una
lacuna all’interno di un’unità significativa della frase? Non era riuscito a interpretare la scrittura (corsiva-personale o di non professionista) dell’esemplare? Oculorumin luogo di obiectorum è da spiegare con un’insufficiente perspicuità grafica tra ocl’orum (oculorum) e ob’orum (obiectorum)?
Per i sermonari, data la natura del testo, gl’incidenti di scrittoio (di copia come d’ordinamento) risultano più frequenti; essi vanno dalla trasposizione alla diplografia alla collocazione d’interi sermoni fuori la debita sezione o rubrica a rimandi topici errati rispetto all’ordine finale dei sermonari ecc. Tali incidenti dovrebbero esser recensiti sistematicamente qualora si volesse far luce sullo stato dei sermoni da cui copiava A. Ma se si dovesse anticipare un’ipotesi di lavoro a partire dai dati di cui già si dispone, sarei più incline a pensare che A non si trovasse a copiare una collezione di sermoni raccolti, ordinati in quaderni già confezionati in codice, ma piuttosto sermoni sciolti, scritti su carte o quaderni
indipendenti, sui quali Remigio aveva segnato le note-guidad’ordinamento delle ricche sezioni dei sermonari. Ma la complessità delle rubriche d’ordinamento e la vastità del materiale (410 carte per il de tempore cod. G4, 406 carte per il de sanctis cod. D, pari a 1.632 pagine!) induceva una notevole media d’errori di copia e d’ordine nel corso dellatrascrizione, per quanto diligente e coscienzioso appaia ilcopista A. Il sermone Aliud cecidit in morte del cardinale Pietro Ispano († Avignone il 20.XII.1310; sepoltura romana 14.II.1311), trascritto per errore tra i sermoni del mercoledì delle Ceneri (cod. G4, f. 50r-v), è soppresso conun va-cat; una nota di mano B indica che il luogo debito è sotto la rubrica dei sermoni funebri nella sezione de diversismateriis, dove in realtà il sermone è fatto trascrivere una seconda volta (cod. G4, ff. 382va-383rb). Nella serie di diciassette sermoni per Tuttisanti, ordinati secondo il testo delle beatitudini del vangelo di Matteo, il sermone XVI (Mt. 5,9) risulta trascritto tra il IX (Mt. 5,2) e il X(Mt. 5,3); una nota di mano B avverte «iste sermo ponatur in loco suo» (cod. D, f . 338vb); e nel luogo che spettava al sermone: «Beati pacifici... Mt. 5[,9]. Require supra eodem post nonum sermonem» (ib. f. 346r, mg. d., mano B). Tra i prologhi sulla sacra scrittura, ordinati nel codice secondo la successione dei libri biblici, quello sui Salmi è trascritto dopo quello sulle Lettere canoniche (cod. G4, ff. 335vb-337ra); mano B avverte che il luogo debito è tra prologo a Giobbe e quello ai Proverbi: «Quere infra post epistolas canonicas» (cod. G4, f. 310r, mg. sup.). E l’elenco degli esempi potrebbe allungarsi, specie per i sermonari (recensione dei sermoni remigiani in J.B. SCHNEYER, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, vol. V, Münster Westfalen 1974, 65-134; Il Repertorio, MD 1980, 634-45). Di qualche sermone di cui è pervenuta una seconda copia si può documentare che fosse trascritto - con tutta probabilità - non dal testo tramandato nelle sillogi curate e edite dall’autore ma da esemplari ad esse anteriori o indipendenti (cf. Il Repertorio 645-50). Taluni rimandi del tipo «vide, require... supra,
infra» scritti nel testo in colonna da mano A sono risultati incongrui all’assetto finale dell’ordinamento deisermonari; così il supra appare cassato o perché il rimando terminava a sermone (talvolta a trattato) trascritto in altro codice o perché il sermone, sia pur nel medesimo sermonario, risulta non supra ma infra (cf. Un’introduzione, MD1981, 64 n. 90). La lista degli articoli dei quodlibeti si trova trascritta non a fine di quest’ultimi (cod. C, ff. 71r-90r) ma dopo il De subiecto theologie a ff. 95vb-96ra; manoB interviene e guida il lettore a rintracciare la tabula più sotto, a fine testo del De subiecto theologie (cod. C, f. 71r, mg. sup.).
D’ordinario i rimandi nei sermonari sono costituiti da due elementi: festa liturgica (secondo il calendario domenicano) e tema del sermone; nella sezione de diversis materiis di cod. G4 la ricorrenza liturgica è sostituita dalla rubrica sotto la quale sono ordinati i sermoni (Il Repertorio, MD 1980, 635-43). Il sistema dispensa da indicazioni topiche, numerali o di foliazione, e risulta altamente funzionale. Centinaia di siffatti rimandi sono disseminati nei due sermonari de tempore e de sanctis; e il facile riscontro conferma la razionalità sia del criterio d’ordinamento che del sistema di consultazione. Ma c’è traccia d’una serie di rimandi con elementi anomali rispetto al sistema suddetto e di cui non saprei suggerire il codice di lettura, a meno che non si debba pensare a notazioni d’ordinamento anteriore alla disposizione ottenuta nella confezione finale dei sermonari. Ecco i casiin cui mi sono imbattuto. Trascrivo i brani strettamente necessari ad intendere l’eventuale significato dei rimandi;inserisco tra parentesi quadre il riscontro quando mi è stato possibile stabilirlo con certezza.
cod. D 1.937In Nativitate Domini, XII: Omnibus omnia factus sum (I
Cor. 9,22). (…) Et primo sui temporalem nativitatem quia factus, Io. 1 «Verbum. caro factum est». Vide supra e(odem) in precedenti sermone de incarnatione [= In Nativit.
Domini, IX: Verbum caro factum est: cod. D, f. 41ra-vb]. Item infra 5 in sermone de nativitate Virginis Bene omnia fecit [= De Nativit. Marie Virg., VIII: Bene omnia fecit: cod. D, ff. 284va-289rb]. Item infra 8 in sermone de dorninica infra octavam Nativitatis Ubi venit plenitudo temporis [= Infra oct. Nativit., I: Ubi venit plenitudo temporis: cod. G4, ff. 12rb-16va]. Item infra f. 6. in sermone de vigilia Natalis Cras faciet Dominus etc. [= De vig. Natalis, V: Cras faciet Dominus: cod. D, ff. 22va-25rb]. (…) Vide infra in sermone de Resurrectione Mane facto [= In die Pasche, V: Mane facto: cod. D, ff. 138vb-141rb]. (…) Vide infra f. X. in sermone Cosme et Damiani Nos reliquimus omnia [= De Cosma et Damiano, I: Nos reliquimus omnia: cod. D, ff. 301vb-306va]. (…) Vide supra e(odem) 7 in sermone de Natali Ecce enim evangeliço [= In Nativit. Domini, VII: Ecce enim evangeliço: cod. D, ff. 39ra-40va] (f. 42rb-va).
In Nativitate Domini, XIV: Ortus est sol (Ps. 103,22).(…) Et certe sol est [Salvator] loquendo
similitudinaliter, quod quidem patet ex tribus. Vide supra f. 6. j. [= In Nativit. Domini, VI: Ortus est sol: cod. D, f. 38va] (f. 43va). (…) Circa secundum nota quod sol calefaciendo frigida inflammat, iuxta illud Eccli. 43 «Sol tripliciter exurens montes». Sic iste. Vide supra f. 6. j. et 7. (…) Vide de omnibus in tractatu de mundo, ubi supra, et f. 6 et 7 (f. 44ra).
In Nativitate Domini, XV: Videamus hoc verbum quod factum est, quod fecit Dominus et ostendit nobis (Luc. 2,15).
Circa puerum natum tanguntur sex, scilicet ipsius visibilitas quia Videamus, singularitas quia hoc, personalitas quia verbum, temporalitas quia quod factum est, supermirabilitas quia quod fecit Dominus, et fructuositas quiaet ostendit nobis. De primo Baruc 2 [3,38] «Post hec in terris visus est» etc. Vide supra f . 6. 9. [= In Nativit. Domini,VI: Ortus est sol: cod. D, ff. 38va-39ra]. De secundo ibidem, «Hic est Deus noster» etc. Vide supra ibidem 8. De tertio IIo. 5 «Tres sunt qui testimonium» etc., supra ibidem 8. De quarto Gal. 4 «Misit Deus filium suum» etc. Vide supra ibidem. De quinto Ierem. 30 [31,22] «Creavit Dominus novurn
super terram» etc., supra ibidem. De sexto Luc. 2 «Natus est nobis hodie Salvator» etc. Ysa. 9 «Parvulus natus est nobis et filius datus est nobis» etc. Vide supra E. 14. 2. et in legendis (f. 44rb; sermone intero).
In Exaltatione Sancte Crucis, I: Ego si exaltatus (Io. 12,32).
[In riferimento alla fede e all’incredulità] Vide supra a. in sermone de beato Mathia Dabitur illi fidei [= De b. Mathia,I: Dabitur illi fidei donum. Sap. 3 d: cod. D, ff. 99va-103ra] (f. 295ra).
cod. G 4.936In Cena Domini, X: Si non lavero te (Io. 13,8).(…) Iuxta illud Ps. [118,136] «Exitus aquarum deduxerunt
oculi mei quia non custodierunt legem tuam» scilicet peccando. Dicit autem septics vel referendo ad septem genera peccatorum etc. Vide supra O. X. 3. (f. 129rb).
Dominica VI, sermo III: Non serviamus peccato (Rom. 6,6).(…) Ex qua scilicet sola scientia habetur cognitio
certissime veritatis, iuxta illud Augustini «Ergo enim fateor caritati tue» etc. Vide supra C. 5. in sermone supertheologiam Radix sapientie [= Prologus IX: Radix sapientie: cod. G4, ff. 289ra-294va] (f. 182rb).
Prologus XII: Sicut protegit sapientia (Eccles. 7,13).[explicit:] per assecutionern sapientie in vita futura
ad quam etc. Vide supra a. 3. 6. (f. 302vb).
Come si vede, oltre ai due elementi abituali dei rimandi(festa liturgica o rubrica+tema) compaiono altre indicazioni, lettere e numeri, che o risultano pletoriche quando accompagnano gli elementi suddetti o restano criptiche ai fini della consultazione quando compaiono da sole. Il numero coincide solo raramente col numero seriale del sermone in casi di più sermoni sotto la medesima rubrica o festa liturgica. La lettera f quando precede un numero potrebbe far pensare a «folio»? Remigio ha usato unavolta questo tipo di rimando in una nota marginale
autografa in cod. G4, f. 392v, mg. sup.: «Prepositus etc. Quere supra in quarto folio» rimanda ai sermoni De prelatis inferioribus episcopo nel medesimo codice, quattro carte sopra (ff. 388vb-389va), dove a sua volta si annota, f. 388v, «Vide infra in quarto folio». E sarebbe così da interpretare «f. 6. j.» del sermone XIV per la Natività Ortus est sol, se il riscontro va trovato nel sermone VI dellamedesima festività e dal medesimo tema? Altrove né lettere né numeri guidano il lettore alla consultazione, cui pure l’autore mirava rinviando con un «vide... ».
Non si potrebbero spiegare queste forme insolite di rimandi per lettera e numeri come residui d’un primo sistema di raccordi tra sermoni sciolti o in quaderni ancora isolati? Si tratterebbe allora di residui rimasti (opassati) nel testo quando i sermoni hanno preso l’ordinamento definitivo nei cieli «de sanctis», «de tempore» e «de diversis materiis» dei sermonari di cod. D ecod. G4; qui, una volta adottati i rimandi per festa liturgica (o rubrica) e tema - sistema economico e razionale nello stesso tempo ai fini della consultazione - qualsiasi riferimento topico e numerale (cui lettere e numeri annuiscono) risultava inutile. Se così stessero le cose, avremmo un’altra spia per intravvedere lo stato del testo dei sermoni prima che questi fossero raccolti, trascritti e ordinati negli attuali sermonari di cod. D e G4. [ipotesi confermata]
E annoto un’ultima curiosità: le parole «C. 5. in sermone super theologiam Radix sapientie» del rimando contenuto nel sermone surriferito «In Cena Domini, X: Si non lavero» sono scritte - in parte su rasura - nel testo in colonna da mano B, lo stesso fra Remigio! Il riscontro col prologo Radix sapientie non è «supra» come vuole il rimando ma«infra», nella rubrica dei prologhi nella sezione de diversis materiis, più di cento carte dopo. Bisogna pensare che raccordi per lettere e numeri fossero ancora utilizzati - al punto che mano B ne inserisce uno nel testo - in fase ditrascrizione dell’enorme mole di sermoni nei nostri due sermonari, prima cioè che i fascicoli delle diverse sezioni
ottenessero l’ordinamento definitivo e fossero rilegati negli attuali codici.
8. Remigio non ha venduto codici dei propri scritti
Per cod. G4 (sermoni de tempore et de diversis materiis) OvidioCapitani aveva a suo tempo avanzato l’ipotesi che si trattasse di «un manoscritto che dipende da un testo di appunti e schemi tracciati in fretta dallo stesso Remigio...» («Bull. Istit. Stor. Ital. per il M.E.» 1960, 106), mentre per la genesi di cod. C (opere trattatistiche)il Capitani ha proposto una diversa ipotesi («Studi Medievali» 1965, 550), che il Tamburini così espone:
Circa la data di composizione dei trattati, il Capitani offre una suggestiva ipotesi. In un primo tempo, cioè tra il 1270 ed il 1314, i trattati sarebbero stati composti dall’autore e scritti singolarmente in codici diversi. Successivamente i singoli trattati furono ricopiati e raccolti insieme in un unico ms., il C 4.940, mentre i codici contenenti i singoli trattati furono venduti per sostenere le spese di costruzione in Firenze d’una casa con annessa la scuola, come scrive fra Remigio nel sermone V ai priori della città, che viene datato appunto tra il 1318-1319. Unico testimone sopravvissuto dei codici contenenti i singoli trattati sarebbe il ms. E 7.938 della BNF, Conv. soppr., scritto da mano diversa da A e che contiene il De modis rerum, trascritto anche nel ms. C 4.940.Secondo questa ipotesi, certamente assai verosimile e ben fondata, il ms. C 4.940 dovette essere composto per l’uso dei frati di SMN e in un periodo di tempo piuttosto breve, dovendo sostituire, riuniti in un solo volume, gli scritti di fra Remigio sparsi in parecchi codici diversi, che dovevano essere venduti (Introduz. p. XXXI; cf. ib. p. 189 n. 25-27).
Lasciando da parte il problema cronologico della composizione delle opere raccolte nella silloge di cod. C (cf. Un’introduzione, MD 1981, 38-66), l’ipotesi
a) suppone che i singoli trattati fossero contenuti in codici indipendenti, scritti e confezionati per poter essere immessi nel mercato librario (editio);
b) suppone che tra i libri venduti in occasione della costruzione della domus e scuola ci fossero anche codici contenenti scritti di Remigio;
c) e suppone infine che le opere di Remigio fossero di quelle assorbibili dal mercato librario della Firenze del tempo.
Ora in che stato fossero i testi remigiani da cui copiavano i copisti di cod. C (se già rifiniti e approntatiper il pubblico o semplicemente in carte o quaderni a uso dell’autore) è proprio il punto che va stabilito; e lo si può fare solo recensendo sistematicamente gl’incidenti di copia di cod. C. Prima d’ipotizzare che tali codici fosserostati venduti, bisogna accertare se siano mai esistiti!
Il testo del sermone Precurre prior (mezzo dicembre 1318, mezzo febbraio 1319: Studio 232) dice: «Unde ego consideransnostrum et etiam comunis bonum et necessitatem, incoavi quandam domum in porta et hucusque perduxi cum venditione librorum nostrorum, super qua adhuc sum» (cod. G4, f. 355v,mg. s.). Il «librorum nostrorum» non costringe a intendere il plurale maiestatico, quando poco prima si era detto «ego... incoavi... perduxi»; e anche altrove Remigio usa d’abitudine il singolare quando parla in prima persona. Il «librorum nostrorum», vista l’istituzione religiosa in cui inserito il ‘frate’ Remigio, ha la sua migliore interpretazione in «libri nostri» cioè «del nostro convento». (L’interpretazione che Remigio vendesse «i suoi libri» risale a FINESCHI, Memorie istoriche che possono servire alle vite degli uomini illustri del convento di S. Maria Novella..., Firenze 1790 178).
Il costo del libro medievale, a confronto con quello d’altri beni di mercato, era estremamente alto a motivo
della pergamena, della confezione e soprattutto del lavoro di copia (cf. C. BOZZOLO - E. ORNATO, Pour une histoire du livre manuscrit au moyen âge, Paris 1980, cc. II-III, pp. 19-52). Nell’Europa latina del XIII e XIV secolo il mercato librario di opere scolastiche era legato principalmente ai centri universitari e ai libri textus: Bibbia, Decreto, Decretali, libri del Corpus iuris civilis e relative Glosse, libri di testo delle diverse facoltà universitarie e commenti dei magistri... (cf. BOZZOLO-ORNATO passim; G. FINK-ERRERA, Une institution du monde médiéval: la pecia, «Revue philosophique de Louvain» 60 (1962) 187-210; ricordo che nei codici remigiani non esistono tracce di trascrizione a ‘pecia’, caratteristica della produzione libraria universitaria); e tali sono i libri che appaiono - e raramente - negli atti notarili della Firenze del tempo (ASF, Notar. antecos.) in transazioni di prestito, pegno, vendita. Mi sembra altamente improbabile, vista la natura del mercato librario del tempo, che vi fossero in Firenze (non vi era ancora, ricordiamo, un’istituzione pubblica universitaria) lettori interessati ad acquistare codici contenenti opere di scuola o trattati omiletici d’un fra Remigio o di chiunque altro fosse. Il caso contrario va provato non supposto.
Si hanno casi di cessione di libri all’interno del convento SMN. Può servire, a scopo orientativo, qualche curiosità sui prezzi nella Firenze del tempo? Poco prima della morte di Remigio dei Girolami, 1319, fra Pietro d’Ubertino degli Strozzi - anch’egli di SMN - acquista da Remigio l’attuale codice BNF, Conv. soppr. A 3.1153, di 323 carte scritte a due colonne; lo paga 3 fiorini quando questo era scambiato con la moneta argentea al valore di lire 3 e soldi 5 (= 65 soldi) (cf. P. KÜNZLE, Prolegomena a BERNARDO DA TRILIA, Quaestiones disputatae de cognitione animae separatae, Berna 1969, 23; POMARO, Censimento I, 344). I 3 fiorini erano pari, in quegli anni, a lire 9,75. Che cosa si comprava a Firenze con tale somma? Dispongo (ASF, Notar. antecos.) di taluni dati anteriori di qualche decennio, ma credo che siano a loro modo significativi. Un bue il
15.X.1294 era stimato lire 15, e il 3.VIII.1298 lire 15,25;una mucca il 3.IX.1295 era stimata lire 15,25 e il 7.IX.1302 lire 13; un’asina il 7.I.1300 era stimata lire 7;carissimo invece il cavallo (usato nelle guerre) che il 2.VIII.1302 è venduto per 58,5 fiorini, pari a lire 146,25;mentre il prezzo d’una pecora si aggirava a 1 lira (anno 1302).
Riassumendo la nostra questione: l’ipotesi Capitani, ripresa dal Tamburini, non risulta né «verosimile» né «ben fondata»: a) non è stato appurato se le opere di Remigio fossero contenute in codici approntati per la pubblicazioneprima d’esser trascritte in cod. C; b) non esistono indizi per asserire che Remigio, per finanziare la costruzione della famosa domus, vendesse codici contenenti propri scritti; c) quel che si sa del mercato librario del tempo edi Firenze in particolare dissuade dall’ipotesi di principio, sollecita semmai la prova del fatto contrario.
9. Codice dei trattati C 4.940: datazione
Cod. G4 composto tra novembre 1314 e agosto 1315: «Da questa datazione ne deriva che il ms. G 4.936, oltre ad essere uno degli ultimi codici di fra Remigio ad esser stato composto, sarebbe anche posteriore al codice dei Trattati C 4.940, poiché vi sono dei precisi rimandi dal primo al secondo manoscritto» (Introduz. p. XXX; corsivo nostro).
Non sappiamo se cod. G4 sia anteriore o posteriore a cod. D, i cui termini di trascrizione sono il 25.V.1314 e il 29.VIII.1316 (se non addirittura il 29.VIII.1315); mentre cod. G4 è anteriore a cod. G3 (Dibattito, AFP 1980, 91-94). I rimandi da cod. G4 a cod. C sono di tale natura che non possono testimoniare priorità/posteriorità temporale della trascrizione dei due codici; si tratta o dirimandi ad opere contenute in cod. C (e allora è la composizione dell’opera non del codice che ottiene un termine ante quem) o di raccordi di consultazione che, come tali, prescindono dalla successione temporale della trascrizione dei codici; in altre parole si possono dare -
e di fatto si danno - rimandi ad opere o sermoni indipendentemente se siano o no già trascritti nel relativocodice o sezione di codice (Un’introduzione, MD 1981, 33-34, 36-38, 62-65). Per il cod. C non è stato possibile finora produrre nessuna prova che fissasse i termini di composizione o che decidesse della priorità/posteriorità rispetto agli altri codici del periodo del riordinamento e trascrizione. Possiamo solo dire che, viste le forti analogie codicologiche (materiale, misure, scrittura), redazionali e di supervisione di mano B tra cod. C e codd. D, G3, G4, la trascrizione della silloge delle opere trattatistiche può essere presumibilmente rimessa al medesimo periodo (1314-16) di trascrizione degli altri tre codici.
Ch.T. Davis è dell’avviso che cod. C sia stato trascritto «at least slightly before Remigio’s other works»(Prefaz. p. X).
Motivi: a) «one wonders whether he [Remigiol could have found time in the brief period 1315-1319 also to rivise andcollect his treatises» (Davis, in AA.VV., Le scuole degli ordini mendicanti, Todi 1978, 291);
b) il testo delle opere di cod. C sembra rivisto con piùcalma e accuratezza; le carte e i margini delle carte di tale codice sono meno tormentati, meno ingombri di correzioni e addizioni rispetto a quelli dei sermonari e dell’Extractio questionum di cod. G3 (ib.);
c) mentre gli altri codici portano numerosi rimandi a opere contenute in cod. C, questo porta un solo rimando (parte scritto da mano A, parte da mano B) ad altro codice,al sermonario cod. D (cod. C, f. 222rb) (ib. pp. 287-88).
Le annotazioni del Davis sono degne di considerazione e potrebbero rivelarsi utili per stabilire la priorità di cod. C rispetto agli altri codici quando potessero esser suffragate da decisivi dati critici. Allo stato attuale esse non sembrano decidere della questione. Remigio, avantinegli anni, cessò dall’insegnamento e dalla predicazione e si dedicò completamente («se totum conferens») a riordinare
i propri scritti - dice la Cronica di SMN. Non si vede perché non avesse avuto modo di soprintendere anche alla trascrizione delle opere di cod. C. È vero che le carte di quest’ultimo sono generalmente meno tormentate (ma vedi pure talune tormentatissime pagine di Quolibet II); ma la cosa può trovare spiegazione nella natura diversa tra operetrattatistiche e sillogi di sermoni; questi costituiscono unità più minute, talvolta sono soltanto schemi o appunti di sermoni; l’autore vi ritorna con note al margine per offrire altri spunti o altre utilizzazioni al predicatore che se ne fosse servito; attività redazionale e glossatoriache non si confanno, almeno nella medesima misura, a composizioni organiche e ben strutturate quali trattati, questioni disputate e quodlibeti di cod. C. E la medesima considerazione (genere letterario diverso) può eccellentemente spiegare che siano i sermoni a rinviare a temi più sistematicamente sviluppati nei trattati e in opere di scuola, e non viceversa.
10. Copista A senza nome
Si può identificare chi fosse (un frate? uno scriptor di SMN?) mano A che ha trascritto i codd. C (eccetto ff. lr-74r), D, G3, G4, pari all’84,5% delle opere di Remigio? Tamburini (Introduz. p. XXVII n. 13) suggerisce di confrontare la scrittura di mano A con le grafie che si succedono nella Cronica di SMN, di cui si conoscono alcuni nomi (per l’iscrizione del documento, divulgato con il titolo di ‘Necrologio’, vedi MD 1980, 11-13).
Il sottoscritto aveva già tentato la pista: mano A dei codici remigiani mai compare tra le grafie del codice dellaCronica (Arch. del convento Santa Maria Novella di Firenze I.A.1). POMARO, Censimento I, 374, 387, 449 ha segnalato altri codici in cui ricorre mano A dei codici remigiani; nessuna identificazione è stata finora possibile.
11. Cronista di Remigio non è fra Scolaio di Squarcia
E sempre a proposito della Cronica, a partire dal nome ditaluni autori forniti da Orlandi, Necrologio I, XLIX ss, si è affermato che autore della notizia biografica di Remigio dei Girolami sia fra Scolaio di Squarcia (OP 1277, † 8.X.1320) (Capitani, «Studi Medievali» 6/2 (1965) 537; Davis, in AA.VV., Le scuole 283-84).
Esito fiorentino di -arius è –aio, Scolaio, contro -aro (Scolario/ Scolaro) degli idiomi centro-meridionali; FRANCO SACCHETTI, Il Trecentonovelle, nov. 176: “Scolaio Franchi”.A dire il vero, lo studio del codice del cosiddetto
Necrologium I (di fatto Cronica fratrum di SMN, ASMN I.A.1) faintravvedere che gli autori-cronisti (e consideriamo le prime venti carte, cioè fino all’anno 1320) non si susseguono come suggerisce l’Orlandi; secondo costui fra Pietro dei Macci avrebbe scritto fino a f. 12r (fino all’obitus 177) e fra Scolaio di Squarcia gli sarebbe subito succeduto (ORLANDI, Necrologio I, p. XLIX). I dati dicui si dispone sono le grafie del testo della Cronica e le saltuarie indicazioni che lo stesso documento dà su taluni scriptores (i tardivi cronisti Matteo Biliotti 1586 e Vincenzo Borghigiani 1757-60, menzionati dall’Orlandi, non disponevano d’altre fonti, e comunque non le indicano). Pietro di Galigaio dei Macci († 1.VII.1301) «huius libelli et cronice compilator extitit et inventor» (n° 179); Scolario di Squarcia del popolo San Iacopo d’Oltrarno (OP 1277, † 8.X.1320) «presentem cronicam ex parte multa compilavit» (n° 221); Bonfantino di Pazzo dei Bonfantini (†III.1337) «multorum fratrum sibi premorientium preconia in hoc libro manu propria annotavit» (n° 280); Paolo da Santa Croce († 9.VI.1348) «magnam partem huius cronice compilavit» (n° 355); Paolo di Lapo dei Bilenci († 20.XI.1381) «in hoc etiam presenti cronica fratres plures preclare laudavit maxime eos qui maxime tempore pestis flebilis 1348...» (n° 496). Ora tali informazioni degli autori della Cronica né sono sistematiche, quasiché si sia voluto tramandare il nome di tutti gli scriptores, né soprattutto asseriscono alcunché circa la successione al
lavoro di cronista, se non quanto è lecito dedurre dagli estremi della loro entrata in religione e della loro morte.Dall’altra parte lo studio del codice rivela che tra i due blocchi di scrittura entro le prime venti carte - da rimettere alla paternità di Petro dei Macci e Scolaio di Squarcia sull’autorità della stessa Cronica - si succedono ealternano anche altre mani. Solo un’edizione critica del prezioso documento e uno studio paleografico minuto delle grafie potrebbero determinare le mani che si succedono al lavoro di registrazione dei decessi. Allora le frammentarieindicazioni degli scriptores risulterebbero utili per dare unnome alle grafie, o almeno a talune di esse (vedi anche quanto giustamente annota in proposito POMARO, Censimento I,335 n. 24).
Per quel che interessa il nostro punto, va segnalato cheuna medesima mano, di tipo notarile-cancelleresco, ha stesola sequenza delle notizie biografiche di Accorso da Monte di Croce († 1.II.1318), Filippo converso († 14.III.1319), Albertino Mazzante di Cambio († 1319), Remigio di Chiaro diGirolamo († 1319), Scolaio di Squarcia († 8.X.1320), Riccoldo da Monte di Croce († 31.X.1320) (ASMN I.A.1, ff. 19v-20v, numeri 217-222 di ed. Orlandi; cf. Studio 188 e Tav. V). Se Scolario avesse scritto l’articolo necrologico di Remigio, sarebbe l’autore della propria necrologia!
12. Quel che la cronaca dice
L’articolo della Cronica fratrum di SMN ha fornito il primo autorevolissimo nucleo biografico di Remigio. La letteratura remigiana vi ha fatto e vi fa continuo ricorso;ma vi ha incontrato anche molti inceppi (cf. Davis, in AA.VV., Le scuole 283-86).
Le difficoltà di concordare i dati cronologici della Cronica hanno origine in parte da un’errata trascrizione della notizia, in parte da un’interpretazione non avallata dal testo della Cronica: che cioè la durata del lettorato (40, non 42, anni e più) si riferisse al lettorato «fiorentino».
La rilettura del testo della Cronica non risponde certo atutte le nostre curiosità, i dati anzi sulla morte di Remigio sono lacunosi se paragonati con quelli provvisti per confratelli a lui prossimi nelle carte della Cronica; e a domande non evase dal documento bisogna trovar risposta da altre fonti. Ma ciò che qui preme annotare è che i dati biografici della Cronica non sono contraddittori né cozzano con quanto accertato tramite altre fonti (Cronologia remigiana).
Ecco in sintesi quanto si può ricavare dalla Cronica (ed.in Studio 189-90):
- Remigio morì nel 1319 (e riteniamo l’anno secondo il computo moderno);
- trascorse nella vita religiosa 51 anni e 10 mesi;- già licenziato in arti a Parigi, entrò nell’ordine a
Saint-Jacques e in breve tempo progredì talmente in virtù escienza che ancora diacono fu nominato lettore nel conventofiorentino («brevi admodum tempore sic profecit quod etiam ante presbiteratus honorem existens dyaconus in conventu florentino ad lectoratus officium est promotus»);
- nell’ufficio di lettorato («in quo quidem officio») perseverò, predicando e insegnando, 40 (non 42) anni e più;
- avanti negli anni e fiaccato dalla vecchiaia cessò dalla predicazione e insegnamento, si dedicò completamente alla consulenza spirituale nonché «scriptitationi et compositioni librorum sacrorum, quorum plurima ac perutiliaedidit».
Morto dunque nel 1319, Remigio dovette entrare nell’ordine nel 1267-68. Non si dice l’anno d’inizio del lettorato fiorentino né quello della cessazione da insegnamento e predicazione; ma la Cronica non parla di 40 anni e più di lettorato «fiorentino» bensì di 40 anni e piùdi «lettorato»; sia esso dunque fiorentino che d’altri conventi. Mentre si dice espressamente che il lettorato nondurò fino alla morte.
Sappiamo dallo studio dei codici che il frate fiorentinoattese al riordino, supervisione della trascrizione ed
edizione («edidit» dicono Cronica e molti explicit delle opere) dei propri scritti negli anni 1314-16. Se supponiamoquesti anni come termine dell’insegnamento e detraiamo i 40di lettorato, l’inizio del primo lettorato «fiorentino» cade negli anni 1274-76. Ma nei «40 anni e più» di lettorato vanno computati sia quello fiorentino (il primo ei successivi) che quello parigino e perugino ben documentati, ed eventualmente lettorati in altri conventi della provincia Romana, se ve ne furono. La partecipazione ai capitoli generali non pregiudica l’anno accademico, datoche i capitoli non durano di regola che la settimana successiva alla festa dei Pentecoste (cf. MOPH III, 123, 127, 131); cosicché non appare giustificato detrarre dagli anni di lettorato gli anni accademici coincidenti con la partecipazione ai capitoli generali.
I dati generali della Cronica lasciano sì indeterminati molti punti importanti della carriera di Remigio ma non sono contraddittori. Il lasso di tempo fra entrata in religione (1267-68) e verosimile inizio del lettorato fiorentino (1274-76) rendono ragione del periodo di noviziato (o probationis), della formazione teologica di base(studio della Bibbia e delle Sentenze) in Saint-Jacques di Parigi, della partecipazione alle lezioni di Tommaso d’Aquino nel secondo insegnamento parigino di costui (1269-72); e rendono ragione infine di quanto affermato dall’autore della Cronica: «brevi admodum tempore sic profecit quod etiam ante presbiteratus honorem existens dyaconus in conventu florentino ad lectoratus officium est promotus».
II - Questioni filologiche e ricognizione delle edizioni
13. Corretto non equivale ad autentico
Il testo dell’edizione integrale del Contra lalsos (ben 292 pagine di stampa computando anche le abbondanti note) èaccurato nella trascrizione e scrupoloso nell’apparato critico, dove o si annotano gl’incidenti di copia del’copista A e gl’interventi correttivi dell’autore, mano B, o si dà ragione delle emendazioni e scelte dell’editore.Lo studioso del frate fiorentino può fare ampio credito al testo edito del Contra falsos. E se si tien conto che taluni scritti di Remigio dati alle stampe sono talmente scorrettida risultare praticamente inutilizzabili (penso al De misericordia, al De bono comuni, ai sermoni De pace), si apprezzerà ancor più il lavoro del Tamburini, il quale mette a disposizione un eccellente testo d’uno dei più estesi trattati di Remigio.
Qualche riserva s’impone.Segnalato tra i criteri d’edizione che in parentesi
quadre sono chiuse integrazioni quando «si è creduto di individuare una lacuna nel testo (p. LX), il lettore è invitato a ritenere che l’integrazione dovesse far parte dell’esemplare, o comunque voluto dall’autore; autentico darestituire, degradato da distrazione di copia o da altro incidente redazionale. Ora una serie d’integrazioni al testo chiuse in parentesi quadre riguarda consuetudini nel modo di citare opere altrui; l’editore - per fare qualche esempio - integra Causa, can. o cap. nelle citazioni del Decreto o Decretali, o il titolo Ethimologiarum d’Isidoro daSiviglia o De fide orthodoxa di Giovanni Damasceno o Glosa alla Bibbia ecc. Tali integrazioni sono ingiustificate perché Remigio dà di regola e più frequentemente il numero della causa o le parole d’inizio del canone o capitolo, e nel caso delle Decretali anche del titolo; consuetudine delresto degli autori coevi. In sezioni di scritti dove le Etymologiae d’Isidoro sono ripetutamente citate, Remigio si dispensa dal ripetere ogni volta il titolo dell’opera e dà solo il numero del libro (cf. Divisio scientie cc. 16-20). Per molti autori di cui si conosce o si cita una sola opera, Remigio dà costantemente soltanto il nome dell’autore, accompagnato secondo il caso dal numero del libro o d’altra
partizione dell’opera: così Valerius sta per Factorum et dictorum memorabilium, Raymundus per Summa de penitentia, Papias per Elementarium doctrine rudimentum (Glosarium), Huguiccio per Derivationes, Donatus per Ars grammatica, Magister per Sententie, Damascenus per De fide orthodoxa; quest’ultima in particolare non appare sotto tale titolo negli autori medievali latini, che la menzionano talvolta col titolo di Summa o Sententie. Parimenti Gregorius, seguito dal numero del libro, sta per i Moralia di Gregorio Magno. Si legge nelDe subiecto theologie:
«Liber non semper intitulatur vel denominatur a subiectovel a causa materiali sed aliquando ab aliis causis, puta ab efficiente, puta cum dicitur Liber Ysaie vel Ysaias, vel Paulus vel Cato» [= Disticha Catonis] (De sub. theol. 340-43).
Sempre in tema di citazioni, il Tamburini tende ad emendare il testo citato da Remigio a partire dalle edizioni moderne dell’autore citato (altri editori di Remigio avevano persino ‘corretto’ il testo parigino della bibbia usata dal frate fiorentino con quello della volgata sisto-clementina!). Certamente il controllo delle citazionisulle edizioni può aiutare, in luogo di congetture, a restaurare un brano palesemente corrotto o che non dia senso; ma laddove il caso non si ponga, il testo della citazione deve comparire come riportato nell’opera di cui si cura l’edizione. Esempi. In Contra falsos 12,19-20, in un prestito dalla Glossa al Decreto, si correggono gli anni 706 in 776, 5 in 15, Leone IV in Leone III sulla base dell’edizione romana (1582) del Decreto con Glossa. Quali numeri portava l’esemplare che Remigio aveva sotto mano?, perché questi erano gli ‘autentici’ di Remigio. In 10,48 (brano di san Girolamo in una citazione del Decreto) primumdi Remigio, attestato nella trasmissione del testo del Decreto (ed. Friedb. in nota), è corretto dall’editore in previum perché tale la lezione nell’edizione di un’opera di Girolamo. Ci si priva della possibilità d’identificare - quando si volesse - la tradizione manoscritta degli esemplari utilizzati da Remigio. In tali casi sarà utile
segnalare in nota le divergenze più notevoli che ricorrono nelle citazioni, non certo ‘correggere’ la lezione che risulti autentica nell’opera di cui si cura l’edizione. Compito dell’editore - ricordiamo - non è procurare un testo corretto in sé ma «la restituzione di un testo che siavvicini il più possibile all’originale» (R. MAAS, Critica del testo, Firenze 1975, 1). Il che non dispensa l’editore dall’individuare - se possibile - anche errori o lapsus d’autore. E dopotutto in taluni casi la testimonianza di Remigio - come di qualsiasi altro scrittore - non potrebbe risultare utile, a titolo di tradizione indiretta, anche aifini della restituire il testo dell’autore citato?
Commentando Politica I, 2 (1253a 3-4) e I, 2 (1253a 27-29) in Contra falsos 76, 68-87, Remigio ricalca palesementeTommaso d’Aquino, Sententia libri Politicorum I, 1/b (EL 48, A 78,85-99 e A 79,190-97), sebbene inverta la successione dell’articolazione del discorso. In riferimento a Politica I, 2 (1253a 3-4) «qui incivilis propter naturam et non propter fortunam, aut pravus est aut melior quam homo»:
Tommaso ha Remigio haAliqui sunt non ciuiles propter fortunam, utpote quia sunt expulsi de ciuitate; uel propter paupertatem necesse habentexcolere agros aut animalia custodire. Et hocpatet quod non est contrarium ei quod dictum est, quod homo sit naturaliter ciuilis: quia et alia naturalia aliquando deficiunt propter fortunam, puta cumalicui amputatur manus, uel cum priuatur cibo (ed.cit. A 78 rr. 85-92).
Si enim homo propter aliquam fortunam separat se a societate aliorum hominum, puta quia est expulsus de civitate vel quia propter paupertatem necesse habet colere agroset custodire animalia, ex hoc non incurrit alteram partem dicte disiunctive. Si enim alicui amputetur manus propter fortunam velsi privetur verbo, non propter hoc est pravus homo, scilicet quasi quedam bestia, vel etiam melior quam homo, quasi scilicet quidam deus id est angelus (Contra falsos
76,73-80).
L’esempio è dell'escluso dalla comunità civile per un accidente di menomazione fisica («propter fortunam»), e dell'implicito parallelismo tra organo umano e sua specifica funzione annuito dalla mano amputata. La lezione verbo testimoniata da Remigio non può rivendicare qualche probabilità al testo originale tomasiano in luogo di cibo della tradizione accolta dall’edizione leonina? Remigio leggeva un esemplare di Tommaso che portava verbo non cibo, là dove anche Tommaso traeva conclusione che né bando né disabilità privano l'essere umano d'appartenenza alla polis. «Una variante abbastanza interessante», mi comunica padre L.J. Bataillon della commissione leonina.
Per tornare al punto specifico, quando il numero delle partizioni di un’opera (libri, capitoli, distinzioni ecc.) non coincide con le edizioni moderne, non c’è nulla da correggere; il lapsus potrebbe essere accertato solo se sapessimo quale numerazione portavano le partizioni dell’esemplare utilizzato dal nostro autore; e in siffatta materia, la trasmissione manoscritta è sempre molto varia; anzi molto lavoro di sistematizzazione in tale settore veniva svolto proprio nei secoli XII e XIII nel fervore di sviluppo delle tecniche di approntamento di opere provvistedi tutti gli ausili di consultazione, dalla divisione in libri o in capitoli agli indici alfabetici (cf. R.H. e M.A.ROUSE, Preachers, Florilegia and Sermons. Studies on the ‘Manipulus florum’ of Thomas of Ireland, Toronto 1979, 38-40 e passim). E si noti il seguente brano di Remigio:
«De numero autem non est vis [sottintendi argumenti] dummodo eadem substantia teneatur, sicut eadem credulitas est nostri et Hebreorum in Paralipomenon cum tamen unus tantum liber sit apud Hebreos et nos in duos propter magnitudinem dividamus, sicut dicit Ieronimus inprologo super eundem librum. Nichil enim est ad substantiam fidei quod biblia per tot capitula dividaturin quot constat non esse divisa a suis autoribus. In Bruto enim Ciceronis dyalogo tres libros assignant cum
tamen a suo autore unus sit editus, ut dicit Ieronimus super Paralipomenon» (cod. G3, f. 180vb).
■ caso dei libri bibliciTalune incongruenze nel numero dei capitoli dei libri
biblici sembrano reali sviste d’autore (o di copista), datoche la numerazione introdotta da Stefano Langton nel primo ventennio del ’200 era acquisita (cf. A. D’ESNEVAL, La division de la Vulgate latine en chapitres dans l’édition parisienne du XIIIe siècle, «Revue des Sciences Philos. et Théol.» 62 (1978) 559-68; B. SMALLEY, Lo studio della bibbia nel medioevo, Bologna 1972,311 ss.). I lapsus sono del resto controllabili nei ricorsidi medesimi testi biblici citati altrove con corretto numero del capitolo (il caso si dà talvolta anche in citazioni delle fonti canonistiche: cf. Contra falsos 11,13: cf. 12,13; 13,6, dove si corregga «dist. 95» in «dist. 96»). Ma il modo di citare i libri di Esdra e Neemia ricorre con una frequenza sufficientemente elevata che esclude una svista involontaria caduta sistematicamente in luoghi diversi sul medesimo testo. D’altra parte Esdra e Neemia (= I e II Esdrae) con gli extracanonici III e IV Esdrae avevano collocazione e numerazione fluttuanti nelle bibbie pretridentine. Versi mnemotecnici sul numero dei capitoli dei libri biblici (da attribuire probabilmente al francescano Guglielmo il Bretone, seconda metà del ’200) dicono a proposito:
Esdre dena dat a, Ne [= Neemie] bis epta, b dat vigen epta,
Bis duodena dat a, tenet Esdre b vigen epta,Sicut habent plures si vis b ter tria dices,In Neemi numerum vix audeo ponere certum,Nam varie varios video distinguere libros,Sed medium tenui, medium tenuere beati.(GUILLELMI BRITONIS, Expositiones vocabulorum biblie, ed.
L.W. e B.A. Daly, Padova 1975, p. XXII).
Correggere sistematicamente i numeri dei libri e capitoli elimina la possibilità d’individuare la bibbia
usata dall’autore. Ecco in tabella come tali libri compaiono nelle citazioni di Remigio; in prima colonna laforma delle citazioni in Remigio, poi i corrispondenti testi nella Volgata sisto-clementina, quindi luogo della citazione.
Remigio Vulgata
Neem. 3 II Esd. 3,6 cod. G4, f. 387v mg., B
Neem. 4 II Esd. 4,19 cod. G4, f. 381va
Neem. 5 II Esd. 5,7 De peccato usure 645,11
Neem. 8 II Esd. 8,10 Contra falsos 71,42-44
Neem. 9 II Esd. 9,31 cod. D, f. 211rb
Neem. 9 II Esd. 11,1 Contra falsos 40,72
II Esdre 4
III Esd. 4,16 cod. D, f. 352vb
II Esdre 5
III Esd. 1,53 De peccato usure 634,10-11
II Esdre 9
III Esd. 3,12 cod. G3, f. 166va; G4, f. 24ra
Il Esdre 10
III Esd. 3,10 Contra falsos 83,64
II Esdre 10
III Esd. 3,12 Contra lalsos 52,64-65
III Esd. 10
III Esd. 3,12 Contra falsos 50,60-61
II Esdre 10
III Esd. 3,20 Contra falsos 84,5-6
II Esdre 10
III Esd. 3,21 Contra falsos 85,9-10.14-15
II Esdre 10
III Esd. 4,26
De via paradisi f. 349/50rb; D, f. 403vb
II Esdre 10
III Esd. 4,42 cod. G3, f. 166va
IV Esdre 1
IV Esd. 2,12 cod. D, f. 169ra
IV Esdre 2
IV Esd. 4,2 cod. D, f. 206va-b
IV Esdre 3
IV Esd. 4,6 cod. D, f. 206vb
IV Esdre 3
IV Esd. 5,36 cod. D, f. 206vb
Apoc. Esdre scilicet in IV libro (= IV Esd.): cod. D, f. 309ra
Sufficientemente ampia la lista per trarre qualche utile informazione circa la bibbia remigiana. Neem., II Esd. e IV Esd. (detto anche Apocalipsis Esdre) di Remigio corrispondono rispettivamente a II Esd. (inc. Verba Neemie...; la tradizione latina aveva suddiviso in due, I e II Esd., l'unico libro ebraico), III Esd. e IV Esd. della sequenza nella Volgata sisto-clementina (qui gli ultimi duelibri rimessi all'appendice extracanonica). Dissonante la numerazione dei capitoli. E fra tante citazioni, anche un errore d'autore! Contro il coerente «super omnia vincit veritas, II Esd. 10» di Contra falsos 52,64-65 (s'ignori l'emendazione dell'editore), Contra falsos 50,60-61 si lascia scappare «super omnia vincit veritas, III Esd. 10». Il testo, noi lo leggiamo in III Esd. della Volgata. Ma in Remigio - così vuole la nostra lista - è una vera svista involontaria; l'unica da emendre per ristabilire il II Esd.10 d'autore! Guglielmo il Bretone (1250-70) cita Neem. 8 per II Esd. 8,10; II Esd. 1b per III Esd. 1,12; II Esd. 7 per III Esd. 8,25 (ed. Daly 449, 221, 336). Raimondo Marti († 1284-85), cita Esd. 7a per I Esd. 7, 6, e Neem. 8 per II Esd. 8,1-2 (Explanatio simboli apostolorum [1257], ed. J.M. March, «Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans», Barcellona 1908, 453).
Sufficiente, questo spoglio, per dissuadere l’editore dal normalizzare la numerazione dei libri e capitoli dei suddetti libri a quella della Volgata sisto-clementina, così come il ricorso a bibbie pretridentine permette di
assicurare lezioni che editori inclinano a ‘correggere’ sultesto della Volgata (vedi qualche esempio più sotto § 18 (§ 6 di ed. a stampa), note al testo di Contra falsos 47,76; 78,71).
Qui in appendice qualche modello di bibbie medievali.Le lettere paoline seguono più frequentemente ai Vangeli,anteposte agli Atti degli Apostoli. La successione dei libri la si arguisce anche dall'ordine di citazione entrole serie di distinctiones bibliche. BAV= Biblioteca Apostolica Vaticana.
modelli di bibbie medievali
Paris, BN lat. 16720 (xiii)("bibbia di St-Jacques") BAV, Regin. lat. 3 (xiii)
BAV,Borgh. 25(xiii)
161va-169vb: Liber Esdre (=I Esd.) 204v-210: Esdre (= I Esd.) I Esd
169vb-181va: Neemie (= II Esd.)
210-216v: Neemie (= II Esd.) II Esd
181va-193va: II Esdre (= III Esd.)
216v-224: II Esdre (= III Esd.) III Esd
193v-201: Tobie (omette IV Esd.)
224-229: Tobie (omette IV Esd.) IV Esd
. . . . . . Iohannis IohannisEp. Pauli Act.
Act. Ep. canonice
Ep. canonice Ep. PauliApo. Apo.
14. Grafia, parte integrante del sistema linguistico
Nei criteri di edizione del Contra falsos ci si propone di«rispettare sostanzialmente» la grafia del codice (p. LX); ma si fanno eccezioni per le quali non si vedono ragioni:
«è stato ridotto il nesso np in mp ed è stato restituito l’uso delle doppie» (ib.). Così forme di scrittura costantenei codici remigiani (e in moltissimi casi comuni al dettato del mediolatino del Due-Trecento) quali comunis e derivati, gramatica, litera, abreviatio, glosa, quatuor («quatuor dicitur quasi "qua tueor"», cod. D, f. 391v) ecc., sono sistematicamente ricondotte alla forma normalizzata communis, grammatica, littera, abbreviatio, glossa, quattuor... Ma va aggiunto che l’editore non è stato del tutto fedele ai suoistessi propositi, e non solo perché avrebbe dovuto per simmetria grafologica restituire le scempie dove sono usatecostantemente le doppie (es. legittimus: 21,56 e passim) od occasionalmente (occeanus: 78,40), ma perché conserva scritture scempie quali apropriare, aproprianter (3,76; 46,65),sucursu (20,22), oportunum (39,8; 56,57), excomunicati (63,54; excommunicandi in 66,27)... Né i criteri d’edizione motivano la sistematica riduzione di efficatia di Remigio in efficacia (21,77; 59,68; 55,210-11; 56,23; 57,2.3; 58,49) o di sotius e derivati in socius ecc. Va annotato comunque che l’edizione in questione offre al lettore, tra testo e apparato critico, tutti i dati della scrittura e incidenti di copia, cosicché il lettore può intravedere lo stato delle cose.
Ma il discorso sul sistema della lingua dei codici remigiani, al di là delle norme della critica del testo («Elle [l’orthographe] n’est qu’un des éléments de la langue de l’auteur et il va de soi qu’une édition scientifique se doit de respecter cet élément exactement aumême titre que les autres; il n’y a donc qu’à appliquer lesmêmes lois de la critique que partout ailleur»: R.-A. Gauthier, in TOMMASO D’AQUINO, Opera, ed. Leonina 48, B 27a), può acquistare ben più consistente valore filologico qualora una recensione delle caratteristiche di scrittura individuasse il fondo costante e lo strato variante del sistema linguistico di Remigio. La cosa sarebbe di notevoleimportanza non solo per guidare le scelte dell’editore (nonpiù conteso a rilevare ‘errori’ sulla tipologia classico-umanistica del dettato latino) su casi che sollecitassero
un intervento emendatorio, ma per rintracciare evoluzioni einnovazioni entro la vasta produzione letteraria del frate fiorentino. La cosa è tanto più pertinente, e storicamente preziosa, se si tien conto della fortunata forma della tradizione delle opere di Remigio; infatti, ad eccezione del quaresimale e della copia tardiva delle Postille super Cantica della Laurenziana cod. 362 (Studio 252-54), il bloccodei codici che ci trasmettono le opere remigiane sono manoscritti d’autore: scritti da amanuensi sotto la supervisione di Remigio, il quale è intervenuto per correggere errori, integrare omissioni, inserire aggiunte, trascrivere talvolta al margine sermoni interi (mano B). “Manoscritti idiografi”, nel lessico della filologia umanistica: S. RIZZO, Il lessico filologico degli umanisti, Roma 1973, 101; R. BESSI - M. MARTELLI, Guida alla filologia italiana, Firenze 1984, 1.
cod. C (opere trattatistiche) di mano X a ff. lr-74r; tutto di mano A da f. 74v in poi;
cod. D (sermonario de sanctis et festis solemnibus) di mano A;cod. E (De modis rerum) di mano Z;cod. G3 (Extractio questionum per alphabetum) di mano A;cod. G4 (sermonario de tempore et de diversis materiis) di mano
A;Postille super Cantica (Laurenziana, Conv. soppr. 516, ff.
221r-226v) di mano Y;Distinctiones (ib. ff. 226v-268v: ed. in Studio 271-83) di
mano B (Remigio).E aggiungo BNP = Parigi BN lat. 3557, ff. 203r-209v;
contiene il sermone remigiano Vado ad Patrem che porta correzioni marginali di mano B (Remigio) a ff. 204ra, 205vb, 206va, 207vb, 208ra interl. (cf. Il Repertorio dello Schneyer, MD 11 (1980) 649-50).
Summa Britonis = GUILLELMI BRITONIS, Expositiones vocabulorum biblie, ed. L.W. e B.A. Daly, Padova 1975.
L’importanza del sistema di scrittura nel caso specifico risulta da due fattori concorrenti: da una parte
almeno quattro copisti (mani A, X, Y, Z) scrivono sotto supervisione dell’autore (mano A trascrive l’84,5% circa ditutto il corpus remigiano), dall’altra l’autore (mano B) consegna ai margini dei codici - oltre ai pezzi integralmente autografi delle Distinctiones, del trattato-sermone De nomine usure e di molti sermoni - una massa considerevole d’interventi autografi. Questo stato di cose permette: a) di fissare le caratteristiche di scrittura dell’autore; b) di verificare la fedeltà o meno dei copistisui testi autografi dell’autore.
Vista la natura della tradizione del testo, il lavoro d’edizione - tranne pochi casi - è da codex unicus; ma l’editore non può dispensarsi dal descrivere in apparato tutti gl’incidenti di scrittura, siano essi dei copisti chedell’autore. E gli errori che sollecitano interventi correttivi di mano B sono provvidenziali, poiché espongono il correttore-autore a esprimere positivamente le proprie scelte.
Un ampio spoglio dei codici remigiani, oltreché delle edizioni disponibili e controllate sull’originale, permettedi proporre un primo abbozzo delle caratteristiche del latino di Remigio. Oltre all’interesse generale d’una testimonianza letteraria avallata da manoscritti d’autore con vaste sezioni di scrittura autografa, la cosa potrà risultare rilevante come guida all’editore per decifrare quando e dove siano veramente occorsi errori involontari (del copista o dell’autore) e corroborare i criteri d’eventuali interventi emendatori. Prenderò in esame soltanto l’aspetto grafologico del dettato remigiano, senzapregiudizio peraltro del relativo valore fonetico. Le operetrattatistiche di cod. C saranno citate col titolo, cui seguirà numero delle carte (da intendere sempre del detto codice); con numero della pagina e dei righi, o solo dei righi secondo il caso, si rinvierà alle opere edite. Quandoil testo qui citato differisce dalle edizioni s’intenda corretto sull’originale. Sigle dei codici e indicazione delle edizioni sono state date in introduzione. Quando
opportuno segnalerò la mano dei diversi copisti con le rispettive lettere maiuscole come segnalate qui sopra.
15. Impasto mediolatino/volgare fiorentino
Annotiamo anzitutto che la scrittura remigiana presenta le forme generali del mediolatino del XIII-XIV secolo comuni alla produzione letteraria della schota. Molto probabilmente talune peculiarità grafologiche, oltreché risentire della pressione esercitata sul latino dalla fonetica delle lingue romanze, testimoniano tratti derivatidal volgare fiorentino. Questo specifico aspetto dovrebb’esser studiato a parte, dopo sistematica recensionedei testi in volgare sparsi nei codici remigiani, specie nei sermonari. Del resto le due lingue - latino e volgare -vivevano in strettissima simbiosi culturale nell’uso quotidiano perché non dessero esiti dalle reciproche impronte. Caratteristiche quali l’uso (e la fluttuazione) delle consonanti scempie e geminate, la concorrenza tra grafie fonetiche e grafie etimologiche (si pensi alla h, y, al digramma ch), soluzioni della nasale preconsonantica, fenomeni fonetici che si riversano sulla scrittura (aferesi, protesi, epentesi, dittongazione ecc.), dissimilazioni vocaliche e consonantiche, fluttuazioni grafologiche per rappresentare suoni c e g velari o gl e gn palatali, o per assicurare nessi latini quali ct, mn, mpt corrosi dalla fonetica volgare, sono un terreno di comune ereciproca pressione linguistica tra latino e lingue romanze. Ne vedremo tra breve un caso tipico in augumentum.
Per suggerire qualche traccia del probabile influsso della fonetica romanza, e di volgarismi fiorentini in particolare, sul latino di Remigio si possono menzionare casi d’aferesi: stronomia <astronomia (Contra falsos 40,3) (la prima forma precedente la parentesi acuta sarà sempre quella dei testi remigiani), Scolapius<Esculapius (Divisio scientie8,5.6), Scarioth<Iscarioth (Speculum f. 154rb); di crasi: preminere, preminens (Quolibet I, 1, f. 72ra; De bono pacis
63,14.26.27; cod. G3, f. 34rb; Contra falsos 52,80), proprissime (cod. G4, f. 300rb), perissem (Postille f. 228va); d’assimilazione regressiva in composti preposizionali: assit, assint<adsit, adsint (De bono comuni 47,14; De via paradisi f. 219ra; Contra fals. 60,4), iccirco<idcirco (De misericordia c. 18, f. 203vb), Herricus (De via par. f. 218v mg. inf., f. 240ra, f. 272rb), aggenerans (Div. sc. 2,38); della più rara assimilazione progressiva testimonia il volgare «con la palla in mano» di cui si dice che «est vulgare corruptum, idest con la palma» (cod. G4, f. 106rb); caduta di elementipreposizionali non assimilabili: astabam<adstabam (De peccatousure 625,2), oscurus (Contra fals. 47,11; altrove sempre obscurus: Contra fals. 47,12 e passim; Distinctiones 406, mano B), scultile<sculptile (De via par. f. 350/lrb), asque<absque (cod. G4, f. 3lrb), susistentia (De modis rerum f. 26vb) e sustantive (Quol. I, 3, f. 74vb) contro il regolare subsistentia e substantive, sustentandis (cod. G3, f. 124rb, ma substentationem pochi righi dopo). La tendenza è testimoniataanche dal caso contrario, quando cioè iperetimologismi presumono di arginare la corrosione della fonetica romanza:obsculatus<osculatus (cod. D, f. 278ra; obsculo in BIAGIO BOCCADIBUE (Registri notarili) vol. I, fasc. 1 (1298-1300), a cura di L. De Angelis ecc., Firenze 1978, 72), subcessus<successus (Distinct. 25, mano B), obmicteret<omitteret (Distinct. 191, mano B). Esempi di protesi sono frequenti in testi volgari: ismarimento (cod. G4, f. 21ra), isbigottimento (ib.), iscusa (cod. D, f. 333va), isfiorito (cod. G4, f. 388rb), istagionevole (ib. f. 3ra), ma stagionato (cod. D, f. 397v, mg. s., B); metatesi: Alfagranus<Alfraganus (Contra fals. 6,38; in De pecc. us. 638,24 è abbreviato Alf.; Alfagrano anche in DANTE, Conv. II, XIII, 11: ed. Busnelli-Vandelli, Firenze 1934, I, p. 196 n. 9), Trimigestus<Trimegistus (Div. sc. 14, 34), ferneticus<phreneticus (Div. sc. 18,99; cod. D, f. 403vb, 404ra; ma freneticus in De bono pacis 61,8 che attinge dal Decreto); esito volgare s<x: testus<textus (cf. Studio 259 n. 43), esta<exta (Div. sc. 18,13), res<rex (cod. G4, f. 327ra);caduta regolare di c nel nesso ct di praticus< practicus, Arturus<Arcturus, dyaletica<dialectica... ; caratteristica
dittongazione romanza di e tonica in sillaba aperta: Galienus, e più significativo ancora abhorriebit (Contra fals. 47,145) per abhorrebit.
Un esemplare caso di epentesi, da una parte documenta leesigenze della fonetica volgare, dall’altra illustra tipicamente il compito dell’editore di discriminare sviste involontarie da emendare e caratteristiche fono-grafologiche da rispettare. In Contra fals. 42,10-12 ci s’imbatte in augumentum, che l’editore corregge in augmentum; più sotto, 67,4, si ha augumentandum con la seconda u espunta. I due esempi occorsi nella medesima opera sarebbero già sufficienti per intravvedervi il fenomeno fonetico dell’epentesi così comune nel mediolatinoe nelle lingue romanze. Il nesso velare gm, in questo casopreceduto da dittongo, presenta notevole asperità fonetica cui si rimedia sillabando la g con una u (per richiamo del medesimo suono nel dittongo): augumentum attenua l’asperità di augmentum. Nei testi remigiani il lessema appare di regola nella forma normalizzata di augmentum; mai casi contrari che si possono raccogliere stanno ampiamente a favore non di un lapsus calami (del copista o dello stesso autore) ma d’una pronuncia epentetica sedimentatasi nella grafia. Augumentationes e augumentant siha ancora in cod. D, f. 14rb e in Quol. I, 13, f. 80vb, e in ambedue i casi la seconda u è espunta; mentre senza espunzione la u epentetica si ritrova in augumentum (cod. G3, ff. 59rb, 59va più volte, 140vb) e nelle flessioni del verbo augumentare (De miser. c. 14, f. 199ra, c. 15, f. 202vb; cod. G3, ff. 59rb, 60va, 61va, 87vb; cod. G4, f. 361vb: Studio 201 v. 40). Il volgare italiano risolverà definitivamente sopprimendo, anziché sillabando, la g velare preconsonantica: aumento; ma augumento e augumentarehanno avuto lunga vita (cf. S. BATTAGLIA, Grande Dizionario della Lingua Italiana vol. I, Torino 1961, 842). Parimenti nel settore dell’epentesi rithimi (cod. G4, ff f. 406va, 407rb, mano A) coesiste con rithmi (cod. G4, f. 409rc, mano B); DANTE, De vulg. eloqu. II, XIII, ha rithimus e rithimari. (Per ilfenomeno nel volgare cf. G. ROHLFS, Grammatica storica della
lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino 1966, 465 ss.;A. CASTELLANI, Nuovi testi fiorentini del Dugento, Firenze 1952, 66-68).
Oh epèntesi! Ieri. E oggi? Non ne sappiamo né nome
né significato, ma la pratichiamo lo stesso, anche
noi che sappiamo leggere e scrivere.
Periodico "L'Espresso" 16.III.2006 (anno 52, n° 10),
pp. 88-89, sezione «Personaggi / Lo psicoanalista
d'assalto». L'articolo, ironico e simpatico,
riferisce di «psicoanalista eretico» (p. 88 col. a),
grande seduttore di «erranti orfane di ideologia»
(p. 89 col. b). Tra le didascalie dell'immagine
superiore in p. 89 (penna di giornalisti della
redazione?) si legge: «scultura ispirata dallo
pisicoanalista <Massimo Fagioli> a Roma».
Pisicoanalista, proprio così. Ecco l'antichissima e
medievale epèntesi!
A sproposito: ma che "eretico" non sia un lapisus
per "erotico"?
(... 15. Impasto mediolatino/volgare fiorentino)
Per evitare comunque una sopravvalutazione quantitativa delle scritture anomale o fluttuanti o di volgarismi, va detto che la vasta produzione letteraria del frate fiorentino mostra un sistema linguistico consolidato, che nel suo insieme si mantiene costante, dalla grafia alla morfologia alla sintassi, in tutti i codici di cui sopra; mentre la presente ricognizione punta a individuare le fasce mobili o anomale del sistema linguistico. E se si tien conto dell’inesistenza d’istituzioni pubbliche centrali che inducessero uniformità linguistica nel mediolatino, lo strato mobile della lingua di Remigio è dopotutto relativamente esiguo; probabilmente non di gran lunga superiore a quello riscontrabile entro la produzione d’uno scrittore italiano a noi contemporaneo se si recensissero sistematicamente varianti nella grafia, preferenze tra scritture latinizzanti e ‘volgari’, uso dell’elisione e dell’apocope, flessioni nominali, alternanze di forme verbali (perfetto forte e debole, ad esempio), reggenze preposizionali, dipendenze sintattiche, uso dei segni d’interpunzione, degli accenti, delle virgolette, sistema delle citazioni ecc. Del resto se in taluni casi le fluttuazioni grafiche non sono pervenute a un esito stabile, altrove - come vedremo subito - Remigio ha fissato forme grafologiche che risultano uniformi e costanti. La revisione delle opere negli anni 1314-1316, inoccasione della loro trascrizione, potrebbe aver operato a favore di un’uniformità e consolidamento d’ampie proporzioni del sistema linguistico se il lettore può scorrere pagine e pagine senza imbattersi in peculiarità o difformità degne di commento filologico. Inoltre - e la cosa mi pare di qualche interesse per la trasmissione del testo - si ricava l’impressione che sia il fondo costante che lo strato mobile della lingua compaiano in ugual misurae nelle sezioni autografe di scrittura e in quelle dei
copisti A, X, Y, Z: come dire che i copisti nell’atto dellatrascrizione non devono essersi prese molte libertà né hanno normalizzato secondo i propri canoni grafologici il dettato di Remigio. Costui del resto mostra chiara consapevolezza del proprio sistema grafologico: le sviste degli amanuensi e gl’interventi correttivi di mano B testimoniano scelte positivamente intese dall’autore. Bastascorrere le edizioni che descrivano in apparato tutti gl’incidenti di copia e di correzione per constatare che mano B estende i propri interventi anche su minute correzioni grafiche, anche d’una sola lettera. Un solo esempio puntato su h, un grafema peraltro che, perduto il sostegno fonetico nelle aree linguistiche romanze, occupavauna posizione fragile nella grafia mediolatina. Hetnicus, oram, exibere, exortare, ystoriographus scrive A (Contra fals. 78,181; cod. D, L 77va, f. 97rb, 98ra ... ), abundanter scrive P (BNP f. 208ra); mano B interviene, inserisce in interlinea h e restituisce i propri grafemi costanti hethnicus, horam, exhibere, exhortare, hystoriograpbus e habundanter (forma mediolatina ipercorretta ma costante per supposta derivazione da habere); exibeat persiste in Quol. I,4,76. All’opposto mathica scrive X (Div. sc. 20,18), hedificium scriveA (cod. D, f. 98ra): un punto soscritto espunge h e restituisce matica e edificium. Nel caso di quest’ultimo la scrittura aspirata si trova cinque volte in una sola colonna (cod. D, f. 98ra), il che non può essere imputabilea errore di copia; l’esemplare doveva portare h, ma nel testo rivisto e corretto di cod. D la h è sistematicamente espunta. La medesima cosa, in senso contrario, accade per ostia (= hostia: vittima, sacrificio) scritto quattro volte senza h nello spazio di cinque righe nel corso d’una brevissima extractio questionis di cod. G3, f. 110ra; mano B restituisce sistematicamente hostia inserendo h in soprarrigo. La conclusione s’impone: Remigio scriveva a suotempo, o gli capitava di scrivere, hedificium e ostia; nei codici rifiniti e destinati a pubblico uso («edidit» diconoalcuni esplicit e la Cronica di SMN) fissa edificium e hostia.
L’insidiosa dissimilazione consonantica delle liquide l e r, comune al mediolatino e ai volgari romanzi, attira unanota grafologico-semantica di Remigio:
«Nota quod debet dici fragrantia per r, idest redolentia; unde verbum flagrantia facit ardorem, sed fragrantia designat odorem» (Postille f. 223rb); sebbene lo spunto gli possa venire dal Graecismus XV, 69 di Eberardo da Béthune: «Fla facit ardorem sed fra designatodorem» (ed. J. Wrobel, p. 154).
Del volgare dell’alto Lazio si segnala la palatizzazionedella l: «Viterbienses dicunt “juna” et “moino” pro luna et molino» (cod. D, f. 280r, mg. s., B: Studio 240 rr. 153-54).Mentre per il caratteristico suono fricativo prepalatale sonoro della g intervocalica del volgare toscano (stagione = ž) si offre la ben documentata grafia dimostrativa sg: busgia, busgiardo, rasgionato (cod. G4, f. 407rb-va) (cf. B. MIGLIORINI, Storia della lingua italiana, Firenze 1971, 269; CASTELLANI, Nuovi testi 18. 31-33). Nel sermone in morte del legista Manno ci s’intrattiene sul genere e desinenza degliantroponimi fiorentini: alcune desinenze, come quelle in -oe -i, sono di genere maschile - si dice - e convengono a nomi di uomini, quali Piero e Iacopo, Vieri e Tieri; altre,in -a, sono di genere femminile, quali Iovanna, Iacopa; altre, in -e, sono d’ambo i generi, quali Bene e Gentile. Talvolta però la desinenza in -a può denotare un antroponimo maschile, come Elcana, Paniccia, Farinata... (cod. G4, ff. 402vb-403rb) (per l’antroponimia fiorentina del Due-Trecento Cf. O. BRATTÖ, Studi di antroponimia fiorentina, Göteborg 1953; ID., Nuovi studi d’antroponimia fiorentina, Stockholm 1955; vedi esempi in BOCCADIBUE passim). In De pecc. us. 624,2-8 si annota accento e genere:
«Quarto quantum ad usum loquentium, et sic “benefacit” producta penultima est proprie dictum, cum tamen “facio”habeat primam brevem. Et simille contingit in pluribus vulgaribus et quantum ad genus masculinum vel femininum et quantum ad breviationem et longationern sillabarum. In vulgari enim gallico “dens” est generis feminini et “copia” producit penultimam, et in florentino “ordo” est
generis ferninini et “Agatha” producit penultimam» (qui l’ed. è scorretta al punto da compromettere il senso).V. VÄÄNÄNEN, Introduction au latin vulgaire, Paris 1981, 32: tendenza a riportare l'accento tonico sulla radicale neiverbi compositi (benefàcit). «Per altra ordine», «ordini angeliche», dice Giordano da Pisa (Quaresimale fiorentino 24/156, 370/73, 498-99).
Come già segnalato altrove, Remigio conta ventitre lettere d’alfabeto nel suo latino, e ne fa coerente uso quale criterio d’ordine negli strumenti di consultazione: nell’indice alfabetico dei santi “non solenni” del santorale cod. D, nelle Distinctiones e nel repertorio, anch’esso alfabetico, dei lemmi teologici della tavola annessa all’Extractio questionum per alphabetum di cod. G3:
a b c d e f g h i k 1 m n o p q r s tu x y ç
(cf. Il Repertorio, MD 11 (1980) 643-44; Un’introduzione, MD 12 (1981) 31-32; Studio 271-83; per l’uso dell’alfabeto come criterio d’ordinamento in strumentidi consultazione nel XIII secolo vedi: R.H. e M.A. ROUSE, Preachers, Florilegia and Sermons: Studies on the ‘Manipulus florum’ of Thomas of Ireland, Toronto 1979, 34-36 e passim).Bisogna aggiungere, nel discorso dell’equipaggiamento
filologico, che Remigio non conosce né ebraico né greco. Le derivationes dall’ebraico e dal greco - spesso deformategraficamente e semanticamente - gli arrivano tramite strumenti comuni e di facile accesso all’intellettuale del tempo: Glossa biblica, testi patristici, Etymologiae d’Isidoro da Siviglia, rifacimenti e ampliamenti nel XII-XIII secolo del Liber interpretationis bebraicorum nominum di san Girolamo, quale quello molto diffuso, e che si ritrova in calce alle bibbie medievali, attribuito a Stefano Langton († 1228), opere lessicografiche di Papia il Lombardo, Uguccione da Pisa, Eberardo da Béthune, Guglielmo il Bretone, traduzioni greco-latine delle opere
d’Aristotele, Dionigi Areopagita, Giovanni Damasceno, e glosse o commenti alle medesime. Mentre ci sono buoni indizi per pensare che Remigio - che aveva trascorso due lunghi periodi a Parigi - avesse appreso il volgare francese. Ben conosciuto è il testo del De bono comuni (28,11-14) in cui ironizzando sulla pronuncia cittadina «Firençe» («Fiorença» per gli estranei) dice che i francesi al sentore di puzzo si otturano il naso e fanno «fi fi». E or ora si è riportato il brano dal De pecc. us. in cui si annota che «dens» è di genere femminile nel volgare gallico. Altrove sono documentati brevi interventi in volgare francese: «rogge idest rubeus secundum linguam gallicam» (Sermoni LI). «Exemplum de Gallicis qui comuniter in vulgari vocant patrem dominum suum scilicet monsegnor, et matrem dominam suam scilicet madame» (De via par. f. 266va). E sempre nel De via paradisi si racconta per esteso un’arguta storiella. L’arguzia è chiusa nella battuta finale; la scioglie chi sa il volgare francese.
Moffla Ghant«Unde dicitur quod quidam
magnus prelatus in Franciaerat multum familiaris unidemoni, a quo multa bonatemporalia et prosperaconsecutus, semel instanterpetivit ab eo de loco suemortis ut ipsum fugereposset. Qui respondit quod siposset declinare quandamterram nomine Moffla, numquammoreretur. Qui diligenterattendens si aliqua sicvocaretur et nullaminveniens, securus vivebat.Tandem pervenit ad quandamterram Gandavum nomine, que
Un prelato francese d'altorango pregò un demonio, col quale intratteneva buoni rapporti, di rivelargli il luogo della propria morte perpoterne stare lontano. Il demonio gli disse: «Tieniti lontano dalla città di Moffla, e non vedrai mai la morte!». «Una città di nome Moffla? - si disse il prelato-; ma non esiste!». E si misel’animo in pace. Una volta pervenne a una città chiamataGhant in volgare gallico, e lì cadde malato senza speranza alcuna, a giudizio
in vulgari gallico vocaturGhant, in qua infirmatus est,et medicis desperatisadvocavit demonem petens abeo si moreretur; quorespondente quod sic, etprelato increpante etredarguente mendacii subdiditdemon: “Moffla et Ghant ceest tout un”» (cod. C, f.218rb).
dei medici. Si rivolse alloraal demonio e gli chiese se doveva veramente morire. «Sì», gli disse costui. Il prelato protestò per l'inganno subìto, ma il demonio soggiunse: «Moffla (mouffle) e Ghant (gant) è lamedesima cosa!».
■ «Moffla et Ghant ce est tout un»: "le mouffle" = guanto (gant!); per lo più di lana senza diti, salvo il pollice. B. KRINGS, Das Ordensrecht der Prämonstratenser vom späten 12. Jahrhundert bis zum Jahr 1227, «Analecta Praemonstratensia» 69 (1993) 192 (De vestitu): «Mufflas de panno foratas pelle, sustinemus haberi pro frigore repellendo, et mufflas de corio spisso tantummodo in labore». «Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique» 19 (1981) 1005-1058.J.G.TH. GRAESSE - F. BENEDICT, Orbis latinus, Berlin 1922, 133: "Gantum, Ganda, Gandavum, Canda": Gent (Gand), oggi in Oost-Vlaanderen, Fiandra belga. G.-G. MEERSSEMAN, AFP 17 (1947) 5-40 (istallazioni domenicane nelle Fiandre, cartina in p. 17).■ Gand/Gent sonava guanto su bocche toscane. DANTE, Purg. XX, 46:«Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia», rispettivamente Douai,Lille, Gand e Bruges. VILLANI † 1348, Nuova cronica IX, 20, 31 «poi n'andò a Guanto, però che Bruggia non era forte…», e moltealtre volte (vol. II, 39-40, 862).A. CASTELLANI, Capitoli d’un’introduzione alla grammatica storica italiana. II: L’elemento germanico, «Studi linguistici italiani» 11 (1985) p. 180: "guanto/Want".■ ... e il toponimo fiorentino "Via Osteria del Guanto", traversa di Via dei Neri, a quale radice linguistica rimonta? Antica residenza della natio gandensis? mercanti e pellegrini di Gand che facevano sosta in Firenze - penso tra me e me. Ho provato a chiederlo agli attuali abitanti della Via; sorridono e mi rispondono "O guanto che significa? guanto, noh!", ed esibiscono le mani!
Ma nell’insieme, la preparazione filologica di Remigio non va oltre quella comune dell’intellettuale della schola del suo tempo, dall’attività prevalentemente riflessivo-teoretica. I limiti, nel settore filologico, sono segnati dalle sue stesse fonti principali: Etymologiae d’Isidoro, Elementarium (1040-50) di Papia il Lombardo, Derivationes (1192-1200) d’Uguccione da Pisa, cui si può aggiungere il Graecismus (fine XII - inizio XIII sec.) di Eberardo da Béthune e l’Expositiones vocabulorum biblie (1250-70) di Guglielmo il Bretone. Nel De subiecto theologie (rr. 398.401) si ha più volte intentio nel senso di intensio; la giustificazione è data altrove, e Remigio dà prova di non disporre di conoscenze linguistiche e di fonti letterarie oltre quelle d’un Uguccione: «... licet secundum usum loquendi, qui in talibus observandus est, non dicatur “intentio” sed “intensio”, ut patet per Philosophum in pluribus locis. Quamvis enim hoc verbum “intendo” habeat utrumque suppinum, scilicet intentum et intensum, tamen in ista significatione acceptum facit suppinum “intensum’, ut dicit Huguiccio» (De modis rerum f. 37va; cf. Uguccione, Derivationes II, 1205 § 9). Ma grave è l’atteggiamento, si direbbe, fideistico davanti a problemi di critica testuale,quando altrove - nella speculazione filosofico-teologica, ad esempio - si dà prova d’audacia intellettuale; un fideismo propiziato dalla sprovvedutezza filologica. Il caso può essere ampiamente illustrato nei riguardi del testo biblico della Volgata. Se Remigio fa frequente uso dilezioni alternative («alia litera», «alia translatio»... ) - che trovava a portata di mano ai margini della propria bibbia, nei correctoria o nelle fonti comuni quali la Glossa ecc. - dall’altra parte dà l’impressione di non poter ammettere (né forse ne intravvedeva il meccanismo) corruzioni nella trasmissione del testo, tanto meno falle nella traduzione. «Sermonem quem audistis non est meus» di Io. 14,24 potrà risultare «incongruus» secondo la grammatica di Donato e di Prisciano (che vorrebbe «sermo»),non secondo la «grammatica di Dio» (Contra fals. 2,13-22). E s’invoca il celebre brano del prologo ai Moralia di Gregorio
Magno: «È indegno costringere le parole dell’oracolo celeste entro le regole di Donato» (ib. 2,24-26; cod. G4, f. 302ra). Il sibillino «illic advocare» di Eccli. 32,15 è difeso, contro chi volesse emendare in «illic advoca», con un generico ricorso alla «gramatica antiqua» (cod. G4, f. 362rb: Studio 202; cod. G4, f. 302rb) (Cf. UGO DA SAN CARO, Postille in Eccli. 32,15: vel advocare «deponens secundum antiquam grammaticam, idest advocatus esto contra teipsum...»: ed. Venetiis 1703, vol. III, f. 234va).
È vero che talvolta si trova a respingere emendazioni, prevalentemente di congettura, che peccavano della medesimaingenuità nei riguardi della critica del testo. Chi voleva emendare «Cumque revertissent» di Dan. 13,14 in «Cumque reversi essent» non mostrava se intendesse ricostituire la lezione originale della Volgata con l’ausilio d’una testimonianza manoscritta o se emendasse sulla base d’un modello di norme morfologiche remote al dettato latino della Volgata (cf. cod. G4, f. 302rb). Eppure i contributi d’uno Stefano Langton, d’un Ruggero Bacone, d’un Ugo da SanCaro e sua équipe di Saint-Jacques, d’un Guglielmo de la Mare, ai primi elementi di critica del testo biblico potevano temperare l’imbarazzo d’un Remigio - come d’altri al pari di lui - di fronte ai problemi della restituzione del testo (cf. S. TIMPANARO, La genesi del metodo del Lachmann, Padova 1985). Il caso di Sap. 9,4 intrattiene più a lungo l’autore e permette di cogliere meglio l’attitudine di costui di fronte ai problemi di critica testuale. «Da michi, Domine, sedium tuarum assistricem sapientiam» è il testo di Sap. 9,4 riportato da Remigio (l’edizione critica della Volgata ha: «Da mihi sedium tuarum adsistricem sapientiam»: vol. XII, Roma 1964, p. 55; «Donne-moi celle qui partage ton trône, la Sagesse», traduce la Bible de Jérusalem). Remigio commenta: sebbene una sia la «sede della maestà divina in forza d’una sola essenza, tuttavia isedenti sono molteplici in forza delle persone divine», cosicché «sedium» può esser glossato «idest sedentium»; oppure, e meglio, il plurale può essere inteso al singolare«idest “sedis tue’». E sotto la scorta d’una veneranda
tradizione esegetica, l’esito risulta non indecoroso per uno scolastico e gli strumenti filologici di cui disponeva.Ma segue poi una discussione che si sposta dal terreno dell’esegesi a quello della critica del testo. Uguccione daPisa aveva sostenuto nelle Derivationes «Assistrix -cis idestastitrix ab asistendo» (cf. Uguccione, Derivationes, ed. Firenze 2004, II, 102). Sfruttando il suggerimento di quest’ultimo, il francescano Guglielmo il Bretone, nelle Expositiones vocabulorum biblie (1250-70), aveva proposto d’emendare assistricem di Sap. 9,4 in astitricem argomentando che sisto e composti non hanno né preterito né supino da cuitrarre il sostantivo verbale assistrix (il quale «nichil est»), mentre astitrix è derivabile da asto -as (ed. L.W. Daly and B.A. Daly, Padova 1975, I, 67-68). Remigio respinge drasticamente la proposta d’emendazione ma rifugge dal misurarsi con le ragioni grammaticali di Guglielmo, né d’altronde contesta l’emendazione col ricorso alla testimonianza della tradizione del testo, che pure gli davaragione. Detto che Uguccione «salva gratia sua hic minus sapienter dixit» e che Guglielmo il Bretone «eum sequendo insipienter britoniçavit», ripiega in un’argomentazione d’evasione, quasi una confessione di fideismo nei confrontidel testo biblico:
«Si enim [“assistrix”] non potest formari a preterito vel a supino verbi, secundum gramaticam Prisciani vel Donati, formetur a presenti scilicet ab “assisto”, vel potius remaneat informatum secundum gramaticam Dei. “Indignum enim vehementer existimo ut verba celestis oraculi restringam sub regulis Donati”, ut dicit Gregorius in prologo Moralium. Temerarius namque reputari deberet qui vellet distinctionem illam a doctoribus approbatam ex longa consuetudine, qua dicunt quod est “opus operans” et “opus operatum”, reprebendere, quia secundum Donatum et Priscianum “operor” est deponens et non verbum comune... » (cod. G4, f. 302ra-b: testi in Il De subiecto theologie, Append. b rr. 124-37).
Vero è che poi assai coraggiosamente rivendica a nuove forme di pensiero il diritto di nuove forme di linguaggio:
«Quinimmo cum gramatica sit inferior omni alia scientia quasi omnium famula, nulla alia scientia astringitur quin possit formare nova vocabula et sub aliis accentibus, quam sicut in comuni gramatica approbata, admagis exprimendum suam intentionem. “Oportet enim figerenomina’, sicut dicit Philosophus in Predicamentorum » (ib. rr. 148-53).Ma perché non prendere sul serio e sul medesimo terreno
le istanze della scienza grammaticale, quando questa da tempo era stata introdotta con profitto a servizio dell’intelligenza critica del linguaggio della bibbia e della fede espresso nel linguaggio dell’uomo? Il grammaticoDonato aveva già ricondotto il virgiliano «Urbem quam statuo vestra est, subducite naves» (Aen. I,573) alla teoria grammaticale del solecismo nella flessione dei casi (Ars grammatica III,2: ed. L. Holtz, Paris 1981, 656 r. 15);e Sedulio Scoto - per fare un solo esempio - vi aveva trovato congrua interpretazione del solecismo della volgatanel caso di Io. 14,24: «Per casus [scil. fiunt soloecismi], sicut “Urbem quam statuo vestra est, subducite naves”, pro “Urbs”. Posuit accusativum pro nominativo. Et tale illud inevangelio [Io. 14,24]: et sermonem quem audistis pro eo quod est “sermo quem audistis”. Nam tertia persona, quod dicitur“est”, non accusativurn sed nominativum desiderat, ut sit recta constructio “vestra est urbs quam statuo”, sed “urbem” propter metricam necessitatem, ut versus stare queat, composuit» (SEDULIO SCOTO, In Donati Artem maiorem III:ed. B. Löfstedt, «Corpus Christianorum» Mediaev. 40 B, p. 343 rr. 90-97).
V. VÄÄNÄNEN, Introduction au latin vulgaire, Paris 1981, 160-61, sull'attrazione del relativo. Annoto che Papias, Bricto e Ughuccio erano registrati nell’antico inventario, metàXIV secolo, della biblioteca di SMN (POMARO, Censimento I, 327).
16. Caratteristiche grafologiche di Remigio
Ed ecco un saggio di recensione dei fenomeni grafologicipiù caratteristici del latino di Remigio. Come si vedrà, gran parte risulta comune alla grafia latina del XIII secolo; qua e là si possono scorgere fenomeni specifici dell'influsso della fonetica romanza e verosimilmente del volgare fiorentino.
■ Pertinentissimo confronto coi trattatelli didattici De dictionibus proferendis sive de accentu, De dictionibus scribendis sive de ortographya, di Bartolomeo da San Concordio OP († 1346): → leggi e confronta. http://www.e-theca.net/emiliopanella/nomen1/bartsc.htm http://archivio.smn.it/emiliopanella/nomen1/bartsc.htm
IACOPO PASSAVANTI, Lo specchio della vera penitenzia [1354-57 ca.], ed.critica a c. di G. Auzzas, Firenze (Accademia della Crusca) 2014, pp. 201-04.La prima forma che precede la parentesi acuta è quella
dei testi remigiani; per i lessemi frequentissimi e costanti non si danno rimandi; semmai si segnalano forme che si scostano dalla norma della lingua dell'autore, o forme concorrenti, di cui - quando possibile - si indica lafrequenza prevalente.
c < ccbucella (cod. D, f. 357va), oculta (Quol. II, 10, f.
86vb), Machabei (cod. D, f. 388vb); aceptis di Contra fals. 82,42 è corretto in acceptis.
In volgare: arrichamento (cod. D, f. 96vb), richo (cod. D,f. 379rb), legàci (Postille f. 222ra).
c < chcaritas (costante), carismata (cod. D, f. 102vb; karismata:
ib. f. 77va), cirographus (cod. D, f. 278 v, mg, inf., B: Studio 237 r. 54), cirotheca, cirurgia, Crisostomus, cronica, mecanicus(cod. D, f. 40ra.b) contro il comune mechanicus, scisma, scismaticus, scola, scolasticus, stomacus e stomachus.
c < x greco
acirologia (Postille f. 226vb; Uguccione, Derivationes II, 21), sciphus e scifus (cod. C, f. 129rb; G4, f. 361ra).
c < gdocmatiçare (De via par. f. 273vb), ma dogma (cod. G4, f.
407vb). «Sicut sunt aliqui qui vivunt de morientibus sicut quidam clerici et religiosi, et sunt aliqui qui sanantur deegrotantibus sicut medici, ita sunt aliqui qui pacantur de litigantibus ut advocati» (cod. G4, f. 139rb).
cc < caccumine in cod. G3, f. 117va ed espunge prima c, ma
acumen (Quol. I, 1 ad 2; cod. E, f. 13v, mg. inf., 11); in Quol. II, 12, f. 87va accutissimas è corretto in acutissimas (accutis in Tommso d'Aq., Tabula Ethic. D 133: ed Leonina 48, B86a); occeanus (Contra fals. 78,40; cod. D, f. 344v, mg. sup., B)
ch < x grecoachademia (Contra fals. 83,20), Marchus (Div. sc. 16,40; De
bono com. 9,10; cod. D, f. 138va) ma Marcus (De bono com. 9,18; 10,9); Nicholaus prevale su Nicolaus; Nichomachus (Div. sc. 12,25), ychonomica (Div. sc. 14,16.18.22; cod. D, f. 279va) ma yconomica (cod. G4, f. 304ra).
ch in volgare per la velare sorda: arrichamento, richo, rechare, manchare...
ch <hmichi, nichil, nichilominus sono costanti quando appaiono
scritti a piene lettere.
ch - crpulcher, pulcherrimus: costante per la velare sorda+e; ma
pulcer (senza che si debba sospettare il suono palatale) duevolte in Postille f. 373r, mg. sup., mano B (pulcer anche in Tommso d'Aq., ed. Leonina 47/1, p. 192*); pulcra, pulcro, pulcritudo... nel caso di velare sorda+r (nelle edizioni si nota la tendenza, ingiustificata, a ridurre er in chr); sepulchrum (BNP f. 208va) e sepulcrum (cod. D, f. 374v, mg. sup. e sin., B).
ci < tidiscaltiatus (cod. G4, f. 75v, mg. inf., A) e discalciatus
(Sermoni XLI), diucius (De sub. theol. 512), eciam (De uno esse 266,36), vicium (Quol. II, 12, f. 87va).
co < quocotidianus; vedi cu<quu, go<guo, gu<guu, -qus<-quus
ct - tPictagora (Div. sc. 12, 24); casi d'iperetimologismo:
implectio (=impletio) (Quol. II, 12, f. 87va), subvenctione poi corretto in subventione (Quol. II, 4, f. 83vb; addictio per additio in Tommso d'Aq., ed. Leonina 22/1, p. 173*). Vedi anche sotto t<ct.
ct - ttlictera e littera compaiono contro la più frequente litera;
illicterato è corretto in illiterato (cod. D, f. 188vb); mictere ecomposti admictere, commictere, dimictere, intromictere, omictere, premictere, pretermictere... sono frequentissimi; ma ricorre anche la forma in -tt-.
cu < quulocuntur e locuti, secuntur e secuti forme più frequenti; ma
compaiono anche loquuntur (cod. G3, f. 184va), loquutus (cod.D, f. 172ra) sequuti (cod. D, f. 97rb, f. 97vb più volte); excocuntur (Quol. II, 10, f. 86rb). Fenomeno della caduta della semiconsonantica u in iato: cf. NORBERG 85; ROHLFS 415-16; vedi anche go<gou, gu<guu, -qus<-quus.
dittonghiI dittonghi nel mediolatino sono ridotti, come si sa, in
monottonghi; ma poche volte compaiono anch'essi e quasi sempre in citazioni: Boeotius (Div. sc. 16,37) e oereas (Div. sc.16,27) da Isidoro da Siviglia; pure conscientiae si ha in Contra fals. 47,62 dalla Glossa biblica.
d < ddadiscere (costante), Engadi (Postille f. 227rb, f. 227va e
ss.); trovo sempre quiditas (De uno esse 263,36 e passim; De
mixtione elem. f. 13ra; Quol. I, 3, f. 74ra; De pecc. us. 619-20più volte, dove l'ed. riduce in quidditas).
-d <-tcapud (De sub. theol. 270.363; cod. D, f. 159ra), inquid
(Div. sc. 11,13), reliquid (cod. D, f. 10Orb), velud (De via par. f. 343/4va 2 volte); ma comunemente con finale -t. Ben diffuso fenomeno di sonorizzazione della dentale finale sorda (cf. NORBERG 85).
In volgare è sonorizzato amadori (De via par. f. 295rb).
e <iBonefatius (De miser. c. 11, f. 201va; c. 12, f. 201vb),
emunitas (=immunitas) (De bono pacis 57,13; 65,6; Cf. STRECKER24), omelia (costante), vendicat (Div. sc. 4,12), vendicans (Contra fals. 75,34; Postille f. 226vb).
In volgare mescuglio (cod. D, f. 5r, mg. inf., B), meglior(cod. D, f. 96vb).
e < oEsiren (= Osirim) (Div. sc. 16,45); il medesimo testo che
porta Exonie (cod. G4, f. 405rb, mano A) ritrascritto dal medesimo copista in cod. G4 ha Oxonie (cf. Dibattito, AFP 1980, 97).
e < yanaleticorum (De sub. theol. 345); così anche
nell'Elementarium di Papia usatissimo da Remigio (ed. V. De Angelis, Milano 1978, p. 235, AN 23) e così nelle edizioni critiche dei testi scolastici con grafia non normalizzata: «Aristoteles Latinus» IV/1-4, pp. 5, 112, 285, 413; Tommso d'Aq., ed. Leonina 48, B 143a; 47/1, p. 193*. Cf. STRECKER 31.
f <phcostanti fantasia, fantasma; dyafonus e dyaphonus; methafora
e methaphora (quest'ultima prevale); methafisica una volta inDiv. sc. 4,28 contro la prevalente methaphisica, almeno quando appare in piene lettere; Porfirius prevale su Porphirius; fiala (De pecc. us. 658,23); scifus (De contrar. pecc. f. 129rb) e sciphus
(ib. f. 129rb; De pace IX, f. 361ra). L'Elementarium di Papiaalterna f e digramma etimologico (cf. ed. cit. p. XLVII); nelle Summa Britonis p. 565 si legge: «Phiala... incipit ab f littera et non a ph».
ff < fEffraym (Distinct. 309 e altrove).
geminazione fonosintatticaIn volgare: nonn è (cod. G4, f. 407rb); k'è lloro (cod. G4,
f. 3ra.b).
g < cLigurgus (Div. sc. 14,35), Nabugodonosor (cod. D, f.
404vb): sonorizzazione di c intervocalica del tipo Dugento (cf. NORBERG 142 e testi sul volgare fiorentino).
go < guolangor (= languor) (Postille f. 229ra 2 volte, f. 229va 4
volte). Rime -cor e -quor, -quus e -cus rivelano un fenomenofonetico dietro quello grafologico (cf. NORBERG 85).
gu < guudistingunt sembra costante o comunque prevale; mentre
arguuntur (De sub. theol. 464).
h < -Frequenti i casi di scritture aspirate iperetimologiche:
abhominatio (Contra fals. 68,23; 78,212.214), abhominabiles (De bono com. 33,14), archa, exhosus (Postille f. 224vb), emphireus più frequente di empireus, habundare e habundanter (costanti e veniva fatto derivare da habere); hedificium (Postille f. 224vb) ma edificium corretto da hedificium in cod. D, f. 98ra (5 volte), Helias, heremita (Quol. II, 14, f. 88vb; Contra fals. 76,195), hethnicus (= ethnicus) (Contra fals. 78,181), humectare (Quol. II, 8, f. 85rb), hyronia ( (Quol. I, 3, f. 74va), Hysidorus (De bono pacis 62,6; De miser. c. 24, f. 205vb)contro il comune Ysidorus, inhermis (Contra fals. 57,18) ma inermis (De pace IX, cod. G4, f. 360va), nicbilhominus (Div. sc. 15,17 emendato, De via par. f. 213ra), prohemium (Div. sc. 7,7),
sepulchrum (BNP f. 208va) e sepulcrum (cod. D, f. 374v, mg. sup. e sin., B).
- < hAltrettanto frequente la caduta di h: actenus (cod. G4,
f. 318 ra), arena (cod. G4, f. 300vb), carta (Div. sc. 11,37), ebdomas, epar (Quol. II, 10, f. 85vb ss.), exalare (=exhalare) (Postille f. 225va), ierarchia, Ieronimus, incoare (Quol.I, 10, f. 79ra; cod. G4, f. 332vb, f. 335vb, f, 355v, mg. s., B) contro il più frequente inchoare, omelia, ortus (= hortus), spera (= sphera), Ylarius (cod. D, f. 356rb) contro ilcomune Hyllarius, yllaritas (Postille f. 288va) contro la più frequente hyllaritas-hylaritas; in tutte le iniziali con ipsilon: ydor, ydromantia, ypallage, Ypocrates, ypostasis, ypothesis...Vedi anche c<ch, ch, f<ph, t<th, th<t.
hii e hiis sono costanti contro le forme hi e his.
i < eSempre Aristotiles quando a piene lettere (Div. sc. 17,110;
Contra fals. 83,14; forma prevalente negli scrittori scolastici), benivolus e benivolentia (costanti), discalciatus, discaltiatus, egistas (= egestas) (De miser. c. 11, f. 201rb), malivolentia e malivolus (De pecc. us. 642, 30.35; 644,36; Postillef. 224vb), nigromantia (Div. sc. 18,116.117; 20,16.23.32), Virgilius (Div. sc. 16,40; cod. G4, f. 390r, mg. s., B).
i < yabissus, colirium, Crisostomus, cristallum, Egiptus (ma anche
Egyptus), elemosina, entimema, ethimologia, martir e martirium (ma martyrium in Postille f. 227rb); mirra, misterium, mistice, misticus (ma mysticus in Postille f. 221ra.b, f. 222rb), nimpha (Div. sc.17,103; cod. D, f. 278ra) e paranimphus (Distinct. 427), phiton (Div. sc. 20,33.43) e phyton (ib. 20,17.31), piromantia (Div. sc. 18,70) e pyromantia (ib. 20,16), pir (De pecc. us. 641,17) e pyr (Div. sc. 18,70), presbiter, rithmus, rismicus (Div. sc. 13,29; Contra fals. 39,16: in apparato usmicam leggi rismicam), sciphus e scifus, sillogismus, simbolum (ma symbolum: Postille f. 221ra, più volte), sinagoga e synagoga, sinonimus (De modis rerum f. 43ra ss), tirannus (ma tyrannus in De miser.
c. 3, f. 198rb: citazione da Seneca; BNP f. 205ra). Nell'Elementarium di Papia y è recensito in i (ed. De Angelis p. XLVIII). Spunti per il trattamento della ipsilon, e d'altre lettere greche, nelle traduzioni greco-latine in «Aristoteles Latinus» XXXIII (1968) pp. XII-XIV. Vedi anchesotto lettera y.
ie < eGalienus (costante; Cf. volgare Galieno in DANTE, Conv. 1,
VIII, 5; Inf. IV, 143; latino Galenus in Monarch. I, XIII, 6); abhorriebit (=abhorrebit) (Contra fals. 47,145; cf. STRECKER 32).
In volgare, dittongazione di e tonica in priego (De pace I, cod. G4, f. 357rb; cf. ROHLFS 102).
kalkimia, alkimicum (ma alchimicum in De pecc. us. 632,27),
kalende, kalendarius (cod. D, f. 34vb), kari, karissimi (ma carissimi in Speculum f. 136vb), Karolus e Carolus, karismata (cod. D, f. 77va), Katerina (cod. D, f. 357vb) e Caterina (cod. D, f. 357vb). Altri grafemi per la velare sorda: ch, ca, co, cu.
In volgare apparekiata (cod. D, f. 397v, mg. s., B), ke (= che) (cod. G4, f. 407rb), ki (= chi) (cod. G4, f. 129rb),kiama (cod. G4, f. 69va), «qui scilicct vulgo vocantur moskettus et smerlius» (De via par. f. 263ra).
l < llApoline (Div. sc. 18,108) ma Apollo (ib. 8,4; 20,43; De bono
com. 10,26, Appolinaris (cod. D, f. 374r, mg. inf. 2 volte; Appolenaris in BOCCADIBUE 85), Apolinaris (cod. G3, f. 57vb), colecta (Contra fals. 98,22) contro la più comune collecta, colirium (cod. D, f. 14vb), difficilimum (Contra fals. 65,68; Quol. I, 7, f. 76va; similimus in Tommso d'Aq., ed. Leonina 48, B 27b; Cf. EBERARDO DA BÉTHUNE, Graecismus XXV, 309-310:ed. Wrobel p. 232) ma difficillimum (De pecc. us. 622,34; cod. G3, f. 29ra; cod. D, f. 357r, mg. d., B) e facillimum (Contra fals. 78,6), equipolenti (De bono com. 12,4) ma equipollent (cod.E, f. 13va più volte), Salustius (De contrar. pecc. f. 128vb;
Speculum f. 154rb; cod. D, f. 404rb; De bono com. 5,20; De bono pacis 56,4), solempnis e solempnitas comuni contro le raresollempnitas, sollempniter (cod. G4, f. 353ra; cod. D, f. 323va).
In volgare pelegrinagio (cod. G4, f. 21va); ma potrebbe essere interpretato come esito della dissimilazione consonantica della liquida (peregrinus).
-lgl- suono palatale in volgareelgli (Div. sc. 15,7), ma meglior (cod. D, f. 96vb), mescuglio
(cod. D, f. 5r, mg. infl, B), simigliança (cod. G4, f. 399ra), toglie (cod. D, f. 333rb). Cf. CASTELLANI c BOCCADIBUE passim.
li →denotativo romanzo di lessema
ll < lexillarat -ret (Contra fals. 44,77 mano B; 47,166 mano A) ma
exilarat (ib. 40,105 mano A); hyllaris, hyllaritas, yllaritas (Contra fals. 97,64; Postille f. 228va) contro hylaris (De miser. c. 17, f. 203va) hylaritate (De miser. c. 17, f. 203va) e hylariter (cod. D, f. 304va); Hyllarius di gran lunga più frequente di Hylarius (cod. G4, f. 305rb) e Ylarius (cod. D, f. 356rb); pollitico corretto in politico (Quol. II, 11, f. 86vb); Quintillianus (Div. sc. 17, 111); sepelliendus (cod. G4, f. 383rb), sepelliatur e sepellietur con la prima 1 espunta in De pecc. us. 633,26.26-27, ma sepeliendo (De miser. c. 17, f. 203vb) e sepelivimus (cod. G4, f. 238vb); simille in De pecc. us.624,4 (l'ed. ha simillime), e simille era stato scritto in Contra fals. 98,55 corretto poi in simile.
m < mmI frequentissimi comunis, comunio, comunicare con derivati
e composti, sono sempre scritti con consonante scempia (e così appaiono nei testi fiorentini del XIII secolo in latino e volgare); segnalo rarissimi casi in contrario: communis (mano A: De modis rerum f. 28vb; cod. D, f. 137va, f. 138ra; mano Z: cod. E, f. 12vb), communiter (mano Z: cod. E, f. 12vb); costante anche gramatica; accomodare e comodum appaiono contro i più frequenti accommodare e
commodum; Emanuel (De via par. f. 227r, mg. d., B), Emaus (Distinct. 245, mano B; cod. G4, f. 77rb, mag. ing., B); imo (Div. sc. 11,23; Postille 221va) e ymo (De uno esse 261,14-15, ymmo l'ed.) contro il più comune immo. Cf. Summa Britonis 630: «Item [Papias] scribit immo per duplex m et bene».
mm < msummere e composti (assummere, consummere, presummere,
resummere ... ) si alternano, talvolta a brevissima distanza, con la scrittura scempia; ma l'alta frequenza della forma geminata presso tutte le mani, compresa B, e intutti i codici esclude una svista di copia (probabilmente era foneticamente contaminata con summare, consummare ecc.;Summa Britonis 158: «Et consummare ponitur pro consumere» (cf. summere in GIORDANO DA PISA, Quaresimale p. CXXXVII); ammisisset (= amisisset) (De via par. f. 231va), Numma (Div. sc. 14,36).
mp: vedi sotto np
mpnCaso della p interconsonantica a scopo eufonico (cf.
NORBERG 16,159,223); costanti le scritture dampnare, dampnum, dampnatio, calumpnia, columpna, solempnis, sompnium, sompnus ... ; hympnus in Postille f. 221ra, bymnus ib. f. 221va. Summa Britonis 735-36: «Et addit [Huguitio] quod predicta vocabula debeant scribi per unum l et per duo n et numquam per m vel per p, ut scribatur solennis, solennitas. Hoc autem non observatur communiter ab omnibus propter euphoniam et ut prima sillaba ostendatur producta per positionem». Cf. Uguccione da Pisa, Derivationes, ed. Firenze 2004, II, 1109.
http://www.e-theca.net/emiliopanella/nomen1/bartsc.htmhttp://archivio.smn.it/emiliopanella/nomen1/bartsc.htmmptpromptius, temptare, temptatio, redemptio (corretto da
rede(n)tio in Contra fals. 45-60), ydemptitas; il nesso dà luogo a casi di contaminazione: si ha contempti col significato dicontenti in Contra fals. 44,43 (cf. NORBERG 159) mentre, ib.
75,33, si scrive contenptus e si espunge la p; «contempta idest spreççata» (cod. D, f. 397v, mg. s., mano B).
- < m, n (caduta della nasale preconsonantica)costellatio (Div. sc. 20,18; altrove constellatio), frequentatibus
(= frequentantibus) (Contra fals. 76,180), impiguatur (= impinguatur) (Studio 102), substetari (= substentari) (De bono com. 26,13), sibolo (symbolo) (Contra fals. 1,15) e sybolo (cod.G3, f. 116ra).
In volgare: no· intende (cod. G4, f. 407rb), co· la mostra (ib.) mentre altrove con la palma (ib. f. 106rb).
ngn = nasale palataleOltre alla scrittura più frequente -gn-, ricorre -ngn-
ben documentata sia in latino medievale che in volgare fiorentino: congnosco e congnitio (Div. sc. 10,31; 13,34; 16,10;18,52.53; De sub. theol. 220; Quol. I, 1, f. 72rb; 11, 5, f. 84ra, f. 84rb; De bono pacis 63,24; Prologus XLVIII rr. 37, 62, 64, 65: in MD 1981, 123-24; cod. E, f. 44va più volte, f. 44vb più volte; Postille f. 221ra più volte; cod. D, f. 97va; in De bono com. 22,24 e 23,20 la prima n è espunta); beningnantur (cod. G3, f. 184va), beningne (cod. G4, f. 184va), lingnum (Contra fals. 41,37 corretto dall'ed.), recongnoscere (Postille f. 230va; cod. D, f. 14rb, f. 358ra), singna con prima n espunta in De via par. f. 231va (cf. gingnitin Tommso d'Aq., ed. Leonina 22/1, p. 14*).
In volgare ongne (= ogni) (cod. D, f. 333rb), sengni (cod. G4, f. 407rb); ma conpagnia (cod. G4, f. 407rb), pugnerecciole (cod. G4, 55vb), vegna (cod. D, f. 153vb).
nasale preconsonanticaLa nasale preconsonantica, di altissima frequenza, è
nella maggior parte dei casi coperta dall'abbreviazione; recensisco pertanto solo i casi in cui compare scritta in extenso, tenendo presente che le edizioni hanno d'abitudinenormalizzato.
nb
anbiguus (cod. G4, f. 408vb), conbinatio (De bono pacis 68,4; in 67,20 conbinatione dell'ed. è sotto abbreviazione nell'originale).
nmconmendatur (cod. D, f. 358ra), conmictere (cod. G4, f.
279rb), genmula (cod. G4, f. 399va), inflanmat (Contra fals. 40,76), inmaterialibus (Div. sc. 7,5), inmediate (cod. G3, f. 163vb; cod. G4, f. 227vb, f. 406ra, f. 406rb), inmediatius (De sub. theol. 211), inmemores (De bono com. 21,3), inmicte (Demiser. c. 2, f. 197rb), inmisit (Postille f. 221ra; cod. G4, f. 314vb), inmixtus (cod. G4, f. 242va), inmo (Contra fals. 47,149; 60,11: normalizzato in immo dall'ed.), inmobilibus (Div. sc. 7,4-5; De modis rerum f. 56rb), inmoderatus (cod. D, f. 137rb), inmunditia (cod. G4, f. 305ra).
mmimmensitas (BNP f. 208vb).
nn < mnonnibus (cod. D, f. 42rb; ma altrove il lessema,
frequentissimo, è sempre abbreviato per contrazione) (cf. NORBERG 31).
npcānpi con n espunta, si legge in cod. G4, f. 397va;
conponitur (Contra fals. 82,50: ridotto in mp dall'ed.), enplastro (cod. D, f. 14vb), inpediatur (De pecc. us. 620,31: ridotto in mp dall'ed.), inpediuntur due volte con tratto d'abbreviazione su i e n espunta (De pecc. us. 620,25.26), inpedimentum (cod. G3, f. 163vb con abbreviazione su i e n espunta; cod. G4, f. 305ra, f. 406rb), inpense (De miser. c. 9, f. 201ra), inperator (Contra fals. 11,13; 14,5.30.42; 15,13;De bono pacis 63,6: sempre ridotto in mp nelle edd.), inperfectio -ctus (Speculum f. 153va; cod. G3, f. 95va, f. 130va, f. 131ra; cod. D, f. 99v, mg. inf., B), inpermixtus (Prologus XLVIII r. 49: MD 1981, 123), inpertinenter (De sub. theol. 641), inpetrabit (De pace I, cod. G4, i. 357va), inpetratio (cod. D, f. 120va), inpetus (De bono com. 11,2), inpingat (De pace 1, cod. G4, f. 357va), inpinguatur (De
pace IV, cod. G4, f. 359ra), inpio (De pace IV, cod. G4, f.358rb: con abbreviazione su i ed espunzione di n), inpletur (De pecc. us. 641,10), inplicat (De sub. theol. 660), inportunus (Devia par. 271vb), inpossibilis (De uno esse 267,32; Quol. I, 8, f. 77va), inpressio (cod. D, f. 98vb), inproprie (De sub. theol. 358), lanpas (cod. D, f. 384rb), sinpliciter (De bono pacis 69,7), superinpendar (De bono com. 13,2), tenperantia (Contra fals. 54,16-17).
In volgare conpagnia (cod. G4, f. 407rb).
mpamplexus (Postille f. 223ra), emplastri (cod. G4, f. 79ra,
B), limpidus (cod. D, f. 279va), impediti (De pecc. us. 630,23),imperator (De sub. theol. 50; cod. D, f. 44va), imperium (cod. D, f. 44rb), impleat (cod. D, f. 14ra), implicet (Quol. II, 1,f. 82vb), implicitam (cod. E, f. Ura 2 volte, f. 13va), limpidus (cod. D, f. 279va), semper (cod. D, f. 13rb), simplex (cod. D, f. 99vb, f. 102ra; cod. G3, f. 117va), simpliciter (Contra fals. 17,7; cod. D, f. 104rb; cod. E, f. 12va, f. 12vb, f. 13ra, f. 13rb, f. 44va più volte, f. 44vb... ; cod. BNP f. 207ra), tempus (cod. E, f. 44vb).
In volgare Alcampo (cod. G4, f. 388ra), campelli (cod. 397va), campo (cod. G4, f. 388ra), corrompa (cod. D, f. 153vb), rompe (cod. D, f. 356v, mg. s., B).
nqinquam (cod. D, f. 14ra), inquisitio, inquit, tanquam (Div. sc.
17,73; De sub. theol. 322; cod. E, f. 12va più volte, f. 13ra,f. 13rb).
mvquamvis (Quol. II, 11, f. 87rb).N.B. Non ho recensito nasale+dentale perché l'esito è
costantemente n; le preconsonantiche n e m concorrono nei nessi nasale+labiale, sebbene n sembri preferita. Le edizioni dovranno informare della soluzione data alla nasale preconsonantica coperta dall'abbreviazione, non già normalizzare le scritture a piene lettere.
o < a
anologia, anologus (Quol. I, 1, f. 72rb; cod. G3, f. 77rb, f. 131rb; ma analogia, analogicus: cod. G3, f. 110vb), diapkonus e dyajonus (=diaphanus) (Contra fals. 40,82; Quol. II, 7, f. 85ra; così pure in Tommso d'Aq., ed.Leonina 22/1, p. 174*), ermophroditus (Quol. II, 9, f. 85va); r9xrovar, è traslitterato tectonos (Div. sc. 16,22).
o < uiocundus e iocunditas (costanti)
p < boptinet (Contra fals. 71,19; 75,31; De sub. theol. 318; De bono
pacis 67,22.23.25), optinemus (Postille f. 230ra; cf. Tommso d'Aq., ed. Leonina 23, 67), optulit (cod. D, f. 374va; ma obtulit tre righi sotto!) (trazione fonetica della seguente consonante sorda; caso ben documentato).
p < phspera (= sphera) (Quol. II, 7, f. 85ra; II, 8, f. 85rb;
cod. D, f. 255va).
p < ppcostanti apropinquare, apropriare, aproprianter (scempiamento in
poisizione protonica prevalente nel fiorentino dal Due al Quattrocento, specie in presenza del prefisso ad: R. BESSI -M. MARTELLI, Guida alla filologia italiana, Firenze 1984, 95), oportunus; Philipenses (De pace V, cod. G4, f. 358va); suplere (cod. D, f. 42vb; cod. G3, f. 73ra più volte), suplet (De bono pacis 63,13) ma supplet nel rigo appresso (ib. 63,14); Ypocrates.
In volgare apropriamento (cod. G4, f. 397ra).
ph: cf. f < ph
pp < pAppolinaris (cod. D, f. 374r, mg. inf.), clippeus (Contra
fals. 50,7; 53,4; 54,103; Distinct. 353.370, mano B); oppinio (De uno esse 264,5) secondo il prevalente oppinione nel volgare, contro opinio; suppinum (De modis rerum f. 37va 2 volte) ma supino (cod. G4, f. 302rb).
-qus <- quusRicorrono con frequenza scritture con caduta della u in
iato: antiqus, coqus, equs, iniqus, longinqus (cf. NORBERG 85; STRECKER 30; ROHLFS 485-86).
r - rrSaraceni (De via par. f. 285va; De miser. c. 7, f. 20Ova;
cod. D, f. 44ra, f. 137rb, f. 373v, mg. s., B; cod. G4, f. 89vb) c Sarraceni (De bono com. 28,31; cod. D, f. 44rb).
s < ssSempre glosa quando scritto per esteso (forma del resto
prevalente nel mediolatino; gli editori di Remigio sciolgono o riducono sistematicamente a glossa) (De sub. theol.332; Contra fals. 78,17; 90,4; Postille f. 225vb, f. 227ra; cod.D, f. 45rb, f. 100vb); e così glosare (Contra falsos 69,50-51; De pecc. us. 646,15; cod. G3, f. 15rb, f. 302ra, f. 327va; cod. D, f. 404v, mg. sup., B, f. 303ra), glosator (Quol. I, 10, f. 78vb 2 volte; 1, 13 ad 3), glosarium (cod. D, f. 391rb; cod. G4, f. 406r, mg. sup., B; cf. Studio 259 n. 43), abscisus (De bono com. 17,11; De bono pacis 61,17; Postille f. 225rb; cod. G3, f. 176vb,), succesisti (Contra fals. 20,11), ysopus (Postille f. 226va). Rileggi la nota autografa di Remigio in cod. A 2.513, f. 3r.
s < tharismetrica (Div. sc. 12,11 e passim; Contra fals. 38,2 e
passim) e arithmetrica in contesto di citazione (Div. sc. 12,6; 13,36), arismetricus (Div. sc. 12,14); rismica (Div. sc. 13,29; Contafals. 39,16, dove leggi rismicam in luogo di usmicam; rismon in Tommso d'Aq., ed. Leonina 48, A 64 n. 4) ma rithmica (Div. sc. 13,32) e rith(i)mi (cod. G4, f. 406va, f. 407rb, f. 409rc, mano B).
s < xeccezionalmente, e per influsso della pronuncia volgare,
s'incontra testus< textus, esta<exta, iusta<iuxta, res<rex...
si < sci
Il frequentissimo scilicet (rappresentativo del fonema sibilante palatale) è abbreviato in s.; le poche volte che appare scritto in esteso è sempre silicet: De sub. theol. 428.476; De modis rer. f. 28vb; Quol. I, 3, f. 74rb; 1, 6, f. 76ra, mg. s., mano B. Cf. NORBERG 66,155; ricorre frequentemente nella scrittura notarile fiorentina: cf. BOCCADIBUE p. xv.
ss < samorossus (Postille f. 229ra) e amorosus (ib.), Narcissus
(cod. G4, f. 234va), vissive (Quol. I, 1, f. Mva, mano X), mentre vissum è corretto in visum (Div. sc. 1,6, mano X).
t < ctartare, artatio, artus, dyaletica, praticus sono costanti, e tale
può esser considerato Arturus (Contra fals. 40, 129.131.132.134.136.165; De pecc. us. 638,36 2 volte; cod. D, f. 78v, mg. d., B) mentre una volta Arcturus in citazione (Contra fals. 40, 139; cf. Tommso d'Aq., ed. Leonina 45/1, p. 33*a); autor, autoritas, iurisditio meno frequenti di auctor (actor), auctoritas, iurisdictio.
■ Dal settimanale "L'Espresso" 29.V.2014, p. 147: «→Auctoritas non autoritas... ».
-t <-dquicquit (cod. G3, f. 84ra) contro il regolare quicquid;
la congiunzione avversativa sed è di regola scritta sotto abbreviazione; mi è occorso di registrarla due volte a piene lettere e appare con la dentale finale desonorizzata set (Postille f. 227rb, mano Y; De pecc. us. 612,25, mano A; la forma set è adottata dall'editore sistematicamente in tutto il De pecc. us. ) (Su sed-set nella letteratura filosofico-teologica della seconda metà del XIII secolo vedi la nota degli editori di Tommso d'Aq., ed. Leonina 43, p. 361; cf. anche 28, p. 56* n. 1). Più numerosi i casi di sonorizzazione della dentale finale: vedi sopra -d < -t.
t<th
autenticus (= authenticus), Boetius, entimema, Iudit (normalizzato in Iudith dagli editori; quest'ultima scrittura appare in cod. D, f. 357vb), Trenos, tronus.
t < ttCostanti Matheus, Mathias, quatuor; litera è di gran lunga più
frequente delle concorrenti lictera e littera; atendenda (Quol. I, 3, f. 73vb, mano X) è corretto in attendenda da mano B.
In volgare profitevole (cod. G4, f. 3ra).
th < tIl digramma aspirato th è caratteristico delle grafie
iperetimologiche, specie in lessemi d'origine greca o ritenuti tali: anthonomasice, athomus, cathena, cathenula, cathetiçare, ethimologia -gice, exthasis (ma extasis: Postille f. 222rb), lintheus, lintheamina, mathesis-matesis (cf. Div. sc. 11,51; 19,12-13; 20,18 in appar.), methaphisica, methaphora, Metheororum, plathea e platea, prothotipum e prototipum, Ptholomeus(ma anche Ptolomeus), rethe, rethorica, Sathana, Thimoteus, Thobias (ma anche Tobias)...
ti < ciCostanti sono tutte le mani efficatia, sotius e composti,
sotietas e composti (poche volte anche societas; nelle edizioni si tende a normalizzare in socius e societas ... ); mendatium (Div. sc. 18,16) e mendacium (cod. D, f. 404v, mg. s., B), sautiatus (Contra fals. 89,11).
tt < tCostante la geminazione in legittimus, testimoniata anche
da scrittura iperetimologica legiptimus (Sermoni XV); «per legiptimarn spem... idest legittima sperança» (cod. D, f. 397v, mg. s., B) (legittimus e legiptimus si alternano in BOCCADIBUE 19 e passim).
u - vIn forma di V se iniziale maiuscola (nella scrittura di
mano B invece la base è a forma tondeggiante a due lobi); ue v irregolarmente (ueritas e veritas, uia e via, uisus e visus, una e vna ... ) se iniziale minuscola, sebbene prevalga u; sempre u altrove. Nota uuandalorum (Contra fals. 16,19; De bono
com. 13,20; cod. D, f. 385vb); «... scilicet uerio uel Verio uel oliuerio de circulis» (= Vieri dei Cerchi) (cod. G4, f. 393va).
Le edizioni, incluse quelle curate dal sottoscritto, hanno adottato la diversificazione in u e v secondo l'uso moderno, senza pregiudizio - peraltro - del relativo valorefonetico bilabiale e labiodentale nel mediolatino (cf. NORBERG 69-70).
y - iCostanti, o di gran lunga prevalenti contro la forma in
i, chyromantia, dyaconus, dyaletica, Dyonisius (= Dionysius), hyems e hyemalis, hyllaris, hyllaritas, Hyllarius, hyronia, hystoria (talvolta anche historia), Moyses (anche Moises), Peryerminias, Raymundus, sydus, sophysticus, ydea, ydemptitas, ydiota, ydolum e ydolatria, ymago e ymaginari, Ypocrates, yris, Ysaac, Ysaias, Ysidorus, Ysmael.
Concorrenti le scritture Chayn-Cain, dyabolus-diabolus, Dyalogorum-Dialogorum, Dydascalicon-Didascalicon, dyocesis-diocesis, Egyptus-Egiptus, Helyas-Helias, laycus-laicus, lymbus-limbus, Parysius-Parisius, symbolum-simbolum, symonia-simonia, usya-usia, Ytalia-Italia.
Casi rari o isolati contro la più comune forma in i: empyreus (Postille f. 230va, Y), Ethycorum (Div. sc. 2,26, X), paradysus (De via par. f. 207ra, A), philosophia (Div. sc. 3,4, X), philosophy (Postille f. 221rb, Y), polyticus (Postille f. 228vb, Y), tymor (De miser. c. 2, f. 197vb, A), ymo (= immo) (De uno esse 261,26-27; ymo anche in DANTE, De vulg. eloqu. I, V, 2: ed. 1921, p. 322; Monarch. I, II, 6: ib. p. 356 e passim), Yeronimus (cod. D, f. 358ra, A).
y < οιychonomica, yconomica (Div. sc. 14,16; 18,22; cod. D, f.
279va; cod. G4, f. 304ra). Iconomica nel volgare di BrunettoLatini (La Rettorica, ed. F. Maggini, Erenze 1968, pp. 46-47).
ç (= z)Costante nei testi latini e volgari. In rarissimi casi
compare z: Nazançeni (De sub. theol. 624; ma Nançançenus in
Contra fals. 10,91), evangelizo (Postille f. 222ra), thopazius (De via parad. f. 207rb).
17. Taluni lessemi meritano d’esser segnalati a parte
Actor e auctor si alternano con uguale frequenza; più raro autor. Medesimi contesti sintattici e semantici accompagnano indifferentemente l’una o l’altra forma, il che fa pensare che Remigio li percepisse come un solo lessema con varianti grafiche, mentre i lessicografi da luifrequentati distinguevano: UGUCCIONE DA PISA, Derivationes, v. 'Augeo': «In prima significatione imperatores proprie debent dici auctores ab augendo... Secundum secundam significationem philosophi et inventores artium, ut Plato et Aristotiles... debent dici autores. Secundum tertiam Virgilius et Lucanus et ceteri poete debent dici autores» (BLF, Plut. XXVII sin. 5, f. 1ra; ed. Firenze 2004, II, 5);EBERARDO DA BÉTHUNE, Graecismus IX, 107-08: «Auctor ab augendo nomen trahit, ast ab agendo / Actor, ab autentin, quod graecum est, nascitur autor» (ed. J. Wrobel, Breslau 1887, 60). Summa Britonis 74: «Autor sine c dicitur ab autentin grece et est communis generis. Unde hec autoritas,id est sententia alicuius imitatione digna vel dignitas meritis comparata. Actor cum c ab ago, agis, masculini generis est. Auctor per u et c ab augeo, auges, scilicet masculini generis est. Unde versus,
Est hic et hec autor, tamen dat hic auctor et actor.Autentico primum dat, ab augeo dico secundum,Ast actoris ago dicatur fons et origo».Cf. Bartolomeo da San Concordio, De dictionibus scribendis. Dante, Convivio IV, 6, 1-5.
Do alcuni rimandi alle singole forme:Actor: Div. sc. 16,18; 18,108; 20,43; Contra fals. 37,139;
66,43; De uno esse 264,3; 266,4; De bono com. 42,19; Quol. II,13, f. 88ra 3 volte; De modis rer. f. 22va; cod. G3, ff. 8ra,15ra, 20ra, 75rb, 116vb, 117vb; cod. G4, ff. 335vb, 356ra.
Auctor: Div. sc. 8,8; 11,62; De sub. theol. 96; De uno esse 260,13; De pecc. us. 615,25; Postille ff. 221rb, 227rb, 230vb; cod. D, ff. 13vb, 45ra, 98vb.
Autor: Contra fals. 99,16; Speculum f. 153rb; cod. G3, f. 180vb 2 volte.
In Quol. II, 13, f. 88ra si scrive auctum e poi si espunge la prima u.
Auctoritas più frequente di autoritas; si alternano senza insinuare differenze semantiche. Qualche incidente documenta il tentativo di fissare una scelta che non ha avuto successo: nella Expositio de duratione monitionum di cod. G4, f. 406rb si scrive autoritas e una volta auctoritas con c espunto; il medesimo testo rivisto dall’autore e fatto ritrascrivere dal medesimo copista A come Questio de duratione monitionum in cod. G3 porta auctoritas in tutt’e due i casi (Dibattito, AFP 50 (1980) 100 rr. 94.95); poi a fine testo una giunta di mano B (Remigio) scrive ancora due volte autoritas (ib. 101 rr. 123.124)!
■ Errori di latino! Leggo nel settimanale "L'Espresso", n°21, anno LX, 29.V.2014, sezione "Lettere", p. 147: «Auctoritas non autoritas. Ho letto l'articolo di Emiliano Fittipaldi e ringrazio per gli elogi, in verità eccessivi (io, luminare?!), mentre non erano eccessive le mie critiche al livello scientifico della Commissione. Preciso, però, che io nel mio articolo su "Judicium" avevo correttamente scritto «auctoritas» e non già «autoritas» come riportato tra virgolette, per una evidente svista nel copiare, così attribuendomi un errore di latino. Comprenderà, spero, che questa rettifica è indispensabile dal momento che nel mio articolo si parlava anche di professori asini e la vostra svista giustificherebbe la medesima accusa nei miei confronti. I migliori saluti. FRANCESCO GAZZONI, professore ordinario di Diritto civile».
La parola latina per ‘autunno’ deve aver presentato asperità grafiche a Remigio, che non sembra si sia risolto a dare un esito stabile al grafema. Mi è occorso di recensirla tre volte, ma i grafemi sono inconciliabili. Il caso risulta tanto più interessante in quanto sono tre le mani diverse che si cimentano nella scrittura: mano A scrive autumpnales (De pecc. us. 631,34, in citazione biblica), mano X scrive auptumpto (Div. sc. 11,27) e mano B, lo stesso Remigio, scrive autupnales (Distinct. 323).
Ci s’imbatte in Britannia (Contra fals. 13,12), Britania (ib. 13,11), Brutannia (ib. 5,44), Brittannia (cod. G4, f. 69r, mg.d., B). E non credo che la u di Brutannia sia un lapsus per i, visto che era luogo comune far derivare Bretagna da Bruto:De proprietatibus rerum di Bartolomeo Anglico († 1275 ca.): «... terram incoaverunt Britanniam quasi insula a Bruto tunc temporis armis et potentia acquisita» (BLF, Conv. soppr.462, f. 154rb: codice posseduto da Remigio; cf. Studio 88, 260, Tav. VI; POMARO, Censimento I, 449-50). VILLANI I, 24, 34-41. A. VARVARO, Letterature romanze del medioevo, Bologna 1985, 273-74.
Cathetiçare (= catechizare, cf. Gal. 6,6) appare ben tre volte nella medesima forma in Contra fals. 7,10; 45,142.143; pertanto non correggerei, come invece preferisce fare l’editore; difatti la medesima scrittura si ritrova ancora in cod. D, f. 99rb. Non mi sono mai imbattuto in catechizare.Non si deve trattare dunque d’un lapsus d’autore o di copia. Cathecizare in Guglielmo il Bretone (Summa Britonis p. 113).
Cistersiensis (De via par. f. 331/2vb), cisterciensis (cod. D, f. 188vb), cysterciensis (Postille ff. 230va, 232rb).
Huguiccio -ccionis quando scritto in esteso; una volta Hugutio in BNP f. 209ra.
Iesus appare solo una volta abbreviato ie(sus) (cod. C, f.163vb = Contra fals. 27,140); altrove sempre nel canonico trittogramma ih’s. Sermone nell'ottava di Pasqua Venit Iesus
(Io. 20,19): «Qui etiam numerus ex ipsis vocabulis quibus dicitur Venit Iesus [ih’s] extrahi potest, quia utrumque est quinque literarum, scilicet et Venit et Iesus [ih’s]; h enim nonest litera sed aspirationis nota» (cod. G4, f. 138rb); sebbene si utilizzi il modello tachigrafico ih’s, le cinque lettere parallele dei due lessemi dice che il grafema latino di Remigio era Iesus non Ihesus. Non ho incontrato altra scrittura per Christus se non il monogramma Xus. Vedi quanto a proposito tramanda e dice Guglielmo il Bretone, Summa Britonis (1250-70) pp. 323-24, 853-54: nettamente a favore di Iesus senza h, erroneamente introdotta - a suo dire - in luogo di "ita" (= eta < η); e a favore di Cristus.
li denotativo romanzo di lessema (cf. D. NORBERG, Manualedi latino medievale, Firenze 1974, 109). Quol. I, 6, f. 76va; De bono com. 38,16.25 (= c. 18,60): li ‘propter’; De pecc. us.618,17: li ‘ut’] verbum ‘ut’ ed.; 624,17: li ‘con’] videturcon ed.; 654,29: li ‘quasi’] quia ed.; Postille ff. 228vb, 229ra; cod. G3, f. 163vb; cod. G4, f. 406rb; BNP f. 209ra 2volte; De uno esse 272,21 dove ed. modifica in ly. Una volta le (De pecc. us. 658,32 in citazione della traduzione latina di Proclo).
DHN 15 (2006) 62 n° 182: MARTIN MORARD, Le petit "li" des scolastiques: assimilation de l'article vulgaire dans le latin des théologiens médiévaux, «Mélanges de l'École Française deRome. Moyen Âge» 117 (2005) 531-593 ["L'article français "li" apparait dans les écoles à Paris dès la fin du XIIe siècle, dans le sillage d'Alain de Lille. Il s'y implante comme outil technique entre 1220 et 1230 et rencontre rapidement un bon écho en Angleterre, se répand entre le milieu du XIIIe siècle et la fin du Moyen Âge, s'efface à la Renaissance", 583. (...) Thomas d'Aquin: 'Le cas de Thomas d'Aquin',571-583; Tableau 1, "li" dans les oeuvres de Thomas d'Aquin', 586-593].
Pannucius (cod. D, f. 40rb), Pannuctius (Quol. II, 14, f. 88va), Pathnutius (Postille f. 225vb; cod. D, f. 40rb).
Quadruvium (Contra fals. 46,18). Così anche in DANTE, Conv.II, XIII, 8, dove a suo tempo si credeva di dover correggere in quadrivium: cf. M. BARBI, Introduzione a Le opere di Dante, Firenze 1921, pp. VII-VIII; e nota a Convivio, ed. Busnelli-Vandelli, Firenze 1934, I, 192.
18. Ricognizione delle edizioni
Ed ecco la ricognizione critica del testo del Contra falsos. La lista potrà sembrare lunga; ma a parte talune sviste di lettura, altre lezioni vertono o sul metodo di adeguare i testi delle citazioni di Remigio alle edizioni degli autori citati o su interventi intesi a normalizzare il latino del frate fiorentino mentre lo spoglio dei codiciremigíani testimonia a favore di forme apparentemente sospette, o infine su soluzioni d'abbreviazioni altrove attestate da scritture a piene lettere.
I numeri rinviano a capitolo e rigo dell'edizione integrale del Contra falsos; il richiamo dà prima il testo dell'edizione, poi, dopo parentesi quadra, il testo da restituire. Non si annotano le integrazioni ingiustificate di Causa o can. o cap. nelle citazioni delle fonti canonistiche o di titolo di opere citate; glossa è sempre daridurre a glosa; la z è sempre ç nell'originale; u è diversificata secondo l'uso moderno in u e v.
■ Contra falsos, ed. F. Tamburini, Roma 1981.
(…….…)
----------------------------------------------------------------------
http://www.e-theca.net/emiliopanella/remigio/8250.htmhttp://archivio.smn.it/emiliopanella/remigio/8250.htm