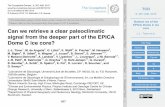POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO Una proposta di lettura intertestuale tra...
-
Upload
liceocanova -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO Una proposta di lettura intertestuale tra...
Aevum Antiquum N.S. 4 (2004), pp. 577-600
ALBERTO PAVAN
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIOUna proposta di lettura intertestuale tra epica e tragedia di Stat. Theb. VI491-517
Nel sesto libro della Tebaide di Stazio l’incidente spettacolare che Apollo pro-voca ai danni di Polinice, apparentemente destinato alla vittoria, avvia allaconclusione la gara delle quadrighe. Il colpo di scena si inserisce in una delleparti del poema più aderenti alla convenzione epica e la narrazione è dissemi-nata di elementi che arricchiscono l’intreccio di numerose connessioni con ilpassato e il futuro della vicenda dando coesione al poema intero.
La rete dell’intertestualità comprende non solo i macroscopici modelliomerico e virgiliano1, ma si estende anche a riferimenti a opere di Ovidio edi Seneca dalle quali Stazio trae la caratterizzazione del protagonista della suacorsa, Polinice. L’obiettivo di questo studio è quello di dimostrare come lamemoria del Fetonte del secondo libro delle Metamorfosi e dell’Ippolito dellaPhaedra evocata attraverso citazioni e allusioni sia servita a Stazio per defini-re la personalità di Polinice e connotare ideologicamente il passo.
1. Il contesto
La corsa delle quadrighe, il primo dei giochi funebri in onore di Ofelte-Archemoro, si svolge nove giorni dopo le esequie del neonato, dopo la cele-brazione di una solenne pompa funebris e il sacrificio novendiale. Come nel-l’archetipo omerico di Iliade XXIII, e in ossequio alla passione romana per legare dei carri, rispetto agli altri giochi la trattazione di questa prova risulta più
© 2
008
Vit
a e
Pens
iero
/ P
ubbl
icaz
ioni
del
l’Uni
vers
ità
Cat
tolic
a de
l Sac
ro C
uore
1 L. Legras, Études sur la Thébaïde de Stace, Paris 1905, pp. 79-90, per primo fa una ricognizio-ne delle fonti dei ludi funebri staziani, che ipotizza essere la Tebaide ciclica e quella di Antimaco diColofone (stando alle testimonianze di Apollodoro e Pausania), ma naturalmente anche il libro XXIIdell’Iliade e il libro V dell’Eneide, con i quali confronta analiticamente lo svolgimento delle gare inStazio. Solo D. Vessey, Statius and the Thebaid, Cambridge 1973, pp. 209-229, dopo aver studiato igiochi come momento irrinunciabile della Epic convention, li interpreta come preparazione alla guerrache inizierà nel libro VII. Si rimanda invece a H. Juhnke, Homerisches in Römischer Epik Flavischer Zeit,München 1972, pp. 108-113 e le tavole di confronto alle pp. 342-344, per l’individuazione puntualedei riferimenti al testo omerico. Non è invece d’aiuto il recentissimo R. T. Ganiban, Statius and Virgil.The Thebaid and the Reinterpretation of the Aeneid, Cambridge 2007, che non tratta il tema dei ludifunebri staziani e virgiliani e della loro relazione intertestuale.
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 577
diffusa, più articolata da un punto di vista narrativo e più ricca di riferimen-ti al resto del poema.
La sua importanza è dichiarata sin dall’inizio dall’invocazione a Febo (vv.296-300) che imprime un ritmo lento e maestoso alla narrazione. Il poetachiede al dio di aiutarlo a passare in rassegna la straordinaria nobiltà di caval-li e cavalieri lì riuniti. S’inizia quindi un catalogo di eccezionale lunghezza perun contesto ludico (vv. 301-350)2, nel quale sono nominati gli aurighi deisette equipaggi coinvolti nella corsa delle quadrighe: Polinice, Amfiarao,Admeto, Toante ed Euneo e Chromis e Ippodamo. All’inizio del catalogo prin-cipale degli equipaggi si apre un secondo catalogo (vv. 301-325), quello degliaurighi di Arione, il cavallo di Polinice, che sarà il protagonista indiscusso dellagara. Prima dell’inizio della corsa tuttavia il poeta indugia ancora su una scenaolimpica (vv. 355-388) in cui Apollo finisce per accordare il suo favore adAmfiarao che scomparirà negli abissi della terra all’inizio di Theb. VII.
Dopo queste ampie premesse, umane e divine, si apre la sezione dedica-ta alla narrazione della gara vera e propria (vv. 389-530). La partenza è ritar-data da una descrizione dell’impazienza che ai cancelli coglie cavalli e cavalie-ri (vv. 389-403): gli animali sono rappresentati come mostri la cui furia si tra-duce nel fuoco dello sguardo e nel vapore che essi esalano dalle froge. Unavolta suonata la tromba, il frastuono, l’impazienza dei concorrenti e la polve-re non consentono di distinguere gli equipaggi, che sembrano un tutt’uno(vv. 404-423). Di lì a breve si delinea un primo ordine di gara: Polinice soloin testa, seguito dalle coppie Amfiarao-Admeto, Euneo-Toante, Chromis-Ippodamo. Colpevole di aver piegato il cavallo troppo vicino alla meta,Polinice è superato per un attimo da Amfiarao e Admeto, fino a che, con rin-novato impeto, Arione, che Polinice non è più in grado di governare, guada-gna definitivamente la prima posizione (vv. 424-453). La gara diventa sem-pre più accesa, tanto che nella descrizione assume i toni cruenti di una batta-glia, nel corso della quale si giunge in vari modi all’eliminazione di alcuniconcorrenti (vv. 454-490).
Nell’ultima fase (vv. 491-530) rimangono in gara Polinice, Amfiarao eAdmeto (Euneo ha un ruolo marginalissimo). L’intervento di Apollo cheinvia l’apparizione di un mostro anguicrinito impedisce il prevedibile succes-
ALBERTO PAVAN578
2 Nella Tebaide i cataloghi dei concorrenti sono mediamente più lunghi di quelli degli altri poemiepici romani: il primo, che si concentra soprattutto sui destrieri, consta di 55 versi (VI 296-350) all’in-terno di una sezione narrativa di circa 250 versi (296-549); il secondo di 38 (VI 550-587). I cataloghidelle triremi dell’Eneide virgiliana (dove la regata è la variazione della gara omerica dei carri) e dei par-tecipanti alla gara di corsa constano rispettivamente di soli 10 e 11 vv. (V 114-123; 291-302). Silio neiPunica descrive cavalli e aurighi nel pieno della corsa e dedica alla descrizione dei corridori 13 vv. (465-477). L’archetipo omerico di Il. XXIII riserva un breve catalogo alla sola gara dei carri (288-304).
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 578
so di Polinice, poiché Arione, il cavallo divino, rimane terrorizzato dalmostro, sbalza dal carro Polinice che rischia la morte e quindi prosegue dasolo la sua folle corsa verso il traguardo (vv. 491-517). Apollo ottiene così chela palma della vittoria, ma non il primo posto assoluto, spetti ad Amfiarao.
Al momento della premiazione (vv. 531-549) Adrasto consegna adAmfiarao il primo premio, un cratere appartenuto a Ercole, cesellato con vio-lente scene della centauromachia, ad Admeto il secondo, una clamide conricamato il mito di Ero e Leandro, e a Polinice, come premio di consolazio-ne, una schiava.
2. Arione, il cavallo di Polinice
La descrizione del primo equipaggio presenta nella distribuzione dei versi unevidente squilibrio a favore del cavallo Arione, la cui straordinarietà privaquasi Polinice di una parte attiva nella gara delle quadrighe, sottolineando ilpredominio della forza bruta dell’animale sulla capacità di controllo dell’auri-ga. Il poeta infatti si concentra sulla caratterizzazione del destriero, che dimo-stra una completa indipendenza dal suo auriga (quando non è addirittura inconflitto): Arione è connotato dalla dismisura nella velocità e dall’incostanzadel temperamento. Nella presentazione staziana ottengono particolare atten-zione la genealogia e la ‘formazione’ del cavallo3, elementi che nella tradizio-ne epica sono di solito trattati in modo cursorio4. I vari padroni sono statianche i maestri di Arione: ci si trova di fronte a un catalogo che è sia una listadi possessori di un oggetto dal significato simbolico (tra i quali Polinice sidistingue, perché è l’unico al quale Arione non recherà successi5) sia un elen-co dei maestri dell’eroe (del cavallo nel nostro caso)6, con la funzione di rias-sumere la biografia del destriero e delle sue gesta di mare e di terra fino all’e-tà adulta. Tre sono stati i cavalieri di Arione: il dio Nettuno (vv. 301-310), ilsemidio Ercole (vv. 311-313), e il re Adrasto (vv. 314-325); Adrasto cede per
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO 579
3 Cfr. Stat. Theb. VI 301-316 Ducitur ante omnes rutilae manifestus Arion|| igne iubae. Neptunusequo, si certa priorum|| fama, pater; primus teneri laesisse lupatis|| ora et litoreo domitasse in puluere fer-tur,|| uerberibus parcens; etenim insatiatus eundi|| ardor et hiberno par inconstantia ponto.|| Saepe perIonium Libycumque natantibus ire|| interiunctus equis omnesque adsuerat in oras|| caeruleum deferrepatrem; stupuere relicta|| Nubila, certantesque Eurique Notique sequuntur.|| Nec minor in terris bellaEurysthea gerentem|| Amphitryoniaden alto per gramina sulco|| duxerat, illi etiam ferus indocilisque tene-ri.|| Mox diuum dono regis dignatus Adrasti|| imperia et multum mediis mansueuerat annis.|| Tunc rectorgenero Polynici indulget agendum. Il testo di Stazio è sempre citato secondo l’edizione di D.E. Hill, P.Papinii Statii Thebaidos libri XII, Leiden-New York-Köln 1996.
4 Per la lunghezza dei cataloghi nell’episodio dei giochi cfr. nota 1.5 Per simili cataloghi di possessori di oggetti preziosi, cfr. la coppa di Adrasto in Stat. Theb. I 540-
542; la collana di Armonia II 289-297.6 Cfr. ad esempio in Theocr. XXIV 105-131 il catalogo dei precettori di Eracle.
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 579
l’occasione della gara il cavallo ignaro al genero Polinice, che egli stesso avver-te delle difficoltà legate alla guida di un simile animale (vv. 316-320).
Il re argivo assume dunque la funzione del pater-praeceptor attestata nelmodello omerico della gara dei carri: in Il. XXIII 306-346 infatti Nestoreavverte il figlio Antiloco (vv. 305; 307 s.) che la mÁtij dell’auriga deve esse-re più determinante della foga dei cavalli (vv. 313 ss.; 319 ss.) e gli dà sugge-rimenti sul percorso da tenere (vv. 326 ss.)7. Quello omerico può essere con-siderato il modello di questo passo dal punto di vista della struttura narrati-va, anche se Stazio riduce il discorso didascalico del praeceptor a una brevitàepigrammatica, limitandolo ai consigli sulla guida (vv. 315-320). Le indica-zioni sul percorso invece sono assorbite in una similitudine Sole-Adrasto,dove si ricorda che il carro solare deve mantenere una rotta mediana lungo lazona temperata equidistante dai due poli, e s’inferisce quindi per analogia cheanche il carro di Polinice non dovrebbe avvicinarsi né allontanarsi eccessiva-mente dalla meta (Theb. VI 320-325):
sic ignea loracum daret et rapido Sol natum imponeret axi,gaudentem lacrimans astra insidiosa docebatnolentesque teri zonas mediamque polorumtemperiem: pius ille quidem et formidine cauta,sed iuvenem durae prohibebant discere Parcae
La similitudine ha come modello la narrazione ovidiana del mito di Fetontein Met. II 1-400 (soprattutto II 140-166). Infatti la voce del narratore, aven-do espresso per bocca di Adrasto i consigli sulla guida, illustra all’interno dellasimilitudine i consigli del Sole relativi al percorso mediano che il figlioFetonte dovrebbe seguire. Pertanto il rapporto padre-figlio e i consigli sullaguida del carro aiutano il lettore a integrare la similitudine con la parte lascia-ta sottintesa: all’esplicita identificazione Sole-Adrasto, infatti, se ne aggiungeuna implicita Fetonte-Polinice8 che getta un’ombra funesta sull’esito dellagara e della vicenda intera9. Stazio sceglie per la sua similitudine il momento
ALBERTO PAVAN580
7 Per un’accurata analisi del motivo, la sua applicazione in diversi contesti e i suoi traslati cfr. M.Citroni, Ovidio Ars 1,3-4 e Omero, Iliade XXIII,315-318: l’analogia tra le artes e la fondazione del discor-so didascalico, Sileno 10 (1984), pp. 157-167.
8 L’assimilazione tra i due personaggi ritorna e si fa esplicita a XII 413-415, quando Antigone eArgia lavano il cadavere di Polinice, così che l’identificazione, qui soltanto suggerita, è alla fine palesa-ta: sic Hyperionium tepido Phaethonta sorores|| fumantem lauere Pado; uixdum ille sepulcro|| conditus, etflentes stabant ad flumina siluae. Questa seconda similitudine, naturalmente con lo stesso inlustrans dellaprima, conclude il racconto mitico parallelo di Fetonte avviato nel libro sesto, sottolineando ulterior-mente la somiglianza tra il figlio del Sole e Polinice.
9 Cfr. R. Corti, Due funzioni della similitudine nella Tebaide di Stazio, Maia 39 (1987), p. 9, dovela similitudine con Fetonte è appunto studiata per individuare una particolare funzione di questa figu-
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 580
precedente alla folle corsa fetontea, della quale omette il tragico epilogo. Permezzo delle allusioni contenute nello svolgimento della gara il lettore, ricor-dando il testo ovidiano, può però facilmente immaginare il seguito dellavicenda di Fetonte.
L’analisi della similitudine mette in luce l’insistenza sul dramma paternoche induce a pensare alla tragica vanità del discorso didascalico, efficace invecenel modello omerico. Al v. 321 infatti il Sole è detto lacrimans, aggettivo che dàun color patetico al passo e anticipa con valore prolettico la triste fine della corsadi Fetonte, e la similitudine si conclude con un andamento sentenzioso (324 s.)che mette in risalto l’atteggiamento accorto del padre di fronte all’ineluttabili-tà del destino del figlio già deciso dalle Parche. Tale potrebbe anche essere laconclusione del breve discorso di Adrasto che, con il tragico epilogo cui allude,lascia intravedere l’esito negativo della corsa di Polinice incapace di governare ilcavallo nonostante i consigli del suocero. Il v. 325 inoltre interrompe pietosa-mente la narrazione del mito passando sotto silenzio la morte di Fetonte, cosìda stornare da Polinice l’ombra di un pessimo augurio e da ottenere una spie-gazione applicabile anche al destino del principe tebano10.
Il mito di Fetonte ha notoriamente un parallelo strutturale e semanticocon quello di Dedalo e Icaro. In entrambe le trattazioni ovidiane di questomito il discorso didascalico del padre, che nel passo staziano fa da cornice allasimilitudine con il Sole e suo figlio, ottiene grande rilievo11. Anche dall’acco-stamento di Fetonte, e quindi Polinice, con Icaro, la cui imprudenza è causadi morte, si comprende come Stazio intenda accentuare il dolore del Sole,umanizzato, e la funzione di omen suggerita dal confronto con gli altri testi.
Nella trattazione staziana il motivo epico del dialogo tra pater-praeceptore figlio-auriga si conclude con questa similitudine che ne è quasi una mise enabîme, perché, provenendo da un contesto simile, riassume e illustra la situa-zione arricchendola di suggestioni letterarie e anticipazioni narrative. Nelbrano c’è tuttavia un particolare che differenzia Stazio sia da Omero, sia daOvidio: Nestore, il Sole e Dedalo sono padri rispettivamente di Antiloco,
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO 581
ra retorica in Stazio, cioè quella di suggerire il modello dell’episodio cui essa appartiene, il rapporto diStazio con i suoi modelli e il ruolo della similitudine stessa all’interno di questo rapporto.
10 M. Fucecchi, La protesta e la rabbia del sole: un’ipotesi su Ovidio lettore di Omero nella scena fina-le dell’episodio di Fetonte (Met. 2, 381-400), con un’appendice su Lucano, Iliacon fr. 7 MOR (=6C.),Sileno 1 (2002), pp. 21 s.
11 Nella prima, in Ars II 22-98, il poeta, attraverso la menzione dell’intemperanza di Icaro, inten-de dimostrare la difficoltà di controllare l’incostanza d’Amore, e nella seconda, in Met. VIII 183-235,indugia sui consigli che Dedalo rivolge al figlio. Dedalo manifesta il suo dolore mentre consiglia il figlio(Ars II 70 nec patriae lacrimas continuere genae; Met. VIII 210 inter opus monitusque genae maduere seni-les), come il Sole in Ovidio (Met. II 124-125 inposuitque comae radios praesagaque luctus|| pectore solli-cito repetens suspiria dixit), e così in Stat. Theb. VI 322 dove è detto lacrimans di fronte alla ignara gioiadi Fetonte. Sulla funzione didascalica di Dedalo nelle trattazioni ovidiane, cfr. A. Sharrock, Seductionand Repetition in Ovid’s Ars Amatoria II, Oxford 1994, pp. 146-155.
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 581
Fetonte e Icaro, mentre nel caso di Stazio la similitudine si fonda su un’ap-prossimazione, perché gli inlustranda sono suocero e genero. Pertanto sembradi poter attribuire al confronto una funzione legittimante il rinnegatoPolinice, per il quale la consegna del cavallo Arione è una sorta di investitu-ra, un riconoscimento di paternità da parte di Adrasto12 (come del resto erala quadriga per Fetonte, figlio naturale del Sole).
Alla luce di questa interpretazione il lessico equestre si presta a una let-tura metaforica in chiave politica13. Il comando che Adrasto esercita sul caval-lo è detto imperia, il re di Argo è rector di Arione, il destriero va governatocon un saggio equilibrio di indulgenza (ne saeua manus) e risolutezza (ne liberhabenis|| impetus). I consigli che Adrasto dà al genero-auriga al momentodella consegna del cavallo sono quelli che un padre-re potrebbe dare al figlionominato successore al trono. Infatti, fin da Platone, il lessico delle gare curu-li è applicato al governo di uno stato: in Resp. 566 si parla dell’atteggiamen-to del tiranno che fa cadere i rivali dal d…frwn tÁj pÒlewj14. Stazio ricorreal lessico metaforico della guida del carro anche nel proemio della Tebaide aI 30, dove il poeta prega Domiziano di rinunciare per il momento all’impe-ro celeste con l’esortazione maneas hominum contentus habenis, un augurio dilunga vita formulato come preghiera del poeta al principe affinché egli, cheha natura divina, si accontenti, finchè in vita, di regnare sugli uomini.
Intorno al lessico equestre come metafora del potere è giocata ancheSilu. I 1 Equus Domitiani15. In essa la statua del cavallo è simbolo del poteredi Domiziano, che è celebrato attraverso il riferimento esplicito ad Arione. Imitici e terribili cavalli della corsa delle quadrighe (ad Arione è associatoCillaro, non perché simile per temperamento, ma perché una sua statua sitrova nel tempio dei Dioscuri vicino al colosso) provano, secondo Ahl, timo-re davanti all’ancora più terribile destriero del principe, che non teme ilpadrone che non ha mai mutato. Geyssen non accetta questa interpretazione,
ALBERTO PAVAN582
12 Cfr. H. Lovatt, Statius and epic games: sport, politics, and poetics in the Thebaid, New York2005, p. 32: «by driving the chariot of Adrastus, Polynices is attempting to abandon his Theban heri-tage and to become truly the son of his adopted father». Simile interpretazione avanzava R. E. Nagel,Polynices the charioteer: Statius, Thebaid 6, 296-549, EMC 18 (1999), p. 385.
13 Per lo studio dell’interpretazione politica del mito di Fetonte e dell’uso metaforico del lessicoequestre, cfr. R. Degl’Innocenti Pierini, Caligola come Fetonte, in Tra Ovidio e Seneca, Bologna 1990,pp. 251-71.
14 Vale la pena ricordare anche il celebre passo di Plat. Phaedr. 247b, la metafora del governodella biga per spiegare il dominio che l’uomo deve esercitare sulla propria anima: «Là i veicoli degli dei,che sono ben equilibrati e agili da guidare, procedono facilmente, gli altri, invece, procedono con fati-ca. Il cavallo che è partecipe del male, infatti, cala, piegando verso terra e opprimendo l’auriga che nonabbia saputo allevarlo bene» (trad. G. Reale).
15 Sviluppano in modi diversi questa interpretazione F. M. Ahl, The Rider and the Horse: Politicsand Power in Roman Poetry from Horace to Stace, ANRW 2,32,1 (1984), pp. 91-102 e J. W. Geyssen,Statius and the tradition of Imperial panegyric: a literary commentary on Siluae 1, 1, New York 1996, pp.87-111.
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 582
obiettando che i cavalli devono piuttosto temere l’aspetto imponente deldestriero, così come è descritto ai vv. 45-5116. Sotto la lode del cavallo si puòscorgere un ambiguo riferimento a Domiziano. Il cavallo non ha mai cambia-to cavaliere, cosa che significa, secondo Geyssen, la perfetta corrispondenza traun cavallo che è terribile e l’auriga che non è certo da meno17 (Silu. I 1,52-55):
hunc et Adrasteus uisum extimuisset Arion,et pauet aspiciens Ledaeus ab aede propinquaCyllarus, hic domini numquam mutabit habenasperpetuus frenis atque uni seruiet astro.
Quel che più conta ai fini della nostra ricerca è l’uso di Arione in funzione diparadigma intratestuale: l’ipotesi irreale con la quale il poeta loda iperbolica-mente il cavallo imperiale presuppone che il lettore conosca l’episodio diinvenzione staziana della gara dei carri. Stazio richiama infatti le caratteristi-che che lui stesso ha inventato per Arione al fine di connotare il destriero diDomiziano e di riflesso Domiziano stesso.
3. Fetonte, Ippolito e Polinice incapace della ‘bella morte’
I vv. 301-325 contengono un catalogo degli aurighi che con la loro periziahanno negli anni addolcito l’indole feroce di Arione. Nella rassegna è possi-bile ravvisare insieme con un criterio cronologico una gerarchia di lignaggioe di moralità. Il dio Nettuno (vv. 301-310), che nella ‘formazione’ del caval-lo rappresenta una sorta di ‘età dell’oro’, lo doma con la dolcezza18; ma già ilfortissimo Ercole, che è ‘solo’ un semidio, incontra dei problemi con il caval-lo: illi etiam ferus indocilisque teneri (v. 313). Per Arione la decadenza conti-nua e l’‘età argentea’ si trasforma in ‘età del ferro’, o degli eroi, quando ilcavallo, ormai reso mansueto dagli anni (v. 315), si lascia cavalcare dal pio,ma mortale, re Adrasto. Erano stati il valore e l’alta moralità a guadagnareArione rispettivamente a Ercole e ad Adrasto19; l’ultimo passaggio di proprie-
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO 583
16 At sonipes habitus animosque imitatus equestris|| acrius attollit vultus cursumque minatur;|| cuirigidis stant colla iubis vivusque per armos|| impetus, et tantis calcaribus ilia late|| suffectura patent. Vacuaepro cespite terrae|| aerea captivi crinem tegit ungula Rheni.
17 È questa l’interpretazione di Ahl 1984, p. 95, che cita Theb. VI 428 s. Inachidae credunt accen-sum laudibus; ille|| aurigam fugit. Arione corre non perché stimolato dalle lodi del pubblico, ma perchévuole evitare a tutti i costi il suo auriga. Il cavallo di Domiziano è docile e non ha mai mutato padro-ne perché è in perfetta armonia con lui.
18 Cfr. le espressioni di VI 303 teneris…lupatis; 305 uerberibus parcens; 308 adsuerat che fannopensare alla particolare attenzione usata ad Arione in virtù della sua origine divina.
19 Pausania VIII 25,10 racconta, citando Antim. fr. 32 M., che il cavallo fu dato da Onco aErcole perché combattesse contro gli Elei, e poi da Ercole ad Adrasto.
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 583
tà avviene invece in modo anomalo: Adrasto, sia pur non del tutto convin-to20, sostituisce alla successione meritocratica una successione dinastica, e perdi più non diretta. L’unico merito di Polinice, principe mortale, maledetto,defraudato del trono ed esule, è infatti quello di essere genero del sovranoargivo (v. 316). Arione, consapevole di essere precipitato in un’‘età del ferro’,tornerà, dopo anni di mitezza garantita dal ‘buon governo’, a essere feroce21.
La similitudine con Fetonte, anticipata da questa trama simbolica, con-clude il catalogo e getta un’ombra fosca sull’esito dell’impresa di Polinice. Lapresenza del lessico metaforico nella prima parte del passo induce anche atentare di leggere il richiamo al mito di Fetonte da un punto di vista più pro-fondo e legato al contesto storico. Infatti la similitudine non racchiude soloun insegnamento etico, ma va inserita in un sistema già consolidato di synkri-seis a sfondo politico. In Suet. Cal. 11,2 il vecchio Tiberio giudica il suo eredeCaligola assimilandolo a Fetonte, paradigma, in quanto auriga incapace, didistruttore dell’universo:
Quod sagacissimus senex ita prorsus perspexerat, ut aliquotiens praedicaret exitio suoomniumque Gaium uiuere et se natricem [serpentis id genus] populo Romano,Phaethontem orbi terrarum educare.
L’attribuzione svetoniana di un tale detto a Tiberio è la più antica testimo-nianza a noi pervenuta dell’uso politico del mito di Fetonte come esempio dicattivo sovrano, riferendosi a qualcosa di ancor precedente all’allusione con-tenuta nella senecana Consolatio ad Polybium 22. Il mito rappresenta le vellei-tà del giovane ‘sovrano’, noncurante dei moniti e dell’esempio paterno, cheavranno come inevitabile conseguenza la distruzione dell’impero, allo stessomodo in cui l’¢kosm…a23 era il risultato della corsa fetontea.
Polinice si può ben inserire all’interno di questa tradizione come allegoriadel giovane intemperante incapace di gestire il potere. La similitudine dei vv. 320ss. stabilisce un’identificazione che Stazio poi sviluppa solo in parte: Polinice è,come Fetonte, un giovane despota dissennato che si lascia prendere la mano daicavalli24, e, fuor di metafora, è vittima della spirale del potere. L’epilogo della
ALBERTO PAVAN584
20 La prudenza di Adrasto è massima nell’affidare il cavallo-regno a un giovane inesperto e intem-perante quale il genero. Cfr. anche VI 317 dove Adrasto si pone nei confronti di Polinice come un pre-cettore: multa monens.
21 Nel corso del poema Arione sarà di nuovo il cavallo di Adrasto, al quale dimostrerà premuro-so affetto quando a XI 442 s. (ac fata monentem|| conversumque iugo propellit Ariona) il cavallo pare met-tere in guardia Adrasto da quanto sta accadendo.
22 A 17,3 Seneca parla di imperium adustum, cfr. Degl’Innocenti Pierini 1990, pp. 250 ss.23 Cfr. Degl’Innocenti Pierini 1990, pp. 259 ss.24 Tra i difetti politici di Polinice il poeta non mette in luce solo la debolezza, ma anche l’incli-
nazione alla tirannide, che, qualora riacquistasse il trono, sicuramente svilupperebbe: cfr. Theb. I 316-319; 2, 307-315; W. J. Dominik, Monarchal Power and Imperial Politics in Statius’ Thebaid, Ramus 18(1989), pp. 76-82.
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 584
gara, però, disattenderà, almeno in apparenza, le aspettative generate dalla simi-litudine. Nell’episodio della corsa dei carri questa identificazione con Fetonte siinnesta nel motivo epico, con funzione ‘normalizzatrice’ (che riconduce cioè losvolgimento dell’azione all’archetipo presente nella corsa omerica), dell’inciden-te25. La dinamica molto elaborata dell’incidente prevede il ricorso all’interventodivino di Apollo, che non provoca un disguido tecnico, come in Omero (dovefa cadere il frustino di mano a Diomede e infonde nuovo vigore ai cavalli), masuscita la spettacolare e illusoria immagine di un mostro che terrorizza Arionetanto da farlo impennare e da far sbalzare Polinice dal carro.
La rielaborazione del motivo dell’incidente, dovuto ora all’apparizionedi un mostro spaventoso, induce a leggere sotto il personaggio di Polinice unaltro referente mitologico (e, di riflesso, un altro modello letterario). Se all’i-nizio della gara Polinice è connotato dall’assimilazione con Fetonte, al termi-ne sembra dover fare i conti con lo svantaggioso confronto con Ippolito26. Siriscontrano in effetti nei due miti alcune analogie strutturali. Il principe ate-niese Ippolito, come Polinice, è stato maledetto dal padre tratto in ingannodalle calunnie della moglie Fedra che gli fa credere di essere stata violata dalfigliastro; e, anche nel suo caso, è una divinità, Poseidone supplicato da Teseo,a mandare il mostro che ne causerà la caduta dal carro. Nel tentativo di ana-lizzare questa mescolanza di associazioni mitologiche e allusioni letterarie,giova notare che, anche nella versione senecana del mito di Ippolito, cioè latragedia Phaedra, si ha un’intersezione con il paradigma di Fetonte. La trage-dia infatti volge al termine con una lunga rhesis del nunzio che racconta lamorte del giovane principe: ai vv. 1090-1092, il nunzio commenta il momen-to in cui, caduto Ippolito dal cocchio, l’assenza di peso fa capire ai cavalli diessere privi di una guida e questi, in preda al panico, iniziano a correre intutte le direzioni. Proprio a questo punto, ai vv. 1088-1092, si ricorre allasimilitudine con il destino di Fetonte27:
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO 585
25 Quello dell’incidente è un topos delle gare curuli: cfr. Diomede ed Eumelo in Hom. Il. XXIII380-397; Atlante in Sil. It. XVI 401-414; Fauno in Nonno Dion. XXXVII 422-438; e, considerata laregata come variazione della gara omerica dei carri, anche Sergesto in Verg. Aen. V 201-209.
26 G. von Stosch, Untersuchungen zu den Leichenspielen in der Thebais des P. Papinius Statius,Berlin 1968, pp. 31 ss., studia il processo di imitazione e di variazione di Stazio nei confronti della nar-razione di Fetonte in Ou. Met. II e, alle pp. 134 s., confronta i due testi. Alle pp. 145 s., osserva che lacaduta di Polinice ricorda la morte di Ippolito, per la quale cita però solo la trattazione ovidiana di Met.XV 506 ss.
27 R. Degl’Innocenti Pierini, Ippolito ‘erede imperiale’: per un’interpretazione ‘romana’ della Phaedra,Maia 57 (2005), p. 475 legge la similitudine, partendo dal motivo dell’assimilazione della bellezza gio-vanile a un astro: «Nella descrizione senecana la similitudine conferisce dimensione cosmica alla vicen-da e accentua il pathos della narrazione. [...] è appena il caso di ricordare come assimilazioni al sole e agliastri siano perfettamente fungibili, se messe in relazione con l’ideologia imperiale, ed è infatti a questaparticolare sfaccettatura del paragone che Seneca vuole alludere avvicinandolo al motivo della correspon-sabilità ed eredità imperiale (tema naturalmente connesso con il mito di Fetonte, che proprio dall’attri-buzione del carro da parte del padre chiedeva un riconoscimento ‘ufficiale’ di paternità)».
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 585
sensere pecudes facinus- et curru leui,dominante nullo, qua timor iussit ruunt.talis per auras non suum agnoscens onus Solique falso creditum indignans diem Phaethonta currus deuium excussit polo.
Il motivo della reazione dei cavalli alla variazione del peso del carro provienedalla versione ovidiana del mito di Fetonte28, dove l’abitudine dei cavalli a undeterminato peso opera come segno distintivo dell’auriga legittimo, ed è pre-sente anche nella Phaedra. Tuttavia quel che induce a confrontare l’Ippolitosenecano con Polinice non è solo l’uso di Fetonte come termine di parago-ne29, bensì il comportamento dei due personaggi nei confronti dei cavalliimbizzarriti. Stazio ha presente la scena descritta nella rhesis senecana e lascompone inserendone le tessere in più parti della sua gara.
Quando, lungo la strada per Trezene, il mare vomita sulla terra la crea-tura di ineffabile mostruosità mezza toro e mezza pistrice, il terrore è univer-sale: coglie gli elementi, paralizza le attività umane e mette in fuga gli anima-li. Ippolito, come un saggio stoico, doma il suo istinto di paura e s’impegnaa governare il carro (vv. 1050-1056):
Tremuere terrae, fugit attonitum pecusPassim per agros, nec suos pastor sequiMeminit iuuencos; omnis e saltu feraDiffugit, omnis frigido exsanguis metuvenator horret. Solus immunis metuHippolytus artis continet frenis equospauidosque notae uocis hortatu ciet.
In questo momento critico si profila in solitudine l’eroe colto nella supremamanifestazione della sua volontà di tener a bada eventi sovrannaturali volutida un destino trascendente. La fermezza di Ippolito risalta nel mezzo del tre-more della terra e del movimento centrifugo e disordinato degli animali edegli uomini, e la ripetizione di metus, alla fine di due versi contigui, costrui-sce un’opposizione netta tra i cacciatori paralizzati dalla paura e Ippolito chene è invece immunis 30.
ALBERTO PAVAN586
28 Cfr. Ov. Met. II 161-162 sed leue pondus erat nec quod cognoscere possent || Solis equi, solitaqueiugum grauitate carebat.
29 Nel caso dell’Ippolito senecano il tertium comparationis è la reazione dei cavalli dovuta però amotivi completamente diversi, rispettivamente all’apparizione del mostro e al mancato riconoscimen-to del nuovo auriga. Nel caso del Polinice di Stazio invece il paragone con Fetonte è più completo perla collocazione della similitudine all’interno di una sezione narrativa affine per argomento e per il fattoche Polinice, come il figlio del Sole, non è l’auriga abituale della quadriga che si trova a guidare.
30 I commentatori non si soffermano sul nesso immunis metu, che solo De Meo (L.A. Seneca,
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 586
Nella seconda fase della gara staziana, ancora prima che appaia il mostro,quando gli aurighi spronano i cavalli con urla e staffilate, Polinice si distin-gue dagli altri concorrenti perché la paura lo costringe al silenzio31. Dopo chePolinice ha definitivamente rinunciato al tentativo di governare il destriero (v.450 sed nec lora regit nec verbera pallidus audet || Labdacides), e Arione, dopole scaramucce iniziali, ha sottomesso il suo cavaliere, il principe tebano è solotra i concorrenti a essere in balia del suo cavallo e si dimostra incapace di vin-cere la paura che lo domina (VI 467 s.):
solus Echionides errante silentia curru maesta tenet trepidaque timet se uoce fateri.
Si possono riscontrare nei due passi sopra citati tracce di una relazione inter-testuale. L’aggettivo solus, in posizione d’enfasi (in Seneca è a inizio di perio-do e si oppone a omnis dei vv. 1052 s.; mentre in Stazio è a inizio di periodoe di esametro, e in opposizione all’elenco di nomi precedenti), connotaentrambi i personaggi, Ippolito positivamente32 e Polinice negativamente. Lavoce di Ippolito, proprio perché nota, è uno strumento per riaffermare l’au-torità dell’auriga sui cavalli spaventati, mentre la voce di Polinice, in quantotrepida, è un’arma che potenzialmente si rivolge contro l’auriga, e cioè nemetterebbe a nudo la paura. Inoltre il verbo continet, col quale Seneca indicail controllo dell’uomo temperante sui cavalli, è richiamato da tenet che inTheb. VI 468 indica invece la preventiva autocostrizione di Polinice al silen-zio. È interessante anche notare come Seneca attribuisca l’aggettivo pauidus aicavalli che hanno bisogno dell’incoraggiamento vocale per affrontare lo spa-vento, mentre Stazio designa con trepidus il suono che rimane nella bocca diPolinice; con maggior evidenza si può contrapporre all’aggettivo trepidus ilsintagma immunis metu di Sen. Phaedr. 1054 che attribuisce al coraggio diIppolito tratti titanici, mettendo in luce per contrasto la pavidità di Polinice.
Sono delineate due situazioni antitetiche: nel primo caso è l’auriga agovernare la situazione, nel secondo invece i cavalli, al punto che l’auriga non
Phaedra, a cura di C. De Meo, Bologna 1990) ad l. si limita a spiegare con «Ippolito non conosce paura».Il nesso è un hapax (per immunis seguito da caratteristiche morali cfr. Lucan. II 257 immunis corruptimoribus aevi; TLL VII 1, 506, 22 ss.) ed è messo in risalto dalla contrapposizione con exsanguis metu(nesso invece abbastanza comune: cfr. Ov. Met. IX 224; Stat. Theb. III 361; cfr. TLL V 2, 1825, 73 ss.)del verso precedente che si trova nella medesima posizione metrica e che significa il contrario.
31 Nella versione ovidiana del mito di Fetonte lo sventurato auriga, non conoscendo i nomi deicavalli, nell’estremo tentativo di controllarli non può neppure ricorrere alla voce: cfr. Ov. Met. II 192nec nomina nouit equorum. Il caso di Polinice è ancora differente perché lui, pur conoscendo il nomedel proprio cavallo, è così schiavo della paura da non riuscire a pronunciarlo. Cfr. Ov. Met. II 192 necnomina nouit equorum.
32 Già in Ov. Met. XV 514, l’episodio di Ippolito, corda pauent comitum, mihi mens interritamansit, dove si noti anche il rilievo dato al pronome di prima singolare posto dopo la pausa metrica eriecheggiato dall’allitterazione.
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO 587
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 587
osa emettere suono. Nella rhesis del nunzio la voce di Ippolito svolge un ruoloimportante: non è solo strumento di dominio nei confronti dei cavalli e quin-di segno della sua fermezza, ma diventa anche la manifestazione della suavana, ma eroica audacia, quando, ai vv. 1064-1067, come accade convenzio-nalmente nei duelli epici, il giovane arringa il suo avversario:
contra feroci gnatus insurgens minax uultu nec ora mutat et magnum intonat: ‘haud frangit animum uanus hic terror meum: nam mihi paternus uincere est tauros labor.’
Ippolito possiede un coraggio iperbolico che lo rende minax perfino di fron-te a una lotta impari. In questo passo, l’unico nella rhesis in cui è usato ildiscorso diretto, il giovane dichiara uanus il terror 33, cioè il mostro destinatoa spaventare, e accresce la propria fiducia in sé facendo appello (il che suonatragicamente ironico) alla tradizione familiare di uccidere i tori (ovvio è ilriferimento al Minotauro).
Polinice, ancora una volta, si comporta in modo opposto a quello diIppolito visto che è il cavallo Arione a minacciarlo, non appena, poco dopol’inizio della gara, si è accorto dell’anomalo peso dell’auriga, VI 428-430:
ille aurigam fugit, aurigae furiale minatur efferus
L’abilità di Ippolito nel governare i cavalli imbizzarriti, prima che gli sfugga-no completamente di mano, è paragonata alla perizia del nocchiero che, nelmezzo di una tempesta, fa di tutto fino all’ultimo perché i flutti non fracas-sino la sua nave (Phaed. 1072-1077):
at ille, qualis turbido rector mari ratem retentat, ne det obliquum latus, et arte fluctum fallit, haud aliter citos currus gubernat: ora nunc pressis trahit constricta frenis, terga nunc torto frequens uerbere coercet.
ALBERTO PAVAN588
33 La definizione che Ippolito dà del mostro è ancora più interessante alla luce dell’occorrenzadel medesimo nesso in Phaedr. 46 s.: picta rubenti || linea pinna uano cludat || terrore feras (il nessouanus terror deriva da Hor. Carm. I 1, 23 s.; cfr. De Meo ad l.). In quel passo indica l’effetto delle cordedecorate con penne rosse usate per spingere la selvaggina nelle reti. Si potrebbe quindi intravedere unaccostamento tra uno spauracchio la cui mostruosità è solo apparente e il mostro autentico che Ippolitodeve affrontare.
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 588
Seneca insiste sulla perizia e sulla perseveranza del nocchiero per esaltare ilcoraggio di Ippolito: il nocchiero infatti usa l’ars per avere la meglio sulleforze della natura e allo stesso modo i verbi che esprimono le azioni diIppolito indicano il suo dominio sulla situazione (gubernat, trahit, coercet eancora i participi pressis e constricta). È questa similitudine che Stazio sembraavere in mente34 quando, in circostanze ben meno tragiche, descrive l’incapa-cità di Polinice di recuperare il controllo su Arione, che ha perduto delle posi-zioni perché si è allontanato dalla meta (VI 450-453):
sed nec lora regit nec uerbera pallidus audet Labdacides: lassa ueluti ratione magister in fluctus, in saxa ruit nec iam amplius astra respicit et uictam proiecit casibus artem.
Entrambe le descrizioni che incorniciano le similitudini si aprono con unacongiunzione avversativa (at; sed) che dà rilievo allo stupore provocato dalcomportamento dell’auriga: non ci si aspetterebbe infatti che Ippolito segui-tasse a lottare nel momento in cui la sconfitta appare certa, né che Polinicesubisse così passivamente le bizze del suo cavallo. Di conseguenza la similitu-dine staziana presenta una situazione ormai precipitata: il nocchiero ha giàdato prova in tutti i modi della sua perizia tecnica e ha gettato la spugna soloperché sconfitto dall’enormità degli eventi: anche i verbi che si riferiscono alnocchiero indicano che la forza del mare ha avuto il sopravvento (cfr. ruit;proiecit). Pare che, nelle intenzioni di Stazio, il rapporto intertestuale tra ledue descrizioni e le due similitudini concorra ad attribuire ad Arione caratte-ristiche ancor più mostruose del toro (infatti Polinice abbandona la lotta)oppure a sminuire Polinice, che si mostra incapace di domare le bizze di uncavallo, mentre Ippolito si sforza di tenere a bada una quadriga di fronte a unvero mostro. Nonostante i suoi eroici tentativi, Ippolito precipita dal carro es’aggroviglia nell’intrico delle redini, così che, trascinato prono (in ora) trarocce e cespugli, è fatto a brani. Polinice invece cade dal carro di schiena (perterga) e riesce a districarsi dalle redini salvandosi la vita35.
34 Corti 1987, p. 6, segnala la vicinanza di questa similitudine alla similitudine di Ov. Met. II184 ss. (ut acta || praecipiti pinus Borea, cui uicta remisit || frena suus rector, quam dis uotisque reliquit)e per prima fa notare il rapporto con Sen. Phaed. 1000 ss. autorizzato non solo dal comune motivo del-l’apparizione del mostro, ma soprattutto dall’impiego delle due similitudini con il nocchiero e conFetonte (1072-1074; 1085-1092).
35 Si può notare ancora il forte contrasto tra il verbo ligo nel passo senecano, in cui le briglie sonola causa della morte di Ippolito, ed exuo in quello di Stazio il cui soggetto è Polinice che quindi è parteattiva nel liberarsi dai vincoli: Sen. Phaed. 1085-1087 Praeceps in ora fusus implicuit cadens || laqueotenaci corpus et quanto magis || pugnat, sequaces hoc magis nodos ligat. Stat. Theb. VI 503-506 ruit ilicetexul|| Aonius nexusque diu per terga uolutus || exuit.
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO 589
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 589
A questo punto Stazio sembra abbandonare la traccia intertestualedell’Ippolito senecano per restituire la conclusione della gara di Polinice a unmodello epico: Polinice impolverato e malconcio si risolleva da terra e tornadal suocero. Il poeta concentra qui la reminiscenza di due passi omerici, lacaduta di Eumelo in Il. XXIII 392-397 e il suo arrivo in coda ai compagni aivv. 532 s.36. Su questi modelli già Virgilio aveva elaborato la caduta di Menetedalla Chimera, Aen. V 172-180, e il ritorno di Sergesto sconfitto a V 273-28137. Dei due momenti virgiliani però Stazio omette un particolare essenzia-le, quasi volesse cambiarne l’atmosfera. Quando Menete riemerge dalle acquesputacchiando, il poeta insiste sulla reazione del pubblico a quel buffo spet-tacolo (Aen. V 181-182):
illum et labentem Teucri et risere natantem et salsos rident reuomentem pectore fluctus 38.
E anche la Centauro di Sergesto, al momento dell’arrivo a terra a 272, è dettainrisa... ratis. Polinice invece, anche se è malconcio e coperto di polvere, nonsuscita il riso del pubblico che permetterebbe di scaricare la tensione accumu-lata durante la gara; il poeta evita significativamente quel momento di catar-si collettiva e inserisce l’apostrofe del narratore a Polinice, che ha perso l’oc-casione di morire con dignità.
Stazio descrive con due soli particolari l’aspetto di Polinice caduto a terra(VI 510-512):
tandem caligine mersum erigit accursu comitum caput aegraque tollit membra solo,
Spicca in questi versi l’immagine di forte impatto descrittivo della testaimmersa nella caligo, che propriamente è la polvere sollevata dall’incidente,ma, per traslato, anche l’intorpidimento dei sensi e dell’intelletto dovuto allacaduta. Il nesso caligine mersus non è raro39, ma assume qui una particolare
36 Hom. Il. XXIII 392 ss. aƒ dš oƒ †ppoi || ¢mfˆj Ðdoà dramšthn, ·umÕj ™pˆ ga‹an ™lÚsqh.|| AÙtÕj d'™k d…froio par¦ trÒcon ™xekul…sqh,|| ¢gkîn£j te per…drÚfqh stÒma te ·‹n£j te,||qrul…cqh dš mštwpon ™p' ÑfrÚsi: të dš oƒ Ôsse|| dakruÒfi plÁsqen, qaler» dš oƒ œscetofwn»; 532 s. uƒÕj d' 'Adm»toio panÚstatoj ½luqen ¥llwn|| ›lkwn ¤rmata kal¦ ™laÚnwnprÒssoqen †ppouj.
37 Cfr. Verg. Aen. V 172-180 e Williams ad l.38 Allo stesso modo in Hom. Il. XXIII 784 reagiscono i Greci quando Aiace d’Oileo cade nel san-
gue e fango dei buoi sacrificati da Achille.39 La prima attestazione del nesso si ha in Verg. Aen. VI 267 in riferimento al mondo sotterra-
neo (così anche in Auson. 339, 4), ma nelle altre occorrenze indica sempre uno stato di ignoranza dieventi passati e futuri (Sil. It. VIII 45; XI 122) o di obnubilamento delle capacità intellettive (è il caso
ALBERTO PAVAN590
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 590
densità semantica se accostato alla sua prima occorrenza in Verg. Aen. VI 266-267, dove la Sibilla rivolge agli dèi inferi questa preghiera:
sit mihi fas audita loqui, sit numine uestro pandere res altas terra et caligine mersas.
Le res caligine mersae del passo virgiliano indicano genericamente il mondosotterraneo avvolto dall’oscurità. Stazio quindi, oltre a visualizzare la condi-zione psicofisica di Polinice dopo la caduta, sembra, attraverso l’allusione agliInferi implicitamente contenuta nel nesso, suggerire anche l’idea della morteo del rischio di morte corso dal suo protagonista. Si ripristina in questo modol’accostamento a Ippolito e la fitta relazione che era stata intrecciata colmodello senecano, e che mostra come Polinice, contrariamente a Ippolito, siriveli incapace di una scelta eroica.
Non è un caso quindi che a questo punto, quando Polinice, secondo leaspettative del lettore, sarebbe dovuto morire nel pieno della gara (risparmian-dosi dal duello fratricida), sia inserita l’apostrofe che tradizionalmente accom-pagna la morte dell’eroe40; Polinice, vittima della caduta, compie invece unasorta di ‘catabasi-anabasi’ e ritorna tra i mortali. Il narratore proferisce un’a-postrofe amaramente ironica sulla bellezza della morte mancata41, che solleci-ta nel lettore un senso di delusione per la sopravvivenza del principe tebano ela sua incapacità di corrispondere a un modello eroico (VI 513-517):
quis mortis, Thebane, locus, nisi dura negasset Tisiphone, quantum poteras dimittere bellum-
di Meneceo in Theb. X 735 illi atra mersum caligine pectus|| confudit sensus; simile in Manil. IV 388rursus et in magna mergis caligine mentem). Nondimeno il verbo mergo accompagnato da una determi-nazione di luogo è di frequente usato in poesia con il senso traslato di ‘uccidere’ o ‘morire’ a partire daVerg. Aen. VI 429; XI 28 funere mersit acerbo. È usato anche in senso assoluto: Verg. Aen. VI 615 quaeforma viros fortunave mersit; Sen. Phaedr. 220; cfr. TLL VIII 833, 65-79. È utile sottolineare anche l’usodel nesso aegra membra (attestato solamente due volte in Ov. Ep. XI 40, detto di Canace, e in un altropasso di tono elegiaco in Lucan. VIII 86, detto di Cornelia) che potrebbe far pensare alla mollezza diPolinice.
40 Nella stessa Tebaide sono numerose, soprattutto nella seconda parte del poema: cfr. VII 683-687; 8, 195 (che si può associare a questa per la ripetizione del te e l’elenco dei luoghi in lutto); IX 767s.; X 498-507.
41 S. Georgacopoulou, Technique narrative et voix du narrateur: l’apostrophe dans la Thébaïde deStace, Paris 2005, p. 62, accosta l’apostrofe a Polinice a quella da lui rivolta a Tideo in quanto sonoentrambe orazioni funebri ipotetiche: cfr. 9, 63 s. non me ense tuo tunc, maxime Tydeu,||- et poteras-,nostri mactatum in limine Adrasti. Polinice rimpiange che il cognato non gli abbia dato la morte all’e-poca del loro incontro (così da non coinvolgerlo nella spedizione tebana). Tale tipo di apostrofe, chepuò essere considerata un epifonema paradossale, è affine ai makarismoì come quello che pronunciaOdisseo vittima della tempesta in Hom. Od. V 306 s.: Trism£karej Danaoˆ kaˆ tetr£kij oƒ tÒt'Ôlonto || Tro…V ™n eÙre…V (ma ancora Verg. Aen. I 94-96 o terque quaterque beati,|| quis ante orapatrum Troiae sub moenibus altis || contigit oppetere!; e Stat. Theb. V 172-174 miseri, quos non aut hor-rida uirtus || Marte sub Odrysio, aut medii inclementia ponti || hauserit!).
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO 591
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 591
te Thebe fraterque palam, te plangeret Argos, te Nemea, tibi Lerna comas Larisaque supplex poneret, Archemori maior colerere sepulcro.
Oltre all’apostrofe, anche i vari richiami al mondo dei morti dei quali l’episo-dio è contesto possono essere citati a conforto di questa proposta di lettura: alv. 496 il narratore ipotizza che Apollo abbia evocato l’immagine mostruosadall’Erebo, ai vv. 499 s. descrive un’iperbolica paura del Lete, fiume infernale,e delle Eumenidi-Erinni. L’impressione d’insieme è quella che il mondo infe-ro si sia spalancato per inghiottire Polinice, ma che egli si sia sottratto a que-sto destino, mostrandosi appunto inadeguato a un modello eroico.
Questa è la seconda volta che Polinice, ormai grottesca figura di antie-roe, perde l’occasione di ‘morire bene’. Infatti Adrasto ad Argo aveva salvatoil futuro genero dal duello mortale con Tideo, e il narratore aveva così com-mentato (I 429-430):
meliusque hostilibus armis lugendus fratri, iuuenis Thebane, iaceres
Anche in quell’apostrofe compare il riferimento indiretto all’infamia dellaguerra civile che la morte avrebbe evitato al principe tebano, e l’allusione sar-castica all’eventuale pianto di circostanza di Eteocle42. La seconda è però piùlunga della prima e culmina con un elogio della bella morte mancata. In veri-tà, anche se Polinice fosse morto durante la gara, la sua gloria sarebbe statadiscutibile: perdere la vita in un incidente, a proposito del quale il poeta nonha esitato a metter in luce l’inettitudine dell’auriga, non è certo onorevolequanto morire in guerra. In ogni caso qualsiasi tipo di morte sarebbe stataauspicabile in quanto avrebbe evitato l’infamia del destino che attendePolinice e suo fratello.
Gli onori che Polinice avrebbe meritati sono paragonati a quelli ricevu-ti dal neonato Ofelte-Archemoro. Il secondo termine di paragone, Archemorisepulcrum43, si riferisce alla narrazione in corso, cioè il momento dei funeraliin cui Polinice sarebbe dovuto morire. A lui sarebbero quindi stati dedicationori ancor più grandi di quel funerale, di cui non c’è pari44. Il paragone con
42 Georgacopoulou 2005, pp. 61-64, osserva che le due apostrofi a Polinice sono collocate l’unaa metà del primo libro e l’altra nel sesto e che entrambe riguardano l’occasione perduta di una mortegloriosa (inserita in episodi estranei al mito di Edipo) che avrebbe evitato il fratricidio, rendendo inu-tile lo svolgimento dell’epopea della guerra sacrilega cui è dedicata la seconda metà del poema.
43 Mi pare giusto in questo caso interpretare sepulcrum come sineddoche per ‘esequie’ con Mozley(Statius, Thebaid, Cambridge Mass. 1961): thou hadst excelled Archemorus in funeral pomp.
44 Cfr. 206 s. non umquam opulentior illis|| ante cinis; 213 s. il numero straordinario dei cavalie-ri; 265 ss. le centinaia di vittime sacrificali per i novendiales; etc.
ALBERTO PAVAN592
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 592
i funerali di Archemoro in corso potrebbe pertanto venare l’apostrofe di unasfumatura ironica: Polinice avrebbe ricevuto onori funebri eccezionali perchédestinati a un eroe morto non in battaglia, ma per una caduta da cavallodovuta alla sua inettitudine.
L’apostrofe mette in stretta relazione Polinice, che non è morto, conOfelte-Archemoro, morto casualmente e ingiustamente, al quale il poeta siera rivolto con toni accorati a V 534-537:
quis tibi, parue, deus tam magni pondera fatisorte dedit? tune hoc uix prima ad limina uitaehoste iaces? an ut inde sacer per saecula Graisgentibus et tanto dignus morerere sepulcro?
Entrambi i personaggi sono protagonisti di destini paradossali: il primoavrebbe potuto ottenere funerali eroici perché morto nei giochi evitando lamorte in guerra, che tradizionalmente dà diritto a tali esequie, e il secondo liha effettivamente ottenuti, in verità solo per glorificare gli Argivi, unici regi-sti della sua cerimonia funebre.
Anche l’apostrofe di VI 513-517, nella quale il narratore affetta un atteg-giamento di pietà, attribuendo alla crudele Tisifone (sotto la quale si puòscorgere il mostro dell’incidente, ma soprattutto l’Erinni familiare cheincombe sui Labdacidi) la causa della mancata morte di Polinice, se letta allaluce del rapporto intertestuale che intrattiene con la prima apostrofe e conquella a Ofelte, finisce per screditare lo stesso Polinice. Il nesso quantum bel-lum di VI 514 ricorda l’identico nesso di Verg. Aen. VI 828 s. (heu quantuminter se bellum, si lumina uitae|| attigerint, quantas acies stragemque ciebunt!),all’interno dell’apostrofe di Anchise davanti alle anime di Cesare e Pompeo,dove rimarcava l’abnormità dello scontro tra i due, inteso come ‘guerra civi-le’. Nel nostro caso quindi, in virtù di tale reminiscenza, si potrebbe richia-mare per contrasto il nesso hostilibus armis di I 429 (in contesto simile all’in-terno dell’apostrofe del narratore a Polinice che aveva evitato la morte nelloscontro con Tideo), sollecitando nella mente del lettore il confronto tra lamorte effettiva di Polinice e quella auspicabile.
Ancora più evidente è il legame tra l’apostrofe a Polinice e quella aOfelte. Entrambe si concludono con una clausola simile che insiste sul moti-vo della magnificenza dei funerali e che suggerisce il confronto tra Polinice eArchemoro: VI 517 Archemori maior colerere sepulcro e V 537 tanto dignusmorerere sepulcro. Infatti Ofelte ottiene una solenne sepoltura per il senso dicolpa e il desiderio di autocelebrazione degli Argivi; invece l’aggettivo maiorattribuito a Polinice fa pensare al triste destino riservato al cadavere del prin-cipe tebano privo di un sepolcro, tema che avrà grande importanza nella partefinale del poema.
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO 593
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 593
A questo punto conviene ritornare brevemente all’Ippolito di Seneca. Lalunga anghelía si conclude con la notizia del pietoso ossilegium di Ippolito, delquale è compianta la morte prematura, e della ricomposizione del cadavereper l’ufficio funebre45. Tutta la parte finale della tragedia è una sorta di lamen-tatio del nunzio, di Fedra e di Teseo per Ippolito erede defunto46. Le paroledi Teseo che prepara i funerali del figlio e della moglie suicida concludono latragedia (1275-280):
Patefacite acerbam caede funesta domum;Mopsopia claris tota lamentis sonet.Vos apparate regii flammam rogi;at uos per agros corporis partes uagasinquisite. – istam terra defossam premat,grauisque tellus impio capiti incubet.
Al momento della morte a Ippolito, prima rinnegato dal padre, vengonorestituite tutte le prerogative della sua nascita al punto che Teseo ordina di eri-gere per lui un regius rogus.
Alla luce della conclusione della Phaedra, appare ancora più marcato ilcontrasto tra Ippolito e Polinice. Anche per Polinice la morte nell’incidenteavrebbe potuto costituire la riabilitazione nell’ambito familiare sancita daifunerali solenni rimpianti nell’apostrofe e dalle prevedibili manifestazioni didolore del fratello Eteocle. La sorte travagliata del cadavere di Polinice, nar-rata nell’ultimo libro del poema, dimostra invece l’impossibilità di concilia-zione del personaggio con la sua famiglia d’origine: il principe è insepolto nelcampo di battaglia e il suo spettro tormenta Argia nel sonno chiedendolesepoltura (vv. 191-193 sed nulla animo uersatur imago || crebrior Aonii quamquae de sanguine campi || nuda venit poscitque rogos). Il divieto di Creontedichiara Polinice, traditore di Tebe e fratricida, indegno di onori funebri, cosìArgia e Antigone gli procurano clandestinamente una pira semiarsa. I restidegli abiti e dello scudo rivelano che quello era il rogo di Eteocle e la fiammache si divide conferma l’immortalità dell’odio tra i due gemelli ricongiunti.
Mentre Ippolito arde su un regius rogus da vero erede al trono, Polinicequasi usurpa la pira del fratello rimanendo anche da morto un diseredato,semper inops aequi (XII 445).
ALBERTO PAVAN594
45 Sen. Phaed. 1111-1114: qui modo paterni clarus imperii comes|| et certus heres siderum fulsitmodo,|| passim ad supremos ille colligitur rogos || et funeri confertur.
46 Cfr. Degl’Innocenti Pierini 2005, pp. 477-480.
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 594
4. La natura dell’apparizione mostruosa
La trama intertestuale ha consentito l’accostamento di Polinice a Ippolito conun notevole arricchimento semantico del passo della gara delle quadrighe;proseguendo sulla stessa linea di analisi, è proficuo studiare anche uno degliaspetti in cui Stazio più si allontana da Seneca, cioè la natura e la descrizionedel mostro47.
Nella Tebaide di Stazio il mostro è strettamente connesso con Apollo chene è l’artefice: il dio, ancora al v. 388, era sceso dal Parnaso e se ne stava indisparte ad assistere allo svolgimento della gara dei carri. Una volta che gliincidenti a catena causano l’eliminazione di due degli equipaggi ‘minori’, ildio comprende che è venuto il momento di intervenire direttamente a favo-re del prescelto tra i suoi pupilli, cioè Amfiarao, per renderne finalmente certala vittoria. Si poteva infatti ancora dubitare se il vincitore sarebbe statoPolinice o il favorito di Apollo.
A questo punto della narrazione, come già è stato detto, Stazio intervie-ne sull’archetipo omerico dell’incidente nella gara dei carri reinterpretandolooriginalmente con uno spunto tratto dalla Phaedra di Seneca. In Hom. Il.XXIII 383-392 Apollo levava il frustino di mano a Diomede, ma Atena se neaccorgeva, rendeva il frustino al suo protetto e, per ripicca, spezzava il giogodi Eumelo, figlio di Admeto caro ad Apollo. Nella Tebaide Apollo ‘si prendela rivincita’ provocando un incidente risolutivo che risponde in apparenzaall’accentuato gusto dell’auxesis e della spettacolarità proprio dell’epica di etàflavia, ma che, in verità, all’interno della finzione narrativa, può passare inos-servato tanto quanto quello omerico: l’incidente sarebbe infatti un’apparizio-ne che solo il cavallo vede (e che il lettore immagina), mentre è celata all’au-riga e agli spettatori48.
Il poeta visualizza nei suoi versi l’allucinazione di Arione (che diventacosì percepibile ai lettori), ma che continua a rimanere ignota ai personaggi(vv. 495-501):
47 Lunga e articolata è l’ekphrasis del mostro marino contenuta nell’agghelía di Sen. Phaed. 1007-1048. In realtà la fisionomia del mostro è descritta solo ai vv. 1035-1048: si ha un ritratto particola-reggiato e cromaticamente ricco di una belva la cui parte superiore è taurina, gli occhi sono di fiamma,e la parte inferiore termina in un’orripilante coda di pesce. I versi precedenti contengono una serie diespansioni descrittive con la funzione di accrescere grazie alla dilazione la meraviglia e il terrore. Dalmare si sente all’improvviso uno strepito senza che il cielo tuoni o che soffi vento (vv. 1007-1010), letempeste suscitate dall’Austro e dal Coro sono inferiori a tale sommovimento (vv. 1011-1014, si notil’anafora nec), il mare si riversa sulla terra e il nunzio se ne domanda le cause che enumera nella formadi due interrogative retoriche (vv. 1015-1021), il paesaggio stesso è modificato dalla comparsa delmostro che sconvolge il mare aspirando e rilasciando l’acqua (vv. 1022-1034).
48 Gli spettatori interni al testo non vedono nulla di strano, solo Arione vede l’apparizione.Lattanzio ad l. non commenta l’episodio, ritenendolo forse sufficientemente chiaro, e von Stosch, nelsuo commento ai vv. 501 ss., va oltre la finzione narrativa e spiega in modo positivistico l’incidentecitando simili cadute che avvenivano nell’ippodromo di Olimpia.
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO 595
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 595
anguicomam monstri effigiem, saeuissima uisuora, mouet siue ille Erebo seu finxit in astustemporis, innumera certe formidine cultumtollit in astra nefas. Non illud ianitor atraeimpauidus Lethes, non ipsae horrore sine altoEumenides uidisse queant, turbasset euntes Solis equos Martisque iugum.
Nella definizione del mostro la lingua di Stazio si fa alquanto criptica e ambi-gua. Esso è presentato come anguicoma monstri effigies, un’elaborata perifrasicon enallage che attribuisce al mostro una morfologia, nella quale l’elementovisivo prevale su quello concreto: è certo che si tratta di una creatura dal caporicoperto di serpenti, ma effigies indica qualcosa di puramente visivo e mate-rialmente inconsistente. Effigies designa infatti l’immagine considerata nellasua incorporeità, quindi anche le visioni oniriche e i fantasmi immateriali eingannevoli inviati dagli dèi 49.
Proprio per lasciare il lettore in uno stato di disorientamento e accrescer-ne la meraviglia, il narratore rinuncia alla onniscienza epica e affaccia due ipo-tesi sull’origine dell’apparizione introdotte dalle congiunzioni disgiuntive siuee seu50: la provenienza dell’entità dal mondo infero oppure la sua creazione daparte di Apollo solo per mettere fuori gioco Polinice e attribuire la vittoria adAmfiarao51.
Il poeta, che lascia aperte due possibilità di determinare la provenienza ela consistenza del mostro, è più chiaro nel descriverne la morfologia. Certe,che si oppone con decisione al dubbio dell’ipotesi multipla, dà per scontatol’aspetto terribile ambiguamente definito con il traslato nefas, parola astrat-ta52, che, attraverso l’idea di ineffabilità, rimanda all’effetto di terrore prodot-
ALBERTO PAVAN596
49 Cfr. TLL V 2 181, 74-78, e soprattutto Ov. Met. XIV 358 s. dixit et effigiem nullo cum corpo-re falsi|| finxit apri in cui Circe plasma la sembianza di un cinghiale per spingere Pico nella foresta dovedichiarargli il suo amore, cfr. F. Bömer (P. Ovidius Naso, Metamorphosen, Kommentar von F. Bömer,buche 14-15, Heidelberg 1986) ad l. La figura etimologica finxit effigiem consente a maggior ragionedi accostare questo passo a Theb. VI 495 s. (anguicomam monstri effigiem... || seu finxit). A ulterioreconferma della sua inconsistenza il cinghiale è detto poi spes uana a 364. Ancora più calzante è l’esem-pio tratto dai Punica in cui Giunone, per preservare Annibale dalla guerra, crea l’immagine di un fintoScipione con tanto di finto cavallo, Sil. It. VII 524-531: effigiem informat Latiam propereque coruscis ||attollit cristis; addit clipeumque iubasque || Romulei ducis atque umeris imponit honorem || fulgentis sagu-li; dat gressum habitusque cientis|| proelia et audaces adicit sine corpore motus.|| Tum par effigies fallacisimagine uana || cornipedis moderando cito per deuia passu || belligerae datur ad speciem certaminis umbrae.
50 L’uso della spiegazione multipla di fronte a fenomeni naturali straordinari è frequente nell’epi-ca di età argentea (ma già a partire da Ovidio, e.g. Met. XV 342-351): cfr. Lucan. I 412-419; Stat. Theb.VII 809-816 e Smolenaars (Statius Thebaid VII: a commentary, by J.J.L. Smolenaars, Leiden 1994) ad l.
51 Mouet infatti fa pensare allo spostamento di qualcosa di corporeo e di grandi dimensioni; fin-xit solitamente indica l’atto di plasmare un oggetto materiale.
52 Nefas è l’empietà in senso religioso, ma può essere usato anche come concreto col significatodi cosa distruttiva (cfr. OLD s.v. 1167, 4b). L’accezione è qui resa più concreta dalla iunctura con cul-tum che fa dell’astratto nefas un sinonimo del concreto monstrum.
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 596
to dall’apparizione piuttosto che alla sua effettiva consistenza. A Stazio delresto importa più l’effetto, che già Seneca trattava in modo particolareggiato,che la natura in senso stretto dell’immagine: infatti, oltre alla chioma angui-crinita, nessun particolare del mostro infernale viene descritto. Espansionidescrittive riferiscono le probabili reazioni delle più terrificanti creature mito-logiche di fronte all’effigies e accrescono a dismisura la mostruosità dell’im-magine senza però definirla puntualmente.
Nonostante la potenziale universalità dell’effetto di orrore sortito dall’ap-parizione, nel testo staziano è solo Arione a provare spavento (vv. 501-504):
ut uidit, saliere iubae, atque erectus in armosstat sociumque iugi comitesque utrimque laborissecum alte suspendit equos.
Arione è l’unico cavallo ad aver visto il fantasma: è lui infatti che rimane perun istante immobile nell’atto di impennarsi53, quasi avesse subito lo sguardopietrificante di Medusa54, trascinando con sé il compagno di giogo e i caval-li laterali estranei al suo stato di alterazione. Se, a conferma di questo, non sipuò citare la caduta di Polinice colto di sorpresa e ormai arresosi da un pezzoalla natura bizzosa del cavallo, vale la pena considerare il comportamentodegli altri cavalli e degli altri aurighi (vv. 507-510):
at hunc putri praeter tellure iacentemTaenarii currus et Thessalus axis et herosLemnius obliqua, quantum uitare dabatur,transabiere fuga.
Senza alcun impaccio, infatti, le quadrighe di Amfiarao, di Admeto e diEuneo55 riescono a superare Polinice gettato a terra da Arione che era corsoavanti a velocità folle. Se ne può facilmente dedurre che i loro cavalli nonhanno visto nulla: il mostro enorme e terribile è stato visto solo da Arione.
Non è tuttavia la prima volta nella letteratura latina in cui un cavallo èantropomorfizzato al punto da essere vittima di allucinazioni: nelleArgonautiche di Valerio Flacco si ha, infatti, un episodio che vale la pena con-
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO 597
53 L’accostamento di un verbo di stasi (sto) e di uno di moto (erigo) mostra Arione paralizzatodalla paura. Il cavallo è come pietrificato nella sua immobilità nella quale spiccano le spalle prominen-ti nell’atto di impennarsi. Cfr. Sen. Phaedr. 1084 (dei cavalli di Ippolito) rectique in pedes iactant onus.
54 Stazio dimostra un’autentica passione per i mostri anguicriniti, la Gorgone in particolare, el’effetto che provocano su chi li vede: cfr. A. M. Taisne, L’esthétique de Stace. La peinture des correspon-dances, Paris 1994, pp. 279-282.
55 Euneo è l’unico dei quattro concorrenti minori a non essere stato travolto dagli incidenti acatena e quindi a poter arrivare alla fine della corsa, anche se al momento dell’arrivo e della premiazio-ne non sarà menzionato.
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 597
frontare con quello staziano. Al momento della battaglia tra gli eserciti diPerse e quelli del suo fratello e avversario Eeta, dopo che le Amazzoni hannofatto strage dei Greci e dei Colchi, anche Ariasmeno scende in battaglia allaguida del carro falcato; allora Atena, protettrice di Giasone e quindi alleata diEeta, rimasta finora in disparte, si risolve a intervenire esibendo il suo scudo(VI 396-400):
Aegida tum primum uirgo spiramque Medusaeter centum saeuis squalentem sustulit hydris,quam soli uidistis equi. Pauor occupat ingensexcussis in terga uiris diramque retorquentin socios non sponte luem.
La conseguenza dell’intervento della dea è disastrosa: lo scudo divino con l’ef-figie della Gorgone terrorizza i cavalli che fanno rotolare a terra i loro aurighie, nello scompiglio generale, i carri falcati senza più una guida finiscono peruccidere gli uomini di Perse. Nel passo di Valerio Flacco la dea interviene infavore dei propri alleati causando un incidente, ma quel che risulta più inte-ressante ai fini dell’interpretazione del passo staziano è che solo i cavalli (tral’altro il poeta evidenzia l’eccezionalità della situazione con il ricorso all’apo-strofe: soli uidistis equi) hanno visto il mostro. Anche qui si tratta di un’imma-gine che la dea rende visibile solo agli occhi degli animali e non a quelli degliuomini56. La somiglianza con l’incidente della gara delle quadrighe sembraquindi notevole: in entrambi i casi ci si trova di fronte a un mostro anguicri-nito visto solo da uno o più cavalli57 che sbalzano dai carri gli aurighi.
56 Così F. Spaltenstein, Commentaires des Argonautiques de Valerius Flaccus 6-8 (coll. Latomus291), Bruxelles 2005, ad l.: «Que seuls les chevaux voient l’égide n’a pas de raison narrative, et s’il avaitimaginé que les guerriers la voient aussi, Valerius n’aurait pas eu à décrire une déroute différente. Maisd’une part, ce trait souligne le caractère magique de cette influence; d’autre part, Valerius voulait ceparadoxe que les chevaux attaquent leurs propres troupes et c’est donc eux qui devaient avoir une rai-son de se detourner». Wijsman (Valerius Flaccus, Argonautica, book 6: a commentary, by H.J.W.Wijsman, Leiden 2000) ad l. si limita a riportare la spiegazione già proposta da Langen: «if the chario-teers had seen the aegis as well they would have turned their backs immediately, thus robbing the vic-tors of their gloria». Pare che la prima occorrenza del motivo dei cavalli turbati alla vista della Gorgoneeffigiata nell’egida di Pallade (segnalata da Spaltenstein, che però esclude ogni rapporto con il passo diValerio Flacco), sia Lucan. VII 570 Palladia stimulet turbatos aegide currus. Anche in Stat. Silu. I 1,37-39 la Gorgone potrebbe esercitare un potere ‘psicotropo’ sui cavalli: dextra uetat pugnas || laevamTritonia uirgo || non gravat et sectae praetendit colla Medusae,|| ceu stimulis accendit equum, detto dellapiccola Atena con la testa di Medusa in mano che la colossale statua equestre di Domiziano regge nellamano sinistra. La dinamica dell’incidente, opportunamente mitizzata, richiama un’antica leggenda nar-rata da Pausania a VI 20,15: «All’altezza dell’uscita che attraversa il banco stesso, sta il terrore dei caval-li, il Taraxippo (quello che fa imbizzarrire i cavalli). La forma è quella di un altare circolare: nel momen-to in cui passano davanti a esso, i cavalli sono presi all’improvviso da un violento terrore, apparente-mente privo di causa, che li fa imbizzarrire: i carri vanno in pezzi e gli aurighi restano feriti; per que-sto gli aurighi fanno sacrifici e pregano il Taraxippo di essere benigno con loro».
ALBERTO PAVAN598
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 598
Visto che nel nostro caso è solo Arione ad avere visto il mostro, è necessa-rio precisare il motivo letterario a cui tentare di ricondurre questo episodio.Non si tratta di un dio che interviene solo per eliminare un avversario o un suostrumento, come nel caso di Valerio Flacco, ma, considerato il contesto agoni-stico, la divinità interviene con l’obiettivo di favorire il proprio protetto, comenegli incidenti a catena di Il. XXIII (dove non si verificano però apparizioni).
Piuttosto viene alla mente l’inganno di Atena in Hom. Il. XXII 226-305:la dea si presenta a Ettore sotto le spoglie ingannatrici del fratello Deífobo, ma,nel momento in cui Ettore ha bisogno di una nuova lancia, l’immagine diDeífobo si è ormai dissolta lasciando a Ettore la prospettiva della morte58.Ancora più vicino sembra il caso di Hom. Il. XXI 599-605: Apollo, preoccu-pato dell’infuriare di Achille tra l’esercito troiano, assunte le sembianze diAgenore si pone davanti a lui (che è l’unico a vederlo) e l’induce a inseguirloverso lo Scamandro, permettendo così ai Troiani di rientrare in città. È quin-di ovvia per il cavallo che riceve la visione ingannatrice da parte del dio unaderivazione da questo motivo omerico con il fine preciso di creare le condizio-ni perché il vincitore della gara risulti Amfiarao. Infatti i poeti latini attribui-scono all’animale la possibilità di ricevere visioni proprio in virtù della sua psi-cologia evoluta e della sua frequente assimilazione con l’uomo.
Conclusione
L’incidente finale della gara dei carri si presenta come il prodotto di una stra-tificazione di motivi e di riferimenti letterari esemplare per la comprensionedella densità semantica e della complessità stilistica del testo staziano. È inse-rito in un contesto agonistico tipicamente epico, ma ha l’impatto visivo dellascenografica morte di Ippolito così come si svolge nella Phaedra di Seneca. Lafelice operazione di intarsio suggerisce al lettore l’associazione per contrastotra Polinice e Ippolito, auriga che reagisce con coraggio e fermezza all’appari-zione del terribile mostro inviato da Poseidone, mentre il principe tebano sirivela nell’occasione un auriga inetto e ne esce screditato.
La similitudine che precede la gara delle quadrighe e gli indizi interte-stuali presenti nelle fasi salienti della contesa consentono invece un’identifi-
57 Secondo A. Sauvage, Études des thèmes animaliers dans la poésie latine. Le cheval (Coll.Latomus, 143), Bruxelles 1975, p. 73, i cavalli vedono i mostri (e cita a esempio i passi di Stazio eValerio Flacco) perché essi, in quanto tradizionalmente umanizzati, hanno timore di tutto ciò cheappartiene all’ambito soprannaturale. A. Hyland, Equus. The horse in the Roman world, London 1990,p. 108, attesta che i cavalli vedono le cose in modo diverso dall’uomo e che quindi ne ricevono ancheimpressioni diverse.
58 Il topos è usato anche da Virgilio in Aen. X 633 quando Giunone dà vita all’immagine di unfalso Enea per salvare Turno dal duello; si trova anche nel brano citato di Sil. It. XVII 524-531.
POLINICE, IPPOLITO MANCATO E ARIONE CAVALLO VISIONARIO 599
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 599
cazione per analogia di Polinice con il Fetonte delle Metamorfosi ovidiane.Polinice infatti è più simile al figlio naturale di Apollo alla ricerca di una legit-timazione attraverso la guida del carro paterno: l’insuccesso di Fetonte è sim-bolo di intemperanza, disconoscimento dell’etica del giusto mezzo e dell’in-capacità di dominare gli eventi. Allo stesso modo il fallimento di Polinice rap-presenta l’incapacità di far prevalere la ragione sulla forza e la passione e, nelcontesto del mito tebano, la perdita della possibilità di una morte dignitosavisto che il principe sopravvissuto è destinato a perire nel duello contro ilgemello Eteocle. L’esplicita presenza di Fetonte suggerisce inoltre l’interpreta-zione politica di quel mito nota a Stazio e alquanto urgente in un periodo di‘tirannide’ che il poeta adombra con il linguaggio universale della mitologia.
Infine, se, dal punto di vista della struttura narrativa e della tecnicadescrittiva, Stazio nella conclusione della gara ricalca ancora l’anghelía dellaPhaedra senecana, innova invece facendo del mostro un’apparizione inconsi-stente visibile solo ad Arione. In tal modo ottiene il risultato di rimarcare ladifferenza tra Ippolito che persevera a combattere con un mostro reale ePolinice sconfitto dall’allucinazione di un cavallo.
ALBERTO PAVAN600
36_Pavan.qxp 02/07/2008 16.27 Pagina 600