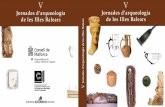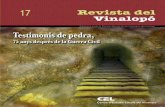Pirateria en mar y en lugares costeros aislados
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Pirateria en mar y en lugares costeros aislados
Alf
onso
Álv
arez
-Oss
orio
Riva
s,Ed
uard
o Fe
rrer
Alb
elda
,En
riqu
e G
arcí
a Va
rgas
(coo
rds.)
SPALMONOGRAFÍASXVII
El estudio de la piratería durante la Antigüedad ha sido una cuestión científica que ha pasado determinados períodos a lo largo de la historia de la historiografía y que se encuentra en boga en los últimos años. Este trabajo colectivo supone la primera aportación desde la Academia española, con la colaboración de notables especialistas internacionales, a este tipo de estudios.
Esta obra se acerca al análisis de la piratería desde una perspectiva dual, es decir, tanto desde la óptica de quienes sufren el supuesto acto pirático, como de quienes lo protagonizan de forma activa. Lo verdaderamente importante del hecho pirático es la perspectiva, quien define a la piratería y a los piratas, y las intenciones que se esconden tras las medidas políticas, bélicas y propagandísticas de quienes se enfrentan a ellos.
Hoy en día, a todos nos resultan familiares los términos “pirata” y “piratería” a partir de los libros, las películas y los medios de comunicación. Las imágenes y conceptos que nos evocan forman parte de la vida contemporánea y la cultura popular, en muchos casos con consideraciones positivas, o cuando menos, con una visión “romántica” de los mismos, pero, como se demuestra en este trabajo, durante la Antigüedad, la aplicación de la etiqueta “piratas” a ciertas comunidades del Mediterráneo constituyó a menudo una deliberada distorsión de la verdadera naturaleza de estos grupos, cuya actividad fue definida no por ellos mismos, sino por quienes la padecieron.
Últimos títulos publicados en laColección SPAL MONOGRAFÍAS
XVII. Piratería y seguridad marítima en el Mediterráneo Antiguo.
Alfonso Álvarez-Ossorio Rivas, Eduardo Ferrer Albelda y Enrique García Vargas, coords.
XVI. La religión del mar. Dioses y ritos de navegación en el Mediterráneo Antiguo.
Eduardo Ferrer Albelda, Mª Cruz Marín Ceballos y Álvaro Pereira Delgado, coords.
XV. Grecia ante los imperios. V Reunión de historiadores del mundo griego.
Juan Manuel Cortés Copete, Rocío Gordillo Hervás y Elena Muñiz Grijalvo, coords.
XIV. Salvación, infierno, olvido. Escatología en el mundo antiguo.
Eduardo Ferrer Albelda, Fernando Lozano Gómez y José Mazuelo Pérez, coords.
XIII. Piedras con alma. El betilismo en el mundo antiguo y sus manifestaciones en la península ibérica.
Irene Seco Serra.
XII. Ofrendas, banquetes y libaciones. El ritual funerario en la necrópolis púnica de Cádiz.
Ana María Niveau de Villedary y Mariñas.
XI. De dioses y bestias. Animales y religión en el mundo antiguo.
Eduardo Ferrer Albelda, José Mazuelos Pérez y José Luis Escacena Carrasco, coords.
X. Las instituciones en el origen y desarrollo de la Arqueología en España.
María Belén Deamos y José Beltrán Fortes, eds.
IX. Imagen y culto en la Iberia Prerromana: Los pebeteros en forma de cabeza femenina.
Mª Cruz Marín Ceballos y Frédérique Horn, eds.
VIII. Testimonios arqueológicos de la antigua Osuna. José Ildefonso Ruiz Cecilia.
VII. Entre Dios y los hombres: El sacerdocio en la Antigüedad.
José Luis Escacena Carrasco y Eduardo Ferrer Albelda, eds.
VI. Arqueología en Laelia (Cerro de la Cabeza, Olivares, Sevilla).
Antonio Caballos Rufino, José Luis Escacena Carrasco y Francisca Chaves Tristán.
Catálogo completo de nuestras publicacionesen la página web
<http://www.publius.us.es>
Alfonso Álvarez-Ossorio RivasEduardo Ferrer AlbeldaEnrique García Vargas
(coords.)
SPAL MONOGRAFÍASXVII
Piratería y seguridad marítimaen el Mediterráneo Antiguo
Pira
terí
a y
segu
rida
d m
arít
ima
en e
l M
edit
errá
neo
Ant
iguo
Genaro Chic García
Philip de Souza
Piero A. Gianfrotta
Adolfo J. Domínguez Monedero
César Fornis
Eduardo Ferrer Albelda
Enrique García Riaza
Antoni Puig Palerm
Isaías Arrayás Morales
Feliciana Sala Sellés
Sonia Bayo Fuentes
Jesús Moratalla Jávega
Alfonso Álvarez-Ossorio Rivas
David Álvarez Jiménez
Antón Alvar Nuño
Listado de autores
PIRATERÍA Y SEGURIDAD MARÍTIMA EN EL
MEDITERRÁNEO ANTIGUO
Alfonso ÁlvArez-ossorio rivAs, eduArdo ferrer AlbeldA, enrique GArcíA vArGAs
(coords.)
SPAL MONOGRAFÍASNº XVII
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. SECRETARIADO DE PUBLICACIONES
Sevilla 2013
Colección: Spal MonografíasNúm.: XVII
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o trasmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación mag-nética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito del Secretariado de Publicacio-nes de la Universidad de Sevilla.
© SECRETARIADO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2013 c/ Porvenir, 27 - 41013 Sevilla. Tlfs.: 954 487 447; 954 487 451; Fax: 954 487 443 Correo electrónico: [email protected] web: <http://www.publius.us.es>© ALFONSO ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, EDUARDO FERRER ALBELDA,
ENRIQUE GARCÍA VARGAS (coords.) 2013© DE LOS TEXTOS, LOS AUTORES 2013Impreso en España-Printed in SpainImpreso en papel ecológicoISBN: 978-84-472-1531-7Depósito Legal: SE 153-2014Maquetación e Impresión: Pinelo Talleres Gráficos, Camas-Sevilla.
Motivo de cubierta: Albanta S.L. Interpretación libre de la Crátera de Aristonotos (primera mitad del siglo VII a.C. Palacio de los conservadores de Roma: un navío de guerra ataca a un barco mercante).
comité editoriAl:Antonio Caballos Rufino (Director del Secretariado de Publicaciones) Eduardo Ferrer Albelda (Subdirector)
Manuel Espejo y Lerdo de TejadaJuan José Iglesias RodríguezJuan Jiménez-Castellanos BallesterosIsabel López CalderónJuan Montero DelgadoLourdes Munduate JacaJaime Navarro CasasMª del Pópulo Pablo-Romero Gil-DelgadoAdoración Rueda RuedaRosario Villegas Sánchez
ÍNDICE
PrólogoAlfonso Álvarez-Ossorio Rivas ......................................................................... 9
Violencia legal y no legal en el marco del estrecho de GibraltarGenaro Chic García ............................................................................................ 15
War, piracy and politics in the Mediterranean 500-30 BCPhilip de Souza ................................................................................................... 31
Pirateria e archeologia sottomarina: rinvenimenti, luoghi e circostanzePiero A. Gianfrotta ............................................................................................. 51
Piratería en Magna Grecia y Sicilia: mecanismos de prevención y contenciónAdolfo J. Domínguez Monedero ........................................................................ 67
Leisteía institucionalizada en la guerra de CorintoCésar Fornis........................................................................................................ 87
La piratería en los tratados entre Cartago y RomaEduardo Ferrer Albelda ...................................................................................... 95
El tratamiento de los piratas en el ius belli romano-republicanoEnrique García Riaza ......................................................................................... 127
La piratería en el archipiélago balear en la Antigüedad ¿sólo una causa de la intervención romana del 123 a.C.?Antoni Puig Palerm ............................................................................................ 145
Entre Oriente y Occidente. La acción de piratas y corsarios en el marco de las guerras silanasIsaías Arrayás Morales ....................................................................................... 167
Dianium, Sertorio y los piratas cilicios. Conquista y romanización de la Contestania ibéricaF. Sala Sellés / S. Bayo Fuentes / J. Moratalla Jávega ....................................... 187
Sexto Pompeyo ¿un pirata romano?Alfonso Álvarez-Ossorio Rivas ......................................................................... 211
Crimen y castigo en la mar: el archipirata Contradis y la inquietud marítima del Mediterráneo Occidental a comienzos del siglo VDavid Álvarez Jiménez ...................................................................................... 233
Riesgo pirático y amuletos mágicos en el Imperio RomanoAntón Alvar Nuño .............................................................................................. 261
Pirateria e archeologia sottomarina: rinvenimenti, luoghi e circostanze
Piero A. Gianfrotta
“Ciò è sempre avvenuto e avverrà sempre finché la natura umana rimarrà la stessa”
(Cass. Dio, 36.20 ss.).
Resumen: Desde el inicio de la búsqueda de los testimonios arqueológicos submarinos, el cuadro de restos de naves o de documentación asociable al fénomeno de la piratería se ha ampliado un poco y confirma su composición geográfica y cronológica. La mayor concentración entre el siglo II y la primera mitad del siglo I a.C. de los testimonios de naves comerciales que portaban armamento a bordo, coincide con las noticias históricas referentes al incremento de la actividad pirática durante la edad tardorrepublicana. En esta ocasión, además de añadir algunos otros restos provenientes del Mediterráneo Occidental, trataremos acerca de algunas cuestiones históricas (complicidades entre Mitrídates, Sertorio y los piratas; ambiguo comportamiento de Verres) o de los materiales arqueo-lógicos que requieren comentario y profundización. Por otro lado, se evidencian nuevos aspectos a los cuales se les debe dedicar especial atención en futuras investigaciones.
Nos referimos a formas particulares de piratería (o actividades asimilables) de carácter local llevadas a cabo a través de prácticas criminales efectuadas con diversas técnicas y que constituyen por sí mismas distintas modalidades. Pueden ser consideradas de este modo algunas categorías de yacimientos submarinos en lugares donde las condiciones de peligrosidad para la navegación de cabotaje ofrecían a las poblaciones ribereñas la oportunidad de efectuar estas prácticas criminales. Los ataques piráticos podrían ser muy adecuados para las características geográficas de algunos promontorios, las zonas de bajo calado, los archipiélagos con pequeñas islas deshabitadas, los estre-chos o los largos tramos costeros desprovistos de orillas utilizables.
Particular atención debe prestarse a algunos testimonios relativos a lugares aislados, lejos de los poderes estatales, como las grandes extensiones de terrenos costeros llenos de pantanos, salinas, instalaciones para la pesca, etc. Lugares caracterizados por una economía de subsistencia mínima, al margen de la vida que podemos encontrar en ámbitos más “civilizados”.
Abstract: Since thirty years ago, when the underwater archaeological research related to the phe-nomenon of piracy started, the picture of shipwrecks or documentation has expanded a little. The high concentration between the second century and the first half of the century B.C. wrecks of commercial vessels with onboard weapons for defensive purposes, coincides with the historical information on increasing piracy in Late Republican age, eradicated by Pompeus in 67 B.C.
52 Piero A. GiAnfrottA
Starting from some findings in the Western Mediterranean, the symmetric complicity with the pirates by Mithridates and Sertorius and some ambiguous behavior of Verres in Sicily is analyzed. Furthermore, new aspects to be examined in future research are discussed, such as particular forms of piracy (or its equivalent) on a local, perpetrated by various techniques and methods. These are connected with places where dangerous conditions for coastal shipping practices had been favored by criminals coastal populations: headlands, shallows, uninhabited islands, narrow and inhospitable coastlines. Particular attention should be paid to isolated areas away from the controls or coastal landscape, salt marshes, facilities for fishing and fish processing, mostly in situations of economic subsistence minimum and on the border of civic life.
La pirateria nel Mediterraneo, uno dei più rilevanti fenomeni della marineria antica, è esistita probabilmente fin dalle prime navigazioni ed è letterariamente attestata già per il secondo millennio, anche se con ruolo sociale differente rispetto a quello che ebbe in seguito. In forme organizzate raramente è stata espressione di un fenomeno autonomo, mentre in genere è stata tollerata, protetta o favorita da retroterra politici, fino a confi-gurarsi come forma latente di belligeranza tra stati. Più volte debellata su larga scala, è ripresa con varia forma ed intensità quando è venuta meno l’attività di controllo da parte di poteri centrali in aree dove oggettive necessità di sussistenza ne determinavano i moventi. L’ampia descrizione che ne fa Appiano (92 e 119) evidenzia come progressiva-mente il fenomeno divenisse irreversibile1.
La pirateria si configura come una dinamica fuori controllo, contraria e in parte paral-lela all’economia legale (a volte, un elemento del sistema), che si avvaleva di forme di organizzazione spesso inserite anche all’interno dei meccanismi normali, con ramifica-zioni persino nei grandi porti (informatori a terra, complicità tra gli equipaggi ecc.) e possibilità di riciclaggio in aree lontane dai controlli2. Inoltre e soprattutto, attraverso intermediazioni le razzie dei pirati alimentavano il commercio degli schiavi3.
Nei periodi di maggiore diffusione e più intensa attività la pirateria giungeva a con-dizionare le navigazioni, a volte quasi a paralizzarle. In un clima d’incertezza e di preoc-cupazione ogni precauzione diveniva importante e tra queste lo scambio d’informazioni. Ai naviganti che lasciavano il porto quelli che giungevano dal largo si affannavano di solito a dare notizie e consigli sui pericoli delle tempeste, dei pirati e dei passaggi difficili (Cic., pro L. Murena 4). Pur di evitare d’incontrarli si preferivano i rischi meteorologici della navigazione invernale, poi lo si è fatto per avidità di guadagno (Plin., Nat. Hist. 2.125). Per esporsi meno all’avvistamento si navigava con vele ammainate o di notte (ad es., Plut., Lucull. 3, a Cipro). E il timore diveniva spesso paura, Teofrasto (Char. 25.1) definisce il vigliacco come uno che in viaggio per mare scambia i promontori per pirati; Plutarco (De superst., 165 D) poteva affermare: “non teme il mare chi non naviga…, non teme i pirati chi resta a casa …”. Malgrado ogni precauzione, intercettazioni sistematiche
1. Sul vasto argomento ci si limita a rinviare, oltre al classico lavoro di Ormerod (1978: 59 ss.), a Marasco (1987); Braund (1992); Tramonti (1994); Ferone (1997); de Souza (1999); Cavazzuti (2004), per ulteriori riferimenti.
2. Ne è illuminante esempio l’esperienza vissuta da Apollonio di Tiana che, quando era pilota di una nave egiziana (Phil., Vita Apoll. 3.24 e 6.21), fu avvicinato da emissari dei pirati in cerca informazioni e di complicità tra i comandanti e i marinai delle navi.
3. Vi erano dietro affaristi, come nel porto franco di Delo (dove dal 166 a.C. insieme con i portoria furono aboliti i controlli), distrutto dai pirati nel 69. Si arrivava a trattarne fino a 10.000 al giorno, Strabo 14.3.2 e 14.5.2.
53Pirateria e archeologia sottomarina: rinvenimenti, luoghi e circostanze
potevano comunque avvenire in zone di transito obbligato (stretti, arcipelaghi). Per difen-dersi si rese necessario dotarsi di scorte armate a bordo4.
In prospettiva ampia e di lungo periodo, la pirateria può essere considerata un feno-meno endemico che si riteneva definitivamente scomparso nella prima metà del XIX secolo, alla nascita del mondo contemporaneo ed in coincidenza con l’abolizione della schiavitù. In questi ultimi anni però si è ripresentata con crescente virulenza (sequestri di navi e di persone rilasciate dietro riscatto, razzie, condizionamenti alle rotte mercantili) in aree economicamente e politicamente marginali, come l’Oceano Indiano ed il Corno d’Africa, e la mobilitazione di navi militari di vari paesi non basta a controllarlo. In fondo, forse la pirateria fornisce una plausibile motivazione alla loro presenza in aree oggi considerate strategiche, divenendo indiretto strumento di politiche internazionali. La sua attualità avvalora quindi la scelta degli organizzatori di questo convegno.
Mi propongo di contribuire con qualche aggiornamento desumibile dall’archeologia subacquea e con brevi commenti su due aspetti della prima metà del I sec. a.C. partico-larmente dibattuti. Inoltre, vorrei attirare l’attenzione su alcune situazioni marittime che meritano di essere indagate in future ricerche.
Una riflessione metodologica preliminare riguarda il contributo, sfuggente ma non per questo trascurabile, che le testimonianze archeologiche possono fornire allo studio della pirateria, nei confronti delle quali atteggiamenti di radicale scetticismo sono ecces-sivi e valgono solo da ulteriore richiamo alla cautela interpretativa. Già nel 1981 nell’av-viare l’indagine si sottolineavano gli ampi limiti di valutazione, del resto insiti nella stessa realtà antica5. Non è mai stato semplice distinguere dalle apparenze i moventi degli uomini6, tanto più quando non se ne conserva nemmeno l’aspetto fisico, ed il giu-dizio può basarsi soltanto su anonime e malridotte testimonianze materiali. Del resto, anche i corpi dei reati venivano prontamente eliminati. L’affondamento della nave, con l’asportazione solo degli oggetti più preziosi facilmente smerciabili, era una necessaria precauzione7. Per motivarlo e per maggiore precauzione, in molti casi poteva essere pre-ceduto da un incendio, Isidoro di Siviglia (Etym. 10.219-220) la reputa una caratteristica dei pirati: “... piratae sunt praedones maritimi, ab incendio navium transeuntium quas capiebant dicti”.
Tuttavia, se la documentazione archeologica della pirateria è per sua natura labile, ciò non impedisce di riconoscere in alcuni relitti elementi di forte valore indiziario. Ad esempio: in quello di Kyrenia a Cipro, datato intorno al 300 a.C., con punte metalliche di giavellotti conficcate nelle murate, di fronte alla Cilicia, zona periodicamente infestata
4. Oltre alle testimonianze archeologiche sottomarine, è significativo l’episodio di M. Octavius Herennus (o Herennius), Macr., Sat. 3-6-10, che resiste ad un attacco di pirati e fa voto a Ercole, nemico dei malvagi e protettore dei buoni (“… terrarum marisque pacator…”, Sen., De beneficiis 1.13.3), a cui poi a Roma dedica il tempio rotondo del Foro Boario, Gianfrotta (1981: 239 con referenze). A un contingente di armati a bordo contro gli attacchi di popolazioni costiere accenna Filostrato, Vita Apoll. 3.35 e/o 6.16.
5. Gianfrotta (1981: 227 ss.).6. Espresso nel celebre dilemma del Ciclope (Od. 9.252-255), riproposto in altri luoghi, periodi e circo-
stanze, ad es., Phil., Vita Apoll. 2.29: a Tassila, nel Gandara, a chiunque approdasse anticamente si chiedeva se fossero pirati; a tal punto si riteneva diffusa questa attività.
7. Procedure simili s’incontrano spesso nei romanzi antichi: nei Racconti efesii (X. Ephes. 1.13-14); in Leucippe e Clitofonte (Ach. Tat. 3.20); nelle Etiopiche (Heliod. 1.3 e 5.23-27).
54 Piero A. GiAnfrottA
dalla pirateria (ancora oggi al centro degli appetiti internazionali che nel 1974 portarono alla spartizione dell’isola)8.
In quello del Sec, a Palma de Mallorca, dove si trovarono ghiande missili di piombo (appropriate nelle Baleari, cfr. Polib., 3.33) e si riconobbero tracce d’incendio ritenuto probabile causa dell’affondamento9.
In quello di Spargi con almeno un morto armato e varie armi a bordo e, sembra, tracce d’incendio10. Pirateria e brigantaggio furono endemici in Sardegna con fertile attecchi-mento nel tessuto sociale (di pastorizia, di povertà e di emarginazione)11.
Ossa umane furono segnalate sul mal scavato relitto di Mahdia, dove era presente una catapulta12.
Non è poi indicazione di poco conto che il grave peso della pirateria sulle naviga-zioni in età tardo-repubblicana trovi un complessivo riflesso archeologico sottomarino in relitti di navi mercantili con armi a bordo, presumibilmente a scopo difensivo, con forte concentrazione tra il II secolo e la prima metà del I sec. a.C., circa il 40 % del totale13, in coincidenza con le notizie storiche sulla massima intensità del fenomeno. E’ il periodo in cui le pratiche criminali della pirateria, almeno quella meglio organizzata, divengono in parte strumento strategico delle guerre contro Roma da parte di Mitridate e di Sertorio e anche elemento di pressione politica14.
La composizione geografica e cronologica del quadro delle testimonianze di armi a bordo di relitti di navi mercantili, a scopo presumibilmente difensivo, risulta confermata e s’incrementa un poco con i rinvenimenti15: di un elmo di bronzo dal relitto arcaico di Cala Saint Vincenc (Pollentia-Maiorca)16; di un elmo di bronzo di tipo corinzio trovato nel Rio Guadalete nel 193817; di un elmo arcaico di bronzo, di tipo corinzio, recuperato nel 1931 a Sud di Capo Colonna (Crotone), in Calabria18; di una corta spada sul relitto con marmi di Punta Scifo (Crotone)19; di un elmo della fine del IV-III sec. a.C. da Sperlonga
8. Cavazzuti (1997: 208).9. Per le ghiande missili (Pallarés 1972: 318). L’esistenza di indizi di un eventuale incendio a bordo mi fu
comunicata da Renzo Ferrandi, capo dei subacquei che effettuarono lo scavo.10. Gianfrotta (1981: 229 ss.); Cavazzuti (1997: 204). Ved. anche Beltrame (1998). Per un secondo elmo
con resti di cranio, Gandolfi (1985: 317, nota 26); Rivista di Studi Liguri XLV. Omaggio a N. Lamboglia III) (1979: 176).
11. Ancora in età augustea pirati sardi si spingevano a fare razzie sul litorale pisano (Strabo 5.2.7). Nel 6 d.C., una dura recrudescenza del brigantaggio anche in mare fu domata con invio di legioni e della flotta (Cass. Dio, 55.28.1); nel 19 furono trasferiti in Sardegna 4000 liberti per combattere atti di latrocinium, cfr. Cavazzuti (1997: 200).
12. Oltre ad ossa di animali (maiale e pecora) fu trovato un perone umano, femminile, altrimenti relativo a persona deceduta nel naufragio, Diolé (1952: 44). Non ve n’è traccia in Das Wrack, forse per la mancata conservazione dei resti.
13. Contrariamente alle aspettative che indirizzerebbero verso le regioni orientali e l’Egeo, le potenziali testimonianze raccolte riguardano soprattutto il Mediterraneo occidentale, dove principalmente sono state con-dotte ricerche.
14. Gianfrotta (1981); (2001); Cavazzuti (1997).15. Gianfrotta (1981); Cavazzuti (1997); Gianfrotta (2001). Per le testimonianze anteriori al V sec. a.C. ved.
l’ottimo riepilogo di Álvarez Arza (2008: 218-223).16. Álvarez Arza et Alii (2008: 199-208 e 218-223).17. Álvarez Arza (2008: 219). Altre armi e un elmo proverrebbero da dragaggi del 1930 nel porto di Huelva,
Terrero (1944: 17-19).18. Álvarez Arza (2008: 220); Medaglia (2010: 295).19. Individuata in ricerche del 1983 e lasciata in situ, segnalaz. di A. Freschi.
55Pirateria e archeologia sottomarina: rinvenimenti, luoghi e circostanze
(Formia) con iscrizione tle incisa (fig. 1)20; di un elmo di bronzo tardo-repubblicano da Camarina (Sicilia sud-orientale)21; del relitto della Pointe du Brouil (baia di Cavalière, La Croix-Val-mer), di una nave naufragata intorno al 130 a.C. probabilmente in seguito a un incendio22; di un frammento di elmo di bronzo con paranuca, rimasto inedito, che era nel giacimento del Grand Con-gloué23; di un elmo tardo-repubblicano da Populonia24; del relitto d’età flavia di Marina di Fiori (Porto Vecchio, Corsica), con tracce d’incendio e resti umani a bordo25, che testimonierebbe episodiche attività criminose in aree periferiche e poco controllate anche nella prima età imperiale26.
Al non lungo elenco si può aggiun-gere, seppure attribuibile ad azioni impropriamente “piratesche”, un rostro bronzeo tridentato con parte del legno dello scafo recuperato nel 2008 a Capo Rasocolmo (Messina)27. Il mare anti-stante il Capo era già stato oggetto di scoperte subacquee messe in relazione con le vicende finali della guerra navale tra Sesto Pompeo e Ottaviano e Agrippa culminata nello scontro di Nauloco del 36 a.C.28.
A circa 8 metri di profondità, erano stati trovati resti di un relitto navale, ma in assenza di legno. Quindici macine di pietra lavica, alcune incomplete. Moltissimi chiodi di varie misure e sagome; concrezioni di rame, ferro e piombo costituite per lo più da chiodi e lamine metalliche (fig. 2). Dieci protomi di cigno in bronzo col capo ricurvo per fissaggio di cime sulle fiancate. Un’ancora di ferro con ceppo di piombo decorato con astragali, un lingotto di piombo con bollo. Un golfare di bronzo costituito da una fascia metallica con
20. Cassieri (2011), avulso da contesto e di datazione vaga, ma in area interessata dalla pirateria etrusco-volsca (Strabo, 5.3.5), Cristofani (1983: 118), e forse poi da episodi di difesa costiera.
21. Pflug (2006: 259 ss.); Di Stefano (2008: 180).22. Pomey et alii (1989: 28).23. Informazione fornitami da L. Long che ringrazio per l’amichevole segnalazione.24. Inedito.25. Bernard (2008: 463).26. Ved. nota 11.27. Che le imbarcazioni usate dai pirati meglio organizzati ne fossero dotate lo si evince dal numero
di quelle rostrate catturate loro da Pompeo Magno nel 67 a.C.: 800 navi secondo App., Mith. 116-117; 846, secondo Plin., Nat. Hist. 7.93, la cui precisione si basava probabilmente su archivi militari.
28. Bacci (1994). Quanto alla definizione di bellum civile o di bellum piraticum, si rinvia alla relazione di A. Álvarez-Ossorio Rivas in questa stessa sede.
Figura 1. Elmo di bronzo da Sperlonga.
56 Piero A. GiAnfrottA
attaccato un grosso anello per ormeggi. L’imbarcazione è affondata dopo un incendio: sono stati rinvenuti elementi di piombo fuso in maniera caratteristica e gocce solidificate a contatto con l’ac-qua, in parte racchiudenti frammenti di legno carbonizzato. Furono recuperati anche piccoli oggetti eterogenei, una ventina di ghiande missili di piombo e una cinquantina di monete in bronzo e di argento (assi e denari di zecche forse spagnole e siciliane29). Le più recenti non vanno oltre la battaglia di Nauloco, il 3 settembre del 36 a.C. Si sono tro-vati anche tondelli non battuti, un asse mal coniato e grumi. Va infine sottoli-neata la presenza di una laminetta di rame di forma lunata, lunga circa cm 15, con l’iscrizione puntinata CN P MAGNUS (fig. 3) probabile piastrina di riconoscimento col nome di Gn. Pom-peo Magno30.
L’insieme dei rinvenimenti indica trattarsi di un’imbarcazione di mode-ste dimensioni ed il loro impiego è confermato da notizie di Appiano (BC
5.106-108, 437-448) e di Cassio Dione (49.1.2) sulle caratteristiche tecniche delle navi in campo nella battaglia. Quelle di Sesto Pompeo erano corte, leggere e affilate, quelle di Ottaviano, di media taglia, erano più pesanti e lente, con più uomini a bordo31. E’ valido quindi il collegamento alle vicende di Nauloco, ma, piuttosto che a una nave colata a picco nello scontro, l’eterogeneo materiale rinvenuto fa pensare a una nave reduce dallo scontro, affondata forse mentre cercava di fuggire verso Messina32. Altrimenti potrebbe trattarsi di una delle navi di Sesto rimaste incagliate nelle secche e poi fatte bruciare da Ottaviano (Cass. Dio., 49.10.2)33.
29. Truppe ispane facevano parte delle forze pompeiane poi passate dalla parte di Ottaviano, ved. Ferone (1989: 191).
30. Manacorda (2005: 138 s.), per la laminetta con iscrizione CNPMAGNUS, pensa ad “un collarino appli-cato, ad esempio, ad un piccolo busto con le fattezze del capostipite della dinastia,…. un’immagine di Pompeo, conservata forse in una sorta di larario a bordo di una delle navi di Sesto”. Va però ricordato che ai coscritti della leva militare veniva dato un distintivo metallico da appendere al collo (“piastrine” di riconoscimento, necessarie anche al recupero dei cadaveri), ved. ad es., Atti e passioni dei martiri, Atti di Massimiliano 2, 6 (pp. 239-241). Sappiamo da Cassio Dione che sugli scudi dei soldati era scritto il nome di Pompeo (42.14.5) e che su quelli di M. Tizio, discutibile armatore filopompeiano, era scritto quello di Sesto Pompeo (48.30.6).
31. Ferone (1989: 197).32. Bacci (1994: 121).33. Ved. Ferone (1989: 191 ss.).
Figura 2. Capo Rasocolmo (Messina), materiali affioranti del relitto.
57Pirateria e archeologia sottomarina: rinvenimenti, luoghi e circostanze
Anni fa avevo esternato una teme-raria suggestione relativa a un ceppo di ancora con iscrizione Mena(s) trovato a Maratea, forse accostabile alle vicende del bellum piraticum tra le flotte di Ottaviano ed Agrippa e quella di Sesto Pompeo. Nelle acque del Tirreno meri-dionale prossime a Maratea si ambienta una delle due disfatte navali subite da Ottaviano, nel 36 a.C. Mentre con una flotta appena costruita navigava verso la Sicilia, nel doppiaggio di Capo Pali-nuro incappò in una tempesta: perse molte navi e per giunta Mena, l’abile ex-capo-pirata in quel frangente tornato a combat-tere dalla parte di Sesto Pompeo, piombando sulle navi superstiti ormai sparpagliate, ne bruciò alcune e ne catturò altre (Cass. Dio., 49.1). L’accostamento però è molto fragile e non possono escludersi altre ipotesi34.
Lo scenario complessivo del periodo a cui si riferisce la maggior parte delle testimo-nianze archeologiche sottomarine é caratterizzato dalla connessione tra gli avvenimenti concomitanti delle vicende di Sertorio, di Mitridate, dei pirati e in parte delle ribellioni servili. Riguardano anche la figura di Verre qual’è trasmessa da Cicerone, nel quadro di un vasto conflitto politico. Alcuni punti si prestano a discussione.
Le guerre di Sertorio in Spagna, di Mitridate in Oriente, i dissidi interni e le rivolte schiavili in Italia e, in mare, l’imperversare quasi incontrollato dei pirati concorsero ad indebolire gli interessi mercantili di Roma35. Un avvenimento cruciale fu la strage di Romani e di Italici in Oriente nell’88 a.C., con la simultanea uccisione soprattutto di Ita-lici, con mogli, figli, liberti e servi, e depredazioni di beni in tutta l’Asia, la cui presenza nel II e nel I sec. a.C. ne monopolizzava l’economia36. Ad ulteriore conseguenza dei mici-diali colpi inferti ai grandi interessi affaristico-mercantili, a Roma restarono insolute le scadenze degli innumerevoli prestiti marittimi e si determinò la crisi del credito37.
Soprattutto a partire dall’82 a.C., bande di pirati cilici collaborarono con Sertorio e agirono d’intesa con Mitridate38. Quest’ultimo sperava di potere congiungere l’Oceano col Ponto e le truppe di Sertorio con le sue in modo da attaccare Roma da Occidente e da Oriente e, come già era stata strategia di Annibale, si proponeva accordi coi Celti e i Sanniti39. D’al-tro canto, cittadini romani scambiavano lettere segrete con Sertorio per sovvertire lo stato
34. Gianfrotta (2001: 213 ss.).35. Cic., De imp. Cn. Pompei 9-10; Plut., Sert. 23; App. Mithridatica 70. Su questi argomenti ved. la con-
divisibile relazione di I. Arrayás Morales in questa stessa sede.36. Appian., Mithridatica 22-24 e 28; anche Vell. Pat., 2, 18, 2.37. Cic., De imp. Cn. Pompei 19: “E’ inevitabile che quando in uno stato molti perdono averi e sostanze,
molti altri siano trascinati nella stessa rovina”.38. Plut., Sert. 7, 3; 9,1; 25, 1; Sallust., Hist. 2, 47, 7; 2, 90. Incappato in una tempesta presso Lemno Mitri-
date riuscì a salvarsi su una nave di pirati, App., Mithridatica 78. Navi pirate andarono in aiuto di Sertorio (Plut., Sert. 18). Ved. anche Plut., Sert. 23 e Pomp. 20; Cic., pro L. Murena 32.
39. Cic., pro L. Murena 32; Plut., Sert. 23. App., Mithridatica 109 e 112. Al suo servizio ufficiali di Sertorio svolgevano ruoli di collegamento e di consiglieri militari, App., Mithridatica 68 e 70; Cic., II Verr. 2.86-90.
Figura 3. Capo Rasocolmo, piastrina iscritta CN P MAGNUS.
58 Piero A. GiAnfrottA
(Plut., Pomp. 20) e vi furono anche collusioni di cittadini con i pirati (Plut. Pomp. 24). Ripetutamente Cicerone nelle Verrine e nella de imperio Cn. Pompei (9-10) evidenzia colle-gamenti tra Mitridate e Sertorio, attraverso mercanti provenienti dall’Occidente che insieme alle merci avevano diffuso nel Ponto storie che parlavano di Sertorio (Plut., Sert. 23)40.
Le rivolte servili potevano contribuire al medesimo disegno. Le connessioni dirette con episodi di pirateria, se ci furono, ebbero però carattere episodico tra due componenti per natura antitetiche dato il ruolo di razziatori di schiavi in genere svolto dai pirati. E’ signifi-cativo che quando Spartacus ebbe contatti con pirati cilici che frequentavano lo Stretto e si accordò con loro per l’attraversamento in Sicilia anticipando buona parte del pagamento, essi sparirono non rispettando i patti (Plut., Crass. 10. 6-7). Il mutevole comportamento può essere facilmente attribuito ad estemporanei impedimenti e alla loro tipica inaffidabilità; agivano abitualmente con doppiezza di ruoli, con informatori e spie nei porti e sulle navi per avere notizie sui carichi, su itinerari e tempi dei viaggi, oltre che per rivendere quanto depredato.
Date le circostanze però (anche per l’arrivo a Brindisi di Lucullo vincitore su Mitri-date, Appian., BC 120.557), non possono escludersi loro opportunismi in cambio di van-taggi con rappresentanti di Roma. In Sicilia esercitava le sue funzioni Verre, al quale Cice-rone rivolge ripetute accuse di complicità e di familiarità con i pirati e con i loro capi. Oltre agli innumerevoli ladrocini e alle malversazioni, i suoi comportamenti duplici, denunciati nella loro palese criminalità, potrebbero essere stati almeno in parte motivati da iniziative nascoste miranti a fronteggiare pericoli per lo Stato romano provenienti da vari fronti.
Cicerone, appunto, rinfaccia a Verre coperture e complicità date ai pirati nei porti della Sicilia, a Siracusa in particolare41. Lo accusa di avere rilasciato capi pirati che anda-vano giustiziati e di averne ospitati alcuni a casa sua (Cic., II Verr. 1.9 e 12); di avere lasciati aperti ai pirati il porto e la città, assalita da Eracleone (1.13); di avere permesso l’incendio della flotta che difendeva della Sicilia e persino che navi pirate incrociassero nel porto di Siracusa (Cic., II Verr. 3.186). Inoltre, lo accusa di avere venduta ai sertoriani Magio e Fannio, che operavano con Mitridate, la nave milesia che lo accompagnava per difesa contro i pirati “… (Verre) piratarum ipsum consceleratum fuisse”. Tutto appare ambiguo, la stessa consistenza dei fatti e come essi vengono presentati.
L’argomento è per molti versi destinato a rimanere oscuro, ma sono sospettabili doppi giochi (o forse anche più complessi) e molteplici cambi di fronte. Rientrava nei compiti di Verre anche vigilare, sospettare collegamenti e interazioni commerciali (collusione e ricettazione) tra i pirati e i mercanti e i naviculari che giungevano a Siracusa oppure accu-sarli di essere complici di Sertorio42. I suoi rapporti con pirati o con partigiani di Sertorio potevano anche servire ad ottenere informazioni e delazioni.
Non è in questione la rivalutazione dell’operato di Verre in Sicilia, ma forse c’è spazio per qualche commento su un aspetto del suo comportamento inquisitorio, vessatorio e –a detta di Cicerone– appositamente zelante per coprire le azioni criminose nei confronti dei negotiatores che giungevano a Siracusa, accusati e a volte condannati in quanto giudicati
40. Navi pirate andarono in aiuto di Sertorio (Plut., Sert. 18). Ved. anche Plut., Sert. 23 e Pomp. 20; Cic., pro L. Murena 32.
41. I Verr. 13; II Verr. 2-4; 3.186.42. Tra esempi di commistioni tra commerci e pirateria, ved. Paus., 4.35.6 (navi degli Illiri che scambiarono
il carico con vino dei Motonei e poi rapirono molti uomini e donne); Plin., Nat. Hist. 6.162 (molte popolazioni arabe si dividono pressoché a metà tra commercianti-ricettatori e briganti.
59Pirateria e archeologia sottomarina: rinvenimenti, luoghi e circostanze
rei di complicità sertoriane. Le alleanze tra Mitridate, Sertorio e i pirati rendevano comun-que plausibili le accuse ed i comportamenti predatori e persecutori contro elementi che appartenevano spesso ad aree politiche avverse alla parte sillana (a volte con certezza).
A loro discolpa i malcapitati mostravano i carichi composti di merci orientali, quindi di tutt’altra provenienza rispetto alla penisola iberica, ma questo non bastava a scagio-narli. Per l’avidità di volergli comunque rapinare le merci pregiate secondo Cicerone43, ma l’accusa di Verre aveva comunque motivazioni generali per essere sostenuta, dato che anche elementi vicini a Sertorio navigavano il Mediterraneo orientale ed i Sertoriani sembra potessero avvalersi di riferimenti in Sicilia (Cic., Verr. 6.146; 6.154 e 6.76). Non sarebbe stata la prima, né l’ultima volta che affaristi e mercanti approfittavano di circo-stanze belliche per fare affari con il nemico44. Di una circostanza di questo tipo, durante la rivolta di Tacfarinas (17-24 d.C.), approfittò, insieme ad un certo Carsidius Sacerdos, anche un personaggio dal nome altisonante come C. Sempronius Gracchus, il cui padre era stato esiliato nell’isola di Cercina, e che ormai “per Africam ac Siciliam mutando sordidas merces sustentebatur” (Tac., Ann. 4.13.2)45.
Le tracce di alcuni dei personaggi che si spostavano e facevano affari sui diversi fronti potrebbero riaffiorare attraverso l’archeologia sottomarina. Sul relitto Escombre-ras 1, a Carthago Nova, si sono trovate anfore di un C. Raecius forse collegabile ad un L. Raecius, negotiator presente a Panhormus, in Sicilia, nel 73/71 a.C. (2 Verr., 5.161)46. Incuriosisce anche la presenza su vasellame a v. n. e su ceramica comune del graffito mercantile HER o anche C. HE47. In quest’ultimo si distingue il prenome C(aius) e nel nesso che lo segue si può vedere l’abbreviazione di un nome, dai molteplici scioglimenti. Uno è Herennius. In tal caso si può tenere presente che un L. (o T.) Herennius, ricco civis romanus, presente a Siracusa nel 73/71 a.C. e quindi coevo al naufragio dell’Escombreras (in 2 Verr. 1.14 è definito negotiator ex Africa e banchiere a Leptis, ivi, 5.155: qui-argen-tariam Lepti fecisse), venne fatto decapitare da Verre con l’accusa di essere Sertorianus48. Le sigle sui vasi potrebbero essere di suoi agenti (o liberti). Se l’accostamento alle sigle dell’Escombreras coglie nel segno, se ne può dedurre un collegamento di Herennius con la penisola iberica.
43. Cic., Verr. II 5.56.146: “Quicumque accesserant ad Siciliam paulo pleniores, eos Sertorianos milites esse atque a Dianio fugere dicebat. Illi ad deprecandum periculum proferebant alii purpuram Tyriam, tus alii atque odores vestemque linteam, gemmas alii et margaritas, vina non nulli Graeca venalisque Asiaticos, ut intelligeretur ex mercibus quibus ex locis navigarent. Non providerant eas ipsas sibi causas esse periculi, qui-bus argumentis se ad salutem uti arbitrabantur. Iste enim haec eos ex piratarum societate adeptos esse dicebat; ipsos in lautumias abduci imperabat, navis eorum atque onera diligenter adservanda curabat”.
Cic., Verr. II 5.59.154: “…; frequentissimi venerunt ad hoc iudicium mercatores, homines locupletes atque honesti, qui partim socios suos, partim libertos, partim conlibertos spoliatos in vincla coniectos, partim in vinclis necatos, partim securi percussos esse dicunt”.
44. Sulla buona accoglienza ad essi riservata si basa Senofonte (Hipp. 4.7) per raccomandare di procurarsi, prima di iniziare una guerra, spie provenienti da città neutrali e reclutate tra i mercanti.
45. Manganaro (1987: 581); D’Arms (1981: 4 e 24).46. Cfr. Fraschetti (1981: 63-65 e 68, n. 16); Gianfrotta (2008: 66).47. Gianfrotta (2008: 66).48. Per una sua origine napoletana, Musti (1980: 200) che rinvia a Gabba (1973: 312), il quale considera
“puteolani gli Herennii (ai Granii e agli Herennii vengono attribuite simpatie sertoriane, anche in considera-zione del conflitto tra Silla e un Granio puteolano, Plut., Sulla 37.5)”.
60 Piero A. GiAnfrottA
Gli si può accostare un ulteriore indizio epigrafico, la cui effettiva validità resta da valutare, che proviene dalla fase più antica degli scavi nella città romana di Iesso (Guis-sona), in Catalogna. E’ il titulus C. HE (in nesso) iscritto in rosso sulla spalla di un’anfora brindisina, tipo Apani V A, timbrata su un’ansa col bollo rettangolare Apollon retroverso. E’ stato integrato C(ai) He(renni) e trovandosi su un contenitore commerciale è stato rife-rito ad un mercator o ad un negotiator49.
INDIRIZZI PER FUTURE RICERCHE
Unitamente alle testimonianze relative ai relitti di navi, utili elementi possono deri-vare dal riesame della documentazione archeologica relativa alle coste, alle piccole isole, ai centri costieri che subirono incursioni e devastazioni, come toccò ad Ostia, a Gaeta, a Miseno (Cic., de imp. Cn. Pomp., 11-12). Anche Cosa potrebbe essere stata distrutta dai pirati intorno al 70 a.C.50. Valore indiziario, non incontrovertibile in circostanze generali di drammatica instabilità politica e di turbolenza, possono assumere i ripostigli monetali della fine del II e del primo quarto del I sec. a.C. in zone costiere oggetto di frequenta-zioni piratesche.
Indagini mirate possono portare all’individuazione di forme particolari di pirateria locale o ad essa assimilabili, commiste al brigantaggio, perpetrate da gruppi d’individui e anche da intere popolazioni attraverso pratiche criminali esercitate in vario modo. In società poco evolute non esistono o non sono chiari i limiti fra pirateria e commercio o fra pirateria e guerra di corsa, come per le fasi più antiche a cui si è accennato all’inizio. Tut-tavia anche successivamente, in alcune circostanze i meccanismi si ripropongono. Basti ricordare le complicità dei sovrani dell’Egitto e di Cipro con i pirati-mercanti di schiavi (Str. 14.5.2.669) o l’ovvio sostegno della regina Teuta ai pirati Illirici che depredavano i mercanti italici (Polib., 2.8)51.
In casi fortunati, potrebbero essere riconosciuti tracce di eventi delittuosi in even-tuali corpi del reato occultati, non imputabili ad affondamenti dovuti a cause naturali o ad errori di navigazione, tanto più interessanti se correlabili a notizie delle fonti antiche. Meritano di essere indagate in questa prospettiva alcune categorie di giacimenti archeo-logici sottomarini (come gli ancoraggi, i “cimiteri di relitti” e altre), in luoghi dove con-dizioni di pericolosità per la navigazione costiera favorivano pratiche criminali da parte delle popolazioni rivierasche. Potevano essere assalite anche navi in sosta presso la costa. E’ quanto facevano gli Isauri che nascosti tra le rupi costiere spiavano i naviganti che frequentavano la zona e quando li vedevano addormentati si arrampicavano a bordo delle navi lungo le cime delle ancore (quadrupedo gradu), uccidevano tutti e portavano via gli oggetti preziosi e quanto poteva tornargli utile (Amm., r. g. 14.2.2-3).
49. Guitart i Duran-Pera i Isern-Carreras i Monfort (1998: 44, 48 s., fig. 9, 1). Ved. inoltre Manacorda 2004: 183.50. Per Cosa, F. E. Brown (1970-71: 362 ss.), opportunamente suggeriva la revisione della documentazione
degli scavi di Vetulonia e di Talamone, dove il tempio fu distrutto all’inizio del I sec. a.C., come altri santuari costieri dell’Etruria meridionale.
51. Cassola (1968: 33 ss.); Musti (1980: 200). Anche in tempi moderni sono state spesso rilasciate patenti di corsa (ad es., al servizio della monarchia inglese; a nobili famiglie catalane o siciliane; a navi di privati per attaccare mercantili nemici durante la guerra d’indipendenza americana; e ancora nell’ultima guerra mondiale).
61Pirateria e archeologia sottomarina: rinvenimenti, luoghi e circostanze
Gli attacchi pirateschi approfittavano delle caratteristiche di alcuni promontori come, ad es., il pericoloso Capo Malea (Polib., 5.95 e 101), Capo Colonna a Crotone (Petr., Sat. 114-116) oppure quello sotto cui avrebbe dovuto gettare l’ancora la nave guidata da Apollonio di Tiana (Phil., Vita Apoll. 3.24). Adatti agli attacchi potevano essere i luoghi con bassifondali, gli arcipelaghi e le piccole isole disabitate, gli stretti (Fretum Siculum, Gallicum, Gaditanum ecc.) ed i lunghi tratti costieri spopolati e privi di ripari52. Non si può escludere che, tra altre possibili cause, anche la nave naufragata a Giens (Tolone) nella prima metà del I sec. a.C. possa essere stata affondata da pirati53. L’eventuale inter-vento di urinatores potrebbe essere avvenuto in un secondo momento.
NAUFRAGI PROCURATI
Una categoria a parte, diffusa e persistente nel Mediterraneo antico, è poi quella consistente in pratiche criminose perpetrate, anche da intere popolazioni, per depredare i resti delle imbarcazioni ed i naufraghi, spesso uccidendoli; a volte i naufragi procu-rati, con false segnalazioni luminose alle navi, in genere con falò notturni. Ai naviganti simulavano la presenza di fari per guidare l’atterraggio o di fuochi regolari sulle alture e presso santuari o di torri. False segnalazioni mandavano le imbarcazioni a naufragare contro gli scogli o ad arenarsi in secche o bassi fondali. Di questa pratica reale può tro-varsi riferimento in un racconto mitico negli Epitoma (6, 7) di Apollodoro, in cui un falso segnale di fuoco fatto da Nauplio sul promontorio Cafareo viene scambiato per l’indica-zione dell’entrata di un porto inesistente per cui le navi dei Greci vanno a sfasciarsi sulle rocce. La praticavano sistematicamente i Frentani di Ortona (cfr. Strabo, 5, 4, 2 [C 242]) ed ancora Dionisio di Bisanzio (Perieg., fragm. 47, 48, 49) riferisce di procacciatori di naufragi lungo le coste del Bosforo tracio.
Anche per esercitare qualche vigilanza in zone isolate, torri per avvistamento contro pirati e briganti erano diffuse in varie regioni, Plin., Nat. Hist. 2.73 (71) e 7.57.11. Torri di riferimento (Strabo, 4.1.8) e di controllo erano distribuite lungo la bassa costa della Camargue (da cui le imbarcazioni entravano nel Rodano), non facilmente distinguibile e raggiungibile a causa delle correnti ed i mutamenti dovuti agli apporti del delta fluviale54.
NAVI SPIAGGIATE
Relitti di imbarcazioni depredate potrebbero trovarsi tra le navi spiaggiate. Quelli insabbiati a minima profondità presso la riva, derivati da imbarcazioni spinte dagli ele-menti naturali o gettatevi mediante intenzionale manovra di atterraggio, col vento che soffia perpendicolarmente alla costa, mettendo la nave di traverso e presentandone quindi
52. Per la la Sardegna e la Corsica, Zucca (2003).53. Tchernia (1989). Un paradossale scherzo del destino è stato poi il saccheggio di tutte le anfore recupe-
rate negli scavi sottomarini dal magazzino in cui erano depositate.54. Nella Camargue, collaborazionismi con attività piratesche sono registrate ancora in età moderna.
62 Piero A. GiAnfrottA
un fianco alle onde55. La loro presenza determina un veloce processo di copertura dovuto al moto ondoso, particolarmente turbolento in prossimità della riva, che, a contatto con lo scafo, può produrre un’azione di rimescolio e di scavo tale da farlo sprofondare, trasfor-mandolo così in un’opportunità di accumulo di sedimenti56.
Di quanto potesse essere appetito il saccheggio dei relitti spiaggiati può dare un’i-dea una notizia di Senofonte relativa alla Tracia pontica. Al fine di evitare dispute che a volte si risolvevano in vere e proprie carneficine, per depredare le navi che entrando nel Ponto si arenavano per la scarsa profondità e finivano quasi all’asciutto, lungo la costa di Salmidesso, i Traci avevano spartito fra loro a fette tutta la riva, delimitandole con cippi, in modo che ogni gruppo di abitanti potesse derubare senza litigi i naufraghi che approdavano nella propria striscia. Le loro case erano piene di letti, casse, rotoli scritti e tutte quelle altre cose che i naviganti usavano portare con sé in bauli di legno (Xen., Anab. 7.5.12-15).
COMPLICITÀ AMBIENTALI ED INIZIATIVE SPONTANEE
In molte aree vigevano complicità tra pirati e popolazioni costiere nell’uso di approdi comuni, in reciproci favori e in scambi57, come in massimo grado si verificò nella Cilicia d’età tardo-repubblicana. Ma una particolare attenzione va rivolta anche a molte altre testimonianze relative a luoghi isolati o a plaghe di grandi latifondi costieri, soprattutto se con paludi, saline, installazioni per la pesca e la lavorazione del pescato, ambientate in aree caratterizzate da economie di minima sussistenza, ai margini della vita civile.
Località e situazioni lontane dall’azione di controlli del potere centrale offrivano facile rifugio a pirati ed occasioni di ricettazione. Sono pirati-pescatori quelli inseriti da Achille Tazio in “Leucippe e Clitofonte”, in un villaggio della costa di Tiro (2.17.3), o nello stesso romanzo i pescatori di porpora che erano finiti a fare i pirati (5, 7, 6) oppure ancora gli scalcinati protagonisti della vicenda di Calliroe che nel racconto di Caritone sono frequentatori dei bassifondi portuali58. I pescatori crotoniati, sul versante ionico della Calabria, sono presentati da Petronio come depredatori di naufraghi (Sat. 114-116). Naturalmente, la pirateria che scaturiva da ambienti di pesca, spontanea, episodica con caratteristiche di risorsa alternativa, aveva portata e forme differenti da quella connessa alle navigazioni commerciali.
Dal punto di vista archeologico, insediamenti di questo tipo sono ancora poco stu-diati perciò non è facile proporre esempi soddisfacenti. Zone tradizionalmente esposte a razzie, fino alle ultime incursioni di barbareschi, erano in genere quelle dove pascolavano greggi o mandrie o quelle in cui si effettuavano raccolte di cereali. Altrettanto poteva avvenire per saccheggiare i proventi di pesca su grande scala dove operavano tonnare e
55. Il fenomeno relativamente frequente spesso originò contenziosi giuridici, come per il getto a mare, determinando specifiche regolamentazioni a protezione di quanto naufragato, per stabilire eventuali responsabi-lità e il risarcimento dei danni, Rougé (1966: 339-343); ved. anche Gianfrotta (2005: 29).
56. Beltrame (1998; 2002: 381 ss).57. Baika (2007-2008).58. Esplicitamente in 1.7.3 e 1.10.2; Ferone (1997: 126 ss). Per la figura del pescatore-predone, Braund
(1992: 206 ss.).
63Pirateria e archeologia sottomarina: rinvenimenti, luoghi e circostanze
stabilimenti di lavorazione del pescato, che in età medievale e moderna sono stati per lo più difesi da torri59.
Alcune situazioni sospettabili possono essere in aree indiziate da riferimenti delle fonti.— Una può riguardare una remota e spopolata plaga della Sicilia sud-orientale, non
lontana da Capo Pachino dove si svolgevano intense attività di pesca (principal-mente tonni, ma anche altri tipi di pesce) e di lavorazione del pescato60. La zona, caratterizzata da estesi sistemi di pantani costieri dove si entrava con le imbarca-zioni, si produceva sale e in parte si allevava pesce, è indicata da Cicerone come frequentata da pirati61.
— Un’altra sulle coste del Bruttium tra Vibo e Velia con lunghi tratti costieri roc-ciosi, privi di ripari ed esposti a rischi, definita da Cicerone (II Verr., 2.99) come adatta ed infesta da pirati, che egli costeggia su una piccola imbarcazione tra schiavi fuggiaschi e pirati62.
— Nelle paludi pontine e nella silva gallinaria agivano gruppi di briganti e, del resto, la situazione era simile lungo gran parte dei litorali della Campania set-tentrionale e del Lazio meridionale (Juv., Sat. 3, 307). In quella zona, capi pirati sbarcati sulla spiaggia di Liternum poterono recarsi indisturbati, senza le ciurme e le armi, a vedere da vicino Scipione l’Africano, il vincitore di Cartagine, e a rendergli omaggio (Val. Max., 2.10.2).
— Una situazione simile riguardava parte delle coste della Liguria, con pirati liguri che su piccole imbarcazioni si spingevano a compiere razzie fino alle Colonne d’Ercole63. La nave di Albenga, con almeno sette elmi a bordo (fig. 4), dimostra la necessità di navigare armati in acque liguri all’inizio del I sec. a.C.
— Lo stesso vale per le coste della Provenza (nel raggio d’azione ligure), presso promontori e isolotti (numerosi i relitti noti a Planier, a Porquerroles, al Grand e al Petit Congloué, a la Madrague de Giens, alla quale si è accennato prima, con due elmi a bordo e asportazioni di materiali).
— A Cabrera, nelle Baleari (dove le popolazioni erano dedite alla pirateria), si rischiava il naufragio per via di una ventina di isolotti determinati dal mare con bassifondi (Plin., Nat. Hist. 3.78-79)64.
— A “lidi infestati da briganti” accenna genericamente Seneca (De beneficiis 7.15.1) nell’esempio paradossale di chi per riscattare un prigioniero ha navigato in inverno col denaro del riscatto, ottenuto in prestito e impegnando i propri
59. Apollodoro (Apollod., 3.2.2) presenta uno sbarco di pirati in una zona deserta di Rodi che viene respinto dai pastori con pietre e giavellotti. In alcuni casi, in zone comunque lasciate indifese, veniva imposto dai pirati una sorta di periodico taglieggiamento, ad es. ai contadini di Lipari, Cic., II Verr., 3.85.
60. Felici 2012. Altri impianti sono noti a Porto Palo e Vendicari, poco più a nord, Bacci 1994; Basile 1992.61. II Verr. 5.87: Ecce autem repente ebrio Cleomene esurientibus ceteris nuntiatur piratarum esse navis in
portu Odysseae: nam ita is locus nominatur; nostra autem classis erat in portu Pachyni.62. Altra area adatta era l’attuale Gargano (Puglia settentrionale), con vaste aree lacustri e paludose carat-
terizzate da misera economia palustre (saline ed allevamenti di pesce), rasentata dalla transumanza oviaria ed equina fino ad età recente infestata da briganti e da incursioni dal mare.
63. Plut., Aem. 6; Cavazzuti (1997: 202); Tramonti (1995).64. A Cabrera sono noti relitti con armi, tre elmi di bronzo sono sul relitto D della prima metà del I sec. d.C.,
Cavazzuti (1997: 200). Referenze delle illustrazioni: fig. 1, da Cassieri 2011; fig. 2 e 3, da Bacci 1994; fig. 4, Istituto internazionale di Studi Liguri.
64 Piero A. GiAnfrottA
averi e, lungo lidi infestati dai briganti ha percorso deserti ed è infine arrivato dai pirati. Ma il prigioniero era stato intanto liberato. E le eventualità negative potevano continuare. E se avesse perduto tutto in un naufragio? E se egli stesso, infine, fosse stato fatto prigioniero?
BIBLIOGRAFIA
ÁLVAREZ ARZA et alii (2008): “Els objectes metàl.lics” , X. Nieto y M. Santos (eds.), El vaixell grec arcaic de Cala Sant Vicenç. Monografies del CASC 7: 199-223. Girona.
BACCI, G. (1994): “Recenti esplorazioni a Capo Rasocolmo”, Atti della VI Rassegna di Archeolo-gia Subacquea (Giardini Naxos 1991): 117-122. Messina.
BAIKA, K. (2007-2008): “Pirate Activities and Surveillance of Trade Routes. New archaeological evidence from naval bases in the Aegean Sea”, Skyllis 8: 56-72.
BASILE, B. (1992): “Stabilimenti per la lavorazione del pesce lungo le coste siracusane: Vendicari e Porto Palo”, Atti della V Rassegna di Archeologia Subacquea (Giardini Naxos 1990): 55-88. Messina.
Figura 4. Gli elmi recuperati dal relitto di Albenga.
65Pirateria e archeologia sottomarina: rinvenimenti, luoghi e circostanze
BELTRAME, C. (1998): “Per l’interpretazione del relitto tardo repubblicano di Spargi”, Rivista di Archeologia 22: 38-45.
—— (2002): “Investigating Processes of Wreck Formation: Wrecks on the Beach Environment in the Mediterranean Sea”, Archeologia Subacquea. Studi, ricerche e documenti III: 381-394.
BERNARD, H. (2008): “Nouvelles épaves hispaniques de Corse: Sud Perduto 2 (Bonifacio) et Marina di Fiori (Porto Vecchio)”, J. Peréz Ballester y G. Pascual Berlanga (coords.), Actas V Jornadas Internacionales de Arqueología Subacuática (Gandía 2006): 461-471. Valencia.
BRAUND, D. (1992): “Piracy under the Principate and the ideology of imperial eradication”, J. Rich y G. Shipley (eds.), War and Society in the Roman World: 195-213. London-New York.
BROWN, F.E. (1970-1971): “Roma e l’Italia fra i Gracchi e Silla”, Dialoghi di Archeologia IV-V: 362 ss.
CASSIERI, N. (2011): “Un elmo di bronzo dal mare di Sperlonga”, G. Ghini (a cura di), Lazio e Sabina 7. Atti VII incontro di Studi sul Lazio e la Sabina: 391-395.
CASSOLA, F. (1968): I gruppi politici romani nel III secolo a.C. Roma.CASSON, L. (1971): Ships and Seamanships in the Ancient World. Princeton.CAVAZZUTI, L. (1997): “Nuovi rinvenimenti sottomarini per lo studio della pirateria”, Archeolo-
gia subacquea. Studi, ricerche e documenti II: 197-214. Roma.—— (2004): “La pirateria nella navigazione antica”, Lezioni Fabio Faccenna (III-IV ciclo): 45-58. Bari.CRISTOFANI, M. (1983): Gli Etruschi del mare. Milano.DAS WRACK = G. HELLENKEMPER SALIES, H.-H. VON PRITTWITZ GAFFRON y G.
BAUCHHENSS (a cura di) (1994): Der antike Schiffsfund von Mahdia (mostra Bonn 1994-1995). Köln.
D’ARMS, J.H. (1981): Commerce and social standing in ancient Rome. Cambridge (Massachusetts).DELL, H.J. (1967): “The origin and nature of Illyrian piracy”, Historia 16: 344-358.DE SOUZA, P. (1999): Piracy in the Graeco-Roman World. Cambridge University Press,
Cambridge.DI STEFANO, G. (2008): “Naufragi Camarinesi”, Aristhonotos. Scritti per il Mediterraneo antico
2: 177-190.DIOLÉ, P. (1952): Promenades d’archéologie sous-marine. Paris.FELICI, E. (2012): “Un impianto con thynnoskopeion per la pesca e la salagione sulla costa meri-
dionale della Sicilia (Pachino,Sr)”, Topografia Antica. Tradizione, tecnologia e territorio 2: 107-142. Catania.
FERONE, C. (1989): “La guerra navale nel Siculum bellum: aspetti tecnico-militari”, XIV Misce-llanea Greca e Romana: 185-204. Roma.
—— (1997): Lesteia. Forme di predazione nell’Egeo in età classica. Napoli.FRASCHETTI, A. (1981): “Per una prosopografia dello sfruttamento: Romani e Italici in Sicilia
(212-44 a.C.)”, Società romana e produzione schiavistica, I. L’Italia: insediamenti e forme economiche: 51-85. Bari.
GABBA, E. (1973): Esercito e società nella tarda repubblica romana. Firenze.GANDOLFI, D. (1985): “Relazione preliminare sul relitto di Capo Testa presso Santa Teresa di
Gallura (Sassari)”, VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Cartagena 1982): 313-323. Madrid.
GIANFROTTA, P. A. (1981): “Commerci e pirateria: prime testimonianze archeologiche sottoma-rine”, Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité 93: 227-242.
66 Piero A. GiAnfrottA
—— (2001): “Fantasmi sottomarini: guerre, pirateria o chissà cos‘altro”, Daidalos 3: 209-214.—— (2005): “Note di topografia marina e marittima”, Atti V Congresso di Topografia antica. Jour-
nal of Ancient Topography XV: 7-36.—— (2008): “Il commercio marittimo in età tardo-repubblicana: merci, mercanti, infrastrutture”, J.
Peréz Ballester y G. Pascual Berlanga (coords), Actas V Jornadas Internacionales de Arqueo-logía Subacuática: 65-78. Valencia.
GUiTART, J.; PERA, J. y CARRERAS, C. (1998): “La presència del vi itàlic a les fundacions urbanes del principi del segle I a.C. a l’interior de Catalunya: l’exemple de Iesso”, El vi a l’Antiguitat. Actes II Col.loqui internacional d’arqueologia romana: 39-65. Badalona.
MANACORDA, D. (2004): “Un’anfora brindisina di Giancola a Populonia”, in Materiali per Populonia 3: 177-189. Firenze.
—— (2005): “Le anfore di Pompeo Magno”, M. Sapelli Ragni (a cura di), Studi di archeologia in memoria di Liliana Mercando: 132-143. Torino.
MANGANARO, G. (1987): “Tacfarinas e la Sicilia (ovvero L. Apronius e il santuario Ericino)”, L’Africa Romana IV: 580-585. Ozieri.
MARASCO, G. (1987), “Roma e la pirateria cilicia”, Rivista Storica Italiana 99: 22-146.MAROTI, E. (1970): “Die Rolle der Seerauber in der Zeit des Mithridatischen Krieges”, Ricerche
storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo, I: 479-493. Napoli.MATTINGLY, H. (1980): “M. Antonius, C. Verres and the sack of Delos by the pirates”, Miscella-
nea di Studi Classici in onore di Eugenio Manni, IV: 1491-1515. Roma.MEDAGLIA, S. (2010): Carta archeologica della provincia di Crotone. Rossano (Cs).MUSTI, D. (1980): “Il commercio degli schiavi e del grano: il caso di Puteoli. Sui rapporti tra
l’economia italiana della tarda repubblica e le economie ellenistiche”, J.H. D’Arms y E.C. Kopff (eds.), The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History. Memoirs of the American Academy in Rome XXXVI: 197-215. Roma.
ORMEROD, H.A. (1924): Piracy in the ancient World. An Essay on Mediterranean History. Li ver-pool (rist. 1978).
PFLUG, H. (2006): “Elmi antichi dal mare di Camarina”, P. Pelagatti, G. Di Stefano y L. De Lachenal (a cura di), Camarina 2600 anni dopo la fondazione. Nuovi studi sulla città e sul territorio: 259-270. Roma.
TCHERNIA, A. (1989): “Les urinatores sur l’épave de la Madrague de Giens”, Navires et commer-ces de la méditerranée Antique. Hommage à Jean Rougé. Cahiers d’Histoire: 491-499. Lyon.
TERRERO, J. (1944): Armas y objetos de bronces extraídos en los dragados del Puerto de Huelva. Reed. Diputación Provincial de Huelva (1991). Huelva.
TRAMONTI, S. (1994): Hostes communes omnium. La pirateria e la fine della Repubblica romana (145-33 a.C.). Ferrara.
—— (1994): “La pirateria in età imperiale romana. Fenomenologia di una struttura”, Ravenna Studi e Ricerche I: 134-175.
—— (1995): “La pirateria ligure e sardo-corsa nel II sec. a. C.”, Atene e Roma n. s. XL, 4: 197-212.ZUCCA, R. (2003): Insulae Sardiniae et Corsicae. Le isole minori della Sardegna e della Corsica
nell’antichità. Roma.
Alf
onso
Álv
arez
-Oss
orio
Riva
s,Ed
uard
o Fe
rrer
Alb
elda
,En
riqu
e G
arcí
a Va
rgas
(coo
rds.)
SPALMONOGRAFÍASXVII
El estudio de la piratería durante la Antigüedad ha sido una cuestión científica que ha pasado determinados períodos a lo largo de la historia de la historiografía y que se encuentra en boga en los últimos años. Este trabajo colectivo supone la primera aportación desde la Academia española, con la colaboración de notables especialistas internacionales, a este tipo de estudios.
Esta obra se acerca al análisis de la piratería desde una perspectiva dual, es decir, tanto desde la óptica de quienes sufren el supuesto acto pirático, como de quienes lo protagonizan de forma activa. Lo verdaderamente importante del hecho pirático es la perspectiva, quien define a la piratería y a los piratas, y las intenciones que se esconden tras las medidas políticas, bélicas y propagandísticas de quienes se enfrentan a ellos.
Hoy en día, a todos nos resultan familiares los términos “pirata” y “piratería” a partir de los libros, las películas y los medios de comunicación. Las imágenes y conceptos que nos evocan forman parte de la vida contemporánea y la cultura popular, en muchos casos con consideraciones positivas, o cuando menos, con una visión “romántica” de los mismos, pero, como se demuestra en este trabajo, durante la Antigüedad, la aplicación de la etiqueta “piratas” a ciertas comunidades del Mediterráneo constituyó a menudo una deliberada distorsión de la verdadera naturaleza de estos grupos, cuya actividad fue definida no por ellos mismos, sino por quienes la padecieron.
Últimos títulos publicados en laColección SPAL MONOGRAFÍAS
XVII. Piratería y seguridad marítima en el Mediterráneo Antiguo.
Alfonso Álvarez-Ossorio Rivas, Eduardo Ferrer Albelda y Enrique García Vargas, coords.
XVI. La religión del mar. Dioses y ritos de navegación en el Mediterráneo Antiguo.
Eduardo Ferrer Albelda, Mª Cruz Marín Ceballos y Álvaro Pereira Delgado, coords.
XV. Grecia ante los imperios. V Reunión de historiadores del mundo griego.
Juan Manuel Cortés Copete, Rocío Gordillo Hervás y Elena Muñiz Grijalvo, coords.
XIV. Salvación, infierno, olvido. Escatología en el mundo antiguo.
Eduardo Ferrer Albelda, Fernando Lozano Gómez y José Mazuelo Pérez, coords.
XIII. Piedras con alma. El betilismo en el mundo antiguo y sus manifestaciones en la península ibérica.
Irene Seco Serra.
XII. Ofrendas, banquetes y libaciones. El ritual funerario en la necrópolis púnica de Cádiz.
Ana María Niveau de Villedary y Mariñas.
XI. De dioses y bestias. Animales y religión en el mundo antiguo.
Eduardo Ferrer Albelda, José Mazuelos Pérez y José Luis Escacena Carrasco, coords.
X. Las instituciones en el origen y desarrollo de la Arqueología en España.
María Belén Deamos y José Beltrán Fortes, eds.
IX. Imagen y culto en la Iberia Prerromana: Los pebeteros en forma de cabeza femenina.
Mª Cruz Marín Ceballos y Frédérique Horn, eds.
VIII. Testimonios arqueológicos de la antigua Osuna. José Ildefonso Ruiz Cecilia.
VII. Entre Dios y los hombres: El sacerdocio en la Antigüedad.
José Luis Escacena Carrasco y Eduardo Ferrer Albelda, eds.
VI. Arqueología en Laelia (Cerro de la Cabeza, Olivares, Sevilla).
Antonio Caballos Rufino, José Luis Escacena Carrasco y Francisca Chaves Tristán.
Catálogo completo de nuestras publicacionesen la página web
<http://www.publius.us.es>
Alfonso Álvarez-Ossorio RivasEduardo Ferrer AlbeldaEnrique García Vargas
(coords.)
SPAL MONOGRAFÍASXVII
Piratería y seguridad marítimaen el Mediterráneo Antiguo
Pira
terí
a y
segu
rida
d m
arít
ima
en e
l M
edit
errá
neo
Ant
iguo
Genaro Chic García
Philip de Souza
Piero A. Gianfrotta
Adolfo J. Domínguez Monedero
César Fornis
Eduardo Ferrer Albelda
Enrique García Riaza
Antoni Puig Palerm
Isaías Arrayás Morales
Feliciana Sala Sellés
Sonia Bayo Fuentes
Jesús Moratalla Jávega
Alfonso Álvarez-Ossorio Rivas
David Álvarez Jiménez
Antón Alvar Nuño
Listado de autores